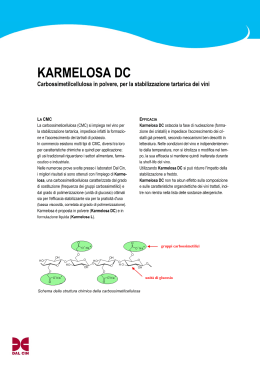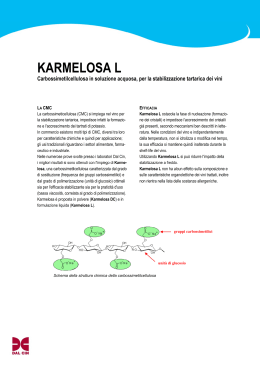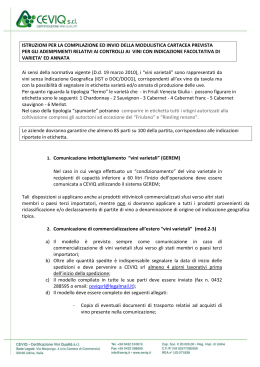APRILE 2005 NUMERO 14 UN POPOLO CHE PARTECIPA In poche regioni d’Italia, forse in nessuna, il popolo vive ed ha vissuto le vicende della propria terra partecipando ad esse come in Romagna. È nell’indole stessa dei Romagnoli essere parte attiva della società in cui vivono, contribuire con la propria mente e col proprio operare allo svolgimento degli avvenimenti che li riguardano buoni o tristi che siano, pur di agire, essere attori e non soggetti passivi di un’azione da cui poi dipenderà i loro vita. L’indifferenza, l’indugio, l’incertezza, sono atteggiamenti che il romagnolo non ha mai conosciuto. Quel miscuglio di Umbri, di Celti, di Romani, di Goti, di Bizantini da cui trassero il ceppo i Romagnoli, diede origine ad un uomo di spiccata personalità, ben fermo nel proprio modo di pensare, disposto a far seguire l’azione al pensiero, raramente propenso ai pentimenti od alle recriminazioni sul passato, spinto da molteplici interessi, primo fra tutti quello per la società in cui vive. Noi possiamo riscontrare questa peculiarità delle genti di Romagna in ogni momento della storia della regione: non è mai avvenuto che un Romagnolo si apparti e lasci che gli eventi si svolgano senza il suo fattivo intervento. Si trattasse di seguire l’Imperatore o il Vescovo principe, di parteggiare per ghibellini o per guelfi, i Romagnoli furono sempre pronti all’azione. E mantennero le caratteristiche di quel loro partecipare alla lotta, nelle simpatie e nelle antipatie che dovevano opporli gli uni agli altri, cittadini di una città, contro quelli di un’altra. Il gusto di essere parte attiva della società, di dedicarsi alle faccende pubbliche, comincia a diventare tratto peculiare dei Romagnoli proprio nel periodo napoleonico. Da allora i Romagnoli tenderanno, senza diversità di ceti o di partiti (alcuni come ribellione allo stato attuale, altri con l’intenzione di collaborare con le autorità costituite) a liberarsi dalla pesante ipoteca dei “celibatari” (come chiamavano i sacerdoti che amministravano le Legazioni) per sostituirsi ad essi nella direzione della cosa pubblica. E per vincere la propria battaglia, nella impossibilità di una libera espressione delle proprie volontà, sorge la ricerca delle società segrete, l’organizzazione delle sette. In pochi luoghi l’attività clandestina trovò più favore che in Romagna. La Carboneria fece adepti ovunque. Vi erano uomini della media e piccola nobiltà, professionisti, artigiani e perfino, unico esempio in Italia, contadini. Per il Romagnolo, il concetto mazziniano della dignità del popolo a governare se stesso, il fare del popolo stesso il depositario della Legge e dell’autorità, non può non essere altamente suggestivo. I romagnoli sono un popolo che partecipa. 1 Bertinoro, colonna dell’ospitalità. TRIBUNATO DI ROMAGNA CCIV TORNATA TORNATA DEDICATA AL MIELE 5 giugno 2005 BRISIGHELLA Il mondo delle api e i loro favolosi prodotti Interventi: TIZIANO RONDININI Api e apicoltura CESARE BUSI I prodotti dell’alveare pranzo a base di miele Luci e ombre della enologia romagnola Due importanti relazioni enologiche alla Tornata deI 20 marzo 2005 a Bertinoro. Il vino ed il mutato contesto economico della produzione e del mercato sono state l’argomento di questa tornata che ha visto le relazioni del prof. Andrea Segre, ordinario di politica agraria e direttore del Dipartimento di Economia e Ingegneria agraria della Università di Bologna e quella del dr. Roberto Monti direttore della Cantina Forlì Predappio. La relazione del prof. Segre per la sua ampiezza, il suo alto contenuto scientifico e relativo corredo illustrativo, ha trovato difficoltà ad essere inserita nella nostra rivista con un numero ridotto di pagine e un livello accessibile e divulgativo e pertanto è stata inserita integralmente nel nostro sito www.tribunato.it corredandola con i link dell’Istituto scientifico che l’ha prodotta. Pertanto qui ne accenniamo solo brevemente, mentre riproduciamo di seguito, fornitoci dall’autore, un riassunto della relazione del direttore la Cantina di Forlì Predappio. La relazione del prof. Segre in collaborazione con il Dottore di ricerca in Economia e Politica Agraria dr. Enrica Gentile, ha come obiettivo analizzare l’evoluzione che ha conosciuto il prodotto vino nel corso degli ultimi decenni, comprendere quali siano divenute, a seguito di questa evoluzione, le attuali caratteristiche della domanda, quali siano stati i naturali adattamenti dell’offerta alle mutate esigenze del consumo, nonché ad un mutato panorama normativo, e in che modo la produzione di vino in Romagna si inserisca nel mutato contesto di mercato e quali opportunità, problemi e prospettive siano prevedibili per il prodotto di quell’area. Relazione presentata alla tornata del Tribunato dei Vini di Romagna tenutasi a Bertinoro il 20 marzo 2005 Relatore: Monti Roberto, direttore Cantina Forlì Predappio Elaborazione dati in collaborazione con Zinzani Giordano Presidente Assoenologi Romagna. 2 La viticoltura da sempre costituisce una coltivazione importante per la Romagna, un territorio con spiccata vocazione viticola, un territorio eterogeneo, montagna, alta collina, pedecollina, vallate, pianura, terreni più o meno fertili, dove si riscontrano potenziali qualitativi o in alcuni casi quali-quantitativi di indubbio valore. L’ettarato viticolo più significativo risiede nella provincia di Ravenna (ca. 17.000 ha) dove nella parte di pianura la coltivazione della vite, prevalentemente trebbiano, è molto diffusa. La superficie media vitata per azienda è bassa, da 1,08 ha. di Forlì Cesena a 2,18 ha. di Ravenna, valori di poco superiori alla media nazionale (ca. 0,90 ha), valori comunque ben al di sotto della media nazionale francese, 7 ha, che sale a 25 ha. nel Midi, o alla media Cilena che raggiunge i 300 ha. di superficie vitata media per azienda; tutto questo conferma che anche nel territorio romagnolo come del resto in gran parte del paese per molte aziende la viticoltura è una coltura marginale. La produzione di uva ha fatto registrare in Romagna, nella vendemmia 2004, circa un incremento del 30 % rispetto al 2003; Il parco vigneti romagnolo è ancora oggi abbastanza obsoleto ed ha subito forti ridimensionamenti dal 70 ad oggi. Allora era diffusa una viticoltura di quantità, con vigneti a bassa densità di impianto, potature lunghe, pareti molto alte e grandi produzioni per ha.. In quegli anni il vigneto delle quattro province superava i 50.000 ettari e dava origine a un prodotto generalmente poco qualificato, se si escludono alcune aree collinari (Bertinoro, Pre- dappio, Brisighella, Dozza etc.) già allora rinomate per i loro prodotti. Negli anni 80 il vigneto romagnolo si è ridimensionato scendendo fin sotto i 40.000 ettari verso i primi anni 90. Erano gli anni delle estirpazioni incentivate dai contributi comunitari, erano anni in cui i reimpianti erano ben al di sotto della quota di rinnovo. L’età media del vigneto romagnolo si è in questo modo alzata, innalzamento favorito anche dalla età generalmente avanzata dei viticoltori, nonché dalla ridotte dimensioni dell’azienda viticola, fattori che hanno frenato in modo significativo il salto di qualità del vigneto romagnolo. Verso la fine degli anni 90 sono partiti investimenti abbastanza consistenti e il vigneto romagnolo si è arricchito di nuovi impianti più orientati alla qualità. Una svolta che ha proseguito dal 2000 ad oggi in modo assai più evidente, a seguito dei contributi sulla ristrutturazione viticola che in queste ultime 4 campagne hanno portato a 4422 ettari di vigneti nuovi nelle 4 province (Forlì Cesena, Ravenna, Bologna, Rimini) grazie anche all’erogazione di contributi per 22.920.000 € a favore dei viticoltori. La produzione di vini a Doc in Romagna è pari a circa 362.000 hl. (dato del 2003), circa un 12 % della produzione totale; si producono vini a IGT per circa il 40 % della produzione totale, mentre la parte restante è vino da tavola. Non tutto il vino a denominazione di origine viene commercializzato come tale, bensì gran parte viene declassato a IGT o a vino da tavola, dato lo scarso valore commerciale di alcune nostre denominazioni (es. Trebbiano di Romagna); è proprio questa una delle cause che determina una scarsa correlazione fra il posizionamento delle produzioni nella piramide qualitativa, secondo le tre grandi categorie, Doc, IGT e tavola, e il reddito per ettaro del viticoltore. Le luci La Romagna enologica comunque di strada ne ha fatta tanta. Per comprendere questa affermazione è sufficiente guardarsi un po’ alle spalle per capire come eravamo, e per apprezzare meglio quello che siamo oggi. Senza andare troppo lontano nel tempo, negli anni 70, la Romagna era terra di mosti muti, di vini per la distillazione, senza poi parlare della scomoda piaga della sofisticazione che ha reso nota la Romagna in tutto il Paese. Si produceva tanto e male e anche nelle aree più nobili, poche erano le aziende di riferimento. Con gli anni 80 la situazione si è evoluta verso produzioni in parte più orientate al mercato, ma si è dovuto attendere gli anni 90 per registrare una vera e propria svolta tecnologica che ha interessato tutte le cantine della Romagna, dalle più piccole fino alle grandi strutture cooperative. In tante realtà si sono diffusi i sistemi di refrigerazione per consentire il controllo delle temperature di fermentazione. Un grande supporto qualitativo è arrivato nelle grandi strutture con l’introduzione delle tecnologie di illimpidimento dei mosti, importanti per il miglioramento qualitativo dei vini da tavola a base trebbiano. Così sono stati introdotti impianti di cen- trifugazione, impianti per la defecazione statica a freddo, impianti di flottazione, una tecnologia innovativa per il settore enologico, già applicata nel settore dei succhi e nel settore ecologico. Ma si potrebbe continuare a scrivere a lungo per citare i dettagli di questa ondata di rinnovamento; è cambiato anche molto il ruolo dell’enologo, in quanto tutte queste tecnologie vanno progettate, gestite e applicate correttamente, se si vuole pervenire a risultati positivi, utilizzando correttamente le biotecnologie per guidare il processo di vinificazione senza lasciarlo al caso, unicamente protetto dall’azione dell’anidride solforosa come si faceva una volta. L’aggiornamento tecnologico è andato avanti coinvolgendo un pò tutte le cantine e continua tuttora: stanno entrando nelle cantine anche le più moderne tecnologie, più rispettose della materia prima, con più trattamenti fisici e meccanici e meno coadiuvanti enologici; ovunque si installano impianti e contenitori luccicanti in acciaio inox, ma, per le produzioni più prestigiose, c’è spazio anche per l’affinamento in legno. Ma qual è il livello qualitativo dei nostri vini? Per la conformazione del territorio, per le caratteristiche dei terreni, per la situazione climatica, la Romagna è sempre stata una terra capace anche di grandi produzioni per ettaro, idonee all’ottenimento di vini con caratteristiche semplici, con costi di produzione contenuti , con prezzi abbordabili, adatti al consumo di tutti giorni: nel daily wine direi che siamo veramente forti. È prevalentemente in mano alle grandi strutture che hanno saputo conquistare la leadership nazionale per queste produzioni in determinati contenitori. Per i prodotti più qualificati , a DOC, o a IGT, troviamo sul mercato una miriade di proposte con tanti marchi, con qualità estremamente variegate; penso si possa affermare che in questa fascia dobbiamo fare un po’ più di chiarezza, lavorare molto, anche a livello di qualità, ma anche di comunicazione: il consumatore si perde in una miriade di etichette, di marchi, di prezzi svariati. Per le selezioni più alte: mentre fino a qualche anno fa erano rare le occasioni di vedere premiate ai concorsi le produzioni romagnole, oggi i riconoscimenti sono tanti. Ai concorsi, nazionali, internazionali, sulle guide, i risultati parlano da soli, e confermano la potenzialità del territorio, dei vigneti, delle cantine. Possiamo migliorare ?? Sì possiamo fare meglio. Nel vigneto: dandoci una nuova impostazione, quella di produrre secondo un obiettivo enologico e commerciale prefissato, senza aspettare quel che viene, ma impegnandosi nelle diverse pratiche colturali e agronomiche per portare la produzione alle caratteristiche prestabilite. Inevitabilmente il vigneto dovrà inoltre assumere dimensioni medie maggiori; gli accorpamenti consentiranno di aumentare la meccanizzazione, di programmare meglio e di ridurre i costi. In cantina: rispettando di più la materia prima, migliorando i processi di estrazione per trasferire le peculiarità del vitigno al vino, cercando nel contempo un utilizzo più selettivo e più contenuto dei coadiuvanti enologici. I vini rossi e i vini bianchi, di pronta beva o non, devono avere più personalità, devono essere più caratterizzati, non sono più gradite le soluzioni idroalcoliche, soltanto fresche e acidule. Tutto sommato comunque, anche se come abbiamo detto possiamo fare meglio, è pur vero che in questi ultimi 30 anni abbiamo fatto passi da gigante. Le ombre Tuttavia al di là dei risultati qualitativi, oggi in linea di massima buoni, possiamo individuare altri problemi che non fanno decollare la vitienologia romagnola. Da un lato manca una programmazione viticola seria, basata su considerazioni fatte con l’ausilio di dati certi sulle produzioni, oggi essenzialmente derivati da stime non sempre attendibili, e anche sulla base di supporti scientifici, come una precisa zonazione di tutto il territorio. Dall’altro manca una impostazione razionale della parte enologica: le cantine sono troppe e ognuna di esse investe migliaia di euro in attrezzature per tutte le fasi della lavorazione, facendo scarso ricorso a servizi terzi ; anche le cantine cooperative sono tante, troppo vicine, troppo piccole, troppo impegnate in attività campanilistiche più che nello sviluppo di strategie di miglioramento e di pianificazioni commerciali. Ma soprattutto c’è un diffuso orientamento ad investire molto nella produzione e poco nella commercializzazione. Dobbiamo metterci in testa la necessità di investire per vendere, dobbiamo investire nell’immagine delle aziende e dei prodotti, nel marketing, nella commercializzazione e nella comunicazione. Si denota invece che le nostre imprese sono poco predisposte all’internazionalizzazione, un male diffuso anche nelle grandi strutture cooperative : non ci si rende conto che il mercato oggi è globale. Sono poche le figure professionali preparate nel marketing che operano nelle nostre aziende, sono tante le figure di buona volontà, poco preparate però ad affrontare la competizione fuori dal Paese. Abbiamo inoltre il difetto di non credere abbastanza nella bellezza e nella potenzialità del nostro territorio, Siamo anche poco comunicativi; consideriamo che i Paesi Nuovi Produttori, quelli dell’altro Emisfero, spendono tantissimo in comunicazione si parla anche di un 10% del fatturato; a confronto la Romagna sta spendendo molto poco. Prezioso il lavoro dei nostri sommeliers sia nella loro attività professionale specifica, sia nelle attività collaterali della associazione; ma è necessario che le aziende romagnole facciano di più per fare conoscere le proprie produzioni. Il mondo di oggi è basato sulla comunicazione, non basta fare la qualità, bisogna raccontarla. Fra l’altro il vino non è un genere di prima necessità e ha un gran bisogno di essere spiegato, ancor di più il vino italiano contraddistinto da una miriade di denominazioni in cui si perde anche il più esperto degli addetti ai lavori, a differenza di quanto avviene per i Paesi Nuovi Produttori che hanno poche regole, e pochi dati essenziali da trasmettere al consumatore: la varietà, larghe aree di produzione, il marchio aziendale, quindi elementi chiari, facilmente comprensibili. Abbiamo una scarsa cultura di territorio : il territorio romagnolo ha poco da invidiare ad altre regioni del nostro Paese; è ricco di elementi naturali e storici in parte ancora da recuperare, che potrebbero essere ripristinati e resi visitabili per rendere tutto il contesto più ricettivo anche nei confronti dell’enoturismo. Inoltre spesso partiamo da preconcetti che oggi non hanno più fondamento; ad esempio pensiamo che sia buono e bello solo ciò che è piccolo o che sia più buono il prodotto che viene da lontano. Nella ristorazione locale spesso si colgono queste sensazioni: 3 pochi i vini romagnoli presenti, ampio assortimento di prodotti extraregione, i vini delle grandi strutture relegati alle occasioni di massa. A questo si aggiunge poi una politica dei prezzi al consumo non sempre equilibrata, specialmente nella ristorazione; bisogna stare coi piedi per terra, anche perché il consumatore è sempre più attento al rapporto qualità prezzo, e non è più disposto a farsi spennare. Queste sono dunque ancora le ombre sulla vitienologia romagnola. E mentre noi siamo poco predisposti all’esportazione, è sempre più vero che il futuro si giocherà principalmente sulle capacità di conquistare nuovi mercati, visto che il consumo interno non cresce, la produzione non cala, le importazioni in un mercato sempre più globale aumentano di anno in anno. Un piccolo flash a conferma di quanto sopra: nei primi 9 mesi del 2004 negli Usa è cresciuta l’importazione di vino australiano del 20 % mentre Italia e Francia hanno perso posizioni. Più recente- mente la situazione ha virato un pò più a favore dell’Italia ma comunque è sempre una battaglia forte e difficile. Conclusioni In poche righe riepiloghiamo le strade da percorrere. Continuiamo a migliorarci e a rapportarci con le esigenze del mercato, puntando alla soddisfazione del consumatore. Rendiamoci conto di avere in mano ottime potenzialità viticole ed enologiche, convinciamoci delle nostre effettive possibilità. Investiamo nella internazionalizzazione delle nostre aziende. Investiamo nel marketing, nell’immagine, nella comunicazione, dobbiamo trasmettere al consumatore le caratteristiche del nostro vino e tutto l’immaginario che c’è intorno se vogliamo far conoscere e valorizzare le nostre produzioni. Dobbiamo sviluppare bene il binomio vino - territorio, un territorio che ben si presta per le sue bellezze naturali e storiche a fare da supporto alla nostra produzione enologica, e a tutte le tipicità gastronomiche di questa splendida Romagna. L’ecellenza territoriale ed i vini di qualità come fattori di crescita della comunità 4 Nelle tre provincie romagnole, secondo il Censimento dell’agricoltura 2000, vi sono 32.427 ettari di vigneti, pari al 46% degli investimenti regionali. Le varietà coltivate nell’area romagnola sono soprattutto i tre storici vitigni ad alto potenziale produttivo: Trebbiano Romagnolo, Albana e Sangiovese. Vi sono pure limitate superfici di vitigni internazionali quali: Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon. Ai vitigni autoctoni regionali come Canina, Uve Longanesi, Barzamino, sono riservati ambiti colturali molto più ristretti (una decina di ettari). In Romagna, ed in particolare in provincia di Ravenna, vi sono infine vitigni autoctoni ancestrali quali Cornacchia, Pignolo Nero, Romanino, Lanzes, Bertinora e Paradisa, che coprono nell’insieme un’estensione stimata nell’ordine di qualche ettaro. Quando si affronta il tema dello sviluppo e della valorizzazione delle produzioni territoriali, uno degli argomenti di maggiore interesse, che coinvolge molti consumatori, è quello della riscoperta delle radici storiche delle nostre produzioni, quindi anche la riproposta di vini appartenenti alla tradizione e alla cultura materiale romagnola. Solo pochi produttori hanno intrapreso questa strada. Fanno eccezione i soci del Consorzio del Bagnacavallo impegnati nella valorizzazione del Burson, nonchè altre iniziative locali, come quelle del recupero dell’Albana Nera (faentino) e della Canena (Russi). La terra di Romagna rappresenta, in ambito nazionale, un importante bacino di biodiversità viticola, proprio in virtù del suo ampio patrimonio di vitigni autoctoni, in grado di fornire vini altamente apprezzati nei secoli scorsi. Le ragioni per cui, dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, questi vitigni furono abbandonati sono essenzialmente due: l’insorgenza della fillossera e una scarsa resa che favoriva per contro le uve molto produttive per ettaro, in un’epoca in cui la quantità faceva premio sulla qualità. Speriamo che questo atteggiamento sia soltanto rappresentativo di un passato, sia pure recente. Accanto alla filiera dei vini di massa, segmento di prezzo molto affollato e poco remunerativo per i produttori e le comunità locali, riteniamo possa oggi trovare spazio il segmento dell’eccellenza territoriale, in grado di offrire un prodotto servizio ad alto valore aggiunto locale. Antichi vitigni e vini romagnoli La letteratura degli ultimi secoli, e soprattutto gli scrittori locali, fanno numerosi richiami ai vini della nostra terra. Piace soffermarci su tre prodotti la Canena, il Barzamino e il Vin Passito, di cui i primi due sono ignorati o poco conosciuti dal grande pubblico. Queste tre perle dell’enologia romagnola non figurano nella lista dei ristoranti che vanno per la maggiore ma hanno rappresentato, per secoli, la tradizione del bere nelle famiglie di Bertinoro campagna e nelle osterie. Sono ricordati dall’abate Piolanti nel suo libro di poesie Bacco in Romagna, (1818). La Canina o Canena viene definita prelibata pien di forza e di brio; l’autore precisa che Canina è il nome di una certa uva rossa, che nasce nel Territorio di Ravenna, e che somministra un vino molto generoso e afferma … una sola volta io l’ho assaggiato, e fu alla tavola dell’Emo Gonfalonieri, Arcivescovo amatissimo di quell’illustre città. Nel testo la Canina troverebbe un preciso spazio di consumo giornaliero e risulterebbe addirittura competitiva rispetto ai rossi di collina. E con vaghe rime liete Dico, Evviva …… La Canina prelibata, Di Ravenna, non che quella Uva rossa così grata Che fiammeggia in Brisighella Fan dei vini a parer mio Pien di forza, pien di brio. Egli è il primo, e lo darei Solo a chi si invecchia, e langue; E il secondo lo berrei Dopo pranzo, dopo cena, Quando l’epa avessi piena. Concorrono a formare la Canena, oltre all’uva Canina Nera, marginalmente coltivata in alcune aziende della bassa ravennate e particolarmente in Comune di Russi, anche piccole quantità di altre uve a bacca rossa, tutte appartenenti all’antica tradizione romagnola: Barzamè o Balsamina, Curnacia, Rumanè, Pignolo Nero, Tintorie o Colorini, Ancellotto. Nel 2004 le uve provenienti da quattro poderi di Russi sono state vinificate dalla Cantina sperimentale del CRPV di Tebano. Il vino è stato proposto come una sorta di prenovello, in occasione della Fiera di Russi, con piena soddisfazione degli esperti e dei consumatori presenti, che hanno manifestato grande interesse verso prodotti ad alta valenza territoriale. Il Piolanti si sofferma pure su un altro vino rosso della tradizione romagnola, la Balsamina; egli afferma che la Balsamina è un vino nero fragrante, spiritoso, ed uno de’ migliori di Romagna. Di questo vino loda in particolare il colore vermiglio ed il piacere che si ha bevendolo. È l’onor d’ogni cantina La vermiglia Balsamina … E’ pure il bel piacere Lo starsene in panciolle Accanto ad un bicchiere Con dei fiaschetti, e colle Bottiglie ad ambo i lati Colme di vini sì grati! Loda infine i nostri Vini Passiti (Vin Santo), vanto della vecchia Romagna rurale e contadina. Nella nostra terra, i vari eventi che scandivano l’anno o la vita di campagna erano ancor più solenni se apparivano in tavola le bottiglie di vino buono. Si trattava per lo più di vino passito il quale era oggetto di omaggio in occasione di particolari ricorrenze: benedizione Pasquale, nascite, battesimi, matrimoni e cresime. Nelle vecchie famiglie contadine le massaie raccoglievano le uve da destinare all’appassimento in giornate asciutte e ventilate. Venivano raccolti solo i grappoli migliori, che erano sottoposti ad accurata toelettatura prima di formare penzane (rest d’uva) di otto dieci grappoli da appendere alle travi in locali arieggiati. La famiglia si nutriva degli acini sin verso l’anno nuovo, l’uva che restava veniva pigiata per produrre il famoso Vin Santo, conservato poi in piccoli caratelli anche per più anni. Per la produzione dei passiti della tradizione romagnola sono oggetto di studio antichissimi vitigni quali: Lanzes (vitigno bianco caratterizzato da grandi grappoli con acini spargoli a diversa grandezza), Bertinora (uva bianca con acini medi, a buccia resistente di color giallo), Paradisa (uva bianca con grappoli abbastanza grandi e acini allungati di colore giallo solare), Angela o Anzola (uva bianca che si trova sia in Romagna che nella vicina provincia di Bologna), Verdea (uva bianca presente in diverse province della regione), Gamberina (uva bianca con grappolo spargolo e buccia resistente, recuperata nell’omonimo podere dell’antica possessione Rasponi in S. Giacomo di Russi). Il Piolanti era un grande estimatore del Vino passito o Vin Santo romagnolo e scrive: A decoro, ed a sostegno Della Scienza, e dell’Ingegno… Benedetto quel Vin Santo A me piace così tanto, Così tanto e di quel son ghiotto, Che vorrei da mane a sera Aver sempre pieno il gotto, Ei versato in terso vetro Rassomiglia a un liquid’oro; Sa corregger l’umor tetro 5 Bertinoro Di chi langue nel mortoro; E ci porge al fin l’idea Della vera Panacea. Questo autore è anche un’autentica scoperta in tema di analisi sensoriale dei vini. La percezione analitica dei distinti profumi e sapori di un vino, che si fa risalire in linea di massima al XX secolo, trova in lui un sicuro precursore e, in merito ai profumi dei vini della terra di Romagna, scrive: Questi vini oh! Son pur grati, Han colore Buon sapore, E al cor danno alacrità L’Aquileja, il maro, il Dittame La rosa Malva Il Timo La Magnolia che sì estimo La viola, il Garofano Il Giglio, gli Anemoni, E ogni altra erba, e Fior Non tanta tramandano Fragranza, e odor. In sostanza la filiera enologica romagnola, sia di collina sia di pianura, non ha nulla da invidiare in termini di cultura materiale, di valori gastronomici e di biodiversità dei vitigni a quella di altre zone che si sono avvalse sinora di una maggiore capacità di comunicazione. La competizione del mercato globale stimola oggi ad uscire dalle rigide codificazioni secondo quali i vitigni furono, nel secolo scorso, classificati in autorizzati e non, assecondando criteri che non rispondono alle esigenze del nuovo mondo di consumatori. Ben vengano quindi iniziative volte alla scoperta e alla valorizzazione dei vitigni tipici. Esse testimoniano la crescita di una cultura che pone maggiore attenzione ai valori del territorio e alle iniziative, anche personali, di quanti si impegnano per trovare, nella tipicità e nella qualità territoriale, una forma più moderna ed equilibrata di crescita sostenibile della propria comunità. Francesco Donati LA PARIGI DELLA BELLE EPOQUE BRINDA CON CHAMPAGNE FAENTINO 6 Francesco Baldi, 1898 La produzione vinicola della Romagna e del faentino è conosciuta sin dai tempi romani; meno noto è che accanto ad una produzione tutto sommato di scarsa qualità nel corso dell’Ottocento, i documenti ci testimoniano anche tentativi di innovare la coltura della vite e la produzione vinicola. In particolare antesignani dell’innovazione sono i Laderchi, cospicua famiglia patrizia faentina più nota per la sua continua partecipazione ai moti risorgimentali dal periodo giacobino sino all’unità d’Italia ed oltre. Per quanto riguarda lo champagne, o meglio la produzione di esso, troviamo una lettera scritta nel 1832 dal generale Giuseppe Sercognani, esule a Parigi dopo i moti del 1831/32, all’amico conte Pietro Laderchi che testimonia la curiosità e l’attenzione di quest’ultimo verso i metodi di produzione vinicoli d’oltralpe: “… Vi rinnovo che sull’affare dello champagne sono varie le opinioni sul modo di farlo e vi manderò il manuale se volete …”. Null’altro ci è dato sapere, almeno per ora, su questa curiosità. Ma nel 1896 un altro faentino, Francesco Baldi, nato nel 1865, inventa e produce macchinari per la produzione dello champagne ed inizia la sua produzione nella villa di Sarna, villa presto soprannominata la “Villa dello Champagne”. Nel 1908 alla grande Esposizione Torricelliana di Faenza la sua produzione di champagne vince la medaglia d’Oro, ma quella faentina non è l’unica onorificenza che ottiene poiché merita premi anche nelle esposizioni di Milano, Torino, Roma, Bruxelles, Pietroburgo e Parigi. La produzione della sua azienda, valutata nel 1916 dal sottoprefetto di Faenza fra le 40 e le 50.000 bottiglie all’anno, è prevalentemente esportata in Francia ed in Russia. I suoi dipendenti, solo per la produzione vinicola, sono sempre nel 1916, dieci fissi con punte di trenta nei momenti di maggiore lavoro. Che la sua produzione sia destinata non al consumo locale, ma prevalentemente all’esportazione ci è confermato dalla quasi totale assenza di pubblicità sulla piazza di Faenza Terminata tragicamente la Belle Epoque con la prima guerra mondiale, lo champagne Baldi resta ancora una delle glorie della città di Faenza; in ogni menù dei banchetti ufficiali del Comune negli anni venti, ospiti autorità dello stato o delegazioni stranie- re, lo spumante Baldi (il fascismo sta mettendo al bando le parole straniere) è sempre presente. Sono due le schede informative che possediamo su Francesco Baldi e sulla sua produzione, entrambe redatte dal sottoprefetto in occasione della proposta di nominarlo Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia. L’8 maggio 1916 il sottoprefetto invia all’On. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio la scheda informativa di prammatica su Francesco Baldi fu Giovanni e fu Pasetti Maria, nato il 6 novembre 1865, essa è la seguente: «Da circa 20 anni egli dedica indefessa e intelligente attività alla produzione agricola ed industriale, distinguendosi specialmente in quella del vino. Di sua esclusiva specialità è il“Gran Spumante”, che viene anche in larga misura esportato all’Estero, dove concorse a molte esposizioni con ottimi risultati.» Le informazioni poi non si limitano ai meriti professionali di Baldi, ma ne illustrano anche quelli pubblici: «Fu in passato per circa due anni, Presidente della locale “Associazione fra Commercianti ed Industriali”, disimpegnando lodevolmente tale ufficio. A favore delle opere di assistenza civile e pro militari ha fatto ragguardevoli offerte, dimostrando spirito largamente benefico e patriottico.» e quelli privati: «Il Sig. Baldi Francesco si trova in ottime condizioni economiche e sociali ed è pure di ottima condotta morale e politica e gode di generale estimazione. La concessione della proposta onorificenza cavalleresca, di cui è meritevolissimo, produrrebbe buona impressione nel pubblico.» Un’altra scheda, qualificata come “riservata”, aggiunge ulteriori preziose notizie sulla dimensione e sulla destinazione della sua produzione: «… ha fondato … in frazione di Sarna, di questo Comune, uno stabilimento di produzione di vini spumanti. Lo stabilimento produce dalle 40 alle 50.000 bottiglie all’anno, che vengono per la maggior parte spedite all’Estero specialmente in Francia e in Russia. Il Baldi ottenne, per la sua produzione, medaglie e diplomi nelle principali esposizioni nazionali ed estere, e precisamente in quelle di Milano, Torino, Roma, Bruxelles, Pietroburgo e Parigi. A detto stabilimento sono giornalmente adibiti 10 operai, numero che in determinate epoche dell’anno sale a circa 30. Lo stabilimento è tra i migliori d’Italia, e in esso vennero introdotti i sistemi più moderni …». Per la verità questa scheda differisce, sia pure marginalmente, dall’altra poiché mentre nella prima viene indicato come figlio di Giovanni e nato a Faenza in questa compare come figlio di Antonio e nato a Bologna. In realtà Francesco è figlio di Giacomo ed appartiene ad un ramo della famiglia Baldi tuttora esistente in Faenza. Il padre Giacomo si trasferisce a Bologna dopo il 1860 ed in quella città esercita molteplici attività imprenditoriali. Francesco, stabilitosi invece a Faenza, inizia nelle sue proprietà faentine la produzione vinicola che lo porta presto al vertice della produzione e commercializzazione. Nella sua villa di Sarna, detta Le Fontane, pone il centro commerciale dell’attività e nell’ampio lago artificiale che è presso di essa, lago che comprende due isole, dette con molta fanciullesca fantasia dei Mamelucchi e dei Pirati, studierà in tarda età, vero precursore, l’allevamento delle trote. Unica pubblicità della ditta, che è stata possibile rinvenire, rivolta al mercato locale, è del 1925, ed essa ci informa come alla tradizionale produzione di Gran Spumante Francesco Baldi avesse affiancato anche una produzione di Vermouth. Francesco Baldi morirà tre anni dopo, nel 1928, ed il figlio Giangiacomo, anche per la sua giovane età, dilapiderà l’azienda ed il patrimonio del padre in iniziative industriali sfortunate. Nino Drei Interno Villa Sarna di F. Baldi, 1910. 7 Un autocarro esce dalla Cantina Baldi. Villa Sarna, 1900 ca. “Rinnovato hanno verga d’avellano” 8 Questa luna piena, fresca d’equinozio, che pesa sulle capriate del Cielo come un destino, nella notte ancora gelida che reca su ali invisibili i prodromi della Primavera appena nata, rimanda alla memoria di una pasqua pagana, nel senso pedissequamente letterario del termine, col valore semantico di: passo, salto, fretta, nel senso di una partenza incombente. Una pasqua pre-israelita, di un popolo che vive del gregge e che ha ormai esaurito le erbe secche del bassopiano e deve raggiungere i pascoli alti dove le piogge primaverili tingeranno di un verde novello i declivi montani. Il vagito dell’anno nuovo lunare si perde nell’affanno dei preparativi e la luce fredda del plenilunio amalgama le forme frettolose intente alla cottura e cena dell’ agnello come viatico propiziatorio per il viaggio lungo e tormentato verso i monti. È la festa di Jahvè della quale Mosè chiedeva umilmente al faraone il permesso di celebrazione. Quell’ agnello che assicurava la salute e la fecondità del gregge sarà poi il Cristo immolato per la salvezza di un gregge fatto di uomini. Pasqua come PESACH , festa della “transumanza”. Dal latino “transeo” e “humus” ovvero: “andare attraverso le terre”, (alla ricerca del pascolo). Questa forma di allevamento primordiale generava il nomadismo degli antichi popoli allevatori. Le tribù seguono gli animali e così vengono tracciate dagli stessi le antiche vie, che saranno poi quelle degli uomini. Ha origine “il viaggio” col suo fascino di incognite, viaggio come metafora della vita. Questa forma di allevamento ha attraversato tutte le civiltà in ogni latitudine e si trova ancora abbastanza frequentemente nelle regioni del Mediterraneo in cui le estati calde e secche non forniscono erbe sufficienti a nutrire un certo quantitativo di bestiame. Conseguentemente gli animali, soprattutto gli ovini,vengono condotti d’inverno nei bassopiani e d’estate sui monti Oggi le greggi vengono trasferite con comodi automezzi, ma fino ai tempi recenti del dopoguerra, anche nell’Appennino tosco romagnolo venivano “transumate” attraverso particolari vie dette “tratturi”, larghe anche un centinaio di metri che portavano prevalentemente nel versante tirrenico, in Maremma e in minor misura nelle terre di bonifica dell’Adriatico, fra Ravenna e Comacchio. Ogni podere mandava un pastore col proprio gregge ma questi dipendeva da un “capo vergaio”, condottiero e responsabile di tutte le greggi , sorvegliava che le cose andassero per il giusto verso e ne aveva mandato da tutti i proprietari di una zona.. “Vergaio” perchè si muniva di un grosso bastone, sulla cima del quale, spesso, era innestato il corno ricurvo. Ma l’interessante era che questo bastone fungeva da rubrica nel senso letterario del termine. Essendo queste persone analfabete incidevano sulla corteccia registrando con segni particolari il tempo trascorso, cadenzato dalle fasi lunari, le spese sostenute durante il viaggio, le nascite degli agnelli, la morte incidentale delle pecore, il pagamento delle “fide”, cioè le tasse di soggiorno del gregge nei “paschi”. La prima banca, forse del mondo, è il Monte Dei Paschi di Siena, che ha origine dall’amministrazione delle terre maremmane destinate ai pascoli. La verga, al ritorno del vergaio, veniva consegnata agli amministratori per la registrazione nei libri contabili delle fattorie committenti. Nella conosciutissima poesia “I pastori”, D’Annunzio non mette casualmente alla fine della seconda strofa, quasi come un’appendice: Rinnovato hanno “verga d’avellano”. Ogni commentatore licenzia questa frase più o meno così: per aiutarsi nel cammino, si muniscono di un bastone di nocciolo… Il poeta, a mio modesto parere, vuole rimarcare l’importanza del gesto, come a sottolineare l’inizio di una nuova avventura e l’assunzione piena della responsabilità di cui renderà conto incidendo la verga. Imola 22-03-05 Emilio Prantoni Bastone o verga Pastorale di area alpina (Vista alla Fiera di Parma nel 2004) Legenda dall’alto: corno di ariete, boccaglio per suonare, legatura con tendini, incisioni per fasi lunari e segni per appunti vari, puntone in ferro. Legno di bambù altezza 2 m. circa 9 Maria Ponti Pasolini e la diffusione di una cultura sociale in Romagna 10 Le scuole professionali, quelle di arti e mestieri, la biblioteca popolare, così come l’assistenza sanitaria, le previdenze per i lavoratori e i nullatenenti, tutto il complesso dei servizi sociali e culturali, nascono alla fine dell’Ottocento e primi anni del Novecento, in realtà o sotto il segno dell’iniziativa privata, con tutti i caratteri in positivo e in negativo che questa comporta, o per la spinta solidaristica delle associazioni operaie e bracciantili. Non poche sono le incertezze della ricerca sia nel metodo della ricostruzione storica sia nell’esattezza delle informazioni, quando si prenda in esame una biblioteca popolare, circolante o settoriale, destinata ad un pubblico da inventare, i cui atti, caso molto frequente, siano stati in gran parte distrutti, il cui nucleo librario costitutivo sia stato smembrato e disperse, o mai esistite, quelle preziose documentazioni offerte dal registro dei prestiti, dal registro degli acquisti, dal movimento delle letture, elementi tutti che permettono a quelle poche minori biblioteche che li posseggono di divenire specchio di una realtà sociale e culturale. Verbali, registri, relazioni morali, come allora si chiamavano i consuntivi sull’attività svolta, non esistono per la Biblioteca Storica «Andrea Ponti» di Ravenna, che, fondata nel 1897, passata all’amministrazione comunale nel 1935, più volte soggetta a traslochi e sistemazioni, guardata con sufficienza dalla prestigiosa e dotta Classense, può essere assunta come tipico esempio di una vita bibliotecaria nella quale si riversano e si riflettono gli umori di una società locale ancora incapace di separare gli stimoli culturali nuovi dai tradizionali, e di uscire dai consueti canali di trasmissione e formazione della cultura. La Biblioteca Ponti di Ravenna nacque per «porgere alle giovani che amano lo studio un mezzo facile di lettura utile, dilettevole ed ordinata» e non era né provinciale, né popolare ai suoi inizi, e forse proprio per questo soffrì per molti anni di un oblio che si tradusse in una progressiva perdita di identità. In seguito per i ritardi culturali e politici nell’impostare il servizio di lettura in Italia, subì tutti gli stravolgimenti possibili, compresi quelli suggeriti dal gusto più corrivo di un pubblico femminile che negli anni Trenta affidò alle esili trame del romanzo rosa i sogni di un suo riscatto dalla piatta quotidianità. L’apertura della biblioteca «Ponti» avvenne il 21 ottobre 1897 per iniziativa della contessa Maria Pasolini Ponti, personaggio di rilievo nell’ambiente ravennate, ma su questo avvenimento la stampa locale, sempre minuziosa nell’informazione dei fatti di cronaca cittadina e nel citare la presenza della contessa Pasolini, tace. L’unica spiegazione possibile di questo silenzio non può essere che la «nascita» di una biblioteca va comunicata a pochi addetti ai lavori. L’ipotesi formulata è confortata dal fatto che la lettera con la quale la Pasolini dava notizia della biblioteca e dei criteri informatori e inviava i primi due cataloghi tematici di libri, è del marzo 1898. Non abbiamo trovato documentazione su quale riscontro abbia avuto la sua lettera d’«intenti», quali persone abbiano risposto contribuendo fattivamente alla cre- scita dell’istituzione; ma una adesione deve esserci stata, anche se l’iniziativa partiva dalla volontà di un singolo, del tutto fuori, quindi, da quei circoli o nuclei di aggregazione che di solito stanno alla base di eventi culturali. Per questo diventa per noi necessario, ai fini di una migliore conoscenza dei caratteri della biblioteca, dare un volto alla sua fondatrice, figura non secondaria nel mondo culturale femminile tra Otto e Novecento. Alla formazione di Maria Pasolini Ponti (Varese,1857-Roma 1938) che a sedici anni sposò il conte Pier Desiderio Pasolini dall’Onda e che il Pareto chiamava, non sempre scherzosamente “leonessa” per il suo spirito battagliero, contribuirono due culture e due esperienze sociali, quella familiare, lombarda, proiettata verso le forme del capitalismo moderno, e quella della famiglia di acquisto, romagnola, che l’antica tradizione legava da un lato alla proprietà terriera, dall’altro a studi di erudizione. È infatti figlia di quell’Andrea Ponti, industriale gallaratese che ben si inserisce nella schiera dei giovani industriali del nord Italia, sui quali si è aperta una indagine approfondita, utile per giungere a decifrare la nascente industria italiana, il suo rapporto col potere politico, con la finanza, col mondo del lavoro. È in questo periodo che la nuova classe imprenditoriale acquista coscienza dei propri poteri ed è pronta a introdurre, nell’organizzazione del lavoro, quegli elementi sconosciuti al padronato agrario che contribuiranno alla costruzione della sua forza, ma anche alla formazione di una classe operaia più agguerrita e preparata allo scontro. Imbevuta di letture e di ideologie inglesi e americane, di un neo-illuminismo che pone al centro del suo interesse la ragione, l’individuo e l’etica, quasi religiosa, del lavoro, la classe industriale italiana è convinta di poter gestire in prima persona, senza legislazioni speciali o interventi statuali, il rapporto con la classe operaia. L’assenza dell’iniziativa pubblica in questo campo favorisce ampi spazi all’iniziativa individuale: da qui la fondazione di casse di previdenza per gli operai del proprio stabilimento, fondi di assicurazione contro gli infortuni, magazzini cooperativi, scuole di formazione tecnica, asili infantili e soggiorni marini per i figli delle operaie, sovvenzioni a istituti culturali. A questa politica della classe imprenditoriale del Nord fa riscontro un’altrettanto vivace politica delle leghe operaie e delle associazioni dei lavoratori in un panorama italiano estremamente diseguale e carico di contraddizioni e di scompensi. La famiglia Ponti si distinse nel gallaratese per una molteplicità di iniziative, e dovette essere tra quelle poche che non teorizzarono troppo, né troppo pesantemente questo tipo di gestione. Da questa famiglia lombarda, da questi esempi di attivismo quasi insonne, viene a Ravenna Maria Ponti, a contatto quindi con una realtà sociale ed economica totalmente diversa, che sembra seguire i tempi e i ritmi più lenti ed immutabili della natura e della produzione agricola, anche se la famiglia Faenza, 1900, uscita dal Ginnasio. Pasolini si distingue per una conduzione agricola più avanzata ed accorta. Passata dall’Istituto di educazione femminile di Poggio Imperiale al matrimonio, a soli sedici anni, la giovane contessa Pasolini dovette percorrere un serio apprendistato per scoprire e coltivare quel vivo interesse per i problemi sociali ed economici, quell’attenzione e quel gusto per gli studi concreti, di documentazione, di analisi statistica che troveremo nei suoi primi saggi. Certo contribuirono ad arricchire una intelligenza non comune la tradizione di studi della famiglia Pasolini, la vita divisa tra Ravenna e Roma (più Roma che Ravenna), l’incontro e l’amicizia con le più importanti figure del mondo politico, letterario e artistico, ospiti abituali della sua casa romana, i viaggi. La predilezione per gli studi sociali, politico-economici, alimentata e nutrita dalla frequentazione con personalità come Bodio, Bonghi, Pantaleoni, Fortunato, Villari, De Viti De Marco, Franchetti la porta a pubblicare nel 1890 uno studio-inchiesta che giustamente viene citato come una delle fonti affidabili, ogni qual volta si tratti del problema mezzadrile in Romagna. E inoltre citiamo il saggio Una famiglia di mezzadri romagnoli nel comune di Ravenna che uscì nel «Giornale degli Economisti». Nel 1892 esce Monografie di alcuni operai braccianti del comune di Ravenna, anch’essa, come la prima ricerca, corredata di dati relativi alle entrate e alle uscite delle famiglie prese in esame, alla tipologia del lavoro, al rapporto tra bilancio di una famiglia ed eventi imprevisti o casuali, quali una malattia, un infortunio, un’annata infausta, che allora avevano veramente il potere di portare al dissesto un nucleo familiare, quando non ne trasformavano completamente lo stato sociale riportandolo alla drammatica condizione di indigenti. Nel 1901 pubblica il libretto Il nostro bilancio nel quale cerca di offrire uno strumento di divulgazione sui mezzi che i cittadini hanno per conoscere la politica governativa: «saper leggere il bilancio di uno Stato- scrive nell’introduzione significa mettersi in grado di apprezzare l’effetto uti— le delle varie forme d’impiego del denaro pubblico». Un liberalismo illuminato, aperto, avido di conoscere e di confrontarsi, di misurarsi con altre realtà, può essere preso come sigla di questa donna singolare, volitiva, autonoma nelle scelte e nei giudizi, sostenitrice dei primi movimenti femminili italiani, pur con quell’equilibrio e quella misura che la classe d’appartenenza le imponeva. La permanenza a Roma e il contatto con tante personalità di così varia formazione culturale, i viaggi all’estero, ma anche quell’osservatorio romagnolo-emiliano, dal quale non si sente mai staccata, allargano i suoi campi di conoscenza, le sue curiosità intellettuali, alimentano le sue letture. Citiamo, di grande interesse, il dibattito sul patrimonio artistico, i suoi interventi per la tutela e la maggiore conoscenza dei beni culturali, sulla necessaria continuità di certe tradizioni artigianali, sull’arte industriale, sui giardini, sull’architettura minore. Questa ultima fortissima passione la porterà a raccogliere una documentazione fotografica eccezionale sull’architettura minore del Lazio e di Roma. Ma la «lettura» della raccolta bibliotecaria non è momento secondario per una piena comprensione della persona e del periodo storico. L’idea che la biblioteca popolare, circolante, di prestito, fosse strumento di educazione e di «elevamento» per quanti non avevano la possibilità di continuare gli studi né di acquistare libri, è molto diffusa nell’Europa dei lumi, ma in Italia si estende notevolmente solo nel XIX secolo. Tra le carte degli archivi di Società di mutuo soccorso, di cooperative, di circoli culturali, di «gabinetti di lettura» non è difficile trovare vecchi elenchi, regolamenti di biblioteche popolari, destinate la maggior parte a deperire e disperdersi nel breve volgere di anni; alle più tenaci pensò il fascismo a circoscriverne il campo d’azione, senza però poter impedire che una circolazione libraria avvenisse tramite biblioteche circolanti private. La necessità di creare quella coscienza nazionale unitaria, che non fu dato acquisito come certa letteratura risorgimentale ha voluto far credere, portava a vedere nella scuola e nella biblioteca i momenti indiscussi di formazione e di coagulo di un popolo che si inseriva nel contesto europeo con tante storie particolari alle spalle. I modi con cui fu condotta la politica scolastica e quella bibliotecaria ci fanno dubitare delle capacità legislative e amministrative dei governi, ma la retorica, di più facile e immediata presa, suppliva le deficienze organizzative e copriva i lamenti, molti in verità e di non lieve peso, degli addetti ai lavori. Sotto i panneggiamenti liberty della Terza Italia resistevano le microstorie delle regioni italiane, con una tradizione culturale mai sufficientemente valutata, che all’interno delle prestigiose e mal curate biblioteche ricucivano i fili del loro passato riconducendoli alla maggior gloria della giovane nazione. Sulla priorità da dare al problema della istruzione, della lettura, della preparazione tecnico-professionale sembravano tutti d’accordo, uomini politici, letterati, studiosi, ma lo stato della situazione, registrabile anche solo attraverso i dibattiti parlamentari, ci fa pensare che le loro petizioni rimanessero solo di principio, mentre le soluzioni erano spesso tali da dar fiato alla aperta opposizione della Chiesa e dei suoi organi di stampa come la “Civiltà Cattolica”. G.F.F. 11 Baldini, il suo dialetto passaporto per il mondo 12 Chi domani vorrà capire qualcosa dei nostri anni convulsi, è anche ai versi di Raffaello Baldini che dovrà rivolgersi. I suoi libri sono infatti gremiti dei fantasmi dell’uomo contemporaneo, a cominciare dal contrasto tra il bisogno di appaesamento, di radicarsi e di riconoscersi in una realtà identificata, e all’opposto la coscienza della sua impossibilità. Forse proprio per questo Baldini aveva scelto di scrivere in dialetto, un romagnolo difficile, ma originalissimo, che lo apparenta alla cosiddetta Scuola di Santarcangelo, a Guerra, a Pedretti, a Fucci, grazie ai quali il piccolo centro del riminese si è conquistato un posto nella geografia letteraria del Novecento. Il paese di Baldini ci riporta a un piccolo mondo provinciale. Senonché il dilagare anche lì della nevrosi e di tutti i mali del nostro tempo ci dice che i mulini bianchi esistono solo nella pubblicità. Come tutti i grandi dialettali, Baldini fa sfilare davanti ai nostri occhi una galleria di personaggi. Per un suo irriducibile pudore, ma anche assecondando un carattere tipico del proprio strumento, a dire io nelle sue poesie non è una figura riconducibile al profilo psicologico del poeta, ma una serie di individui che trascinano le loro esistenze tra senso di colpa e assurdo, tra Kafka e Beckett. Non c’è la voce, ma il coro. E sono loro, i nevrotici, gli strambi, gli sconfitti, ma anche gli eroi di una spenta quotidianità, a comporre gli interminabili monologhi, che registrati con oltranza mimetica e con una forte sottolineatura drammaturgica, tracciano l’immagine della solitudine contemporanea. Non per nulla la sua raccolta di esordio, uscita nel 1976 «a spese dell’autore», come elegantemente chiosava Baldini, si intitolava E’ solitèri, «il solitario», con intenzionale ambiguità tra il gioco di carte e la condizione esistenziale. Tutti i personaggi di Baldini invocano un interlocutore, ma nessuno riceverà una risposta: «u n’arspònd mai niseun», «non risponde mai nessuno», scrive nella poesia che apre Ciacri (Chiacchiere»), apparso da Einaudi nel 2000. Continueranno fino alla fine ad avvilupparsi nel garbuglio dei loro discorsi, che li imprigionano in una ripetizione senza scampo. Questo mettere l’estraneità proprio all’interno del paese, che è invece il luogo topico del riconoscimento, costituisce uno deg1i aspetti più crudeli della poesia di Baldini. Non stupisce allora che, rompendo con il mito novecentesco della lingua primigenia, materna, pura e vicina alle cose, anche il dialetto impiegato fotografi perfettamente quello usato dai parlanti. Mentre il poeta novecentesco, cresciuto alla scuola dei simbolisti, ha creduto di superare l’insensatezza del vivere accedendo al mistico regno delle madri, Baldini ha creduto invece che proprio in quell’insensatezza stesse la verità. Con il procedere delle raccolte, il suo romagnolo appare sempre più gravemente interferito dall’italiano regionale, ricco di calchi, di scorie della pubblicità, di voci del mondo dello spettacolo, di espressioni prelevate dalle lingue straniere. Non è proprio un caso che la sua ultima raccolta, uscita ancora da Einaudi nel 2003, si intitoli Intercity. Insomma non la lingua che più non si sa di pascoliana memoria, ma quella che effettivamente si parla, anzi che si chiacchiera ogni giorno, resa con impressionanti effetti di iperrealismo. Siamo insomma nel solco della più accreditata tradizione comicorealistica dei Porta, dei Belli, dei Tessa, a dimostrazione che anche le vie della poesia sono davvero infinite. Perfettamente coerente con questo diagramma la scelta della narratività. Baldini amava la misura del poemetto, ma anche nei suoi fulminei testi composti solo di tre quattro versi, a delinearsi erano sempre frammenti di storie. Né deve stupire l’approdo di Baldini al teatro. Con la surreale fantasia che era sua, negli ultimi anni aveva saputo dare un’attuazione scenica al franare dei suoi versi componendo alcuni monologhi mirabilmente interpretati da Ivano Marescotti. E tutta teatrale è stata la straordinaria esecuzione che delle sue poesie egli forniva, quelle poesie che con insistito understatement si ostinava a definire «versi». Quando leggeva i suoi testi, l’individuo discreto e riservato che Baldini era, lasciava il posto a un personaggio inaspettatamente istrionesco, che si lanciava nei suoi spericolati monologhi con travolgente velocità, suscitando l’ilarità generale. Era il suo modo di farci sentire quanto l’oralità premesse dietro la pagina scritta, Raffaello Baldini restituendo il dialetto al suo contesto più naturale. Alcuni mesi fa gli amici si erano riuniti a Santarcangelo per festeggiare i suoi ottant’anni. C’erano Beccaria, Isella, Mengaldo, la critica più attenta, una volta di più persuasa che, a dispetto del pregiudizio dialettale, Baldini è stato il poeta italiano più importante a cavallo del millennio. Dal Corriere della Sera del 30 marzo 2005 Franco Brevini Brótt Amo i brótt, ènca mè a séra póch bèl, però pu si an, ch’l’avrébb da és pézz, invìci, t’arvén, dabòn, mé a m so ènca inamurè. Brutto. E be’ sai, i brutti, anch’io ero poco bello/ Però poi con gli anni, che dovrebbe essere peggio, invece/ cambi in meglio, davvero, io mi sono anche innamorato. Santarcangelo, via delle Osterie dove si declamano poesie. Il Bianco mangiare da “La buona cucina del latte “ di Graziano Pozzetto La cucina con il latte nasceva dalla stalla, e a mano a mano che se ne allontanava, ricorrendo allo zucchero e alle spezie, si conformava ad un modello cromatico. Fra i piatti beneamati nei banchetti sono quelli in cui domina il bianco ottenuto con i più sottili artifici. Ingrediente d’elezione è il latte che deve essere “bianchissimo e chiaro che non abbia ne colore che tiri al citrino, ne al rosso, ne al livido “25”, materia prima di tutte le creme e mezzo di cottura delicato, per ravioli, tortelli, lasagne e gnocchi, conditi con formaggio. Il bianco latte serve quindi da termine di confronto a tutte le possibili imitazioni, agli ingredienti che gli assomigliano o le eguagliano. Lo troviamo nel bianco mangiare, presente in tutti i ricettari europei dal XIV secolo al XX secolo, e riproposto da Pellegrino Artusi fra i dolci al cucchiaio. Ha la peculiarità di essere una vivanda monocroma e composita, riunendo a piacere: farina di riso, amido, mollica, mandorle, petti di cappone (oppure pesce quaresimale), burro, chiare d’uova, pinoli, zucchero, acqua di rose e coetera. Lo Scappi ne suggerisce due formule con latte di capra e ne precisa l’esito: “quando esso bianco magnare sarà come il nome mostra che ha da essere, candido, & lustro, & corrispondente il gusto alla bellezza, si potrà servire caldo o freddo a beneplacito con il zuccaro sopra “ Il risultato dipendeva dalla pulizia dei cuochi, da una perfetta amalgama degli ingredienti polverizzati in mortaio di marmo, da una cottura sulle braci lenta in cui la poltiglia, rimescolata con pazienza, non attaccava né bruciava, evitando di ricevere qualsivoglia crosticina scura o sbavatura rossiccia. Era un minestra assai richiesta, che lo Scappi insegna a preparare al volo (Per far minestra di bianco magnare all’improvista), con pochi ingredienti, latte, zucchero, grasso di rognone, sale ed acqua di rose. Due belle poesie romagnole di Ubaldo Galli di Castel Bolognese INCUMPIUDA La stèla de’ buver la s’guerda intoren smarida, che l’à pers la cumpagnèia, al su surèli agli è za andedi vèia, al lassa pòst a e dè che ven so zoven. L’è armasta da par lì la buvarèna, int l’èiba ròsa e sponta la matèna. L’arlus i mont, al fòma in bass al vall, vialà, vialà luntan e canta un gall. CANZONETTA Senio che scendi a Castelbolognese / fiume dall’acqua cristallina e cheta, / tu sei il fiume del mio paese / e solo per te son diventato poeta. / Il fiume corre a valle / e si snoda come un serpente / fra tutte le canne / quando c’è sussurrar di vento / Bagna città e paesi, / campagne e monti scoscesi, / fin che arriva al mare / dove, sul lido marino, termina il suo lungo viaggio, / e l’acqua , nel suo cammino, / sposa l’acqua del mare. / Ubaldo Galli INCOMPIUTA La stella del bovaro si guarda intorno smarrita, perché ha perduto la compagnia; le sue sorelle sono già andate via, lasciano posto al dì che vien su giovane. Sola è rimasta lì la bovarina, nell’alba rosa spunta la mattina. Rilucono i monti, fumano in basso le valli, qua e là lontano canta un gallo. CANZONETA O Sèni che t’ven zò a Castèlbulgnès fiom da l’acva cristalèna e chièta, te t’si e fiòm dè mi paes, e sol par te a so dvinte pueta. E fiòm e corr a val e us snoda cmè un sarpènt, stamèz a toti al cann cum che sburdèla e vènt. E bagna zitè e pais, campagn e mont a dvèr, int’e su ande dizis, fèna ch’l’ariva a e mer, dov, in t’e sabiòn marèn, e finèss e su long viazèr, e l’acva, int è su camèn, la sposa l’acva de mer. 1905 - 1996 Ubaldo ad un simposio poetico. 13 I “forti nuotatori” imolesi 14 Non ricordo i particolari, ovvero il nome esatto della società sportiva, né l’anno di questi avvenimenti, ma il fatto sì, perché mi fu raccontato di persona dal prof. Romano Rotelli tanti anni fa ed è troppo bello per essere dimenticato. Mettiamo che la società sportiva imolese si chiamasse “Sempre Avanti” e che i fatti si siano svolti negli anni del secolo scorso dal 1920 al 1930. La “Sempre Avanti” era una società sportiva composta prevalentemente di ginnasti e di ciclisti che si era ben affermata nel panorama sportivo di quegli anni a livello regionale e vantava una certa fama meritata. Ne facevano parte, in prevalenza, la piccola e media borghesia che nella città erano di idee progressiste, ovvero di tendenza repubblicana e socialista. Anche le discipline sportive risentivano delle idee politiche per cui in un primo tempo il ciclismo venne osteggiato come manifestazione borghese poi accolto, ma subito i praticanti si divisero in due squadre: i ciclisti bianchi e quelli rossi, questi ultimi impegnati anche nei trasferimenti per i comizi. La società sportiva imolese, che non possedeva impianti sportivi, eccelleva nella ginnastica artistica e nella lotta grecoromana, ma in alcuni sport era completamente assente. Uno di questi sport era il nuoto in quanto non esisteva una piscina o un laghetto dove praticarlo. Non dimentichiamo che la villeggiatura al mare o ai laghi era riservata solo alle classi molto abbienti che potevano frequentare quei luoghi, il popolo e anche la piccola borghesia ne venivano esclusi. I bagni erano possibili solo al fiume e nel canale dei molini, corsi d’acqua imolesi che erano praticabili solo in estate ed il primo, per di più, aveva borri e gorghi che lo rendevano molto pericoloso tanto che ogni anno le cronache denunciavano un certo numero di annegati. Chi era capace di nuotare o magari di stare semplicemente a galla, era un esigua minoranza ed era invidiato dalla rispettiva maggioranza. Il prof. Rotelli, all’epoca dei fatti, era un giovane della piccola borghesia che avendo frequentato le scuole superiori era amico e compagno di altri giovani, pochi, che ugualmente le avevano frequentate, ma provenivano dalla nobiltà o alta borghesia imolese. Allora Imola era la città dei “cento orti fecondi” come ebbe a scrivere il poeta Luigi Orsini, e questa sua caratteristica dipendeva dal canale dei molini il cui corso circondava la città e permetteva l‘irrigazione degli orti e la grande produzione di ortaggi e frutta. Fu appunto un compagno di scuola del nostro, figlio di un nobile proprietario terriero, che discorrendo col primo di sport gli confidò la notizia di avere scoperto un “grande atleta”, figlio dell’ortolano, che lui aveva visto nuotare, nel tratto di canale che lambiva il suo orto, con grandi bracciate, a grande velocità. I nostri, umili gregari iscritti alla società sportiva imolese, pensarono così di ottenere qualche foglia di gloria improvvisandosi “presidenti” e “mister” di una sezione “nuoto” della stessa alla quale avrebbero iscritto la “scoperta” ovvero il nuotatore figlio dell’ortolano. Facilissimo l’ingaggio, facile ottenere il consenso della società con una dimostrazione natatoria ai gruppi atletici che avevano affollato le rive del canale ed avevano potuto apprezzare le capacità del soggetto proposto.. In breve, venne il tempo dei campionati provinciali e la “Sempre Avanti”, che negli anni precedenti si era ben piazzata, si iscrisse a Bologna inserendo anche la nuova, non comune disciplina: il nuoto. Il trasferimento degli atleti a Bologna allora avveniva con il treno e quella domenica il treno ebbe un guasto tanto da accumulare un ritardo di un’ora solo nel tratto Imola Bologna per cui gli imolesi giunsero, dove si svolgevano, a campionati stessi già conclusi. Ma gli atleti erano ben conosciuti e stimati per gli ottimi piazzamenti nelle precedenti edizioni, per cui gli organizzatori dei campionati non se la sentirono di privare gli spettatori delle esibizioni degli imolesi e giustificando il ritardo dovuto a forza maggiore, ma non potendo rifare le gare già effettuate, annunciarono una esibizione dei “forti atleti” della provincia. Chi mi ha raccontato il fatto non ricordava se l’esibizione del nuoto fosse avvenuta in una piscina vera e propria o in un laghetto adattato, fatto sta che oltre al nuoto vi avevano effettuato anche le gare di tuffo dal trampolino e pertanto la profondità dell’acqua era molto superiore alla statura umana. Fu così che il “forte nuotatore” della società imolese si esibì: buttatosi in acqua, arrancò alcune bracciate poi affondò come un sasso; solo l’intervento di alcuni veri nuotatori bolognesi lo salvò dall’annegamento, ma non dal tumulto dei fischi. Si scoprì così che nel canale imolese l’ortolano, che era di alta statura, non nuotava ma correva con ampie falcate delle gambe! Gian Franco Fontana Sulla viabilità romagnola È noto: le tre Province romagnole (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) guidano da tempo la graduatoria nazionale degli incidenti stradali ed è ormai del tutto pacifico che ciò dipende prevalentemente dalla viabilità del nostro territorio. Vecchissima e del tutto inadeguata al traffico ed alle comunicazioni. All’interno di tale realtà, si caratterizzano, in senso ulteriormente negativo, le situazioni dei comuni di Forlì e Cesena, con popolazione a ridosso dei centomila abitanti ma ancora mancanti di adeguate circonvallazioni. In data 14 marzo “Il Sole-24 Ore” ha pubblicato la graduatoria delle Province italiane i cui titolari di patenti di guida hanno percentualmente perduto più punti a seguito, ovviamente, di irregolarità nella circolazione stradale. Guida la classifica la Provincia di Ravenna con 430 punti detratti per ogni mille abitanti maggiorenni. Segue, in terza posizione, Forlì-Cesena con 350 punti, mentre Rimini è al 13° posto a quota 307. La media romagnola è, dunque, di 362 punti rispetto ai 225 nazionali e ciò, di fronte alle sei Province emiliane da 288. Esattamente 74 unità, in meno. Pubblichiamo questi numeri per evidenziare la realtà di estremo disagio viario, dal momento che ci sentiamo di escludere ogni vocazione romagnola a guidare irresponsabilmente e ad incorrere in pesanti sanzioni . Sottoponiamo le considerazioni di cui sopra al Presidente della Giunta regionale emiliano-romagnola Vasco Errani anche perchè siamo il territorio balneare turistico più importante d’Europa. Stefano Servadei Il baco da seta o Bombice In Italia e anche in Emilia Romagna, vi sono notizie dell’allevamento del baco da seta gia nel 13° secolo, ricavate da documenti riguardanti piantagioni “al piantè” di gelsi le cui foglie costituiscono l’unico alimento del baco. Ai quei tempi, la Chiesa diede dei patroni a questi laboriosi bruchi, nei santi San Giobbe e San Marco. L’allevamento del baco da seta ebbe, in passato, una grande importanza economica. Per le famiglie meno abbienti, esso era una delle poche possibilità per alleviare la miseria della vita contadina del tempo. Era tale il risultato economico di questi allevamenti che, non essendovi una cultura e una comunicazione come oggi, fiorirono molti proverbi che sopperivano, almeno in parte, alle mancanze descritte: “L’animel zintil zintil e ven a e mond e mès d’abril, e mè d’abril l’è de scomd, in nòv mis e ven a e mond”. Questo proverbio o indovinello romagnolo, ne racchiude in poche parole l’intero ciclo della vita. Si dice che all’inizio del 20° secolo, l’ottanta per cento delle famiglie presenti nel territorio, contadini, braccianti, artigiani, avessero in casa bachi da seta. Se nelle famiglie contadine, il vitto era assicurato dal grano, dal maiale e dagli animali da cortile, se i tessuti in gran parte erano forniti dalla lavorazione della canapa, con la vendita dei bozzoli “bozal” al mercato della seta, che si svolgeva nel mese di giugno, entravano in casa i primi denari di quell’anno, in contanti. La stagione del baco, detto comunemente “filugello o cavaliere”, iniziava in aprile, seguendo il proverbio secondo il quale per “Sa Merch e’ bigat o l’è post o l’è ned”. La famiglia contadina, riceveva dal fattore un’oncia di uova, oppure una misura detta “ditale”, (ognuno ne conteneva qualche migliaio) assieme a mille raccomandazioni. L’incubazione avveniva con tutte le precauzioni possibili: infatti per fare schiudere le uova, le massaie le avvolgevano in un panno caldo e le tenevano in seno (all’epoca molto prosperoso) per circa una settimana. Un altro proverbio romagnolo recitava “Par sa Zòrz d’è spnacc, s’t’a n’è pòn e’ cavalir e’ dventa mat” ( per San Giorgio dal pennacchio, se non lo poni il baco diventa matto – cioè va a male). Il pericolo che preoccupava maggiormente gli allevatori di bachi, era il malocchio. Dalla schiusa delle uova, alla raccolta dei preziosi bozzoli, era un susseguirsi di pratiche magiche per evitare il malocchio. La più comune era quella di bruciare nelle bigattiere, a scopo propiziatorio, i carboni residui del ceppo di Natale, del Sabato Santo, della notte di San Giovanni o di San Lorenzo. Per fare in modo che le uova si schiudessero regolarmente, le pettorute massaie le portavano in processione il giorno di San Marco, o alla Messa della Domenica delle Palme. Dalla fine di aprile, fino a meta giugno, la famiglia allevatrice era sottoposta ad un intenso lavoro, perché i bachi richiedevano cure assidue e altrettante attenzioni. I bachi venivano sistemati su intelaiature voluminose, “i bez”, al piano superiore della casa, nelle camere da letto e nei magazzini per evitare l’umidità. In questo modo però le famiglie dovevano dormire nella stalla, “int la stala”, nel capanno, “int e’ capan”, o anche nel pagliaio opportunamente adattato. Per incubare le uova, la donna anziana della casa provvedeva che si mantenessero ad una temperatura media di 25 gradi avvolgendole in una pezzuola (la guipadina) e ponendole, di giorno, sul proseno, fra la sottoveste e il busto, di notte nel letto sotto il cuscino dei piedi. Dopo circa cinque o sei giorni di incubazione, le uova cominciavano a schiudersi. Sopra i bacolini neonati, veniva posto un foglio di carta paglia “cherta zala”, forata con tanti forellini del diametro di circa un millimetro. Sopra la carta viene posta della foglia di gelso “foja d’mor” finemente tritata. Le piccole larve, attratte dall’odore della foglia, cominciano a salire attraverso i fori, iniziando a mangiare voracemente la foglia tritata. Quando tutti i piccoli bachi erano saliti sopra la carta, questa veniva trasferita su un setaccio “sdaz)” e continuamente alimentati con altra foglia fresca. Appena le uova erano schiuse, iniziavano i riti all’interno della bigattiera, luogo nel quale solo le persone deputate potevano entrare. In questo luogo non si doveva fare rumore, né dire che i bachi erano belli e grassi (in Romagna esisteva il detto che “Se u s’vò che i bighèt i vegna bèn, bisogna mandèj d’j’ azzidènt” = se vuoi che i bigatti vadano bene, bisogna mandare loro degli accidenti.) La raccolta delle foglie di gelso era demandata agli uomini, che se anche non avevano problemi, ché dei gelsi ce n’era in abbondanza, si lamentavano perché “i magna dla grosa”. Durante il suo sviluppo della durata di circa tre giorni, il baco aumenta le sue dimensioni di circa ottomila volte; per fare questo, il baco cambia pelle “muta” per almeno quattro volte. Durante la crescita, vengono trasferiti sui graticci “i garzu” del bazzo. Per allevare un’oncia e mezzo di bigatti occorrevano almeno 15 quintali di foglia di gelso. Al termine del ciclo e dopo la formazione del bozzolo gli allevatori non aspettavano la trasformazione del baco in farfalla, che avveniva forando il bozzolo, ma immergevano in acqua calda quando questi avevano raggiunto una buona compattezza e durezza; in questo modo il baco moriva e non forava il bozzolo compromettendolo. Sistemati poi in cesti foderati di tessuto candido di bucato perché facessero bella figura al mercato, gli uomini li caricavano sulla “spalona” e portavano i bozzoli in piazza. Generalmente il mercato si svolgeva sotto i portici della piazza centrale “è pavaiò” della città e durava dai venti ai venticinque giorni. Al mercato si recavano sia le donne che avevano curato l’allevamento, sia il fattore e i bozzoli venivano esposti in bella mostra sotto il loggiato della piazza. I commercianti e gli agenti delle filande esaminavano con cura il prodotto e, se era di loro gradimento, iniziavano le trattative di acquisto con il fattore il quale, prima della decisione finale, chiedeva con un cenno del capo il parere del contadino alla vendita. Stabilito il prezzo della seta, i cesti venivano portati alla pesatura: qui un funzionario del Comune procedeva al controllo del peso, dichiarando a voce alta il peso riscontrato, esigeva dal venditore la tassa comunale di pesata e rilasciava un cartellino col peso dichiarato. Al passaggio di proprietà dei bozzoli, il fattore si recava alla cassa del compratore col cartellino del peso e riscuoteva l’importo. Fatto questo si rivolgeva al contadino e gli versava immediatamente la metà della somma in contanti. Gli spiccioli venivano offerti come mancia “par bo man” alle donne: quei soldi servivano per qualche piccolo desiderio personale, ma soprattutto per coprire le spese per la conduzione del podere. Pier Giorgio Casadio Prati 15 CERVIA NELLE PAGINE DI LINA SACCHETTI 16 Era nata a Cervia nel novembre del 1894 da una famiglia cervese, prima di otto fratelli. Era bella, la migliore delle sorelle, ma non ambiziosa. Di carattere forte e riservato, non si perdeva in piccolezze e non accettava sprechi. Il padre era salinaro: regolava il mercato del pesce e stimava il valore del pescato man mano che veniva scaricato dai bragozzi. Era il cosi detto “parznevul”. Lina fu avviata agli studi e frequentò le Magistrali a Ravenna conseguendo il titolo di maestra elementare a 16 anni. Esercitò con passione la sua professione di insegnante e in seguito partecipò ad un concorso indetto dal Ministero (della Pubblica Istruzione. e vinse il titolo di Ispettrice. Fu ispettrice per tutta la sua vita con tale capacità e competenza da meritare due Medaglie d’oro dal Ministero della P.I., e un “Premio della cultura” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.. Ma fu soprattutto una educatrice. Si occupò dell’infanzia per la quale diresse il periodico “La scuola ed il libro”, e degli adolescenti a cui dedicò un testo di largo respiro e profondità “La storia della letteratura per la gioventù”, nonché “La religione e i giovani”. È vissuta a Roma per trent’anni, ed ha viaggiato in Italia e all’estero per diffondere cultura, ma Cervia è restata la sua base, il suo ambiente naturale: la pianura uniforme, monotona, intersecata da lenti canali, tanto vasta e suggestiva da dare il senso dell’infinito, la fascia litoranea dei pini, il luccichio argenteo dei bacini saliferi. Autrice di testi di liriche ispirate alla sua terra e agli avvenimenti che l’avevano percorsa, vi ha profuso sentimenti e passioni. Si intitolano “Fra due fuochi”, “In terra di Romagna” e “Stagione a Cervia” (con prefazione di Aldo Spallicci): da “La piana” ....Ampie chiazze d’oro nella piana ubertosa... Folte sono le prode di screziati cespi di corolle... Il sambuco odora. Coglieva spesso immagini da “Il paese del vento” di Grazia Deledda e citava volentieri “la bella ventosa azzurra Cervia”. Si incantava a guardare il canale dei porto “solcato da pescherecci che formavano una foresta coloratissima di alberi, pennoni, vele, reti” A volte andava incontro all’alba che sorge, raccoglieva sull’arenile le “poverazze” affioranti fra le alghe sulla sabbia bagnata, attratta anche dal gioco dei gabbiani, l’uno accanto all’altro, con le penne del collo gonfie e arruffate pronti a gettarsi sul pesce gettato dai marinai. La città le parla al cuore: “ Se dalla piazza Garibaldi, il cuore della cittadina, si vuol raggiungere la piazzetta Carlo Pisacane, si deve attraversare l’atrio di accesso al Comune, il cosiddetto “voltone”. È diventato il sacrario delle memorie cittadine. Mostra incisi su lapidi di marmo i nomi di personaggi che hanno onorato Cervia, letterati, scienziati, patrioti, benefattori e martiri. Se si prosegue oltre la piazza, ci si immette nella circonvallazione Edoardo Sacchetti, la strada dedicata all’amato, eroico, sfortunato fratello di Lina. La scrittrice ne ha raccontato la vita nel volume “Storia di una coscienza”, con toccanti liriche dettate dalla sua sofferenza: “ Risali dal tumulto, fratello...Tu mi sei pane, anima e ala di canto”. La raccolta di poesie “Stagione a Cervia” ci presenta immagini di un tempo, di tormento e di attesa. Le liriche seguono gli avvenimenti che dal settembre 1943 trasformarono la città in campo trincerato, soggetta a bombardamenti e mitragliamenti. I cervesi erano sfollati in capanne e il tifo dilagava, le saline erano state allagate. I cittadini, conosciuto l’ordine tedesco dell’allagamento erano corsi a fare la provvista di sale… …l’umana ombra empie avida sacchi, otri, ceste prima che la marea salga e tutto sommerga. Con fatica il mio peso porto anch’io... E sgomenta, con il mio sacco sulle spalle, m’ incammino incespicando La vita di Lina è stata fortemente segnata dall’amicizia fraterna con Grazia Deledda. A lei ha dedicato il testo “Arte e Umanità di G.D.” e in seguito il bellissimo “Grazia Deledda: ricordi e testimonianze”: è una biografia semplice e viva, corredata di episodi, incontri, corrispondenze. Fu la sua compagna e la sua mentore per le strade di Cervia e dei dintorni. Le fu fedelmente vicina: solerte, attiva, intelligente durante tutti i 15 anni del soggiorno estivo della grande scrittrice sarda, che si spense il 15 agosto 1936. Lina continuò la sua opera di valorizzazione e approfondimento del lavoro deleddiano, producendo testi e articoli, tenendo conferenze in ambito nazionale, raccogliendo materiale epistolare inedito e iniziando il poderoso riordino delle novelle (in alcune delle quali si delineano pittoresche figure di cervesi, come Truciolo l’omino della goccia di stagno). Lina Sacchetti è scomparsa i1 13 gennaio I988, a 94 anni. Aveva fatto dello studio la sua sola e vera ragione di vita. Ma negli ultimi anni era tornata a Cervia, nella sua casa sul mare, accanto ai suoi cari, per ritrovare affetti, ambienti, profumi della sua giovinezza e lasciarsene avvolgere. Cito, a chiusura, un brano che ritengo il suo testamento spirituale: “Appare sempre più urgente il recupero della fede in ciò che qualifica l’uomo, il suo spirito. Lo testimonia l’esperienza dolorosa di un’intera società, e della mia generazione in particolare, alla quale anch’io ho reagito, sull’onda di tremende emozioni, liberandomi nella pagina scritta, secondo il ritmo del cuore, delle sue più autentiche modulazioni”. Wilma Romeo Venturi È zoch -periodico di attività culturali Aprile 2005, numero 14 Autorizzazione del Tribunale di Bologna n° 6718 Direttore: Daniele Franchini Direttore responsabile: Gian Franco Fontana Redazione: Santerno Edizioni sas di Fontana Gian Franco e C. Via IV Novembre, 7 40026 Imola Bo Stampa: Litografia Ragazzini, Faenza E mail: [email protected] [email protected] In questo numero scritti di: Franco Brevini Pier Giorgio Casadio Prati Francesco Donati Nino Drei Gian Franco Fontana Ubaldo Galli Roberto Monti Graziano Pozzetto Emilio Prantoni Andrea Segre Stefano Servadei Wilma Romeo Venturi Le fotografie sono di Gian Franco Fontana © 2005
Scaricare