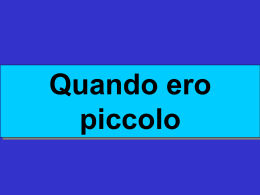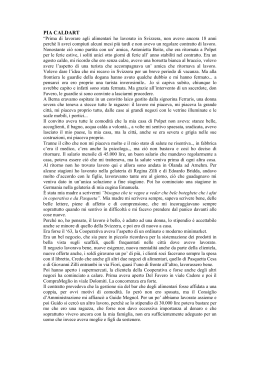leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it romanzo Traduzione dall’inglese di Marianna Cozzi Prima edizione: marzo 2013 Titolo originale: Easy © 2012 by Tammara Webber © 2013 by Sergio Fanucci Communications S.r.l. Il marchio Leggereditore è di proprietà della Sergio Fanucci Communications S.r.l. via delle Fornaci, 66 – 00165 Roma tel. 06.39366384 – email: [email protected] Indirizzo internet: www.leggereditore.it Italian language rights handled by Agenzia Letteraria Internazionale, Milano, Italy in cooperation with Dystel & Goderich Literary Management. Proprietà letteraria e artistica riservata Stampato in Italia – Printed in Italy Tutti i diritti riservati Progetto grafico: Grafica Effe A Kim, confidente, sorella che non ho mai avuto, nessuna parola è adatta a descrivere quello che sei per me. Grazie di essere tutto quello che sei. Nel mio cuore, per sempre. 1 Prima di quella sera non avevo mai notato Lucas. Era co me se non esistesse, e poi improvvisamente lo vedevo o vunque. Me l’ero appena svignata dalla festa di Halloween ancora in pieno fervore. Mi intrufolai tra le auto ammassate nel par cheggio dietro la sede della confraternita del mio ex, e scrissi un sms alla mia compagna di stanza. Era una bella serata cal da – una tipica estate di San Martino dei Paesi del Sud. Dalle finestre spalancate del club si udiva una musica assordante che giungeva fino al marciapiede, punteggiata ogni tanto di fragorose risate, sfide tra ubriachi e richieste di altri drink. Dovevo fare da autista, quindi, anche se non ne potevo più di quella festa, era mia responsabilità riportare Erin tutta intera alla casa dello studente dove alloggiavamo, dall’altra parte del campus. Il mio messaggino le diceva di chiamare o mandare un sms non appena fosse stata pronta ad andarse ne. Tuttavia, dai balli osceni che lei e il suo ragazzo Chaz ave vano fatto, sbronzi di tequila, prima di prendersi per mano e inciampare per le scale, mentre salivano verso la stanza di lui, si poteva presupporre che mi avrebbe chiamata solo l’in domani. In quel caso, ridacchiai al pensiero di lei che cammi 9 nava vergognosa nel breve tratto tra la veranda d’ingresso del club studentesco e il mio furgoncino. Premetti Invio e frugai nella mia borsa per cercare le chiavi. La luna era completamente offuscata dalle nubi e le finestre ben illuminate del club erano troppo lontane perché potesse ro far luce anche in fondo al parcheggio. Dovevo procedere a tentoni. Quando un portamine mi si conficcò nella punta del dito, mi lasciai andare a un’imprecazione e battei pesan temente a terra un piede che calzava una scarpa col tacco a spillo, quasi sicura di essermi fatta uscire il sangue. Una volta prese le chiavi mi succhiai il dito: il gusto leggermente metalli co mi faceva intendere che avevo bucato la pelle. «E ti pareva» mormorai aprendo la portiera del furgon cino. Negli istanti che seguirono ero troppo disorientata per com prendere quello che stava succedendo. Un attimo prima ero intenta ad aprire la portiera e un attimo dopo mi ritrovai diste sa con la faccia sul sedile, immobile e senza fiato. Nonostante i miei sforzi, non riuscivo ad alzarmi perché il peso che avevo addosso era come un macigno. «Il costume da diavoletto ti sta proprio bene, Jackie.» La voce era indistinta, eppure familiare. Il mio primo pensiero fu: Non chiamarmi così. Ma quell’o biezione fu subito accantonata e rimpiazzata dal terrore non appena sentii una mano alzare la mia gonna già bella corta. Avevo il braccio destro fuori uso, intrappolato tra il mio cor po e il sedile. Annaspavo con la mano sinistra contro il sedile, accanto al mio viso, cercando nuovamente di tirarmi su, e la mano sulla mia coscia nuda si precipitò ad afferrarmi il pol so. Cacciai un urlo quando il tizio mi tirò il braccio dietro la schiena, tenendolo ben stretto nella sua mano. Il suo avam braccio premeva sulla parte superiore della mia schiena. Ero bloccata. «Buck, toglimi le mani di dosso. Lasciami andare.» La mia 10 voce tremava, però tentavo di avere il più possibile un tono perentorio. Riuscivo a sentirgli la puzza di birra nell’alito e un acre odore di sudore, e mi venne la nausea. La sua mano libera ritornò sulla mia coscia sinistra, il peso del suo corpo era ora sul mio fianco destro, mi schiacciava. I miei piedi penzolavano dal furgoncino; la portiera era an cora aperta. Tentai di piegare il ginocchio per mettermelo sotto, e lui rise per i miei patetici sforzi. Quando mi ficcò la mano tra le gambe divaricate cacciai un urlo riabbassando di scatto la gamba, troppo tardi. Lo strattonai e mi dimenai per staccarmi da lui ma poi, rendendomi conto che non potevo competere con quell’armadio, cominciai a supplicarlo. «Buck, fermati. Ti prego... sei ubriaco e domani te ne pen tirai. Oh, mio dio...» Mi infilò il ginocchio tra le gambe e mi arrivò un colpo d’aria al fianco scoperto. Sentii l’inconfondibile suono di una chiusura lampo e la risata di Buck quando, dopo averlo im plorato ragionevolmente, passai al pianto. «No-no-no-no...» Con tutto quel peso addosso non riuscivo a prendere abbastanza fiato da urlare e avevo la bocca schiac ciata contro il sedile, il che soffocò così qualunque mia prote sta. Lottavo invano. Mi era difficile credere che quel ragazzo che conoscevo da più di un anno, che nemmeno una volta mi aveva mancato di rispetto per tutto il tempo in cui avevo fre quentato Kennedy, era lì, ad aggredirmi nel mio furgoncino sul retro del parcheggio del club studentesco. Mi abbassò le mutandine fino al ginocchio, e tra i suoi sfor zi di tirarle giù e i miei nuovi tentativi di divincolarmi, sentii lo strappo del loro tessuto delicato. «Cristo, Jackie, ho sem pre saputo che avessi un bel culo, ma... Cristo santo, bellez za.» La sua mano si fiondò di nuovo tra le mie gambe e quel peso si tolse per mezzo secondo dal mio corpo... abbastanza a lungo da permettermi di tirare una boccata d’aria e urlare. Mentre mi liberavo il polso, lui con la mano mi diede un col 11 petto alla nuca schiacciandomi di nuovo la faccia contro il se dile di pelle finché non stetti in silenzio, quasi senza respiro. Benché ora avessi il braccio sinistro libero, era inerte. Feci leva con la mano sul pianale dell’abitacolo e spinsi, ma i mu scoli stanchi e doloranti non rispondevano ai miei comandi. Singhiozzavo nel sedile mentre sulle guance si mischiavano lacrime e saliva. «Ti prego no, ti prego no, oh dio, fermati... fermati...» Odiavo il flebile suono della mia voce impotente. Per mezzo secondo il suo corpo a peso morto si sollevò di nuovo dal mio. Forse aveva cambiato idea, o posizione: non mi ci volle molto per scoprire quale delle due fosse. Mi con torcevo e tiravo su le gambe, e nello spingermi verso l’estre mità del sedile per raggiungere faticosamente la maniglia, sentii che i tacchi a spillo delle mie scarpe avevano bucato la morbida pelle della tappezzeria. Il sangue mi scorreva velo ce nelle orecchie mentre il corpo si riprendeva per una lotta senza esclusione di colpi o la fuga. E poi mi fermai perché Buck non era più nel furgoncino. All’inizio non capivo il motivo per cui stesse lì in piedi, appena oltre la portiera, col viso rivolto dalla parte opposta alla mia. E poi rigirò di scatto la testa. Due volte. Fece il gesto di colpire violentemente qualcosa, però tirò i pugni a vuoto. Solo quando barcollò indietro sbattendo contro il mio fur goncino riuscii a vedere con cosa – o chi – stava lottando. Il tizio mollò in faccia a Buck altri due forti sinistri senza staccargli mai gli occhi di dosso, scattando su e giù, di lato, mentre giravano in tondo, e pure Buck, col sangue al naso, sferrava pugni, anche se mancava puntualmente il bersaglio. Alla fine chinò improvvisamente la testa e caricò l’avversa rio come un toro, ma quello sforzo fu la sua rovina poiché lo sconosciuto con estrema facilità gli sferrò un montante alla mascella. Quando la testa di Buck si alzò bruscamente, un gomito gli picchiò la tempia con un tonfo nauseante. Urtò di nuovo contro la fiancata del furgoncino respingendo e 12 caricando lo sconosciuto una seconda volta. Come se tutta quella lotta fosse orchestrata, il tizio afferrò le spalle di Buck e lo strattonò verso di sé, violentemente, dandogli una gi nocchiata sotto il mento. Buck si accasciò a terra. Lo sconosciuto lo fissava dall’alto, con i pugni serrati e i go miti lievemente piegati, pronti a mollare un altro colpo se necessario. Non ce n’era bisogno. Buck era quasi privo di sensi. Mi accovacciai alla portiera opposta a quella aperta, ansimando, mentre al senso di panico subentrava lo shock. Lo sconosciuto alzò lo sguardo verso di me. Con lo stivale girò Buck su un fianco, poi mise un piede sull’apertura della portiera dando una sbirciata all’interno del veicolo. «Tutto okay?» Il suo tono era basso, premuroso. Volevo di re di sì. Volevo fare cenno con la testa. Ma non ce la facevo. «Chiamo il 911. Hai bisogno di assistenza medica o solo della polizia?» M’immaginai la polizia del campus arrivare sulla scena, gli invitati alla festa che sarebbero usciti in massa dal club al suono delle sirene. Erin e Chaz erano solo due dei molti amici che avevo lì dentro, di cui più della metà erano minorenni e stavano facendo uso di alcol. Sarebbe stata colpa mia se la fe sta fosse diventata l’obiettivo della polizia. Sarei stata additata. Scossi la testa. «Non chiamare nessuno.» «Non devo chiamare un’ambulanza?» Mi schiarii la gola e scossi la testa. «Non chiamare nessu no. Non chiamare la polizia.» Rimase con la mascella semiaperta e lo sguardo fisso sull’al tra estremità del sedile. «Mi sbaglio o questo tizio ha appena provato a violentarti...» Trasalii a quella brutta parola. «...E mi dici di non chiamare la polizia?» Chiuse subito la bocca, scos se la testa una volta e mi diede ancora una sbirciatina. «O per caso ho interrotto qualcosa che non dovevo interrompere?» Con un filo di voce e le lacrime agli occhi dissi: «N... no. Ma voglio soltanto andare a casa.» 13 Buck si rotolò di schiena, lamentandosi. «Caaazzo» dis se senza aprire gli occhi, uno dei quali era comunque chiuso perché troppo gonfio. Il mio salvatore lo fissava dall’alto muovendo la mascella. Dondolò il collo da un lato e poi indietro e roteò le spalle. «Bene. Ti accompagno io.» Scossi la testa. Non ero scampata a uno stupro solo per fare qualcosa di tanto stupido come entrare nella macchina di uno sconosciuto. «Ce la faccio a guidare» dissi con voce stridula. I miei occhi si posarono subito sulla mia borsa, infilata contro la console, da cui erano usciti degli oggetti ora sparpagliati sul pianale del furgoncino, dal lato del conducente. Il ragazzo abbassò lo sguardo e si chinò a raccogliere le mie chiavi. «Credo che prima tu stessi cercando queste.» Le fece pen zolare dalle dita mentre mi rendevo conto che ancora non mi ero avvicinata a lui. Mi leccai il labbro e per la seconda volta, quella sera, sentii il sapore del sangue. Mi precipitai in avanti, verso il punto il luminato dalla luce sopra il cruscotto, stando attenta a man tenere abbassata la gonna. Mi venne il capogiro non appena fui pienamente consapevole di quanto per poco non era suc cesso, e allungai la mano tremolante per prendere le chiavi. Il tizio si accigliò racchiudendole in un pugno, poi riabbas sò il braccio lungo il fianco. «Non posso lasciarti guidare.» A giudicare dalla sua espressione, la mia faccia era un disastro. Sbattei le palpebre, con la mano ancora tesa verso le chiavi che lui aveva requisito. «Cosa? Perché?» Contò sulle dita tre motivi. «Stai tremando, probabilmen te come conseguenza dell’aggressione. Non so se effettiva mente non hai riportato ferite. E probabilmente hai bevuto.» «No, non l’ho fatto» dissi con tono seccato. «Dovevo fare da autista.» Il ragazzo inarcò un sopracciglio guardandosi intorno. «Esattamente, per chi dovresti fare da autista? Se fossi sta 14 ta in compagnia di qualcuno, tra l’altro, forse stasera non ti sarebbe successo nulla. Invece sei entrata in un parcheggio buio, da sola, senza prestare alcuna attenzione a ciò che ti sta va intorno. Un comportamento davvero responsabile.» Di colpo andai su tutte le furie. Ero arrabbiata con Kenne dy per avermi spezzato il cuore due settimane prima e per non essere stato con me quella sera, a controllare che salissi incolume sul mio furgoncino. Arrabbiata con Erin per aver mi convinta ad andare a quella stupida festa e persino più arrabbiata con me stessa per aver accettato. Ero arrabbiata con lo stronzo semicosciente che stava sbavando e sanguinando a terra a qualche centimetro di distanza. E ce l’avevo con quello sconosciuto che aveva preso in ostaggio le mie chiavi accu sandomi di essere incauta e senza cervello. «Così sarebbe colpa mia se mi ha aggredita?» Nonostante avessi la gola infiammata cercai di superare il dolore. «È col pa mia se non posso andare a piedi da un club studentesco al mio furgoncino senza che uno di voi provi a violentarmi?» Gli rinfacciai quel brutto verbo per dimostrargli che ero in grado di sopportarlo. «Uno di voi? Non vorrai mica mettermi sullo stesso piano di questo pezzo di merda?» Indicò Buck col dito senza mai staccare gli occhi dai miei. «Non sono affatto come lui.» Fu allora che notai il cerchietto d’argento sul lato sinistro del suo labbro inferiore. Grandioso. Mi trovavo in un parcheggio, da sola, con uno sconosciuto offeso e col piercing in faccia che aveva ancora le mie chiavi. Non ne potevo più di quella serata. Dalla gola mi arrivò un singhiozzo mentre tentavo di rimanere calma. «Posso riavere le mie chiavi, per favore?» Tenevo la mano tesa; volevo smettere di tremare. Lui deglutì, mi guardò, e io a mia volta lo fissai nei suoi oc chi chiari. Non riuscivo a decifrarne il colore nella luce fioca, però erano in netto contrasto con i suoi capelli scuri. La sua 15 voce era più dolce, meno ostile. «Vivi nel campus? Lascia che ti accompagni. Posso tornare qui a piedi a riprendere la moto più tardi.» Non avevo più la forza di contrastarlo. Annuii allungan do il braccio per togliere di mezzo la mia borsa. Lui mi aiutò a raccogliere il lucidalabbra, il portafogli, gli assorbenti inter ni, gli elastici per capelli, le penne e le matite sparpagliati sul pianale, e a rimetterli in borsa. L’ultimo oggetto che raccolse fu una scatola di preservativi. Si schiarì la gola e me la diede. «Non è mia» dissi. Lui si accigliò. «Sicura?» Serrai la mascella tentando di non andare di nuovo su tut te le furie. «Sicurissima.» Il ragazzo lanciò ancora un’occhiata a Buck. «Bastardo. Probabilmente stava per...» Mi guardò dritta negli occhi e poi guardò nuovamente Buck aggrottando le sopracciglia. «Ehm... nascondi la prova.» Non ci avevo nemmeno pensato. Lui infilò la scatola nella tasca anteriore dei jeans. «La butterò via... di sicuro non la riavrà.» Con la fronte ancora corrugata mi lanciò di nuovo un’occhiata mentre saliva sul furgoncino e accese il motore. «Sei sicura che non vuoi che chiami la polizia?» Le risa risuonavano dalla porta sul retro del club. Annuii. Incorniciato nella finestra centrale, Kennedy ballava cingen do alla vita una ragazza che indossava un vestitino bianco trasparente e scollato con tanto di ali e aureola. Perfetto. Pro prio perfetto. A un certo punto durante la mia lotta con Buck avevo perso il cerchietto con le corna da diavolo che Erin mi aveva infilato in testa quando ero seduta a letto a lamentarmi del fatto che non volevo andare a una stupida festa in costume. Senza quell’accessorio ero soltanto una ragazza in un vestito succinto e con paillette rosse che in un’altra occasione mi sarei categoricamente rifiutata di indossare. 16 «Sono sicura.» I fari del furgoncino illuminavano Buck mentre uscivamo dal parcheggio a marcia indietro. Lui si mise una mano da vanti agli occhi tentando di mettersi seduto. Persino a quella distanza riuscii a vedergli il labbro spaccato, il naso deforme e l’occhio gonfio. Era un bene che non stessi io al volante. Probabilmente l’avrei investito. Comunicai il nome della casa dello studente dove alloggia vo al mio accompagnatore e rimasi a fissare fuori dal finestri no, dal lato del passeggero, incapace di spiccicare un’altra pa rola mentre vagavamo per il campus. Mi strinsi forte tra le braccia provando a nascondere i brividi che mi torturavano. Non volevo che lui mi vedesse in quello stato, ma non riuscivo a trattenerli. Il parcheggio della casa dello studente era quasi pieno; i posti vicino all’entrata erano stati tutti occupati. Il tizio siste mò il furgoncino in uno spazio sul retro, poi saltò fuori dal veicolo e fece il giro per venirmi incontro non appena scesi dalla parte del passeggero. Barcollando fino quasi a perdere l’equilibrio, presi le chiavi dopo che lui aveva attivato la chiu sura automatica delle portiere, e lo seguii fino all’edificio. «Il tuo codice identificativo?» chiese una volta arrivati al l’entrata. Le mie mani tremarono quando sganciai la linguetta sulla parte anteriore della borsa ed estrassi la tessera. Lui me la sfilò dalle dita e in quel momento gli notai il sangue sulle nocche. Dissi con un filo di voce: «Oh, mio dio. Stai sanguinando.» Lo sconosciuto si diede un’occhiata alla mano e scosse la testa. «No. È quasi tutto sangue di quel tizio.» Compresse le labbra e si voltò per passare la tessera nel sistema di accesso. Mi chiesi se intendesse seguirmi dentro. Sapevo che non a vrei potuto reggermi in piedi ancora per molto. Dopo aver aperto la porta mi restituì la tessera identifica 17 tiva. Nella luce dell’atrio riuscii a vedergli gli occhi più chia ramente. Erano di un grigio-azzurro sotto le sopracciglia abbassate. «Sei sicura di star bene?» mi chiese per la seconda volta, e mi sentii la faccia contrarsi in una smorfia. Infilai la tessera nella borsa, mento in giù, e annuii inutil mente. «Sì, bene» mentii. Lui fece un sospiro, incredulo, passandosi una mano tra i capelli. «Posso chiamarti qualcuno?» Scossi la testa. Dovevo raggiungere la mia stanza per po ter crollare. «Grazie, ma no.» Gli passai accanto stando atten ta a non sfiorarlo e mi diressi verso le scale. «Jackie?» mi chiamò dolcemente senza muoversi dall’u scio. Mi girai a guardarlo, afferrando il corrimano, e i nostri sguardi si incrociarono. «Non è stata colpa tua.» Mi morsi il labbro, forte, annuendo una volta prima di vol tarmi e correre su per le scale, con le mie scarpe che battevano contro i gradini di cemento. Mi fermai di colpo al pianerot tolo del secondo piano e guardai indietro, verso l’entrata. Se n’era andato. Non sapevo il suo nome e non ricordavo di averlo visto prima di allora. Però di sicuro avrei ricordato quegli occhi chiari. Non avevo idea di chi fosse... eppure mi aveva già chiamata per nome. Non il nome sulla mia tessera identifica tiva – Jacqueline – ma Jackie, il vezzeggiativo con cui convive vo da quando Kennedy mi aveva ribattezzata così al nostro penultimo anno delle superiori. Due settimane prima «Vuoi venire? O rimani lì? Erin starà da Chaz questo fine settimana...» La mia voce era scherzosa, cantilenante. «Il suo compagno di stanza è fuori città. Il che significa che sarò sola soletta...» 18 A me e Kennedy mancava un mese al nostro terzo anni versario. Ultimamente Erin aveva cominciato a chiamarci ‘la vecchia coppia sposata’. Al che rispondevo: «Gelosa.» E poi mi alzava il dito medio. «Ehm, sì. Verrò per un po’.» Quando si fermò nel parcheg gio della casa dello studente a cercare un posteggio si mas saggiò la nuca con un’espressione enigmatica. Mi sentii pungere il petto dall’ansia e deglutii preoccupa ta. «Tutto okay?» Massaggiarsi il collo era un segno di stress che conoscevo bene. Mi lanciò un’occhiata. «Sì, certo.» Parcheggiò nel primo bu co libero infilando la sua bmw tra due pick-up. Non infilava mai, e dico mai, il suo prezioso gioiello in posti così stretti. Il rumore delle portiere che urtavano lo faceva diventare matto. C’era qualcosa sotto. Sapevo che era preoccupato per gli im minenti esami di metà trimestre, specialmente per quello di precalcolo. La sua confraternita avrebbe dato anche una festa la sera successiva, il che era totalmente da idioti a una settima na dalla fine di metà trimestre. Feci entrare entrambi nell’edificio passando la mia tessera identificativa nel sistema di accesso e arrivammo alla trom ba delle scale sul retro che da sola mi faceva sempre venire la pelle d’oca. Con Kennedy dietro di me notai i muri sudici e pieni di gomme da masticare e l’acre puzza di chiuso. Feci di corsa l’ultima rampa e sbucammo nel corridoio. Girando lo sguardo indietro, verso di lui, mentre aprivo la porta, scossi la testa di fronte alla curiosa rappresentazione di un pene che qualcuno aveva scarabocchiato sulla lava gnetta bianca che io ed Erin usavamo per lasciarci dei mes saggi. Le case dello studente miste erano meno disciplinate di quelle rappresentate nei siti web dei college. A volte era come vivere insieme a un gruppo di dodicenni. «Potresti darti malato domani sera.» Gli appoggiai una mano sul braccio. «Rimani con me... passiamo il fine settima 19 na a studiare e a ordinare cibo da asporto... e a fare altre atti vità antistress...» Feci un largo sorriso malizioso. Lui si fissava le scarpe. I battiti del mio cuore accelerarono e improvvisamente mi sentii avvampare. Qualcosa non andava. Volevo che sputas se il rospo, qualunque cosa fosse, perché la mia mente stava contemplando solo brutte eventualità. Era passato così tanto tempo dall’ultima volta in cui avevamo avuto un problema che ora mi sentivo in un vicolo cieco. Kennedy entrò nella mia stanza e si sedette sulla sedia della scrivania, non sul letto. Gli salii sopra; le nostre gambe incrociate. Volevo mi di cesse che era soltanto di cattivo umore o preoccupato per gli imminenti esami. Col cuore che mi batteva forte gli poggiai una mano sulla spalla. «Kennedy?» «Jackie, dobbiamo parlare.» Le pulsazioni che mi martellavano nelle orecchie si fece ro sempre più forti e la mia mano gli cascò dalla spalla. La afferrai nell’altra mia mano e mi sedetti sul letto, a meno di un metro di distanza. La mia bocca era così secca che non riuscivo a deglutire, e men che meno a parlare. Lui era silenzioso ed evitò il mio sguardo per quelli che mi sembrarono degli interminabili minuti. Alla fine alzò gli occhi su di me. Sembrava triste. Oh, dio. «Ultimamente ho avuto qualche... guaio. Con altre ragazze.» Sbattei le palpebre, felice di essere già seduta. Le mie gam be avrebbero ceduto e sarei finita a terra se fossi stata in piedi. «Che vuoi dire?» chiesi con voce roca. «Che intendi per ‘gua io’ e ‘altre ragazze’?» Sospirò profondamente. «Non quella cosa lì, non proprio. Voglio dire, non ho fatto nulla.» Guardò da un’altra parte e so spirò di nuovo. «Ma penso di volerlo.» Ma che diavolo...? «Non capisco.» La mia mente lavorava freneticamente 20 per rendere quella situazione la migliore possibile al di là di tutto, ma le alternative che trovavo, anche le più improbabili, erano disgustose. Kennedy si alzò e andò avanti e indietro per la stanza per due volte prima di risedersi e piantarsi in pizzo alla sedia, sporgendosi in avanti con i gomiti sulle ginocchia e le mani serrate. «Sai quant’è importante per me fare carriera nell’av vocatura e in politica.» Annuii, ancora ammutolita dallo shock, facendo di tutto per non vacillare. «Conosci la nostra confraternita femminile?» Annuii ancora. Era proprio quello di cui mi ero preoccu pata quando si era trasferito nel club. A quanto pareva, non mi ero preoccupata abbastanza. «C’è una ragazza... un paio di ragazze, in realtà, che... ecco...» Provai a tenere un tono di voce razionale e normale. «Ken nedy, questo non ha senso. Non mi starai mica dicendo che... o che vuoi...» Mi guardò fisso negli occhi, così non ci sarebbero stati fraintendimenti. «Lo voglio.» In effetti avrebbe potuto soltanto darmi un pugno nello stomaco, perché il mio cervello si rifiutava di comprendere le parole che stava pronunciando. Un’aggressione fisica sa rebbe stata più comprensibile. «Lo vuoi? Che diavolo intendi dire con ‘lo voglio’?» Lui saltò dalla sedia e si diresse verso la porta per poi tor nare indietro... «Cosa pensi che voglia dire? Cristo. Non far melo dire.» Restai a bocca aperta. «Perché no? Perché non dirlo? Se addirittura immagini di farlo, allora perché cazzo non lo dici? E questo che c’entra con la tua carriera...» «Ci sto arrivando. Tutti sanno che una delle cose peggiori che un candidato politico o un rappresentante eletto possa fare è rimanere coinvolto in qualche scandalo sessuale.» I 21 suoi occhi erano puntati sui miei in quella che riconoscevo come una faccia-da-discussione. «Sono solo un essere uma no, Jackie, e se ho questi desideri di dar sfogo ai miei bollori e li reprimo, probabilmente mi verranno più in là, e anche di peggiori. Ma dopo sarà come buttare all’aria la mia carriera.» Aprì le mani in un gesto disperato. «Non ho scelta se non quella di liberarmi di questo peso ora che lo posso fare senza annientare la mia futura reputazione professionale.» Dissi tra me e me: Non può essere vero. Il mio fidanzato, il ragazzo con cui stavo da tre anni, non stava rompendo con me per potersi sbattere in tutta tranquillità e senza scrupoli le studentesse. Chiusi gli occhi e provai a fare un respiro pro fondo, ma non ci riuscii. Non c’era ossigeno nella stanza. Lo fulminai con lo sguardo, in silenzio. Lui serrò la mascella. «Okay, quindi presumo che tradirti sia stata una cattiva idea...» «Rompi con me per poterti scopare altre ragazze? Senza sentirti in colpa? Sei serio?» «Come un infarto.» L’ultima cosa che pensai prima di prendere il mio libro di economia e lanciarglielo addosso fu: Come fa a servirsi di un cliché tanto schifoso in un momento come questo? 22 2 La voce di Erin mi svegliò. «Jacqueline Wallace, porta il culo fuori da quel letto e va’ a salvare la media dei voti. Per l’amor del cielo, se permettessi a un ragazzo di farmi perdere qualunque interesse per lo studio in questo modo, non avrei più pace.» Emisi un suono sprezzante da sotto la trapunta prima di fare capolino. «Quale interesse per lo studio?» Aveva le mani sui fianchi, avvolta in un asciugamano, ap pena docciata. «Ah ah. Molto divertente. Alzati.» Arricciai il naso, ma senza muovermi. «Vado bene in tutte le altre materie. Non posso essere bocciata in questa?» Spalancò la bocca. «Ma ti senti?» Mi sentivo eccome. Ed ero tanto disgustata dalla mia vigliac cheria quanto lo era Erin, se non di più. Il pensiero, però, di sedermi accanto a Kennedy per un’ora intera di lezione tre volte alla settimana era insopportabile. Non avevo la certezza di ciò che il suo nuovo status di single avrebbe significato in termini di flirt o accalappiamenti, ma qualunque cosa volesse significare, non volevo assistere. Era già orribile immaginare i dettagli. Se solo non l’avessi spinto a frequentare insieme una ma 23 teria questo semestre! Quando ci iscrivemmo ai corsi autun nali lui chiese perché volessi frequentare economia – non era un corso richiesto per la mia laurea in Educazione musicale. Mi chiedevo se l’avesse intuito, anche allora, che saremmo arrivati a questo punto. O se l’avesse saputo. «Non posso.» «Tu puoi e lo farai.» Tirò via la trapunta. «Ora alzati e fai la doccia. Devo essere puntuale alla lezione di francese altri menti monsieur Bidot mi interrogherà senza pietà sul passé composé. A malapena faccio il passato in inglese. Figuriamoci se lo riesco a fare en français di primo mattino.» Arrivai davanti all’aula direttamente alle nove, sapendo che Kennedy, di solito puntuale, sarebbe già stato lì. L’aula era grande, a gradinata. Mi infiltrai per la porta secondaria e lo individuai al centro della sesta fila. Il posto alla sua destra era vuoto – il mio posto. La seconda settimana di lezione il professor Heller aveva fatto circolare una tabella dei posti a sedere che utilizzava per segnare le presenze e rendere meri to a chi partecipava assiduamente. Avrei dovuto parlare con il mio ex dopo la lezione perché non c’era motivo di sedergli ancora accanto. Scrutai le file dietro. C’erano due posti vuoti. Uno era tre file sotto, tra un ragazzo col viso appoggiato sulla mano, quasi sempre addormentato, e una ragazza che beveva qual cosa da una bottiglietta e chiacchierava incessantemente con la tizia di fianco. L’altro era nella fila dietro, accanto a un tipo che sembrava fare degli scarabocchi a margine del suo libro di testo. Mi girai verso quella direzione nello stesso momen to in cui il professore entrò da una porta laterale in basso. ‘L’artista’ alzò la testa verso la prima fila. Rimasi di sasso nel riconoscere il mio salvatore di qualche sera prima. Se avessi potuto muovermi mi sarei voltata per fuggire dall’aula. Tutt’a un tratto mi assalì il ricordo dell’aggressione. Il senso di impotenza. Il terrore. L’umiliazione. Avevo pianto tutta la 24 notte, rannicchiata sul letto, sollevata per l’sms di Erin in cui mi diceva che sarebbe rimasta da Chaz. Non le avevo rac contato cosa aveva fatto Buck... un po’ perché sapevo che si sarebbe sentita responsabile per avermi fatto andare a quella festa e poi avermi lasciata da sola. E un po’ perché volevo di menticare completamente ciò che era successo. «Se si siedono tutti, cominciamo.» Le parole del professo re mi scossero dallo stupore: ero l’unica studentessa in piedi. Mi fiondai sulla sedia vuota tra la ragazza chiacchierona e il tipo assonnato. Lei mi lanciò un’occhiata senza mai smettere di confidarsi con l’amica sul suo fine settimana, su quanto era stata sbron za, dove e con chi. Il tipo, invece, alzò appena gli occhi quan do mi infilai tra di loro, sedendomi sulla sedia imbullonata al pavimento, ma per il resto non si mosse nemmeno di un millimetro. «È occupata?» gli sussurrai. Lui scosse la testa e mormorò: «Lo era. Ma la tizia ha lascia to perdere. O qualcosa del genere.» Sollevata, tirai fuori dalla borsa un blocchetto a spirale. Tentai di non guardare Kennedy, però era dura consideran do la disposizione dei posti. I suoi capelli biondo scuro dalla perfetta acconciatura e la camicia button-down senza una piega attiravano il mio sguardo ogni volta che si muoveva. Conoscevo l’effetto che suscitava quel tessuto scozzese acco stato ai suoi spettacolari occhi verdi. Lo conoscevo dalla pri ma superiore. Avevo assistito al suo cambiamento di look, dal ragazzo che tutti i giorni indossava pantaloncini sportivi e scarpe da ginnastica a quello che mandava a stirare le sue camicie su misura, manteneva le scarpe immacolate e aveva sempre l’aspetto di chi era appena uscito dalla copertina di una rivista. Avevo visto più di un’insegnante girare la testa al suo passaggio, prima di distogliere subito lo sguardo da quel corpo perfetto e proibito. 25 Al penultimo anno delle superiori abbiamo fatto insieme il precorso d’inglese. Si era concentrato su di me dal primo giorno di lezione, sfoggiando il suo sorriso con le fossette, invitandomi a unirmi al suo gruppo di studio, chiedendomi quali fossero i miei progetti per il week-end... e alla fine riu scì a farne parte. Nessuno mi era mai corso dietro con tanta sicurezza di sé. Come nostro capoclasse, lo conoscevano tut ti. Come atleta, faceva onore alla squadra di baseball. Come studente era tra i migliori. Come membro del gruppo di di battito, era noto per la brillantezza delle sue argomentazioni. Come fidanzato, era paziente e premuroso, non mi faceva mai uscire dai gangheri o prendere delle decisioni affretta te. Non dimenticava mai un compleanno o un anniversario. Non mi faceva mai dubitare della serietà del nostro rappor to. Una volta fidanzati ufficialmente, mi cambiò nome – e tutti fecero lo stesso, inclusa me. «Tu sei la mia Jackie» mi diceva, riferendosi alla moglie di Jack Kennedy, il suo omo nimo, nonché suo idolo. Non aveva legami di parentela con lui. I genitori erano un po’ particolari... e ai ferri corti tra di loro. Aveva una sorella di nome Reagan e un fratello di nome Carter. Non mi facevo chiamare Jacqueline ormai da tre anni, e ora combattevo ogni giorno per riottenere quella parte di me che avevo accantonato per lui. Non era l’unica cosa a cui avevo rinunciato, o la più importante. Era solo l’unica che potessi riprendere. A forza di saltare le lezioni pur di evitare di starmene lì a fissarlo per cinquanta minuti, il mio cervello era diventato pigro e poco collaborativo. Quando terminò la lezione, mi resi conto di non aver assimilato granché di quanto spiegato. Seguii il professor Heller nel suo ufficio mentre nella testa mi frullavano diverse suppliche per indurlo a darmi l’oppor tunità di mettermi in pari. Fino a quel momento non avevo 26 dato importanza al fatto che potessi essere bocciata. Ora che la possibilità era diventata una probabilità, ero terrorizzata. Non ero mai stata bocciata in una materia. Cosa avrei rac contato ai miei genitori e al mio consulente universitario? Questa F sarebbe rimasta sul mio libretto per il resto della mia vita. «Bene, signorina Wallace.» Il professor Heller tolse dalla sua valigetta rovinata un libro di testo e un mucchio di ap punti disordinati, e cominciò a camminare per l’ufficio come se non stessi lì. «Mi esponga i fatti.» Mi schiarii la gola. «I fatti?» Con una faccia stanca mi diede una sbirciata da sopra i suoi occhiali. «Ha saltato le lezioni per ben due settimane... in clusi i test di metà trimestre, ed è mancata anche oggi. Deduco che sia qui, nel mio ufficio, per darmi una qualche spiegazio ne sul perché non dovrebbe essere bocciata in macroecono mia. Sto aspettando questa spiegazione con il fiato sospeso.» Sospirò, riponendo il libro in uno scaffale. «Penso sempre di averle sentite tutte, ma alla fine riuscite sempre a sorprender mi. Quindi avanti. Non ho l’intera giornata, e credo nemme no lei.» Deglutii. «Ero a lezione oggi. Solo che non mi trovavo al solito posto.» Lui annuì. «Voglio crederle, poiché mi si è avvicinata alla fine della lezione. È tornata a prendere parte alle mie lezioni, e va a suo favore... equivale a circa un quarto di punto. Ma ha sei giorni di lezioni mancate e uno zero all’esame princi pale.» Oh, dio. Come se mi avessero tolto il tappo, gli riversai tut to quello che avevo dentro in un fiume confuso di scuse e di consapevolezze. «Il mio ragazzo ha rotto con me, e lui viene a lezione, e non ce la faccio a vederlo, men che meno a sedermi accanto a lui... oh, mio dio, ho saltato metà trimestre. Sarò boc ciata. Non sono mai stata bocciata in una materia in vita mia.» 27 E come se quel discorso non fosse abbastanza mortificante, i miei occhi si inumidirono finché non scoppiai a piangere. Mi morsi il labbro per evitare di singhiozzare apertamente, fissando la scrivania, incapace di incrociare lo sguardo del professore, che immaginavo avesse assunto un’espressione di repulsione. Sentii il suo sospiro nello stesso momento in cui un fazzo letto di carta mi apparve davanti agli occhi. «È il suo giorno fortunato, signorina Wallace.» Presi il fazzoletto e mi ci tamponai le guance umide. «Guarda caso, ho una figlia solo un po’ più giovane di lei. Di recente ha sofferto per la fine di una piccola storia d’amo re. La mia brillante studentessa con A in tutte le materie si è trasformata in una pappamolle che ha passato il suo tempo a piangere, dormire e ancora piangere... per circa due setti mane. E poi è tornata in sé e ha deciso che nessun ragazzo le avrebbe rovinato il curriculum scolastico. Per amore di mia figlia, le darò una chance. Una soltanto. Se la sprecherà, ri ceverà il voto che ha meritato alla fine del semestre. Intesi?» Annuii versando altre lacrime. «Bene.» Il mio professore venne a porgendomi un altro fazzoletto, un po’ imbarazzato. «Oh, per l’amore di Pete – chiamo così mia figlia –, non c’è nessun ragazzo al mondo per cui valga la pena angosciarsi così. Lo so, anch’io sono stato giovane.» Scarabocchiò qualcosa su un pezzo di carta e me lo diede. «Ecco l’indirizzo email del mio tutor di classe, Landon Maxfield. Le suggerisco le sue lezioni supplementa ri. Senz’altro le servirà anche un tutoraggio personalizzato. È stato uno studente modello nella mia classe, e da qualche anno mi fa da tutor. Gli comunicherò i dettagli del program ma di ricerca che mi aspetto da lei per rimpiazzare il voto di metà trimestre.» Mi sfuggì un altro singhiozzo quando lo ringraziai, e pen sai che avrebbe potuto imbarazzarsi troppo. «Bene, bene, sì, 28 certamente, lei è la benvenuta.» Tirò fuori la tabella dei posti. «Mi mostri dove vuole sedersi d’ora in avanti, così può otte nere un quarto di punteggio per la frequenza.» Indicai il mio nuovo posto, e lui scrisse il mio nome nella casella. Avevo la mia chance. Tutto ciò che dovevo fare era metter mi in contatto con questo Landon e presentare un program ma di ricerca. In fondo non era poi così complicato, no? La fila da Starbucks al circolo universitario era chilome trica, ma pioveva e non avevo voglia di inzupparmi per at traversare la strada fino al bar appena fuori dal campus; co munque dovevo rifocillarmi prima della lezione pomeridia na. Nel mio folle ragionamento, quello era anche il bar dove molto probabilmente avrei trovato Kennedy; ci andavamo quasi tutti i giorni dopo pranzo. Per principio, lui tendeva a evitare le ‘mostruosità delle grandi catene’ come Starbucks, anche se il caffè era migliore. «Non riuscirò mai e poi mai ad arrivare in tempo dall’al tra parte del campus se mi metto in fila ad aspettare.» Erin brontolava, irritata, sporgendosi per vedere quante persone avevamo davanti. «Nove persone. Nove! E cinque aspetta no che venga servito loro da bere! Chi diavolo è tutta questa gente?» Il tizio davanti a noi si girò di spalle con sguardo corrucciato. Lei ricambiò e io serrai le labbra per non ridere. «Caffeinomani come noi?» suggerii. «Puah» sbuffò e poi mi prese per il braccio. «Quasi dimen ticavo... hai sentito cosa è successo a Buck sabato sera?» Sentii un nodo allo stomaco. Il ricordo che volevo cancel lare non mi dava pace. Scossi la testa. «Si è intrufolato nel parcheggio dietro al club. Due tizi volevano il suo portafogli. Probabilmente dei senzatetto, ha detto lui... ecco quello che può capitare in un campus al cen tro di una grande città. Non hanno preso nulla, quei bastar di, ma che diamine, la faccia di Buck è tumefatta.» Si sporse 29 più vicino. «In realtà così è un po’ più fico. Arrapante, sai cosa intendo, no?» Mi sentii male, a stare lì muta e fingere interesse invece di confutare la spiegazione di Buck per come era ridotta la sua faccia. «Be’, stronzate. Dovrò trangugiare un Rockstar per evita re di deconcentrarmi durante la lezione di scienze politiche. Non posso fare tardi... abbiamo un questionario. Ci vediamo dopo il lavoro.» Mi abbracciò velocemente e se ne andò in tutta fretta. Scivolai in avanti nella fila, pensando per l’ennesima volta a quel sabato sera. Eppure non riuscivo a capacitarmi di quanto mi sentissi vulnerabile. Non ero mai stata cieca al fatto che i ra gazzi sono più forti. Kennedy mi aveva sollevata con le brac cia un’infinità di volte; una volta addirittura mi aveva caricata sulle spalle salendo di corsa le scale mentre ero aggrappata alla sua schiena, a testa in giù, a ridere. Al contrario di me, riu sciva ad aprire facilmente i barattoli, o spostava mobili che io a malapena muovevo. Mi ero accorta davvero di quanto fosse forte quando, avvolgendomi in un abbraccio, si era irrigidito e gli avevo toccato i bicipiti. Due settimane prima mi aveva spezzato il cuore e non mi ero mai sentita così ferita, così vuota. Ma non aveva mai utilizzato la sua forza fisica contro di me. No, quello era tipico solo di Buck. Buck, un ficone del cam pus che poteva avere tutte le ragazze che voleva. Un tipo che non aveva mai fatto capire che avrebbe voluto o potuto fe rirmi, o che addirittura si fosse accorto di me, se non come ragazza di Kennedy. Avrei potuto dare la colpa all’alcol... ma no. L’alcol rimuove le inibizioni. Non fa scattare la violenza criminale dove non esiste. «Il prossimo.» Scacciando i miei pensieri guardai dall’altra parte del ban 30 cone, pronta a dare la mia solita ordinazione, e mi ritrovai davanti il tizio di sabato sera. Lo stesso che avevo evitato quel la mattina alla lezione di economia, decidendo di non se dermi accanto a lui. Spalancai la bocca senza però spiccicare parola. E proprio come era successo in quell’aula, mi assalì di nuovo l’immagine di quel sabato sera. Avvampai in viso ricordando la posizione in cui ero stata, cosa lui doveva aver visto prima di intervenire, e quanto doveva considerarmi stupida. Ma poi aveva detto che non era stata colpa mia. E mi aveva chiamata per nome. Il nome che non utilizza vo più da sedici giorni. Fu del tutto vano il mio desiderio che non si ricordasse di me. Ricambiai il suo sguardo penetrante nel quale riuscii a leggere che ricordava tutto, chiaramente. Ogni particolare umiliante. Il mio viso stava andando a fuoco. «Sei pronta per ordinare?» La sua domanda mi distolse da quel senso di disorientamento. La voce era tranquilla, ma sentivo l’esasperazione dei clienti impazienti alle mie spalle. «Caffè americano, grande, per favore.» Le mie parole era no così sussurrate che mi aspettavo mi chiedesse di ripeterle. Lui invece segnò la tazza, e fu lì che mi accorsi degli strati di sottile garza bianca avvolti intorno alle sue nocche. Passò la tazza al barista e batté l’importo della bevanda sul regi stratore di cassa mentre mostravo la carta di credito. «Tutto okay oggi?» chiese, con quelle parole così appa rentemente casuali, eppure così colme di significato per noi due. Passò la mia carta di credito nel lettore e me la ridiede insieme allo scontrino. «Sto bene.» Le nocche della sua mano sinistra erano graf fiate. Quando presi la carta e lo scontrino, le nostre dita si sfiorarono. Ritrassi la mano. «Grazie.» Sgranò gli occhi, ma non disse nient’altro. «Prenderò un Caramel macchiato da mezzo litro... con latte 31 scremato e caramello senza zucchero, non schiumato.» La ra gazza impaziente dietro di me aveva fatto la sua ordinazione attaccata alla mia schiena, senza toccarmi, ma aveva invaso il mio spazio. La mascella del tizio si irrigidì quasi impercettibilmente quando il suo sguardo si spostò su di lei. Segnò la tazza e le servì il tutto con tono smozzicato, guardandomi di sfuggita ancora una volta mentre mi allontanavo. Non so se mi ha guardata anche dopo. Aspettai il mio caffè dall’altra estre mità del bancone e me ne andai di corsa senza aggiungere le solite gocce di latte e le tre bustine di zucchero. Economia era un corso generale, e in quanto tale c’erano parecchi iscritti... probabilmente duecento studenti. Potevo evitare lo sguardo di due ragazzi in mezzo a così tante per sone per altre sei settimane del semestre autunnale, no? 32
Scarica