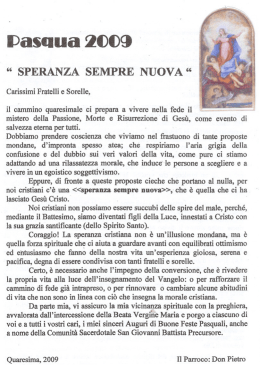Domani cercasi Un vangelo di speranza per i giovani dell’Italia di oggi Tracce di approfondimento e di verifica Un saluto … con alcune integrazioni Buongiorno a tutti! Prima d‘accingerci al nostro confronto, mi sembrano doverose alcune integrazioni rispetto alla presentazione formale che di me è stata fatta (peraltro, in termini assai cortesi e garbati, di cui ringrazio), perché vi mancano (ma non per colpa di chi mi ha introdotto) le cose per me più importanti … mentre il resto, se gradite, potrete pure dimenticarlo ... Di queste integrazioni, vengo subito alla prima. Voi vedete me seduto qui, questa mattina, ma in realtà non sono solo. Qui c’è anche mia moglie, seduta tra voi, e non si tratta della presenza d’un mero accompagnatore. Sono infatti sposato, da quasi venticinque anni; abbiamo avuto dal Signore in dono tre figli (che attraversano, con le loro età, generazioni anche tra voi in buona parte rappresentate); e, in qualche modo, le scelte fondamentali, professionali, di vita e più in generale di responsabilità verso la Chiesa – e la chiesa particolare in cui specificatamente siamo inseriti (cioè la diocesi di Reggio Calabria – Bova) – le abbiamo maturate e condivise lungo un cammino di dialogo e confronto coniugale e familiare. Allo stesso modo, gran parte delle analisi e valutazioni che proverò ad illustrarvi e delle proposte (più o meno provocatorie) che vi potrò fare – ed in una certa misura la stessa traccia d’approfondimento e verifica che forse vi hanno già distribuito per meglio seguire questo mio intervento – sono il frutto di percorsi di studio, d’approfondimento e discussione vivaci, anche animati, essi pure coniugali e familiari. Perciò, anche se voi ascoltate, questa mattina, me; intendetemi piuttosto come il portavoce di un’esperienza, lo ripeto ancora, coniugale e familiare, cioè a più voci, a più cuori, a più cervelli. Anche nel viaggio per arrivare qui, in auto, abbiamo del resto a lungo parlato: si discuteva, in particolare, se intitolare questa conversazione con il punto interrogativo (Un vangelo di speranza?) o con il punto esclamativo (Un vangelo di speranza!) o con entrambi … Ma c’è una seconda integrazione che desidero formulare; perché ben più importanti dei titoli (talvolta pomposi e altisonanti) con cui un relatore viene introdotto sono quelle particolari esperienze da cui poi più specifiche scelte provengono, e tra queste, soprattutto gli incontri (tanti …) con quegli autentici testimoni di santità, spesso sconosciuta ai più, che il Signore consente d’incontrare nei bivi dell’esistenza e che ci mette accanto, talvolta apparentemente come imprevisti compagni di strada, per i suoi disegni di bene sulla nostra vita. Nel mio caso, anche se si tratta di esperienze ormai risalenti, desidero ugualmente farvi cenno: si tratta dell’obiezione di coscienza (rispetto all’obbligo della leva militare) e del servizio civile. Esse, negli anni delicati che hanno in parte preceduto ed in parte accompagnato la scelta universitaria prima, poi l’orientamento professionale e nel contempo la scelta vocazionale matrimoniale e familiare, hanno avuto per me non poco peso; e, con esse, anche alcune persone in particolare 1. Quelli sono stati anche, per me, gli anni dell’apprendistato della maturità, che – grazie all’amicizia d’un sacerdote mio conterraneo (un reggino, filosofo della scienza e del diritto, di cui L. Accattoli ha scritto che, già prima della mondializzazione poi esplosa alla fine del secondo millennio seppe insegnare a molte generazioni di giovani della FUCI “quanto mondo si può conoscere da Reggio Calabria”) – mi hanno permesso di aprire di molto i miei orizzonti mentali e m’hanno offerto l’opportunità straordinaria, imponendomi di conoscere la mia terra – e le sue frastagliate varietà sociali ed ecclesiali – d’ulteriori incontri ad alto rilievo formativo, che hanno inciso in modo determinante sulle scelte di vita che avrei compiuto ed hanno fatto fiorire amicizie che ancora oggi, grazie a Dio, resistono al tempo. Sono stati, quelli, anni assai densi e ricchi, per la storia dell’Italia d’allora: si proveniva dalla fine degli anni di piombo (un incubo per la democrazia ma anche una prova di coesione sociale non indifferente per un paese che scopriva le proprie montanti difficoltà, sia morali sia culturali, che il decennio successivo la crisi di Tangentopoli avrebbe messo a nudo) ed il futuro appariva incerto, ma c’era voglia e passione di contribuire a costruirlo. Anni in cui, nella Chiesa italiana, la vitalità e la forza della profezia animavano l’ordinario rendendolo in realtà “straordinario” (per quanto lasciavano presagire – come nella schiusa d’un orizzonte di luminosa e radiosa primavera – della contagiosa potenza d’utilità sociale e di bellezza etica intrinseca a tanta dedizione ed autentico impegno del volontariato, con la spendita del proprio tempo e delle proprie capacità per il bene dei più sofferenti, emarginati o esclusi, nella realtà civile dei molti Mezzogiorni d’Italia e nell’intero paese). Ormai, però, quegli anni appaiono, probabilmente, già dimenticati, forse ormai superati (come temperie ideale) dalle correnti vicende sociali, di certo smentiti dagli attuali orientamenti di vita di tanti giovani più o meno precocemente adultizzati, di questa tormentata stagione dell’Italia d’inizio millennio. Voi non mi sembrate però (almeno in prima approssimazione) già così avvizzirti, invecchiati ed incartapecoriti. Il vostro essere “per scelta di vita” (e non contingenza stagionale) volontari, in un settore così delicato come quello della prossimità agli ammalati, è già, in qualche modo, una promessa, non una scommessa. So pertanto di parlare a persone che, in qualche misura, anche perché aderenti ad una federazione d’associazioni ispirate dai principi evangelici, hanno già in sé buone (e, mi auguro, molte) ragioni di speranza circa il futuro che ci attende. Una premessa Il tema del vostro incontro di questi giorni, pur in un ambito generalissimo, tratta del rapporto tra vita e legalità. Avete già affrontato questioni specifiche: 1) cosa sia oggi l’Italia (mi auguro abbiate anche, e copiosamente, dibattuto su quale Italia vorreste che fosse quella dei prossimi anni); 2) in che termini esista e vada affrontata una questione “morale”, in questa Italia tormentata dei primi anni di questo terzo millennio; 1 Tra cui mi piace ricordare, per chi l‘avesse conosciuto, don Italo Calabrò – che ha contribuito a fondare la Charitas verso la fine degli anni Settanta, cioè gli anni di mons. Nervo e mons. Pasini e, quindi, di “don” Tonino Bello e mons. Luigi Di Liegro. 2 3) 3) che responsabilità puntuali vadano riferite all’arcipelago delle agenzie informative e formative nell’edificazione di una più buona, una migliore società in cui vivere. Avete anche conosciuto uno di quelli che si usano definire (nel corrente ecclesialese) “piccoli semi di speranza”: i ragazzi di Addio pizzo. Questo tema potrebbe essere declinato in molte, innumerevoli prospettive ulteriori. Ne elenco solo alcune, di quelle che avevo valutato come proponibili entro questa cornice, ripeto, assai generale: - il valore ed il rilievo del diritto nella vita delle comunità; il senso odierno del cd. bene comune; il rapporto tra legalità e giustizia; i meta-principi costituzionali il rapporto tra principi (non solo morali ed etici, ma anche giuridici) e scelte di vita; il fondamento della “vocazione” all’impegno personale e sociale; le forme di una cittadinanza autentica, attiva e responsabile. Dopo aver riflettuto, ho creduto opportuno proporvi un percorso del tutto peculiare, diverso da questi: avete del resto già sentito due colleghi (due magistrati) parlarvi finora e, siccome il terzo avrebbe potuto stancarvi – per troppa omogeneità (vuoi di linguaggio, vuoi di pensiero) con i precedenti – ho scelto di trattare con voi del rapporto tra i giovani, quali voi in prevalenza siete, ed il futuro. Legalità equivale, in prima approssimazione, ordine e certezza nei rapporti interindividuali e sociali. Concettualmente, essa funziona come strumento per assicurare stabilità ad una collettività, ancorandola a principi più o meno condivisi in cui essa possa riconoscersi e che “dicano” come essa vuole proporsi identitariamente. Non preclude (ovviamente) le sperimentazioni, né le sgradisce; privilegia però l’esistente, poco orienta al mutamento. Il futuro equivale invece incertezza, che è condizione obiettivamente sfavorevole alla stabilità ed alla certezza delle relazioni interpersonali, ma appartiene ineludibilmente alla vita e con esso bisogna fare i conti. Spesso, ciò che saremo si può intuire in ciò che già siamo. Più spesso, però, osiamo soltanto ambire di propugnare ciò che vorremmo essere, ma le dure repliche della storia ci restituiscono con i piedi per terra, e l’avvenire costituisce la miglior cartina di tornasole dell’effettiva bontà delle aspirazioni nutrite e del grado di condivisione dei principi in cui una collettività aveva scelto d’identificarsi e delle scelte con cui aveva ritenuto di farvi fronte. Il futuro si può temere e si può desiderare; si può rincorrere, ma anche tenere a distanza; si può subire, ma si può anche concorrere a costruirlo. Parlare quindi del rapporto con il futuro mi è parso più intrigante, in questa sede ed occasione, ed ho pensato di farlo giocando molto sul nesso tra futuro e speranza. Perché per me la speranza è la chiave del rapporto con il futuro. Da qui il titolo del mio intervento: Domani cercasi – Un vangelo di speranza per i giovani dell’Italia di oggi. In realtà, il vero titolo dovrebbe essere un altro: “Io; voi; noi; quale futuro cerchiamo, nell’Italia di oggi?” E la risposta, quella che vi propongo, è la seguente: io, voi, noi, cerchiamo un futuro di vera, autentica speranza. E desideriamo esserne capaci. 3 Entriamo allora subito nel vivo della questione, non senza però avervi prima chiarito con quale spirito e metodologia vi parlerò. Un’espressione in particolare di don Domenico Farias desidero affidarvi, perché rappresenta, per così dire, il filo rosso della proposta che vengo ad illustrarvi, e che ritrovate nella traccia che vi è stata consegnata: a fondamento di qualsiasi capacità di speranza c’è “uno studio che potenzia l’azione”. Ma cosa significa che “lo studio potenzia l’azione”? Significa ciò che, con altro linguaggio, si legge nel NT, precisamente nella prima lettera di Pietro, là dove s’afferma, proprio in riferimento alla problematica della speranza: “dopo aver preparato la vostra mente all’azione, siate vigilanti …”. Il termine “vigilanti”, al di là della problematica di traduzione, è lo stesso che dire: “state svegli!” Ora, lo stare svegli non è semplicemente tenere le antenne tese, per captare, ascoltare, cercare di capire, rendersi conto, quindi un qualcosa che allude esclusivamente all’osservare ed analizzare, ma, evidentemente, è già un agire. E però si dice (nel resto biblico) che questa azione deve essere ben preparata (come suggerisce, ricordatelo, l’espressione “… dopo aver preparato la vostra mente all’azione …”). C’è dunque un’arte da apprendere e coltivare, in cui la capacità di speranza si concretizza, che è appunto un “preparare la mente all’azione”. Ora, io capirei cosa significa preparare l’azione attraverso la riflessione, ma in 1 Pt si legge proprio “preparare la mente all’azione”. Al di là del testo (non sono un esegeta e quindi non sono in grado di formulare una proposta a questo riguardo più accurata), nell’originaria risonanza di questo invito c’è dunque qualcosa di più difficile, di più complesso di quel che potremmo immaginare: perché c’è indubbiamente un’altra dimensione da attingere, e che forse trascuriamo, che in questo preparare la mente all’azione dobbiamo invece riscoprire e rivitalizzare, e cioè quella “contemplativa”. Di solito, la contemplazione è ridotta alla dimensione d’un mero spazio interiore in cui l’individualità si raccoglie e, per così dire, come ripiegata su sé stessa, si proietta in spazi diversi da sé, per coglierne la peculiarità. Ma in realtà, ed a ben vedere, si tratta di qualcosa di ben diverso da una solitudine, sia pure ricercata per una maggiore apertura (di mente e di cuore): come insegnano non solo l’esperienza dell’ascolto della Parola e della frequentazione dell’Eucaristia – i due pilastri su cui poggia la fede del cristiano autentico – ma anche quella dell’adorazione, essa è invece un’esperienza di profonda ed intensa “relazione” (con Dio e con gli uomini e le donne in cui la sua divinità è immersa). E di che indole sia questa relazione, ben lo spiega la stessa etimologia del termine: adorare viene da ad orem, ossia dal gesto del bacio, del contatto intimo con le labbra tra due persone che si esprimono così vicendevolmente il loro volersi bene, il loro aversi a cuore. Una relazione face to face, particolarmente impegnativa dunque, e da vivere nella verità, che è la premessa essenziale di ogni scelta “di vita”, dunque anche di quello “schierarsi” che tempi mai così difficili quali quelli attuali esigono da tutti, e soprattutto da noi. Giovani – Speranza – Il contesto (tra Italia e pianeta “globale”) Soffermiamoci ora sui tre profili delle tracce d’approfondimento e verifica che lo schema distribuitovi propone. Preferisco esordire con il secondo, perché è il più impegnativo da comprendere ed insieme il più arduo da condividere: cosa sia la speranza, per un cristiano, e che rapporto abbia con il futuro. 4 Speranza Il termine “speranza” è molto denso di rilievo, ma difficile da definire. Esso, presentandosi ad alto impatto evocativo e risultando particolarmente suggestivo, ma proprio per questo sfuggente, è assai risonante emotivamente, e dunque molto coltivato, ma pure assai temuto. Il perché s’intuisce bene: il vocabolo allude ad un oltre, di cui non possediamo le coordinate per contestualizzarlo ed inquadrarlo e le chiavi per decifrarlo, ma che equivale felicità vera, non illusione. “Speranza” rimanda sempre, per così dire, a ciò che vorremmo, ma non osiamo (né attendere, né pretendere). Comprende, insieme, il sapore un po’ amaro dell’incerto e quello dolce dell’attesa dell’avveramento di desideri sempre molto intimamente vissuti. Scommette talora poco sul proprio agire e molto più sull’altrui e, se non di passività fideistica o fatalismo, si colora addirittura di teismo (quando non di superstizione). Include, comunque, sentimenti d’ansia e frustrazione in agguato e pretese di gratificazione o troppo vaghe (per non deludersi) o troppo pronte a sopirsi (per non soffrire). E così, di regola, accade che questo oltre di felicità lo si viva come se fosse solo un tempo che verrà in “futuro” ed estraneo alla realtà presente o, addirittura, a quella a venire (in quanto proprio piuttosto dell’idealità). Qualcosa d’inattingibile, che funziona come una sorta di gravità ma è privo di forza attrattiva verso di sé (o, paradossalmente, sprigiona energia repulsiva, suggerendo di non puntar tutto su di essa nel vivere quotidiano, perché se ne restassimo privi ci sentiremmo solo presi in giro dalla sorte e dalla vita). “Speranza” può significare anche altro, invece? Può essere un vivere l’oggi diversamente, in novità, con occhi che sanno accogliere il presente scorgendovi sin da adesso quelle tracce di pienezza, di compimento – dunque, di vera felicità – che vi sono già seminate? La risposta dipende dall’idea di felicità che ci siamo confezionati. Per molti, forse per i più, oggi felicità è benessere (e, primariamente, buona salute). Per noi cristiani, felicità e salvezza (cioè: comunione con Dio) coincidono. E la comunione con Dio (sappiamo intellettualmente) è sempre fonte di bene, di ogni bene. Perché Dio ci ama e vuole essere amato da noi; ed ogni uomo e donna hanno bisogno, insieme, di essere amati e di amare, per vivere felici. Ma le vie del vero Bene e del vero amore che l’icona del sacrificio del Cristo sulla croce ci sbatte in faccia (con il volto tumefatto di un uomo sfigurato da un pestaggio di violenza inaudita, coperto di sputi, sanguinante e con il cuore oppresso dalla volontà di male sperimentata sulla propria carne, e con lo sguardo di fede di sua madre, che ai piedi del figlio morente compie il più disarmante atto di fede pensabile in quel Dio che gliel’aveva dato in dono ed ora non le risparmia tanta sofferenza) sono troppo forti, per quanto tanta nostra mielosa immaginazione vorrebbe invece esprimessero. E contraddicono la ben più rassicurante immagine di felicità d’un volto lietamente sorridente in una luminosa mattina di fine maggio come quella di oggi che, istintivamente, desidereremmo la incarni. Per cui rifiutiamo, non solo istintivamente questa volta, ma avvedutamente, di ritrovarne la declinazione nelle forme disarmanti che essa pur assume: quelle del cinismo e dell’atrocità di tanti delitti spregevoli e dell’inaccettabilità della loro diffusa impunità; del dolore lancinante delle esperienze di molte agonie non curabili e di troppe morti non ineluttabili; della cronicità di sofferenze (fisiche, psichiche e spirituali) logoranti; della sedimentazione di odi e proliferazione di vicende di violenza e vendette, di trascuratezze ed abbandoni, di 5 tradimenti ed inganni, di beffe e di soperchierie, di corruttele e di traffici affaristici, e finanche di puro amore di male che la cronaca (non solo quella nera) ci spinge a giudicare ormai normalità – mentre nulla di normale recherebbero a chiunque le osservasse in sé, ossia decontestualizzate dalla nostra storia presente – di un mondo senza più pace, diritto, giustizia ed amore misericordioso e come disumanizzato che ci tocca di vivere. Ma, anche se non ci piace (e men che meno ci seduce) chi realmente sia Gesù Cristo, e cosa sia venuto a fare e come sia venuto a stare tra noi, resta intatta la verità della sua identità: Dio che, nel Figlio, ama fino alla morte quegli uomini e quelle donne che lo rinnegano, lo tradiscono, lo violentano e lo uccidono e ne fa implodere tutta la drammatica capacità di male di cui sono strumenti in un abisso di bene, redimendone la condizione con l’offrire del tutto gratuitamente questo proprio amore senza misura come unica via di salvezza autentica per l’eternità. Questo insegnamento è duro, straordinariamente arduo da cogliere ed assumere. Ma sbaglieremmo, se attendessimo che ad orientare la nostra vita nelle scelte fondamentali e a darci speranza siano, per esemplificare: la vittoria del giusto sull’ingiusto (ad es. la cattura o la condanna di un killer o di un capo mafioso, o di un imprenditore truffaldino o bancarottiere o sfruttatore, a dar ristoro alle sue vittime, innocenti e non); o del buono sul malvagio; o il positivo del rassicurante epilogo delle nostre iniziative, piccole e grandi (come la prevalenza in una competizione, magari elettorale, che assicura prestigio e potere insieme). La vera speranza, per un cristiano, non ha il volto di un vindice trionfante, o quello sazio di chi ha trovato soddisfazione alle proprie pretese ed ai propri diritti nella vittoria d’un conflitto o d’una gara o, più semplicemente, se la sa cavare e sta bene. Essa ha, invece, il volto sfigurato dell’agnello senza macchia sgozzato; ha il volto ed il corpo violentati di tanti martiri, sofferenti (e finanche uccisi), il cui dolore innocente ed il cui sangue testimonia come l’ultima parola l’abbia il bene, e non (come pur sembra in apparenza) il male. E questo perché il loro cuore non ha odiato, ma ha amato, con fede, fino a dare la vita per i propri nemici. Essa ha il volto di tanti che, sebbene oppressi e sfruttati, delusi, sconfitti, resi irrilevanti, dimenticati, o al più ignorati e resi muti, eppure mai veramente soli ma compagni di strada (spesso generosi e solidali) d’altrettanti marginali, lasciano che la propria integrità non sia scalfita e la loro dignità resti affidata al semplice essere fedeli al gusto della vita buona del Vangelo. Ed è questo che li rende veramente grandi, anche se nessuno li cerca o li coglie come esempi d’umanità piena, e sono loro gli autentici segni della speranza, per questi nostri tempi così difficili, sebbene, secondo logica comune, tutt’altro che “rassicuranti”. E sperare, allora, non significa solo e semplicemente attendere dal futuro il compimento di una salvezza non ancora posseduta. È vero che il senso autentico della speranza integra un orizzonte escatologico, un vivere nell’al di qua come fossimo già nell’al di là; ma questo non significa, come purtroppo sempre più di frequente accade che sia misconosciuto, che vivere il presente non sia già vivere l’eternità. Quando una comunità di cristiani non spera più, in un certo senso è come se fosse già morta: forse annuncia ancora il Vangelo, ma il suo tono diventa stanco, rassegnato, come con la convinzione che non serva più di tanto, perché l’al di qua ha sostituito per lei l’al di là. E pian piano, s’avvia a persuadersi che, molto probabilmente, oggi la via della vita buona tracciata dal Vangelo non sia più seriamente percorribile, che bisogna trovare altre strade, e giunge ad ammettere che valori essenziali del Vangelo di Gesù (gratuità, amore, povertà, piccolezza) siano come cose di tempi passati, ed aggiorna il proprio vocabolario, 6 con nuovi termini–chiave (efficacia, successo, risorse, forza di numeri e di mezzi, ossia potenza) che, nel Vangelo, chiunque faticherà a trovare. Probabilmente, ha esaurito, se non la pensabilità, la stessa “possibilità” della speranza: non si esercita più in questa capacità, in quest’arte di speranza, non sa più orientare le attese della vita nella “grande speranza”. La speranza cristiana, invece, è una vita nuova. Per meglio chiarire questa prospettiva, potremmo dire così: che sperare significa vivere già ora secondo uno stile di vita che “anticipi” il futuro, quel futuro che spetta anche a noi di scrivere, ponendo completamente il proprio fondamento nella pienezza del tempo, nel “compimento” del tempo, ossia nella gloria di Gesù sulla croce che è la più eloquente manifestazione dell’amore di Dio per l’umanità. Ricordate la premessa (della 1 Pt)? Sarebbe come dire: dopo aver preparato la vostra mente all’azione, puntate sempre più le vostre energie sul Cristo, che vi è stato dato, e che in voi sta crescendo e … siate svegli, vigilate … perché nella vita nuova della grande speranza c’è molto da fare ed un alto prezzo da pagare, per far crescere il granello di senapa affidatoci! Uscendo di metafora, per meglio spiegarmi, sul punto mi permetto di proporvi una considerazione del cardinale Martini, di chiarezza evidente, secondo cui la speranza di chi crede in Cristo (la vita nuova di cui parlavo prima) non è l’ottimismo, ed in particolare non è l’ottimismo semplice (quello che ti fa dire: beh, in fondo la vita non mi va tanto male, in qualche modo me la so cavare, alla fine ne esco …). Anche quando fosse possibile affermare questo – perché è possibile vivere un’esperienza di questo genere e questo ottimismo reca in sé una connotazione positiva (che è il riflesso di una condizione felice, frutto comunque un dono di Dio) – la speranza cristiana, comunque, non gli corrisponde: è altro. Perché la speranza cristiana non è sapersi accontentarsi (magari di poco, o a buon mercato …) o anche chiudere gli occhi di fronte a qualcosa che ci appare oscuro, negativo o ineluttabile. Non è, insomma, l’atteggiamento di chi non vuole guardare una storia che si va degradando, pensando che, in fondo, riesce comunque a galleggiare. È ben altro: è volgere gli occhi alla vita buona quale ci viene da Cristo. Ed è al di sopra di ciò che ci può sfuggire di mano (o deludere), perché non dipende da condizioni esterne più o meno favorevoli e perché non è un’ascesi o una via umana che ne assicura l’attingimento ed il possesso. Essa è infatti, innanzi tutto, in un dono gratuito, di Dio; ma, insieme, è anche nell’accettazione di questo dono. E dipende dal sapere elevare lo sguardo, in alto, dove l’esperienza particolare di gloria del Cristo prima crocifisso che mantiene tutti intatti e visibili i segni cruenti nel corpo del risorto della sua Passione emana una luce speciale. Non è solo un guardare al futuro, anche in un mare d’oscurità, senza timore di smarrirsi, come se nell’oscurità (o nelle tenebre) ci fosse qualcosa come una piccola candelina accesa a far luce, che da sola, per quanto tenue e fioca, prevale sul buio che apparentemente potrebbe ingoiarla (ma prima o poi la risucchierà). In questa luce, la speranza non si deprime, né sparisce, anzi: cresce! Più l’esperienza della vita sembra invitare a chiudere gli occhi, a lasciarsi andare, quasi nulla più valesse la pena, questa luce speciale costringe ad aprire invece gli occhi, ad elevare lo sguardo; ed in questo guardare, intensamente, il tutto ed ogni dettaglio, la straordinaria vis di cui l’amore di Cristo, come una gravità attrattiva, permea la storia di ogni uomo e donna nel loro tempo biografico, finisce per far vera chiarezza e rende 7 conoscibili i segni obiettivi della Sua presenza: i segni del Bene e della sua particolare bellezza e contagiosità. Brevemente e riassumendo: la speranza è il saper elevare con fiducia lo sguardo al Cristo in croce, il quale esprime un amore che anche oggi, in questo tempo, sta toccando questi uomini e queste donne in questo territorio. Il vero problema della speranza, verrebbe fatto di dire a mo’ di battuta, è allora quello d’indossare per bene gli occhiali, per cogliere dove davvero siano i segni della presenza del Cristo Risorto nella vita dell’umanità dentro questa stagione particolare che ci è dato d’affrontare. Segni che, molto spesso, non sono dove ce li aspetteremmo: ossia, dove ci sono successo, prosperità, sicurezza, stabilità, a cominciare dal bene fondamentale (la salute fisica). Quando la speranza è veramente fondata sul Cristo, essa sa insieme elevare lo sguardo ed anche abbassarlo, verso le realtà pure le più negative dell’esistenza. E le guarda nella luce del Regno, riconoscendo che già qui ed ora sono beati: coloro che piangono; coloro che hanno fame e sete; coloro che sono perseguitati; coloro che soffrono. La speranza dei credenti in Cristo è dovunque una situazione negativa della vita viene “letta”, accolta ed attraversata con una forza d’amore, un’energia, più grande della sofferenza, della delusione, dello smarrimento. Ed è, anche, dovunque una situazione positiva può essere riconosciuta come un preannunzio di pienezza, con riconoscenza e gratitudine. Questa è la potenza della speranza cristiana, perché ci permette di vedere e di cogliere dove umanamente non potremmo (o vorremmo) riporvela mai, la gloria, ossia l’amore con cui Cristo ci ama, di cui anche noi possiamo essere capaci per gli altri. C’è in realtà anche un’altra definizione di speranza che pensavo di proporvi. La speranza in cui credo Essa riguarda alcuni degli amici che, nella traccia, ho indicato e che desidero raccomandarvi, in questo percorso che oggi ci vede impegnati insieme e per l’estate ormai imminente che ci attende, come compagni di strada per questa nuova vita buona. Questi amici sono tutti dei santi, e tra questi alcuni a me più congeniali e vicini (come i santi italo–greci di Calabria, fioriti nella tradizione monastica orientale della seconda metà del primo millennio dopo Cristo), ma anche alcuni martiri. Tra questi, permettetemi di parlarvi un po’ soprattutto di un francescano, insieme molto e poco noto, che mi sembra sia straordinariamente significativo, anzi esemplare per questa Italia e per questi tempi del presente, in riferimento al tema che ci siamo dati d’affrontare: S. Massimiliano Kolbe. Noi tutti lo ricordiamo perché quest’uomo, presbitero ed apostolo mariano, finito in campo di concentramento nella metà della seconda guerra mondiale (perché polacco, religioso e cattolico), ad un certo punto offre la sua vita per salvare quella di un altro recluso, un padre di famiglia condannato a morte per una rappresaglia dovuta alla violazione di una delle innumerevoli ed infami regole di quell’internamento funzionale al puro sterminio delle sue vittime. S. Massimiliano sceglie di sacrificare la sua vita per offrire una speranza di vita (e di futuro) ulteriore ad un suo più sfortunato fratello di prigionia in quel lager. Racconta papa Paolo VI (nel suo splendido testamento spirituale, dal titolo La gioia cristiana, altro esemplare strumento per comprendere cosa sia per un cristiano sperare in Cristo) che alcuni dei testimoni oculari della vicenda della morte di padre Kolbe – cioè 8 alcuni tra i suoi compagni di prigionia – sentiti durante il suo processo di beatificazione, riferirono d’avere capito ad un certo punto che Kolbe da tempo “pensava” ad un’esperienza di martirio, del proprio martirio, all’interno del campo. Ed avevano cominciato a provare una paura grande, intuendo cosa nell’esperienza di vita spirituale del loro amico stava avvenendo e cosa il santo stava maturando: evidentemente, si trattava di una chiamata particolare che il Signore gli stava rivolgendo, in quei frangenti così drammatici, per il compimento della sua vita, ma loro non l’avevano capito. Tanto che gli avevano anche detto pressappoco così: “… ma tu sei matto! Tu sei prete: sei l’unico che può amministrarci i sacramenti, di cui abbiamo tremendamente bisogno, e che può celebrarci l’eucaristia; sei l’unico che ci può confessare e sostenere spiritualmente a non soccombere del tutto al male e a non odiare mortalmente chi ci sta ferendo ed uccidendo; sei l’unico, insomma, che ci può aiutare a rimanere capaci di umanità. Sei come l’unico barlume di luce, come una fiammella che ci dà ancora senso per vivere. Non possiamo permettere che tu ci abbandoni, e così; non possiamo perderti, non puoi “venir meno” a noi!” E recalcitravano, cercavano di fargli intendere quanto lui fosse essenziale per loro, che sarebbero rimasti (almeno per ora) ancora vivi. Pensiamo per un attimo a quello che è successo anche ad un altro martire, di questa terra che oggi ci ospita, padre Pino Puglisi: i suoi più stretti collaboratori, comprendendo quanto rischio per la sua azione pastorale senza sconti e senza accomodamenti in Brancaccio di Palermo stesse facendo crescere alla sua incolumità, gli andavano dicendo, in un certo senso: “… ma chi te lo fa fare, calma un po’ i toni, abbassa la voce, cerca di non esporti eccessivamente, abbi una certa misura e cautela …”; e lui? Lui tira dritto come un treno in corsa … Insomma, per farla breve: si verificò quello che più temevano e padre Kolbe esaudì quello che aveva capito essere la chiamata di Dio per lui. Con desiderio di adempiere al sacrificio richiestogli, si condusse senza tentennamenti alla cd. buca della morte, vi rimase per circa due settimane sepolto vivo, nel buio di un cunicolo (stretto, malsano, umido e maleodorante), senza né cibo né acqua, e fu ucciso da un’iniezione letale di veleno in vena, perché ancora era vivo quando il carnefice aveva aperto la porta di questa prigione per condannati a morte per sfinimento e la sua fibra mostrava ancora intatta una straordinaria, sovrumana capacità di resistenza (che rende ben chiara la vicinanza a lui del Cristo in croce). Ebbene, proprio allora, questi compagni ed amici, sofferta indicibilmente questa incarcerazione e poi questa morte spietatamente attuata in una così terribile agonia, testimoniarono che in un primo momento patirono l’esperienza della desolazione più cruenta, della povertà estrema (ed in verità avevano effettivamente perso, in un certo senso, l’unica ricchezza che ancora avevano per loro …). Ma poi, come per una paradossale rivelazione, la perdita dell’unico giovamento di cui ancora godevano e questa loro povertà estrema, umanamente parlando insopportabile, spalancarono alle loro menti ed ai loro cuori un’evidenza chiara: che, cioè, erano stati come affrancati, una volta per sempre, da quella paura di morire che li aveva irretiti ed accecati. “Che mi possono togliere ancora? La vita fisica? Ma poi non mi possono fare proprio nulla di più!” Percependo questa sensazione di liberazione, primo frutto del martirio di padre Kolbe fu allora, quasi immediatamente, un effetto inaspettato: nella baracca dove il santo aveva vissuto, e tutt’attorno, vi fu come il prodursi (in loro ed in quanti erano loro prossimi) di un’atmosfera come di serenità, di pace, e tutti questi prigionieri, che avevano respirato quest’ansia, quest’angoscia spirituale durante la sua agonia, anziché inaridirsi del tutto, 9 iniziarono a moltiplicare piccoli e grandi gesti di attenzione e carità vicendevole, e divennero, per così dire, nel tratto e nella relazione personale, altrettanti padre Kolbe! E l’effetto ulteriore fu come quello di una fioritura, in un luogo tetro di tinte buie, di estrema ignominia e fetida bestialità, dove l’uomo stava dimostrando tutto il peggio di cui sa talora essere capace, di tanti piccoli fiori, delicati ma profumati, assolutamente belli, e colorati di una spontanea luminosità irradiantesi naturalmente. E pian piano questa esperienza divenne contagiosa, si diffuse un po’ in ogni dove di quel campo di concentramento. Conclude Paolo VI (è qui il termine di questa lunga citazione): quale miglior esempio per dire cosa siano la speranza e la gioia dei credenti in Cristo! Sono parole diverse, ma il concetto è identico a quello che vi ho proposto prima nelle efficaci metafore del cardinale Martini: saper volgere lo sguardo al Cristo risorto, che mantiene tutte intatte e visibili le stimmate della sua Passione, ci permette di guardare insieme terra e cielo. Questa speranza, molto probabilmente, consiste nella capacità di riconoscere il bene con la b maiuscola, di essere riconoscenti cioè per i doni straordinari che fin dal concepimento (perché siamo concepiti non per quaranta, sessanta, ottant’anni … ed oltre, per i più fortunati …, ma per l’eternità) il Signore ha per noi. Una capacità di riconoscimento di bene e di doni – e, ad un tempo, riconoscenza – che è insieme forte di luce, cioè di chiarezza: quello sguardo superiore che salva se si eleva e se sa anche abbassarsi ed è, in una certa misura, un punto d’approdo, un traguardo, non un punto di partenza; ma comunque un dono. Senza di me non potete fare nulla Questa capacità attinge due dimensioni, sono le stesse citazioni evangeliche a chiarirlo. La prima è: “senza di me, non potete far nulla”; lo dice Gesù, nel vangelo di Giovanni: “senza di me, non potete far nulla”. Chiedete e vi sarà dato E la seconda è “chiedete e vi sarà dato”: la conferma d’un legame d’amore indissolubile; la certezza d’un rapporto essenziale (voluto da Dio senza alcun nostro merito) e di un dialogo (costantemente da Lui ricercato); la solidità d’una promessa (per vivere la vita eterna già qui ed ora) cui la nostra fiducia non potrebbe trovare miglior fondamento. Siate riconoscenti Poi S. Paolo aggiunge un’altra considerazione, che sarà di estremo impegno per capire cosa sia la speranza dei credenti in Cristo, con l’invito: “siate riconoscenti”. Cosa significhi essere riconoscenti nella condizione di malato terminale di cancro, è un terribile punto interrogativo; nella condizione di detenuto innocente, è un durissimo punto interrogativo; nella condizione di oscurità o di cecità o di ricerca (o, peggio, di perdita di fede), è un grosso punto interrogativo. Però c’è una perla, preziosa e bella, ma soprattutto luminosa, mi sia permesso d’utilizzare qui un piccolo slogan, che permette di credere nella vita e di amare la vita; una perla su cui torneremo. E allora, chiediamoci, tutti: 10 è questa la speranza in cui credo? Una chiesa di qualità Nella traccia che vi ho proposto, per cui ho saccheggiato ampiamente alcune riflessioni di mons. BREGANTINI in un suo libretto (dal titolo La terra e la gente. La speranza in cui credo), ci sono molte espressioni evocative, ma molto acute e dense, che vogliono suggerirvi un più specifico percorso di riflessione. Che può significare, anche per voi, l’invito di mons. BREGANTINI ad “una chiesa di qualità?” La vostra è un’associazione ecclesiale. Siete un pezzetto di chiesa. Un piccolo resto d’Israele, come tanti, con un carisma specifico assai impegnativo: quello della vita con i più sofferenti. Ora, la Chiesa non è ovviamente solo gerarchia, organizzazione e strutture; essa è soprattutto popolo di Dio in cammino, cioè persone – ognuna irripetibile - amate da Dio ed in cerca di Lui (anche senza esserne formalmente parte), consapevoli (ma non sempre) d’essere credenti si, ma pure d’avere bisogno che la propria fede sia accresciuta. Lui ha sottolineato, in particolare, in questo testo, di desiderare una chiesa “più giovane” e “aperta”. I due aggettivi sono già sufficientemente chiari, non mi fermo a commentarli. A me, questo tema evoca però altri due profili problematici. Il primo è riassunto in una frase che ho letto alcuni anni addietro (e mi è rimasta scolpita dentro, perché è durissima da vivere, anche se assai suggestiva ed entusiasmante): “la Chiesa si ama per quello che è, non per quello che vorremmo che fosse”. È così, anche per noi? Le siamo fedeli? Si tratta di mettersi in discussione; di mettere in discussione soprattutto la coerenza tra i principi che affermiamo essere la nostra bussola di vita e le scelte, i comportamenti concreti della quotidianità, in cui attuiamo e mostriamo questa necessità di coerenza. Ognuno rifletta, per sé, in un meditato esame di coscienza, in proposito; ma non una tantum, questo è il mio invito: lo faccia costantemente, come stile di responsabilità e di maturità (secondo l’adagio della 1 Pt: “… pronti sempre a rendere ragione della speranza che è in voi …”). In altre parole: ad essere non solo credenti, ma anche credibili, e, soprattutto, creduti. Il secondo è in un bisogno che dovrebbe essere certezza: che, cioè, la Chiesa si vive come la realtà fondamentale, essenziale della propria vita (perché “dove sono due o tre riuniti nel Mio nome, là sono Io …”). È così, anche per noi? Siamo capaci, pur essendole fedeli, di ricercare e riconoscere la verità dei nostri limiti, dei nostri peccati, delle nostre controtestimonianze, quelle situazioni cioè per cui si può dire che se è certa la santità della Chiesa non lo è altrettanto – quanto sarebbe sperabile e pretendibile che fosse – la santità nella Chiesa? Questo difetto, questa nostra mancanza di santità non ci esima allora dal nostro impegno a dirci lealmente che abbiamo bisogno d’essere veri (ossia autentici) e sinceri (ossia franchi, così d’atteggiamenti come di parole), a pretenderlo, vicendevolmente, come quando si ha a cuore qualcosa di troppo essenziale per potersi accontentare di vivacchiare ... Dopo aver seriamente riflettuto e meditato, con amore e con affetto, e con spirito di correzione fraterna, diciamoci allora, sempre, ciò che ci è necessario per crescere. 11 Oggi, non domani Ma c’è anche il problema dell’oggi, e non del domani! La questione escatologica che era adombrata all’inizio della nostra conversazione è più seria di quello che possiamo immaginare, perché noi siamo tentati di pensare che la questione della speranza è una questione di vita eterna, cioè di un oltre che vale per il domani, e non per l’oggi, ossia di qualcosa che riceveremo, non di ciò che già nel presente dobbiamo invece “dare”, spendere, di noi. Oltre, di solito, lo traduciamo in senso cronologico, per noi significa “dopo” (“a poi”, si dice dalle mie parti) e questo “dopo” può nascondere una visione consolatoria e diventare una vera e propria rimozione del tempo presente, equivalente ad espressioni del tipo: “oggi tiro duro”, mi rassegno”, “cercherò d’attrezzarmi, poi ne avrò un compenso”. Una volta sono rimasto colpito da una frase: “se non ci fosse l’inferno, non riuscirei ad accettare tanti soprusi, ingiustizie e cattiverie”, ho bisogno di un’idea della giustizia in cui non c’è solo il paradiso ma c’è anche l’inferno. Come dire: verrà il giorno in cui … Verrà, certo: ma questo non ci esime dal considerare che è già qui, oggi, ora, e non soltanto domani, “il giorno in cui”, ossia il regno di Dio! Uscendo fuori di metafora: dobbiamo abituarci a considerare che questa è già ora vita, e vita eterna. E questo, praticamente, cosa significa? Cambiare è possibile Che questo è ormai il tempo delle scelte e che cambiare non è solo possibile, come leggete nella traccia, ma, in un certo senso, necessario e doveroso ed a tanto siamo aiutati fortemente dal quel riconoscimento (da quella luce e dal quello sguardo che sanno insieme abbassarsi ed elevarsi) e da quella riconoscenza, quella gioia che l’esperienza di un amore senza misura di Dio per noi può suscitare. C’è un altro santo, che mi permetto ora di porre alla vostra attenzione come compagno di strada per questa nuova vita buona, anche se non l’hanno ancora elevato agli onori degli altari. È don Andrea SANTORO. Sapete tutti chi è? Anche lui un martire. Un martire di specie diversa da quella di padre Kolbe. Era un sacerdote della diocesi di Roma, incardinato quale donum fidei in Turchia, prestato cioè alle povere e quasi scomparse chiese di questa terra straordinaria (la Terra santa seconda, come dicevano i padri orientali) ed ucciso da un integralista islamico, in circostanze e per ragioni rimaste tuttora assai oscure, di sera, nella sua chiesetta mentre era intento a pregare. Martirio proseguito, nell’anno trascorso, dal suo vescovo (mons. PADOVESE), pugnalato dal proprio autista, egli pure musulmano. E c’è un libretto, costituito dalla raccolta delle lettere scritte alle comunità parrocchiali cui raccontava, in guisa di diario quotidiano, la propria esperienza spirituale di missionario tra la gente del Nord Ovest turco, in cui i cristiani costituiscono oggi una percentuale quasi nulla per la popolazione residente (a Iskenderun poco più di un migliaio; ad Odessa, molti di più, quasi ventimila, prevalentemente ortodossi). A un certo punto della sua vita, don Andrea chiede di andare a Gerusalemme per un pellegrinaggio: è un periodo di difficoltà, di forte interrogativo sul senso del proprio sacerdozio, peraltro di straordinario rigore interiore ed esemplarità nelle condotte, e da quell’esperienza partorisce il bisogno, per sé, per la propria vita e per la Chiesa, di essere testimone come presbitero in una chiesa di frontiera, di minorità. Chiede di andare nella chiesa paolina di Turchia, ad Harran ed Urfa. Sono i luoghi della rivelazione di Dio ad Abramo, nella regione armena (quella dell’Ararat, dove l’arca di Noè 12 sarà depositata al ritirarsi delle acque dopo il diluvio universale e dove ha il suo vero e proprio inizio la storia della salvezza per l’umanità); ma sono anche i luoghi in cui i cristiani hanno vissuto nei primi anni del ventesimo secolo la tragica esperienza di genocidio consumato contro di loro dalla rivoluzione laicista di Kemal Ataturk nei cd. 40 giorni del Mussa Dagh: genocidio che le chiese occidentali non avevano conosciuto quasi per nulla nella loro entità ed avevano per così dire negletto (i mezzi di informazione di massa non erano del resto quelli attuali), cogliendone il reale significato solo dopo l’orrore dei lager nazisti, e che invece le comunità ebraiche della diaspora avevano subito percepito come una prova anticipata di shoah. Don Andrea è parroco anche a Trabzon: un porto di frontiera sul mar Nero, popolato dopo l’apertura delle frontiere dell’ex Unione Sovietica da molti pendolari dei cantieri navali ed edilizi dei tanti insediamenti residenziali per turisti europei ed americani di quelle coste bellissime, ed anche la cittadina numero uno per prostituzione in tutta la Turchia. Questo lo scenario che don Andrea va ad affrontare, con uno stile che in questo libro, che vi consiglio caldamente (sarà un ottimo sussidio per quest’estate, se lo vorrete assaporare), emerge chiaramente: un atteggiamento esemplare di un uomo di fede, di vera fede. Noi siamo abituati a pensare che aver fede sia credere; che avere fede significhi riconoscere che Dio esiste, che ci ha creato, che ci ha dato questo pianeta per viverci. No, non è questa fede, o, almeno, la vera fede: anche il demonio crede che Dio esiste, ma non lo ama, affatto, anzi, lo odia e gli è profondamente ostile, così come odia con profonda ostilità ogni essere umano, ogni creatura, perché amata da Dio. Il demonio dunque ha fede, nel senso della credenza, della conoscenza, ma non nel senso della fiducia in Lui, dell’amore per Lui. Don Andrea SANTORO è un uomo che ha capito perfettamente che il problema vero, il bivio della fede per la vita è questo: che significhi la fede non come esperienza di mera conoscenza, ma di amore. Fatta esperienza d’aver ricevuto l’amore senza misura di Dio, questo amore non si può non spenderlo, non si può non restituirne almeno un po’, almeno una briciola di quello che si è ricevuto; non si può cioè non amare a propria volta con un amore vero, che può chiederti tutto, anche il sacrificio della tua vita qui sulla terra. Questo è ciò che don Andrea ha capito, per cui, come nel caso del mercante, trova la perla preziosa, va, vende tutto, la compra ed è felice. C’è una bella espressione di Benedetto XVI per un’omelia del giovedì santo di alcuni addietro – quella della lavanda dei piedi (per intenderci) – che ci rammenta che dobbiamo prestare il nostro corpo a Gesù Cristo, oggi, per renderlo visibile: non è cosa da poco, ma grossa. E d’altra parte è quello che ha fatto non solo don Andrea, ma anche padre Pino PUGLISI (pure lui martire per fede, cioè per fiducia, ossia per amore), quando ha vissuto il suo ministero morendo di morte violenta perché semplicemente prete, fino in fondo, e non (come pure taluno pare preferire di ricordare) perché “prete antimafia”. Sono figure, mi rendo conto, la cui biografia non sembra, in prima approssimazione, pacificante o rassicurante: è inquietante, piuttosto. Eppure, ci ricordano che quando giunge il tempo delle scelte decisive per la vita, non si può essere tiepidi (né freddi né caldi, si legge nel Vangelo). Gesù stesso (con un accento decisamente “forte”, forse inconsueto) ha detto: “se siete tiepidi, vi vomito”. Immaginatevi che pesantezza allora può esserci in una vita spesa con questa modalità, con questo spirito, con questo sentimento e cosa, invece, può essere una vita spesa per fede, e con fede! 13 GIOVANI Veniamo ora all’altro termine (ed al secondo profilo) della nostra riflessione . Chi è giovane, oggi? Nell’antico diritto romano, dopo gli infantes minores (fino a cinque anni d’età) e quelli maiores (fino a quattordici anni), vi erano gli adulescentes (“coloro che si irrobustiscono”, noi diremmo: “si fanno le ossa”, si allenano; fino ai ventuno anni d’età) e quindi gli iuvenes (coloro che “sono in rigoglio”, che erano identificati nello scaglione anagrafico fino ai trenta anni). Solo ulteriormente (e fino ai quarantacinque anni) si parlava di viri, ossia di adulti, e quindi di senes o seniores (i quali erano tutti coloro che avessero maturato, oltre i quarantacinque anni e normalmente intorno ai sessant’anni, un’esperienza sociale rilevante e sperimentata nell’adultità tale da ammetterli alle responsabilità pubbliche più gravi, come il fare le leggi; diremmo, il motore di una comunità organizzata, i facitori della legalità). Voi avete varie età. La maggior parte di voi, ne sono certo, si definisce e si riconosce “giovane”; ma fino a quando durerà questa stagione e quanto è invece già esaurita? Secondo l’ultima indagine statistica qualificata sull’argomento, che troverete nella pubblicazione L’eccezionale quotidiano, dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza, probabilmente sarete inseriti nelle scaglione di coloro che sono definibili young for ever, e non per scelta, ma per necessità, dettata dalla precarietà dell’inserimento lavorativo e della stabilizzazione della posizione personale, familiare e sociale. Precarietà che, indubbiamente, riguarda anche e soprattutto l’aspetto vocazionale, ossia quello delle scelte fondamentali (tra cui essenzialmente l’autonomizzarsi sia in senso economico sia in senso abitativo, l’instaurare o meno un legame affettivo significativo, metter su una famiglia, avere dei figli, etc.). Sulla cd. questione giovanile si potrebbero dire tante altre cose, ma a me interessano due messaggi da trasmettere, in particolare. Vi si potrebbe definire “coloro che sono in stand by”, e non vorrebbero più di tanto rimanerci, né così a lungo (come sembra pronosticabile che debba avvenire, per il prossimo quinquennio almeno). Quelli del “non già” e del “non ancora”, che affrontano la condizione problematica di chi cerca un domani, e non un evanescente ed incerto futuro, ma che non sa se e quando esso potrà mai avere concretezza in un progetto di vita (che sia attuabile in approdi e traguardi reali). Cercate di smentire, allora, questa sottovalutazione del vostro indubbio potenziale. Ma avete difficoltà supplementari. In primo luogo, sperimentate la triste carenza educativa dei vostri adulti di riferimento, cioè la povertà da deprivazione di cura educativa e da non comunicazione (per deficit d’adeguata maturità) tra generazioni che il tempo presente sta accentuando viepiù e che rende assai disagevole la transizione all’età delle scelte responsabili ed impegnative, se non proprio irrevocabili. Detto incidentalmente: si parla della condizione giovanile come quella latrice di disagi a vario e largo spettro, mentre (come ho sentito una volta in un convegno) “disagiati sarete piuttosto voi adulti; noi non ci sentiamo affatto tali!” In secondo luogo, vivete tempi di radicale e diffusa problematicità e di crisi dei rapporti di coppia, intesi come fondamento proprio d’ogni vocazione familiare, e di paura di rapporti stabili. 14 La stagione che vi è dato di vivere propone dunque, in linea generale: paura di futuro; paura di legami stabili e permanenti; difficoltà di ottimismo (anche solo semplice, nel senso che avevamo accennato); e queste, che sembrerebbero essere le coordinate attuali del “pianeta giovani”, per come disegnato almeno dalla indagini sociologiche più accreditabili, non sono prospettive certamente né gradevoli né intriganti. Dimostrate, allora, di fronte a tempi così impegnativi, che la pasta di cui siete fatti è quella di autentici protagonisti, non di gregari disposti solo a subire. Ma, in un simile quadro, è possibile pensare a sogni, a progetti, a utopie? Ed è possibile, poi, avere forza di profezia? Il contesto (tra Italia e pianeta globale) Quello che ho sintetizzato prima circa la condizione giovanile è un po’ il quadro riflettente l’assetto ordinario della vita quotidiana dell’Italia come paese reale. Ma la criticità del caso Italia è, per così dire, più profonda, culturale ed estesa allo stesso piano istituzionale. Il mio contesto, tra Italia e pianeta globale Dopo una “seconda repubblica”, mai istituzionalmente formalizzata ma concretamente impostasi (“a prescindere” dalla Costituzione vigente), galleggia oggi una “terza repubblica”, insieme “virtuale” e “reale”. Non è ancora (giuridicamente) nata, ma è già concepita, tanto che è facilmente osservabile (negli ambienti privati ma anche in piazze, scuole, e pure negli ambienti ecclesiali) e mostra di sé caratteristiche inquietanti. Nelle famiglie di fatto ed in quelle di diritto; nei figli nati e in quelli non voluti (o rifiutati); nelle sofferenze delle relazioni affettive ed educative; nel selvaggio competere e soccombere dei più (nei mercati della produzione e del lavoro); nel crescere di nuove povertà; nell’eclisse della solidarietà verso i più deboli; nell’apatia strisciante, crescente fino alla disaffezione, verso la democrazia partecipativa e nel rifiuto in quanto tale dell’impegno (civile); nella crisi dello Stato, sia nel modello del welfare sia in quello del (più recente) neoliberismo. I colori del mondo: i Sud e i Nord E mentre il pianeta sembra segnato da un tempo d’epidemia collettiva, che ha sradicato molti da una speranza solidamente fondata circa il futuro, è diviso tra i Sud che faticano a sbarcare il lunario e vedono accentuarsi il rischio di una loro marginalizzazione sempre più accentuata ed i Nord che isteriliscono in un presente consumistico ed inaridiscono nella difesa ad oltranza della loro pretesa (e presunta) superiorità di know how, in realtà senza spessore né prospettiva, anche lo scenario nazionale e quello locale stanno manifestando problematicità inquietanti: il non riuscire a proporre un patto, un nucleo di valori rappresentativi di un modello di comunità in grado d’integrare in sé generazioni diverse (native ed immigrate, anziane e giovani); il non saper riconoscere e vivere virtuosamente i mutamenti delle forme e delle regole della democrazia e le nuove forme di partecipazione e dialogo che si vanno diffondendo; il non saper rendere più efficienti ed insieme meno costose le istituzioni di governo delle comunità (a qualunque livello: pensiamo alle circoscrizioni …). Nel caso poi dei diversi Sud di questa stessa Italia sempre più sofferente, divisi ormai anche nell’immaginario diffuso dai suoi Nord più opulenti ed altezzosi, quattro in 15 particolare sono le caratteristiche più attuali del caso serio ulteriore di questi territori che desidero evidenziarvi: - la modernità estenuata, nel contesto di una modernizzazione senza sviluppo; e cioè: la diffusione di stili di vita che non abbiamo contribuito a progettare, né a realizzare né in qualche misura ad alimentare), per cui notevoli sono l’omologazione e l’indifferenziazione, prevalentemente – ma non esclusivamente – tra le generazioni dei giovani, che rendono i calabresi assai somiglianti a persone che vivono stabilmente in aree territoriali, culturali e geografiche notevolmente distanti da loro, ma nel contempo sostanzialmente gregari nell’esperienza del confronto e della crescita rispetto ai non calabresi e privi di memoria circa le loro radici (in una scuola della mia provincia, un liceo classico del resto, m’è capitato che gli studenti non sapessero dove e cosa fosse la Magna Grecia …); - le vicende di migrazioni frequenti e intense (sia immigrazioni, sia emigrazioni), che stanno rendendo l’aggregato dei conviventi sul medesimo territorio non più un vero e proprio popolo, bensì una mera popolazione; accadimento, questo, che, nella storia recente del Mezzogiorno (già caratterizzata da anomia ed alegalità diffuse tuttora assai problematiche), favorisce l’ulteriore disamore verso la terra d’origine e lo smarrimento delle sue radici, con una seria perdita di aspettative e di speranza verso il futuro di chi abbia la disavventura – come molti giovani – di dovervi comunque continuare a vivere (senza neppure più poter nutrire utopie positive quanto al loro futuro) all’insegna della mera sopravvivenza immediata; - la cd. questione istituzionale, cioè quella del divario tra cittadini e loro rappresentanti politici (forse mai come oggi acuto); - il perdurare della radicata, dilagante e diffusa presenza oppressiva mafiosa (sul punto non sono necessarie chiose specifiche da parte mia). Le nuove povertà, i nodi da sciogliere I nostri sono così diventati tempi difficili, rispetto ai quali le nostre capacità d’analisi appaiono chiaramente insufficienti ed annaspanti e non in grado di renderci protagonisti di progetti efficaci di futuro già nel breve periodo: tempi di nuove povertà personali (le fragilità e le malattie, anche spirituali, di tanti) e collettive (con la grave sofferenza della democrazia partecipativa), di deficit evidente nei bilanci esistenziali delle positività ed incremento delle negatività. È vero che, diverse volte, i vescovi del Mezzogiorno sono intervenuti, con documenti di varia qualità e fortuna, a sollecitare prassi virtuose che inneschino percorsi di verità, di coraggiosa proposta, di denuncia capillare e tenace d’ingiustizie e malaffare, ed hanno rivendicato un rinnovato patto unitario, che attui la solidarietà tra territori e municipalità e respinga tentazioni secessioniste o chiusure egoiste dei più privilegiati verso i meno avvantaggiati. Per tutti, vorrei ricordare l’esemplare enunciazione dell’invito formulato dalla Conferenza episcopale calabrese pochi anni addietro (con il triplice “annunciare/denunciare/rinunciare” di un messaggio di una certa notorietà nell’ambiente non solo ecclesiale): apparentemente 16 soltanto dei verbi, ma, nella sostanza, soprattutto scelte pesantissime, durissime, per le implicazioni che recano. La strada, comunque, è tutta in salita. Per darne conferma, vorrei raccontarvi un breve aneddoto, che mi sembra ben rifletta un sentir comune ormai: prima di venire qui, confrontandomi con alcuni amici sul nostro tema di oggi, ho chiesto loro: “se vi invitassero, voi, cosa direste a dei giovani cui vi è chiesto di parlare di speranza e di futuro, oggi, in Italia?”, qualcuno di loro mi ha risposto “io andrei da un’altra parte … “ (ossia, preferirei non andarci, non parlare, oppure scappare). Ad ogni modo: il denunciare, credo che un po’ tutti intendiamo cosa significhi, e quanto sia nel contempo necessario; il rinunciare, invece, credo sia un momento d’estrema prova e difficoltà: ma quando giunge il tempo in cui le scelte devono essere fatte (e questi sono tempi di scelte, non d’attesa guardinga e di smarcamento continuo dalle difficoltà), l’annuncio ci sia e sia esemplare, non una controtestimonianza. Tanti sono però i nodi da sciogliere: un esempio, per tutti, la questione delle pratiche di clientelismo (che sono, nel delicatissimo intreccio pubblico/privato scaduto profondamente nell’ultimo decennio un riflesso della crisi della partecipazione alla vita democratica e della cittadinanza attiva e responsabile donde trae origine l’odierna contingenza italiana di gravissima crisi di bene comune da tutti constatabile). Io … noi … Testimoni di speranza? Chi e come oggi è, o può essere, testimone di speranza? Quanti, tra noi? Tutti? E dei giovani, in particolare, “possono” o “devono” esserlo? E può, ancora, un non credente essere testimone di speranza? Di quale speranza? La domanda può essere espressa anche in un’altra forma. In questa sala sono rappresentate tante età, tra loro anche abbastanza distanti, e molte stagioni di vita. Ognuno di noi, credo, riesce bene a percepirsi, in questo momento, nella sua irripetibilità, nella sua individualità, ma, quale vero e proprio microcosmo, temo anche esaurisca questa percezione ponendosi come al centro dell’universo (o di quella porzione di universo che riesce a cogliere dal proprio personale punto di vista, con la propria biografia) e quindi mantenendo la cattiva abitudine di pensare al futuro in termini troppo privati o addirittura individualistici. Abitudine che ci rende poco attenti e poco disponibili a cogliere e valorizzare i momenti sociali della nostra esistenza protesa in avanti. La lettera agli Ebrei ci dice che però un cristiano non ha qui, cioè in terra, una città permanente, ma è in cerca di una città futura. Il Paradiso, la Gerusalemme celeste, l’oltre, la parusia, l’escatologia di cui parlavamo prima, certo: ma anche l’oggi, quell’oggi così intriso di vera speranza del riconoscimento del quale abbiamo, credo compiutamente, chiarito il rilievo e l’importanza. Ed allora: io; voi; noi; quale futuro cerchiamo? Quel Domenico Farias di cui vi aveva narrato in principio ha molto ben scritto, al riguardo (ed era in agonia per un cancro, quando ha pubblicato un articolo di cui proverò a darvi qualche breve lettura su questo nostro tema; cancro che l’ha ricondotto a Dio appena una settimana dopo …) che davvero complessa ed ardua è la presa di coscienza dei tempi sociali. È molto più facile per un uomo, al passare degli anni, progredendo nella conoscenza vissuta della propria esistenza, capire il senso dell’infanzia, giovinezza, maturità, 17 vecchiaia; e queste sono fasi della vita che diventano senza troppa difficoltà memoria, diario, autobiografia, Capire, invece, che anche una comunità nasce, cresce, declina ed alla fine si estingue richiede molta sensibilità in più. È però vero che in situazioni storiche eccezionali (non c’è bisogno degli tsunami e degli incidenti nucleari recenti del terremoto giapponese per rammentarcelo) “i rapporti tra l'individuo che progetta il proprio futuro o che almeno, in qualche modo, si dà da fare per sopravvivere, e la società circostante – ultradinamica, o invece sclerotizzata, o addirittura in agonia – possono farsi molto drammatici.” L’individuo può vivere dolorosamente eventi che costringono, volenti o nolenti a riconsiderare globalmente i fondamenti più elementari della convivenza, o addirittura decidere di tagliare i ponti e scappare. Scappare … ma dove? Ci sono paradisi in terra? E perché scappare, poi? I tempi difficili sono un po’ dovunque oggi: noi italiani, francesi, inglesi etc. in cerca di un'Europa metaeconomica la cui costituzione giuridico – politica appare sempre più nebulosa, stiamo assistendo quotidianamente all’esperienza di centinaia di extracomunitari che arrivano (praticamente ormai da ogni parte) e che non solo sono alla ricerca, ma sono in fuga, verso un'altra patria di cui ignorano tutto o quasi. Gli basta, in qualche modo, sopravvivere. È o no, questa, per loro e per noi, un’esperienza seria di prova di fede? In questo contesto le parole "non abbiamo qui una città permanente, ma ne cerchiamo una futura” possono essere qualcosa di più di una semplice suggestione, a patto che non siano mera descrizione della nostra cronaca quotidiana, ma assunzione d’impegni di vita. Volenti o nolenti, che lo sappiamo o no, siamo già avviati a questa città futura: - sia che siamo extracomunitari senza futuro, perché senza pane e disperati di poterlo avere; - sia che siamo extracomunitari che hanno il sogno di poter soccombere in quella malintesa forma di santità che è il terrorismo dei kamikaze (che danno morte e si danno morte in quella che per noi è un’insensatezza nichilista totale ma che per loro è via di paradiso) come se fosse quella la frontiera per attingere il vero e desiderabile futuro; - sia che siamo comunitari senza futuro, perché non sappiamo se e come prolungare negli anni avvenire uno standard di vita (cioè un consumismo) quale non si era avuto mai nella storia dell'umanità; e condividiamo la stessa temperie storica ed epocale d’incertezza sul futuro. Qualche mattina fa, in supermercato, la radio che accompagna i clienti negli acquisti dava notizia di uno studio recente sull’opportunità o meno per i genitori d’acquistare un telefonino per i bambini di età fino a sette anni, che sempre più lo richiedono … perché in realtà si è accertato che già ne possiedono più di uno, e non si tratta solo di quelli dismessi dagli adulti di riferimento – perché ormai tecnologicamente obsoleti o guasti – ma anche di quelli ricevuti in dono, magari in occasione di ricorrenze ordinarie o straordinarie, fruiti non come strumenti di comunicazione bensì come strumenti di gioco, meglio, quali gadget per il quotidiano. 18 Fino a vent’anni fa, però, a Sarajevo, per una guerra altrettanto insensata ed un conflitto interetnico di cui tuttora le popolazioni salve patiscono le dolorosissime conseguenze, giovani della vostra età e condizione sociale soffrivano fame e sete, non avevano più l’elettricità – non per connettersi ad internet, ma per illuminare le loro buie paure notturne di bombardamenti, saccheggi e pulizie etniche inaudite – e rischiavano la vita sotto il tiro dei cecchini per attingere una piccola riserva d’acqua giornaliera alle poche fontane accessibili nelle strade dopo il sabotaggio degli acquedotti urbani o azionavano congegni antidiluviani a manovella per fornire con generatori di fortuna o improvvisati un po’ d’energia elettrica ai dispositivi essenziali d‘una casa moderna, mentre voi oggi sareste in sindrome d’astinenza se non poteste ricaricare tranquillamente i vostri lettori o ipod scarichi… Ma anche il proliferare delle polizze assicurative di un decennio addietro e l’economia finanziaria parassitaria della cd. bolla speculativa di due anni fa ci rammenta di tempi in cui il denaro ed il benessere da esso ritraibile sono stati e continuano purtroppo ad essere l’unica bussola delle scelte di vita di molti, come se il futuro ce lo si potesse comprare o assicurare – in tutti i sensi – a buon mercato e con un utile netto a rendimento garantito e l’unico obiettivo sia quello di dare ai figli una casa, un conto in banca, una rendita consistente per il primo avviamento della loro autonomia! Ma siamo davvero sicuri noi adulti già maturi (almeno anagraficamente) che si sarà, di qui a dieci – vent’anni, ancora un mondo da vivere per questi nostri figli? O avremo problemi dì inquinamento, di mancanza tale di risorse essenziali – come l’acqua, cd. risorsa non rinnovabile, la cui penuria è causa di desertificazione crescente di molte aree continentali e é considerata come l’oro blu, la risorsa strategica determinante molto più del petrolio per l’equilibrio planetario dei prossimi trent’anni – da far rischiare loro l’autentica sopravvivenza? Non dimentichiamo, poi, che negli USA è tuttora fiorente la vendita di bunker antiatomici, ossia di costruzioni ad uso abitativo stabile sicure in caso di cd. allarme rosso, con kit d’autosufficienza per circa tre, quattro settimane e che già oggi, ad Atlanta, vi sono quartieri iperprotetti concepiti dagli architetti, per la difesa dei loro residenti dalla criminalità comune ed ordinaria, non più come gli attici a vetratura totale della Manhattan eternata da Woody Allen, ma come antichi castelli feudali, muniti di finestre a feritoia antintrusione con potenziata illuminazione artificiale interna – ovviamente, surrogatoria di quella naturale – e ricostruzione in ambientazioni virtuali dei paesaggi non altrimenti godibili – e di sofisticate barriere con riconoscimento contestuale delle impronte papillari, dell’iride e del timbro vocale per ammettervi all’ingresso chicchessia. E d’altra parte: se ci sono fior di analisti e tecnici che studiano tali trend ed offrono soluzioni pianificate di sicurezza siffatte, accessibili peraltro solo a chi se le può permettere, è segno evidente che l’attuale stagione d’incertezza non fa presagire nulla di buono all’orizzonte, ed anche: se gli armamenti démodés di Gheddafi – che pure massacrano come quelli ultratecnologici di Obama – la fanno da protagonista sui media e paiono monopolizzare l’attenzione; altrove rimangono del tutto attuali le gravi ansie derivanti: da un Iran in belligeranza totale con l’occidente; dalla polveriera sempre attuale – non a caso, del resto, perché, in un certo senso, tutto si tiene, don Andrea Santoro aveva fondato un’associazione, Finestra sul medio oriente, proprio per coltivare la pace nell’area più instabile del pianeta … – del medio oriente; dai regimi ambigui dell’estremo oriente asiatico; e non sappiamo che scenari andranno a disegnarsi nel futuro immediato e prossimo: se, cioè, soffieranno venti di pace o si determinerà quel conflitto globale distruttivo preconizzato da Jeremy Rifkin (nel notissimo saggio sullo scontro delle civiltà e sul nuovo 19 ordine mondiale che ne potrebbe scaturire), dopo l’avvento dominante sulla scena della Cindia e del suo modello di sviluppo. Un modello che prevede: un degrado crescente fino all’insostenibilità dell’ambiente (di cui le gru da tonnellate dell’urbanizzazione a cementificazione spinta di molte megalopoli cinesi ed indiane sono l’emblema più eloquente); lo sfruttamento senza remore o pudori di sorta dei lavoratori (pura risorsa produttiva, o “materiale umano”, come si usa definirli); strategie aggressive e incursioni speculative più o meno selvaggiamente gestite sui mercati mondiali (nella conquista di quote di clientela e di proprietà azionaria) ed impiego cinico di qualsiasi capitale disponibile previo suo lavaggio e riciclaggio accurato (tanto, pecunia non olet …); nessuno scrupolo deontologico e libera recedibilità dai patti assunti; sinergia tra potere politico (militare e poliziesco) ed economico-finanziario; estrema spregiudicatezza nella gestione di rapporti internazionali. “Riusciremo in questa contingenza a non dimenticare le pagine più semplici del Vangelo che tante volte proprio di questo parlano e ci istruiscono? O saremo così sciocchi da pensare che ci sia qualche potere umano così forte da poterci togliere il futuro?” In un cartello si è letto, una volta, questo slogan: “la mafia è potente, ma Dio è onnipotente”. Certo, è così; ma Dio non è solo onnipotente: indubbiamente questo è uno dei i suoi titoli, ma io ne preferisco un altro, quello d Dio padre (un padre buono, un padre misericordioso). Ed il futuro è di Dio, Lui è la nostra speranza, cioè un futuro “sempre aperto”. Un futuro, per dir così, che sembrerebbe almeno in parte già scritto, ma non lo è del tutto: perché spetta a noi, a voi scriverlo, nelle tante pagine bianche di questo libro aperto. Noi possediamo oggi l’alfabeto di questo futuro, forse non anche una grammatica; di certo, non abbiamo ancora una sintassi. Abbiamo però molte, e buone, ragioni per vivere gioia e speranza in questi nostri anni così difficili, cioè per vivere situandoci nello sguardo luminoso di Dio, riconoscendovi il Suo disegno di bene per ogni uomo e donna Suoi figli ed amando a pieno questo tempo. Questo non é un tempo, insomma, da fuggire, ma di grandi opportunità di bene e l’avvenire cui possiamo contribuire è alla nostra portata, perché è un futuro aperto. Io desidero salutarvi – e vi ringrazio d’avermi accolto ed ascoltato con così tanta pazienza e cura – con l’auspicio che l’esperienza di questo incontro sia stata positivamente inquietante, per tutti noi: il lievito ed il sale, nella massa, funzionano se e quando scompaiono, lo sappiamo tutti, ed il problema maggiore è quello di quando il sale perde il suo sapore ed il lievito non fermenta più. L’augurio è che ci aiutiamo, nell’esperienza della Chiesa, ad essere come il buon sale ed il buon lievito (che ci sono, ed infatti si sentono – perché danno un certo gusto, che si riconosce – ma non si vedono … perché spariscono). Ed io lo faccio subito … Grazie ancora a tutti! 20
Scarica