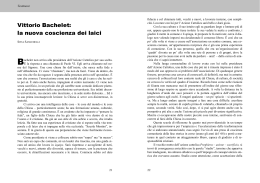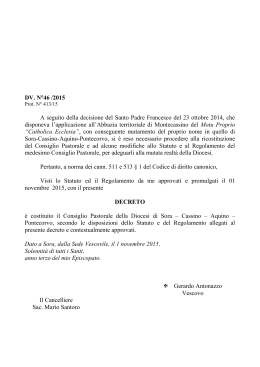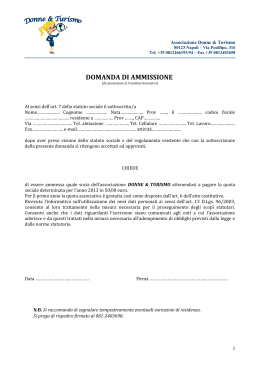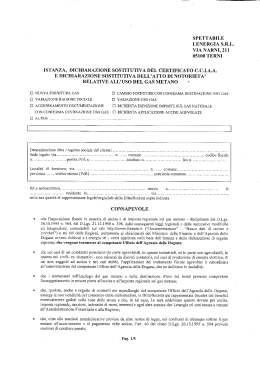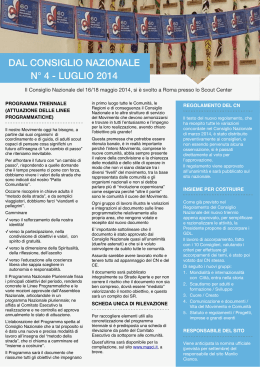AZIONE CATTOLICA E SESSANTOTTO: CHE COSA RESTA?
Che cosa resta del Sessantotto?
Comincerò con una breve testimonianza. Nel Sessantotto ero in Fuci. Da studente tra
il 1961 e il 63 avevo organizzato al liceo di Brescia una “prefuci” con l'aiuto di due padri
filippini, Manziana e Bevilacqua. Già allora parlavamo di riforma della Chiesa e di cultura
critica, riforma della scuola e della società. Si facevano manifestazioni, si voleva
democrazia nella scuola. Lì mi ricordo le prime manganellate, le trattative con la polizia. Mi
ero poi laureato alla Cattolica di Milano, in Legge, ai primi di novembre 1967, il clima era
già acceso, avevo partecipato a dibattiti e a educatissime “occupazioni” da vari mesi.
Appena laureato mi iscrissi a Filosofia (che presto lasciai sia perchè mi trasferii a Roma per
fare il giornale della Fuci, Ricerca, sia perchè la cultura accademica stava diventano
l'oggetto delle nostre critiche...
Devo dire che per noi fucini di quegli anni, il Sessantotto non fu una gran sorpresa.
Anzi, ci ritrovammo facilmente nel clima di anticonformismo e in quello stile critico verso
la politica e la cultura dominanti. Potrei dire, semmai, che il movimento studentesco, del
quale molti di noi facevano naturalmente parte, ci diede il coraggio di esprimere con parole
e fatti quanto avevamo pensato da tempo.
La Fuci si occupava tra l’altro di “politica universitaria” e da tempo lavorava per un
superamento degli schieramenti precostituiti, cercando di rivendicare l’autonomia
universitaria e invocando una profonda riforma degli Atenei e della politica scolastica. Da
parecchi anni infatti non era più quella associazione “collaterale” alla Dc che aveva potuto
essere ai tempi di Dossetti e De Gasperi. Moro era ancora sulla scena, ma sempre in
difficoltà, emarginato, insidiato, calunniato anche da quelli che avrebbero dovuto essergli
amici. Noi capivamo e apprezzavamo il suo sforzo, ma sentivamo che il nostro compito era
di guardare più in là.
Analogamente potremmo dire per la vita ecclesiale e il rinnovamento promesso dal
Concilio, che tuttavia tardava ad arrivare. Volevamo un gran bene a Paolo VI (ed anche
naturalmente a tanti vescovi e preti e a tutta la Chiesa) ma ci sembrava necessario e
doveroso denunciare il ritardo e la insufficiente convinzione nella attuazione del concilio,
nella purificazione della fede, nel dialogo col mondo moderno.
Questo atteggiamento da intellettuali critici e disorganici ci costò molto caro, perché
finimmo quasi tutti, noi della presidenza nazionale di quegli anni, emarginati e sospetti in un
tempo in cui, dal Pci alla Dc fino ai movimenti tipo Gs e poi Cl, gli intellettuali era
sopportati soltanto se organici, funzionali, decorativi e peggio.
Infatti persino nel mondo cattolico più vicino dissero che la Fuci non c’era più, oppure che
aveva perso la sua vera fisionomia, quasi fosse quella di presidiare un “ordine stabilito” che
era piuttosto un disordine. Così facilmente finimmo con l’esser considerati untori - mentre
cercavamo d’esser medici o, almeno, osservatori attenti - secondo quel classico errore di
prospettiva per il quale si scambiano per avversari quelli dei nostri che con maggior
coraggio si battono sulle barricate in prima fila. (Ma stanno di qui e non di là; e
possibilmente semmai cercano di capire e persuadere l’avversario, anziché bombardarlo di
lontano). E infine, con interventi d’autorità, tentarono di farla sparire davvero, la Fuci; senza
tuttavia riuscirci. Ma questa è vicenda degli anni ’70.
Noi avevamo preso sul serio il ’68 perché avevamo maturato da tempo la
convinzione che il mondo stesse cambiando profondamente e che l’ antico sistema fosse
entrato radicalmente in crisi. Non era allora – come non lo è neppure oggi – un fatto
evidente a tutti, poiché la secolarizzazione non era esplosa, la scristianizzazione era nascosta
dalla temporanea permanenza di abitudini esteriori, il boom economico sovrastava la crisi
dei valori, l’antico prestigio della cultura accademica faceva da baluardo e consentiva a
molti di credere ancora che la cultura delle università fosse sempre viva e creativa, mentre
ormai lo era in ben piccola misura. Il Sessantotto ci confermò in una intuizione che
avevamo e ci permise di dire a voce alta che era spesso miserrima la qualità della cultura,
della creatività, della giustizia, della progettualità predominante nella società. La quale
sembrava quelli che corrono sempre di più, senza sapere dove vanno.
E dunque ritenevamo che ci fosse bisogno di un gran soprassalto critico, in tutte le direzioni,
dagli atenei alle professioni, dalla politica alle scienze, alla filosofie, alle religioni. Una
“contestazione permanente” di quel che è, per affermare che può e deve esser migliore.
Si andava sulla luna, in quegli anni; e a noi sembrò ragionevole chiedere (ma fummo
quasi soli, e derisi) chi avesse scelto quella meta anziché altre per l’impiego delle risorse
disponibili; e se in genere ciò non nascondesse un radicale problema di democrazia e di
giustizia. E se non fosse più giusto, e integralmente umano (eravamo gli ultimi, ma non
ripetitivi, discepoli dell’umanesimo integrale) pensare e progettare una società più integrata,
razionale e fraterna (un po’ quello che Paolo VI intendeva con civiltà dell’amore) e sperare
una Chiesa della koinonia, della diakonia e del dialogo, radicalmente protesa all’evangelo.
A me sembra che oggi sarebbe ben difficile dire che avessimo torto; anche se certo
abbiamo molto sbagliato fidando troppo nell’utopia e talora in qualche deriva
irrazionalistica; credendo ingenuamente che le proposte lanciate con disinteresse potessero
incontrare ascolto intelligente e risposte efficaci. Ben altro realismo e disincanto ci voleva
per leggere tutti i lati della realtà… ma non credo che avessimo torto. E sono ben convinto
che se si vorrà ricominciare a costruire qualcosa, in questo scenario desolato che abbiamo
dinanzi, in questo baccanale di esteriorità, ebbene bisognerà ricominciare dal Sessantotto. E
domandarsi perché alle domande di quella stagione non furono date le risposte giuste; anzi
furono date quelle peggiori possibili, della sordità, della repressione e persino della
provocazione sanguinosa. Soprattutto bisognerà ripartire da quelle pagine, idee e persone –
come certo furono tantissimi fucini – che non si lasciarono poi spingere dalla delusione
verso le tentazioni della violenza né tantomeno si “pentirono” in vista di comode carriere:
utili ai patrimoni personali e devastanti per la speranza comune.
Ma oggi, che cosa resta del Sessantotto?
Da più parti e con differenti approcci ce lo si è chiesti: dopo quarant’anni che cosa
resta del Sessantotto nella cultura e nella società di oggi? Domanda giornalistica, posta in
questi termini. Eppure buona occasione per un esame di coscienza, per uno sforzo di
riflessione, di bilanci e di prospettive. Certo sappiamo che il Sessantotto non è stato un
masso erratico o un meteorite improvvisamente caduto dal cielo nella nostra pacifica città
laboriosa e ordinata. Neppure è stata la scintilla creatrice di una nuova fase liberante della
vita personale e universale. Credo che abbia una certa ragione Ferdinando Adornato quando
dice che «in fondo il Sessantotto è rimasto sempre un mistero. Doloroso o gaudioso a
seconda dei punti di vista. Una parte dell’Italia è disposta a giurare che il Sessantotto fu un
Diavolo. Che dal suo seno sgorgarono il terrorismo, lo sciopero facile, l’involgarimento del
costume e quant’altro, Un’altra parte è invece disposta a giurare che il Sessantotto fu un
Santo. Uno stato di grazia irripetibile che fece diventare maggiorenne il Paese».
Se Mario Capanna scriveva per Garzanti “Formidabili quegli anni”, le edizioni
Liberal proponevano un volume a più voci “Sciagurati quegli anni. Contro la beatificazione
dei mitici anni 60”. E il brillante moralista francese Nicolas Sarkozy spiega che «il
Sessantotto ci ha imposto il relativismo intellettuale e morale». In realtà il Sessantotto non è
un fenomeno storico a se stante, ma il capitolo di una vicenda, espressione-reazione ad un
insieme di trasformazioni e di involuzioni; è stato effetto e causa di una svolta nella cultura
e nella società. A questo punto mi sembra che vada posta la domanda interessante. Non se il
Sessantotto fosse Diavolo o Santo, ma se ha segnato (e in quale direzione) un passaggio. Se
è stato una “svolta” o un semplice soprassalto, un tentativo fallito.
Proverò ad anticipare la mia valutazione, che si articola in due momenti. In prima
battuta mi sembra di poter definire il Sessantotto un’occasione mancata, dunque un
fallimento. Ma, attraverso una valutazione più approfondita, più duttile e aperta, mi sembra
di poter ipotizzare che il Sessantotto sia tuttora una promessa di futuro: abbia seminato idee
e valori che si sono diffusi, hanno segnato (e direi positivamente) gli anni successivi e forse
potranno dare anche più frutti nella stagione che verrà.
Certo il 1968 non è composto esattamente dai 12 mesi da gennaio a dicembre. È l’insieme di
quella vicenda storica tra la fine degli anni ’60 e i primi ’70, che Aldo Moro riassumeva
dicendo: «C’è un mondo nuovo che nasce. E vincerà».
Pochi anni prima il Concilio Vaticano II aveva preso atto, nella Gaudium et Spes, che
il mondo stava vivendo una svolta epocale, del tutto straordinaria per profondità e rapidità.
E lo stesso Paolo VI, che alcuni superficialmente dipingevano come triste e angosciato,
sognava: «Noi avremo un periodo di più grande libertà nella vita della chiesa e di
conseguenza di ciascuno dei suoi figli. Questa libertà significherà meno obblighi legali e
meno inibizioni interiori. La disciplina formale sarà ridotta, ogni arbitrio sarà abolito, così
come ogni intolleranza, ogni assolutismo. La legge positiva sarà semplificata, l'esercizio
dell' autorità temperato, il senso della libertà promosso…».
Il mondo, dicevo, stava cambiando (e forse molti non l'hanno ancora capito). Lo
sviluppo delle scienze, la diffusione della informazione e della libertà, la disponibilità di
risorse un tempo impensabili per una gran quantità di uomini, la fine del colonialismo e la
planetarizzazione, una nuova autocoscienza e possibilità di manipolazione della persona
umana…
Quello degli anni ’60 è uno scenario tutto nuovo per virtualità e per sfide. Ma era
anche uno scenario che si era aperto al culmine della devastante crisi delle coscienze che ha
segnato la prima metà di questo secolo, con le due grandi guerre mondiali e i totalitarismi, il
colonialismo e l’atomica. Così che dopo il secondo conflitto l’intera umanità, si può dire,
cercò di ricostruirsi e di ritrovare un’innocenza e una speranza. Nessuno può dimenticare il
grande sforzo delle Nazioni Unite e della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, e quello per la
Costituzione e per l’unificazione europea dopo tanta lacerazione; intraprese di evidente
significato e matrice cristiana. E tuttavia bisogna riconoscere che la ricostruzione del
dopoguerra fu soprattutto materiale ed economica. In poco più di due decenni il mondo
occidentale, anche sulla base di una rinnovata etica del capitalismo, realizzò un sistema di
benessere diffuso, spesso combinato con un’accettabile democrazia. Non era cosa da poco,
ma si accompagnò con una dimenticanza dei fini. La crisi culturale ed etica, che non era
minore di quella economica, non fu affrontata. Furono ricostruite le case e le officine, non
gli animi. Un efficiente macchinismo planetario orientato a far crescere il Pil e produrre
profitto.
La “gioventù bruciata” degli anni ’60, del “miracolo economico”, si trovò di fronte
l’etica delle tre emme: mestiere, moglie, macchina. Il materialismo pratico, cioè,
l’individualismo competitivo. Tutti i mezzi, nessun fine. Tanto benessere, ma poca
preoccupazione per la giustizia, libertà. Consumismo e scristianizzazione nascono lì. E se ci
siamo scordati di quello scenario possiamo rivederlo, con sostanziali analogie, nell’attuale
sviluppo dei Paesi emergenti o usciti dal socialismo reale.
Il Sessantotto fu una reazione, un grido d’allarme, la coscienza che ci sono dei fini
nel nome dei quali orientare e, se del caso cambiare, l’esistente. Un’esigenza insieme
culturale, spirituale e morale. Certo fu presentata soprattutto come sfida, rifiuto,
contestazione, si diceva. E forse non era giusto contestare? Invece che amministrare gli
interessi della società, ci si proponeva di cambiarla, secondo un progetto di giustizia e di
altruismo. È questa una sopravvalutazione della politica, un sogno di Prometeo?
Un mondo che non si era fatto problema di coscienza per il colonialismo, per la fame
nel mondo, per le condizioni dei poveri, per la rigidità dei ceti sociali, per una scuola rigida
e conservatrice, per la violenza, la guerra, lo spreco delle armi, per la schiavitù di tanti
uomini e tante donne…. si scandalizzò d’esser contestato. Il Sessantotto mise sul tavolo i
temi della libertà, della giustizia, dell’uguale dignità, della corresponsabilità comunitaria,
del cambiamento. E come potevano i cristiani non esser dentro a questa vicenda, non
sentirsi chiamati a collaborare, continuandola e perfezionandola giorno dopo giorno, alla
creazione del mondo ad opera di Dio?
È naturale, dunque che i cristiani abbiano partecipato al Sessantotto accanto agli altri.
Che abbiano sognato e cercato le vie di una politica che fosse meno amministrazione degli
interessi esistenti e più espressione di “amore e progetto”, come riassumeva Arturo Paoli.
Sappiamo come sono andate le cose: anziché stimolare una risposta positiva, un salto di
qualità, la contestazione del ’68 ebbe in risposta un irrigidimento del “sistema”. Fu
indifferenza culturale e repressione fisica. Il Congresso della Dc nel 1969 isolò Moro
all’opposizione ed avviò, come risposta alle attese di novità, una politica di restaurazione
che cominciava con l’ “accoppiata Dorotea” e si sviluppava poi con un governo di
centrodestra fatto coi liberali e gradito ai missini. Bisognerebbe ricordare poi le inutili e
violente cariche della polizia contro studenti nonviolenti e fin troppo per bene, che
manifestavano per il diritto allo studio e la cultura critica. Fu una crisi di fiducia tra lo Stato
repubblicano e gran parte di una generazione. Intanto, per fermare il ‘68 studentesco e
soprattutto operaio, cominciava la strategia della tensione con le stragi nere di Piazza
Fontana (1969), di Piazza della Loggia e dell’Italicus (1974) fino alla stazione di Bologna
(1980). Dei protagonisti di quella stagione, si sa, alcuni caddero nell’estremismo e nella
violenza; molti si rassegnarono alla disillusione; non pochi si lasciarono sedurre proprio da
ciò che avevano contestato. Certo il Sessantotto italiano finì presto, come sostengono
giustamente Marcello Flores e Alberto De Bernardi (“Il Sessantotto”, ed Il Mulino); e i
movimenti degli anni Settanta e successivi sono parecchio distanti dallo spirito del ’68. Dal
miracolo economico agli anni ottanta si è consumato un itinerario che è stato definito bene
da Guido Crainz “Il Paese mancato” (Donzelli). E tuttavia gli anni Settanta, che per molti
versi hanno segnato il passaggio, come diceva Paolo Giuntella (che ricordiamo qui oggi con
commozione, a pochi giorni dalla sua morte prematura e toccante anche per il coraggio, la
serenità e direi la gioia cristiana con cui l'ha vissuta), il passaggio, dicevo, dal “dissenso” al
“dissesto”, sono stati anche gli anni in cui, di fronte ai segni di involuzione, si sono
sviluppate iniziative piccole, ma di lungo respiro (vedi Giovanni Moro, Gli anni 70,
Einaudi) . Ricordo la Lega Democratica di Ardigò e Scoppola, il rinnovamento di Aci e
Agesci, Caritas e Pax Christi, Cittadinanza attiva e Sant’Egidio, la nascita della Rosa
Bianca, tante riviste piccole ma vivissime; e penso a Bose o Camaldoli, a tanti testimoni e
gruppi parrocchiali più vivi delle curie diocesane…. Così i problemi irrisolti, le
contraddizioni e le speranze di quella stagione sono restati vivi nella realtà e nelle
coscienze; ed è difficile guardare al nuovo secolo che si avvicina senza ripensare al
Sessantotto e intuire che quella pagina andrà riletta e quelle idee in qualche modo riprese,
anche per quel che riguarda la vita della Chiesa.
Il Sessantotto, infatti, non era stato soltanto una presa di coscienza, e quasi un
sussulto, di carattere culturale e politico. Era anche, e intimamente, religioso e morale. Ed
persino ecclesiale. L’idea che si fosse ad una svolta storica e che occorresse un
atteggiamento nuovo, non riguardava solo le istituzioni, l’università, gli eserciti, la giustizia,
l’economia. Toccava anche la Chiesa. Del resto si era appena svolto il Concilio che aveva
invitato la Chiesa ad una vera e permanente “riforma” (e ci voleva del coraggio ad usare
questa parola, così legata ad un’aspra vicenda…). Così i cattolici avevano uno specialissimo
libretto rosso che li guidava nella loro contestazione: i documenti del Concilio. Anzi, più
che alla contestazione, il Sessantotto ecclesiale era interessato ad accelerare il rinnovamento
delle strutture ecclesiali, della teologia, della spiritualità, della morale. Ci furono impazienze
ed esagerazioni anche qui, ma nel complesso fu una straordinaria mobilitazione. I laici
scoprirono d’esser Chiesa, con l’impegno di partecipazione e responsabilità che ciò
comporta; esplose un interesse per la cultura religiosa che occupava le vetrine delle librerie
e le pagine dei grandi quotidiani; i rapporti dei laici con preti e vescovi si fecero molto più
intensi e familiari, ed anche più schietti. Si riscoprì che la Chiesa più che struttura è
comunione; che la fede è fondata sull’amore di Dio, non su leggi e abitudini; che i non
cattolici non sono nemici ma fratelli. Separati, maggiori o lontani, ma sempre fratelli, cui
voler bene e dai quali imparare qualcosa.
Si voleva tradurre in pratica, tutto e subito. Perché chi partecipava all’Assemblea
eucaristica non poteva prendere la parola? Perché le decisioni della parrocchia non venivano
prese insieme, ma solo dal parroco? Perché le associazioni erano organizzate come eserciti
anziché come comunità? Perché la liturgia non si faceva più familiare e spontanea, al modo
delle prime comunità cristiane? Perché i laici (e preti) preferiti erano gli esecutori obbedienti
anziché quelli fedeli e coraggiosi? Perché la pastorale continuava ad aspettare che i lontani
venissero in chiesa anziché cercarli con lo stile di Emmaus? Perché si aveva fiducia nei
Concordati, nella benevolenza e nei privilegi concessi dai potenti? Perché non ci si
schierava con gli uomini che lottano per la libertà e la giustizia?
Non mancarono gesti discutibili come l’occupazione di chiese, iniziative polemiche,
irregolarità ed errori. E tuttavia ci fu anche una straordinaria mobilitazione delle coscienze
e un rinnovamento profondo dello spirito religioso ed ecclesiale. Moltissimi cristiani, specie
giovani, scoprirono un cristianesimo molto più coinvolgente, capace di trasformare
veramente la vita in una dimensione di amore e di verità. Certo si sarebbe potuto valorizzare
molto di più questa provvidenziale irruzione di energia vitale che ha comunque contribuito a
trasformare in modo irreversibile il profilo della vita ecclesiale e ci ha preparato, seppure in
maniera ancora parziale e contraddittoria, al tempo nuovo che ci attende.
Speranza di una nuova limpidezza della religione "pura e immacolata, in spirito e
verità", di una vita ecclesiale vissuta in koinonia secondo lo spirito del Concilio, di una
chiesa in dialogo con il mondo, una chiesa "semper reformanda", attenta al suo essere, ed
essere fedele a Cristo, prima e più che preoccupata della sua immagine pubblica. Speranza e
impegno di una nuova evangelizzazione, di un ritorno alle fonti, di una purificazione
dell'immagine di quello che secondo Bonhoeffer rischiava di essere il "Dio tappabuchi".
Certo nel movimento e nella cultura del sessantotto vi erano anche elementi caduchi
o accentuazioni pericolose: lo spontaneismo, un eccesso di movimentismo, la
sopravvalutazione, nel quadro della cultura moderna, del marxismo e del movimento
storico-politico che ne è derivato in varie forme; la non rigorosa condanna della violenza e
una certa confusione tra la situazione intollerabile dei paesi sottosviluppati e sottoposti a
dittature e le imperfezioni, pur gravi, delle democrazie sviluppate. Ancora, soprattutto dal
punto di vista ecclesiale, fu superficiale e ingenua la tendenza a volere tutto e subito
(l'esperienza traumatica di consigli pastorali nazionali come quello olandese fece bloccare
sul nascere altre iniziative), la sottovalutazione della dimensione sacramentale e gerarchica,
la troppo facile udienza concessa a teologi improvvisati e in genere a ipotesi di lavoro
semplicistiche; ancora: la commistione, specialmente a livello etico, di esigenze di vero
rinnovamento (un'etica più fondata sulla gratuità, l'amore e la responsabilità, scelta tuttavia
più impegnativa della morale tradizionale) con tendenze invece proprio di tipo
consumistico, lassiste e deresponsabilizzanti, (specialmente nel campo della morale privata,
familiare e sessuale) indotte dalla società edonista e materialista;tendenze ben lontane
dall'alto ed esigente messaggio conciliare e intese ad un generale allentamento delle norme e
anche ad un abbassamento degli ideali etici in nome di un vago relativismo e di una ingenua
modernizzazione.
E L'Azione cattolica?
Se questo era il panorama delle sollecitazioni indotte dalla stagione del '68, resterebbe da
esaminare quale fosse la realtà della Azione cattolica in quegli anni.
Parecchio è già stato scritto sull' AC negli anni '60. (pag 292 segg La storia dell' AC di De
Antonellis, il profilo storico di Preziosi, il libro di Guido Formigoni) Altri, anche in questa
sede ne hanno parlato e ne parleranno più e meglio. Ricorderò solo che essa era già in crisitrasformazione ben prima del Concilio. In un certo senso credo si possa dire che non fu mai
superata la crisi del '54! (Congedo di Mario Rossi, in De Antonellis p 267). Da allora nella
Chiesa, tra i vescovi ed anche tra i laici, vi furono tensioni costanti sul tema dell' Ac,
tensioni che il successo numerico non bastava a cancellare.
Proprio perciò tra le prime preoccupazioni di Papa Giovanni, e poi naturalmente di Paolo VI
che aveva vissuto e sofferto ben da vicino la storia dell'Ac, ci fu quella del suo
rinnovamento.
Bachelet, nella prima assemblea nazionale dopo il nuovo statuto,nel 1970, dirà così:
"In passato l' Ac ha fatto molte varie e nobili cose; ma ora ha ritenuto che fosse suo compito
proprio puntare sui valori essenziali dell'annuncio evangelico e della vita cristiana
concorrendo con il proprio apporto agli aspetti più sostanziali e profondi della costruzione e
missione della chiesa". E, riferendosi alle scelte, impegni e schieramenti in campo parapolitico che avevano caratterizzato (soprattutto attraverso i comitati civici) l' Ac nei decenni
precedenti, soggiungeva: "La necessità di queste scelte provocò tensioni che tutti ricordiamo
e crisi profonde nel decennio precedente al Concilio: tanto che (contrariamente a quanto
molti sembrano credere) il Concilio - che anche l'esperienza della Ac aveva contribuito a
preparare - ha piuttosto aiutato, poi, l' Azione cattolica a ritrovare la sua funzione e il suo
compito essenzialmente religioso e apostolico. E del resto non a caso questo era stato
l'indirizzo indicato da Papa Giovanni al momento in cui chiese anche all' Azione cattolica di
rinnovare se stessa nella generosità dell'impegno missionario , nel primato spirituale, nella
piena comunione con clero e vescovi, nell'unità della testimonianza e del comune lavoro,
nella coerenza di principi e di vita, ma senza ne' confusioni ne' contrapposizioni con altre
responsabilità ed altre energie di cristiani operanti in campi diversi".
Fu dunque Papa Giovanni a chiedere all' Ac la "scelta religiosa", che Paolo VI
confermò accompagnandola con un costante, incalzante incoraggiamento. "Tanta è la stima
che noi tuttora tributiamo al vostro grande sodalizio e alla sua attività - diceva ai presidenti
diocesani nel 1965 - che saremmo pronti a farne l'apologia nei confronti di alcuni vostri
critici, le cui voci arrivano sovente fino a Noi, come ad esempio: l' Azione cattolica ha fatto
,il suo tempo, è formula sorpassata; è movimento tutto esteriore e meccanizzato in strutture
complicate e pesanti; è tutto un sistema disciplinare dove autorità e obbedienza prevalgono
su ogni libera e originale espressione; è una rete di interessi benefici, se volete, ma in realtà
economici, amministrativi, burocratici, rivolti a scopi particolari e temporali; è un insieme di
gruppi chiusi, per iniziati ad un loro gergo clericale, incapaci di aperture moderne verso le
nuove correnti della storia; e così via. No, carissimi figli; queste critiche, se pur toccano
aspetti e forse difetti particolari, non toccano l'essenza della vostra compagine, non vedono
la bontà, veramente cristiana, dei principi su cui si fonda il vostro movimento..." E, di
seguito, il Papa ricorda l'unione, l'azione, la sincerità religiosa, la collaborazione con la
Gerarchia, l'entusiasmo, la passione per l'umanità...
Nasce di qui la decisione non di sciogliere l' AC - come in quegli anni taluno pensava
seriamente - ma di rifondarla, attraverso un nuovo Statuto (benchè il presidente Vittorio
Bachelet e l'assistente Franco Costa - da seri cultori delle discipline giuridiche quali erano
entrambi - non avessero alcuna simpatia per la applicazione alla vita ecclesiale delle
categorie giuridiche e pensassero che il dibattito sugli aspetti giuridici e normativi avrebbe
rischiato di deviare attenzione ed energie verso aspetti marginali, accendendo interminabili
quanto poco utili dibattiti).
Il nuovo Statuto venne preparato attraverso una larga consultazione delle associazioni
diocesane e delle varie articolazioni. Più che un dibattito giuridico-organizzativo si cerca di
farne un'occasione per riflettere sul proprio impegno pastorale e sulle prospettive della
evangelizzazione in un Paese in trasformazione. Non mancano qualificati momenti di studio
e di preghiera, tra il 1966 e il 1969. Il saggio di Mario Casella, con l'ampia raccolta di
documenti curata da Mario Falciatore (in "Lo Statuto della nuova Azione cattolica" ed
Civitas) forniscono un ottima messe di informazioni e di giudizi e illustrano, soprattutto
attraverso i dibattiti di quella che allora si chiamava "Giunta centrale" (e che corrisponde
pressapoco all'attuale Consiglio nazionale) come il dibattito fosse aperto, e fossero ben
presenti molti temi tipici del '68.
Le sfide del '68 sono ben presenti nei lavori, anche perchè il nuovo Statuto viene
preparato sulla base di un larghissimo ascolto. E' tuttavia una attenzione critica e un
discernimento prudente. Se alcune componenti si fanno voce delle attese e delle intuizioni
più dinamiche, altre componenti, ben rappresentate e sulla base di una lunga tradizione, si
mostrano molto prudenti per non dire critiche. Tra gli Uomini e la Giac (e anche tra Fuci e
Laureati cattolici) le diversità sono notevoli e spesso appaiono anche sulla stampa e nei
dibattiti (es polemica Coscienza-Ricerca).Avvenire d' Italia e Italia coinvolti nella diversità
di indirizzi (del resto classica nella storia del giornalismi cattolico del nostro Paese). Grande
ruolo di ascolto e di mediazione di Costa, Bachelet, Sassudelli, Del Monte e Franceschi.
Mario Casella ("Lo Statuto della nuova Ac" pag 25-26) conclude così il suo saggio
introduttivo: "Al momento del suo varo il nuovo Statuto, accanto a molti consensi, suscitò
sconcerto e malcontento, soprattutto nelle due ali più estreme dell' Aci.Per i giovani più
radicali era stata persa un'irripetibile occasione per ridisegnare il volto dell' Aci e renderlo
più aderente e coerente con la svolta innovativa segnata dal Concilio; per i "vecchi" (cioè
per i sostenitori ad oltranza della tradizionale Aci) erano state gettate le basi per una non
lontana liquidazione di un' Associazione che aveva reso importanti servizi alla Chiesa e al
Paese.
Ma era possibile una carta statutaria migliore e diversa? Si ha l'impressione che se a livello
associativo fossero passate (e poi recepite nello statuto) le più audaci tra le proposte delle
componenti giovanili, difficilmente lo Statuto avrebbe avuto l'approvazione della autorità
ecclesiastica, e ciò avrebbe di fatto segnato la fine dell'Aci.... Per usare un'espressione dello
stesso Bachelet (che in tutta la vicenda si mantenne al di sopra delle parti, pur in un
atteggiamento di sostanziale simpatia per le posizioni più moderate dei "giovani"), si può
dire che si sia trattato di una soluzione relativamente equilibrata.”
Ecco: si può ben dire che l'atteggiamento dell' Ac, di fronte alla stagione del '68, fu
proprio di attenzione, accoglienza e prudente discernimento. Forse può essere sottolineato
proprio l'aggettivo prudente. E tuttavia, se si guarda al contesto e alla storia successiva si
potrebbe anche dire coraggioso.
In sostanza i valori che il sessantotto aveva meso in luce furono accolti, le sfide che aveva
lanciato furono colte e ad esse ci si sforzo di rispondere, le ambiguità e gli errori furono
affrontati e combattuti, con carità e chiarezza.
C' era, ad esempio, un rischio di orizzontalismo (categoria un po' ambigua, certo, ma
molto usata in quegli anni), di ingenua fiducia nelle ideologie e nella azione storica, una
certa riduzione del Vangelo all'impegno sociale, una utopia progressista. Alcuni ritennero di
rispondere a questa sfida contrapponendo una risposta di tipo conservatore, altrettanto
ideologica e orizzontalista, ma di segno diverso. Invece l' Ac, proponendo la sua scelta
religiosa rispose in modo che a me pare corretto e lungimirante (anche se meno fruttuoso in
termini immediati e meno vistoso). Il problema non era di contrapporsi ad un progetto di
rinnovamento sociale, era piuttosto quello di non dimenticare la dimensione verticale ne' di
imprigionarla (con un inedito integralismo in un progetto essenzialmente temporale. La
scelta religiosa coglieva l'esigenza di essenzialità, di fondazione radicale dell'agire umano, il
ritorno alle fonti. Non si poneva come una scelta fra le altre, ma come un andare alla radice
in un tempo di trasformazioni rapide e profonde; la volontà di stabilire le giuste distanze dal
piano immediatamente temporale e non compromettersi col potere e il sistema, senza
identificarsi neppure con gli aspetti temporali e le scelte operative di un progetto di
cambiamento. La sfida era: voi cristiani, legati a doppio filo all'attuale sistema di potere,
sarete capaci di diventare progressisti? Molti, come si sa, si sforzarono di rispondere sì, altri
fecero valere con forza - e talora con rabbia - il loro no. La risposta dell' Ac fu molto più
profonda: disse che quello che contava era la radice, il rapporto con dio, la fede nelle cose
ultime. Questa ricchezza sarebbe stata un viatico prezioso per tutti quelli che avrebbero
voluto impegnarsi per rinnovare e migliorare la realtà temporale. (cfr Bachelet: in un tempo
di profondi rivolgimenti, quando l'aratro della storia...)
Il '68 aveva lanciato anche le sfide della democrazia assembleare e dello
spontaneismo. Nello Statuto la risposta è rappresentata dalla scelta democratica e
associativa. L' Ac valorizza a tutti i livelli la dimensione assembleare (che aiuta tra l'altro a
cogliere la dimensione globale del popolo di Dio, della unità nella diversità, dell' evento
rappresentato dall'essere convocati e dall'incontrarsi. Ma, parzialmente andando contro
corrente, valorizza anche i momenti della democrazia rappresentativa e "delegata" (ruolo dei
consigli e delle presidenze). Si decise di mantenere la tessere, benchè alcune componenti
fossero contrarie e un legame forte tra il centro e la base. Benchè la diocesanità fosse
giustamente molto valorizzata si mantenne ferma l'idea che l' Ac fosse associazione
nazionale, pur se articolata in associazioni diocesane. Lo spontaneismo fu sottoposto ad una
critica severa, nella misura in cui esprimeva una tentazione di deresponsabilizzazione, una
falsa libertà di chi non vuole impegnarsi con fedeltà e continuità, una instabilità di
atteggiamenti in cui la sincerità si contamina con la superficialità volubile. Proprio nel '68
Bachelet, parlando ai presidenti diocesani, rilevava che "il problema non è solo di forma ma
è anche di sostanza: il rifiuto cioè di un certo tipo di impegno. Non dico di ogni impegno,
ma di un impegno che non si limiti ad un piccolo gruppo omogeneo, ma si collega invece
più largamente sul piano nazionale con esperienze, mentalità e bisogni diversi, e anche
localmente accetta la fatica e la gioia di incontrarsi con persone di età, esperienze, abitudini
diverse". Lo Statuto risponde in positivo a questa sfida dello spontaneismo e dei piccoli
gruppi omogenei proponendo una forma associativa che responsabilizzi al massimo
possibile (compatibilmente con la superiore direzione della gerarchia) il contributo, la
responsabilità dei laici. Dallo statuto si evince chiaramente che l' AC non preesiste alla
volontà degli aderenti che la compongono e - attraverso l'incontro della loro volontà col
consenso gerarchico - danno vita e caratterizzano questa singolare forma associata di
apostolato cattolico. Sono i laici che liberamente si associano (cfr Premessa allo statuto) ed
offrono al Vescovo la propria fattiva collaborazione per rendere più efficace e responsabile
il loro servizio pastorale alla comunità. Quanto alla forma democratica, essa recepisce
certamente lo spirito del tempo, ma in realtà costituisce anche, com' è noto, un ritorno all'
antico, a prima della "clericalizzazione" dell' Ac resa necessaria dal confitto col fascismo.
La guida democratica nell' Ac fu vista come la migliore soluzione al problema della
partecipazione e della direzione associativa, la più responsabilizzante e dunque la più
formativa e, in sostanza, cristiana.
La scelta unitaria. Diceva Lazzati, presidente dell' AC ambrosiana, già nel 66
nell'articolo "una più forte unità per una più valida azione" in "Direttive" genn 66: "Non vi
sono tante azioni cattoliche quanti sono sono i rami e i movimenti; vi è una sola AC che tutti
intendiamo nel medesimo modo. L' AC deve essere una nel metodo di formazione... Se l' Ac
vuole essere, come deve, espressione autentica della Chiesa non può non riprodurne le note
profonde e in primo luogo quella della sua unità".(Formigoni-Vecchio, pag 147).
Dunque l'unità venne affermata con forza nel nuovo statuto, benchè vi fosse una
tendenza a pensare piuttosto ad una federazione di componenti. Ma si cercò di garantire che
ogni articolazione avesse il suo spazio necessario a svilupparsi e a sentirsi a suo agio nella
casa comune e si lasciarono norme molto "aperte" (es art 19: nell'associazione parrocchiale
possono costituirsi dei gruppi come prima elementare e vitale esperienza associativa". Si
prevedeva che potessero essere riconosciuti o promossi per ragioni formative, di
testimonianza negli ambienti ecc; e ciò a tutti i livelli) . Non si voleva perdere il contributo
di quelle nuove energie che, in quegli anni, avevano dato vita ad oltre ottomila gruppi
spontanei all'ombra dei campanili (ma l'esperienza dimostrerà che ben pochi di essi
entreranno nell'orbita dell' Ac forse per la insufficiente convinzione con la quale tali
possibilità furono esplorate)
Un' altra scelta fu la drastica semplificazione della struttura operativa. L' Ac era
famosa per la sua superorganizzazione, capillare e assai articolata anche se dietro
l'apparenza il funzionamento non era sempre così perfetto ed efficace come molti
pensavano. Dallo statuto, in seguito alla unificazione di rami e movimenti e alla distinzione
della vera e propria Ac dalle varie opere, segretariati e associazioni collaterali (dal Csi al
Ctg, dal segretariato per la moralità al Cniop al centro cattolico stampa, ecc) uscirà invece
una struttura semplicissima, come era auspicato soprattutto dai più giovani che, sensibili
agli indirizzi di un rinnovamento pastorale, avevano timore per la troppa organizzazione
esteriore, convinti che essa portasse quasi inevitabilmente a compromessi col potere
pubblico, col danaro, con la mentalità trionfalista ed efficientista del mondo secolare.
La estrema brevità dello Statuto, pur così a lungo preparato, la "Premessa" di vasto
respiro ma di scarsa natura giuridica e il carattere aperto degli articoli (più programmatrici
che normativi) sottolineano l'approccio culturale, che fu assai poco dirigista ed
organizzativo e proteso invece, pur salvando con un minimo di norme quanto già esisteva, a
valorizzare ogni nuova possibilità, in un atteggiamento di apertura fiduciosa verso il futuro e
verso le trasformazioni culturali e spirituali che si annunciavano o avrebbero potuto
svilupparsi. In sostanza c'era, ed è stato espressa nello statuto, una forte consapevolezza dei
mutamenti in corso e futuri ed una coraggiosa disponibilità ad affrontarli anche quando
chiedessero all'associazione fatiche e difficoltà. Fu affermata nei fatti la centralità
dell’educazione alla libertà. Anche il notevole calo degli iscritti fu affrontato con questo
spirito di disponibilità al cambiamento. Intanto c'erano ragioni "umane" a spiegarlo: la crisi
di tutte le forme associative organizzate, il moltiplicarsi di altre forme di apostolato
approvate o tollerate dalla gerarchia, il riconoscimento che nei "grandi numeri" della
stagione precedente c'era anche qualche ipertrofia non propriamente fisiologica... Ma poi c'
era una ragione spirituale che aiutava l' Ac, e Bachelet in primo luogo ad affrontare con
serenità quella che era una vera prova e a molti sembrava una vera sconfitta. Cominciò così
uno dei suoi ultimi discorsi da presidente, nel marzo del '73: «Javhé disse a Gedeone: "E'
troppo numeroso il popolo che è con te perchè io metta Madian nelle sue mani: non avvenga
che Israele se ne faccia vanto a mio danno e mi dica: "La mia mano mi ha liberato". Quindi
proclama ciò alle orecchie del popolo: "Colui che ha paura e trema torni indietro" ».
Qualche volta -soggiunse- viene fatto di domandarci se la Chiesa non sia in un momento
simile. Quando vediamo sacerdoti che lasciano il ministero, vocazioni sacerdotali e religiose
ridotte, associazioni di apostolato che restringono le loro fila, cristiani che - magari
pensando di impastarsi meglio all'umanità di cui sono fermento - rinunciano ad essere luce
sul monte e se necessario segno di contraddizione, può venire la tentazione dello
scoraggiamento. Eppure io credo che questa povertà della chiesa sia la prova attraverso la
quale si prepara la vittoria del Signore. Se abbiamo paura o temiamo è perchè pensiamo che
che possa essere ma nostra mano a liberarci o a liberare l'umanità.»
Questo insieme di opzioni , per molti aspetti, era anche la scelta della Chiesa
italiana, forse meno esplicita (cfr l' aureo libretto di Enzo Franchini "Il rinnovamento della
pastorale") di quella dell'AC, ma egualmente limpida almeno negli anni di monsignor
bnartoletti, Poma, Cè, Caporello, Ballestrero...
Ci furono però grandi difficoltà di far capire questo disegno di apertura al nuovo, di
discernimento, di valorizzazione, e di tradurlo in pratica, tantopiù in un contesto che andava
mutando, in direzione opposta. La Chiesa e la società italiane infatti si distinguono per una
rapida capacità di capire e di sensibilizzarsi e per una certa buona volontà immediata, ma
anche per una notevole incostanza e incapacità a reggere disegni di lungo periodo tantopiù
se profondamente innovativi (anche per la volontà-bisogno di fruire di risultati immediati).
Oggi tutto ciò può sembrare lontano e per molti versi radicalmente sconfitto. Tuttavia
se le utopie sono cadute, alcune forti speranze hanno messo radici, al punto che non è
irragionevole dire che il Sessantotto resta tuttora una profezia, una promessa di futuro.
Anzitutto abbiamo ereditato da quegli anni la coscienza che siamo noi ad essere
responsabili del nostro futuro. È nata la necessità di essere protagonisti, liberi e
anticonformisti… Il lavoro pensato come con-creazione dell’universo, non solo destino
talora umiliante, talora prepotente. Una fede più limpida, disinteressata non esibita nè
strumentale, una relazionalità più sincera con il prossimo, una fiducia nei contropoteri, nella
controcultura, nell’obiezione di coscienza…
E ancora: il Sessantotto ha seminato un’inquieta attenzione verso il resto del mondo:
fino ad allora quasi nessuno, anche tra i cristiani, si domandava se fosse giusto che i
bianchi-cristiani-ricchi dominassero e rapinassero con la violenza quasi tutto il resto del
mondo. Ora non è più così, anche se non ne abbiamo ancora tratto le conseguenze: la
convinzione che un mondo diverso è possibile, e dunque necessario e doveroso sta
diventando patrimonio di ogni retta coscienza; e crea un’inquietudine che non sarà facile
soffocare. Il Sessantotto infine ci ha aiutato a capire che la vita è un pellegrinaggio, un
esodo, non un possesso. Che la cultura, la coscienza di fede, la famiglia, la società non sono
un dato di fatto immobile, ma una realtà in mutamento: in crescita e sviluppo, salvo che la
nostra cattiveria o indifferenza ne facciano un’involuzione, un pericolo e una tragedia.
Tutti questi semi sono rimasti in milioni di coscienze e si trasmettono in maniera
anche imprevedibile di generazione in generazione; sono nei piccoli gruppi; nella coscienza
dei lontani; nei messaggi trasmessi da piccoli strumenti, piccole riviste di cultura e
spiritualità, pagine su internet, incontri di giovani. Tutto ciò aiuta resistere nella lunga, arida
stagione che stiamo vivendo; e ci rende fiduciosi che quando verrà la primavera troverà dei
semi buoni e vitali pronti a metter radici e germogli.
Angelo Bertani
Scaricare