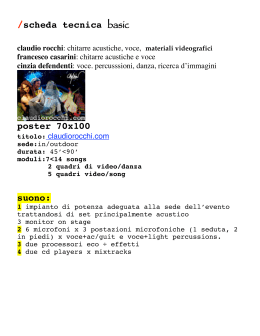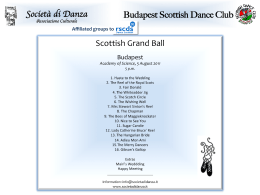TUTTA LA FRAGILITÀ DELL’ESISTERE. LA DANZA MISTICA E UMANA DI GIOVANNI DI CICCO di Silvia Poletti coreografia Giovanni Di Cicco, Francesca Zaccaria musiche originali Chiara Cipolli danza Luca Alberti, Filippo Bandiera, Massimo Cerruti, Eleonora Chiocchini, Erika Melli, Francesca Zaccaria scene Paolo Giacchero luci Aldo Mantovani produzione Dergah Danza Teatro, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara in collaborazione con Teatro dell’Archivolto, Comune di Cagli, Ikonoclaste Festival di Wuppertal PRIMA ASSOLUTA durata dello spettacolo: 90’ foto di scena Aldo Mantovani Tra le ipotesi per l’etimologia della parola danza c’è l’antichissimo retaggio indo-europeo che ne affonda l’origine in un inscindibile connubio tra umano e spirituale. La ‘radice’ sanscrita tan/ten da cui dipartono le varie declinazioni della parola (danza, dance, tanz, danse) allude infatti all’idea di ‘tensione’, ascesa verso l’alto, necessità interiore che si traduce in turgore muscolare, trasformazione fisica, energia che muove il corpo nello spazio e nel tempo, nel bisogno segreto di trovare un contatto con un’altra dimensione. Un Iter Mentis in Deum affidato all’espressione del corpo, consapevoli che “chi conosce la potenza della danza risiede in Dio”. Nelle culture nelle quali la danza non si è completamente secolarizzata il danzatore perde una connotazione soggettiva, né il suo è più un mero ruolo ‘artistico’, ma si fa identità assoluta, insieme veicolo e ricettacolo della dimensione spirituale in quanto tale. Anche se con la forza stessa della sua umanità, nell’atto stesso del danzare egli va allora inteso come emanazione dell’assoluto cui si tende. Se questa funzione di medium è semplicisticamente leggibile nei danzatori che si lasciano andare a movimenti convulsivi, facendosi invadere dal ritmo del proprio corpo in una perdita del sé che rimanda all’antica fusione orgasmica con la madre terra della Theia Mania dionisiaca, un’altra qualità di danza – espressione di una tensione verso l’assoluto ispirata dall’utopia dell’Harmonia Mundi – riesce ugualmente a significare nella sua fortissima valenza simbolica e coreutica il superamento dell’umano. Qui infatti il superamento della materia e l’approccio all’assoluto avviene per sublimazione, il corpo perde ogni senso di gravità, si stempera e allo stesso tempo nel suo movimento perpetuo assorbe le energie dell’universo. I movimenti stessi dei danzatori e il loro agire nello spazio diventano così non solo pura rappresentazione di questo armonioso movimento universale, ma anche strumento di comunicazione di ciascuno di loro con la dimensione superiore. “Cuori! Mondi! Il vostro danzare si arresterebbe se Non lo accendesse amore, Allah hu! E Colui che guida la nostra ronda d’amore è più in alto del sole e dell’aurora...” Questi versi del mistico persiano Galàl al-Dìn Rûmi ben colgono il senso profondo di una danza intesa come atto d’amore, quindi atto generativo, che coniuga umano e divino e fa dell’uomo una sorta di ‘utero’ pronto a ricevere l’universo. Non a caso, i mistici dervisci nella loro danza roteante, composta e armoniosa, nel gesto di apertura delle mani, l’una con il palmo rivolto verso l’alto, l’altra con il palmo verso il basso evocano, come osserva anche l’antropologo Curt Sachs, “l’espressione più avvincente delle facoltà ricettive femminili. Il derviscio che, volteggiando su se stesso, stende orizzontalmente le braccia... si mette, senza volerlo, nell’atteggiamento di accogliere, aprirsi. Non da lui emana l’energia fecondatrice, ma è egli stesso che si offre alla forza generatrice, che di lui si impossessa, lo libera da tutti i legami del corpo, spegne ogni barlume di consapevolezza e infonde lo spirito divino nel suo corpo umano.” In questa congerie intellettuale e spirituale è fiorita la ricerca di Giovanni Di Cicco ben presto diventata esistenziale, più che meramente artistica, nella quale la danza ha la valenza primaria di necessità vitale, essenza stessa della propria natura e personalità, oggetto e via di arricchimento emotivo e incontro con gli altri. Una condizione del sé, per usare un concetto filosofico, che ha caratterizzato ben presto il percorso di ricerca di questo danzatore e coreografo formatosi tra Italia, Francia e la Folkwang Hochschule di Essen, oltre che alla discipline marziali orientali (come il kinomichi, scienza del corpo/mente che punta al raggiungimento dell’armonia interiore) attivo sulla scena nazionale e internazionale fin dai primi bagliori del Movimento della Nuova Danza Italiana, e che, diversamente da altri suoi compagni d’arte con cui ha collaborato, ha scelto di concepire il mo- vimento non tanto come ‘artificiale’ espressione d’autore, bensì come unico modo possibile per rivelare l’essenza dell’umano. Procedendo nella propria ricerca spirituale e filosofica Di Cicco ha così gradualmente maturato la consapevolezza di ritornare alla verità dei corpi, liberi da ogni sovrastruttura sociale, culturale ed estetica: una sorta di spoliazione di tutte le convenzioni che aggravano la condizione, per raggiungere, come lui dice “il movimento più puro, assoluto, colto nella sua meravigliosa fragilità”, vale a dire in quella sincerità nata dalla diretta connessione della dimensione emozionale/spirituale con quella fisica. E se all’arte della coreografia ha affidato sempre più un ruolo ‘maieutico’, così da guidare nella rivelazione del sé più puro e assoluto gli altri danzatori, al teatro ha restituito il senso della sua sacralità arcaica, il luogo dove attraverso l’azione si punta alla catarsi e all’elevazione. In questo senso, come in una liturgia primordiale scevra da ogni convenzione stilistica, Il Quattordicesimo Fiore, che Di Cicco firma insieme a Francesca Zaccaria, ‘avviene’ in uno spazio materico dove tre uomini e tre donne attraverso la verità della danza evocano il senso atavico dell’esistenza passando dai momenti cruciali della definizione della propria identità, dell’erotismo e della morte. Lo spunto di partenza è il libretto di Stravinskij e del pittore antropologo Nicholas Roerich per Le Sacre du Printemps, messa in scena di un rito sacrificale della Russia pagana nel quale una vergine eletta danzava fino a morire per propiziare le forze della natura. E anche qui si ‘muore di danza’, dopo che gradualmente, in un procedimento a ritroso, in quattordici ‘ideali’ tappe (dove il quattordici è un numero mistico che rimanda alle stazioni della Via Crucis) gli interpreti abbandonano tutte le pastoie convenzionali – per esempio il rito sociale del ballo di corteggiamento – e riconquistano la condizione antica di corpi pronti a farsi viatico dell’incontro con l’assoluto. Ancora una volta infatti la morte è intesa come niente altro che la liberazione dell’ “io” occulto di origine divina, pronto a passare/ tornare nella dimensione superiore. E l’Eletta, consapevole, come dice Pindaro, “che il corpo segue la chiamata della morte possente” si ‘fa’ danza per superare il confine del reale e ritrovare la dimensione spirituale che ogni passaggio iniziatico porta con sé.
Scaricare