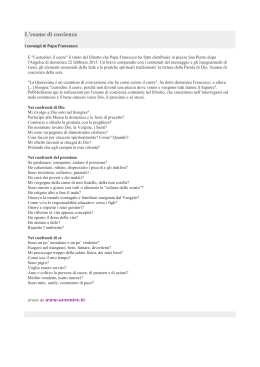Domenica La di DOMENICA 12 APRILE 2009 Repubblica la società La Pasqua dei rom e di Gomorra MARINO NIOLA cultura Cacciatori e mercanti di libri perduti PAOLO MAURI e FRANCESCO MERLO Oltre quattromila sono le immagini del proprio pc inviate dai lettori a Repubblica.it Ecco gli sfondi su cui cliccano gli italiani MICHELE SMARGIASSI UMBERTO ECO «E i sono delle cose che io non faccio e tuttavia ne riconosco l’impatto e il significato sociale. Per esempio non uso il telefonino, se non per chiamare i taxi se sono in giro, e per il resto resta lo lascio spento perché il fine primario della mia vita è non ricevere mai messaggi da tutta quella gente che c’è qui intorno, e possibilmente non inviarne, se non via Repubblica. Eppure capisco come questo strumento stia cambiando la vita di molte persone, e in certi rari casi persino in senso positivo. Non seguo abitualmente le partite di calcio se non una volta all’anno. Quando non esisteva neppure il telefonino, un cronista ha tentato di disturbarmi mentre ne guardavo una con mio figlio quattordicenne, e il ragazzo ha risposto mirabilmente «papà non può venire al telefono perché sta ascoltando Brahms». L’episodio ha fatto il giro delle redazioni sportive e da allora sono stato lasciato in pace durante le partite di cui una volta ogni scomparsa di presule uso compiacermi se sono giocate bene. (segue nelle pagine successive) se non fai subito il bravo», disse Alice minacciosa al suo gattino, «ti metto dentro lo specchio, cosa ne diresti?». Quando Lewis Carrol scriveva questo, gli specchi erano ancora dure lastre di vetro argentato, magiche, ma attraversabili solo con la fantasia. Oggi, che ci vuole? Basta allungare la mano (la manina bianca con l’indice puntato in alto) e clic, sei già dall’altra parte, in un altro mondo. Oggi chiunque di noi sa attraversare uno specchio, lo facciamo tutti i giorni, perché la loro diafana superficie s’è fatta davvero, come immaginava il reverendo di Oxford, «morbida come un velo, come una specie di nebbia». Non riflette più quel che c’è di qua, ma quel che c’è di là, il mondo catturato nella Rete. Gli specchi elettronici davanti ai quali passiamo sempre più ore delle nostre giornate sono interfacce, membrane osmotiche tra noi e il mondo fisico: sono gli schermi piatti o ciccioni dei nostri computer, portatili o mastodontici, ruderi o ultimo grido, di casa o d’ufficio. (segue nelle pagine successive) C FOTO CORBIS Desktop Art spettacoli Gli scintillanti palcoscenici del rock GINO CASTALDO e GIULIANO SANGIORGI i sapori La sfida colomba-pastiera CORRADO ASSENZA e LICIA GRANELLO le tendenze Mobili anfibi, per dentro e fuori AURELIO MAGISTÀ l’incontro Paolo Villaggio, l’uomo che non ride DARIO CRESTO-DINA Repubblica Nazionale 26 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 12 APRILE 2009 la copertina Animali domestici e non (con il gatto al primo posto), ritratti di figli e persone care, paesaggi desiderati e lontani E poi divi del cinema, mostri del rock, eroi e miti politici Ecco come illustriamo lo sfondo del nostro computer, facendone una bacheca, un manifesto, una bandiera, Desktop Art uno spazio identitario e anche una nuova forma espressiva Autobiografia collettiva racchiusa in un clic MICHELE SMARGIASSI (segue nelle pagine successive) osì permeabili che possiamo davvero metterci in castigo il micetto disobbediente, volendo. Infatti ce lo mettiamo davvero. Il gatto: ecco il re incontrastato dei desktop, il dominatore dei monitor, il personaggio di gran lunga più ricorrente su tutti gli schermi. Il campione di cui disponiamo è sufficiente per esserne certi: sono tremilaseicento i lettori di Repubblica.it che hanno accettato di mostrare a tutti «Il mio desktop», l’immagine fissa che ciascuno di loro ha scelto come sfondo per le lunghe ore di lavoro o divertimento davanti a un mouse e a una tastiera. Quasi certi, perché un dubbio ci assale: che l’autocensura dei partecipanti abbia filtrato ed escluso i desktop del desiderio maschile, le nuove pin-up, equivalenti elettronici dei calendari da gommista, insomma gli sfondi che vengono di scatto coperti da noiosissimi fogli di Excel quando passa la collega d’ufficio. Scontando questa sospetta assenza, comunque i gatti sbaragliano i cani, ma anche i tramonti sul mare, le cime innevate, i prati fioriti, le vedute pittoresche. Curioso: compriamo l’attrezzo più tecnologico oggi disponibile e lo tappezziamo di cliché visuali da vecchia cartolina. Dev’essere un bisogno di rassicurazione, di relax, come le musichette chill-out; un modo per riscaldare il freddo dei bit (c’è anche un sorprendente numero di camini accesi, sui desktop degli italiani). La finestra che ci si illumina davanti agli occhi ogni mattina, prima di iniziare il lavoro, deve darci un saluto benaugurante. Il desktop è un talismano. Desktop, nel mondo fisico, è il ripiano della scrivania, la superficie di lavoro su cui disponiamo, a portata di mano, gli oggetti materiali di un lavoro intellettuale. Il loro (dis)ordine è quello delle nostre menti: «È un caos, ma io mi oriento». Nel mondo virtuale, il desktop è tutto questo ma anche qualcosa di più: è la soglia tra noi e tutto il resto. «Una retina esterna» per il guru del virtuale Derrick De Kerchove: protesi visuale su cui viene a proiettarsi l’immagine del mondo. Una meravigliosa porta ma anche un pericoloso buco nero che può inghiottirci. I produttori di computer lo hanno capito. E generosamente ci permettono di «personalizzare» quello spazio di trapasso, mettendo a guardia un’immagine votiva e consolatrice (per i più timorosi) o aggressiva e seduttrice (per gli avventurosi). È la nostra nuova porta di casa. I navigatori lo sanno. Per questo in tanti ci hanno inviato non la pura e semplice copia elettronica della schermata, ma una fotografia della postazione di lavoro, della scrivania reale, di quella porzione dello studio, del salotto, dell’ufficio in cui lo schermo (spesso gli schermi, due, tre, anche sei affiancati, un vera iconostasi cibernetica) si erge solenne come nuovo tabernacolo per il rito dell’immacolata interconnessione. Sono immagini che rincuorano: non ci siamo ancora trasferiti a pié pari nella virtualità. Penne, fogli, post-it, ma anche tradiziona- C li foto dei figli in cornice, la piantina grassa, le ciabatte sul pavimento, il sacchetto delle patatine e la tazza del tè, peluche e ninnoli sul corpo del pc come soprammobili su un comò: lo spazio del lavoro è ancora a misura d’uomo, dei suoi bisogni materiali, delle sue fatiche reali (la caffettiera su un fornello da campo: notti insonni per consegnare in tempo quel lavoro...). Ma il confine va sbiadendo. L’immagine sintetica sullo schermo tende a mangiarsi il contesto reale. C’è un gatto che sonnecchia di fianco alla tastiera: ma c’è lo stesso gatto dentro lo schermo (sarà quello, birichino, messo in punizione da Alice). Oggetti e luoghi d’affezione, ritratti di amici e di persone care, vengono trasferiti nel quadro luminoso. È l’ambiente reale che ingloba l’intruso elettronico, o viceversa? In tutti i casi quella che affiora ogni volta che accendiamo l’apparecchio è un’immagine nostra, scelta dai nostri sentimenti profondi più che dai nostri gusti estetici. Quello del computer, insegnano i teorici dei nuovi media, è uno spazio emotivamente sovraccaricato. Il rettangolo dello schermo non è come la cornice sul camino, non è un reliquiario di ricordi o una bacheca per le immagini che ci piace avere sotto gli occhi. È più simile a una seconda pelle: una superficie di contat- La schermata che s’illumina quando accendiamo il pc è la soglia tra noi e il mondo virtuale nel quale passiamo molte ore della nostra giornata to con gli altri. Un’intera generazione è ormai cresciuta con questo involucro interattivo addosso, nelle sue disparate versioni: display del cellulare, finestra del gameboy, schermo del pc e del laptop. Sono gli screenagers, neologismo inventato dal mediologo Douglas Rushkoff e prontamente accolto dall’Oxford English Dictionary. I blog dei cyberfanatici sono pieni di dichiarazioni d’amore passionale per il proprio desktop, perfino di gelosia: «voodoobytesman» per esempio racconta che il vero strazio, quando dovette cedere il proprio laptop alla figlia seienne, non fu il momento in cui lei cancellò tutti i suoi programmi e i file d’archivio, ma quando sostituì il suo vecchio desktop «con un bel cavallo al galoppo. Ho sentito una fitta al cuore: ecco, il portatile che mi aveva accompagnato in tanti viaggi e battaglie non era definitivamente più mio». Un pezzo dell’Io, un ricettacolo d’identità: «Tanti disinibiti internauti inviano a repubblica.it la foto del loro desktop, senza pudore», confessa «nardi», «io ci ho pensato e ripensato, poi ho deciso di astenermi: il mio desktop è una cosa privata». Sfogliare queste migliaia di immagini fa sentire intrusi, come chi entra in casa d’altri a guardare i letti sfatti e i cassetti in disordine. La disposizione delle icone tradisce la personalità dell’utente. Alcuni desktop ne sono interamente ricoperti, al punto da rendere irriconoscibile l’immagine sullo sfondo. Ci sono immagini scelte apposta per lasciare un angolo di sfondo uniforme in cui poggiare le icone (il cielo dei panorami, l’ombra di un ritratto) che però finiscono sempre per debordare, straripando dove non dovrebbero. E questi sono i disordinati, che lasciano lì dove capita cartelle di file, collegamenti ad applicazioni, il cestino, vecchi programmi di setup ormai inutili: ci vorrebbe una colf virtuale che venisse a rassettare ogni tanto (qualche produttore di software deve averla anche inventata). All’estremo opposto ci sono gli ordinatissimi: poche icone, disposte simmetricamente, a girotondo, in processione come vagoncini, incollate ai fogli di un quaderno disegnato, appiccicate come magneti alla foto di un frigo, appese ai rami di un finto albero di Natale. Infine, gli organizzati: con il desktop pulsante di attività automatiche, le previsioni meteo aggiornate, i titoli di Borsa in tempo reale, le ultime news che scorrono, l’agenda che ti avverte degli appuntamenti. Per tutti costoro l’immagine non è più importante di una tappezzeria, qualcuno ci rinuncia e lavora sull’azzurro Microsoft in dotazione. Ma per la grande maggioranza la scrivania virtuale non è un piano di lavoro elegante, né una parete decorativa: è una bacheca, un manifesto, una bandiera. Uno spazio enunciativo e identitario. Divi del cinema, mostri del rock, eroi della storia, miti politici. Quanti Obama: superano i Che Guevara. Le falci-e-martello scomparse dalle piazze le trovate qui. E poi slogan, ironie, raffinatezze grafiche, colpi di genio, ma per chi tutto questo esibire? La schermologia, neodisciplina che studia le superfici mediali, ci racconta il progressivo restringimento del campo: la visione collettiva del cinema, quella familiare della tv, quella individuale del computer. Password impediscono che estranei accedano alle nostre scrivanie elettroniche. «Il mio desktop» è mio come il mio corpo (ecco un desk con la radiografia toracica), o come il corpo nudo dell’amata, visibile solo a me. È un’autogratificazione privata, un piacere solitario. Nessun altro può vedere lo schermo attraverso cui vediamo tutto: è davvero una finestra a specchio, di quelle che lasciano sbirciare solo in una direzione. Ma ne siamo proprio sicuri? I nostri desktop sembrano castelli inaccessibili, e invece sono campi di battaglia. Spazi ancora vergini dal mercato, fanno gola alle multinazionali del software, che cercano di appropriarsene. Ogni volta che installiamo un programma, quello tenta di piantare la sua bandierina sul nostro schermo. La Rete è piena di siti che cercano di venderci o regalarci strepitosi desktop interattivi, magari con pubblicità allegata. È cominciata la colonizzazione di un territorio incautamente abbandonato alla creatività individuale. Speriamo di veder nascere un Movimento di liberazione dei desktop. Repubblica Nazionale DOMENICA 12 APRILE 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 27 L’INIZIATIVA IN MOSTRA Una foto di famiglia, uno scatto con l’amico o la fidanzata, un disegno, una spiaggia tropicale, un cane, un gatto, un pesciolino L’elenco è una lunga autobiografia collettiva È l’iniziativa Il mio desktop lanciata da Repubblica.it a gennaio: si chiedeva ai lettori di inviare le immagini che usano come sfondo del computer Oggi sono state pubblicate sul sito centosessanta gallerie (oltre quattromila immagini, alcune delle quali riprodotte in queste pagine). E come era già accaduto lo scorso anno con l’iniziativa Le finestre di fronte, un’ampia selezione delle immagini inviate saranno presentate e mostrate nell'ambito di FotoGrafia, Festival internazionale di Roma (dal 29 maggio al 2 agosto al Palazzo delle esposizioni) Una rivolta a colori contro l’anonimato dell’era digitale UMBERTO ECO (segue dalla copertina) on annuso cocaina ma sono molto soddisfatto che, annusandone troppa, tanti grandi manager si siano buttati in speculazioni avventate e ora siano sul lastrico. Ecco. Ho pertanto riflettuto alla bella esposizione di desktop che Repubblica mi ha sottoposto. Io ho un desktop pulitissimo, ovvero con colore di fondo uniforme, perché ho tante icone di programmi di diversi che devo essere in grado di trovare subito quel che cerco e non potrei permettermi di metterle ai lati per lasciare al centro neppure un disegno di Raffaello con dedica autografa. Anche con lo screen saver mi sono ritirato, dopo molti esperimenti, su quello che mi dà gli orologi con le ore di tutto il mondo, che almeno serve a qualcosa appena accendo il computer. Però se molte persone si dedicano a inventare immagini, molte originalissime, per il loro desktop, la cosa deve avere un senso, tanto quanto parlare di calcio, e parlarne magari al telefonino. Così di per sé non avrebbe senso sporcare i muri esterni di casa propria eppure esistono graffitari molto interessanti (che però hanno la prudenza di graffitare sui muri altrui). Farsi un desktop alla cui invenzione si sono dedicati tempo, fatica, immaginazione e tanta passione vuole dire che, non appena il computer si illumina, noi dobbiamo ritrovare qualcosa di rassicurante, e di nostro. In tal senso il desktop personale può essere un modo per reagire all’anonimato a cui ci spinge Bill Gates. Lui ci vorrebbe tutti uguali e il desktop personalizzato sarebbe la nostra risposta rivoluzionaria. Però ritengo significhi qualcosa di più. Che sia il sostituto della copertina di Linus, ovvero oggetto transizionale? Infine si potrebbe pensare al desktop come a una nuova forma di arte. Ogni nuova tecnologia ha generato la propria arte specifica, molti artisti avevano persino cominciato a praticare la Fax Art, si pensi ai vari esempi di Computer Art, in fondo nessuno se ne era reso conto ma anche il telefono aveva generato la propria forma specifica di invenzione artistica, la telefonata poetica sussurrata, la seduzione via timpano (o coclea, o labirinto, non so bene), e in fondo una forma degenerata dell’arte telefonica è la chiamata del disturbatore notturno in preda a satiriasi. Ed ecco dunque la Desktop Art, meno effimera di tante altre forme artistiche, e al postutto molto — come dire — libera e morale, perché prodotta per un godimento privato e non per ottenere il plauso delle folle — salvo il caso di concorso nazionale. E in fondo, non si tratta neppure di qualcosa di insostenibilmente nuovo. Dall’invenzione di Gutenberg e sino a parte del Settecento, i libri venivano venduti a fogli stesi e poi ciascuno se li faceva rilegare a proprio gusto. Per non dire che, almeno per un secolo, le lettere iniziali si lasciavano in bianco, in modo che il cliente potesse farle miniare dall’artista di fiducia, avendo così l’illusione di possedere ancora un manoscritto. Amare un libro perché ha una rilegatura e delle iniziali diverse da quelle di tutti gli altri è certamente un piacere aristocratico (e costoso). Democratico e gratuito è invece avere invece un computer diverso da tutti coloro che usano il proprio senza fantasia. E infine, se qualcuno dedica tempo costruirsi il proprio desktop invece di perdersi in insulse spiate dal buco della serratura su You Tube, o addirittura sui siti porno, non è forse meglio? E il ministro Brunetta potrebbe considerare fannulloni anche gli impiegati del catasto che usano le ore d’ufficio per farsi un bel desktop? N Repubblica Nazionale 28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 12 APRILE 2009 la società Al santuario della Madonna dell’Arco, in provincia di Napoli, accorrono a piedi ogni lunedì in Albis migliaia di fedeli Il pellegrinaggio si tramuta in un dramma collettivo, tra furore estatico e superstizione. È solo uno degli antichi Altre Pasque FOTOFOTO ALAMY riti religiosi che sopravvivono nel nostro Paese, trasformandosi adesso in rappresentazioni postmoderne La Vergine invocata dai rom e da Gomorra MARINO NIOLA C SANT’ANASTASIA (Napoli) orrono, piangono, pregano, gridano, strisciano, implorano, imprecano, si gettano in ginocchio e avanzano fino all’altare. Davanti alla Vergine risplendente d’oro culmina il concitato e drammatico pellegrinaggio che porta ogni anno, il lunedì di Pasqua, un’interminabile schiera di devoti scalzi al santuario della Madonna dell’Arco, la potente signora dei terremoti, la «grande domatrice della natura». Siamo a Sant’Anastasia, sotto la mole incombente e minacciosa del Vesuvio. A due passi da Pomigliano d’Arco dove la Fiat di Marchionne produce l’Alfa Romeo GT, cassintegrazione permettendo, e dove l’industria aerospaziale Alenia fabbrica tecnologie per la Nasa. Dal mondo contadino a quello postindustriale. Nel volgere di pochi anni qui tutto è diventato post. Centocinquantamila persone rigorosamente vestite di bianco arrivano a piedi nudi da tutta la Campania. Sventolano stendardi coloratissimi ricoperti di banconote, portano sulle spalle ceri da trecento chili, avanzano tra il frastuono dei tamburi e cantano antiche litanie. Un fiume candido che irrompe tumultuoso da un passato lontano e fa tracimare sul presente tutta la sua arcaica energia. Facendo cortocircuitare la storia in un blob tutto postmoderno. Sottoproletari, precari, contadini, operai, malati, disoccupati, cassintegrati, impiegati, immigrati, camorristi. Umanità periferiche, vite interinali, che abitano secoli diversi della storia, si trovano tutte insieme a celebrare un rito pasquale dove la penitenza cattolica e l’esplosione pagana della primavera, il Cristo che risorge e la na- tura che rinasce, diventano una cosa sola. Si chiamano fujenti, letteralmente «i fuggenti», questi devoti vestiti di bianco che si struggono per una Madonna dal volto ferito, forse la prima tra le icone che sanguinano. È proprio la ferita, simbolo di un dolore antico, all’origine di questo culto. Si racconta che il lunedì in Albis del 1500, un giocatore di palla a maglio (un antenato del baseball), furibondo per aver perduta la partita, colpì con la palla di legno il volto della Vergine affrescato sotto l’arco di un acquedotto romano. Le cronache dell’epoca raccontano che l’immagine cominciò a sanguinare e il giovane uomo, colto da una frenesia irrefrenabile, si mise a correre e a saltellare come un posseduto. Era la punizione della Madonna, o almeno così venne interpretata. Da allora questa Madonna è ritenuta l’emblema stesso della potenza, e la sua immagine viene spia- ta e interpretata come un segno celeste. All’indomani del terremoto del 1980 nei quartieri popolari di Napoli si sparse la voce che la bocca della Vergine si fosse contratta in una smorfia. Come un sismografo soprannaturale che indica una corrispondenza tra la deformazione del viso e il corrugamento della terra. Comincia all’alba del lunedì la lunga marcia dei fujenti. Molti partono addirittura la notte. Li attendono ore di strada e di fatica sull’antico cammino della penitenza e della speranza. Giunti davanti alla chiesa, i volti si fanno più tesi. E il pellegrinaggio si trasforma in dramma collettivo. Quando gli uomini vestiti di bianco varcano la soglia della basilica e vedono l’immagine della Madonna la loro emozione precipita nei gesti da sempre ripetuti di una ritualità millenaria. Vinti dalla stanchezza, dalla tensione e dalla sofferenza cadono in preda a un BORMIO FIRENZE I “pasquali di Bormio” sono i carri allegorici dei cinque reparti in cui si divide il centro valtellinese che sfilano la mattina di Pasqua. La tradizione prevedeva la sfilata di cinque agnelli ornati posti su un carro con un bambino e un giovane, “interpreti” di Gesù bambino e Cristo risorto Lo scoppio del carro di fuochi d’artificio e della colombina anima il giorno di Pasqua a Firenze, in piazza Duomo. Il fuoco viene acceso dalle pietre focaie che, secondo la tradizione, provengono dal Santo Sepolcro. L’esplosione dei fuochi ricorda l’arrivo della primavera Repubblica Nazionale DOMENICA 12 APRILE 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29 IN PROCESSIONE FOTO MAURIZIO FRASCHETTI Nella parte alta della pagina, alcune immagini della festa della Madonna dell’Arco I diversi gruppi e comunità di fedeli custodiscono una loro immagine della Madonna, che il lunedì dell’Angelo portano in processione fino al santuario Le madri di Scampia, della Sanità, dei Quartieri spagnoli camminano in ginocchio portando in braccio i figli malati I disoccupati gridano il loro bisogno di lavoro. Giovani tossicodipendenti implorano di essere liberati dalla droga, offrendo a Maria siringhe d’oro che vanno ad arricchire la collezione di ex voto che risale ai primi del Cinquecento Da una decina d’anni gli immigrati sono i nuovi devoti furore estatico. Molti entrano violentemente in trance, come accadeva anticamente nei templi delle grandi dee mediterranee, e soprattutto in quello di Cibele, la divina signora della fertilità. Forse non è un caso che il santuario della Madonna dell’Arco poggi proprio sui resti del tempio di questa dea pagana. Come in un antico rito di passaggio i pellegrini si gettano nell’abisso del sacro a braccia aperte e con gli occhi nel nulla. Così la devozione diventa teatro. Alcuni intonano un canto lungo e modulato che sta fra il richiamo del muezzin e il grido dei venditori, e che chiama a raccolta tutti i «figli della mamma dell’Arco». L’invocazione profondissima e remota sembra risvegliare le ombre mediterranee che non hanno mai abbandonato questi luoghi, facendo affiorare una parentela dimenticata tra culti che si richiamano da una sponda all’altra del mare no- strum. Dalla Grecia al Nord Africa, all’Andalusia. Mentre da fuori giunge il battito ostinato degli strumenti che accompagnano le tarantelle e le tammurriate, nell’oscurità della chiesa la musica cede il posto al grido. I fujenti urlano i loro mali, il loro dolore, si buttano di schianto per terra e si trascinano sulle braccia fino all’altare. Alcuni strisciano la lingua per terra. Le madri di Scampia, della Sanità, dei Quartieri spagnoli camminano in ginocchio portando in braccio i figli malati. I disoccupati gridano il loro bisogno di lavoro. Giovani tossicodipendenti implorano di essere liberati dalla schiavitù della droga offrendo alla Vergine siringhe d’oro che vanno ad arricchire la imponente collezione di ex voto del santuario: migliaia di pezzi dai primi del Cinquecento ad oggi, una infinita ricapitolazione di sofferenze patite e di grazie ricevute. Ci sono perfino i guantoni che Patrizio Oliva offrì alla Madonna dopo essere diventato campione del mondo dei superleggeri. Travestiti e femminielli, capelli biondo platino, entrano in chiesa tenuti per mano dalle loro madri, donne senza età con i capelli dell’identico biondo fai da te. Ai mille volti dolenti della tormentata umanità napoletana si aggiungono, da una decina d’anni, schiere di nuovi devoti: filippini, srilankesi, polacchi, latino-americani e tanti, tantissimi rom. Di fronte alla folla ondeggiante, i padri domenicani schierati ai piedi dell’immagine sembrano fare un debole argine all’impetuosa marea umana che monta verso l’altare. I devoti, alcuni esanimi, altri urlanti, altri ancora irrigiditi da un tremito convulso, vengono portati fuori da un efficientissimo servizio d’ordine. Uno dopo l’altro, i gruppi dei devoti scorrono davanti all’immagine come un fiume inarrestabile, dall’alba fino al tramonto. Quando il rito si avvia alla sua conclusione i pellegrini prendono la strada del ritorno per riporre i loro stendardi fino all’anno successivo. Molti di essi si perdono tra la folla della fiera che si svolge nelle vie circostanti sciogliendo la tensione del voto nell’animazione della festa. Di fatto è una sorta di sacralizzazione della maternità che conduce da secoli tanti uomini e donne a chiedere protezione e grazia a quella che essi chiamano la «mamma di tutte le mamme». Un simbolismo materno che dalle matres matutae, le oscure madri di pietra che troneggiano nel Museo archeologico di Capua, si snoda come una sorta di filo rosso che giunge fino alle “madri dolorose” di quelle periferie dove si comincia a lavorare ad otto anni e a sedici si è già espulsi dal mercato del lavoro. E dove ogni madre ha sette spade nel cuore. SULMONA CASTELVETRANO Una vera e propria rappresentazione sacra a Sulmona, con le statue dei santi Pietro e Giovanni che bussano al portone della chiesa di San Filippo per annunciare la Resurrezione. La statua della Madonna fugge in piazza, scorge il Cristo, si libera della veste nera e scopre un abito verde In provincia di Trapani si perpetua la messa in scena barocca dell’“Aurora”. Le statue di Cristo e della Madonna vengono collocate in due angoli opposti di piazza Duomo. L’Angelo Nunziante per tre volte fa la spola tra i due finché madre e figlio si incontrano allo scoppio dei mortaretti Repubblica Nazionale 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 12 APRILE 2009 CULTURA* Da sempre i librai del lungosenna parigino hanno alimentato i sogni dei bibliofili. E, nell’era degli acquisti online c’è ancora chi, rovistando tra volumi polverosi, va a caccia dell’esemplare raro, della copia firmata dal grande scrittore o di quella che porta sul frontespizio una dedica curiosa. Una mostra a Roma celebra quei piccoli templi del commercio culturale tra memoria e nostalgia Illusioni perdute sulle bancarelle dei libri FRANCESCO MERLO S PARIGI ono “quadri mentali” i bouquinistes di Parigi, come il caffè Flore dove “vediamo” senza vederli gli scrittori che al loro tavolo stanno creando i capolavori futuri, come le chiese frequentate dai gobbi innamorati, come il Pont-Neuf dove ci si bacia sotto la regia di Prévert. Allo stesso modo, almeno una volta nella vita, siamo tutti caduti nell’illusione di trovarli davvero, tra quei libri presentati alla rinfusa, sbrandellati e coperti di polvere, i famosi stravizi dello spirito, la grassa segatura dell’ingegno umano. Hanno infatti la funzione simbolica e decorativa di altari eretti al Sapere queste famose bancarelle di legno verde disposte in fila sul lungosenna. E benché tutti sappiamo che non esiste l’oro a buon mercato, c’è sempre il bibliofilo improvvisato che si vanta d’avere l’occhio per individuare gli speciali colorini e gli inequivocabili frontespizi delle edizioni preziosissime. Insomma, il Comune li mantiene a vita e li protegge come protegge i musei, le biblioteche, le Grandi scuole e tutti gli altri luoghi che qui sono consacrati al Pensiero perché i turisti a Parigi, come i fedeli alla Mecca, hanno davvero bisogno di credere nella bancarella metafisica. E difatti il mondo è pieno di feticisti che, se bene stimolati, raccontano di aver trovato lisciando, sfogliando e fiutando il vital nutrimento, non so quale rarità dimenticata e pur modesta all’aspetto: un volumetto tarchiato, di colore oscuro ma con qualcosa di irrequieto che subito ti tocca il cuore e ti commuove. E, guarda caso, stava proprio lì dove non può stare e dove mai l’abbiamo trovato: dal bouquiniste sulla Senna, un signore più falso dei suoi libri, patacca già nella tunica grigia e nel baschetto nero alla parigina, con il bricco di caffè caldo e il sorrisetto sovvenzionato dal Comune. Ce n’è uno, Mathieu Delarue si chiama, che al convegno turistico letterario intitolato Papiers de Paris, Paris de papierin una sala messa a disposizione dal Municipio del sedicesimo arrondisse- ment in rue de la Pompe, dice di considerarsi come «un farmacista della morale». Delarue si è messo raccontare che «tra poesie di nozze, primi saggi di poeti falliti, romanzi rachitici, almanacchi, vecchie copertine della Bardot, libelli, capricci, corbellerie, cenci e cocci della letteratura» lui regolarmente «imprigiona» lì a casaccio, come fosse un gratta e vinci, «una perla da biblioteca dello spirito». E una volta persino ci mise — dice — una prima edizione numerata e firmata di Victor Hugo, e un’altra il calepi- LE COLLEZIONI ESPOSTE Una stampa litografica di inizio Ottocento che raffigura un bouquiniste In alto, una cartolina francese in cui si vede il Louvre. I materiali in mostra a Roma provengono dalla collezione Ceccarius della Biblioteca nazionale e da quella del Museo parigino a Roma no triangolare che era stato di Breton. Tutti pensano che c’è stato un tempo in cui le bancarelle erano davvero piene di meraviglie, quando gli scrittori erano pochi e quando i lettori erano gli happy few di Stendhal o i venticinque di Alessandro Manzoni. E invece ride di compiacenza, monsieur le bouquiniste, e lascia intendere che in fondo la bancarella anche allora era già una menzogna e che mai ci sono finiti i tesori di lettura del funzionario ottomano caduto in disgrazia e/o del rifugiato della corte zarista. Al punto che se oggi ci fosse davvero una bancarella piena di libri preziosi e rari nessun turista la frequenterebbe e il Comune costringerebbe l’incauto bouquiniste a traslocare in un vero negozio, in una vera libreria, in un vero quartiere. E infatti secondo lui nessuno mai si accorge di quelle splendide fantasie dell’universo che egli cela — per celia verso il proprio mestiere — tra tanti inutili volumetti uniformi e poveri. La gente compra invece la tazza con la Tour Eiffel da un lato e la Giocondadall’altro. E, se proprio si decide a prendere un libro da una di quelle lunghe file schierate come eserciti, ebbene sceglie una banalità che abbia però l’aria della rovina, qualcosa che altrove avrebbe guardato con indifferenza e trattato con pochi riguardi ma che qui diventa una copia impreziosita dalla vita, dell’Étranger di Camus per esempio: alla Fnac, in edizione più elegante, costerebbe persino meno. Dal bouquiniste il libro d’occasione deve avere l’aspetto logoro che hanno i turisti, e magari anche le sottolineature a penna che gli danno un’aria di abito smesso, e le pagine piegate che sporgono un po’ come una barba e i margini che, segnati da unghie sconosciute, sono visi rugosi… Alla fine della conferenza gli chiedo se non li invecchia da sé certi libri; se non gli dà lui, per esempio, quel fondotinta di retorica che si chiama dedica e che spinge anche un tipo scanzonato come me a sfogliare, non importa quale titolo, per trovare in apertura di Les effets psychologiques du vinla frase datata 13 luglio1953 «in regalo al signor prefetto di polizia da parte del compagno socialista Bruno, tre volte arrestato tre volte innocente: suo uguale, ma non servo». Mi racconta di una copia di Frammenti di un discorso amoroso impreziosita da una dedica in inglese che gli rese ben 35 euro: «A Joe, l’uomo della mia vita, da parte di Dag, l’uomo della sua vita». Io ricordo invece un Prévert che Robert comprò «per Jacqueline, compagna… delle mie vite». E ancora un Lu Hsün con su scritto un misterioso «davvero mi rincresce di piacerti». È probabile che esistano i collezionisti di dediche e si sa che anche i libri possono diventare un vizio, ma non è dal bouquiniste che trova soddisfazione il pervertito che si placa quando palpa un’edizione originale e trae fremiti di voluttà dalle copertine d’antiquariato. Per i viziosi del libro che si incapricciano di vezzose legature aristocratiche e fiutano i frontespizi d’antan, il mercato è sempre più specializzato. Per loro, come per i pervertiti sessuali, la vetrina delle occasioni sta sul web, la sola bancarella piena di sorprese che ti restituisce persino i libri che ti hanno formato e che proprio per questo non possiedi più. NeI libri nella mia vita, delizioso libro sui libri, Henry Miller smonta infatti la bibliofilia, ossessione di possedere, per- Repubblica Nazionale DOMENICA 12 APRILE 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 Gli eterni esploratori dell’edizione alfa PAOLO MAURI l raccontoè sempre avvincente, dunque tanto vale ripeterlo. Il 2 febbraio del 1922, alle sette del mattino, Sylvia Beach, che era la proprietaria a Parigi della libreria inglese Shakespeare and Company, aspettava alla Gare de l’Est il treno proveniente da Digione. Il convoglio non si era ancora fermato del tutto che un controllore le andò incontro e le porse un pacchetto: conteneva due copie della prima edizione dell’Ulysses da lei stessa pubblicato. Una copia fu data subito a Joyce e l’altra messa in vetrina e ben presto attirò l’attenzione dei lettori. La copertina era blu. Quel romanzo, tirato in circa un migliaio di copie, in parte su carta di lusso e con firma dell’autore, in parte in forma più economica, era destinato a suscitare lo scandalo dei benpensanti, ma rappresentava una vera rivoluzione letteraria. Tra i primi illustri lettori troviamo Gide, Yeats, Pound, Eliot, Sherwood Anderson, Dos Passos. Ma non basta: Lawrence Rainey, cui dobbiamo queste notizie (vedi Il vero scandalo dell’Ulyssesin L’oggetto libro ’98edito da Sylvestre Bonnard) racconta anche che il ritrovamento di certi taccuini della Beach hanno permesso di sapere chi erano i successivi e anonimi acquirenti, visto che la bravissima intellettuale libraia prendeva nota di tutto. Un caso eccezionale, non c’è dubbio. Ma spesso capita, cercando e trovando libri vecchi o addirittura libri antichi, di incontrare le cosiddette “tracce d’uso”, quando non addirittura il nome di un precedente proprietario. Talvolta notissimo. Una parte della biblioteca di Arturo Carlo Jemolo finì in mano ai bouquinistes della capitale: uno di loro, un certo Mario, aveva una bancarella in piazza Cairoli a Roma. Spesso con libri a prezzi stracciatissimi. Lì trovai molti anni fa un’edizione delle opere dell’Alfieri in una trentina di volumi degli anni Venti dell’Ottocento. Noi cerchiamo i libri e i libri cercano noi. Giulio Einaudi, negli ultimi anni, comprava d’antiquariato i libri che lui stesso aveva pubblicato mezzo secolo prima e che aveva perduto. Anche i luoghi a volte contano, Nel recente e appassionato libro di Giampiero Mughini in veste di bibliofilo pubblicato da Einaudi c’è un capitolo su Marradi (luogo di origine della famiglia paterna) e dunque su Campana e il suo dannato esordio. Un libretto, Canti orfici, stampato dal poeta alla bell’e meglio a proprie spese e che oggi è quasi introvabile e dunque molto costoso. Ironia della sorte: vivo l’autore non si riusciva quasi a vendere. Del resto anche gli Ossi di seppia di Montale ebbero una sorte simile, anche se non ci fu mai quell’aura maledetta che avvolge tutta la storia di Campana. Cercare le prime edizioni dei nostri poeti è impresa non semplice: erano spesso plaquettes di poche pagine, stampate in poche centinaia di copie. Però, facendo un salto indietro di due secoli, ho visto qualche settimana fa sul catalogo della libreria antiquaria Mediolanum la prima edizione del Mattino di Giuseppe Parini: un libretto di una sessantina di pagine, uscito nel 1763. Troppo cara per me, ma mi fa piacere che ci sia. A proposito di grandi lombardi e dei loro libri, mi è tornata in mente l’ultima volta che incontrai Dante Isella. Avevo appena comprato le poesie di Carl’Antonio Tanzi pubblicate postume a Milano nel 1766. Il volume ha appunto una bella introduzione del Parini, che racconta come Tanzi fosse un uomo spiritoso e un po’ collerico, bravo soprattutto nelle poesie in dialetto milanese. Isella si complimentò: «Io ce l’ho, naturalmente. Ma l’avrei comprato anch’io. È una bella edizione, averne due copie non guasta. Sa che ce n’erano anche degli esemplari su carta azzurra?» Toccare con mano. Lo diceva bene Dionisotti che una cosa è leggere un testo in una edizione nuova e un conto è prendere in mano la prima edizione: fare i conti, cioè, con l’infanzia di un’opera e magari di una grande opera. Chi cerca un libro in particolare è meglio che si affidi a Internet mentre il bello del cercare tra bouquinistes e simili è che si va alla ventura e non si sa mai che cosa si può trovare. Spesso, viaggiando all’estero, si possono fare scoperte di vecchi o antichi libri nostri che chissà come, e chissà con chi, hanno viaggiato anche loro. Negli anni Ottanta mi capitò a Lisbona di trovare a O mundo do livro Le ultime lettere di Jacopo Ortis in una terza edizione del 1802. È quello l’anno in cui Foscolo, dopo una disgraziata edizione pirata bolognese da lui ripudiata perché pubblicata a sua insaputa e per giunta completata da un altro, dà alle stampe per la prima volta il suo celebre romanzo. Oggi lo leggiamo nell’edizione zurighese di qualche anno dopo, ma quella del 1802 è preziosa. Qualche volta sarebbe sciocco fermarsi alla prima edizione, che è la fissazione dei collezionisti: del Pasticciaccio, per esempio, ho comprato per niente da un libraio romano la seconda edizione del settembre 1957 (la prima è del luglio dello stesso anno). Poi ho letto in una nota gaddiana di Giorgio Pinotti che quella edizione risultava introvabile. Insomma andar per librerie o bancarelle è sempre un bell’andare. Pontiggia, che era un eccellente bibliofilo, quando viaggiava visitava sempre gli antiquari del luogo. Una volta a Buenos Aires con Nico Orengo decidemmo di andar per librerie. Siccome pioveva senza tregua prendemmo un taxi, che lì non costa niente, e con le pagine gialle in mano girammo per mezzo pomeriggio. La preda, naturalmente, fu un libro di Borges. I SCORCI DI FINE OTTOCENTO Nella foto sopra, caccia al libro tra i bouquinistes del lungosenna; da destra, in senso orario, una veduta di Parigi, una figurina con un bouquiniste romano, una litografia di Grasset e una stampa dal Figaro Illustré ché l’amore per i libri è un sentimento ben diverso dall’amore per la lettura. Racconta che negli scaffali che tappezzano la sua stanza non ci sono i titoli che ha amato di più. Un libro, non appena lo hai letto, diventa molto più bello se lo regali. Ci sono libri, che altri ci hanno dato o abbiamo acchiappato chissà dove, che ancora viaggiano, passano di mano e tanto più profonda è la traccia che lasciano quanto prima ce ne sbarazziamo. Della biblioteca di una vita rimane dunque la bancarella con i libri da deco- La capitale francese li protegge come fa con i musei e i luoghi consacrati al Pensiero ro, libri senza dignità che nessuno vuole, nessuno compra e nessuno ruba. Monsieur Delarue spiega come il fenomeno del furto del libro, che è un problema per i librai di Parigi, sia quasi inesistente per i bouquinistes. Appassionati, gentili e raffinati, pieni di interessi e di sentimenti, i ladri di libri sono gli ultimi ladri perbene che ci sono in giro. I bravi librai sanno che un libro rubato è comunque un libro che sarà letto e perciò susciterà nuove curiosità e nuove letture piuttosto che nuovi furti e nuovi crimini. Meglio dunque un libro rubato che un libro non letto: «Una volta sola mi è capitato il ladro. Mi aveva rubato — pensate — Le suicidologe,dizionario dei suicidi celebri edito da Le Castor Astral. L’ho invitato a cena e gli ho salvato la vita». LA MOSTRA Con Les Bouquinistes - Librai ambulanti tra Parigi e Roma la Biblioteca nazionale centrale di Roma propone dal 21 aprile al 20 giugno una carrellata di immagini (alcune sono in queste pagine) e documenti dell’editoria parigina a cavallo tra Ottocento e Novecento L’evento si inserisce nella rassegna Sous le ciel de Paris 2009 Repubblica Nazionale 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 12 APRILE 2009 La sobrietà di Springsteen, le invenzioni dei Pink Floyd, gli scenari alieni di David Bowie, le macchine febbrili degli U2 Per ogni loro concerto, un luogo e una scenografia diversa, spesso rivoluzionaria, a volte semplice guscio vuoto della caduta creativa. Ora un libro SPETTACOLI raccoglie i dietro le quinte dei luoghi in cui si celebra l’unico rito pagano collettivo, il live THE WALL WORLD TOUR Sopra, disegno quadrangolare di Mark Fisher per il Wall World Tour dei Pink Floyd; nella foto grande, i Pink Floyd a Torino per il Division Bell Tour Nell’altra pagina dall’alto, Ligabue, Madonna, i Radiohead e i Rolling Stones GINO CASTALDO ietro i palcoscenici del rock c’è tutta l’ambiziosa magia del sogno, la virtù illusionistica di una cultura che ha coltivato l’insano desiderio di creare eventi dello spazio-tempo fuori dalla normalità della percezione quotidiana. Quella delle scenografie del rock è una storia nella storia, una definizione artistica degli spazi che ha assorbito (come del resto il rock ha fatto a partire dalle sue matrici musicali) linguaggi diversi: il teatro, la mimica, la pittura, l’architettura, il cinema e la fotografia, spesso mescolandoli con spudoratezza, con audacia, creando magnifiche illusioni, a volte fraudolente, per coprire con sfarzi inimmaginabili un vuoto di creatività artistica, altre volte generando moduli avanzati e spiazzanti, idee innovative che poi sono stati riassorbite dalle stesse discipline saccheggiate inizialmente dalla onnivora e tentacolare natura del rock. Grazie al rock sono state possibili ricerche notevolmente avanzate a livello tecnologico, talvolta spericolate, audaci anche nelle proporzioni, vista l’attitudine ai grandi spazi, alle adunate oceaniche di cui il rock ha dato prova in molte occasioni. Fronte del palco aveva intitolato Vasco Rossi il suo celebre doppio live del 1990 registrato nel Blasco Tourdell’anno prima richiamando gli echi di lotta nei docks di New York di Fronte del porto. Fatica e violenza, energia e catarsi, buio e colpi di tamburo, Vasco e Marlon Brando. Tutto insieme, tutto dal vivo e nell’unico luogo in cui il più grande rocker italiano continua a dare il meglio di sé, sul palco. D Le effimere cattedrali rock Lo stesso vale per chi ha avuto il privilegio di “vedere” i concerti storici dei Pink Floyd (The Wallin primo luogo), le geniali mise en scene di Peter Gabriel (che una volta creò un sistema di luci mobili che interagivano con lui come personaggi incombenti) o le macchinazioni febbrili e multiple degli U2, ha vissuto i vertici assoluti della costruzione spettacolare, una globalità coinvolgente ed estrema, la sperimentazione di una frontiera che non ha avuto confronti possibili con nessun’altra forma di spettacolo. I Kraftwerk usarono quattro robot al loro posto: volevano mostrare che si poteva fare a meno degli artisti Serge Latouche in libreria Mondializzazione e decrescita L’alternativa africana prefazione di M. Giannini e V. D’Amico www.edizionidedalo.it Questa unicità è ben messa in rilievo da un libro, On the stage. I grandi palchi del rock di Cesare Molinari con fotografie di Bruno Marzi (Stampa Alternativa) nel quale viene descritta la natura ibrida e multilinguistica dello spettacolo rock. «Il palco è il luogo della luce, della presenza, della rilevanza. La platea il luogo dell’ombra, dell’assenza, del sogno. La penombra in cui è adagiata la platea determina una situazione favorevole agli incantesimi dell’immaginazione e marca una soglia invalicabile nei confronti della rappresentazione che avviene sul palco», racconta Molinari. Ma è anche la celebrazione di un rito, la più grande festa pagana concessa alla modernità, una sfida di emozioni forti pronunciata con gli strumenti musicali, certo, ma anche con fasci di luce, enormi pupazzi semoventi, schermi potenti, robot, fumi, oggetti immaginifici. E c’è un mondo di cose da riepilogare, da fotografare, da analizzare, per costruire una possibile storia di questa speciale, imparagonabile, estrema branca della dimensione spettacolare. Il rock ha davvero praticato ogni sentiero possibile, ha cercato spesso avvolgenti minimalismi, la scena l’ha a volte negata, rifiutata, oppure blandita, suggerita, o esaltata, lanciata verso costruzioni smisurate. Difficile dire se il rock nella sua essenza ha davvero bisogno di queste complesse costruzioni. Ovvio che quando la musica perde di tensione creativa, gli allestimenti perdono di originalità in maniera direttamente proporzionale. Le cattedrali che girano oggi negli stadi del mondo sono spesso gusci fragorosi e poco nutriti all’interno di adeguata sostanza, ma è indubbio che in passato i palchi del rock abbiano vis- suto momenti inarrivabili, sprazzi di sognate avanguardie, soluzioni avvincenti e perfettamente adeguate alla proposta musicale. Da un estremo all’altro delle possibilità. A uno come Bruce Springsteen non serve molto, la sobria crudezza dei suoi palchi corrisponde al messaggio, la scena è appena un contenitore dove possono materializzarsi energie fiammeggianti, una tavola che deve rimanere neutra in attesa di pennellate musicali. Ma pensiamo ai Pink Floyd. Cosa sarebbe stata la loro musica senza le geniali mise en scene che hanno fatto epoca? I loro allestimenti sono giustamente passati alla storia perché rappresentavano molto di più di una semplice illustrazione, andavano oltre i limiti imposti dalla traduzione di quanto veniva già prodotto nei dischi. Ogni volta che andavano in tour la scena occupava gran parte dei loro pensieri. C’era un’attenzione maniacale, un punto di vista progettuale, raffinatissimo. Il prodotto finale era, in linea con la totalità che il teatro musicale aveva sperimentato nella classicità del melodramma, un’opera audiovisuale completa, nella quale i musicisti (in controtendenza col culto della personalità diffuso nel rock) quasi scomparivano, annullati da macchine di proporzioni disumane. La scena può essere ogni cosa, anche il suo esatto contrario, come quando i Kraftwerk misero sul palco quattro robot al loro posto, come dire una costruzione talmente autosufficiente da poter fare a meno perfino degli stessi musicisti. Ma quella era una provocazione, un monito sugli artifici che stavano minacciosamente prendendo il posto degli individui. Anche Peter Gabriel una volta Repubblica Nazionale DOMENICA 12 APRILE 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 IL LIBRO Si intitola On the Stage I grandi palchi del rock (Stampa Alternativa, 167 pagine, 25 euro, in libreria dal 15 aprile) il libro di Cesare Molinari con fotografie di Bruno Marzi che raccoglie idee, soluzioni, progetti e segreti delle scenografie di memorabili concerti da The Wall in Berlin dei Pink Floyd alle performance barocche dei Rolling Stones, alle idee di Peter Gabriel e David Bowie al PopMart Tour degli U2 a Vasco fino a Madonna ZOOTV TOUR FOTO BRUNO MARZI Accanto, progetti per il palco dello ZooTV Tour degli U2; sotto, il progetto Gigabyte City del Voodoo Lounge Tour dei Rolling Stones e uno storyboard di Mark Fisher per The Wall Dr. Dre, Eminem e Snoop Dogg proiettavano video con rapinatori Poi chiedevano: “Spariamo?” volle svelare l’illusione che era sottintesa a ogni spettacolo musicale. Aprì una valigia al centro del palcoscenico e come un provetto prestigiatore ci fece entrare tutti i musicisti e poi lui stesso, scomparendo dalla scena. E ai suoi tempi migliori Michael Jackson chiese aiuto al mago dei maghi, David Copperfield, per mettere a punto un momento del suo show in cui spariva all’improvviso da un lato del gigantesco palco e riappariva istantaneamente dal lato opposto. Senza arrivare a tanto ci sono state scenografie che hanno tradotto in sogni visivi quello che gli artisti predicavano: la teatrale fantascienza di David Bowie, le lunatiche alchimie dei Radiohead, i disgustosi demoni horror dei metallari, gli afrori erotici di Prince e perfino il rap ha avuto i suoi fasti scenici, quando una volta Dr. Dre, Eminem e Snoop Dogg si cimentarono in una faraonica tournée in cui da scenette girate in video si passava magicamente al palcoscenico. Sul video fermavano dei rapinatori, li bloccavano puntandogli delle pistole alla tempia e poi dal vivo chiedevano al pubblico: «Che facciamo, spariamo, o no?». Noi, monaci profani al servizio della musica GIULIANO SANGIORGI er antonomasia: l’abito non fa il monaco, soprattutto se il monaco in questione è ROCK... così dovrebbe andare. Il rock, coerentemente con i suoi principi di “strafottenza” estetica e noncuranza della forma, penserebbe solo alla sostanza della sua voce: la musica. Per cui, peso non avrebbero alcuno, ai fini della sua essenza, abiti da cerimonia, luoghi più o meno sacri, illuminazioni idolatranti o immaginette iconografiche. Basterebbe un posto qualsiasi, un buio o un abito qualsiasi perché quel monaco rock entri in scena a professare “substantia”: e musica sarebbe ovunque! Così dovrebbe andare. Ma il monaco rock, fin dalla notte dei tempi, in verità sceglie e sceglie una chiesa povera a un’altra sfarzosa e ricca e, quando può, si lascia investire dalla luce di un occhio di bue che simuli quella divina e lasci, così, l’odore e la scia di un’icona di se stesso nei secoli dei secoli, almeno spera. È allora che arriva il miracolo. È allora che si ascolta, si sente, si respira e si vede il suo credo. Così il rock sceglie ogni cosa sia necessaria a restare nelle orecchie, negli occhi, nelle narici, nelle mani, sulla pelle dei suoi seguaci. E prima di tutto seleziona il luogo e la maniera migliore per rendere quest’ultimo “il più sacro possibile”. Così va. Eccezion fatta per frati come noi (conventuali devoti al dio bacco Negramaro) che cercano di percorrere una via nel mezzo di questa strada. Obiettivo comune è scegliere luoghi tanto sacri quanto pagani, tanto celebrativi quanto “casual”. Per cui, sia che si tratti di un piccolo teatro o di un grande palazzetto o di un infinito stadio, il nostro atteggiamento è pensare a uno scenario che sia da un lato rispettoso del sacro, dall’altro, ossequioso del profano. Per un palco-evento, abbiamo optato per una struttura imponente e in acciaio che riproponesse, semplicemente, l’ossatura ferrosa del rock. Tralicci giganti hanno creato uno scheletro su cui reggere la pelle sudata di un concerto “vero”, basato sulla sola cruda essenza della musica. Solo due schermi giganti all’esterno palco che rendessero visibile da ogni distanza quello che in scena sarebbe successo di lì a poco. Ci è sembrato un gesto rispettoso nei confronti di un altare da attraversare in punta di piedi. Differente è stato per le scene usate nell’ultimo tour nei palazzetti dello sport di tutta Italia. Qui, siamo già più di casa. Abbiamo optato per soluzioni che si spingessero un po’ più oltre nell’utilizzo di materiale visual, restando pur sempre a servizio completo della musica, unica, assoluta e indiscussa protagonista. Proiezioni su tela bianca entravano in scena solo quando avrebbero dovuto sostenere, con più forza e vigore, il nostro suono. Per ogni tipo di palco e di location cerchiamo sempre di dare un unico concept artistico, coerente con il mood dell’ultimo album. Così, in linea con il nostro ultimo lavoro La finestra, il comune denominatore, nella scelta di scene e scenografia, è stato l’utilizzo di impalcature che meglio rappresentassero fisicamente questo grande oblò da cui guardare il mondo. In tour diversi, con strutture diverse, grandi finestre sono state padrone della scena. Nei teatri con dimensioni e illuminazioni molto intime. Nei palazzetti dello sport con estensioni più grandi e con luci più oniriche e diffuse per tutto il tempio. Nello stadio con unica finestra, grande tutto il palco. L’autore è il cantante dei Negramaro P Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i sapori Sfide di primavera DOMENICA 12 APRILE 2009 L’una ha avuto successo come prodotto industriale; l’altra, fragile costruzione che vive di freschezza e di fragranza, è invece patrimonio e creazione esclusivamente famigliare Entrambe sono al meglio quando escono dalle mani di straordinari artigiani. Per contendersi il posto d’onore al termine del pasto festivo, nel giorno della Resurrezione LICIA GRANELLO «C olomba pasquale Motta, il dolce che sa di primavera». Era il 1934, e nel bel manifesto disegnato da Adolphe Mouron Cassandre per la ditta dell’ex fornaio Angelo Motta, due colombe — l’uccello bianco e il dolce — si sovrapponevano in un fazzoletto di cielo azzurrissimo. Un esempio raffinato di marketing alimentare, perfetta coincidenza di produzione industriale e sentimento popolare. Da allora la colomba non ha più smesso di essere identificata con la celebrazione gastronomica della Pasqua, miscellanea sapiente di valenza simbolica e offerta golosa. In teoria, il posto d’onore nel menù dei dolci pasquali dovrebbe essere condiviso con l’uovo di cioccolato. Ma i due dolci non sono assimilabili: dove la colomba è tutto uno sbriciolio di granella e soffice affondar di denti, l’uovo si frammenta in un attimo per svelare la sorpresa, sua vera ragion d’essere, mentre il contenitore viene smangiucchiato, senza troppo curarsi della qualità. E infatti, se per l’uovo valgono le indicazioni stabilite nel 2003 a carico del cioccolato (minimo 43 per cento per la dizione “finissimo”, obbligo di citazione di grassi diversi dal burro di cacao), da quattro anni la colomba gode di un disciplinare tutto suo, che obbliga i produttori a utilizzare lievito naturale e vieta i grassi idrogenati. La pastiera, invece, non è mai stata oggetto di normative specifiche perché è impossibile produrla industrialmente: troppo fragile la costruzione di un dolce che, tra pasta frolla e farcitura, vive di freschezza e fragranza. Come per il casatiello (la ciambella salata pasquale), le melanzane al cioccolato o la minestra maritata, ogni famiglia vanta un’interpretazione originale, un primato di sapori con cui è impossibile scendere a patti. Così, in un ideale giro di compasso che ingloba Napoli e Costiera, la settimana pre-Pasqua viene vissuta casa per casa in un tormentone di grani bolliti e stampi imburrati. Ma scegliere la ricotta più setosa o procurarsi le uova dal parente contadino non basta. Nella ricerca della perfezione culinaria, che fa del pranzo pasquale napoletano una passerella trionfale di carni e primizie, da un anno all’altro si programmano la giornata giusta, il nu- Due modi italiani di dire Pasqua con dolcezza Colomba contro Pastiera ‘‘ Per far sorridere mia moglie ci voleva la pastiera Ora dovrò aspettare la prossima Pasqua per vederla sorridere di nuovo FERDINANDO II DI BORBONE su Maria Teresa d’Austria, “La regina che non sorrideva mai” mero di pastiere, e soprattutto si sceglie la cucina con il forno migliore: lì, al mattino presto, comincia la produzione in serie, con tre, quattro famiglie e rispettivi vicinati da accontentare. Se i dolci non sono esattamente la vostra specialità, la pasta frolla si spezza solo a guardarla o siete turbati dalle trentacinque ore di lievitazione complessive della colomba, attingete senza pudore al meglio dell’arte bianca, regalandovi una super-pastiera artigianale, la sfiziosa colomba al mandarino tardivo di Ciaculli — creata da Loison in accordo con il presidio Slow Food — o quella squisita prodotta dai detenuti del carcere di Padova (commercializzata anche on line su www.idolcidigiotto.it). In caso di avanzi, invece di riesumare il caffelatte d’antàn, fate un tortino freddo con la colomba a cubetti, cioccolato bianco e fondente sciolti a bagnomaria, latte, colla di pesce ammollata e panna montata. Lo chef milanese Giancarlo Morelli garantisce una Pasquetta golosamente memorabile. itinerari Simone Finazzi è il pasticciere di “Vittorio”, ristorante bistellato vicino a Bergamo. Per la sua colomba, farina con germe di frumento, burro di panna, miele di zagara e mandorle siciliane biologiche RINOMATA OFFELLERIA PERBELLINI PASTICCERIA VENETO DOLCIARIA MANERA AL DOLCE FORNO PREGIATA FORNERIA LENTI Via Vittorio Veneto 46 Bovolone (Vr) Tel. 045-7100599 Via Salvo D’Acquisto 8 Brescia Tel. 030-392586 Via Pietragalletto 5 Fossano (Cn) Tel. 0172-692404 Via Di Lucciano 33/39 Quarrata (Pt) Tel. 0573-738657 Via Raffaello 11 Grottaglie (Ta) Tel. 099-5665376 Repubblica Nazionale DOMENICA 12 APRILE 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 Colomba Il tempo, il grano, l’acqua gli ingredienti sono gli stessi L’alter ego primaverile del panettone diventato dolce-simbolo di Pasqua grazie alla Motta negli anni Trenta, è protetto da una legge che vieta l’uso di grassi idrogenati Lievito madre La miscela di acqua e farina, costantemente rinfrescata e nutrita con succhi di frutta e miele, può durare anche anni. Così l’impasto subisce una lievitazione naturale che garantisce la fragranza Mandorle Intere, dimezzate, polverizzate o tagliate in lamelle, le mandorle tostate vengono usate per preparare la glassa Nelle produzioni industriali si trovano spesso le armelline Glassa Bianchi d’uovo, zucchero a velo e frusta: così si lavora la ghiaccia che rifinisce la colomba. Prima di spalmare l’impasto si aggiungono le mandorle macinate Uova Freschissime le uova da inserire a una a una nell’impasto, cominciando dai tuorli e dimezzando la quota albumi. Nella ricetta vegana, le uova vengono sostituite dall’olio di mais Pastiera La profumata torta di pasta frolla ripiena di un impasto a base di ricotta, uova e grano cotto, nasce come cibo primaverile. Il nome deriva dalla pasta cotta con cui veniva farcita CORRADO ASSENZA ono stato invitato come arbitro imparziale — vivo su un’isola dove non c’è tradizione né di colomba, né di pastiera — di una disfida a suon di dolci primaverili, profumi di bontà. Al di là della ricorrenza religiosa, votata alla pace e alla riconciliazione, il periodo tormentato della vita delle gente che nel nostro Paese vive e lavora mi suggerisce di frugare tra similitudini e sintonie più che occuparmi di chi primeggia e siede sul trono. Li definirei entrambi dolci sapienti. La colomba, quella industriale padana, è generata dalle esigenze di una produzione stagionale (il panettone), per la necessità di ammortizzare i costi degli impianti. La pastiera, figlia della generosa cultura partenopea, solare, mediterranea, è intrisa di mille leggende e novelle che ne datano alla notte dei tempi le forme più ancestrali. Simile, in questo, all’altro dolce bandiera della cultura gastronomica del Sud Italia: la cassata siciliana. Ma la cosa che più di tutte le accosta è il loro stretto legame con la cultura del tempo lento (parlo ovviamente delle preparazioni artigianali dei grandi interpreti delle due ricette). Il tempo diventa ingrediente: la lunga preparazione del lievito madre, le ripetute lievitazioni dell’impasto nella colomba, la preparazione del grano ammollato per giorni e cotto a fiamma bassissima nella pastiera. Al di là della frenesia della vita moderna, il tempo, tanto, tutto quello necessario, riesce come valore intrinseco delle due specialità, restituisce la giusta immagine alla cura che il singolo artigiano pone nella preparazione del proprio capolavoro. Il tempo e gli ingredienti. I più poveri, i più umili: il grano e l’acqua. Il primo, sotto forma di farina nella colomba e in forma propria nella pastiera, ha fondamentale importanza nella leggerezza e nel profumo che il dolce emana a partire dagli impasti preliminari fino all’arrivo in tavola. Abbiamo imparato quali varietà adottare per la preparazione di una grande pasta lievitata, che la parte proteica del grano deve reggere, sostenendone lo sviluppo in cottura. La stessa scienza ci regala indicazioni valide per scegliere il grano da pastiera, che deve reggere il lungo ammollo ed esprimere delicata fragranza, una volta miscelato con la ricotta e gli altri ingredienti aromatici. La seconda ha un ruolo vitale per la miriade di microelementi che contiene ed è generatrice di vita nel lievito madre, coccola estrema durante l’ammollo e la cottura di un cereale dall’involucro tenace come il grano. Usare acque di sorgente o acque clorate d’acqedotto fa una differenza incredibile... Due diversi bouquet, un solo obbiettivo: proclamare a bocca piena l’arrivo della primavera. Impossibile scegliere una delle due. Appartengono entrambe ai dolci che amo realizzare, sapienti, capaci di raccontare la cultura della gente che li produce, la bontà della terra e il lavoro dei contadini. Un insegnamento per gli artigiani di domani, purché ancora disposti, a discapito di qualche sacrificio, a sfornare dolci come questi, fragranti profumi di primavera. Che sia Pasqua, buona Pasqua. L’autore, uno dei più rinomati artigiani dolciari italiani, gestisce il “Caffè Sicilia” di Noto (Siracusa) S Ricotta Di pecora e mucca insieme, o di sola pecora (secondo i puristi), va setacciata e lavorata con gli altri ingredienti. La sua freschezza è importante per bilanciare le note dolci Grano Lasciato a lungo in ammollo (cambiando l’acqua), viene cotto lentamente nel latte Può essere tritato per meglio impastarlo con la ricotta Nella farcitura tradizionale i chicchi sono interi Fiori d’arancio L’essenza ottenuta lasciando in infusione i fiori di arancio amaro (zagare) per un giorno intero in acqua, scuotendo e filtrando il liquido, è la “firma” della pastiera Si trova anche in fialetta Canditi Ben diversi dai tocchetti di rapa colorata di certe produzioni a basso costo, si producono con scorze di agrumi biologici cotte a bassa temperatura in bagni di sciroppo di zucchero itinerari Mario Iaccarino dirige il ristorante di famiglia, il glorioso “Don Alfonso” sulla costiera sorrentina Nel menù primaverile, uno strepitoso soufflé di pastiera con sorbetto di fiori di zagara PASTICCERIA ALFONSO PEPE SCATURCHIO PASTICCERIA SCHETTINO MOCCIA PASTICCERIA MARIGLIANO Via Nazionale 2/4 S. Egidio del Monte Albino (Sa) Tel. 081-5154151 P.zza San Domenico Maggiore19 Napoli Tel. 081-5516944 Via Napoli 129 Castellammare di Stabia (Na) Tel. 081-8725203 Via S. Pasquale 77 Napoli Tel. 081-42506 Via D’Annunzio 7 San Gennarello di Ottaviano Tel. 081-5296831 Repubblica Nazionale DOMENICA 12 APRILE 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 le tendenze Società liquida Gli spazi della casa si ibridano sempre più e gli arredi non sono da meno: tavolini-sgabelli, cucine-armadio, poltrone-chaise longue... I materiali seguono: plastica, pietra, ferro invadono anche l’interno dell’appartamento INTRECCI D’AUTORE NON SOLO VASO VESTIVAMO ALLA MARINARA DESIGN D’ANTAN Vegetal si ispira alla topiaria, antica arte dei giardini Dei fratelli Bourollec per Vitra Cubalibre di Plust, a forma di bicchiere tumbler, ha illuminazione interna Marseille è una delle quattro poltrone Dedon Dress Code che Jean-Marie Massaud “veste” con texture moda Patricia Urquiola reinterpreta il passato con Re-Trouvé In tondino di ferro, per Emu Mobilianfibi (ECO)LOGICAL MIND COME TESSUTO Dalla prima collezione esterni Roche Bobois, Bel Air, con seduta profonda e rivestimento riciclabile L’effetto ondulato del policarbonato cita il tessuto plissé. Impilabile e in sei colori, è Frilly di Kartell AURELIO MAGISTÀ nche il design si fa liquido. Peccato che la metafora di Zygmunt Bauman, per colpa della troppa fortuna, sia un po’ inflazionata, ben oltre i significati che il sociologo polacco gli attribuiva nel saggio Modernità liquida. Quindi è quasi con riluttanza che la decliniamo nel design, ma è la riluttanza dell’inevitabile. Perché la metafora della liquidità allude alla mutevolezza dei liquidi, che non hanno forma ma assumono quella del recipiente che li contiene. Il design è elaborazione di forme. E il design contemporaneo è davvero, appunto, liquido. Liquido perché crea forme mutevoli, destinate a mettere in crisi classificazioni e definizioni consuete, e i caratteri che lo dominano sono l’eclettismo, la polifunzionalità, la trasformabilità. Gli spazi della casa si ibridano: il soggiorno con la cucina, la camera da letto con il bagno, fino al caso estremo dello spazio unico, sia il loft dei ricchi che il monolocale di chi, single o giovani coppie, fa di necessità virtù. Nello stesso modo, le distinzioni dei mobili tradizionali si indeboliscono: tavolini-sgabelli, cucine-armadio, poltrone-chaise longue... Le strutture dei mobili incorporano snodi e parti che si muovono e parti che possono essere aggiunte oppure tolte per assecondare i bisogni del momento: l’ormai antico divano letto ha fatto lezione fino a diventare paradigmatico. Le principali tendenze che già si intui- A OTTOCENTO CONTEMPORANEO Crinoline di B&B Italia ha schienale alto e rigido - come l’accessorio moda da cui prende nome - fatto in corda intrecciata scono del prossimo Salone del mobile, in programma alla fiera di Rho dal 22 al 27 aprile, sono quasi tutte nel segno di questa liquidità. Fra queste scegliamo quella più adatta a far da esempio: mobili ibridi in spazi ibridi. La casa è per definizione uno spazio chiuso che si definisce come in, dentro, in opposizione a un out, fuori. Ma la casa ha le sue eccezioni, spazi di compromesso e di confine, spazi liquidi che generano mobili anch’essi ibridi: giardini, terrazze, balconi, porticati, verande. In concreto questo che cosa significa? Non solo rimandi di elementi stilistici fra mobili da esterno e mobili da interno. Ma anche materiali tipicamente da esterno come le plastiche, la pietra, il ferro, che contagiano i mobili da appartamento, mentre i mobili per esterno diventano raffinati ed eleganti: hanno imbottiture, cuscini, dettagli in tessuto. Tutto apparentemente poco pratico, ma si tratta quasi sempre di elementi staccabili che possono essere presi e messi al riparo quando serve. La contaminazione fra in e out, poi, è suggerita da altri dettagli che alludono al portare dentro e fuori, come le ruote per chaise longue, tavoli e divani, l’ampliabilità (tavoli allungabili), la chiudibilità (sedie pieghevoli), per una casa dove il movimento degli arredi racconta una vita di relazione altrettanto movimentata. Una volta si diceva: vestiti, usciamo. Adesso il fuori, grazie al design, viene risucchiato dentro. Vengono gli amici e si sta in terrazza, in balcone se di più non si può. I mobili lo permettono, e costa molto meno. Buoni per dentro e fuori adatti a una vita in movimento DOPPIA VOCAZIONE Alison è il sistema divani per interni e esterni di Rodolfo Dordoni per Minotti. In legno massello d’iroko, stabilizzato in forni di essiccazione Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 12 APRILE 2009 l’incontro Non è più nessuno dei personaggi televisivi che gli dettero fama: Fantozzi, Fracchia, il professor Kranz A settantasette anni è un narratore di nostalgie e di amici scomparsi: De André, Gassman, Tognazzi... Gli sono compagne la memoria, l’intelligenza acuminata, la scrittura Mentre sta per uscire il suo nuovo libro, lui si guarda indietro e conclude: “Sì, posso dire di essere stato molto felice” Solitari Paolo Villaggio on riesce a ridere. Sotto il vetro della sua terrazza romana di via Anapo ti aspetti che prima poi una risata si liberi dalla sua grande pancia o dalla barba bianca o dalla voce da rodomonte e finalmente ti contagi. Ma non succede. Attorno tutto è semplice, essenziale, un po’ triste. Un divano di tela grezza, una scrivania di legno sottile, un computer, una risma di fogli pieni di appunti, due bicchieri di acqua naturale. Paolo Villaggio non è più Fantozzi, non è più Fracchia, non è più il cattivo tedesco, il professor Kranz. È un narratore di nostalgie, di rimpianti, di amici che sono scomparsi e si sono rivelati insostituibili, di solitudini con le quali bisogna fare conti che non quadrano mai. I ricordi volano come piume uscite da un cuscino, sono difficili da raccogliere. Villaggio usa una memoria che appare intatta, un’acuminata e diabolica intelligenza e la tenacia presa in prestito dal fratello gemello. «Piero è un marziano. Da ragazzo ogni giorno studiava a memoria cento versi dell’Iliade tradotta da Vincenzo Monti. Lo trascinavo a fatica nelle partite di pallone, non rivolgeva parola a nessuno. Correva sul campo ripetendo a alta voce la morte di Ettore. Alla fine la sapevano tutti, arbitro compreso». Si comincia da Genova. Metà degli anni Sessanta. Appena dopo l’esperienza sulla “Federico C.”, nave da crociera della Costa. Sul ponte Villaggio e De André a fare i menestrelli. «Due piani sotto, al night, un pianista bravissimo. Lui, Silvio Berlusconi, una voce straordinaria, la sua vera vocazione. Un incantatore, e continua a esserlo. Berlusconi non è un fascista. È piuttosto un utilitarista entra- il sodalizio con Vaime, Terzoli e Marcello Marchesi. L’incontro con Cochi e Renato: «Grandissimi, due scemi veri. Pozzetto mi ha sempre divertito molto, il comico deve essere uno squilibrato, un malato di mente. Per strada la gente lo abbracciava e rideva, a me mostravano i pugni. Mi odiavano». Volti che si affollano. Amicizie, gesti che sembrano muoversi ancora adesso nell’aria di questa terrazza al sole. Vittorio Gassman: «Un genio. Lui, sì, buono davvero, leale e per nulla ipocrita, un signore sia con gli umili sia con i potenti. Siamo a Madrid, invitati a Villa Italia per un ricevimento con il re Juan Carlos. Vittorio è ubriaco, precipita lungo lungo com’è lui su un tavolo pieno di bicchieri che cadono e si frantumano con rumore orrendo. Lui grida mentre ancora sta volando con la sua voce da baritono: “Non vi preoccupate, rispondo di tutto…”». Ugo Tognazzi: «Il più intelligente e il più vero. Un uomo che sapeva donare allegria e che vendicava le massaie perché era orgoglioso di essere un provinciale. Lo ricordo in un Costanzo Show con Sgarbi e Zecchi che discutevano animatamente e dottamente di ar- Mi piacerebbe morire e ricominciare, vivere nel 36.500 dopo Cristo. Oggi abitiamo un mondo imbarazzante, prigionieri del presenzialismo e della mediocrità FOTO FARABOLAFOTO N ROMA to in politica per difendere le sue aziende e la sua felicità. Oggi è un imperatore appena punzecchiato da una sinistra che non esiste, con capi improvvisati che si azzannano tra di loro con una ferocia da portineria. Veltroni ha un talento da aiuto regista, Franceschini non so, forse ha dalla sua il vantaggio di essere un po’ più giovane…». Genova, si diceva. Una balera, sigarette e vino bianco. Canzoni popolari storpiate, luride, scollacciate più degli abiti delle ragazzotte appena carine che spiccavano in una platea in prevalenza maschile. Paolo voce per così dire narrante, Fabrizio alla chitarra. «Una sera in fondo alla sala compare un signore grassottello e con i baffi che assomiglia a Maurizio Costanzo. È proprio lui. Mi si avvicina e mi fa: sono un giornalista di Grazia, venga a Roma, le garantisco che avrà un grande successo. Io lo guardo come si guarda uno squilibrato e mi trattengo a fatica dal mandarlo a cagare». Paolo Villaggio lavora all’Italsider, è un impiegato di secondo livello, un banco all’ufficio servizi, uno stipendio di 120mila lire al mese. È Fantozzi prima della sua nascita. Nella coppia vera la parte forte è la moglie Maura. È lei a spingerlo al di là della sua codardia. Gli dice, più o meno come farà qualche anno dopo la signora Pina con Ugo: «Scegli l’incerto per il certo». Gli domando se un uomo cattivo, una carogna, è quasi sempre anche un vigliacco. Dice: «Le peggiori carogne sono le persone che si ammantano di bontà. Sono stato tra le 180 suore di Calcutta e ho incontrato madre Teresa, quando il suo sguardo si è posato su di me non mi è piaciuto affatto, non era uno sguardo buono. Io sono soprattutto pigro, la pigrizia, come mi disse Leo Benvenuti, mi ha impedito di diventare un grand’uomo. Sono fisicamente un vigliacco e non sono un generoso, uso il denaro come mezzo di corruzione. Ma non sono avaro. La leggenda sulla tirchieria dei genovesi è una balla, gli avari autentici sono i piccoli borghesi romani, gentaglia». A Roma Villaggio arriva nel ‘66, sulla scena esordisce che è ottobre. «Al “Sette per Otto” di Trastevere, via del Mattonato. Una specie di museo, un sottoscala. Ci sono Garinei, Giovannini, Marco Ferreri incazzato in un angolo. Tognazzi va via indispettito perché c’è troppa gente e lui non riesce a respirare, Flaiano cade dalla sedia per il troppo ridere, Sergio Saviane scriverà di essere venuto a vedermi in una cantina pieno di diffidenza e di avere scoperto uno spettacolo straordinario e un linguaggio completamente nuovo». La strada si trasforma in una discesa. Milano, la tv, te e filosofia. Costanzo a un certo punto della trasmissione gli chiede le ragioni del suo silenzio e lui: “Mi scusi dottor Costanzo, non ho detto una parola perché data la mia ignoranza non ho ancora capito un cazzo”». Alberto Sordi: «Il primo comico italiano veramente cattivo. Sublime». Totò e Peppino: «Buoni, ignoranti e poveri. Totò è il nostro Chaplin». Marco Ferreri: «Autenticamente invidioso, a volte insopportabile, afasico, ma con un ingegno acuto e lampeggiante». Fabrizio De André: «Più simile a me lui di mio fratello gemello. Gli piaceva giocare a fare l’esagerato, come quella volta che per fregare ventimila lire a Gigi Rizzi mangiò un topo morto. Negli anni del successo ci siamo un po’ persi di vista. Fabrizio era ossessionato dal rischio dell’oblio, di essere dimenticato. Lo vado a trovare l’ultima volta in ospedale, al San Raffaele di Milano. So che lo troverò consumato dalla malattia. Metto su un’espressione gioiosa, voglio cercare di rasserenarlo. Lui mi vede e fa: “Smonta quella faccia, so benissimo quello che mi aspetta. Ricordati che quando ti chiederanno di me, dovrai dire che non sono stato un cantautore, ma un grande poeta”. Ecco, ora lo dico credendoci». Paolo Villaggio ha settantasette anni. Scrive libri. La sua Storia della libertà di pensiero edito da Feltrinelli è stato letto da moltissimi ragazzi tra i quindici e i diciassette anni. Tra pochi giorni uscirà da Mondadori Storie di donne straordinarie, biografie delle mamme di uomini famosi, da Mosè a San Francesco, da Gesù a Dante, da Proust a Hitler. Una macchina del tempo. «Mi piacerebbe morire e ricominciare, vivere nel 36.500 dopo Cristo. Oggi abitiamo un mondo imbarazzante, prigionieri del presenzialismo, della mediocrità nelle arti e della filosofia ereditata dall’America: non conta essere felici ma sembrarlo. E viviamo nell’invenzione di Dio. Mi domando come si faccia a credere in Dio, con questo Papa vestito da monaco medievale che pensa di essere il solo depositario della verità, con un Vaticano dove regnano sodomia e pedofilia, con una Chiesa che è stata peggio dello stalinismo, che ha inventato la tortura e che bruciava chi osava anche soltanto ipotizzare che forse la terra non era piatta. Abbiamo venduto tutto e buttato via tutto, anche gli odori del mare, dei fiori, delle donne». Torno sulla felicità, mi viene in mente che qualcuno ha detto che vivere è una preghiera che solo l’amore di una donna può esaudire. Villaggio mi spiega di avere sempre evitato il dolore. «Astutamente, come un ebreo, non ho mai cercato fortune impossibili. Ho il terro- re delle sconfitte. Due donne, è vero, mi hanno fatto felice. Mia madre, alla quale ho fatto credere che volevo fare l’aviatore, e mia moglie. Sì, grazie alla mia tenacia assoluta posso dire di essere stato molto felice. Nel ’45 la guerra era appena finita quando mio padre condusse mio fratello e me sulla spiaggia. Genova era segnata dai bombardamenti, eravamo spaventati. Papà ci fece un sorriso bellissimo e disse: “Non sarà sempre così, la vita è una cosa meravigliosa”. Più tardi, col successo, mi sono gonfiato come una rana e così ho perduto mio padre. Quando ero libero invece di tornare a casa da lui preferivo andare in Sardegna a fare il coglione. È il mio più grande rimpianto, vorrei poterlo incontrare ancora una volta, mi basterebbe un pomeriggio, sentirlo leggere per me qualche pagina di un libro. È l’ultimo pezzo di felicità che mi manca». Si alza dalla sedia. Deve andare in casa a prendere un’altra bottiglia d’acqua. L’ampio saio di cotone gli copre il corpo pallido, ma non gli stinchi che sono glabri, i vecchi si pelano come pulcini. Quanto è lontano il ragionier Ugo Fantozzi, il suo «com’è umano lei», la sua «è una cagata pazzesca» che fece crollare il santuario intellettuale di sinistra della Corazzata Potëmkin. «Eppure Fantozzi esiste più che mai. Io l’avevo vestito da clown, oggi si è travestito. Porta gli orecchini, esibisce l’abbronzatura artificiale e i capelli impomatati. La dittatura televisiva gli impone desideri comuni e disperati, il confronto con Berlusconi e i tronisti di Maria De Filippi. I Fantozzi di oggi non ce la fanno, il mio a guardar bene sì. È stato assunto a ventitré anni, ha il posto fisso, una moglie che lo ama benché ripugnante, la sua Bianchina, la gita sul mare di Ostia e la settimana bianca aziendale. Sta in un inferno, ma lui ne è consapevole ed è orgoglioso delle cose semplici che possiede. In fondo non è infelice, è soltanto sfigato». ‘‘ DARIO CRESTO-DINA Repubblica Nazionale
Scarica