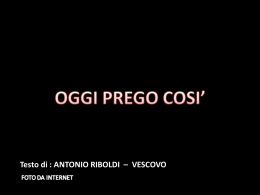RASSEGNA STAMPA di martedì 22 marzo 2016 SOMMARIO Ancora un attentato, ancora tanti morti innocenti. Bruxelles, il cuore dell'Europa, è in queste ore sotto attacco terroristico. Prima due esplosioni all'aeroporto di Bruxelles Zaventem alle 8 del mattino che hanno ucciso almeno 13 persone e ne ha ferite 35. Un'ora dopo due altre bombe sono esplose in centro, alle fermate di Metro Maelbeek e Schumann, vicino alle istituzioni europee. Secondo i media belgi 10 persone hanno perso la vita, portando complessivamente il bilancio (provvisorio, ovviamente) delle vittime a 23. Un assedio che segue di tre giorni dall'arresto di Salah Abdeslam, il principale ricercato per gli attentati di Parigi del 13 novembre. L’Osservatore Romano pubblica ed anticipa oggi le meditazioni delle quattordici stazioni della Via crucis che sarà presieduta da Papa Francesco al Colosseo la sera del venerdì santo; sono state scritte dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, che ha intitolato la sua riflessione «Dio è misericordia». Il testo integrale è in Rassegna, qui proponiamo ed evidenziamo tre stazioni. SETTIMA STAZIONE - Gesù cade per la seconda volta Dal libro del profeta Isaia 53, 2-3: Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Gesù cade ancora. Schiacciato ma non ucciso dal peso della croce. Ancora una volta Egli mette a nudo la sua umanità. È un’esperienza al limite dell’impotenza, di vergogna dinanzi a chi lo schernisce, di umiliazione davanti a chi aveva sperato in lui. Nessuna persona vorrebbe mai cadere a terra e sperimentare il fallimento. Specialmente di fronte ad altre persone. Spesso gli uomini si ribellano all’idea di non avere potere, di non avere la capacità di portare avanti la propria vita. Gesù, invece, incarna il “potere dei senza potere”. Sperimenta il tormento della croce e la forza salvifica della fede. Solo Dio può salvarci. Solo Lui può trasformare un segno di morte in una croce gloriosa. Se Gesù è caduto a terra una seconda volta, per il peso del nostro peccato, accettiamo allora anche noi di cadere, d’esser caduti, di poter cadere ancora per i nostri peccati. Riconosciamo di non poterci salvare da soli con le nostre forze. Signore Gesù, che hai accettato l’umiliazione di cadere ancora sotto gli occhi di tutti, ti vorremmo non solo contemplare mentre sei nella polvere, ma fissare in te il nostro sguardo, dalla stessa posizione, anche noi a terra, caduti per le nostre debolezze. Donaci la coscienza del nostro peccato, quella volontà di rialzarsi che nasce dal dolore. Dà a tutta la tua Chiesa la consapevolezza della sofferenza. Offri in particolare ai ministri della Riconciliazione il dono delle lacrime per il loro peccato. Come potrebbero invocare su di sé e sugli altri la tua misericordia se non sapessero prima piangere le loro colpe? UNDICESIMA STAZIONE - Gesù è crocifisso Dal Vangelo secondo Luca 23, 39-43: Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». Gesù sta sulla croce, «albero fecondo e glorioso», «talamo, trono ed altare» (Inno liturgico Ecco il vessillo della croce). E dall’alto di questo trono, punto d’attrazione dell’intero universo (cfr. Gv 12, 32), perdona i suoi crocifissori «perché non sanno quello che fanno» (Lc 23, 34). Sulla croce di Cristo, «bilancia del grande riscatto» (Inno liturgico Ecco il vessillo della croce), risplende una onnipotenza che si spoglia, una sapienza che si abbassa fino alla follia, un amore che si offre in sacrificio. Alla destra e alla sinistra di Gesù ci sono due malfattori, probabilmente due omicidi. Quei due malfattori parlano al cuore di ogni uomo perché indicano due modi differenti di stare sulla croce: il primo maledice Dio; il secondo riconosce Dio su quella croce. Il primo malfattore propone la soluzione più comoda per tutti. Propone una salvezza umana e ha uno sguardo rivolto verso il basso. La salvezza per lui significa scappare dalla croce ed eliminare la sofferenza. È la logica della cultura dello scarto. Chiede a Dio di eliminare tutto ciò che non è utile e non è degno di essere vissuto. Il secondo malfattore, invece, non mercanteggia una soluzione. Propone una salvezza divina e ha uno sguardo tutto rivolto verso il cielo. La salvezza per lui significa accettare la volontà di Dio anche nelle condizioni peggiori. È il trionfo della cultura dell’amore e del perdono. È la follia della croce nei confronti della quale ogni sapienza umana non può che svanire e ammutolire nel silenzio. Donami, o Crocifisso per amore, quel tuo perdono che dimentica e quella tua misericordia che ricrea. Fammi sperimentare, in ogni Confessione, la grazia che m’ha creato a tua immagine e somiglianza e che mi ricrea ogni volta che io pongo la mia vita, con tutte le sue miserie, nelle mani pietose del Padre. Che il tuo perdono risuoni per me come certezza dell’amore che mi salva, mi fa nuovo e mi fa stare con te per sempre. Allora io sarò davvero un malfattore graziato e ogni perdono tuo sarà come un assaggio di Paradiso, già da oggi. QUATTORDICESIMA STAZIONE - Gesù è deposto nel sepolcro Dal Vangelo secondo Matteo 27, 59-60: Giuseppe prese il corpo [di Gesù], lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. Mentre Giuseppe chiude il sepolcro di Gesù, Egli scende negli inferi e ne spalanca le porte. Quella che la Chiesa Occidentale chiama “discesa agli inferi”, la Chiesa Orientale la celebra già come Anastasi, cioè “Risurrezione”. Le Chiese sorelle comunicano così all’uomo la piena Verità di questo unico Mistero: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete» (Ez 37, 12. 14). La tua Chiesa, Signore, ogni mattina canta: «Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte» (Lc 1, 78-79). L’uomo, abbagliato da luci che hanno il colore delle tenebre, spinto dalle forze del male, ha rotolato una grande pietra e ti ha chiuso nel sepolcro. Ma noi sappiamo che tu, Dio umile, nel silenzio in cui la nostra libertà ti ha posto, sei all’opera più che mai per generare nuova grazia nell’uomo che ami. Entra, dunque, nei nostri sepolcri: ravviva la scintilla del tuo amore nel cuore di ogni uomo, nel grembo di ogni famiglia, nel cammino di ogni popolo. O Cristo Gesù! Tutti camminiamo verso la nostra morte e la nostra tomba. Permettici di fermarci in spirito accanto al tuo sepolcro. Che la potenza di Vita, che in esso si è manifestata, trafigga i nostri cuori. Che questa Vita diventi la luce del nostro pellegrinaggio sulla terra. Amen. (San Giovanni Paolo II) Intanto, proprio in queste ore, sta per andare on line il rinnovato sito diocesano. Lo si cerca e lo si trova sempre allo stesso indirizzo: www.patriarcatovenezia.it . Ma adesso si presenta tutto cambiato e profondamente rinnovato, per essere sempre più e meglio al servizio della Chiesa veneziana favorendo la comunicazione e la messa in circolo - anzi “on line” - di quanto in essa succede e delle principali informazioni o approfondimenti che la riguardano. Un’immediata visita e un bel giro di… navigazione lo merita senz’altro. 3 – VITA DELLA CHIESA L’OSSERVATORE ROMANO Pagg 4 – 5 Dio è misericordia Le meditazione per la Via crucis presieduta dal Papa la sera di venerdì santo Pag 8 Amore senza fine Nella domenica delle Palme il Papa parla della passione di Gesù e ricorda il destino dei profughi di cui nessuno si assume la responsabilità Pag 8 Avanti con coraggio All’Angelus affida la Gmg all’intercessione di san Giovanni Paolo II CORRIERE DELLA SERA Pag 49 L’appello di suor Rita per una chiesa di donne di Dacia Maraini IL FOGLIO Pag 1 Rivoluzione o no? Cosa aspettarsi dal verdetto del Papa sul Sinodo di Matteo Matzuzzi Porte aperte ma non troppo WWW.CHIESA.ESPRESSONLINE.IT Lavanda per tutti. Il giovedì santo di Francesco di Sandro Magister La lavanda dei piedi mette ormai in ombra la messa dell'ultima cena. Il papa ha ammesso al rito le donne, purché appartenenti alla Chiesa. Ma lui si spinge più in là e lava i piedi anche ai musulmani 5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO AVVENIRE Pag 2 Le nazioni più felici non sono sempre giuste di Massimo Calvi Il valore dei comportamenti virtuosi, il rischio del bene per sé Pag 3 Berlino e la grande inflazione. Crisi e conseguenze politiche di Antonio Fazio La lezione della storia per l’economia e la democrazia 8 – VENETO / NORDEST CORRIERE DEL VENETO Pag 5 Vita da Erasmus, quei centomila veneti nel “cuore” dell’Europa di Sara D’Ascenzo Fenomeno in crescita in tutti i nostri atenei Pag 8 Picchiata e minacciata dal marito per 40 anni. “Il prete mi diceva: sopporta e prega” di Milvana Citter Nel Trevigiano … ed inoltre oggi segnaliamo… CORRIERE DELLA SERA Pag 1 Non tradiamo il loro sogno di Beppe Severgnini Pagg 2 – 3 Progetti e sogni di sette ragazze La tragedia dell’Erasmus. Avevano tutte tra 22 e 25 anni. Provenivano da Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana e Lazio. I volti e le storie delle vittime dell’incidente di Tarragona Pag 15 Lavacri e nostalgie, gli ex Msi e i conti con il passato mai fatti del tutto di Pierluigi Battista Pag 28 I rischi del decisionismo senza corpi intermedi di Giuseppe De Rita LA REPUBBLICA Pag 41 Il cristianesimo sulla via dell’Oriente di Silvia Ronchey LA STAMPA Una tragedia che tocca ogni famiglia di Francesca Sforza AVVENIRE Pag 1 Come in uno specchio di Marina Corradi Un vertiginoso dolore, e domande Pag 2 Quelli che non sanno quello che fanno di Ferdinando Camon Salah e tutti gli altri pronti a dare la morte Pag 12 Ecco la stepchild per sentenza di Angelo Picariello Utero in affitto in Canada, a Roma accolta richiesta del partner. La politica surrogata. Reazioni: “Scavalca il Parlamento” LA NUOVA Pag 1 Quei ragazzi andati via sognando di Giorgio Boatti Torna al sommario 3 – VITA DELLA CHIESA L’OSSERVATORE ROMANO Pagg 4 – 5 Dio è misericordia Le meditazione per la Via crucis presieduta dal Papa la sera di venerdì santo Le meditazioni delle quattordici stazioni della Via crucis che sarà presieduta da Papa Francesco al Colosseo la sera di Venerdì santo, 25 marzo, sono state scritte dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia - Città della Pieve. Il presule ha intitolato la sua riflessione «Dio è misericordia». Il testo che anticipiamo, come di consueto, sarà pubblicato anche dalla Libreria editrice Vaticana. Le immagini - tratte dal ciclo che illustra il libretto preparato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice riproducono alcune formelle di maiolica della Via crucis realizzata nel 1930 da Alfredo Santarelli (Gualdo Tadino, 1874 - ivi, 1957) per la cappella del seminario arcivescovile perugino. Introduzione Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! (2 Cor 1, 3). In questo Giubileo straordinario, anche la Via Crucis del Venerdì Santo ci attrae con una forza particolare, quella della misericordia del Padre Celeste, che vuole riversare su tutti noi il suo Spirito di grazia e di consolazione. La misericordia è il canale della grazia che da Dio arriva a tutti gli uomini e le donne di oggi. Uomini e donne troppo spesso smarriti e confusi, materialisti e idolatri, poveri e soli. Membra di una società che sembra aver rimosso il peccato e la verità. «Guarderanno a me, colui che hanno trafitto» (Zc 12, 10): si adempiano anche in noi, questa sera, le parole profetiche di Zaccaria! Lo sguardo si sollevi dalle nostre infinite miserie per fissarsi su di Lui, Cristo Signore, Amore Misericordioso. Allora potremo incontrare il suo volto e udire le sue parole: «Ti ho amato di amore eterno» (Ger 31, 3). Egli, col suo perdono, cancella i nostri peccati e ci apre il cammino della santità, sul quale abbracceremo la nostra croce, insieme a Lui, per amore dei fratelli. La fonte che ha lavato il nostro peccato diventerà in noi «una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4, 14). Preghiera Eterno Padre, attraverso la Passione del tuo diletto Figlio, hai voluto rivelarci il tuo cuore e donarci la tua misericordia. Fa’ che, stretti a Maria, sua e nostra Madre, sappiamo accogliere e custodire sempre il dono d’amore. Sia lei, Madre della Misericordia, a presentarti le preghiere che ti innalziamo per noi e per tutta l’umanità, affinché la grazia di questa Via Crucis raggiunga ogni cuore umano e vi infonda nuova speranza, quella speranza indefettibile che si irradia dalla Croce di Gesù, che vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. PRIMA STAZIONE Gesù è condannato a morte Dal Vangelo secondo Marco 15, 14-15: Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Gesù è solo dinanzi al potere di questo mondo. E si sottopone fino in fondo alla giustizia degli uomini. Pilato si trova dinanzi a un mistero che non arriva a comprendere. Si interroga e chiede spiegazioni. Cerca una soluzione e arriva, forse, fin sulla soglia della verità. Ma sceglie di non varcarla. Tra la vita e la verità, sceglie la propria vita. Tra l’oggi e l’eternità, sceglie l’oggi. La folla sceglie Barabba e abbandona Gesù. La folla vuole la giustizia sulla terra e sceglie il giustiziere: colui che potrebbe liberarli dall’oppressione e dal giogo della schiavitù. Ma la giustizia di Gesù non si compie con una rivoluzione: passa attraverso lo scandalo della croce. Gesù sconvolge ogni piano di liberazione perché prende su di sé il male del mondo e non risponde al male con il male. E questo gli uomini non lo capiscono. Non capiscono che da una sconfitta dell’uomo può derivare la giustizia di Dio. Ognuno di noi, oggi, è parte integrante di quella folla che grida: «Crocifiggilo!». Nessuno può sentirsi escluso. La folla e Pilato, infatti, sono dominati da una sensazione interiore che accomuna tutti gli uomini: la paura. La paura di perdere le proprie sicurezze, i propri beni, la propria vita. Ma Gesù indica un’altra strada. Signore Gesù, come ci sentiamo simili a questi personaggi. Quanta paura c’è nella nostra vita! Abbiamo paura del diverso, dello straniero, del migrante. Abbiamo timore del futuro, degl’imprevisti, della miseria. Quanta paura nelle nostre famiglie, negli ambienti di lavoro, nelle nostre città... E forse abbiamo paura anche di Dio: quella paura del giudizio divino che nasce dalla poca fede, dalla non conoscenza del suo cuore, dal dubbio sulla sua misericordia. Signore Gesù, condannato dalla paura degli uomini, liberaci dal timore del tuo giudizio. Fa’ che l’urlo delle nostre angosce non ci impedisca di sentire la dolce forza del tuo invito: «Non abbiate paura!». SECONDA STAZIONE Gesù è caricato della croce Dal Vangelo secondo Marco 15, 20: Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. La paura ha emesso la sentenza, ma non può svelarsi e si nasconde dietro gli atteggiamenti del mondo: scherno, umiliazione, violenza e derisione. Ora Gesù è rivestito delle sue vesti, della sua sola umanità, dolorosa e sanguinante, senza più alcuna «porpora», né alcun segno della sua divinità. E come tale Pilato lo presenta: «Ecce homo!» (Gv 19, 5). Questa è la condizione di chiunque si mette alla sequela di Cristo. Il cristiano non cerca l’applauso del mondo o il consenso delle piazze. Il cristiano non adula e non dice menzogne per conquistare il potere. Il cristiano accetta lo scherno e le umiliazioni che derivano dall’amore della verità. «Che cos’è la verità?» (Gv 18, 38), aveva chiesto Pilato a Gesù. Questa è la domanda di ogni tempo. È la domanda di oggi. Ecco la verità: la verità del Figlio dell’uomo predetto dai Profeti (cfr. Is 52, 13 – 53, 12), un volto umano sfigurato che svela la fedeltà di Dio. Troppo spesso, invece, andiamo in cerca di una verità a buon mercato, che faccia comodo alla nostra vita, che risponda alle nostre insicurezze o che addirittura soddisfi i nostri più bassi interessi. In questo modo, finiamo per accontentarci di verità parziali e apparenti, lasciandoci ingannare dai “profeti di sventura che annunciano sempre il peggio” (San Giovanni XXIII) o da abili pifferai che anestetizzano il nostro cuore con musiche suadenti che ci allontanano dall’amore di Cristo. Il Verbo di Dio si è fatto uomo, è venuto a raccontarci la verità tutta intera, su Dio e sull’uomo. Dio è colui che prende la croce sulle sue spalle (cfr. Gv 19, 17) e s’incammina lungo la via del dono misericordioso di sé. E l’uomo che si realizza nella verità è colui che lo segue in quel medesimo cammino. Signore Gesù, donaci di contemplarti nella teofania della croce, il punto più alto della tua rivelazione, e di riconoscere nello splendore misterioso del tuo volto anche i tratti del nostro volto. TERZA STAZIONE Gesù cade la prima volta sotto la croce Dal libro del profeta Isaia 53, 4. 7: Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Gesù è l’Agnello, predetto dal profeta, che s’è caricato sulle spalle il peccato dell’umanità intera. Si è fatto carico della debolezza dell’amato, dei suoi dolori e delitti, delle sue iniquità e maledizioni. Siamo arrivati al punto estremo dell’incarnazione del Verbo. Ma c’è un punto ancor più basso: Gesù cade sotto il peso di questa croce. Un Dio che cade! In questa caduta c’è Gesù che dona senso alla sofferenza degli uomini. La sofferenza per l’uomo è a volte un assurdo, incomprensibile alla mente, presagio di morte. Ci sono situazioni di sofferenza che sembrano negare l’amore di Dio. Dov’è Dio nei campi di sterminio? Dov’è Dio nelle miniere e nelle fabbriche dove lavorano come schiavi i bambini? Dov’è Dio nelle carrette del mare che affondano nel Mediterraneo? Gesù cade sotto il peso della croce, ma non ne rimane schiacciato. Ecco, Cristo è lì. Scarto tra gli scarti. Ultimo con gli ultimi. Naufrago tra i naufraghi. Dio si fa carico di tutto questo. Un Dio che per amore rinuncia a mostrare la sua onnipotenza. Ma anche così, proprio così, caduto a terra come un chicco di grano, Dio è fedele a sé stesso: fedele nell’amore. Ti preghiamo, Signore, per tutte quelle situazioni di sofferenza che sembrano non avere senso, per gli ebrei morti nei campi di sterminio, per i cristiani uccisi in odio alla fede, per le vittime di ogni persecuzione, per i bambini che vengono schiavizzati sul lavoro, per gli innocenti che muoiono nelle guerre. Facci capire, Signore, quanta libertà e forza interiore c’è in questa inedita rivelazione della tua divinità, così umana da cadere sotto la croce dei peccati dell’uomo, così divinamente misericordiosa da sconfiggere il male che ci opprimeva. QUARTA STAZIONE Gesù incontra sua Madre Dal Vangelo secondo Luca 2, 34-35. 51: Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Dio ha voluto che la vita venisse al mondo attraverso le doglie del parto: attraverso le sofferenze di una madre che dà la vita al mondo. Tutti hanno bisogno di una Madre, anche Dio. «Il Verbo si fece carne» (Gv 1, 14) nel grembo di una Vergine. Maria lo ha accolto, lo ha dato alla luce a Betlemme, lo ha avvolto in fasce, lo ha custodito e fatto crescere col calore del suo amore, ed è giunta con Lui alla sua “ora”. Adesso, ai piedi del Calvario, si compie la profezia di Simeone: una spada le trafigge l’anima. Maria rivede il Figlio, sfigurato e sfinito sotto il peso della croce. Occhi addolorati, quelli della Madre, partecipe fino in fondo del dolore del Figlio, ma anche occhi colmi di speranza, che dal giorno del suo “sì” all’annuncio dell’angelo (cfr. Lc 1, 2638) non hanno mai cessato di riflettere quella luce divina che risplende anche in questo giorno di sofferenza. Maria è sposa di Giuseppe e madre di Gesù. Ieri come oggi la famiglia è il cuore pulsante della società; cellula inalienabile della vita comune; architrave insostituibile delle relazioni umane; amore per sempre che salverà il mondo. Maria è donna e madre. Genio femminile e tenerezza. Sapienza e carità. Maria, come madre di tutti, «è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto», è «la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita» e «come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 286). O Maria, Madre del Signore, Tu fosti per il tuo Figlio divino il primo riflesso della misericordia del Padre suo, quella misericordia che a Cana gli chiedesti di manifestare. Ora che tuo Figlio ci rivela il Volto del Padre fino alle estreme conseguenze dell’amore, ti metti, in silenzio, sulle sue orme, prima discepola della croce. O Maria, Vergine fedele, prenditi cura di tutti gli orfani della Terra, proteggi tutte le donne oggetto di sfruttamento e di violenza. Suscita donne coraggiose per il bene della Chiesa. Ispira ogni madre a educare i propri figli nella tenerezza dell’Amore di Dio, e, nell’ora della prova, ad accompagnare il loro cammino con la forza silenziosa della sua fede. QUINTA STAZIONE Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la croce Dal Vangelo secondo Marco 15, 21-22: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «luogo del cranio». Nella storia della salvezza compare un uomo sconosciuto. Simone di Cirene, un lavoratore che tornava dai campi, viene costretto a portare la croce. Ma proprio in lui, per primo, agisce la grazia dell’amore di Cristo che passa attraverso quella croce. E Simone, costretto a portare un peso controvoglia, diventerà un discepolo del Signore. La sofferenza, quando bussa alla nostra porta, non è mai attesa. Appare sempre come una costrizione, talvolta perfino come un’ingiustizia. E può trovarci drammaticamente impreparati. Una malattia potrebbe rovinare i nostri progetti di vita. Un bambino disabile potrebbe turbare i sogni di una maternità tanto desiderata. Quella tribolazione non voluta bussa, però, prepotentemente al cuore dell’uomo. Come ci comportiamo di fronte alla sofferenza di una persona amata? Quanto siamo attenti al grido di chi soffre ma vive lontano da noi? Il Cireneo ci aiuta a entrare nella fragilità dell’anima umana e mette in luce un altro aspetto dell’umanità di Gesù. Persino il Figlio di Dio ha avuto bisogno di qualcuno che lo aiutasse a portare la croce. Chi è dunque il Cireneo? È la misericordia di Dio che si fa presente nella storia degli esseri umani. Dio si sporca le mani con noi, con i nostri peccati e le nostre fragilità. Non se ne vergogna. E non ci abbandona. Signore Gesù, ti ringraziamo per questo dono che supera ogni aspettativa e ci svela la tua misericordia. Tu ci hai amati non solo fino a darci la salvezza, ma fino a renderci strumento di salvezza. Mentre la tua croce dona senso a ogni nostra croce, a noi è data la grazia suprema della vita: partecipare attivamente al mistero della redenzione, essere strumento di salvezza per i nostri fratelli. SESTA STAZIONE Veronica asciuga il volto di Gesù Dal libro del profeta Isaia 53, 2-3: Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Tra la concitazione della folla che assiste alla salita di Gesù al Calvario, compare Veronica, una donna senza volto, senza storia. Eppure una donna coraggiosa, pronta ad ascoltare lo Spirito e seguirne le ispirazioni, capace di riconoscere la gloria del Figlio di Dio nel volto sfigurato di Gesù, e di percepirne l’invito: «Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un dolore simile al mio dolore» (Lam 1, 12). L’amore, che questa donna incarna, ci lascia senza parole. L’amore la rende forte per sfidare le guardie, per superare la folla, per avvicinarsi al Signore e compiere un gesto di compassione e di fede: fermare il sangue delle ferite, asciugare le lacrime del dolore, contemplare quel volto sfigurato, dietro al quale è nascosto il volto di Dio. Siamo istintivamente portati a fuggire dalla sofferenza, perché la sofferenza fa ribrezzo. Quanti volti sfigurati dalle afflizioni della vita ci vengono incontro e troppo spesso voltiamo lo sguardo dall’altra parte. Come non vedere il volto del Signore in quello dei milioni di profughi, rifugiati e sfollati che fuggono disperatamente dall’orrore delle guerre, delle persecuzioni e delle dittature? Per ognuno di loro, con il suo volto irripetibile, Dio si manifesta sempre come un soccorritore coraggioso. Come Veronica, la donna senza volto, che asciugò amorevolmente il volto di Gesù. «Il tuo volto, Signore, io cerco!» (Sal 27, 8). Aiutami a trovarlo nei fratelli che percorrono la strada del dolore e dell’umiliazione. Fa’ che io sappia asciugare le lacrime e il sangue dei vinti di ogni tempo, di quanti la società ricca e spensierata scarta senza scrupolo. Fa’ che dietro ciascun volto, anche quello dell’uomo più abbandonato, io possa scorgere il tuo volto di bellezza infinita. SETTIMA STAZIONE Gesù cade per la seconda volta Dal libro del profeta Isaia 53, 2-3: Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Gesù cade ancora. Schiacciato ma non ucciso dal peso della croce. Ancora una volta Egli mette a nudo la sua umanità. È un’esperienza al limite dell’impotenza, di vergogna dinanzi a chi lo schernisce, di umiliazione davanti a chi aveva sperato in lui. Nessuna persona vorrebbe mai cadere a terra e sperimentare il fallimento. Specialmente di fronte ad altre persone. Spesso gli uomini si ribellano all’idea di non avere potere, di non avere la capacità di portare avanti la propria vita. Gesù, invece, incarna il “potere dei senza potere”. Sperimenta il tormento della croce e la forza salvifica della fede. Solo Dio può salvarci. Solo Lui può trasformare un segno di morte in una croce gloriosa. Se Gesù è caduto a terra una seconda volta, per il peso del nostro peccato, accettiamo allora anche noi di cadere, d’esser caduti, di poter cadere ancora per i nostri peccati. Riconosciamo di non poterci salvare da soli con le nostre forze. Signore Gesù, che hai accettato l’umiliazione di cadere ancora sotto gli occhi di tutti, ti vorremmo non solo contemplare mentre sei nella polvere, ma fissare in te il nostro sguardo, dalla stessa posizione, anche noi a terra, caduti per le nostre debolezze. Donaci la coscienza del nostro peccato, quella volontà di rialzarsi che nasce dal dolore. Dà a tutta la tua Chiesa la consapevolezza della sofferenza. Offri in particolare ai ministri della Riconciliazione il dono delle lacrime per il loro peccato. Come potrebbero invocare su di sé e sugli altri la tua misericordia se non sapessero prima piangere le loro colpe? OTTAVA STAZIONE Gesù incontra le donne di Gerusalemme Dal Vangelo secondo Luca 23, 27-28: Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». Gesù, anche se è straziato dal dolore e cerca rifugio nel Padre, sente compassione per il popolo che lo segue e si rivolge direttamente alle donne che lo stanno accompagnando sulla via del Calvario. E il suo è un forte appello alla conversione. Non piangete per me, dice il Nazareno, perché io sto facendo la volontà del Padre, ma piangete su di voi per tutte le volte che non fate la volontà di Dio. È l’Agnello di Dio che parla e che, portando sulle sue spalle il peccato del mondo, purifica lo sguardo di queste figlie, già rivolto verso di Lui, ma in modo ancora imperfetto. «Che cosa dobbiamo fare?» sembra gridare il pianto di queste donne davanti all’Innocente. È la stessa domanda che le folle avevano rivolto al Battista (cfr. Lc 3, 10) e che ripeteranno poi gli ascoltatori di Pietro dopo la Pentecoste, sentendosi trafiggere il cuore: «Che cosa dobbiamo fare?» (At 2, 37). La risposta è semplice e netta: «Convertitevi». Una conversione personale e comunitaria: «Pregate gli uni per gli altri per essere guariti» (Gc 5, 16). Non c’è conversione senza la carità. E la carità è il modo di essere Chiesa. Signore Gesù, la tua grazia sostenga il nostro cammino di conversione per tornare a te, in comunione con i nostri fratelli, verso i quali ti chiediamo di donarci le tue stesse viscere di misericordia, viscere materne che ci rendano capaci di provare tenerezza e compassione gli uni per gli altri, e di arrivare anche al dono di noi stessi per la salvezza del prossimo. NONA STAZIONE Gesù cade per la terza volta Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 2, 6-7: Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Gesù cade per la terza volta. Il Figlio di Dio sperimenta fino in fondo la condizione umana. Con questa caduta entra ancora più stabilmente nella storia dell’umanità. E accompagna, in ogni momento, l’umanità sofferente. «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). Quante volte gli uomini e le donne cadono a terra. Quante volte gli uomini, le donne e i bambini soffrono per una famiglia spezzata. Quante volte gli uomini e le donne pensano di non avere più dignità perché non hanno un lavoro. Quante volte i giovani sono costretti a vivere una vita precaria e perdono la speranza per il futuro. L’uomo che cade, e che contempla il Dio che cade, è l’uomo che finalmente può ammettere la propria debolezza e impotenza senza più timore e disperazione, proprio perché anche Dio l’ha provata nel Figlio suo. È per misericordia che Dio s’è abbassato fino a questo punto, fino a giacere nella polvere della strada. Polvere bagnata dal sudore di Adamo e dal sangue di Gesù e di tutti i martiri della storia; polvere benedetta dalle lacrime di tanti fratelli caduti per la violenza e lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. A questa polvere benedetta, oltraggiata, violata e depredata dall’egoismo umano, il Signore ha riservato il suo ultimo abbraccio. Signore Gesù, prostrato su questa terra riarsa, sei vicino a tutti gli uomini che soffrono e infondi nei loro cuori la forza per rialzarsi. Ti prego, Dio della misericordia, per tutti coloro che sono a terra per tanti motivi: peccati personali, matrimoni falliti, solitudine, perdita del lavoro, drammi familiari, angoscia per il futuro. Fai sentire che Tu sei non distante da ciascuno di loro, poiché il più vicino a Te, che sei la misericordia incarnata, è l’uomo che avverte di più il bisogno del perdono e continua a sperare contro ogni speranza! DECIMA STAZIONE Gesù è spogliato delle vesti Dal Vangelo secondo Marco 15, 24: Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Ai piedi della croce, sotto il Crocifisso e i ladroni sofferenti, ci sono i soldati che si contendono le vesti di Gesù. È la banalità del male. Lo sguardo dei soldati è lontano da quella sofferenza ed è distante dalla storia che li circonda. Sembra che quello che sta accadendo non li tocchi. Essi, mentre il Figlio di Dio subisce i supplizi della croce, continuano imperterriti a condurre una vita in cui le passioni hanno il sopravvento su tutto. È questo il grande paradosso della libertà che Dio ha concesso ai propri figli. Di fronte alla morte di Gesù ogni uomo può scegliere: contemplare il Cristo o “tirare a sorte”. È enorme la distanza che separa il Crocifisso dai suoi carnefici. L’interesse meschino per le vesti non consente loro di cogliere il senso di quel corpo inerme e disprezzato, irriso e martoriato, in cui si compie la divina volontà di salvezza dell’umanità intera. Quel corpo che il Padre ha «preparato» per il Figlio (cfr. Sal 40, 7; Eb 10, 5) ora esprime l’amore del Figlio verso il Padre e il dono totale di Gesù agli uomini. Quel corpo spogliato di tutto fuorché dell’amore racchiude in sé l’immenso dolore dell’umanità e racconta tutte le sue piaghe. Soprattutto quelle più dolorose: le piaghe dei bambini profanati nella loro intimità. Quel corpo muto e sanguinante, flagellato e umiliato, indica la strada della giustizia. La giustizia di Dio che trasforma la sofferenza più atroce nella luce della risurrezione. Signore Gesù, vorrei presentarti tutta l’umanità sofferente. I corpi di uomini e donne, di bambini e anziani, di malati e disabili non rispettati nella loro dignità. Quante violenze lungo la storia di questa umanità hanno colpito ciò che l’uomo ha di più suo, qualcosa di sacro e benedetto perché viene da Dio. Ti preghiamo, Signore, per chi è stato violato nel suo intimo. Per chi non coglie il mistero del proprio corpo, per chi non l’accetta o ne deturpa la bellezza, per chi non rispetta la debolezza e la sacralità del corpo che invecchia e muore. E che un giorno risorgerà! UNDICESIMA STAZIONE Gesù è crocifisso Dal Vangelo secondo Luca 23, 39-43: Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». Gesù sta sulla croce, «albero fecondo e glorioso», «talamo, trono ed altare» (Inno liturgico Ecco il vessillo della croce). E dall’alto di questo trono, punto d’attrazione dell’intero universo (cfr. Gv 12, 32), perdona i suoi crocifissori «perché non sanno quello che fanno» (Lc 23, 34). Sulla croce di Cristo, «bilancia del grande riscatto» (Inno liturgico Ecco il vessillo della croce), risplende una onnipotenza che si spoglia, una sapienza che si abbassa fino alla follia, un amore che si offre in sacrificio. Alla destra e alla sinistra di Gesù ci sono due malfattori, probabilmente due omicidi. Quei due malfattori parlano al cuore di ogni uomo perché indicano due modi differenti di stare sulla croce: il primo maledice Dio; il secondo riconosce Dio su quella croce. Il primo malfattore propone la soluzione più comoda per tutti. Propone una salvezza umana e ha uno sguardo rivolto verso il basso. La salvezza per lui significa scappare dalla croce ed eliminare la sofferenza. È la logica della cultura dello scarto. Chiede a Dio di eliminare tutto ciò che non è utile e non è degno di essere vissuto. Il secondo malfattore, invece, non mercanteggia una soluzione. Propone una salvezza divina e ha uno sguardo tutto rivolto verso il cielo. La salvezza per lui significa accettare la volontà di Dio anche nelle condizioni peggiori. È il trionfo della cultura dell’amore e del perdono. È la follia della croce nei confronti della quale ogni sapienza umana non può che svanire e ammutolire nel silenzio. Donami, o Crocifisso per amore, quel tuo perdono che dimentica e quella tua misericordia che ricrea. Fammi sperimentare, in ogni Confessione, la grazia che m’ha creato a tua immagine e somiglianza e che mi ricrea ogni volta che io pongo la mia vita, con tutte le sue miserie, nelle mani pietose del Padre. Che il tuo perdono risuoni per me come certezza dell’amore che mi salva, mi fa nuovo e mi fa stare con te per sempre. Allora io sarò davvero un malfattore graziato e ogni perdono tuo sarà come un assaggio di Paradiso, già da oggi. DODICESIMA STAZIONE Gesù muore in croce Dal Vangelo secondo Marco 15, 33-39: Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». Buio a mezzogiorno: sta accadendo qualcosa di assolutamente inaudito e imprevedibile sulla terra, ma che non appartiene solo alla terra. L’uomo uccide Dio! Il Figlio di Dio è stato crocifisso come un malfattore. Gesù si rivolge al Padre gridando le prime parole del salmo 22. È il grido della sofferenza e della desolazione, ma è anche il grido della completa «fiducia della vittoria divina» e della «certezza della gloria» (Benedetto XVI, Catechesi, 14 settembre 2011). Il grido di Gesù è il grido di ogni crocifisso della storia, dell’abbandonato e dell’umiliato, del martire e del profeta, di chi è calunniato e ingiustamente condannato, di chi è in esilio o in carcere. È il grido della disperazione umana che sfocia, però, nella vittoria della fede che trasforma la morte nella vita eterna. «Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea» (Sal 22, 23). Gesù muore in croce. È la morte di Dio? No, è la celebrazione più alta della testimonianza della fede. Il XX secolo è stato definito il secolo dei martiri. Esempi come quelli di Massimiliano Kolbe ed Edith Stein esprimono una luce immensa. Ma ancora oggi il corpo di Cristo è crocifisso in molte regioni della terra. I martiri del XXI secolo sono i veri apostoli del mondo contemporaneo. Nel grande buio s’accende la fede: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!», perché chi muore così, volgendo in speranza di vita la disperazione della morte, non può essere semplicemente un uomo. Il Crocifisso è l’offerta piena. Non si è tenuto niente, né un lembo di veste, né una goccia di sangue, né la Madre. Ha dato tutto: «Consummatum est». Quando non si ha più niente da dare perché si è dato tutto, allora si diventa capaci di veri doni. Spogliato, nudo, mangiato dalle ferite, dalla sete dell’abbandono, dagli improperi: non c’è più figura d’uomo. Dare tutto: ecco la carità. Dove finisce il mio, comincia il paradiso. (don Primo Mazzolari) TREDICESIMA STAZIONE Gesù è deposto dalla croce Dal Vangelo secondo Marco 15, 42-43. 46a: Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch’egli il Regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce. Giuseppe d’Arimatea accoglie Gesù prima ancora di aver visto la sua gloria. Lo accoglie da sconfitto. Da malfattore. Da rifiutato. Richiede il corpo a Pilato per non permettere che venga gettato nella fossa comune. Giuseppe mette a rischio la sua reputazione e forse, come Tobi, anche la sua vita (cfr. Tb 1, 15-20). Ma il coraggio di Giuseppe non è l’audacia degli eroi in battaglia. Il coraggio di Giuseppe è la forza della fede. Una fede che diventa accoglienza, gratuità e amore. In una parola: carità. Il silenzio, la semplicità e la sobrietà con cui Giuseppe si avvicina al corpo di Gesù contrasta con l’ostentazione, la banalizzazione e la fastosità dei funerali dei potenti di questo mondo. La testimonianza di Giuseppe ricorda, invece, tutti quei cristiani che anche oggi per un funerale mettono a rischio la propria vita. Chi poteva accogliere il corpo senza vita di Gesù se non colei che gli aveva dato la vita? Possiamo immaginare i sentimenti di Maria che lo accoglie tra le sue braccia, lei che ha creduto alle parole dell’Angelo e ha serbato tutto nel suo cuore. Maria, mentre abbraccia il suo figlio esanime, ripete ancora una volta il suo «fiat». È il dramma e la prova della fede. Nessuna creatura l’ha sofferta come Maria, la madre che tutti ci ha generato alla fede ai piedi della croce. Ripeteva la preghiera del mondo: «Padre, Abbà, se è possibile...». Solo un ramoscello d’olivo dondolava sopra il suo capo a un silenzioso vento... Ma non una spina tu gli levasti dalla corona. Trafitto anche il pensiero non può, non può lassù il pensiero non sanguinare! E non una mano gli schiodasti dal legno: che si tergesse dagli occhi il sangue e gli fosse dato di vedere almeno la Madre là, sola... Perfino potenti e maestri di ferocia e gente, al vederlo si coprivan la faccia e Lui a fluttuare dentro una nuvola: dentro la nuvola del divino abbandono. E dopo, solo dopo. Tu e noi a ridargli la vita. (Padre Turoldo) QUATTORDICESIMA STAZIONE Gesù è deposto nel sepolcro Dal Vangelo secondo Matteo 27, 59-60: Giuseppe prese il corpo [di Gesù], lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. Mentre Giuseppe chiude il sepolcro di Gesù, Egli scende negli inferi e ne spalanca le porte. Quella che la Chiesa Occidentale chiama “discesa agli inferi”, la Chiesa Orientale la celebra già come Anastasi, cioè “Risurrezione”. Le Chiese sorelle comunicano così all’uomo la piena Verità di questo unico Mistero: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete» (Ez 37, 12. 14). La tua Chiesa, Signore, ogni mattina canta: «Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte» (Lc 1, 78-79). L’uomo, abbagliato da luci che hanno il colore delle tenebre, spinto dalle forze del male, ha rotolato una grande pietra e ti ha chiuso nel sepolcro. Ma noi sappiamo che tu, Dio umile, nel silenzio in cui la nostra libertà ti ha posto, sei all’opera più che mai per generare nuova grazia nell’uomo che ami. Entra, dunque, nei nostri sepolcri: ravviva la scintilla del tuo amore nel cuore di ogni uomo, nel grembo di ogni famiglia, nel cammino di ogni popolo. O Cristo Gesù! Tutti camminiamo verso la nostra morte e la nostra tomba. Permettici di fermarci in spirito accanto al tuo sepolcro. Che la potenza di Vita, che in esso si è manifestata, trafigga i nostri cuori. Che questa Vita diventi la luce del nostro pellegrinaggio sulla terra. Amen. (San Giovanni Paolo II) Pag 8 Amore senza fine Nella domenica delle Palme il Papa parla della passione di Gesù e ricorda il destino dei profughi di cui nessuno si assume la responsabilità Se il mistero del male «è abissale», la realtà dell’amore che lo attraversa è «infinita» e assume «tutto il nostro dolore per redimerlo». Così Papa Francesco ha descritto la logica della Croce nell’omelia della messa della domenica delle Palme celebrata in piazza San Pietro nella mattina del 20 marzo. «Benedetto colui che viene nel nome del Signore» (cfr. Lc 19, 38), gridava festante la folla di Gerusalemme accogliendo Gesù. Abbiamo fatto nostro quell’entusiasmo: agitando le palme e i rami di ulivo abbiamo espresso la lode e la gioia, il desiderio di ricevere Gesù che viene a noi. Sì, come è entrato a Gerusalemme, Egli desidera entrare nelle nostre città e nelle nostre vite. Come fece nel Vangelo, cavalcando un asino, viene a noi umilmente, ma viene «nel nome del Signore»: con la potenza del suo amore divino perdona i nostri peccati e ci riconcilia col Padre e con noi stessi. Gesù è contento della manifestazione popolare di affetto della gente, e quando i farisei lo invitano a far tacere i bambini e gli altri che lo acclamano risponde: «Se questi taceranno, grideranno le pietre» (Lc 19, 40). Niente poté fermare l’entusiasmo per l’ingresso di Gesù; niente ci impedisca di trovare in Lui la fonte della nostra gioia, la gioia vera, che rimane e dà la pace; perché solo Gesù ci salva dai lacci del peccato, della morte, della paura e della tristezza. Ma la Liturgia di oggi ci insegna che il Signore non ci ha salvati con un ingresso trionfale o mediante potenti miracoli. L’apostolo Paolo, nella seconda Lettura, sintetizza con due verbi il percorso della redenzione: «svuotò» e «umiliò» sé stesso (Fil 2, 7.8). Questi due verbi ci dicono fino a quale estremo è giunto l’amore di Dio per noi. Gesù svuotò sé stesso: rinunciò alla gloria di Figlio di Dio e divenne Figlio dell’uomo, per essere in tutto solidale con noi peccatori, Lui che è senza peccato. Non solo: ha vissuto tra noi in una «condizione di servo» (v. 7): non di re, né di principe, ma di servo. Quindi si è umiliato, e l’abisso della sua umiliazione, che la Settimana Santa ci mostra, sembra non avere fondo. Il primo gesto di questo amore «sino alla fine» (Gv 13, 1) è la lavanda dei piedi. «Il Signore e il Maestro» (Gv 13, 14) si abbassa fino ai piedi dei discepoli, come solo i servi facevano. Ci ha mostrato con l’esempio che noi abbiamo bisogno di essere raggiunti dal suo amore, che si china su di noi; non possiamo farne a meno, non possiamo amare senza farci prima amare da Lui, senza sperimentare la sua sorprendente tenerezza e senza accettare che l’amore vero consiste nel servizio concreto. Ma questo è solo l’inizio. L’umiliazione che Gesù subisce si fa estrema nella Passione: viene venduto per trenta denari e tradito con un bacio da un discepolo che aveva scelto e chiamato amico. Quasi tutti gli altri fuggono e lo abbandonano; Pietro lo rinnega tre volte nel cortile del tempio. Umiliato nell’animo con scherni, insulti e sputi, patisce nel corpo violenze atroci: le percosse, i flagelli e la corona di spine rendono il suo aspetto irriconoscibile. Subisce anche l’infamia e la condanna iniqua delle autorità, religiose e politiche: è fatto peccato e riconosciuto ingiusto. Pilato, poi, lo invia da Erode e questi lo rimanda dal governatore romano: mentre gli viene negata ogni giustizia, Gesù prova sulla sua pelle anche l’indifferenza, perché nessuno vuole assumersi la responsabilità del suo destino. E penso a tanta gente, a tanti emarginati, a tanti profughi, a tanti rifugiati, a coloro dei quali molti non vogliono assumersi la responsabilità del loro destino. La folla, che poco prima lo aveva acclamato, trasforma le lodi in un grido di accusa, preferendo persino che al suo posto venga liberato un omicida. Giunge così alla morte di croce, quella più dolorosa e infamante, riservata ai traditori, agli schiavi, e ai peggiori criminali. La solitudine, la diffamazione e il dolore non sono ancora il culmine della sua spogliazione. Per essere in tutto solidale con noi, sulla croce sperimenta anche il misterioso abbandono del Padre. Nell’abbandono, però, prega e si affida: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23, 46). Appeso al patibolo, oltre alla derisione, affronta l’ultima tentazione: la provocazione a scendere dalla croce, a vincere il male con la forza e a mostrare il volto di un dio potente e invincibile. Gesù invece, proprio qui, all’apice dell’annientamento, rivela il volto vero di Dio, che è misericordia. Perdona i suoi crocifissori, apre le porte del paradiso al ladrone pentito e tocca il cuore del centurione. Se è abissale il mistero del male, infinita è la realtà dell’Amore che lo ha attraversato, giungendo fino al sepolcro e agli inferi, assumendo tutto il nostro dolore per redimerlo, portando luce nelle tenebre, vita nella morte, amore nell’odio. Può sembrarci tanto distante il modo di agire di Dio, che si è annientato per noi, mentre a noi pare difficile persino dimenticarci un poco di noi. Egli viene a salvarci; siamo chiamati a scegliere la sua via: la via del servizio, del dono, della dimenticanza di sé. Possiamo incamminarci su questa via soffermandoci in questi giorni a guardare il Crocifisso, è la “cattedra di Dio”. Vi invito in questa settimana a guardare spesso questa “cattedra di Dio”, per imparare l’amore umile, che salva e dà la vita, per rinunciare all’egoismo, alla ricerca del potere e della fama. Con la sua umiliazione, Gesù ci invita a camminare sulla sua strada. Rivolgiamo lo sguardo a Lui, chiediamo la grazia di capire almeno qualcosa di questo mistero del suo annientamento per noi; e così, in silenzio, contempliamo il mistero di questa Settimana. Pag 8 Avanti con coraggio All’Angelus affida la Gmg all’intercessione di san Giovanni Paolo II All’Angelus recitato al termine della celebrazione eucaristica il Pontefice ha dato appuntamento a Cracovia, dove alla fine di luglio si terrà la prossima giornata mondiale della gioventù. Saluto tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione e quanti sono uniti a noi tramite la televisione, la radio e altri mezzi di comunicazione. Oggi si celebra la 31ª Giornata Mondiale della Gioventù, che avrà il suo culmine alla fine di luglio nel grande Incontro mondiale a Cracovia. Il tema è «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5, 7). Il mio saluto speciale va ai giovani qui presenti, e si estende a tutti i giovani del mondo. Spero che potrete venire numerosi a Cracovia, patria di san Giovanni Paolo II, iniziatore delle Giornate Mondiali della Gioventù. Alla sua intercessione affidiamo gli ultimi mesi di preparazione di questo pellegrinaggio che, nel quadro dell’Anno Santo della Misericordia, sarà il Giubileo dei giovani a livello della Chiesa universale. Sono qui con noi molti giovani volontari di Cracovia. Tornando in Polonia, porteranno ai responsabili della Nazione i rami di ulivo raccolti a Gerusalemme, Assisi e Montecassino e benedetti oggi in questa piazza, come invito a coltivare propositi di pace, di riconciliazione e di fraternità. Grazie per questa bella iniziativa; andate avanti con coraggio! E ora preghiamo la Vergine Maria, perché ci aiuti a vivere con intensità spirituale la Settimana Santa. [Angelus Domini...] CORRIERE DELLA SERA Pag 49 L’appello di suor Rita per una chiesa di donne di Dacia Maraini Una bellissima e amorosa lettera è partita dalle terre dei fuochi verso il Vaticano. Ma non ha avuto risposta. La lettera è stata scritta da suor Rita Giarretta che da vent’anni è in missione a Caserta dove, «insieme alle mie consorelle abbiamo dato vita a Casa Rut, un luogo di accoglienza per donne, spesso minorenni, spesso incinte o con figli piccoli, per lo più vittime di quell’infamia che è la tratta delle donne». Suor Rita racconta che, mentre viaggia in treno per Roma, immagina di rivolgersi a papa Francesco: «pensavo a te, ai tuoi gesti, alle tue parole, ma anche ai tuoi silenzi, al tuo coraggio, al tuo essere oggi per noi trasparenza, cuore, cammino dell’amore di Dio, manifestatosi in Gesù che per amore si è fatto servo di noi». Qualcuno sostiene che «“presto finirà la ricreazione”», riferisce suor Rita, ma quale ricreazione, se un attivo ed esigente Papa continua a chiedere di «lavorare la vigna del Signore?». Il fatto è che suor Rita, come tante altre sorelle, è accorsa a zappare e fertilizzare la vigna. Ma per quanto fatichino, la loro parola è muta all’interno di una Chiesa tutta governata da persone di sesso maschile. «Eppure nelle Scritture si parla di una misericordia che nasce “dall’utero di Dio”», continua suor Rita, «quindi Dio è madre oltre che padre… Ma questa assenza di donne, oso dire questa diseguaglianza, non tradisce il Vangelo di Gesù?» si chiede umilmente suor Rita ,«la Chiesa non è Casa di tutti e per tutti anziché proprietà esclusiva di alcuni?». «Caro Francesco, fra le tante rivoluzioni che sei chiamato a portare avanti, credo che questa sia una delle sfide più importanti e necessarie: liberare la chiesa da quell’immagine che sa di autorità, privilegio, potere sacrale, dominio e restituirle il volto luminoso e trasparente di Dio madre e padre, il volto divino di Gesù che parla di vita,di compassione, di misericordia». La sincera e rispettosa lettera certamente esprime un largo mondo femminile sommerso, generoso sempre e disponibile, silenzioso e attento, ma privo di una parola decisionale. Suor Rita introduce la necessità di «nuove resurrezioni» all’interno di una Chiesa oppressa da tanti scandali e regressioni. Non sarebbe giusto e doveroso rispondere a chi, con tante altre coraggiose sorelle, lavora oggi in silenzio e con abnegazione le vigne del mondo? IL FOGLIO Pag 1 Rivoluzione o no? Cosa aspettarsi dal verdetto del Papa sul Sinodo di Matteo Matzuzzi Porte aperte ma non troppo Roma. Sabato scorso, il Papa ha firmato l'esortazione post sinodale sulla famiglia che sarà resa pubblica entro le prime due settimane d'aprile. E' il documento in cui il Pontefice tira le somme del doppio Sinodo, facendo capire quale sia il suo pensiero circa le tante questioni dibattute dai padri non sempre in un clima da sala da tè britannica secentesca. Un testo corposo, ha sottolineato entusiasta il cardinale Walter Kasper, peroratore massimo della svolta in nome della misericordia per quanti sono andati incontro a un fallimento nella propria vita: duecento pagine per trecento paragrafi, più del triplo rispetto all'esortazione Familiaris consortio di Giovanni Paolo II, che di paragrafi ne conta solo ottantasei. Kasper, che il documento l'ha visto, ha già parlato di "rivoluzione", di una "riforma che farà voltare pagina alla chiesa dopo millesettecento anni". Il Sinodo, insomma, come una sorta di punto e a capo, di inversione totale rispetto non solo alla pastorale familiare di Giovanni Paolo II prima e Benedetto XVI poi, come domandato dai settori più progressisti della chiesa, specie di quelle realtà nordeuropee alle prese con carenza di fedeli, ma anche in rapporto a tutto quel che la chiesa romana è stata dopo il Concilio di Nicea del 325. Ben più prudente è stato invece mons. Georg Gänswein, prefetto della Casa pontificia, che in un' intervista a Deutsche Welle s'è detto convinto che Francesco continuerà sulla strada tracciata dai predecessori" e cioè "secondo quel che dice il Magistero della chiesa. Di conseguenza, ha aggiunto il segretario di Joseph Ratzinger, "nell'esortazione si troveranno dichiarazioni in questo senso". Tradotto, significa che a giudizio di Gänswein non vi sarà alcuna apertura rivoluzionaria, nessun portone spalancato come auspicato da Kasper nel biennio sinodale - già a partire dal concistoro segreto del febbraio 2014. Una posizione condivisa anche dal prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, Gerhard Ludwig Müller, che nel libro in uscita "Informe sobre la esperanza", scritto con il sacerdote spagnolo Carlos Granados, rimarca quei paletti più volte fissati sul tema oggetto del Sinodo: "La misericordia non è una rinuncia ai comandamenti di Dio o una giustificazione per sospenderli o invalidarli. Il più grande scandalo che la chiesa può dare è quello di smettere di chiamare per nome la differenza tra il bene e il male, smettendo di spiegare cosa è il peccato e pretendendo di giustificarlo per una presunta maggior vicinanza e misericordia verso il peccatore". Michelle Boorstein sul Washington Post ha riassunto in poche righe il probabile significato ultimo dell' esortazione di Francesco: nessun cambiamento riguardo l'ortodossia cattolica - che però è da tempo anche la tesi dei novatori, sostenitori di un mutamento della sola prassi pastorale - ma una maggiore attenzione ai "diversi tipi di famiglie cattoliche", facendole sentirle parte integrante della chiesa. Nulla di nuovo, insomma, anche perché se la "svolta" si riducesse al via libera ai divorziati per fare da padrino al battesimo, sarebbe ben poca cosa rispetto alle "attese che non possono essere disattese" di cui parlò Kasper. Il Washington Post prevede la conferma - messa nero su bianco dal Papa - della linea uscita vittoriosa dall' appuntamento sinodale dello scorso ottobre, con un coinvolgimento del confessore e del vescovo diocesano nel valutare chi può essere riaccostato ai sacramenti. Secondo il biografo papale, Austen Ivereigh, alla fine l'esortazione sarà un documento in cui troverà spazio di tutto, in cui ogni sfida alla famiglia sarà enucleata, tenendo ben presente "il quadro giuridico e culturale ostile" figlio "della società occidentale contemporanea", e cioè quella "colonizzazione ideologica" contro cui più volte il Pontefice s'è scagliato. E' ottimista, Ivereigh, e non prevede rivoluzioni: "L'esortazione sarà un tributo edificante alla bellezza della vita familiare, offrendo sostegno e conforto a quanti lottano contro i feroci venti contrari del mondo contemporaneo". Inutile, insomma, ridurre tutto alla mera questione della comunione ai divorziati risposati, come peraltro già Francesco aveva detto in un passaggio della conferenza stampa in aereo di ritorno dal viaggio in Messico, lo scorso febbraio: "Io conosco cattolici risposati che vanno in chiesa una volta l'anno, due volte: 'Ma, io voglio fare la comunione!', come se la comunione fosse un' onorificenza". WWW.CHIESA.ESPRESSONLINE.IT Lavanda per tutti. Il giovedì santo di Francesco di Sandro Magister La lavanda dei piedi mette ormai in ombra la messa dell'ultima cena. Il papa ha ammesso al rito le donne, purché appartenenti alla Chiesa. Ma lui si spinge più in là e lava i piedi anche ai musulmani Roma. Come riformatore, papa Francesco si distingue anche in campo liturgico. E dopodomani, giovedì santo, nelle chiese di tutto il mondo sarà sotto gli occhi di tutti l'innovazione che egli ha introdotto nel rito della lavanda dei piedi, alla quale anche le donne sono ora ammesse. Come teatro del rito da lui celebrato, Francesco ha scelto questa volta un centro profughi, mentre negli anni passati si era recato nel 2013 in un carcere minorile, nel 2014 in un ospizio per disabili e nel 2015 in una grande prigione. Sempre quindi in luoghi di umanità sofferente. Questo di dopodomani sarà dunque il primo giovedì santo successivo alla riforma. Ma Jorge Mario Bergoglio l'ha messa in pratica fin dal suo primo anno di pontificato, lavando i piedi già allora anche a delle donne. Anzi, il papa è persino andato al di là di quanto consentito dalla sua stessa riforma, lavando i piedi – come ha fatto più di una volta – anche a uomini e donne non appartenenti alla Chiesa. Ma andiamo con ordine. Il criterio generale al quale Francesco si ispira per innovare in campo liturgico l'ha enunciato nel 2013 nella sua intervista programmatica a "La Civiltà Cattolica" e ad altre dodici riviste della Compagnia di Gesù: "Il Vaticano II è stato una rilettura del Vangelo alla luce della cultura contemporanea… I frutti sono enormi. Basta ricordare la liturgia. Il lavoro della riforma liturgica è stato un servizio al popolo come rilettura del Vangelo a partire da una situazione storica concreta". Questa concezione della liturgia come atto pedagogico dettato dall'attualità è un immiserimento che ha comprensibilmente lasciato interdetti i cultori della materia. Tra i quali il cardinale Robert Sarah, pur promosso da Francesco nel 2014 a prefetto della congregazione vaticana per il culto divino. Sta di fatto che, dopo la nomina, il papa subito ha detto al cardinale Sarah di avere in animo un cambiamento nel rito della lavanda dei piedi. Cambiamento che ha reso esplicito ed imposto in una lettera allo stesso Sarah del 20 dicembre 2014: "Dispongo che venga modificata la rubrica secondo la quale le persone prescelte per ricevere la lavanda dei piedi debbano essere uomini o ragazzi, in modo tale che da ora in poi i pastori della Chiesa possano scegliere i partecipanti al rito tra tutti i membri del popolo di Dio". Ma c'è voluto più di un anno, fino all'Epifania del 2016, perché Sarah emettesse il relativo decreto. Evidentemente non convinto della bontà della riforma, il cardinale ha chiesto e ottenuto di pubblicare assieme al decreto, da lui firmato, anche la lettera con la quale Francesco gli aveva ordinato l'innovazione, affinché la reale paternità del cambiamento fosse manifesta. Nel decreto si dispone appunto che al rito della lavanda dei piedi non accedano più solo degli "uomini", ma più genericamente dei "prescelti tra il popolo di Dio". Cioè in pratica "uomini e donne, giovani e anziani, sani e malati, chierici, consacrati, laici". Il risultato è un cambiamento nella simbologia del rito. Mentre tradizionalmente la lavanda dei piedi riproduceva il gesto fatto da Gesù con gli apostoli nel cenacolo e per questo era compiuta solo con uomini e in numero di dodici, ora essa dovrebbe rappresentare tutt'altra cosa: "la varietà e l’unità di ogni porzione del popolo di Dio". È curioso che un distacco così netto dal gesto compiuto da Gesù con i dodici apostoli sia stato voluto proprio da un papa gesuita, cioè seguace di quel sant'Ignazio che era sensibilissimo alla precisa "composizione di luogo" – scena, parole, personaggi – di tutti i gesti compiuti da Gesù nella sua vita terrena, e incitava a immaginarli e a riviverli come realmente erano narrati nei Vangeli, applicandovi tutti i cinque sensi. Non solo. Con la modifica del rito è venuto a cadere anche un elemento che ci si sarebbe aspettato molto caro a Francesco e alla sua incessante predicazione della misericordia: cioè il fatto che tra i dodici apostoli ai quali Gesù lavò i piedi c'era anche Giuda, al quale egli offrì perdono e amicizia fino all'ultimo, anche dopo che il diavolo gli aveva già messo in cuore di tradirlo. Certo, l'innovazione voluta da Francesco non è obbligatoria per tutti, ma solo consentita a chi vuole. Interpellato sull'argomento – dopo che in un commento ufficiale al decreto il segretario della congregazione per il culto divino, Arthur Roche, aveva fatto pensare a un obbligo – il cardinale Sarah ha ribadito che il giovedì santo non "si deve" lavare i piedi anche a delle donne ma semplicemente "si può". Ma i fatti si impongono con forza propria, tanto più quando hanno il papa come protagonista. Con lui la messa "in Cena Domini" del giovedì santo entra di fatto nell'ombra – e con essa il ricordo dell'istituzione dell'eucaristia e dell'ordine sacro –, mentre a prorompere in primo piano è il gesto della lavanda dei piedi, che tra l'altro fino al 1955 si era sempre celebrata fuori della messa. Un gesto il cui carattere "inclusivo" sovrasta ora su ogni altro. Perché se è vero che la lettera del decreto di riforma ammette alla lavanda dei piedi solo gli appartenenti al "popolo di Dio", cioè alla Chiesa cattolica, lo spirito con cui Francesco lo mette in pratica non conosce confini. Nel giovedì santo del 2013, nel carcere minorile romano di Casal del Marmo, il papa ha lavato i piedi anche a dei cristiani ortodossi e a dei musulmani, tra i quali ultimi una giovane donna di nazionalità serba. Nel giovedì santo del 2014, nel centro per disabili "Santa Maria della Provvidenza" della Fondazione don Gnocchi, Francesco ha lavato i piedi, oltre che a quattro donne, a un libico di religione musulmana. Mentre nel giovedì santo del 2015, nel carcere romano di Rebibbia, tra i sei uomini e le sei donne ai quali il papa ha lavato i piedi hanno fatto notizia la showgirl congolese Silvy Lubamba e soprattutto il transessuale brasiliano Isabel. Torna al sommario 5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO AVVENIRE Pag 2 Le nazioni più felici non sono sempre giuste di Massimo Calvi Il valore dei comportamenti virtuosi, il rischio del bene per sé Danimarca, Svizzera, Islanda, Norvegia, Finlandia, Canada, Olanda, Nuova Zelanda, Australia, Svezia. Sono i dieci Paesi più 'felici' al mondo secondo la classifica del World Happiness Record 2016 diffusa nei giorni scorsi. L’Italia è risultata cinquantesima, posizione che abbiamo accettato senza protestare, segno che in fondo quel posto lo sentiamo adeguato. Ma che cosa hanno veramente in comune i dieci Paesi più felici? Qual è la formula che conduce alla felicità? E soprattutto: di quale felicità stiamo parlando? Alcune risposte sono già state fornite dagli autori del rapporto, e 'Avvenire' ne ha dato ampio conto: dove la disuguaglianza è più bassa, la popolazione si sente più felice. A contribuire sono in verità molti fattori: il Pil reale pro capite (aspetto non certo irrilevante), l’aspettativa di vita in buona salute, l’avere qualcuno su cui contare (dunque le relazioni), la libertà percepita nel fare scelte di vita, i bassi livelli di corruzione, la generosità. Volendo allargare lo sguardo ci sarebbero altri tratti comuni strutturali e persino curiosi a unire questi Paesi, come l’elemento fortemente caratterizzante dell’ambiente naturale, la disponibilità di risorse, la circostanza di climi non propriamente invidiabili. Anche il tema di come l’uomo si rapporta alla natura nello sforzo di creare condizioni di vita migliori, insomma, appare significativo. Ma quello della bassa disuguaglianza resta centrale, e porta diritto a parlare di condivisione. Come ha fatto notare l’economista Jeffrey Sachs, la formula richiede di «lavorare duro, avere buoni rapporti sociali», ma soprattutto «governare onestamente, pagare molte tasse in cambio di servizi adeguati». Già, perché dietro all’equità si cela un cammino lungo e ben tracciato. I Paesi più 'felici' sono tutti Paesi nei quali il fisco non è leggero, ma dove le risorse sono prima messe in comune e poi ridistribuite in modo da attenuare le disuguaglianze grazie a un sistema di welfare capace di offrire alle famiglie un ritorno elevatissimo in termini di servizi. Modelli invidiabili. Eppure c’è qualcosa che stona. A molti non è sfuggito che nella top ten vi siano anche molte nazioni che si distinguono per l’applicazione di politiche migratorie altamente selettive e severe, per non dire respingenti, Paesi in cui si può fare esperienza di fenomeni che contrastano con l’idea comune di felicità, come l’elevato tasso di suicidi o di alcolismo, o dove sono permesse pratiche eticamente condannabili, come l’eutanasia attiva o il programma danese di eliminazione della sindrome di Down attraverso l’aborto dei bambini che ne sono portatori. E allora che cosa è questa felicità che stiamo affannosamente cercando in una classifica come in una caccia al tesoro planetaria, quasi una ricerca di un nuovo Graal? È qualcosa che riusciamo a riconoscere e apprezzare come membri di un’unica famiglia umana, oppure è la soddisfazione dei superstiti che si sono dati buone regole di convivenza su un’isola nascosta alle mappe? La questione non è irrilevante, nella fase storica che il mondo sta attraversando. Onorare le più elementari norme civiche e di convivenza è da sempre la formula che permette alle ricchezze dei singoli di trasformarsi in bene per la collettività. Tutto parte da cittadini che rispettano le regole, i divieti, si fermano agli stop, sorpassano in modo civile, timbrano i biglietti del bus, e soprattutto pagano le tasse: bassi livelli di evasione e corruzione forniscono la traccia decisiva nella costruzione di un percorso che conduce alla felicità grazie alla riduzione della disuguaglianza. Eppure fermarsi a questi ingredienti di base non può bastare, esattamente allo stesso modo in cui il Pil non è più adeguato a fissare il benessere di una società. La classifica della felicità si basa su valutazioni soggettive, dunque non si può fare niente se i cittadini di un Paese si dicono più felici di quelli di un altro. Ma questo è anche il suo limite, dato che la somma delle singole felicità individuali non è certo la formula del benessere collettivo. Forse in questo caso dovremmo chiederci se è corretto parlare di 'felicità', e non invece di 'soddisfazione', 'serenità', 'appagamento', o altro. E poi ricordarci che una società di felici non è per forza anche una società più giusta. Pag 3 Berlino e la grande inflazione. Crisi e conseguenze politiche di Antonio Fazio La lezione della storia per l’economia e la democrazia Il problema dell’Europa esiste ed è serio. C’è un problema grave di disoccupazione e sottooccupazione: la principale fonte di disuguaglianza sociale e di conseguenze politiche, ancora non completamente espresse. C’è un problema serio di deflazione, che frena gli investimenti. E c’è poi il discorso dell’integrazione; fino a che non ci comprendiamo come lingua, ma anche come cultura, tutto è molto complicato. «Historia magistra vitae», diceva Cicerone. La storia è luce di verità. C’è una frase di Keynes, rivoluzionatore innovatore del pensiero economico e maggiore economista del XX secolo: «La difficoltà non sta nelle idee nuove, ma nell’evadere dalle idee vecchie, le quali per coloro che sono stati educati, come la maggioranza di noi, si ramificano in tutti gli angoli della mente». È una frase valida ancora oggi per spiegare alcuni snodi della situazione economica. Il problema che deve stare a cuore agli economisti è l’occupazione. Lo sviluppo di una società si misura – a tutt’oggi – con il Prodotto interno lordo; ma l’ammontare del Pil è strettamente correlato con il tasso della buona occupazione. L’economista, se svolge la sua funzione di 'medico sociale' in qualsiasi campo, sia della politica economica sia della politica monetaria, deve avere davanti a sé questo obiettivo. Quando c’è disoccupazione la società non sta bene, la società è malata! La nostra Costituzione si apre col fondamentale articolo 1: «La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro». Il lavoro è alla base dei diritti civili e della cittadinanza; il lavoro non è solo fonte di reddito, ma anche fonte di dignità. Ho la sensazione che ci siamo scordati, a livello politico, di questo fondamento. I grandi uomini e fondatori dell’Europa, De Gasperi, Adenauer, Schumann, lo avevano ben presente. Il fenomeno del non voto e del voto di protesta è strettamente legato a questa problematica. La crisi economica, la crisi di occupazione, ha delle profonde influenze politiche oltre che sociali. Per studiare la storia dell’economia del tempo, occorrono serie analisi, altrimenti si fanno chiacchiere. Sempre Keynes nel libro «A Tract on Monetary Reform» del 1923 analizza l’inflazione dal 1913 fino ai primi sei mesi del ’23. Nel 1913 la Germania era la seconda potenza economica mondiale. Non abbiamo dati attendibili sul Pil, ma c’è l’indice della produzione di energia elettrica che era allora, più di oggi, fortemente legata all’andamento dell’industria. In Germania era maggiore di quella di Inghilterra, Francia e Italia tutte insieme. Nel 1914 viene meno il Gold Standard (il legame rigido tra il valore di una moneta e l’oro), che aveva di fatto garantito per vari decenni la stabilità mondiale dei prezzi. Le spese della guerra deprimono i valori delle monete, fanno crescere ovunque i prezzi. Nel Regno Unito i prezzi passano da 100 nel 1913 a 160 nel 1923; in Francia i prezzi si quadruplicano, in Italia quasi si sestuplicano. Nel Giappone si raddoppiano. Gli Stati Uniti, diventati oramai la prima nazione industriale del mondo, mantengono il Gold Standard fino agli inizi degli anni Trenta (lo congelano, a dire il vero, tra il ’17 e il ’23). Dopo il 1923 il dollaro è la moneta più stabile a livello mondiale. Ma guardate cosa succede in Germania, dove nella prima metà del 1923 i prezzi sono aumentati di migliaia di volte rispetto a dieci anni prima. P arlo di questi aspetti della storia economica e monetaria, perché hanno inciso profondamente sulla storia politica e sulla cultura tedesca. Costantino Bresciani Turroni è autore del trattato: 'Le vicende del Marco tedesco'. Sono vicende sconvolgenti per la loro intensità e per le gravi conseguenze politiche. La politica ha un ruolo rilevante, determinante per l’economia, a causa dell’inflazione, quindi della successiva politica deflazionistica, negli anni della grande depressione. I tedeschi sono convinti di vincere la guerra; aumentano fortemente le spese pubbliche. Improvvisamente si rovesciano le sorti; cade il secondo Reich di Bismarck, l’imperatore va in esilio. Nasce la Repubblica di Weimar. A causa delle esagerate riparazioni di guerra richieste dagli Stati vincitori, la Germania viveva gravi difficoltà dell’economia, anche per tentare di venire incontro, con sussidi e forme di occupazione fittizia, a quasi 6 milioni di uomini che dalla guerra erano rientrati nelle attività civili. L’equilibrio viene trovato ricorrendo progressivamente alla stampa di moneta. Il marco inizia a perdere valore nei confronti delle altre monete: salgono i salari e i prezzi, lo Stato riduce la disoccupazione creando nuova moneta. Nel 1919 l’aumento dei prezzi sale in un anno al 60%, nel 1920 del 240%. Nel 1923, a causa anche dell’invasione della Ruhr da parte dei francesi, sale tra il 15 e il 40% al giorno. Si raccontano gli aneddoti, veri, degli avventori che si sedevano al bar per prendere il caffè; quando si alzavano il prezzo era raddoppiato. Diventa frequente, per i dipendenti pubblici, ma anche privati, di andare a riscuotere gli stipendi con le carriole. I salari erano pagati in biglietti di banca. I francobolli con l’immagine di Bismarck sono di molti milioni di marchi; non ce la fanno più a stamparli a valori crescenti, le lettere venivano affrancate con biglietti di banca. Si stampano banconote da mille miliardi di marchi, da 5mila, da 100mila miliardi; non fanno in tempo a stamparle da ambedue le parti, sono stampate solo su un lato. I prezzi a Berlino nel novembre ’23: un chilo di pane costava 428 miliardi di marchi, 1 kg. di burro 5.600 miliardi di marchi, un francobollo 100 miliardi. È un fenomeno di cui non si ha nessun altro precedente, fortunatamente, nella storia. I tedeschi sono stati capaci di creare un’inflazione di cui gli studiosi stanno ancora cercando di capire le cause. Cosa avevano fatto? Iniziano ad espandere fortemente il debito pubblico, perché sperano di vincere e rifarsi con i territori conquistati. Non ci riescono, debbono stampare moneta in misura sempre crescente. Quando l’inflazione è così forte alla fine diventa un fenomeno puramente monetario. Si arriva al nuovo marco, il cui valore è stabilito in mille miliardi di vecchi marchi. Dal 1924 in poi la politica economica tedesca, come chiarito da Bresciani Turroni, si è ispirata al concetto che la preoccupazione della stabilità monetaria dovesse prevalere su qualunque altra considerazione. E questo è vero ancora oggi. per fronteggiare la recessione hanno danneggiato ulteriormente le economie del continente, a partire da quella italiana (si veda il grafico in pagina). Con un’attenzione quasi ossessiva per la stabilità monetaria e per il controllo della 'corsa' dei prezzi stiamo scivolando verso la deflazione. Un fattore che determina la frenata negli investimenti, già messi a dura prova dalle cure draconiane inflitte ai conti pubblici. Così, fra bilanci ristretti, bassa crescita e alto debito si alimenta un circolo vizioso di cui non si vede l’uscita. Fazio, che nell’euforia del passaggio alla moneta comune fu quasi l’unica voce a prevedere che gli anni dell’euro sarebbero stati «un purgatorio», e che da banchiere centrale negli anni 90 bloccò in Italia l’inflazione, ci offre oggi la sua analisi. Ecco perché mi interessava raccontare questo: all’epoca bisognava mantenere stabile la moneta a qualunque costo, anche a prezzo di ripercussioni temporaneamente dannose per l’economia. Quando si sente il ministro delle Finanze Schauble, bisogna ripensare a tutto questo... Lo Statuto della Banca Centrale Europea è più o meno su questa linea: la Bce ha l’obbligo di mantenere la stabilità della moneta, il che significa un’inflazione del 2% all’anno. Adesso siamo allo 0,4%, a un livello forse di deflazione, che è una malattia estremamente grave. Il 2% di inflazione è un fenomeno molto meno grave della deflazione. La politica deflazionistica si prolunga nel corso degli anni Venti. Nel 1930 la Germania era il secondo Paese industriale nel mondo. Alla crisi del 1929, iniziata a livello internazionale e già manifestatasi fortemente negli Stati Uniti, si aggiunge la deflazione in Germania. Si comincia a parlare di politiche di tipo keynesiano, di lavori pubblici per far fronte alla disoccupazione, enormemente aumentata. Non se ne fa nulla per timore dell’inflazione. Si insiste nella deflazione. Risultato: nel 1932 si parla in Germania di 6 milioni di disoccupati, ma forse erano 8 milioni, contro gli appena 800mila del 1928. Il nazismo, chiamato ad assumere la responsabilità di a seguito della grave crisi economica, rilancia l’occupazione. Viene fondata, attraverso i sindacati, la Volkswagen. La motorizzazione privata era pressoché inesistente; lo stesso Hitler progetta il Maggiolino, ne affida lo sviluppo all’ingegner Porsche. La produzione industriale della Germania dal 1932 raddoppia in 5 anni, anche perché si avvia la produzione di carri armati, aerei e armi. Che cosa avviene negli altri Paesi? Nel 1925 l’Inghilterra, nel tentativo di riassumere il suo primato nella finanza internazionale, rientra nel Gold Standard; ma lo fa ai prezzi del 1913. Keynes era già famoso per la critica al Trattato di Versailles deplorato anche da Eugenio Pacelli, allora nunzio in Baviera -, che è essenzialmente alla base del disastro dell’economia tedesca per le onerose riparazioni di guerra. Per Keynes, ciò avrebbe comportato un grave danno per tutta l’economia europea. Ancora Keynes nel pamphlet 'Economic Consequences of Mr. Churchill' critica la mossa del Cancelliere dello Scacchiere sul cambio fissato di nuovo ai prezzi del 1913, mettendo in luce la conseguente perdita di competitività. L’economia inglese risente negativamente, negli anni seguenti, dell’errore nella fissazione del cambio, compiuto per motivi di prestigio, per tentare di far riprendere a Londra un ruolo centrale nel sistema internazionale. Critiche dure sono mosse da Keynes anche verso la Banca d’Inghilterra, che attua una politica restrittiva per tentare di abbassare salari e prezzi. Il risultato è invece un peggioramento della disoccupazione. La mossa dell’Inghilterra si rivela ancora più grave poiché anche la Francia decide ugualmente di rientrare nel Gold Standard, ma a un tasso di cambio svalutato. Segue un’altra trentina di Paesi, sempre per motivi di prestigio. La politica monetaria allora intesa, in senso grettamente limitato, come difesa del rapporto di cambio tra la moneta legale e l’oro, distrae da una politica economica che avrebbe dovuto essere indirizzata a combattere l’incipiente recessione. Della politica tedesca si è già detto. L’Italia nel 1926 attua ugualmente una politica di forte restrizione, la cosiddetta 'quota 90'. Gli economisti italiani consigliano a Mussolini di seguire la politica - che Keynes aveva ironicamente consigliato a Churchill - di ridurre del 10, d’imperio, prezzi e salari. Cosicché la 'quota 90', rapporto di cambio tra lira e sterlina, viene a essere popolarmente interpretata come la riduzione al 90% di tutti i prezzi, tariffe, stipendi e salari. Ciò non basta per riacquisire competitività verso l’estero; occorrono altre riduzioni forzate di prezzi e salari. L’Italia mette comunque in atto una politica di grandi opere pubbliche, combattendo in qualche misura la recessione. Il tentativo di molti Paesi - di legare le monete ai prezzi dell’oro oramai fuori linea con i livelli dei prezzi interni - fa precipitare l’economia mondiale nella Grande crisi. La crisi, iniziata per motivi di mercato in agricoltura, si manifesta nell’estate del 1929 negli Usa attraverso una brusca caduta della produzione industriale. Segue il crollo delle azioni a Wall Street. La forza produttiva degli Stati Uniti attrae l’oro delle banche centrali da tutto il mondo verso il mercato finanziario di New York. Anche la Francia accumula oro grazie alla svalutazione del franco. Tutti gli altri Paesi perdono oro: iniziano crisi bancarie, dapprima in Austria e Germania. L’Inghilterra lascia poi svalutare la sterlina nel settembre ’31. La crisi continua ad espandersi, con ripercussioni politiche fatali. Gli Stati Uniti escono dalla recessione solo attuando una forte espansione degli investimenti pubblici, e aumentano notevolmente la quantità di moneta rivalutando l’oro rispetto al dollaro. Dopo la forte caduta, l’economia americana riprenderà a crescere, ma lo fa al ritmo del 10% all’anno in termini reali. Ben Bernanke, in un articolo pubblicato sul Journal of Money, Credit and Banking nel 1995, dimostra che in tutto il mondo la ripresa per ogni Paese si ha, negli anni Trenta, mano a mano che le singole economie si staccano dal Gold Standard. L’avvento del nazismo, conseguenza politica della grande inflazione trasformatasi poi nella grande depressione, trascina il mondo in guerra. Torna al sommario 8 – VENETO / NORDEST CORRIERE DEL VENETO Pag 5 Vita da Erasmus, quei centomila veneti nel “cuore” dell’Europa di Sara D’Ascenzo Fenomeno in crescita in tutti i nostri atenei Venezia. Nel giorno del lutto e della disperazione per i 13 ragazzi morti nell’incidente di Tarragona, ricordare le atmosfere scanzonate e liberatorie dell’Appartamento spagnolo , il film che da quasi quindici anni racconta l’identità e lo spirito dei ragazzi Erasmus, potrebbe sembrare fuori luogo. Eppure in tutti i ventenni o giù di lì che si trovano a vivere quella particolare e irripetibile esperienza, le avventure e disavventure del giovane Xavier, che nel film francese del 2002 si trovava catapultato a Barcellona a condividere il tetto con una comunità europea decisamente godereccia, esercitano ancora oggi una fascinazione fortemente identitaria. Il frigo che straripa di cose quasi immangiabili, la pulizia che manca, le difficoltà di condividere la casa con qualcuno che non si conosce, il senso di libertà di essere fuori casa lontano migliaia di chilometri dal controllo degli affetti più cari (e un po’ ingombranti): vale tutto nel racconto degli studenti che hanno fatto quell’esperienza o sono ancora lì a farla. Dal 1987, anno del lancio dell’iniziativa a livello europeo, a oggi, in Italia sono oltre 3 milioni i ragazzi partiti per un periodo che può andare da pochi mesi a un intero anno accademico, a seconda delle destinazioni e delle convenzioni con i vari atenei; 100 mila circa quelli partiti dal Veneto. Nel solo bando 2015/2016, che è quello al quale hanno partecipato gli studenti che ora sono all’estero, il Veneto ha mandato all’estero circa 2.715 studenti dei quattro atenei: 591 da Ca’ Foscari, 216 dall’ateneo Iuav, 518 dall’università di Verona, 1.390 dall’ateneo di Padova, 480 in uscita nel semestre in corso, da gennaio 2016 a giugno. E proprio l’università di Padova, la stessa dalla quale era partita Elisa Valent, è la seconda in Italia per numero di studenti che partono. Il trend è in continua crescita. Dall’anno accademico 2004/2005, quando partirono da Padova 653 ragazzi, la progressione è stata continua, fino agli oltre 1.390 dell’ultimo anno accademico: praticamente raddoppiata. Stessa percentuale per Ca’ Foscari, che dal 2010 a oggi ha visto aumentare del 56% la partecipazione al progetto; progressione anche per Verona, che nel 2013 ha mandato 378 ragazzi a studiare all’estero, nel 2014 421. Regina di cuori, ovviamente la Spagna: dei 591 studenti che hanno vinto la borsa di studio, 123 hanno scelto la Spagna, seguita dai 103 della Francia e i 96 della Germania. Il resto è presenza piuttosto marginale. Proporzione leggermente maggiore per Iuav: dei 216 all’estero, 62 sono divisi tra le varie università della Spagna. Ma i numeri da soli non bastano a leggere il fenomeno Erasmus, che anche in Veneto significa nuove amicizie, scappatelle o grandi storie d’amore che costringono a trasferirsi, a mollare quello che si ha in Italia e in molti casi a continuare a studiare nel Paese dove si era vissuto quell’anno magico. O ancora carriere universitarie esaltanti o semplici esami recuperati all’ultimo mese prima di partire, col vecchio ma incrollabile «studio matto e disperatissimo». «La mia “esperienza Erasmus” - racconta Alessandro Marani, trevigiano, studente di Scienze Politiche - è stata fatta due anni fa all’università di Paris 8, ed è stata così forte e importante che mi ha spinto a trasferirmi in Francia e continuare la carriera universitaria all’Università di Paris 1 Panthéon-Sorbonne». E il dolore e lo stupore che i ragazzi Erasmus ieri non smettevano di comunicare per la tragedia spagnola, si legava indissolubilmente però anche a un forte senso d’appartenenza alla comunità che ha per casa l’Europa. Come Marco De Rovere, 27 anni, studente di Biologia molecolare a Trieste, Erasmus a Helnsinki: «La migliore esperienza della mia vita. La prima vera fuori casa, con persone totalmente sconosciute: devi gestire tu i tempi tra lo studio e far festa. E così a me è capitato di fare più che altro festa per quattro mesi e poi ritrovarmi l’ultimo mese a dover studiare come un matto! L’Erasmus lo fanno le persone, non la città dove sei. E una volta che ha fatto l’Erasmus sei studente Erasmus per sempre». Proprio con quel cuore Erasmus la generazione di ventenni che guarda al mondo ieri e l’altro ieri ha letto le notizie spagnole come un filo che si spezzava nella vita di persone che erano lì «per vivere il loro momento più bello. E sapere di averle perse così fa ancora più male», spiega ancora Marco. «Quella di domenica è una perdita per tutta l’Europa», conclude Alessandro. E noi con lui. Pag 8 Picchiata e minacciata dal marito per 40 anni. “Il prete mi diceva: sopporta e prega” di Milvana Citter Nel Trevigiano Codognè (Treviso). Una moglie deve sopportare. Porta pazienza e prega perché il Signore lo faccia cambiare». Così consigliavano, la madre e il prete, a una donna vittima di violenze da parte del marito. Non cento anni fa quando i femminicidi venivano chiamati «delitti d’onore», un’epoca in cui una donna non poteva neppure pensare di ribellarsi al consorte e il matrimonio era davvero per sempre. È successo in un’era nella quale è consentito scegliere di lasciare il compagno violento. Ma come si fa a prendere una decisione tanto importante se si è da sole e le persone alle quali chiedi aiuto ti dicono: «Devi sopportare»? Per questo motivo lei ha sopportato. Per ben 42 anni. Ha sopportato le botte, gli insulti e le umiliazioni, e anche le minacce. Fino a quando non ce l’ha fatta più, lo ha lasciato e lo ha denunciato. Così il marito è finito a processo ed è stato condannato, per maltrattamenti in famiglia, a 2 anni e 3 mesi senza sospensione condizionale. A darle il coraggio è stata la paura che dalle parole il compagno passasse ai fatti e la uccidesse, così come tante volte l’aveva minacciata. Un incubo che per la 69enne di Codognè è iniziato subito dopo le nozze. Niente di quel che lei faceva andava bene al marito, ed erano insulti e umiliazioni. Anche l’annuncio dell’arrivo del primo figlio è stato accolto in modo violento: «Mi ha dato un ceffone, mi ha detto che ero una puttana e che non era suo». Poi c’erano le pentole scagliatele addosso con i cibi bollenti quando non erano di suo gradimento, le umiliazioni: «Non vali niente, non sai fare niente», infine le minacce. «Una volta - ha raccontato la donna al giudice - ha preso il fucile da caccia ed ha esploso un colpo sul soffitto della cucina. Mi ha detto “ti ammazzo”». Lei aveva avuto paura e gli aveva fatto portar via tutte le armi. Ma questo non l’aveva placato: «Non serve il fucile per farti fuori. Basta un cuscino per soffocarti e poi ti butto nel fosso». Minacce che costringevano la donna a dormire in un’altra stanza, chiusa a chiave. Eppure, nonostante tutto, lei è rimasta con quell’uomo per 42 anni. Perché tutti le dicevano che non poteva rompere il matrimonio. Glielo diceva la madre: «Prendi il rosario e prega il Signore che lo faccia cambiare». E glielo ribadiva il parroco, con il quale si era più volte confidata: «Devi sopportare, portare pazienza e pregare. Pregherò anch’io per te. Vedrai che le cose andranno meglio». Ma le cose non sono mai migliorate. Un incubo quotidiano e purtroppo condiviso: sono infatti oltre 300 le donne che in un anno, nella Marca, hanno chiesto aiuto. Numeri che diventano ancora più grandi considerando il territorio regionale: sono 1.315 le donne che da gennaio a ottobre 2015 si sono rivolte ai Centri antiviolenza del Veneto, in media 4 al giorno. La 69enne trevigiana, però, ha deciso di dire basta e di salvarsi. Lo ha lasciato e lo ha denunciato. E quel marito violento è stato condannato. Torna al sommario … ed inoltre oggi segnaliamo… CORRIERE DELLA SERA Pag 1 Non tradiamo il loro sogno di Beppe Severgnini I ritratti sorridenti delle ragazze di Tarragona sono insostenibili. La morte è sempre inspiegabile; la morte giovane è inaccettabile. Perché loro? Perché il destino doveva salire a bordo di quel pullman, travestito da autista assonnato? Cinquantasette studenti Erasmus di ritorno da una festa popolare a Valencia, la prima notte di primavera: la fotografia perfetta della bellezza e della gioventù d’Europa. Il mezzo su cui viaggiano invade la corsia opposta, si scontra con un’auto. Tredici morte, tra cui sette italiane. Francesca, Serena, Lucrezia, Valentina, Elena, Elisa, un’altra Elisa. La mamma di un’altra ragazza, Annalisa, racconta che la figlia ha perso tutte le amiche. È grave in ospedale, ancora non lo sa. La reazione istintiva è associare questi viaggi, questa età e queste esperienze con il pericolo. Non leggerete editoriali in proposito; nessuno andrà in televisione a dire «Ragazzi, state a casa!». Ma il continente spaventato, ieri, ha aggiunto una paura nuova. L’aereo della Germanwings, il concerto del Bataclan, ora l’autobus di Tarragona. È come se il sogno europeo perdesse, uno dopo l’altro, i suoi colori. Restano il mare nero e le facce dietro le frontiere chiuse. Le testimonianze dei genitori delle vittime strappano il cuore: aspettavano una laurea, le aspettano in un obitorio. Qualcuno, davanti allo strazio, lascerà intendere che sia più saggio e sicuro non muoversi, non andare, non sperimentare. Non è vero: non lo è mai stato. La cronaca italiana lo dimostra. I pericoli sono dovunque: spesso vicino a casa, talvolta addirittura dentro casa. Non è rinchiudendole che proteggiamo le persone cui vogliamo bene. Siamo circondati da allarmisti interessati. La tragedia di Tarragona, se la nostra reazione non sarà pronta, rischia di diventare il simbolo di una gioventù irresponsabile, superficiale, disposta a correre rischi inutili. Non è così, ovviamente. Su quell’autobus potevamo esserci noi, trent’anni o quarant’anni fa; oggi ci sono i nostri figli e nipoti, e dobbiamo lasciarli andare. Una delle mie molte nipoti, Ilaria, romana, 24 anni, studentessa di psicologia, sta finendo lo scambio Erasmus a Santiago di Compostela, in Galizia. Sappiamo che viaggia, gira, si sposta per la Spagna. Certo: ci siamo preoccupati, in famiglia. L’abbiamo chiamata, e quando abbiamo saputo che era lontana da quella strada catalana abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Ma non abbiamo mai pensato - e non penseremo mai - che l’esperienza all’estero la metta in pericolo. Pensiamo invece che l’abbia migliorata e maturata. Il programma Erasmus è nato nel 1987, ha quasi trent’anni. Tre milioni di giovani europei hanno cambiato università, residenza, abitudini, lingua. Si sono innamorati e hanno incontrato nuovi amici. Hanno imparato la categoria della distanza, che solo il primo grande viaggio insegna. Hanno appreso la lezione della tolleranza: persone diverse in posti diversi fanno cose diverse, e va bene così. Gli investimenti per Erasmus sono, in assoluto, i soldi meglio spesi dall’Unione Europea. Il programma non crea politiche europee, finanziamenti europei, garanzie europee. Crea europei - sostantivo. È diverso e più importante. Non è facile trasformare il cordoglio in convinzione. Ma il dolore è un formidabile fertilizzante. Se volessimo rendere omaggio alle ragazze su quell’autobus — a chi è morto, a chi è ferito, a tutti gli altri che quella notte di marzo non la dimenticheranno mai - dovremmo costruire l’Europa come la vogliono: mescolata, solidale, orgogliosa e generosa. Dovremmo aprirci, non chiuderci. Sognare, non spaventarci. Sognare, insieme ai nostri figli e nipoti, un futuro condiviso e migliore. Facciamolo in nome delle vittime di Tarragona. Facciamolo per rispetto dei ragazzi che siamo stati. Pagg 2 – 3 Progetti e sogni di sette ragazze La tragedia dell’Erasmus. Avevano tutte tra 22 e 25 anni. Provenivano da Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana e Lazio. I volti e le storie delle vittime dell’incidente di Tarragona La passione per lo sport di Lucrezia, la cucina e il volontariato di Francesca, la dimestichezza con le lingue straniere di Valentina, la curiosità per la Catalogna di Elena, la sensibilità di Serena, l’umiltà della romana Elisa e il sogno di diventare scrittrice dell’altra Elisa, friulana. Sette storie di sette ragazze che erano partite non solo per completare gli studi ma soprattutto per rendere più concrete le loro ambizioni, per realizzare i loro progetti. Sette vite che si sono spezzate in un’autostrada spagnola, al ritorno dopo una notte di festa e divertimento. Venivano dal Piemonte e dal Veneto, dalla Toscana e da Genova e Roma, studiavano economia o medicina, farmacia o filologia. Sette storie diverse che hanno trovato un destino comune, difficile da accettare per delle esistenze così giovani. Gli studi in Economia, poi la pallavolo e il catechismo - Ha lottato in ospedale tutta la mattina dopo l’incidente, ma neanche il suo corpo giovane, atletico, sano l’ha salvata. Lucrezia Borghi è la settima ragazza italiana a essersene andata a Barcellona. Papà Fabrizio e mamma Cecilia e il ragazzo di Lucrezia l’hanno dovuta riconoscere da sotto un lenzuolo, e poi cercare di tenersi in piedi. Dovevano esserci, come se potesse servire a qualcosa ormai starle accanto. Sapevano che Lucrezia era tra le vittime, ma non potevano restare fermi, così lontani, perché magari c’era stato un errore, uno scambio di documenti, erano tante le ragazze in ospedale, ferite, gravi, ma vive. Perché non anche lei? E allora, senza posti in aereo, senza cartine, si sono messi in automobile e sono partiti. Da Greve in Chianti a Firenze poi Genova, Monaco, Montpellier fino a Barcellona, 12 ore senza pausa, con il gruppo di whatsapp a fare da supporto e da navigatore. A casa, a due passi da Firenze, è rimasto il fratellino di 14 anni. Voleva aprire le uova di Pasqua con la sua Lucrezia. Gliel’aveva promesso. Nonno Franco, i compagni di liceo, dell’università, della squadra di pallavolo, dell’oratorio non riescono a farsene una ragione perché una ragione non c’è. E allora pregano. Tutti assieme a don Flavio Rossetti orgoglioso di quella sua catechista così «sensibile, seria e brillante». Chiesa piena ieri sera a Greve, per una veglia di preghiera e di lacrime. Lucrezia studiava Economia a Firenze e sapeva quale mondo difficile l’avrebbe aspettata alla fine degli studi. Ma lei era ottimista, aperta al mondo, con le radici saldissime nella provincia dov’è nata. Una ragazza global con amicizie da Greve in Chianti a Palermo, da New York a Francoforte, da Kingston a Barcellona. Sapeva quanto fosse importante questo periodo di studio per lei. Un’occasione per aprire la mente, conoscere altri professori, altri metodi, spalancare opportunità. Il 19 marzo, dopo gli auguri telefonici al papà, aveva scritto una mail all’ateneo fiorentino per prolungare di un mese il suo Erasmus. «Per quanto riguarda la borsa di studio, come funziona? - domandava assieme a tre amiche -. Sarebbe possibile averla anche a luglio?». Lucrezia è morta, altre due amiche, loro sì, sono solo ferite. Era guarita dalla leucemia. I suoi post pieni di ironia - Su Facebook, il 20 febbraio, aveva messo la foto dello scatolone pronto, con i vestiti e i libri da portare in Spagna: «Si comincia a imballare. Meno 4 giorni alla partenza. Mi piange il cuore neanche se stessi andando in guerra». Elisa Valent aveva 25 anni, studiava Filologia moderna a Padova, ma era nata in Friuli, a Gemona. Gli studi allo Scientifico, poi la laurea triennale a Udine, il sogno di diventare scrittrice, e a fine febbraio fa l’inizio dell’Erasmus a Barcellona. I suoi messaggi su Internet sono anche il diario dei suoi ultimi giorni di vita: la scalata con i colleghi sulla montagna del Montserrat, la foto davanti alla Sagrada Familia, le canzoni di Caparezza, il giorno a letto con la febbre. O la lezione di spagnolo per scoprire che menestra non si traduce in minestra: «Non c’è nemmeno su Google Traduttore, ora ditemi come faccio a sopravvivere qua» scriveva appena venerdì sera, il giorno prima di morire. Ironica e solare, soprattutto adesso che, proprio alla vigilia dell’Erasmus, si era liberata dell’apparecchio ai denti («Dopo tre anni un sorriso è d’obbligo») e soprattutto aveva vinto la sua battaglia con la leucemia. Aveva avvisato i genitori, che vivono con l’altra figlia a Venzone, vicino a Gemona, che sarebbe andata a Valencia per la festa dei fuochi. Mamma Anna, commessa, e papà Eligio, ferroviere in pensione, hanno saputo dell’incidente dalla tv e si sono disperatamente attaccati al telefono. La loro Elisa non rispondeva, hanno subito temuto il peggio e chiesto aiuto al sindaco, Fabio Di Bernardo. Il quale ha avuto dalla Farnesina la conferma della tragedia e ora dice: «Qui ci conosciamo tutti, il dramma vissuto da questa famiglia è il dramma di tutto il paese». Elisa un po’ per gioco un po’ forse per davvero era timorosa della parentesi di studio lontano dall’Italia. Il 6 febbraio annotava: «Tra tre settimane esatte sarò in Erasmus a Barcellona. Aiuto. Oddio, ricordatemi come una cara ragazza che salutava sempre». Esagerazione da studentessa alla vigilia di quella che era comunque un’avventura. Mai avrebbe potuto immaginare che certo non stava «andando in guerra», eppure non sarebbe più tornata a casa. Aspettava il giorno dopo l’abbraccio dei genitori - Quel prototipo di città giardino, il Park Güell di Barcellona, l’aveva stregata. «È straordinario, camminare qui sembra di vivere in una favola», aveva raccontato alle amiche dopo aver postato su Facebook una foto datata 3 marzo, ore 19.56. L’ultima. E un po’ prota-gonista di una fiaba si sentiva davvero, Valentina Gallo (Frangetta per gli amici), 22 anni, studentessa di Economia azienda-le e management all’università di Firenze e ora in Erasmus, tanto desiderato e ottenu-to grazie ai buoni voti, alla conoscenza delle lingue e a quella «grinta dolcissima e garbata» con la quale affrontava la vita. Figlia di due insegnanti delle superiori, il professor Gerardo, di origini campane, e la professoressa Giulia, calabrese, era nata a Bagno a Ripoli, comune dell’hinterland di Firenze, ma solo perché lì c’era la maternità dell’ospedale di Ponte a Niccheri, perché lei si sentiva fiorentina doc, orgogliosa di abitare con i genitori nell’ap-partamento di via dello Statuto, quartiere di Rifredi, non lontano dalla Fortezza da Basso e dalla stazione di Santa Maria Novella che giudicava i simboli della bellezza e degli orizzonti allargati. Fiorentina, certo, ma anche cittadina europea. Ed era stata proprio lei a proporre alle colleghe di corso di andare a Barcellona e a prolungare il periodo dell’Erasmus di un mese. Gli esami li aveva fatti quasi tutti e i 27 crediti obbligatori per l’esperienza di studio europea erano vicini, come la laurea. «Era felicissima di questa esperienza - racconta Francesco, un compagno di università -, era brava nelle lingue e riusciva a sostenere gli esami sia in inglese che in spagnolo. Mi aveva detto che aveva trovato un gruppo di amiche straordinarie». La sua felicità l’esternava spesso anche al fratello maggiore Alessio, 24 anni. Eppure l’anima di quella ragazza così cosmopolita, che sognava di diventare un’imprenditrice, nascondeva anche il desiderio di riscoprire le sue radici. Con la famiglia andava spesso a trovare i nonni novantenni Rocco e Michelina e i cugini che vivono a Vallata (Avellino), soprattutto durante le feste. Ma la Pasqua quest’anno Valentina aveva deci-so di trascorrerla a Barcellona con mamma e papà. Erano appena partiti per la Spagna quando hanno saputo dell’incidente. La scelta di Medicina perché voleva «fare da sola» - Elisa portava con lievità quel suo cognome importante, Scarascia Mugnozza, dinastia di professori universitari. Figlia di Giuseppe direttore del Dibaf dell’Università della Tuscia, nipote di Gabriele, prorettore della Sapienza di Roma. Agronomo uno, geologo l’altro. Lievità per Elisa voleva dire fare da sola, crescere, farsi strada con le proprie forze. Aveva scelto Medicina anche per quello. Non voleva vantaggi, Elisa, ma non per polemica, per dispetto o presunzione, solo perché, dicono le amiche di Facebook, aveva un enorme rispetto, quasi un culto, per il lavoro, lo studio, il merito. Valori, si sarebbe detto una volta, assorbiti proprio in famiglia. Il rapporto con il papà era sempre stato fortissimo. Stima, rispetto, amore. Appena sentito dell’incidente, il professor Giuseppe ha telefonato al cellulare della figlia. Muto. La paura ha cominciato a crescere. Ogni chiamata andava persa e, tra gli accordi di Elisa con i genitori, c’era anche quello di lasciare il cellulare sempre acceso. Non servirà, non ti chiameremo, ma così, giusto per lasciarci tranquilli. Niente e nessuno, se non la fiducia in Elisa, diceva che proprio quella figlia fosse stata coinvolta in quello schianto pauroso in terra spagnola, ma il papà non se l’è sentita di aspettare. Senza dir niente a nessuno è corso in aeroporto, deve essersi messo in lista d’attesa, ed è riuscito a partire. Un volo con gli occhi sbarrati, il cuore strizzato, il desiderio sconfinato che Elisa per una volta avesse disobbedito, si fosse dimenticata, qualun-que cosa tranne quella. La peggiore di tut-te, senza rimedio. A Barcellona, con l’aereo ancora in cerca dell’area di parcheggio, il presentimento è diventato tragedia, strappo. «Di Elisa potevi fidarti ciecamen-te. Sempre disponibile, sempre pronta a darti una parola di conforto» racconta via Facebook Luca, un amico. «Tanto dura quanto fragile. Le piaceva stare insieme alla gente, divertirsi, staccare la spina, ma sempre con intelligenza. Era l’amica che tutti vorrebbero avere». L’amica con la A maiuscola, però, era l’altra Elisa, Elisa Beraldi. Erano inseparabili, confidenti, aperte, sincere, amiche. Non smette di piangere Elisa. Non può smettere è come se avesse perso una parte di se stessa. Aveva già appuntamento a Gavorrano: arrivo alle 19 - Il liceo a Follonica, l’università a Firenze, il corso triennale di Economia aziendale, poi il gran balzo all’estero: da due mesi la vita stava andando proprio come Elena Maestrini, 22 anni, aveva voluto. «Era felice» assicura Francesca, un’amica che era già rientrata in Italia, ma che condivideva le giornate di Elena alla scoperta di Barcellona. Il programma Erasmus era la realizzazione di un sogno che aveva riempito negli ultimi tre anni le sue serate fiorentine, le chiacchiere con gli amici, i colloqui con i professori, i moduli da compilare. Un ultimo esame a gennaio con il preside del corso di Economia, Vincenzo Zampi, e poi via, all’inizio del 2016 era cominciata la sua avventura: poco meno di sei mesi a Barcellona per approfondire le materie del suo indirizzo, Economia aziendale e management, ma anche per conoscere un Paese nuovo, sperimentare il modo di vivere alla catalana e quell’«appartamento spagnolo» che ha stregato generazioni di italiani. Elena si era iscritta alla gita a Valencia, organizzata dall’Erasmus Student Network dell’Università di Barcellona, assieme a Lucrezia e Valentina, amiche, compagne di studi e toscane come lei, anche se al rientro l’aspettava subito un altro viaggio: a casa, questa volta, a Bagno di Gavorrano, frazione di tremila abitanti in provincia di Grosseto, nella sua Maremma, dove aveva previsto di arrivare ieri sera per trascorrere la Pasqua con i genitori. «Arrivo alle 19» aveva fatto sapere al gruppo di amici su Whatsapp, poche ore prima della tragedia. La settimana di Pasqua sarebbe stata la sua prima vera vacanza da quando era partita, e probabilmente l’ultima fino al rientro a Firenze, quest’estate, a stage concluso. Era viva, Elena, quando i primi soccorritori sono arrivati al famigerato chilometro 333 dell’autostrada Barcellona - Valencia. Ma in condizioni disperate. Il padre, Gabriele, e la madre, Roberta, sono partiti per Tarragona prima ancora che arrivasse la notizia peggiore. Al paese sono rimasti gli amici d’infanzia, ancora increduli: «Per noi era come una sorella. Possiamo soltanto sperare che dormisse, quando è avvenuto l’incidente, e che non si sia accorta di nulla». L’ultima foto di una farfalla che si posa su un fiore - Tanti programmi, tante attese. La prossima: il compleanno, 23 anni lunedì prossimo, da festeggiare con le amiche a Barcellona. Perché sarebbe stato indimenticabile. Serena Saracino aveva le idee chiare: era tempo di rendersi indipendente e, a Torino, la città dov’era cresciuta, molti la ricordano come una delle maschere della sala concerti della Rai. La più puntuale, gentile e servizievole. Ma non aveva fretta di tornare in Italia: così qualche giorno fa aveva scritto alla facoltà di Farmacia dell’ateneo torinese, dov’era iscritta al quarto anno, e in pari con tutti gli esami, chiedendo di prolungare la sua permanenza a Barcellona, con il tirocinio. Sarebbe fiera, Serena Saracino, di suo padre, Alessandro, 60 anni, medico condotto a Settimo Torinese. Sarebbe fiera di sentire come parla ora di lei e di ascoltarlo mentre chiede, trattenendo le lacrime, a «un Paese amico», la Spagna, che «tutto questo non accada mai più», che non si permetta ancora a un autista stanco di riportare a casa un pullman carico di ragazzi, alle quattro del mattino, sotto la pioggia battente. Prima di alzarsi all’alba di sabato con l’amica, Annalisa Riba, anche lei aspirante farmacista, per prendere il bus in partenza da Barcellona, Serena ha postato sul suo profilo Facebook una foto che le piaceva: una farfalla che si posa un papavero. Struggente come un ultimo saluto. Era una ragazza studiosa e ubbidente, ha detto suo padre, la sua unica, bellissima figlia. E pensava che fosse al sicuro in quella città piena di giovani e di promesse, di allegria e di ottimismo. Da febbraio Serena divideva la sua nuova casa con Annalisa, che sedeva vicino a lei anche sul bus, ma è sopravvissuta al violento impatto, con qualche ferita non grave, da cui si sta riprendendo all’ospedale di Tarragona. Nessuno ha ancora trovato il coraggio di dirle che la sua amica invece non ce l’ha fatta. Serena aveva parlato anche con i genitori di quella sua idea di fermarsi in Catalogna; e il padre aveva persino immaginato di potersi trasferire anche lui a Barcellona, con la moglie: «Ora non ci resta che tornare a casa e ammazzarci. Senza di lei non viviamo» ha detto. Ma questo a sua figlia non piacerebbe sentirlo. Il volontariato in Ciad e la passione per la cucina - Quando era arrivata a Barcellona aveva organizzato una festa e preparato per una cinquantina di ragazzi le lasagne «al tocco», il tipico ragù alla genovese. Francesca Bonello, che avrebbe compiuto 24 anni a giugno, amava la cucina e fare qualcosa per gli altri. Per questo aveva scelto di diventare medico, che per lei, profondamente religiosa, era più una missione che una professione. Lo ricorda padre Francesco Cavallini, gesuita della Comunità vita cristiana di Genova, che Francesca frequentava: «Era andata in Ciad l’estate scorsa con il fidanzato Federico, che è già medico, con una nostra associazione. Ed era andata là per mettere in pratica quello che stava imparando, per aiutare gli altri». Era stata anche volontaria in Romania e assisteva in città gli anziani dell’Istituto Paverano. «Francesca era una ragazza generosa che viveva la religione con una fede vera, concreta - dice commossa Caterina, un’amica di famiglia -. Ha lavorato tanto con i poveri, era una persona piena di amici, solare e bella. La sua è stata una vita breve ma vissuta per gli altri». Caterina e molti di quelli che la conoscevano ieri si sono ritrovati per una messa in ricordo nella Chiesa del Gesù, frequentata da tutta la famiglia Bonello, il padre ingegnere, la madre insegnante di scienze. «Era contenta e spaventata per questa avventura in Spagna dice Paola, amica dai tempi del liceo -. Di lei non ho ricordi in cui non sia sorridente». Concorda padre Cavallini: «Era la persona più vitale che abbia mai conosciuto. Ovunque è andata si è sempre fatta amare». E il vescovo vicario di Genova, don Nicolò Anselmi: «Non ci sembra possibile che sia successo proprio a lei. Sprizzava gioia e desiderio di vivere da tutti i pori. Era una ragazza amatissima, soprattutto dai bambini, sempre disponibile. Veniva dal mondo degli scout e le piaceva mettersi in gioco, dare una mano quando c’era bisogno». I genitori domenica sono subito partiti per la Spagna. Marta, la sorella di poco più piccola, è invece rimasta a casa. Risponde al citofono e piange: «Francesca era una persona speciale, una studentessa modello. Era in Erasmus da un mese. Ma non posso dire altro, non riesco a parlare. Cercate di capire quello che stiamo vivendo». Pag 15 Lavacri e nostalgie, gli ex Msi e i conti con il passato mai fatti del tutto di Pierluigi Battista Una spina. Un prurito. Un’ossessione. Il lavacro di Fiuggi del ’95 non ha sradicato il passato in fondo al cuore. Il peso di una storia mai smaltita che si fa sentire fino ad oggi. «Io non sono mai stata fascista», dice di sé Giorgia Meloni rispondendo a Berlusconi che ha bollato con disprezzo usando l’epiteto (ancora?) infamante di «fascisti». «Mai» è molto impegnativo. Chissà perché allora il Msi ha sentito il bisogno di non chiamarsi più così e di ribattezzarsi Alleanza Nazionale. E perché nelle tesi di Fiuggi si è addirittura scomodato l’antifascismo come momento storicamente necessario al ritorno della libertà in Italia. E perché Gianfranco Fini, con il parere entusiastico e unanime dei colonnelli che via via gli hanno voltato le spalle fino ad arrivare all’attuale irrilevanza collettiva, ha sentito il bisogno nel ’93 di andare in pellegrinaggio alle Fosse Ardeatine, e poi ad Auschwitz, e poi in visita commossa allo Yad Vashem di Gerusalemme, faccia a faccia con il «male assoluto» della Shoah, mentre in Italia borbottavano per quella kippah in testa. Il fascismo è stata una storia grande e tragica. Con la fine della Prima Repubblica, fondata sull’antifascismo costituzionale, quella storia sembrava essersi esaurita. Hanno chiuso le insegne del comunismo e del fascismo. Restano i fantasmi, i residui, i ricordi che stregano le idee e le teste. E lo psicodramma che non si spegne mai. Con lo spettro del fascismo il centrodestra berlusconiano ha duellato sin dall’inizio. Quando Berlusconi disse di optare per Fini come sindaco di Roma (la storia comincia nei pressi del Campidoglio e qui sta volgendo alla fine, potenza dei simboli e dei ricorsi), gli avversari gli misero un fez in testa: il Cavaliere nero. Bossi, alleato riluttante di governo, si mise in marcia sotto il diluvio nel 25 aprile milanese che sembrava rinato dal nulla, dopo anni di celebrazioni ufficiali stanche e sfibrate. Disse anche, con la sua prosa trattenuta e moderata, che i fascisti sarebbero stati inseguiti «casa per casa» e che con i fascisti mai più da nessuna parte. Poi invece il «da nessuna parte» diventò Palazzo Chigi. La sinistra impazziva per il «regime» in agguato. Ogni manifestazione del centrodestra nella Capitale diventava la «marcia su Roma». Berlusconi faceva finta di non sentire: scherzava addirittura sulle isole del confino fascista dipinte come ameni luoghi di vacanza. I missini smisero di essere tali: divennero aennini. Sparirono saluti romani e labari. Anzi, riapparvero in qualche funerale (che Fini e i suoi dovevano abbandonare prima che risuonasse lo stentoreo «Presente!» con braccio teso) e quando un gruppo di ex fascisti, o postfascisti, o fascisti salutarono con entusiasmo Gianni Alemanno che aveva vinto le elezioni a Roma. Sempre al Campidoglio: quando si dice la fissazione dei luoghi. Non erano più fascisti, fuori e dentro? Alessandro Giuli, che dedicò al gruppo dirigente di An uno sferzante pamphlet, scrisse che il passo delle oche aveva sostituito il passo dell’oca. Chi voleva restare fascista aveva a disposizione da Fiuggi in poi la Rifondazione nera capeggiata da Pino Rauti. Gli altri si adagiarono sulla strada dello sdoganamento e addirittura confluirono disciplinatamente nel Pdl nato dal predellino di Berlusconi. Tranne Francesco Storace, che con Daniela Santanché mise su «La Destra», in rotta con il Fini che a Gerusalemme si era spinto troppo oltre. Una storia grande e tragica, quella del fascismo e anche quella del neofascismo. La scommessa di una destra che finalmente all’aria aperta, finalmente non più ghettizzata, finalmente non più confinata nel reparto dei reprobi della Repubblica, avrebbe potuto dimostrare tutte le sue potenzialità, è stata una scommessa persa. Quando Fini osò alzare il capo con Berlusconi, i colonnelli che erano stati di An e che erano cresciuti insieme nella palestra missina per disegnare «il fascismo del Duemila» sfilarono sul palco per condannare il refrattario e per giurare fedeltà imperitura al Capo. Questa parola, «fascismo», ristagnava sullo sfondo, chiusa in un armadio, con la naftalina perché non esalasse cattivi odori. Ma i conti con il passato non sono mai stati fatti. «Fascista»? Giammai, sembra dire Giorgia Meloni avanzando le prove dell’anagrafe. Il rimosso non se ne va. Il passato non passa. Sotto il tappeto è già tutto pieno. Pag 28 I rischi del decisionismo senza corpi intermedi di Giuseppe De Rita Da qualche anno si parla spesso della crisi dei corpi intermedi. Lo sforzo di ristabilire il primato della politica ha portato infatti a verticalizzare il potere in poche sedi decisionali; a declassare il concetto della mediazione e la prassi della concertazione; a diroccare tutti i soggetti che per tradizione rappresentano vecchie e nuove istanze di mediazione (i sindacati, i partiti, le rappresentanze imprenditoriali, il sistema camerale, le amministrazioni provinciali, ecc.). Molti osservatori decantano questo processo di «disintermediazione» e il conseguente sfoltimento della boscaglia intermedia; altri, quorum ego , lo vivono con il timore che la desertificazione intermedia possa creare un deficit di coesione sociale e possa ridurre la vitalità e la convergenza dei tanti particolaristici soggetti del nostro sviluppo. La prima di queste due posizioni è oggi decisamente vincente, così la seconda dovrà intraprendere una lunga marcia nel deserto per far crescere «fili d’erba e cespugli» di nuova rappresentanza. Presi dai toni accesi da questa contrapposizione, non tutti però si sono accorti che c’è un deficit di dimensione intermedia anche nella dilagante verticalizzazione del potere pubblico. Il decisionismo politico porta certamente al primato del comando; ma questo rimane nullo senza una catena di comando che trasmetta alle strutture amministrative e alle periferie del sistema le opzioni di vertice. È questo il pericolo su cui si stanno avvitando il potere politico e lo Stato italiano. Ad un progressivo accentramento delle funzioni di governo in alcune sedi di vertice (forse in una sola) si accompagna infatti una altrettanto progressiva povertà dei meccanismi attuativi in cui incanalare la politica. Alcuni apparati ministeriali in pratica esistono ormai solo di nome, vuote macchine senza identità; altri sono in grave stato di frustrazione identitaria, talvolta anche professionale; intere macchine burocratiche sono presidiate da personale contabilizzato «a giornata» da alcune grandi società di consulenza e quindi senza alcuna possibilità di professionalizzazione e di carriera; non cresce quindi nessuna classe dirigente capace di progettare e portare avanti nuovi compiti o nuovi assetti d’azione pubblica; e il complessivo vuoto di potere e di controllo che ne discende crea una diffusa deresponsabilizzazione - e talvolta anche pericolose devianze - nei comportamenti dei singoli. Magari i giornali sottolineano le devianze più clamorose, ma è il deserto delle responsabilità intermedie che le rende possibili. In questo deficit di trasmissione dettagliata del comando politico, la volontà politica resta un potere nudo, spesso di puro annuncio, senza seguito concreto. Qualcuno, anche su queste colonne (da Ainis a Cassese), arriva a dire che lo Stato non c’è più; altri (il presidente Boeri) prevede il default dei servizi Inps a causa della consunzione dei quadri medio-alti; ed altri ancora (antichi o aspiranti sindaci a Roma) avvertono che nessuno si illuda di governare la città con l’attuale inerte burocrazia capitolina. Gli esempi potrebbero continuare, ma bastano quelli citati per capire che mentre tutti ce la prendiamo con la mancanza di legalità negli apparati pubblici, la crisi vera sta nel fatto che quegli apparati non funzionano, quasi non esistono più. Non si fronteggia tale deserto nel cuore dello Stato affollando poche stanze di vertice, con il rischio di ulteriori deresponsabilizzazioni intermedie. Meglio sarebbe prendere atto che ogni società e struttura complessa vive di efficienza intermedia. Ce lo dice anche il mondo delle imprese (anche quelle più personalizzate al vertice), dove l’attenzione è spasmodica verso quei dirigenti e quadri chiamati a trasmettere gli impulsi e i comandi dall’alto, ma anche a creare quel tessuto di relazioni di reciprocità senza il quale nessuna organizzazione può vivere. Se partissimo da tale fenomenologia potremmo fare un esame di coscienza sulle polemiche fin qui andate di moda e recuperare un po’ di dimensione intermedia, nella società come nello Stato. LA REPUBBLICA Pag 41 Il cristianesimo sulla via dell’Oriente di Silvia Ronchey «Crediamo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito Figlio di Dio, che fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno risuscitò, secondo le Scritture»: così della natura e vicenda di Gesù recita il symbolum fidei niceno-costantinopolitano del 381. Ma la storia di morte e resurrezione tramandata dai Vangeli e riflessa nella formula di fede che consideriamo fondante, almeno in occidente, per la dottrina di ciò che chiamiamo "il" cristianesiasimo, non era stata in origine, né sarebbe stata in seguito, interpretata allo stesso modo da tutti. Per esempio, secondo una curiosa versione orientale, Gesú non morì sulla croce. Si limitò a svenire. Quand' era già nel sepolcro si riprese, fu curato dai discepoli e fuggì, sulle orme di Alessandro Magno, in India. Qui, dopo una lunga vita di predicazione, si ritirò sulle montagne del Kashmir e morì centenario nel distretto dei laghi ancora oggi famosi per le loro case galleggianti, dove sarebbe tuttora sepolto. Mirza Ghulam Ahmad, il fondatore della setta islamica indiana detta appunto Ahmadiyya cui si deve questo racconto, alla fine dell'Ottocento riconobbe il nome di Gesù (che normalmente è Yassou nella resa arabo cristiana, mentre 'Isa è la dizione musulmana usata nel Corano) nell'appellativo Yus Asaf inscritto in una cripta di Srinagar, su una tomba di origine buddista o induista, che nel XIV secolo, con l'invasione islamica della zona, era stata riorientata verso la Mecca e fu cantata dal poeta sufi Muhammad Azam Didamari. Quest'eresia bizzarra e sincretistica, recente e ancora oggi piuttosto seguita seppure ripetutamente sconfessata dall'islam ortodosso, è solo l'ultima, e certo la più estrema, di una comunque lunga e variegata linea di narrazioni asiatiche del Cristo, che si svilupparono da una visione della vicenda neotestamentaria difforme da quella cristiana ortodossa ma molto più diffusa di quanto si creda: la visione nestoriana, che all'inizio del IV secolo negò l'interpretazione divina della sua figura e la cosiddetta "unione ipostatica" della sua doppia natura umana e divina così come sarebbe stata ratificata dalla teologia dei concili di Efeso, che condannò come eretica la versione di Nestorio, e poi di Calcedonia, che condannò sia il nestorianesimo sia l'eresia inversa, il monofisismo, emettendo un suo credo in cui riconosceva in Cristo «due nature senza confusione, senza cambiamento, senza divisione, senza separazione». Entrambe le dottrine condannate nel V secolo si affermarono però in quel grande e primario bacino di diffusione del cristianesimo che furono il Medio Oriente, l'Africa e l'Asia, e lì prosperarono e diedero luogo a una molteplicità di fioriture, in cui il cristianesimo, nella meno ardua versione dottrinaria che ne fornivano, poté ibridarsi più facilmente sia con le religioni preesistenti - lo zoroastrismo, il manicheismo, il buddismo, il taoismo - sia con altre varianti del ceppo monoteistico giudaico e in particolare con quella che si sarebbe prepotentemente affermata di lì a poco: l'islam. A queste efflorescenze dottrinali che si inanellarono lungo la via della seta fino all'India e alla Cina, ma soprattutto alla lunga, complessa e per lo più proficua coesistenza testuale e intellettuale, oltre che spirituale, tra cristianesimo e islam, è dedicato il notevole libro di Philip Jenkins, La storia perduta del cristianesimo. Il millennio d'oro della Chiesa in Medio Oriente, Africa e Asia (V-XV secolo), ora tradotto in Italia, con prefazione di Giancarlo Bosetti (EMI, pagg. 352, euro 22), che partendo dalla sconfinata avventura della predicazione nestoriana ripercorre la storia del cristianesimo, dall' età dei concili al XV secolo, in un'ottica euroasiatica e antieurocentrica; traendo a volte conclusioni paradossali e discutibili, porgendo talora deduzioni storiche immotivate o eccentriche, ma fornendo una profusione di materiali e dettagli utili ad arricchire le nostre conoscenze sul passato di quell'unica civiltà euroasiatica da cui è espressa non solo la cultura che chiamiamo tout court occidentale, ma anche l'identità religiosa che a volte troppo drasticamente chiamiamo a contraddistinguerla. "Povero nestoriano smarrito" si definiva Eugenio Montale in Iride, evocando "il Volto insanguinato sul sudario" nel miraggio di luce di un altro continente. C'è un'esitazione, uno smarrimento, anche all' inizio del lungo viaggio che la storia di Cristo, uomo, dio, profeta, bodhisattva, compie per le strade dell'est, anzitutto dell'Arabia e della Persia. Un gioco di specchi vede le varianti orientali del cristianesimo riflettersi nello splendore delle prime grandi corti califfali. È nella Baghdad delle Mille e una notte che la dialettica del katholikòs Timoteo, primate della chiesa nestoriana sotto gli abbàsidi, poté incrociarsi, alla fine dell' VIII secolo, con la proverbiale moderazione del califfo al-Mahdi. È in un leggendario - probabilmente posteriore e spurio - dialogo tra i due che si incastona la celebre parabola della perla: «Se di notte, in una casa buia, cade una perla preziosa, tutti cercheranno di raccoglierla, ma a uno solo toccherà. Gli altri stringeranno chi un pezzo di vetro, chi una pietruzza o un grumo di terra, ma tutti saranno felici e orgogliosi e si sentiranno i veri possessori della perla». La perla della vera fede è caduta nel mondo mortale, dove non è dato distinguere chi la possieda realmente. Tutte e tre le religioni del libro ritengono di possederla, ma la verità finale non può essere nota a questo mondo di tenebra. Se la devianza cristologica del nestorianesimo rendeva il versante islamico del monoteismo più permeabile al beneficio del dubbio, la forza culturale della sua predicazione gettava i suoi germi verso le terre dei turchi e dei mongoli. Nelle rotte dei mercanti sogdiani, tra il Khorasan e la Transoxiana, lungo le vie carovaniere, la narrazione cristiana era moneta sonante: «Viaggiate ben cinti come i mercanti / per farmi guadagnare il mondo», scandisce un inno nestoriano. La fioritura era così ibrida, così stretto il dialogo transconfessionale, da indurre Jenkins a vedere nel nestorianesimo dell'età di Carlo Magno un superstite della grande "era assiale" in cui si formarono le religioni mondiali postulata da Karl Jaspers. Se, grazie anche a queste forme di predicazione più adattabili e flessibili, eclettiche ed eterodosse, l'oriente fu il bacino primario di diffusione del cristianesimo, l'Europa ne fu, sostiene paradossalmente Jenkins, un alveo di deflusso secondario, meno importante e solo inopinatamente sopravvissuto, per fattori contingenti, alla snaturante collaborazione tra chiesa e stato. «Spettro del defunto impero romano che siede incoronato sulla sua tomba» secondo la definizione di Thomas Hobbes, il papato, nella sua deriva di intolleranza teocratica, fu ulteriormente spalleggiato dalla violenza dei sacri romani imperatori. Come suggerì Teodoro di Beza, successore di Calvino al tempo della strage di san Bartolomeo, «la chiesa è un'incudine che ha consumato più del martello». Dal massacro dei sassoni di Carlo Magno a quello dei catari sotto Innocenzo III, la "spada di Costantino" - è stato sottolineato da molti dopo gli accenni all'"originaria" violenza islamica nel discorso di Ratzinger a Ratisbona del 2006 - non fu certo meno violenta di quella di Maometto. Oggi le parti si sono, almeno in apparenza, rovesciate. A rivendicare il titolo dei tolleranti califfi è la barbarie terroristica dell'Is, che manipola l'ideologia religiosa per mistificare e distruggere il passato. Ma, se come scrive Jenkins «la migliore ragione per studiare sul serio la storia è che praticamente tutti usano il passato nelle discussioni quotidiane», il passato non ha un solo volto. E la storia, scriveva Maxime du Camp, «è come Giano: che guardi il passato o il presente, vede le stesse cose». LA STAMPA Una tragedia che tocca ogni famiglia di Francesca Sforza Lo sgomento e il dolore per le giovani vite spezzate dall’incidente in Catalogna non si era ancora potuto stringere intorno ai nomi e alle identità di ognuna di loro che già era partito, tra le famiglie italiane, il tam tam dell’ansia. Come se fosse una questione personale, come se prima di essere un fatto di tutti, fosse un fatto di ognuno. Grazie alla potenza di fuoco dei social network l’emotività collettiva diventa immediatamente percepibile: su Twitter la parola chiave #Erasmus è stata ieri tra il primo e secondo posto nei Trending Topics (il barometro che misura i cinguettii più discussi); i gruppi WhatsApp di classe – ma ci sono anche quelli della palestra, della scuola di musica, degli scout, a ciascuno il suo – hanno trillato senza posa sulla notizia sollevando in ordine sparso diversi ordini di preoccupazioni - «Mio figlio è appena partito, suo padre era contrario, e se adesso gli succede qualcosa?», «Chi controlla lo stato psico-fisico di chi si mette alla guida dei pullman con i nostri figli a bordo?», «Ma ci si potrà fidare dei tutor dell’Erasmus?» -, persino l’antica pratica della chiacchiera occasionale ha preso la piega nervosa del voler offrire con ogni mezzo una spiegazione logica, e poi di respingerla, e la fatalità non basta a spiegare tutto questo, e come ci si difende, non si sa. Un Paese bambino, viene da pensare a un primo sguardo, che non resiste alla tentazione di riportare a se stesso il fatto del giorno, di ricondurlo entro i limiti del proprio circuito di riferimento, siano essi i figli in partenza per l’estero o le gite scolastiche in preparazione con l’arrivo della primavera. Ma a un secondo sguardo – al netto dei toni, di tante frasette accompagnate da faccine tristi o citazioni d’occasione - le ansie e le preoccupazioni che hanno attraversato tante famiglie italiane sono il segno di qualcosa di più forte, e di più vero. C’è lo smarrimento che si era sentito nei giorni del Bataclan, quando insieme a tutto il resto, si strutturò un senso di appartenenza europea che trovò nel volto di Valeria Solesin il suo manifesto più toccante. Come lei, le ragazze dell’Erasmus sono il segno di un Paese sano, che affronta con la forza della giovane età le sfide di un mondo sempre più complicato, in cui la competizione, i pericoli, i cattivi maestri sono sempre in agguato. Sorridevano tutte, nelle foto che ora ce le ricordano. E le loro famiglie sanno meglio di ogni altro quanto è costato costruire dei sorrisi così: ci vuole impegno, ci vuole fortuna, ci vuole di non mollare mai la presa quando tornano a casa la sera avvilite per le battute dei compagni o per un brutto voto o per una cosa che è andata storta e non vogliono dire cos’è. Perché la vita nelle famiglie italiane non è mai facile, i percorsi sono sempre a ostacoli, e la probabilità che un piccolo problema si trasformi in un grande problema è molto più elevata rispetto a quella che vede il problema risolversi. E forse, tra i sogni più pazientemente coltivati, c’è proprio quello di vedere i propri figli diventare europei, partecipare al grande gioco dello scambio tra i Paesi, sapere che si sanno muovere con disinvoltura tra lingue e culture, nella convinzione che questo renda migliori loro e noi. Ecco perché, ognuno a suo modo, nessuno si sente escluso dal dolore di una morte arrivata così. AVVENIRE Pag 1 Come in uno specchio di Marina Corradi Un vertiginoso dolore, e domande Erano le quattro del mattino e a bordo quasi tutti erano caduti addormentati, sfiniti di stanchezza, e anche dalla bellezza di quella notte a Valencia, illuminata dai fuochi d’artificio, colma di musica, e già pregna del primo alito della primavera. Si può immaginare una comitiva più felice di quella del bus di Tarragona? Vent’anni, la festa, le luci, gli amici, forse l’amore, in una notte di marzo sul Mediterraneo. E Valentina, Francesca e le altre undici, le pensiamo assopite, nel rombo monotono del motore del grosso autobus; strette fra loro, l’una con la testa su una spalla dell’altra. Come accade in gita, a scuola, fra ragazzi, quando la stanchezza ammutolisce le confidenze e le risate, e resta solo il respiro regolare del sonno sulle facce ancora quasi infantili. E d’improvviso l’autobus che sbanda, in un fragore orrendo di vetri infranti e di acciaio, e stridere di freni, mentre tutto che si capovolge: solo un istante per pensare a casa, ai genitori, in un rimpianto incredulo e infinito – e poi il buio. Sono morte così in tredici ragazze, sette italiane, le altre da tutta Europa. Studentesse, quasi tutte, di Erasmus, il programma che porta gli studenti all’estero, l’atteso e desiderato tuffo nel mondo da soli, da 'grandi'. Le foto delle vittime scorrono sulle tv nelle case, nei bar, e la gente zittisce e resta a guardare, commossa. Sono così belle Elisa, Elena e le altre. E che limpidi occhi ridenti ha Francesca, genovese, cattolica impegnata, studentessa di Medicina – che già era andata volontaria tra i poveri in Africa e in Romania. Era una scatola colma di speranza e voglia di vivere, quel grosso bus bianco e rosso che ansimava sulla strada del ritorno a Barcellona. Su delle ragazze addormentate dopo una festa, sui progetti e sulle attese, è piombata rapida una feroce ombra: in un attimo, solo per un colpo di sonno dell’autista, l’autobus, da bestione ubbidiente che era, si è ribellato, la cieca mole scagliata a tutta velocità oltre il guard rail. E ciò che turba noi che in tv guardiamo quei bei volti è che la morte, stavolta, abbia scelto il culmine della giovinezza, della bellezza e della gioia. L’istante traboccante di futuro e attese, la speranza intoccata dei vent’anni, in una notte di quasi primavera. Non osiamo pensare al dolore in quelle case, allo schianto di quel pugno abbattutosi su tredici porte. In un attimo, quei bei volti da cui ci si aspettava solo notizie liete – lauree, fidanzamenti, matrimoni, lavoro, figli – inghiottite nel buio. Non ci sono parole, ma solo preghiere: per quei padri, quei fratelli, e per quelle madri che ieri hanno avvertito in sé uno strappo lacerante di viscere, ben più doloroso del parto. Nel dolore per i begli occhi spenti di Elisa, Elena, Valentina e delle altre, dolore in cui ci riconosciamo in tanti – genitori, nonni, insegnanti, tutti coloro che guardano a dei ragazzi di vent’anni con affetto e speranza – ci ritroviamo davanti allo schiaffo della morte: che è ancora più secco, se chi muore è nel fiore degli anni, nel culmine della felicità. E come sempre, davanti alla morte restiamo inermi e atterriti. Noi non sappiamo, non possiamo immaginare perché tanto dolore, in un solo vertiginoso secondo, per tante famiglie, insieme. I giornali parla di un oscuro Caso, ma noi non possiamo chiamarlo così. Noi cristiani non crediamo al Caso ma un destino, al disegno, per ciascuno di noi, di un Dio che ci ama e ci conosce. Ci ama, e ci rapisce i figli in un momento, mentre dormono dopo una festa, come bambini? Sentiamo attorno e anche nel fondo di noi questa cocente domanda, questa ribellione. Ma la morte che in questa settimana celebriamo ci torna in mente e ci zittisce: di quale morte è morto Cristo, il primo dei figli di Dio, sulla Croce. Allora avvertiamo la densità grave di un mistero che non possiamo pretendere di capire. Quegli occhi ridenti, quei bei visi ci domandano di pregare per dei genitori affranti; ma, forse, e anche, più per noi che restiamo quaggiù, che per le ragazze morte a Tarragona. Loro partite fanciulle, loro che oggi, come promette Paolo ai Corinzi, vedono non più «come in uno specchio, oscuramente », ma, infine, faccia a faccia. Pag 2 Quelli che non sanno quello che fanno di Ferdinando Camon Salah e tutti gli altri pronti a dare la morte Salah è un eroe del Daesh? Nella strage di Parigi era uno dei più attivi, entrava e usciva col kalahsnikov dalle stanze dove s’eran nascoste le sue vittime: nel filmato che tutti abbiamo visto c’è una ragazza che entra curva in un bar, corre di qua e di là, cerca un nascondiglio, Salah arriva calmo e dritto con l’arma in mano, vede la donna, punta l’arma e preme il grilletto, la raffica non parte, l’arma s’è inceppata, forse (penso io) il sistema di caricamento, quello che solleva le cartucce dal caricatore (che nel kalahsnikov è curvo) e le porta in canna. Salah rinuncia a sparare e se ne va. La ragazza deve la vita a questo inceppo, che nel kalahsnikov è raro. In quella strage Salah ha fatto decine di vittime. Tutto il gruppo è stato deciso, audace, spietato. Sparavano e abbattevano. Il kalahsnikov è noto per la sua forza perforante: fora anche i nostri giubbetti antiproiettili. Salah è un perfetto guerriero? Per lui, veniva prima la missione, poi la vita? Credevamo di sì. Poi, a missione compiuta, l’ordine era di non farsi prendere, ma farsi esplodere. Salah aveva già la cintura esplosiva allacciata. Se tirava una cordicella, andava in frantumi. La cintura era piena di dinamite o simile, e biglie d’acciaio: farsela esplodere addosso era come farsi scoppiare in mano due-tre bombe a mano. Salah non si fece esplodere. Slacciò la cintura, e la buttò via. L’abbiamo ritrovata, intatta, ancora carica. Salah scappò, vivo, e si nascose. Salah è un vigliacco? Da allora abbiamo pensato che si nascondeva per non farsi prendere da noi, ma neanche dai miliziani del Daesh, che l’avrebbero immediatamente giustiziato per diserzione o tradimento. Appena catturato dalla polizia, Salah ha detto: «Dovevo farmi esplodere allo stadio, ma ci ho ripensato». Un kamikaze che parte per la missione non può ripensarci. I kamikaze delle Due Torri avevan ricevuto un giorno prima della missione un’istruzione, che li guidava minuto per minuto a mangiare, lavarsi, dormire, imbarcarsi e sfracellarsi senza pensare a nient’altro. Una specie d’ipnosi. Abbiamo quel libretto (ed. Quodlibet, 2001). Seguire quelle istruzioni vuol dire seguire Allah. Salah ci ha ripensato? Un dubbio etico, o paura? Adesso, nel covo di Salah, han trovato 'armi pesanti'. Una volta con 'armi pesanti' s’indicavano le armi di reparto, adesso indicano anche le armi individuali. Forse le armi pesanti di Salah sono i kalahsnikov. Vuol dire che in casa ne aveva più d’uno. Per un’altra strage? Voleva uccidere da capo? Qualche voce parla di una strage di 'bambini francesi'. In una strage di bambini non c’è valore militare, c’è soltanto crudeltà. Salah o chi per lui voleva dar prova di crudeltà, per sgomentare il nemico? Salah è un combattente quando si tratta di uccidere gli altri, un riluttante quando si tratta di uccidere se stesso? Questa audacia nel far morire e questa viltà nel morire si riscontra in tanti personaggi della storia. Guardiamo in casa nostra, e non pensiamo alla base, pensiamo ai vertici. Prima Guerra Mondiale, Cadorna. Seconda Guerra Mondiale, Mussolini. Avrebbero dato gli ordini che davano, se avessero dovuto eseguirli di persona? Mussolini ha fatto morire soldati in tutto il mondo, ma quand’è venuto il suo turno cercava di scappare, con un’uniforme straniera. Il Generalissimo sarebbe andato col petto nudo contro le mitragliatrici? Ci avrebbe mandato suo figlio? Lo so, sono i discorsi di Bertoldo. Ma Bertoldo non era stupido. Che cos’è la morte non lo capisci finché uccidi, lo capisci quando tocca a te morire. Finché non ti tocca, non lo sai. Di fronte a Salah che dà la morte agli altri ma non a se stesso, come ai nostri comandanti che mandavano i soldati a morire ma si tenevano in salvo, vale il detto evangelico: «Non sanno quello che fanno». Pag 12 Ecco la stepchild per sentenza di Angelo Picariello Utero in affitto in Canada, a Roma accolta richiesta del partner. La politica surrogata. Reazioni: “Scavalca il Parlamento” Roma. Ancora una sentenza 'innovativa' sulle adozioni. Un nuovo caso di stepchild adoption, 'stralciata' dal testo in discussione sulle unioni civili, ma di nuovo autorizzata dai magistrati. Stavolta si tratta - per la prima volta - di una coppia di uomini, due professionisti romani che nel giugno 2015 aveva fatto richiesta di adottare un bambino che vive con loro da circa 5 anni, nato in Canada attraverso la maternità surrogata. I due risultano sposati in Canada e subito dopo la nascita del bambino sono rimasti per qualche tempo nel Paese nordamericano con la madre “surrogata” e avrebbero mantenuto i contatti con la donna, recandosi spesso da lei col bambino. A firmare la sentenza, emessa il 31 dicembre scorso ed appena pubblicata, è stata la ormai ex presidente del Tribunale dei minori di Roma, Melita Cavallo, appena prima di andare in pensione. La coppia convive da 12 anni ed è stata considerata presente nella vita del bambino. Il giudice ha così ritenuto che la stepchild, l’adozione da parte del compagno del padre biologico, fosse nell’interesse del piccolo, facendola rientrare nei 'casi speciali' previsti dall’articolo 44 della legge 184 del 1983 sulle adozioni, superando un divieto, sancito dalla legge sulla 40 fecondazione assistita, per la maternità surrogata. Già in due precedenti occasioni il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’adozione a una coppia di donne. Ma entrambe le sentenze erano state appellate: la prima, risalente al luglio 2014, attende il vaglio della Cassazione, mentre per la seconda, dell’ottobre 2015, è previsto il secondo grado ad aprile. Mentre questa è definitiva, spiega la stessa presidente Cavallo «perché non è stata impugnata dalla Procura. Come sempre assicura - abbiamo privilegiato l’interesse superiore del bambino che nel caso specifico frequenta la scuola dell’infanzia in maniera del tutto serena». E assicura che la donna canadese «mantiene rapporti costanti sia con la coppia sia con lo stesso bambino che ha portato in grembo per 9 mesi». La maternità surrogata sarebbe stata a titolo gratuito. D’altronde lo stesso giudice Cavallo in una recente intervista - a sentenza già emessa ma non ancora pubblicata - aveva difeso la pratica, vietata in Italia dalla legge, «se è un dono. Se posso donare un rene per far sopravvivere una persona cara, dov’è lo scandalo di far nascere un bambino grazie all’utero di un’altra donna?», si era chiesta. Ma, come sostiene Alberto Gambino, docente di diritto privato all’Università europea di Roma, «non si può disgiungere l’idea di genitorialità da quella di responsabilità. È aberrante che una madre non si occupi del figlio che ha messo al mondo e il fatto che in questo caso, come risulta, se ne occupi almeno un po’ mi sembra un’ipocrisia volta a tentare di mitigare il giudizio su una pratica inaccettabile». Ma i dubbi sul piano giuridico sorgono anche per il riferimento della sentenza alle adozioni speciali che, spiega Gambino, «presuppongono che un genitore non via sia, mentre qui la madre c’è». Certo, gli anni di convivenza vanno tenuti in conto, ragiona Gambino, «ma tutto nasce dall’aggiramento del divieto per una pratica che tutti definiscono inaccettabile. Allora - conclude - il punto è rendere effettivo e ineludibile questo divieto, evitando che si crei una sorta di 'zona franca' attraverso la quale poi poter invocare lo stato di necessità». Roma. Sentenza creativa, frutto di un’iniziativa legislativa dannosa. Al contrario, la magistratura fa bene e supplisce a un vuoto legislativo. Il mondo politico si divide sulla decisione di ieri del Tribunale dei minori. E lo fa secondo i due fronti che si sono contrapposti nella discussione del ddl Cirinnà e nel dibattito sulle adozioni alle coppie dello stesso sesso. «La nostra magistratura continua a scavalcare il Parlamento in virtù di una interpretazione creativa che non tiene in nessun conto il dibattito che c’è nel Paese, anche in organismi così qualificati come il Comitato nazionale di Bioetica», sottolinea Paola Binetti (Udc). Ed è dal campo dei centristi e della destra che arrivano le stoccate più forti contro la sentenza. Il pronunciamento «dimostra quanto sia urgente approvare il nostro ddl che punisce la pratica della maternità surrogata anche se effettuata all’estero», afferma Valentina Castaldini, portavoce nazionale del Nuovo Centrodestra. Per Maurizio Sacconi il pronunciamento «legittima la pratica razzista e classista dell’utero in affitto» ed è «penoso» vedere ex marxisti convertiti al mercato sull’umano. Invita a una «battaglia comune» contro l’utero in affitto la forzista Elena Centemero, per la quale «non è accettabile mercificare la maternità e non lo è legittimare questa pratica, riconoscendola nei fatti con sentenze giudiziarie». Eugenia Roccella (Idea) ritiene che il ddl sulle unioni civili approvato in prima lettera al Senato «legittima definitivamente e promuove sentenze come questa». E, sottolinea, come fa anche il fondatore del movimento Gaetano Quagliariello, che nel dispositivo della norma siano presenti commi che avallano l’utero in affitto, che non è mai stato perseguito. Insomma, sarebbe in atto un meccanismo che porterà queste sentenze ad essere la regola. Posizione sostenuta anche dalla leghista Barbara Saltamartini. La sentenza «testimonia che si è giunti ad una legge giusta e corretta», il commento di Monica Cirinnà (Pd). Esulta l’Arcigay. «Questo ennesimo pronunciamento suona come un rimprovero al Parlamento», dice Gabriele Piazzoni, segretario nazionale. Ma per Fabio Rampelli (Fdi) tutto ciò dimostra solo che «l’Italia è diventato il Paese dell’arbitrio giudiziario». Mario Adinolfi, del Popolo della Famiglia, definisce «vergognosa» la decisione, anche per il metodo e la tempistica. Più che un trend ormai è un’abnorme prassi: anziché il Parlamento, le leggi vengono scritte (o riscritte) da sentenze, tanto che questa opzione viene contemplata come plausibile, e anzi probabile, nel dibattito in commissioni e aula. I magistrati prendono di fatto il posto dei legislatori eletti da noi cittadini, e certa giustizia soppianta la politica con la pretesa implicita di fagocitare un potere ritenuto incapace di decidere (o di decidere nel senso voluto da qualcuno...). Il Senato ha espunto la contestatissima 'stepchild adoption' dalla già discussa legge sulle unioni civili, ritenendo più che sospetto il possibile legame con l’aberrante pratica dell’utero in affitto? Il Tribunale dei minori di Roma ha già deciso che invece si può benissimo legalizzare l’adozione del figlio del partner dello stesso sesso nato all’estero da madre surrogata. L’opinione pubblica apprende che una pratica inaccettabile sotto ogni profilo, già vietata da una legge vigente, con un acceso dibattito globale in pieno svolgimento per sancirne il «bando universale», e che è stata oggetto di due bocciature consecutive da parte di istituzioni europee, viene ammessa per sentenza dallo stesso Stato che in Parlamento si chiede come fermarla nel modo più efficace. Serve altro per capire che ciascuno deve tornare nel proprio ruolo, smettendola di surrogarne un altro? LA NUOVA Pag 1 Quei ragazzi andati via sognando di Giorgio Boatti La morte probabilmente ha colto nel sonno le 13 ragazze dell’ultimo dei cinque pullman, affollati di studenti Erasmus di ogni Paese d’Europa, che stavano facendo ritorno a Barcellona dalla “Fiesta de las Fallas” di Valencia. Sull’autostrada era sorta da poco l’alba e un sole mediterraneo pareva dire addio all’inverno, salutare l’arrivo della primavera. Le famiglie e gli amici delle vittime di una casualità che, per ora, non ha scontate spiegazioni, possono nel loro dolore, essere certi di una cosa: che le ragazze che hanno amato se ne sono andate avendo tesaurizzato, nelle loro ultime ore, una sintesi di tutta la gioia, autentica e vitale, che la Spagna, e le sue feste tradizionali, sanno ancora regalare. I loro occhi, intanto che il bus macinava la strada del ritorno, forse si sono chiusi ricordando il ritmo delle musiche popolari appena sentite, portando con sé le coloratissime immagini delle centinaia di “fallas”, le gigantesche figure, ispirate alla cronaca, alla politica, al costume, che sfilano per la via di Valencia in occasione della festa di San Giuseppe. A vent’anni ci si sente invincibili e magnifici come non capiterà mai più nel corso della vita. Ci si sente, anzi si è, inquieti e potenti, curiosi di tutto e mai sazi di niente. Si è affamati di luoghi, di incontri, di musiche e colori, di pensieri nuovi e di orizzonti in continuo cambiamento. A vent’anni si scopre che il mondo è immenso e va esplorato a larghi passi, interrogandolo non solo con le domande suggerite dai libri e dagli adulti ma andando di persona a conoscerlo. Il progetto Erasmus, voluto dall’Unione Europea a partire dal 1987, è stata una delle realizzazioni più felici e importanti che il vecchio Continente abbia varato per andare incontro alle giovani generazioni. Ha infatti consentito a più di tre milioni di studenti europei - che prima hanno usufruito di Erasmus, poi, dal 2005, del progetto Erasmus/Socrates - di trascorrere sei mesi, o più, di studio e di soggiorno presso atenei di un altro Paese dell’Unione. In questo modo anche centinaia di migliaia di giovani italiani si sono misurati con una lingua diversa da quella natale, con altre culture ma, soprattutto, vivendo esperienze fondamentali per la propria maturazione esistenziale. Più che in altri Paesi europei Erasmus è stato inizialmente, per le famiglie italiane, un test difficile: permaneva, nel rapporto con i figli, quel legame, ansioso e possessivo, che li preferiva comunque vicini, radicati nei pressi di casa, nel timore che la loro lontananza diventasse distanza e li esponesse a quei rischi e a quelle incognite che, ora forse lo si è capito, nel mondo globale non si fermano certo alle frontiere. I rischi sono ovunque e possono capitare in ogni momento. Non c’è rifugio timoroso né stanzialità abbarbicata alla soglia di casa che possa proteggerci, padri o figli, vecchi o giovani, turisti per caso o studenti Erasmus, lavoratori in trasferta in Libia o ricercatori come Giulio Regeni in Egitto. La generazione Erasmus questo lo ha capito per prima e senza aver dovuto leggere quella poesia di Khalil Gibran - «voi siete l’arco/ dal quale come frecce vive/ i vostri figli sono lanciati in avanti...” - che noi genitori silenziosamente rammentiamo ogni volta che li accompagnano all’aeroporto. Quando loro, sicuri e fiduciosi, partono alla scoperta del mondo. E rispondono, con un sorriso, a quella stretta dolorosa che sentiamo nel cuore. Torna al sommario
Scarica