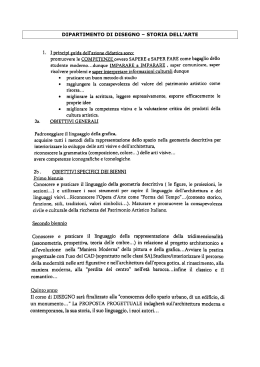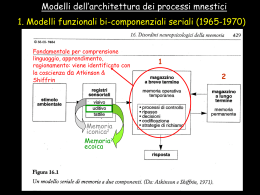Biblioteca 14 Edizione originale: Culture after Humanism Copyright © 2001, Iain Chambers Prima edizione: 2001, Routledge, London Copyright © 2003, Meltemi editore srl, Roma Traduzione di Nicola Nobili È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, non autorizzata. Meltemi editore via dell’Olmata, 30 - 00184 Roma tel. 064741063 - fax 064741407 [email protected] www.meltemieditore.it Iain Chambers Sulla soglia del mondo L’altrove dell’Occidente Introduzione e cura di Faranda MELTEMI Indice p. 7 15 Introduzione Capitolo primo Questione di storia Dalla nave ammiraglia La vulnerabilità dell’interpretazione Un’altra storia Dal passato Narrazioni interne Posizioni Il sublime della modernità Posizionalità storiche Al di là della rappresentazione I limiti della politica e la poetica dei limiti 65 Capitolo secondo Cornici terrestri La tecnologia è l’umanesimo Un’altra modernità 77 Capitolo terzo La storia, il Barocco e il giudizio degli angeli La facciata e l’ornamento La magia, la mortalità e la sfiducia della mimesi La malinconia e lo spazio coloniale Lo stile del tempo Suoni impronunciabili Casa 107 Capitolo quarto Voce nell’oscurità, mappa della memoria Potrei cominciare Citare il passato Pensare Potremmo considerare la musica Danza gitana sotto un albero La memoria, attorno alla quale Iscrivere la memoria nella musica 137 Capitolo quinto Architettura, amnesia e il ritorno all’arcaico “L’arte del vuoto” Impalcature invisibili, vite invisibili La volontà di architettare Lettere del tempo Il terreno sotto i nostri piedi La tecnologia e i limiti terrestri Sull’orlo della costruzione La tradizione del discontinuo 175 Capitolo sesto Estraneo in casa Il mistero della casa Il trauma della traduzione Antropologizzare l’antropologo La sfida dell’incompleto Estraniare l’Occidente 201 Capitolo settimo Sulla soglia Sull’orlo della cornice Possesso La casa del linguaggio Alla deriva La soglia del pensiero Lo spaesamento Esporsi Viaggio interrotto La casa in rovina Un luogo nel mondo 237 Bibliografia Introduzione Dunhuang, con le sue mele croccanti, la sua uva selvatica, le sue prugne profumate e i suoi meloni di oasi, è una polverosa città nel deserto, situata lungo l’antica Via della Seta, nella Cina occidentale. In apparenza, è un centro urbano periferico nel luogo in cui la Cina sfuma nell’Asia centrale e le campagne della pianura alluvionale cedono il passo alle dune di sabbia, dove la Grande Muraglia lascia il posto a fortezze solitarie abbandonate al vento. Dunhuang è uno dei crocevia storici del pianeta. Qui si incontrano il buddismo e l’islamismo, il kebab e i dim sum, in quella che sia Paul Gilroy che James Clifford descriverebbero come una “cultura del viaggio” che rivela quel che c’è di comune nelle diversità: qui tutto è plasmato e vissuto, in maniera pragmatica, nel substrato cangiante dell’appropriazione storica. Se il volo diretto della China Northwest Airlines da Ürümqi a Jedda, dal Turkestan cinese all’Arabia Saudita, fornisce un collegamento immediato che taglia il mondo islamico, questa è anche la regione in cui, durante il suo viaggio spirituale cominciato in India, passato per l’altopiano tibetano, e quindi proseguito per la Cina e giunto nell’arcipelago giapponese, il buddismo ha lasciato una testimonianza significativa. A partire dal terzo secolo dopo Cristo, e per più di mille anni di sviluppo ininterrotto, le grotte di Magao, a sud di Dunhuang, sono state certamente una delle gallerie d’arte di pittura parietale e scultura buddista più grandi del mondo. (Nonché il magazzino che ha conservato migliaia di manoscritti buddisti in sanscrito, tibetano e cinese, per lo più trafugati e ricomparsi a Londra e a Parigi all’inizio del ventesimo secolo). Qui, nelle diversificate tonalità di colore, di figurazione e di fisionomia del Budda, dei IAIN CHAMBERS suoi discepoli, dei racconti della sua vita e dei suoi insegnamenti, è possibile ricostruire in che modo le forme originariamente “occidentali” del subcontinente indiano si siano modificate e “cinesizzate”. Questo passato bastardo e questa incubazione ibrida tradiscono una versione assai più selvaggia e incerta della “Cina”, della sua gente, della sua lingua e della sua cultura, rispetto a quella divulgata ufficialmente. Qui c’è dell’altro, c’è di più, e questo di più mette in discussione il senso del passato, e pertanto anche il presente e il futuro. Quest’insolita “lezione” di storia, ovviamente, non è una peculiarità della Cina: essa mette in discussione tutte le forme ufficiali di identità nazionale e la modernità culturale che incoraggiano. Ciò nonostante, il “balzo della tigre” nel passato che propone Walter Benjamin contiene altresì la rivelazione di un altro futuro: un futuro che sfugge sia al controllo del presente, sia all’istituzionalizzazione del passato (Benjamin 1955, p. 84). Questa osservazione serve ad accompagnare l’ossessione del viaggiatore per “l’afrore di un leopardo delle nevi a quattromila metri” (Chatwin 1981, p. 20) con una narrazione ulteriore che attraversa, complica e collega il percorso turistico a una concezione più instabile e potenzialmente più aperta della modernità (Chatwin 1981). Rendere la modernità altrui problematica, plurale e porosa significa anche rendere meno tranquilla la propria modernità. Se è possibile caratterizzare l’epoca della modernità come l’epoca dell’umanesimo occidentale, di un mondo basato sulla continua conferma del soggetto che osserva, allora è anche legittimo considerare ciò che avviene all’autorità delle lingue critiche, della storiografia e dell’inclinazione occidentale alla conoscenza e al potere, alla luce della messa in discussione e della dispersione di quella particolare disposizione storica. Nelle pagine che seguono, questa è l’argomentazione principale che verrà sviluppata. Inizialmente si potrà discutere unicamente su quanto sia nuova questa procedura, dal momento che questa storia è già stata raccontata: la modernità ha sempre litigato con se stessa, e la sua superficiale affermazione del “progresso” è sempre stata accompagnata da una serie di eventi che parlano d’altro e hanno altra origine. È in questo contesto che il postmoderno, come ha ribadito ripetutamente Jean-François Lyotard, non segna la fine della moder- INTRODUZIONE nità, ma una relazione diversa con essa. In maniera più immediata e incisiva, gli studi postcoloniali hanno esteso il fermo invito alla cultura occidentale a rivisitare non soltanto la propria modalità di vita ma anche le proprie modalità di pensiero. In ballo c’è qualcosa di più della trasgressione o addirittura della revisione radicale del modo di intendere che abbiamo ricevuto in eredità: c’è qualcosa che arresta persistentemente la pulsione alla coerenza e rende tanto l’adattamento politico successivo, quanto quello culturale, più ardui, se non impossibili. Sbrogliando la matassa della modernità, non solo viene messa in discussione la sua struttura, ma i suoi fili pendenti ritornano per proporre uno schema diverso del tempo e del modo in cui lo occupiamo. Il modo in cui vengono trattate queste tematiche nei capitoli seguenti risente chiaramente dell’enfasi con cui Martin Heidegger asserisce che il recupero del senso dell’essere nel mondo non è riconducibile alla somma dei singoli individui. Essere al mondo non è mai un punto d’arrivo, non si ottiene mai il quadro completo, il verdetto conclusivo. C’è sempre qualcosa in più, che sfugge alla cornice che vorremmo imporre. A questo punto, il senso del mondo che abbiamo ricevuto in eredità, in cui il soggetto umano viene considerato sovrano, il linguaggio il mezzo trasparente del suo volere e la verità nient’altro che la rappresentazione del suo razionalismo, è soggetto a una revisione radicale. Ancora una volta, che cosa accade alla storia, alla cultura, alla soggettività e all’analisi critica, quando si comprende che i linguaggi che costituiscono queste formazioni e queste pratiche vanno al di là della volontà e del controllo comune? La questione si situa in uno spazio che, provocatoriamente, potremmo definire postumanesimo. Questa prospettiva non apre a un universo antiumano, né tantomeno annuncia la fine del soggetto, bensì, nel tentativo di spostare il rapporto egemonico, propone un soggetto che differisce, nonché una diversa etica della comprensione. Paradossalmente, criticare l’universalismo astratto dell’umanesimo occidentale significa gettare l’uomo nell’immediatezza culturale e storica di un’umanità differenziata e sempre incompleta. Se tutto ciò vuole attirare l’attenzione sul potere della cultura e sollevare una problematica di natura politica, vuole anche perorare la causa di una politica che vada al di là delle soluzioni stru- IAIN CHAMBERS mentali per toccare la ragione stessa del linguaggio e della narrazione. Qui il politico slitta inevitabilmente nell’ambiguo potenziale del linguaggio, nel viaggio delle sue estensioni poetiche. L’adozione di questa prospettiva, unita alla constatazione della natura inscindibile dell’etica e dell’estetica, ha fornito l’ossatura di questo libro. A questo punto, la proposta di una configurazione che acquisisca una forma dopo l’umanesimo tocca una corda più profonda allorché l’universalismo ricevuto in eredità viene collocato in un contesto storico e culturale preciso. Immanuel Kant nella Critica del giudizio (1790), nella celebre disquisizione sul bello e sul sublime, sostiene la necessità di una distanza critica e di uno sguardo disinteressato nell’appropriazione della bellezza, e la natura del sublime come subordinata al consenso universale della ragione. Quantunque il giudizio estetico, a differenza del giudizio teorico, non riesca ad affermare la propria validità sui concetti a priori, insistendo sull’universalità del gusto disinteressato della collettività umana rientra a far parte dell’ambito dell’oggettività universale. Questa razionalizzazione del sentimento assicura le fondamenta del giudizio critico e la continua autorità del soggetto. Nondimeno, se la ragione non è in grado di fornire che una pallida rappresentazione di ciò che esprime il sublime, allora la provocazione dell’inquietante immensità e dell’infinita informità alienano potenzialmente la ragione da se stessa. Quanto appena asserito concede un varco al passaggio della critica successiva dei limiti di una ragione incapace di percepire una conoscenza che la prevarica e mette in discussione la sua supremazia. Proprio questa indeterminazione, studiata successivamente dai romantici tedeschi ed esposta insistentemente da Friedrich Nietzsche, rappresenta una sfida alla sistematica disposizione della conoscenza in una totalità autoreferente e concettuale. In ultima istanza questa eredità, che, volenti o nolenti, è anche la nostra eredità, è il disfacimento dell’umanesimo come disposizione critica. Questa è la strada attraverso cui la conoscenza può ottenere la libertà di seguire altre direttive. La distanza disciplinare viene turbata da vicinanze inattese che trasformano la condizione dell’estetica, della poetica e dei linguaggi che esprimono il nostro potenziale. Ciò mi induce a vedere, sentire e avvertire nell’opera artistica un disturbo ininterrotto, una frattura nel tessuto di quanto INTRODUZIONE ci si attende. Nell’insistenza del linguaggio che rende l’ordine dell’ordinario straordinario, irriducibile a una razionalità finale, magico, persino sacro e forse divino, è implicata una sensazione di dislocazione affettiva. Perché andando al di là del significato prestabilito, l’opera d’arte rivela non tanto un “messaggio” distinto quanto un senso che, in definitiva, è un non-senso, il rifiuto dell’omologazione che apre la prospettiva sul vuoto e che oppone resistenza alla razionalizzazione, quel vuoto dove il significato immediato è fluttuante, sospeso, silente1 (Agamben 1970). In tale contesto, la dissoluzione dell’estetico e la mutilazione della distanza critica, rappresentano al contempo la dissoluzione del paradigma umanistico che ambedue hanno storicamente propagato. Oltre i confini della critica estetica si palesa un senso del bello che non è né sistematico, né definitivo. Scaturisce durante la veglia di quanto è accaduto, intesa sia come transito che come lutto (Buci-Glucksmann 1992, p. 16). Si tratta di un senso del bello palesemente postkantiano, dal momento che annuncia ciò che non può essere contenuto. Non si conferma alcun piacere razionalista, bensì si dichiara il confine, l’accenno del sublime, il brivido del mondo, l’incontro con l’angelico e lo straordinario; veniamo trasportati al di là di noi stessi nell’erotismo del tempo e nel senso di perdita che ne consegue, che si proclama come identità. Prendere congedo criticamente dalla storia del soggettivismo possessivo e dalla conoscenza che afferma se stessa non significa necessariamente abbandonare il “valore d’uso” e l’“umano” alla feticizzazione e all’alienazione della modernità (Carchia 1982, p. 61). Proporre una poetica dell’inquietudine non significa proporre un mezzo di comunicazione, ma sabotare quell’ordine e rivedere senza esitazioni le premesse del soggetto dell’operatività storica dell’umanesimo occidentale. Louis Althusser scriveva, nel 1963: “Tutto dipende quindi dal riconoscere la natura dell’umanesimo come ideologia” (Althusser 1965, p. 206). Considerare l’antiumanesimo alla luce dell’eredità di Marx, Nietzsche, Freud e Heidegger non significa, tuttavia, optare per la logica crudele delle strut1 In un breve scritto pubblicato nel 1970, e significativamente intitolato La cosa più inquietante, Giorgio Agamben mette alla prova la propria argomentazione, domandandosi se i tempi siano maturi per distruggere l’estetica e, di conseguenza, per riconoscere il vuoto che consente all’opera d’arte di emergere nel suo “divino terrore”. IAIN CHAMBERS ture impassibili e delle relazioni sociali caratterizzate da un grado di determinazione esasperato, ma restituire forza critica alla complessità di un mondo che non si può ricondurre a una visione omogenea o a un unico punto di vista (Elliot 1998)1. A questo punto, il poetico che canta della soglia e del non rappresentato investe il politico, e parla senza avere l’intenzione immediata di informare o di apportare necessariamente un beneficio al soggetto. Si tratta di un ritorno alla comprensione di tutta la complessità culturale che si avverte negli schemi, nelle tensioni e nelle tendenze prive di soluzione delle formazioni storiche. Per tornare brevemente alla Cina, laggiù si pratica la millenaria attività della calligrafia, affascinante osmosi tra scrittura e pittura, in cui la significazione sconfina dalla semantica immediata e penetra in un senso assai più ambiguo e più libero. A differenza della comprensione pragmatica della scrittura, la calligrafia non tenta di comunicare un’assenza, di rappresentare la “realtà”. Il ricorso ai caratteri dipinti rivolge l’attenzione sul mezzo stesso. La calligrafia, nelle sue diverse scuole e nei suoi diversi stili, non è semplicemente un mezzo per la comunicazione, che rappresenta qualcos’altro, bensì è un mezzo in se stesso; l’arte della scrittura, la scrittura come arte, una firma storica e culturale che finisce per rivelare molto più di qualsiasi messaggio intenzionale. Al di là della palese autorità culturale e politica della scrittura c’è l’affascinante nesso di uno stile dell’iscrizione che è anche sintomo di una sequenza di pensieri: pratica testuale, senso e direzione, che al contempo sono assoggettati al significato e lo superano (Connery 1998)2. Vorrei suggerire che anche lo stile e la lingua di questo libro si sforzano di ricondurre a questa possibilità. In un tempo e in uno spazio circoscritti, le pagine che seguono riguardano le implicazioni politiche e poetiche dei linguaggi in cui ci muoviamo e ci stabiliamo. Con ciò si vuole proporre che, a prescindere dalla comprensione strumentale che egemonizza la vita contempora1 Confermato anche dal filosofo francese in persona nei suoi ultimi lavori. Indubbiamente questo denuncia un certo orientalismo. Nella Cina imperiale la scrittura e l’interpretazione erano, soprattutto, un’attività regolamentata rigidamente, concepita per assicurare l’autorità centrale dello Stato. Nondimeno, se i caratteri grafici “non erano semplicemente indicatori trasparenti del contenuto”, allora gli stili dell’iscrizione tradiscono in una qualche misura qualcosa di più della semplice autorità del testo approvato. 2 INTRODUZIONE nea, nelle sue implicazioni e nella sua potenzialità più profonde la realtà ha inizio e si conchiude nella casa del linguaggio. In ultima istanza è nella nostra vita materiale, storica, culturale e psichica che risiediamo, riconosciamo e riconsideriamo noi stessi. È alla luce di questa modalità di vita che i seguenti capitoli prendono in considerazione gli studi culturali, geografici, architettonici e storici tenendo un occhio fisso sulla loro potenziale rivalutazione e ristrutturazione. Capitolo primo Questione di storia La conoscenza, vista come processo di transizione, non ha fondamenta, soltanto una struttura nel tempo. (Bhaskar 1975, p. 189) Dalla nave ammiraglia Golfo di Napoli, 1799. Nei primi mesi dell’anno una rivolta ha portato alla presa del potere da parte dell’intellighenzia liberale del luogo e all’abbandono della città da parte della monarchia borbonica. La movimentata esistenza del nuovo Stato si protrasse per appena cinque mesi, prima di essere schiacciata dalla milizia contadina del cardinale Ruffo, aiutata e spalleggiata dal sostegno navale di Horatio Nelson e della flotta britannica. Molti dei capi della rivolta furono giustiziati pubblicamente in piazza del Mercato: decapitazione per gli aristocratici, impiccagione per i borghesi. Direttamente ispirata dalla Rivoluzione francese, ancora oggi la breve Repubblica del 1799 viene vissuta da molti napoletani come una ferita aperta che stilla sangue sulla formazione della città contemporanea. Secondo questa visione del passato, il “1799” rappresenta un momento perduto, e la storia successiva è la testimonianza della brutale negazione delle sue possibilità. Si ritiene che questa spiegazione storica e storicista rievochi un evento singolare, l’unica Repubblica indipendente nella storia moderna dell’Italia, che distingue la storia di Napoli da quella del resto della penisola. Al di là dei confini di un’idealizzazione spesso stucchevole, emerge nondimeno l’importante analogia tra il 1799 e, per esempio, il 1999, allorché si iscrive un fatto storico specifico in un quadro della modernità occidentale di più ampio respiro. Forse la maniera di apprezzare tale analogia non è racchiusa tanto nell’ennesima analisi del 1799 come un evento storico irripetibile, quanto nel dare ascolto alle domande che scaturiscono da quel particolare momento: domande che mettono in di- IAIN CHAMBERS scussione la concezione e la rappresentazione definitive sia dell’allora che dell’adesso. Potrei cominciare da una scena semplice, tratta da un’opera della scrittrice e critica americana Susan Sontag, L’amante del vulcano (1992). Una nave da guerra britannica è ancorata nel Golfo di Napoli, da cui si gode di una vista della città dal mare. Dalla nave parte l’ordine di sopprimere l’imberbe Repubblica. A bordo si trovano Nelson, Sir William e Lady Hamilton. Sir William è un amante del Vesuvio, nonché uno dei padri della neonata scienza chiamata vulcanologia e un membro della Royal Society. Nelson, l’amante di Lady Hamilton, è l’ammiraglio della flotta inviata da Londra per dar manforte al fronte del Mediterraneo contro la Francia. L’anno precedente aveva annientato la flotta francese nelle acque egiziane nella battaglia di Abukir. Nel frattempo, la Francia repubblicana stava per trasformarsi nell’Impero napoleonico. Anche la rivolta napoletana e la conseguente proclamazione della Repubblica fanno parte di questa storia. Questo sguardo telescopico induce a inserire la storia locale di Napoli in una prospettiva europea, o anche globale, e mi stimola a considerare gli eventi del 1799 in una luce diversa. Per esempio, qui Napoli si ritrova inserita in una cronologia di rivolte e rivoluzioni moderne. Questa particolare narrazione ha inizio nel 1776, con la rivolta delle colonie del Nord America contro la Gran Bretagna, che a sua volta ha fornito l’ispirazione per l’evento più famoso: la Rivoluzione francese del 1789. Tuttavia, la più lunga e sanguinaria di tutte le rivolte fu quella dei “giacobini neri”, gli schiavi di Santo Domingo capitanati da Toussaint L’Ouverture e influenzati direttamente dagli eventi francesi. Al termine di tredici anni di lotte contro britannici, spagnoli e, soprattutto, francesi, la rivolta si risolse con la proclamazione della prima Repubblica nera di Haiti, nel 1804. L’anno prima della fondazione della Repubblica Napoletana, l’alleanza cattolico-protestante degli “irlandesi uniti” di Wolfe Tone si era battuta per l’indipendenza dell’Irlanda, prima che la rivolta fosse sedata nel sangue. Nell’arco dei successivi vent’anni l’intera America Latina fu scossa da una serie di rivolte con cui le colonie ottennero, violentemente, la secessione dalla Corona spagnola. Nelle diverse forme di contestazione dei poteri autoritari, centralizzati e non rappresentativi (sovente a tutela di interessi e oligarchie locali), è stato possibile, col senno QUESTIONE DI STORIA di poi, identificare il passaggio verso una modernità caratterizzata dalla diseguale acquisizione della politica di massa, della democrazia di massa e della cultura di massa (Anderson 1983). Per tornare al Golfo di Napoli e alla nave di Nelson, questa nave da guerra, come tutte quelle della marina britannica, il cui equipaggio era composto per il trenta per cento da marinai di colore, aveva i ponti verniciati di rosso per mascherare il sangue dei caduti sul campo. Questa nave, questa flotta, rappresentavano il pragmatismo brutale di un imperialismo per il quale il Mediterraneo, analogamente ai Caraibi, all’Atlantico, all’oceano Indiano e all’Australia, di recente colonizzazione, non era che un tassello nell’economia politica globale. La questione che si pone è: questa prospettiva rappresenta solamente una panoramica di Napoli inquadrata da una nave da guerra britannica e imposta dal Ministero degli Esteri di Londra, oppure consente il profilarsi di una prospettiva di più ampio respiro? Mi permetto di osservare che, analogamente alla presenza di un progetto giapponese che al momento domina il profilo architettonico di Napoli, la visuale che giunge da altrove offre, a prescindere dal verdetto finale, un punto di vista che interrompe il consenso ufficiale di un’immagine locale. Traducendo la storia della Repubblica Napoletana in un planisfero meno provinciale e più mondano, gli eventi rappresentati dai cinque mesi di vita della Repubblica acquistano una risonanza etica più ampia e si inseriscono in una contestualizzazione storica e politica più vasta. Inquadrata da un orizzonte più ampio, la presenza della Francia in questa particolare storia, al di là della forza simbolica del 1789 e della presenza e dell’aiuto concreti dei soldati francesi nei primi giorni della fondazione della Repubblica, rivela una serie di questioni e di condizioni tanto difficili da spiegare quanto la presenza della flotta britannica nel Golfo di Napoli alcuni mesi più tardi. La titubanza del Direttorio di Parigi nel riconoscere la Repubblica Napoletana, come la sua analoga riluttanza ad accettare l’istanza di abolizione della schiavitù nell’isola più ricca del suo impero coloniale (Santo Domingo), evidenzia una politica dettata più dalle necessità politiche ed economiche del centro metropolitano, che dalle richieste delle libertà locali. In quest’ottica emerge una Napoli che ha la duplice funzione di oggetto di interessi europei superiori e di particolare città europea risucchiata nella ragnatela di questioni maggiori, di portata globale. IAIN CHAMBERS Una delle catene principali, per quanto in gran parte non rilevabile dalla popolazione, che ancorava la natura locale specifica di Napoli al resto del mondo in questo periodo storico era un sistema coloniale basato sul lavoro degli schiavi neri importati dall’Africa alle Americhe. Il riconoscimento della centralità di quel tipo di economia rispetto alla formazione culturale e politica della modernità richiama l’attenzione su storie subalterne raccontate da altri punti di vista. In questo caso, sull’“Atlantico nero”, come propone in maniera eloquente l’importante studio di Paul Gilroy (1993a). Riportando il discorso alla città da cui siamo partiti, e restringendolo alla gastronomia, il caffè, la cioccolata, i pomodori, il peperoncino, le patate e lo zucchero sono tutti prodotti e sapori che hanno visto uno sviluppo sulla scia dell’espansione coloniale, alimentata dalla medesima economia politica che forniva la base per la rivendicazione di nuovi diritti politici. Le “scoperte” del Nuovo Mondo aprirono anche la porta al nuovo mondo delle esigenze politiche postfeudali, che raggiunsero l’apice con avvenimenti come la guerra civile inglese, la Rivoluzione francese e la Repubblica Napoletana. Proprio a questo sviluppo paradossale si riferiva Jaurès quando ribadiva che le basi economiche della Rivoluzione francese sono state la schiavitù e la tratta degli schiavi: “I patrimoni creati a Bordeaux, a Nantes, dal traffico negriero permisero alla borghesia di rivendicare il bisogno di libertà e di emancipazione umana” (citato in James 1980, p. 50). La modernità occidentale, che la si evincesse dalla Londra georgiana o dalla Napoli borbonica, faceva parte di questo quadro comune. Sfruttare una narrazione fittizia per affrontare la questione della Repubblica Napoletana, e quindi espandere la storia su ulteriori dimensioni, potrebbe sembrare un’appropriazione non ortodossa (illegittima? sovversiva?) degli eventi storici. Tuttavia, al di là del gioco retorico dei diversi punti di vista, un approccio di questo tipo è fondamentalmente legato alla ricerca di una contestualizzazione del senso contemporaneo della “conoscenza” e della “verità”. Nella narrazione storica, nel racconto del passato, vengo spinto a osservare, come insiste Paul Ricoeur, che il “senso” non deriva dai “fatti” nudi e crudi e dagli “eventi” isolati, bensì è un qualcosa che scaturisce dalla temporaneità della narrazione, dal racconto del tempo (Ricoeur 1983-84-85). Pertanto, dove e come si situano la distinzione della narrazione del “1799” QUESTIONE DI STORIA proposta nella rappresentazione storica a opera di Benedetto Croce e l’attenta ricerca esposta con grande dovizia di dettagli storici in L’amante del vulcano?1. Su che basi poggiano queste distinzioni? Raccontando il mondo, da dove si traggono i protocolli? Nella costellazione di narrazioni che circondano il “1799”, sospese nella scrittura, nel linguaggio della rappresentazione, dove finisce la finzione e dove comincia la “realtà”? Se anche fosse possibile ritornare nel passato e confrontare i “fatti”, quella realtà dovrebbe sempre essere trasmessa mediante la logica e i linguaggi della rappresentazione: documenti pubblici, diari privati, dati statistici, la testimonianza del costume e delle arti, tutti elementi che richiedono una certa rielaborazione per essere leggibili in una struttura organizzata dalla scrittura. Eccoci giunti alla soglia del dibattito in cui tropi di storiografia, come ha coerentemente asserito Hayden White (1985), diventano oggetti di analisi a pieno titolo. Mettere in discussione la disciplina della storiografia sottintende una ricontestualizzazione del linguaggio, il quale viene trasferito dalla condizione astratta di “verità”, garantita da una neutrale “scientificità” dei “fatti”, a una posizione in cui il linguaggio stesso assurge al ruolo di fattore di significato temporaneo. La storiografia stessa si fa storia. A questo punto, e dato il valore simbolico che ha il 1799 per la storia e la cultura della Napoli di oggi, forse il modo migliore per onorare il sacrificio di chi ha perso la vita nel nome della rivoluzione non sta tanto nella narrazione di eroi e vittime, quanto nell’elaborazione di un lutto che apre le porte a uno spazio vitale nei linguaggi che rappresentano sia quel momento storico, sia ciò che noi siamo oggi. In quest’ottica, è possibile vivere il ritorno al e del 1799 come un interrogativo che tormenta e mette in discussione il nostro modo di usare, interpretare e costruire il passato. Allorché un’insurrezione, una rivoluzione, entra a far parte della storia ufficiale di una città, di una cultura, è quasi ineluttabilmente autorizzata ad assumere il ruolo di narrazione del passato che contribuisce alla conservazione della contestualizzazione 1 Oppure, per restare più vicini a dove risiedo attualmente, nella ricostruzione letteraria operata da Enzo Striano (1979) della vita di Eleonora Pimentel de Fonseca, una delle “martiri” del 1799. IAIN CHAMBERS egemonica del presente. Il tradimento della costellazione storica del 1799 può essere letto nell’ottica di questo uso e abuso. Focalizzata in una specificità storico-culturale ristretta, la luce che potrebbe gettare la Repubblica Napoletana sulla condizione attuale della città risulta di fatto oscurata. Per far sì che emerga una diversa storia della Repubblica, la storia di una città europea inserita in un complesso scenario mondiale, e quindi una storia provvista di risonanze politiche, storiche ed etiche prossime al mondo contemporaneo, diventa necessario disfare e riscrivere la versione ufficiale. A questo scopo è necessario avanzare una critica della cultura che ha costruito e conservato quella particolare storia. A questo punto, prima di addentrarsi in un qualche tentativo di fornire una spiegazione socio-storica e culturale della particolare formazione della società napoleonica, occorre riflettere sulla struttura istituzionale della “conoscenza” “scientifica” e storiografica, la quale, come ribadisce Michel Foucault, è sempre una struttura di potere, mediante cui si è consolidata e diffusa quella particolare maniera di rappresentare il “1799”. La vulnerabilità dell’interpretazione Nel caso di Napoli ciò significa fare i conti con un approccio alla storia che si identifica con le premesse (l’ideologia?) dello storicismo. Ripensare il tempo e lo spazio di Napoli vuol dire divellere lo storicismo che ha dettato la cultura e la storia della città, nonché aprire quella “storia” alla distinzione tra la chiusa consolazione di quanto già determinato e la vulnerabilità di una storia soggetta ad altre modalità di narrazione. Se lo storicismo racconta la continuità dei vincitori, forti della comprensione omogenea del tempo e della conoscenza, una storia critica, aperta e vulnerabile potrebbe, invece, essere concepita come narrazione, racconto, sospesa tra l’inclusione e l’esclusione, tra la rappresentazione e la repressione, e nella quale non arriva mai la parola conclusiva. Sarebbe una storia al di là della grandiosa macchinazione del destino storico. Sarebbe ugualmente una storia non riducibile alla rappresentazione empirista e alla tirannia discorsiva di un realismo per così dire oggettivo. Non si tratterebbe di una storia del passato “com’è stato davvero”, bensì di una storia del presente intrisa QUESTIONE DI STORIA degli interrogativi del passato, un confronto e una configurazione reciproci, in cui tanto il passato quanto il presente divengono luoghi di transito temporaneo, di traduzione culturale e di indagine etica. Ciò vorrebbe dire abbandonare l’utopistico compito di una narrazione neutrale o “obiettiva” del passato a favore dell’ancor più imperativa assunzione della responsabilità del computo del tempo, recando testimonianza delle generazioni passate in un linguaggio aperto al giudizio in qualsiasi condizione (Lévinas 1961). Chiaramente, questo non ha: nulla in comune con la posizione autoevanescente dello storicista, il quale immagina davvero di potersi astrarre dalle condizioni della propria esistenza e che, di conseguenza, si trasforma egli stesso in una pallida ombra. Per Benjamin, così come per Nietzsche, questa obiettività egoista è a tutti gli effetti “empatia” con il “vincitore”. Lo storicismo è quindi ben lungi dall’essere disinteressato, ma gli interessi che rappresenta sono lungi dai propri. L’enucleazione “metodologica” del presente, accoppiata all’opposta esaltazione del presente come la sola e unica autorità, l’unico giudice superstite del passato, rappresenta la contraddizione di fondo dello storicismo (Wolfarth 1998, p. 23). Se l’empirismo offre l’autorità incontestabile di fatti e artefatti, lo storicismo assicura una coerenza che non può essere messa in discussione, basandosi essa su una retorica dimentica della tematica ontologica del linguaggio e delle instabili coordinate della narrazione. Dove ha inizio il racconto? In che modo, perché, e per chi? Dove si conclude? Come osserva Hans Kellner (1997), “l’ipotesi secondo cui il passato è in qualche modo continuo è di natura letteraria” (p. 129). Se l’empirismo ricorre alla fattualità priva di mediazione del mondo, lo storicismo si appella alla struttura eterna di una dimensione temporale unica che avanza dal passato verso il futuro. Per entrambi la verità storica non sta nei linguaggi che ci permettono di sentirci come appartenenti alla nostra realtà e con cui diamo un senso al mondo, ma altrove, nei “fatti” e nella “verità” rivelati dalla ragione. In particolare, per lo storicismo la coerenza intellettuale è assicurata dal continuum in cui la storia e la ragione si rispecchiano reciprocamente, assumendo carattere di indivisibilità e unicità. In quest’ottica lo storico non è tanto colui che fa ritorno al passato per rivisitarlo, rappre- IAIN CHAMBERS sentarlo e riscriverlo, quanto il custode dell’archivio della conoscenza umana in perenne espansione. Questo archivio rimane stabile nella sua forma, sostanzialmente immutabile nelle sue fondamenta. Questa visione del passato è destinata a non produrre altro che “vittime”: tutto trova spiegazione nel dispiegarsi del processo storico stesso. Il lessico tecnico lo definisce teleologia, mentre in parole povere lo si denomina “destino”. Proprio in questa luce, come annunciava Walter Benjamin negli anni Trenta, prima dell’ascesa trionfale del fascismo, lo storicismo si immedesima nella versione del passato proposta, nonché imposta, dai vincitori (Benjamin 1955a). È possibile incrociare, costruire e contestare questo tempo storico sia per mezzo del linguaggio che nel linguaggio; il fatto che sia possibile apprenderlo e interpretarlo soltanto nell’ambito del passaggio culturale, che precede e supera tutti gli appelli alla stabilità del significato, getta una sfida inconfutabile. Forse, invece di limitarsi a testimoniare il ricordo ufficiale della Repubblica Napoletana come se si trattasse di un evento conchiuso, morto e sepolto con la sua sconfitta, sarebbe il caso di cercare di estrapolare dall’evento storico e critico le energie per piegare e rielaborare il presente al fine di mettere in discussione un destino apparentemente imposto dalla “storia”. Ciò vorrebbe dire vedere negli eventi del 1799, nei suoi dettagli e nella sua complessità, non la battuta di arresto di un processo che avrebbe dovuto aprire la strada che avrebbe portato la città direttamente verso la modernità e la realizzazione del “progresso”, bensì un segnale assai più inquietante: Napoli come allegoria della precarietà della modernità. Allora la città, da luogo in cui una determinata continuità viene riaffermata e celebrata in un’identità folcloristica, verrebbe ad assumere i connotati di luogo inquietante dove è costantemente aperta la questione irrisolta della modernità del mondo. Ciò significa concepire il mondo in cui vivo come un prodotto del tempo. Pensare al tempo, e al mio essere in questo tempo chiamato modernità, equivale a prendere in considerazione le categorie che rendono comprensibile questo passaggio terreno. Nondimeno, prendere in considerazione queste categorie vuol dire anche registrare la volubile contestualizzazione del tempo, apprezzare la costruzione culturale di come viene rappresentato il tempo: i linguaggi e i limiti di ciò che normalmente definiamo storia. Se tutto QUESTIONE DI STORIA ciò che trapassa è destinato a far parte della storia, è ugualmente vero che la storia non registra tutto ciò che passa. La storia del tempo è anche la storia del tempo. Concezioni differenti della temporalità, nonché contestualizzazioni differenti dell’organizzazione sociale e semantica, si sono ritrovate storicamente sottomesse alla modernità occidentale. Ecco che la rappresentazione del passato viene subordinata alla protervia del progresso. Che sia concepito direttamente, in termini di causa ed effetto, oppure negli sviluppi contraddittori del dinamismo dialettico, si presume che il tempo storico riveli un fine teleologico. Ma da dove originano questo particolare tempo e questa particolare definizione? È possibile concepire il tempo come fosse il trasmettitore omogeneo dei nostri desideri e delle nostre azioni? Il tempo risponde solamente all’imperativo lineare, a un’identità pubblica astratta che non muore mai1. Sembra impossibile fornire delle risposte a queste speculazioni metafisiche, fintanto che non ci sovviene la premessa fondamentale, ossia che il tempo, questa cosa di cui registriamo istintivamente il passaggio in un battito cardiaco, nelle rughe sul volto, e in ciò che viene custodito ufficialmente in monumenti, musei e archivi istituzionali, viene sempre percepito, trasmesso e compreso nei linguaggi, cioè la formazione culturale e storica da cui deriviamo e in cui diamo un senso alla nostra esistenza. Questa storia non è situata al di fuori di ognuno di noi, come se fosse un oggetto indipendente da studiare e spiegare, bensì è una storia in cui ciascuno di noi viene in-corporato, “espresso” e articolato. Noi non facciamo la storia secondo modalità che scegliamo liberamente, come giustamente ci ricorda Karl Marx. La storia stessa deriva dall’atto di incorporazione che forse è possibile comprendere meglio come atto di interpretazione. In un’intervista televisiva rilasciata nel 1969, Martin Heidegger commentò la celebre insistenza di Marx sulle Tesi di Feuerbach secondo cui la filosofia ha interpretato il mondo soltanto quando c’era da trasformarlo rendendo suggestivamente prossima l’apparente contrapposizione tra trasformazione e interpretazione. La trasforma1 Come afferma Heidegger (1927), è il “tempo di nessuno”, il tempo anonimo di “quelli” che non muoiono mai, poiché, non essendo toccati dalla morte individuale, c’è sempre tempo. IAIN CHAMBERS zione del mondo, a suo dire, presuppone un cambiamento nella rappresentazione del mondo che dipende dall’interpretazione1. A ciò è possibile aggiungere le parole dette da Salman Rushdie (1991, p. 18) in tempi più recenti: “è dunque chiaro che quello di ridescrivere un mondo è il primo passo necessario a trasformarlo”. La denuncia di Marx contiene un annuncio critico, filosofico. La storia è un atto di interpretazione che si presenta nella sua forma naturale. Il realismo, in quanto modalità privilegiata della narrazione storica, rafforza ed espande questa inclinazione fino a quando i limiti della disamina storica si sovrappongono ai limiti del mondo. Dalla presunta divisione tra narrazioni immaginarie e realistiche del mondo scaturiscono le moderne discipline denominate “letteratura” e “storia” (Anderson 1983), le quali sono tuttavia intrinsecamente legate alla matrice soggiacente che pone un freno alle pretese epistemologiche della “storia” di poter spiegare “che cosa è successo”. Entrambe le discipline producono resoconti del mondo nel mondo. Entrambe trovano sostegno e verifica nel linguaggio, dove per linguaggio non si intende semplicemente il supporto tecnico della linguistica e della cultura della carta stampata, bensì il nutrimento ontologico del senso. Questa storia, che viene considerata la pietra angolare su cui poggia la spiegazione, di cui la letteratura è l’ornamento immaginario, è essa stessa una forma di narrazione, un’articolazione sociale, che parla della storia di una particolare formazione culturale. Un’altra storia Eppure, questo tipo di conoscenza del passato, nonché del presente, data l’egemonia di cui gode al momento, e malgrado i tentativi subalterni di contrastarla, non si può cancellare con un colpo di spugna. È tuttavia possibile riconoscerne i limiti, ciò che la “storia” istituzionale stessa rappresenta e reprime, e inscriverli in ulteriori e contrastanti contestualizzazioni del tempo. Ciò vor1 Martin Heidegger in una conversazione con Richard Wisser, trasmessa il 24 settembre 1969 dalla ZDF e pubblicata da Günther Neske ed Emil Kettering (1988). In questa sede mi riferisco all’edizione italiana. QUESTIONE DI STORIA rebbe dire sottrarre la modernità alla tirannia di una razionalità onnipotente e all’universalismo di un punto di vista unico e lineare, al fine di impostarne i termini, i linguaggi, le comprensioni e i desideri su un terreno più aperto, e quindi spostarsi in un mondo che non si può ricondurre alla sua identità (Wellmer 1993). Nel lutto di una modernità positivista e sicura di sé, ciò che emerge non è l’espressione di dolore per aver perso la certezza, quanto la necessità di seppellire i morti per poter “investire nuovamente il mondo e il sé di significato simbolico” (Wheeler 1998). Si tratta di un lutto che si attesta in una costellazione culturale e politica che presta attenzione alla mortalità e alla modestia, ai limiti. Non significa abbandonare il sogno, abbandonare l’utopia, bensì trasformarla in un’azione contemporanea, ossia in un’etica che va di pari passo con la contestualizzazione storica incerta in cui parla e che le permette di parlare. Ma che cos’è, esattamente, questa contestualizzazione? Da dove sbuca, e a che esigenze fa fronte? Per cominciare a fornire una risposta al quesito è inevitabile riconoscere una distinzione di luogo culturale e storico che dipende sempre più da una struttura globale non sufficientemente riconosciuta, la quale è in evoluzione fin dall’alba della modernità occidentale, cinque secoli fa. Nelle reciproche complessità dell’occidentalizzazione del mondo e nella mondializzazione dell’Occidente, ogni singolo evento reca testimonianza della sua particolare collocazione nel mondo, nonché della maniera in cui è stato rappresentato e… represso. Pertanto, parlando da un certo luogo, la voce che testimonia di un passato e di un presente particolari risuona vieppiù nei canali dell’amplificazione globale. Tuttavia, ciò non significa semplicemente gettare una particolare storia o posizione nella cacofonia pluralistica delle voci più disparate che tentano di raccontare una storia. Si tratta, invece, di ritoccare il senso della narrazione, la testimonianza del tempo, della vita, contro i poteri strutturali che ci incasellano in maniera diversa e diseguale. Il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, pubblicato nel 1997 riferisce di un 18 per cento della popolazione mondiale (circa 800 milioni di persone) che possiede l’83 per cento della ricchezza, mentre l’82 per cento (circa cinque miliardi di persone) amministra il 17 per cento della ricchezza. La stessa pubblicazione indica che sarebbe possibile sradicare la povertà estrema IAIN CHAMBERS spendendo ogni anno meno del patrimonio dei sette uomini più ricchi del pianeta. Negli Stati Uniti, l’uno per cento della popolazione possiede il 40 per cento della ricchezza, un altro 20 per cento possiede un’ulteriore fetta pari al 40 per cento della ricchezza, mentre al restante 79 per cento rimane il 20 per cento. Si prevede che entro il 2010 nello Stato della California un bambino su quattro sarà affetto di malnutrizione («La Repubblica», 19/8/1999)1. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti detengono il 25 per cento dell’intera popolazione carceraria mondiale2. Queste statistiche descrivono un quadro profondamente antidemocratico delle risorse politiche e delle responsabilità della vita quotidiana, che nel “Primo” mondo trovano, emblematicamente, massima espressione negli Stati Uniti, dove il ricorso alla legge e all’indiscussa predominanza della Costituzione, “un piano di governo redatto da un gruppo di mercanti e schiavisti all’alba dell’era moderna”, ha immancabilmente la priorità sulla giustizia e sul processo democratico (Lazare 1998)3. A Bulawayo, un disinvolto ragazzone nero con un variopinto telefonino Motorola Star TacTM allacciato alla cintura attraversa la strada al semaforo, avanzando tra le macchine. Eppure il Sud del mondo, con quella sua instabile commistione di segnali globali e realtà locale, rimane il Sud del mondo. Gli investimenti, il tenore e le prospettive di vita rimangono così radicalmente diverse che nemmeno il brusio delle statistiche è in grado di mettere a tacere la tragedia che incarnano. Nello Zimbabwe, la speranza media di vita è scesa di trent’anni con la comparsa del virus dell’HIV. Nessun volo delle compagnie aeree statunitensi raggiunge alcuna città africana, comprese il Cairo e Johannesburg. In un continente in cui il potere pare dipendere più dal clientelismo che non dal profitto o dallo sviluppo, in termini economici parlare di un’Africa in relazione neocoloniale con l’Occidente ha poco senso, dal mo1 Per ulteriori informazioni si consulti il sito: www.undp.org/poverty/publications. Per ulteriori informazioni sul crescente impoverimento della maggior parte della popolazione degli Stati Uniti nel contesto di un’economia in crescita, si veda Blau 1999. 3 Come asserisce convincentemente Lazare, limitare il governo a un sistema di controlli e bilanciamenti significa altresì limitare la democrazia e lo “sviluppo della coerente regola della maggioranza”. La politica istituzionale viene a essere limitata agli interessi di gruppi e lobby che dispongono dei mezzi economici e sociali per rendersi visibili, e quindi “politici”. Ne risulta ciò che Lazare definisce un “regime controdemocratico”. 2 QUESTIONE DI STORIA mento che nel 1990 controllava solamente l’1,9 per cento del commercio mondiale (ne gestiva il 5,2 per cento nel 1950), e i ritorni degli investimenti nel continente sono calati dal 30,7 per cento negli anni Sessanta al 2,5 per cento negli anni Ottanta. Si tratta di uno scenario caratterizzato da una mancanza quasi totale di investimenti, in cui l’investimento esterno, privato, commerciale ammontava ad appena 504 milioni di dollari nel 1992, “ossia all’1,6 per cento degli investimenti totali di Africa, Asia, America Centrale e Meridionale messe assieme”. Nel 1992 il prodotto interno lordo (PIL) dell’intera Africa sub-sahariana, pari a 270 miliardi di dollari, era inferiore a quello dei Paesi Bassi. L’Africa sub-sahariana comprende il Sudafrica. Per dirla in maniera spicciola, “il continente sta scivolando fuori dal Terzo Mondo, per finire nella sua desolata categoria dell’ennesimo mondo”1. In questa parte del mondo si concentra un 60 per cento della popolazione che non ha mai fatto una telefonata. Come ci ricorda Zillah Eisenstein (1998), ci sono più linee telefoniche a Manhattan che in tutta l’Africa sub-sahariana. Nel computo globale, un continente, l’Africa, si è semplicemente disperso. La Banca Mondiale prevedeva che entro l’anno 2000 sarebbe stato necessario importare un terzo di tutti gli alimenti necessari. Tra il 1961 e il 1995, la produzione alimentare pro capite dell’Africa ha registrato un calo dell’11,6 per cento (contrariamente a quella dell’America Latina, che è aumentata del 31,4 per cento, e dell’Asia, salita del 70,6 per cento). In questo scenario, lo Stato costituisce una struttura “neopatrimoniale” in cui il problema principale non è lo sviluppo, quanto rimanere al potere: L’obiettivo principale è rimanere al potere. Occorre che l’esercito sia soddisfatto, che alle masse urbane sia dato da mangiare, che gli interessi conflittuali delle coalizioni politiche vengano bilanciati. Per questo fine, ogni aspetto dell’economia diviene uno strumento di protezione. Quote, tariffe, sussidi, licenze di importazione, la valuta 1 Tutte le cifre e le citazioni sono tratte da Gifford 1998. Al pessimismo di considerare che apparentemente un continente “si sia perso” occorre ribattere con la consapevolezza di una situazione storica ben precisa, la quale “semplicemente non vuole riconoscere i suoi debiti nei confronti dell’Africa” (Reader 1998, p. 4). Come se il passato e il futuro dell’Africa non fossero anche i nostri, come insegnano i postcolonialisti e i globalisti. IAIN CHAMBERS sovrastimata e così via assurgono al ruolo di canali di arricchimento, mediante l’attività di ricerca dell’affitto. I privilegi dell’élite dipendono dal monopolio del potere nell’ambito della società, non dalla produttività della società nel suo insieme, molto meno dalla sensazione di benessere che permea la popolazione in generale. Almeno a breve termine, un efficiente programma di sviluppo economico contrasta con questa situazione. Le esigenze economiche e politiche del potere personale seguono la propria logica. La mala gestione trova effettivamente un suo fondamento logico nel sistema neopatrimoniale (Gifford 1998, p. 13). Anche questo rientra nel cuore della complessa eredità storica e della contestualizzazione contemporanea della modernità. Non si tratta di un’idiosincrasia periferica, bensì di una componente strutturale di quella storia, di quella modernità. Dal passato In questa prospettiva, com’è possibile raccontare il passato, o i passati? Certamente la coerenza delle narrazioni consolidate non può essere eguagliata da una coerenza alternativa. Dopo tutto, proprio il senso della coerenza, che porta alla natura conclusiva della finitezza razionale, è il problema: una finitezza che, come la prospettiva che ha per centro il soggetto, in ultima analisi è infinita nelle proprie pretese. Forse il cliché barocco delle “rovine” trova collocazione più consona in questo contesto. L’edificio fondato dalla storiografia occidentale non viene spazzato via, persiste e sopravvive, ma ora viene assillato da una serie di interrogativi; la sua struttura viene frantumata da un movimento culturale imprevisto e scossa dalla presenza di nuovi abitanti storici cui precedentemente non si prestava attenzione. La storia che scaturisce da questo edificio non offre più la rivelazione di un destino astratto, né corrisponde perfettamente all’articolazione di strutture socioeconomiche verificabili: adesso ospita una temporalità più sregolata creata dalla produzione sociale di una posizione nel tempo. Tutto questo per parlare di una modernità multipla in cui il passato e il presente si congiungono e interrogano scambievolmente, perché in un’affiliazione con-temporanea di questo tipo il senso del presente e il “progresso” che vi si associa si ritrovano a essere in de- QUESTIONE DI STORIA bito nei confronti delle questioni irrisolte che vengono loro incontro dal passato. Quindi il passato irrompe nel presente non soltanto per annunciare l’altro lato della modernità, quello represso, ma anche per piantare le radici di un turbamento più sregolato. La modernità non diviene semplicemente più complessa a causa dell’aggiunta di quanto non era stato riconosciuto, risulta irrimediabilmente disfatta da tematiche che non è più in grado di contenere. L’arcaico, dato come perso nella nebbia dei tempi, fa la sua comparsa nel bel mezzo della modernità, apportando un senso diverso, una diversa direzione. Sorprendentemente, si ripropone l’assenza, la “perdita” del mondo del passato rispetto al quale il presente misura il proprio “progresso”, per tormentare la modernità. La sicurezza razionale affronta un fantasma che reca testimonianza del ritorno dell’economia, apparentemente senza tempo, dell’“arcaico” e del “primitivo”: “un brusio di parole svanite non appena enunciate, perse dunque per sempre” (de Certeau 1975, p. 223). Questo perché le potenti tracce di questi linguaggi perduti, le diverse contestualizzazioni culturali del tempo e dello spazio (pitture rupestri preistoriche in Sud Africa e Zimbabwe, città precolombiane nelle giungle e nei deserti delle Americhe, le vie dei canti tra gli arbusti australiani, vessilli delle preghiere nei passi montani asiatici) possono scardinare a forza il presente per interrogare la sua conoscenza che tutto abbraccia. È possibile che l’“esotico” turistico riferisca, inaspettatamente, un testamento più profondo quando l’assenza del significato immediato è in grado di aprire uno squarcio nel tempo. Al turbamento provocato dall’idea di formazioni culturali stabili situate nell’epoca mitica delle società “primitive” si contrappongono le prove dell’Africa australe e del Nord America (per non parlare delle prove di ininterrotte migrazioni in Oceania e Asia): spazi storici attraversati dalle migrazioni, dai movimenti e dagli spostamenti delle pretese territoriali e dei confini, tanto prima quanto dopo il “primo contatto” con gli europei. La pressione della Confederazione degli Irochesi dalla costa orientale ai Grandi Laghi si estese alle praterie orientali, spingendo così verso ovest altre nazioni, tra cui i Sioux e i Lakota. Ottocento anni fa parte del gruppo linguistico Athabasca uscì dal Canada nordoccidentale e penetrò in quelli che oggi sono gli Stati Uniti sudoccidentali; du- IAIN CHAMBERS rante questo processo divennero Navaho e Apache. Nell’Africa meridionale, all’inizio del diciannovesimo secolo, ebbe luogo il movimento degli Ndebele che passarono dal Natal nello Zimbabwe meridionale (probabilmente a causa dello schiavismo sulle coste del Mozambico), esercitando una pressione militare e territoriale sugli Shona e sui San di quella zona, prima che i coloni angloboeri usurpassero direttamente quel territorio. La terra come punto di origine mitico, come costante orizzonte dell’identità e testimonianza della tradizione non è mai, malgrado le apparenze, senza tempo. Viene coltivata dal linguaggio e, se trasformata dal mito in un riferimento costante, non è esente da una nuova iscrizione, una nuova narrazione (Ranger 1996)1. Si insiste sulla natura storica dell’“arcaico”, introducendo una temporalità che turba le asserzioni occidentali unilaterali del “progresso” e della sua storiografia, ma che, nondimeno, rimane una temporalità che registra l’entità storica e la trasformazione culturale in termini propri. È possibile che il mantenimento della distanza temporale e culturale, sia per mezzo della razionalità strumentale che della sicurezza trascendentale dello storicismo, venga messo in crisi, e non solo dalle prove storiche, ma anche dalle tracce contemporanee dell’arcaico, annunciato nel passaggio umano inciso su una parete di roccia, in una narrazione geroglifica il cui mistero e la cui magia resistono agli imperativi della teleologia e alla trasparenza strumentale (Garlake 1995). In presenza di un altro linguaggio, e delle forme di conoscenza a esso relative, scaturisce un dinamismo insospettato che devia la netta distinzione tra l’universo verosimilmente naturale e statico del “primitivo” dal movimento culturale perenne del “moderno”. Una linearità logocentrica che insiste sul passaggio dal preistorico allo storico, dalla natura alla cultura, dall’oralità alla scrittura, si dissolve in qualcosa di meno rassicurante (Carchia 1982, p. 177). Questo perché se la scrittura penetra nell’arcaico, distruggendo tutte le illusioni di ripristinare il mondo “così com’era”, l’arcaico si ripropone per assumere altresì il ruolo di esempio contempora1 Il medesimo autore analizza altresì la stratificazione multipla delle culture e dei poteri, che risulta nella mutabilità del paesaggio e nel passaggio storico della prospettiva, in Ranger 1999. QUESTIONE DI STORIA neo della scrittura che tenta di rappresentarla e circo-scriverla. Il mondo “così com’era” è perduto per sempre, non resta altro che le vestigia della rappresentazione. Ciò nondimeno, questi residui non sono oggetti morti in attesa di essere classificati e spiegati secondo una logica universale, bensì interrogativi vitali che perseguitano la mia comprensione con altre storie, con gli altri. L’arcaico, come ad esempio tenta di suggerire il cinema di Pier Paolo Pasolini, non è un mero e tranquillo ritorno a un tempo antecedente al mio, bensì è una presenza inquietante che propone una nuova configurazione del mio presente (Page 1998). Scene di questo tipo non rappresentano “l’esotismo” della modernità, quanto i suoi interrogativi, le sue interruzioni: un invito a riconcettualizzare e riconstestualizzare la modernità stessa. In Edipo Re (1967), la Grecia mitologica e il nord Africa contemporaneo sono periferie temporanee, culturali, fisiche e psichiche che Pasolini raffigura come inquietantemente vicine. D’un tratto, l’“aborigeno”, il “nativo” e il “primitivo” diventano contemporanei, fanno parte della modernità che strutturalmente li esclude1. Quanto appena detto equivale ad attingere da altri ordini di senso (arcaico, mitico, inconscio, poetico), al fine di riscrivere il mondo, ambientare le storie in un ritmo differente e cercare di rendere il mondano magico (Page 1998). Insistere sull’arcaico come narrazione strategica che interroga le supposizioni, le razionalizzazioni, le repressioni e le negazioni della modernità non significa cercare di recuperare un’innocenza perduta, quanto piuttosto proporre una ricerca critica su come narrare, come rivestire di erotico la realtà. Contro questa possibilità, la spazializzazione della conoscenza tenta di fissare la distinzione tra centro e periferia, ovvero, la prospettiva tra soggetto e oggetto. In questo modo è possibile realizzare un piano controllato su cui la narrazione successiva può spiegarsi in una continua riaffermazione del narratore. Distanziandosi in siffatta maniera è possibile riconoscere l’altro sempre e soltanto in termini di soggetto: 1 Per ulteriori osservazioni sulla rappresentazione della componente “aborigena” della modernità, si veda Jebb, a cura, 1996. IAIN CHAMBERS Una parte del mondo che sembrava interamente altro è ricondotta allo stesso attraverso l’effetto di sfalsamento che disloca la diversità per farne un’esteriorità dietro cui si può riconoscere un’interiorità, l’unica definizione dell’uomo (de Certeau 1975, p. 235, corsivo nell’originale). Narrazioni interne In questo contesto la scrittura, con la sua organizzazione della conoscenza e della comprensione, viene a essere ri-posizionata nel più ampio settore delle iscrizioni grafiche, in cui la cristallina logica dell’utilità mimetica, la trasmissione lineare di un “messaggio” chiaro e coerente, viene scavalcata e classificata nelle tracce, nella ricerca di stati del mondo eterogenei. Il desiderio della simmetria e della successiva fissazione della distanza tra il moderno e l’arcaico, tra l’osservatore occidentale e gli “oggetti” della sua disciplina e del settore di ricerca, inaspettatamente viene ricondotto a una vicinanza condivisa. L’arcaico ritorna come presenza asimmetrica che mette in discussione il trionfo apparente del monoteismo e la separazione del mondo spirituale da quello materiale, della cultura dalla natura, del razionalismo dalle altre forme della ragione. Proprio questo spazio, lo spazio della non identità, ci attira altrove. Come il taglio orizzontale, la spaccatura terrestre che squarcia l’intensità monocroma di una tela di Mark Rothko, qualche “cosa” incede nella bellezza del nulla. Una prospettiva di questo tipo, non più incentrata sul soggetto, bensì inter-mondiale, potrebbe, usando le parole dell’artista indiano Anish Kapoor, “portare all’espressione (…) e quindi a dirigersi verso un’esistenza poetica” (Kapoor, citato in Bhabha 1998, p. 11). Questa è l’idea di Kapoor di “narrazione interna”, di ciò che è insito nel materiale, ciò che può essere estratto da quanto è già dato, depositato e disseminato, che qui può rivelarsi stimolante, poiché il materiale è ciò che insiste e che attende una forma, è ciò che ci viene incontro e ci interroga. È ciò che, essendo inquadrato, ci invita a considerare il processo stesso di inquadramento che costituisce la prospettiva del senso, la conoscenza e l’affetto, ma che al contempo, attirando l’attenzione sull’azione d’inquadramento, accentua e riconosce i limiti di quei registri. Ci QUESTIONE DI STORIA troviamo a parlare di ciò che apre l’intervallo e la tensione tra materiale terrestre e il particolare mondo e i linguaggi che incorniciano e registrano quell’intervallo, ciò che ci spinge contro il quadro che, nel divenire, rende possibile l’impossibile: è in questo che il poetico acquisisce il proprio potenziale. Per citare il titolo di un’opera dello stesso Anish Kapoor, un disco gigantesco, rosso sangue, cavo, che pende dal soffitto, si tratta di ritrovarsi “al confine del mondo”. Giungere fino a questo punto, e indagare sulle possibilità di un senso della “verità” storica assai meno saldo, sfonda i confini esistenti della rappresentazione istituzionale e minaccia di recidere il cordone ombelicale che tradizionalmente tiene legate le umanità al continuum di un fondamento logico storico e umanistico. L’imposizione della storia, trasportata al di là della concezione storicista ed empirista, è ciò che registra con maggiore precisione i limiti temporali e ontologici dell’iniziativa umanista. Esiste una costellazione congiunturale, particolarmente evidente nella terminologia della postmodernità e del postcolonialismo, che annuncia bruscamente, quantunque sovente in maniera superficiale, questo sganciamento dalla formazione umanista. Ciò che occorre, in questo passaggio, fissare altrove non è il senso di cancellazione, bensì il senso di rielaborazione: relazioni di potere, discriminazione, disuguaglianza, sfruttamento e repressione nelle loro manifestazioni di classe, coloniali, sessiste e razziali permangono in una contestualizzazione differente ma continua del mondo. L’attenzione verso gli interrogativi disseminati dalle forme interculturali che circolano nel mondo, che trattano degli scambi tra storie, tradizioni, letterature e oralità, induce a puntare i riflettori sulla collocazione mutevole della traduzione storica e culturale. In questa zona di confine avviluppata dalle nebbie balugina la possibilità di una conoscenza di frontiera. Questa conoscenza evoca una concezione geopolitica della posizione, nonché, e in maniera più immediata, una trasformazione nella relazione con le discipline esistenti e le figure istituzionalizzate della comprensione. Ecco che si insinua un linguaggio critico che ricava la propria etica dalle esperienze, dalle pratiche e dalle proposte del subalterno. Può essere questa la conoscenza dell’“altro” (non si tratta di un accademico ventriloquio che parla a nome del subalterno, riconfermando così le egemonie già esistenti), ma un’“altra” cono- IAIN CHAMBERS scenza che irrita, turba e alla fine sovverte la precedente disposizione della conoscenza e del potere (Saldívar 1997). Ciò significa fare ritorno alla voce dell’Occidente, assuefatta al riconoscimento universale, alla sua posizione repressa e profondamente disturbata nella storia. Posizioni Giunti a questo punto, è possibile traslare questo “ritorno” in una sintassi più immediata osservando, per esempio, chi e che cosa sia un intellettuale postcoloniale? Pur riconoscendo e prendendo atto dell’impossibilità di fornire una risposta chiara e lampante a questa domanda, nondimeno è possibile osservare lo spazio, nonché i successivi luoghi in cui si delinea il predetto quesito. Questo particolare spazio è certamente istituzionale, ma è anche significativamente storico, geopolitico e ontologico. Personalmente, chi scrive è interessato a riconoscere in queste coordinate una precisa posizionalità che modula la sua successiva risposta alla domanda fatta dal “postcoloniale”. Pertanto, i commenti riportati qui di seguito non vogliono parlare in nome dello spazio o dell’astrazione teorica, bensì in termini di una particolare posizione in cui il discorso nominato dal postcoloniale viene pronunciato e rappresentato. Nei meandri e nelle sottigliezze del dibattito, il postcoloniale, in quanto voce critica, lessico intellettuale e pratica istituzionale, è certamente anche indice, sintomo di modificazione storica. Chiaramente non si tratta di alterazione omogenea, né nella sua presenza, né nei suoi effetti. Come termine che deliberatamente tenta di ricontestualizzare il corpus della conoscenza e delle comprensioni anteriori (quel “post”, infatti, non è un segnale cronologico puro e semplice, bensì è anche di natura epistemologica), il “postcoloniale” fa appello a un incontro storico e teorico in cui a tutti è posto l’invito a ri-vedere e ri-considerare le proprie posizioni terrene e differenziate nell’articolazione e nella gestione del giudizio storico e delle definizioni culturali. Ecco che il postcoloniale si presenta come spazio teorico e politico che consente di scavare a fondo nella conoscenza occidentale, intesa sia come disposizione di discipline che come specifica disposizione storica della verità. QUESTIONE DI STORIA Se il postcoloniale si pone in stretta relazione con una rivisitazione critica delle precise storie e della scomparsa del colonialismo, in particolare la sua narrazione subalterna, repressa e sovversiva, esso propone altresì, implicitamente, una critica fondamentale delle istituzioni, dei linguaggi e delle discipline che storicamente hanno organizzato, definito e spiegato il “coloniale”, ovverosia la conoscenza, scientifica quanto umanistica, avviluppata nella “storia” che la modernità occidentale ha raccontato a se stessa. Si tratta della storia che ha modellato la mia “casa”, consentendomi di parlare, ed è a partire da quella storia che tento di rispondere e acquisire responsabilità. Essendo io nato (per quanto l’insistenza di Heidegger sullo stato involontario dell’essere “gettato” nel mondo sia forse più consona a un senso storico dell’essere sfumato) nel cuore della “terra verde e piacevole” di Blake1, in me il postcoloniale ispira una duplice sensazione, perché esso sposta questioni apparentemente marginali, ancorate all’inamovibile tempo della schiavitù, della conquista coloniale, dell’imperialismo e del razionalismo del razzismo, verso la costituzione del meridiano, mentre al contempo riposiziona quel centro su un’altra carta geografica assai meno provinciale. La questione dell’“altro” (l’ex schiavo, la minoranza, i diseredati, gli emigranti) assume il ruolo di controversia della formazione storica del mio “sé”. Il passato scivola dalle flebili lusinghe di un silenzioso ripostiglio a un insistente interrogativo del presente. Sebbene questo riposizionamento radicale non possa affatto garantire l’assenza del narcisismo intellettuale (sia gli europei bianchi che quelli del “Terzo” mondo lucrano sulla ri-proposizione di se stessi e del loro patrimonio culturale sotto i riflettori della nuova luce critica), se perseguito con insistenza porta a conseguenze irreversibili per la comprensione storica e culturale. Il postcoloniale effettua un’incisione nel corpus esistente della conoscenza, e più precisamente nel sapere umanistico; pertanto, impone altresì un’interruzione nell’apparente ineluttabilità del “progresso” storico. Alla teleologia del tempo storico della modernità, al dispiegarsi lineare dello sviluppo e alla sostituzione del 1 Espressione tratta dalla poesia di William Blake intitolata Milton, pubblicata originariamente nel 1804 (N.d.T.). IAIN CHAMBERS primitivo con la perfezione del futuro si sostituisce una spirale di ritorni trasversali che innestano il passato nel presente, l’arcaico nell’avanguardia. In questa interruzione inattesa, la narrazione storica non è semplicemente costretta ad amplificare le proprie conoscenze, bensì le viene richiesto anche di riconsiderare la propria struttura, i propri stimoli e i propri desideri. Ciò equivale a spezzare la linearità della spiegazione e riportare la modernità alla fase iniziale che aveva segnato l’inizio di uno scenario mondiale, nel Quattrocento. Ritornare alla violenta appropriazione, colonizzazione, imperializzazione europea e alla successiva ibridazione del resto del mondo vorrebbe dire invertire le tendenze critiche prevalenti che vedono nella globalizzazione semplicemente la più recente (nonché ineluttabile) manifestazione della precedente storia economica. Vorrebbe dire che la globalizzazione non riguarda solo l’accaparramento del potere delle multinazionali e del capitale, ma anche, e in maniera più significativa, la più estesa cartografia ontologica che trasformi il mondo in identità e interesse occidentale in ogni ramo dell’attività storica. È questa particolare struttura storica che si tradisce nel presunto universalismo del suo umanesimo e delle tecnologie del sé. In questa prospettiva, la dimensione postcoloniale è forse più facile da comprendere come luogo sovradeterminato in cui sia chi era colonizzatore che chi era colonizzato è stato colonizzato fisicamente e psichicamente. Qui forse è necessario congedare la “storia” stessa per uscire dagli schemi che ognuno di noi ha ricevuto in eredità e quindi per ritagliarsi lo spazio necessario a riacquistare la possibilità di muoversi (McLean 1998). La storia non è solo parziale, è anche partigiana. Riconoscere e registrare il tempo e lo spazio, la voce, il corpo, l’intento cosciente e inconscio, significa essere più, non meno, storico. Raccontare il passato con questa disposizione più flessibile può richiedere di leggere meno “storia” e di ascoltare più musica, di dedicarsi ai romanzi anziché alla statistica, al fine di de-centrare la comprensione “realista” (e le sue fondamenta epistemologiche nella presunta trasparenza del linguaggio e della ragione) cui fanno appello numerose storie. Qui la spirale del linguaggio (in quanto testimonianza, evocazione e letteratura) interrompe la linearità che divora il tempo in nome del progresso. Qui la storia ritorna non in veste di “fatto”, bensì di sopravvivenza. Questo ricorso storico apre QUESTIONE DI STORIA alla tensione tra la storia e la narrativa, tra la scrittura e l’oralità o, per dirla con Michel de Certeau, tra l’oggettivo e l’immaginario, tra il positivismo e la poetica. È la trasgressione di questa frontiera che sottolinea i limiti dell’oggettivo e delle strutture che oggettivano. Qui emerge la controforza di “atlanti eclettici”, in cui ciò che sfugge allo sguardo oggettivante e alla sua struttura classificatoria della visione diviene un sito produttivo di comprensione1. Più in là, emerge l’autorità astratta dell’io razionalizzante che differenzia e rivela le biografie individuali e collettive di ciò che è e diviene nel mondo. Insistendo sui limiti della rappresentazione storica, il mio obiettivo non è soltanto di attirare l’attenzione su una pluralità potenziale e sull’eterogeneità dei “punti di vista”, bensì quello di stabilire i termini ontologici più radicali del non visto e del non visibile, di ciò che permane in un particolare spazio e tempo al di fuori dell’ambito del riconoscimento e della rappresentazione istituzionali: di ciò che rimane come punto di interruzione, come limite, dimensione sconosciuta e interrogativo potenziale. Non rientra in questi confini che il postcoloniale si manifesti come problematica che interessa contemporaneamente i passati colonizzatori e colonizzati. Come perturbazione critica la cui eco risuona in vari luoghi, fornisce un senso di connessione e distinzione contemporanee. Suggerendo legami tra mondi precedentemente separati da una distanza intellettuale, storica, politica e fisica, l’affermazione postcoloniale rende contemporaneamente immediati l’ineffabile e l’incommensurabile: ciò che in precedenza era stato represso, estromesso dall’equazione, o più semplicemente passato sotto silenzio. Certamente il concetto del postcoloniale è stato coniato a vantaggio dell’Occidente. Qui, verosimilmente, stanno la sua genesi, il suo credito istituzionale e il suo apparente beneficio, come affermano molti dei suoi critici. Tuttavia, nell’idea del beneficio è implicito anche il significato di profitto diretto, nonché il guadagno più ambiguo che emerge da un tipo di comprensione 1 Mi sono appropriato dei concetti di mappe eclettiche dall’architetto Stefano Boeri. Queste mappe tentano di suggerire una visuale obliqua che rivela che la geometria bidimensionale (e la sua successiva estensione nella grafica tridimensionale al computer) non è in grado di “vedere”. IAIN CHAMBERS che non termina necessariamente acquisendo autoconferma. Laddove detta autoconferma comincia a vacillare e perdono consistenza le premesse soggiacenti dell’egocentrismo, quello è esattamente il punto in cui non è più possibile spostare o evitare la tenacia dell’alterità. In relazione alla diversità e all’alterità, inevitabilmente proiettate e prodotte dal soggetto che distingue se stesso/a dall’altro/a, inaspettatamente mi scontro anche con l’inquietante corpo del cyborg: l’hardware e il software tecnologici che sovente ci estraniano da noi stessi. Questa divagazione tecnologica apre effettivamente un sentiero nella formazione storica della conoscenza e della cultura, qui orbitanti attorno alle pratiche della “scienza”, che porta altresì alla complessiva dislocazione dell’épisteme occidentale nello stesso campo di forza emesso dal postcoloniale. Sia per il colonizzato che per il cyborg, sono inquietanti sintomi della metafisica della modernità. Qual è esattamente la relazione, per non parlare della prossimità, tra il corpo di chi in passato (e talvolta ancora oggi) è stato colonizzato e il cyborg? Entrambi sono corpi costruiti e gestiti da poteri che li hanno resi oggetti di studio e di ricerca, ma anche, e contemporaneamente, oggetti di controllo, sfruttamento e disciplina. Entrambi nascono apparentemente dal nulla: il corpo colonizzato da una storia e un luogo negati, il cyborg dall’inanimato, dal non umano. Nondimeno, questi corpi hanno acquisito anche la facoltà di rispondere, e di rispondere nei linguaggi che in precedenza li relegavano a posizioni subordinate. L’oggetto si rivela come soggetto storico. I miei linguaggi fanno ritorno nel corpo dell’altro, rendendo il mio senso di identità irritante, vulnerabile, aperto agli interrogativi che giungono da altrove. Sono costretto a rispondere. Inoltre, nominare la relazione tra il corpo colonizzato e il corpo integralmente costruito e colonizzato dalla tecnologia, ovvero il cyborg, vuole dire altresì introdurre il concetto del sublime, di ciò che mi attira e al contempo mi minaccia: in questo particolare caso, si tratta del sublime razziale e tecnologico, cioè un desiderio, pur negato, che fa parte della mia stessa identità. Questo inquietante incontro con l’alterità, sia sotto forma di corpo extraeuropeo storico e culturale che sotto forma di corpo non naturale, la macchina e le relative tecnologie, ha sempre accompagnato lo sviluppo della modernità occidentale e i concetti QUESTIONE DI STORIA del sé. Storicamente, e non solo in Occidente, la costruzione dell’“io”, in quanto individuo sessuale, etnico, storico, culturale e nazionalizzato, è avvenuta attraverso la presenza, sia reale che immaginata, di un altro, che ha immancabilmente vestito i panni alieni della mostruosità. L’indebolimento di questa relazione, il rifiuto dell’altro di rispecchiare me e le mie ossessioni, conduce a una crisi nel senso precedente del mio sé. La vicinanza dell’altro a me, raggiunta per mezzo delle forze economiche e politiche della modernità e dell’annullamento delle distanze a opera della tecnologia (dalla nave a vela all’aeroplano alla tecnologia digitale e alla robotica), apre alla critica e al criticismo quella precedente disposizione culturale, con il suo fermo senso di distanza razziale, sessuale, geopolitica e strumentale e la conseguente assicurazione di un’identità separata. Tuttavia, intendo altresì proporre qualcosa che sfugge, o forse si libera, dal semplice dualismo, dalla dicotomia tra centro e periferia, tra egemonia e subalternità, tra me e l’altro. Le osservazioni sulle differenze etniche, storiche e culturali che compongono e interrogano il mondo d’oggi avvengono in un contesto caratterizzato da un mutamento perenne. È un contesto in cui le supposizioni della stabilità apparentemente antropologica dell’identità etnica e razziale, dell’identità del sesso, dell’identità dell’umano stesso, vengono viste e vissute in maniera assai meno sicura. Come ha ripetuto con vigore Frantz Fanon (1991, p. 202) – “Non sono prigioniero della Storia. Non devo cercarvi il senso del mio destino” – si tratta di indebolire, persino sconfessare queste ancore dell’identità nel passaggio critico oltre i confini delle strutture egemoniche del potere/sapere occidentale e dell’affermazione automatica delle lotte storiche che vi si contrappongono. Ecco che l’identità, da sereno porto d’arrivo, diviene il punto di partenza per un viaggio privo di garanzie1. Avventurarsi al di là dell’assolutismo dell’identità (tutti sappiamo chi siamo, non è vero?) vuol dire varcare una serie di frontiere, le più ovvie delle quali sono quelle dell’Illuminismo e dell’Umanesimo europeo, e penetrare in un’etnografia in cui l’“uomo” 1 Questo punto viene espresso nella maniera più eloquente nelle pagine conclusive di Said 1994. IAIN CHAMBERS della conoscenza, lo scienziato, il soggetto, diventano l’oggetto di un discorso, di una storia, di un mondo, di uno spazio ontologico che si interroga ed è interrogato. È implicito l’abbandono di un senso del sé fisso che, nella sua pretesa universalità, espone un punto di vista unilaterale. Come rileva Rey Chow, un siffatto umanesimo ha storicamente e ontologicamente una propria specificità razziale e geopolitica e, come hanno ribadito alcuni, ha trovato la sua completa realizzazione nella razionalizzazione del terrore e del genocidio programmatico dell’altro (Chow 1998). Dobbiamo allora procedere criticando tanto questi assolutismi quanto le loro controparti? Che succede alla presunta autonomia di una “diversità” assoluta, allorché essa finalmente si trova ad affrontare “la fine dell’innocente concetto del soggetto nero essenziale”, già annunciata nel 1988 da Stuart Hall? Qui l’idea di razza, di identità, persino l’idea di umano e del corpo come fondamento della verità vengono messe a confronto per consentire la fuga dalla camicia di forza di un particolare “tempo” storico, verso una maniera diversa di essere nel tempo. Tornare all’osservazione dei poteri scritti sul corpo – costruito conformemente alle leggi e alle logiche razziali, sessuali, scientifiche e tecnologiche – ci spinge a ripensare questi meccanismi non come strutture astratte, bensì come formazioni culturali, come contestualizzazioni storiche, come iscrizioni sociali e psichiche. Oggi la costellazione storica che rivela una siffatta situazione viene apparentemente inquadrata dai processi differenziati della globalizzazione. Eppure la globalizzazione, la tendenza a trattare la storia, la cultura e, soprattutto, l’economia politica come sistema mondiale, ha inizio con la modernità stessa. La possibilità di ricondurre il mondo a un punto di vista solo e unico, e da lì gestirne l’economia, la politica, la storia e la cultura è stata, se non creata, quantomeno vittoriosamente impiantata dalla modernità occidentale. La prospettiva quattrocentesca del Rinascimento, in cui ogni oggetto viene distribuito nello spazio e regolato dallo sguardo del soggetto che osserva, artista o scienziato, è ciò che dà il via a questa immagine del mondo. Ed è qui che oggi incontro l’ineluttabile dis-locazione e il de-centramento di questi poteri e linguaggi, nel fatto che gli “oggetti” del mio sguardo rispondono. Quando le mie costruzioni, le estensioni del mio mondo si rivelano indipendenti ed esprimono le proprie storie, i propri desideri, QUESTIONE DI STORIA le proprie logiche nel mio linguaggio, ecco che vengo trascinato oltre gli schemi (e i poteri) di quella precedente immagine del mondo. Qui, ai limiti dell’Umanesimo occidentale, mi viene chiesto di considerare la mia “casa” non più come una struttura fissa, con radici che affondano saldamente nelle premesse epistemiche basate sulla lealtà logica e sulle istituzioni della tradizione nazionale, bensì come un transito contingente, una via che, letteralmente, mi conduce altrove. A questo punto, essere post-umanista non significa rinunciare all’umano: al contrario, annuncia qualcosa che è più umano precisamente attraverso il suo tentativo di uscire dagli astratti confini e controlli di un soggetto universale che crede che tutto abbia inizio e fine in se stesso. Accettare l’idea del post-umanesimo vuol dire registrare dei limiti, iscritti a livello locale del corpo, della storia, del potere e della conoscenza che parla. Proprio qui, entro questi precisi confini storici, mi trovo a dialogare nella vicinanza dell’altro che rifiuta di essere “altro” rispetto a me, ossia, rifiuta di mantenere le distanze, come oggetto dipendente dei miei desideri e del mio potere. Donna Haraway (1991) suggerisce che proprio negli estremi del cyborg, in questa cifra priva di storia, io vengo invitato nel modo più duro a contemplare questa possibilità. Nella commistione e contaminazione dell’umano e della macchina, nell’estensione simultanea di me stesso e della mia agognata separazione dallo stratagemma strumentale, nel misto di organico e inorganico, la mia autonomia soggettiva, mentale e fisica viene messa in discussione. Mi viene rivolto l’invito a entrare in quel passaggio tra pericolo e salvezza, per citare la nota definizione di Heidegger della tecnologia, per pensare e procedere in maniera diversa. Ma allora, qual è il senso di questo momento storico e globale, allorché gli oggetti del mio sguardo, del mio linguaggio, chiedono maggiore… riconoscimento, attenzione, giustizia, libertà, e mi gettano in uno stato in cui sono chiamato a riflettere sui limiti, sui miei limiti, sui limiti di una visione che si credeva capace di afferrare e comprendere ogni cosa? E quindi, come posso acquisire un senso e una direzione da questa interruzione che mi offre una prospettiva che si spinge al di là di me? Questo tipo di interrogativo può servire, soprattutto, a sciogliere il nodo tradizionale che ha legato indissolubilmente sangue e terra nelle disquisizioni sull’identità. L’annuncio dell’altro manda in mille pezzi la presunta IAIN CHAMBERS omogeneità di me come individuo e dell’identità collettiva. Se il corpo alienato del colonizzato e del cyborg è stato parte integrante della realizzazione del mio mondo, della mia modernità – com’è quasi certamente il caso – allora devo necessariamente riconoscere l’eterogeneità come parte integrante di quella storia, di quella formazione culturale e della costruzione della mia identità. In tal modo, come asserisce giustamente Julia Kristeva (1988), l’estraneo mi trasforma in un estraneo, rendendo la mia storia, il mio linguaggio, la formazione di me ignota, inquietante. In questa battuta d’arresto, in questa scissione e intervallo (sovente doloroso e difficile da accettare, segnatamente per coloro che hanno sempre vissuto la storia come riflesso di se stessi), mi ritrovo in viaggio senza la possibilità di colmare il vuoto, costretto a vivere la mia storia come apertura etica. Ciò potrebbe voler dire non limitarsi a “usare” e “sfruttare” l’esempio postcoloniale a beneficio istituzionale e individuale, bensì accettarlo come un invito a ripensare le premesse stesse dello “storico”, e quindi le conseguenze culturali, politiche, psichiche e poetiche che derivano dallo smuovere, scavare e coltivare il terreno su cui poggio i piedi. Il sublime della modernità In questa sfida alla verità razionalista e al soggetto universale è insita la sfida alla modernità occidentale. Tuttavia, prima ancora del discorso contemporaneo sulla postmodernità e sulla postcolonialità, questa particolare sfida ha già affondato profondamente le radici nell’arte e nella letteratura occidentali, più precisamente nei tentativi settecenteschi di limitare l’eccesso sentimentale ed emotivo proposto dal sublime. In questo senso, la Critica del giudizio di Kant del 1790 analizza la relazione tra l’immaginazione e la ragione, e giunge alla conclusione che la prima debba essere subordinata alla seconda. In una rielaborazione razionalista dell’indagine svolta più in termini fisiologici da Edmund Burke in Inchiesta sul bello e sul sublime, del 1757, il sublime viene considerato esclusivamente un prodotto della mente, un costrutto mentale; il piacere è dato dall’afferrarne l’enormità, invece che dall’avere a che fare con un oggetto particolare, come nel caso del bello. Per questa ragione, la Natura e i suoi oggetti non possono essere QUESTIONE DI STORIA sublimi: possono soltanto essere belli. Il sublime è una sensazione, risiede nella mente, e rappresenta l’inadeguatezza dell’immaginazione di afferrare la portata di ciò che si contempla. L’immaginazione viene superata dalla ragione. In The Feminine Sublime, Barbara Freeman (1995, p. 71) fornisce un commento critico: La funzione della ragione è di comprendere una totalità che l’immaginazione da sola non può rappresentare, e quindi scoprire una superiorità sulla natura che altrimenti la mente non riuscirebbe a raggiungere. Il bello e il sublime non possono sfidare o sminuire il potere della ragione, ma soltanto riaffermare la sua portata in ogni angolo dell’universo. Il soggetto estende il proprio influsso, immune da dubbi, domande e ambiguità che vengono registrati soltanto per essere “risolti” nell’unità razionale dello scopo e del progresso di una totalità di generazioni che si estende verso l’infinito. Tutto, compresa la “più selvaggia e sregolata confusione e devastazione”, rientra nell’ambito della ragione: poiché il vero sublime non può essere contenuto in alcuna forma sensibile, ma riguarda solo le idee della ragione, le quali, sebbene nessuna esibizione possa essere loro adeguata, anzi appunto per tale sproporzione che si può esibire sensibilmente, sono svegliate ed evocate nell’animo nostro (Kant 1790, p. 93). Come afferma Barbara Freeman proseguendo, Frankenstein di Mary Shelley è la realizzazione, o forse la messa in scena, dello scenario kantiano. Kant, come Victor Frankenstein, ritiene che la ragione possa svelare e ricondurre ogni cosa nel diapason del soggetto pensante. Tutto può essere rappresentato e reso cristallino dalla ragione. La conoscenza non si acquisisce per caso, ma si conquista, acquisisce e reclama. Victor Frankenstein “fornisce un ritratto di Kant, ovvero lo specchio del desiderio metafisico” (Freeman 1995, p. 87). Per Kant il sublime deve sempre operare entro limiti determinati dalla ragione e dalla sua autorità morale, altrimenti diviene, come egli stesso afferma, “mostruoso”. La mostruosità è ciò che interferisce col progetto della ragione, valicandone i confini teorici e usurpandone gli imperativi razionali. Per dirla con Corpi che contano di Judith Butler IAIN CHAMBERS (1993), il sublime è ciò che registra nella maniera più diretta il movimento del confine stesso. Al cospetto della purezza della ragione, i corpi, la carne fisica, il sangue e le ossa, differenziati per sesso, genere, razza, età e mortalità, recano testimonianza della tremenda confusione dei confini, di un’inquietante imprecisione e del potenziale sovvertimento della coerenza maschile da parte di sregolati eccessi femminili. In questo contesto un corpo senza confini, in cui l’interno e l’esterno, il fisso e il fluido, vengono confusi, trasfigurati, viene annunciato nella maniera più significativa nella gestazione del corpo materno: da donna a mostro, il passo è breve. Negli abissi dell’indefinito, in cui l’orrore dell’abietto sovverte il controllo canonico, la razionalità viene resa drammaticamente responsabile per ciò che tenta di reprimere e distanziare. La misoginia e il razzismo della ragione vengono costretti a riconoscerne le pretese universali. Come conclude, suggestivamente, la Freeman, a questo punto il sublime e la mostruosità, l’alterità e la natura ibrida, divengono elementi di una teoria, invece che ciò che la teoria si sforza di escludere e negare. Il quadro di J. M. W. Turner Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying: Typhoon Coming On (Negrieri che gettano a mare morti e moribondi: tifone che incombe, meglio noto come Nave negriera) venne esposto in pubblico per la prima volta a Londra nel 1840. Una nave a vela viene sballottata dalle onde selvagge di una imminente tempesta. Tra le onde, si intravedono pesci e gabbiani stridenti. Nell’angolo in basso a destra, una gamba nera incatenata sta per sprofondare per sempre negli abissi. Questo quadro di Turner conduce al centro di un discorso estetico una manifestazione complessa del sublime spaventoso, condensato in un segnale storico e sociale: la schiavitù, un’istituzione che era stata abolita appena sette anni prima nell’Impero Britannico, e che era ancora in vigore in altre parti della regione atlantica. Ecco che l’oggetto della ragione, lo sguardo disinteressato che contempla la bellezza, assume una connotazione doppiamente inquietante, perché si riscontrano sia l’inquietudine del sublime, dei sentimenti portati all’eccesso e della passione irrazionale, che l’inquietudine di affrontare il represso: la repressione della schiavitù, i cui proventi indiretti delle piantagioni di zucchero, cotone e caffè finanziavano il mondo produttivo e la società che QUESTIONE DI STORIA patrocinava la mostra, la galleria d’arte e perfino l’acquisto dell’opera di Turner. Non si vuole con questo gettare la croce sull’opera, bensì coglierne l’ambiguità (chiaramente Turner non ritrasse una simile scena per sostenere la causa della schiavitù) e afferrare in quella ambiguità modi diversi di interpretare e rispondere all’opera e, con essa, alla modernità occidentale. Il primo proprietario del dipinto fu il critico d’arte John Ruskin, che lo ricevette in dono dal padre. Nel suo libro Pittori Moderni (1843), Ruskin esamina il dipinto solo relativamente al modo in cui l’acqua debba essere dipinta, suggerendo che quello fosse “il più nobile mare” (p. 480) mai dipinto da Turner e da un pittore. Il fatto che “la nave colpevole” (ib.) trasportasse schiavi e che gettasse gli schiavi fuori bordo viene relegato a una noticina a piè di pagina. Ovviamente è possibile commentare il quadro per quanto concerne la realizzazione dell’acqua, ma in questo caso l’omissione, per mezzo della quale la schiavitù esce di soppiatto dal quadro, è forse anche emblematica. Vent’anni più tardi, Ruskin vendette il quadro. Si disse che per lui il soggetto fosse troppo doloroso da contemplare. Tuttavia, ciò che aveva trovato troppo doloroso da contemplare non poteva interferire col suo giudizio estetico (Gilroy 1993c). Ciò cui intendo brevemente accennare in questa sede, riferendomi al commento sulla questione del critico britannico Paul Gilroy, è che, al contrario, potrebbe essere oltremodo illuminante interrompere un giudizio estetico con un giudizio etico, o persino mescolare e congiungere i due giudizi. Si giungerebbe alla massima di Wittgenstein, secondo cui l’etica e l’estetica si sovrappongono. Tuttavia, ed è questo che ci dice Gilroy (e che propone il romanticismo tedesco nella sua critica alla subordinazione kantiana del sublime alla ragione), qualora li abbinassimo, apriremmo la porta non soltanto a una maniera nuova di vedere il quadro, ma anche alla modernità stessa. Ricollocare la schiavitù nella cornice, riprendere quei corpi neri abbandonati e riportarli nel quadro, non significa soltanto affrontare i limiti della ragione e di un’estetica riluttante a contemplare l’altra faccia della rappresentazione. Riportare questi corpi nel quadro significa altresì segnare i limiti di questa ragione e delle sue narrazioni politiche e culturali, e suggerire che esistano altre storie, altre modernità da raccontare. IAIN CHAMBERS La tematica dell’arte, del bello e del sublime si rivela quindi assai più di un dibattito provinciale limitato al settore dell’estetica e all’autorità dell’Illuminismo. Vuol dire restituire l’arte della modernità alle rivendicazioni originarie. Fin dal principio, si è ritenuto che l’arte occidentale moderna aprisse una finestra sul mondo per riflettere ciò che osserva l’occhio in modo che “in questa superficie si presentino le forme delle cose vedute, non altrimenti che se essa fusse di vetro tralucente” (Leon Battista Alberti 1436, pp. 26-28)1. Una tale logica della rappresentazione ha sancito la supremazia dell’ottica e la centralità dell’occhio. La tecnologia della prospettiva è ciò che assicura all’occhio che lo spazio venga determinato esclusivamente in modo che posto il punto centrico, (…) segno diritte linee da esso a ciascuna divisione posta nella linea del quadrangolo che giace, quali segnate linee a me dimostrino in che modo, quasi persino in infinito, ciascuna traversa quantità segua alterandosi (p. 36). La prospettiva, con il suo punto d’origine e una geometria dello spazio regolata e omogenea, situa l’occhio dell’osservatore al centro della cornice, a controllare e definire ciò che bisogna vedere, catalogare, descrivere, spiegare. La griglia della teoria, la cornice della visione, l’ordine della vista che pone se stesso al centro, protegge l’osservatore dal rischio di essere esposto a ciò che non riesce a vedere, contemplare o rappresentare. È questo potere individuale e assoluto sullo spazio che lo rende uniforme e perfettamente evidente agli occhi dell’osservatore. La sistematica elaborazione dei principi della prospettiva è quanto il pittore, l’architetto e l’urbanista rinascimentale rappresenta nella storia dell’arte. La conoscenza e l’estetica che scaturiscono da questo punto di vista che pone il sé al centro sono, ovviamente, profondamente inserite nella formazione e nella successiva esecuzione della modernità stessa. Ne consegue che la biografia dell’artista diviene emblematicamente intercambiabile con la biografia del genio universale che è la modernità occidentale (Soussloff 1997). 1 Per le citazioni dal De pictura dell’Alberti, trattandosi di un classico disponibile in numerose edizioni, i numeri di pagina si riferiscono all’edizione riportata nella bibliografia (N.d.T.). QUESTIONE DI STORIA La prospettiva instaura la razionalizzazione dello spazio, la sua colonizzazione, consentendo all’osservatore di ritrarsi dal ciglio dell’infinita dispersione. Come nel caso del sublime kantiano, la minaccia della dispersione e della degradazione, il “punto di fuga” nel quadro, viene riposizionato nell’ambito dell’appropriazione razionale: il continuum che si dipana tra l’occhio del soggetto e l’infinito si fa discreto, soggetto a misurazione, calcolo e convergenza (Burgin 1990). Si tratta di un’arte che pone al centro l’osservatore. È la vista di chi guarda che attiva la prospettiva, la quale gli garantisce che la sua posizione è il punto di origine di ciò che viene rappresentato. Quantunque condotto lungo linee visive che tendono all’infinito, lo sguardo dell’osservatore non vacilla e non si dissolve mai. Fissato nella cornice e sospeso nella ponderata geometria del campo ottico, il soggetto conferma il quadro nell’istanza condivisa che il quadro riconferma la posizione di fulcro del soggetto. In questa persistente centralità dell’occh-ìo1, la distanza tra le semplici strutture del Rinascimento utilizzate per delineare la prospettiva e le videocamere digitali del giorno d’oggi – entrambe rendono la realtà immediata, come senza intervento tecnico (“una chimera nel paese della tecnica”, Benjamin 1955b) – è assai più breve di quanto i cinque secoli che li separano indurrebbero a ritenere. Sono lo spostamento in atto di questa “immagine del mondo”, il suo umanesimo incentrato sul soggetto, le implicazioni storiche, politiche e poetiche di questo spostamento, che suggeriscono qualcosa di ben più profondo del semplice passaggio cronologico di un’epoca storica. Il pensiero storico, la scrittura, l’arte e il dibattito, fin dagli anni Quaranta, hanno costretto sempre più a una radicale ri-valutazione della modernità occidentale alla luce delle migrazioni globali, degli spostamenti storici e delle traduzioni culturali assurti a protagonisti della modernità fin da quando essa ha fatto la sua comparsa, cinque secoli fa. Se l’Occidente si è quindi, per molti 1 L’autore conia il composto “eye/I” sfruttando l’omofonia tra i termini inglesi “eye” (occhio) e “I” (io). Si è deciso di rendere in italiano questo gioco di parole con “occh-ìo”, scomponendo il vocabolo italiano “occhio” in modo da rendere riconoscibili entrambi i lessemi del neologismo inglese e spostando l’accento tonico, al fine di evitare che la lettura ad alta voce vanifichi l’effetto retorico (N.d.T.). IAIN CHAMBERS versi, sovrapposto al mondo moderno, con la sua economia politica, i suoi linguaggi, le sue tecniche e la sua tecnologia che forniscono e sorreggono una cornice globale, quello spazio è divenuto altresì il luogo della differenza, la “casa” di altre storie, culture e identità. Nel foggiare il mondo, si sono inevitabilmente trasposte le presunzioni dell’Occidente di possedere e dirigere il linguaggio e le istituzioni che portano il suo nome. Questa enfasi sulla dislocazione, sulla migrazione e sulla ri-appropriazione non viene proposta per recuperare l’emigrazione altrui pro domo mea, e per asserire che ormai siamo tutti “emigranti”. Piuttosto, significa registrare una risposta, una responsabilità, nei linguaggi di cui dispongo per operare la necessaria interruzione e la rivalutazione della mia voce, della mia storia e della mia cultura in un mondo in cui il passaggio storico e la traduzione culturale dell’emigrazione sono divenuti inscindibili dalle definizioni della modernità. Ecco che la configurazione sia poetica che politica del mondo viene ricreata o foggiata in maniera differente. La visione rassicurante offerta dalla distanza critica della prospettiva soggettiva e l’universalismo della visione a volo d’uccello vengono adesso integrati e sovvertiti da uno sguardo obliquo che emerge da una storia e da un luogo particolari, necessariamente “dal basso”, che conducono allo spostamento e alla potenziale dispersione della precedente visione. Che cosa compare, che cosa si registra e si ode, allorché si riconosce questo movimento? Posizionalità storiche La rigidità unilaterale della relazione osservatoreosservato/soggetto-oggetto che ci ha lasciato in eredità l’umanesimo cede il posto a un linguaggio differente: meno violento nella sua caparbietà, più aperto nel suo significato. L’intenzionalità diretta e l’azione unilaterale cedono il posto a un incontro meno condizionato, alla ricettività, all’accettazione dell’ascolto. L’altro non viene fissato per essere decifrato e spiegato in quanto oggetto del mio discorso e della mia conoscenza, bensì viene recepito come l’eco, la risonanza di ciò che sfugge alle intenzioni della mia rappresentazione (Carchia 1982, p. 17). QUESTIONE DI STORIA Ecco allora che il soggetto, l’“io”, viene provocato e invocato dall’altro al punto di diventare, esso stesso, un oggetto dell’appartenenza condivisa dell’interprete all’oggetto dell’interpretazione, ciò che Gadamer (1965) chiama notoriamente “fusione d’orizzonti”. Tuttavia, ciò che si manifesta in questo contesto, e che infrange il cerchio perfetto dell’estetismo ermeneutico dello stesso Gadamer, non è tanto la sostituzione della “distanza critica” kantiana con una sublimazione organica di soggetto e oggetto nella natura comune delle cose, quanto piuttosto un senso acuto di posizionalità storica . Si tratta di una consapevolezza talmente acuta da incunearsi nelle pretese universali di un razionalismo che presume già di conoscere appieno se stesso e la storia che si propone di rivelare, e talmente acuta da rendere ogni singola tradizione dell’interpretazione, ogni singola ermeneutica, ogni singola conoscenza, un luogo instabile di passaggio, di trasformazione e di traduzione (ib.). In questa versione maggiormente agnostica e vulnerabile della storia, priva di una ragione obiettiva in grado di garantire la costellazione della nostra vita, le premesse stesse del soggetto e dell’azione storica, dell’umanesimo occidentale, mi invitano a riconsiderare in una riproposizione del tutto nuova la comprensione storica e la critica culturale. Questo mi riporta alla questione della “verità” nell’arte. Contrariamente alla comprensione proposizionale, in cui si presume che il linguaggio e l’oggettività coincidano in una relazione garantita dalla razionalità consensuale, qui la prospettiva della “verità” diventa una condizione priva di determinazione, la quale dice più di quanto possa esprimere un qualsiasi linguaggio razionale. Non si tratta necessariamente di una proposta teologica o mistica, sebbene Walter Benjamin, per esempio, non abbia trascurato questa eventualità, bensì di un’argomentazione sul tempo e lo spazio, o sulla storia e sull’essenza, come il Romanticismo tedesco, Benjamin e Heidegger, in modi diversi, hanno cercato di esprimere. Ed è proprio la questione dell’arte che più di tutto tiene aperta la visuale su questo orizzonte. Contenuta in una costellazione storica in cui il significato emerge dai limiti, e non dall’universalità senza tempo del linguaggio astratto dei concetti, l’opera d’arte ci prospetta le indicazioni temporali di un orizzonte del linguaggio, di una posizionalità IAIN CHAMBERS mondana e di una cornice terrena, che si trovano dietro di noi, davanti a noi e al di là di noi. Si tratta di un senso del significato che scaturisce dall’interno delle limitazioni materiali della contestualizzazione storica che è, proprio per queste ragioni, sia posizionabile che, in ultima istanza, priva di fondamenta permanenti o atemporali. Nel tempo e del tempo, questo significato costituisce una “via” (Heidegger), un “passaggio” (Benjamin) che registra la posizionalità, la responsabilità della posizione, piuttosto che l’universale, cumulativo “progresso” di cui la razionalità strumentale tenta di circondarsi. Pensare in questo modo non umanista, ossia in un modo che precede e eccede il “soggetto”, non vuole dire pensare in termini antiumanistici, cosa che sarebbe altrettanto arbitraria, altrettanto dispotica, e quindi, altrettanto umanista. Cambiare il segno, ribaltare la formula, non vorrebbe dire altro che riconfermarla. Prendere criticamente le distanze dalla storia del soggettivismo che si pone al centro di tutto non significa identificarsi con l’indifferenza dell’inumano, anzi, il non umanista è il supplemento critico che precede e eccede l’imperialismo del soggetto. Per molti, questo supplemento critico è ciò che il linguaggio, nella più ampia accezione del termine, custodisce. Il linguaggio conserva il potenziale esecutivo di ciò che va al di là di ciò che è semplicemente strumentale e prescrittivo. Come iscrizione che si dispiega, come rivelazione culturale e storica, il linguaggio non è un problema linguistico, bensì un problema del divenire, il cui lessico e la cui grammatica si possono esprimere in una sintassi etica e poetica, mediante corpi e tecnologia, mediante sessualità e suoni. La poesia di Hölderlin per Martin Heidegger, un futuro fantascientifico del suono per Jimi Hendrix, il cyborg contemporaneo e futuro per Donna Haraway; per ognuno, un’integrazione irriducibile alle consolazioni dell’umanesimo e al fondamento e alla riconferma del soggetto che ne conseguono. In questa sospensione della tendenza umanista, nella dispersione della sua logica, nell’indebolimento della sua voce, nello spostamento della sua visione, si riscontra l’invito ad accettare il mondo asimmetrico e incompleto non come destino consolatorio di un umanesimo non affrancato, bensì come lo sperone, l’interrogativo di una non identità che ci sospinge. Il senso dell’arte che sto tentando di evocare in queste righe si dispiega in prossimità di questo limite, annunciando la soglia, che QUESTIONE DI STORIA richiama ciò che ci sostiene nel passaggio dal consenso di quel che è noto a un altrove, a “strade mai prese” (Lipsitz 1990, p. 30). È un’arte irriducibile a una funzione ideologica o comunicativa: è un’arte, o una poetica, che stabilisce un’insistenza etica. A questo punto, la razionalità di una specifica formazione della rappresentazione deve registrare i propri limiti. Ecco che un particolare senso del mondo si trova di fronte a una battuta d’arresto: è dove una ragione, un’arte, un’estetica, un’identità nutrita in e con una siffatta formazione devono lasciarsi alle spalle le proprie premesse e superarle. Andare oltre il proprio “se stesso” non vuole dire smarrirsi nel delirio dell’identificazione con la propria storia, tecnologia e cultura: si tratta, invece, di custodire un tale egocentrismo in maniera critica (Bowie 1997). Registrare detti limiti equivale ad allontanarsi da un assorbimento del sé che trasforma il linguaggio, la storia, la cultura e il mondo in una sterile, e in fin dei conti omicida, ossessione per il possesso: la “mia” lingua, la “loro” cultura, la “nostra” storia. Allontanarsi e inseguire un’arte, un linguaggio, una storia in una maniera avulsa dal possesso significa avvicinare la promessa dello spostamento e dell’alterità, e per mezzo di essa il potenziale per ricontestualizzare il senso di noi stessi. Non si tratta di un’arte della sublimazione, qualcosa che in apparenza ci consente di rilassarci, tranquilli, nella contemplazione dell’autoconferma, bensì di un esame. Non ci permette di sfuggire a noi stessi, piuttosto ci rende maggiormente soggetti all’interrogazione e al dubbio, perché non è né la proposta dell’integrazione, né della domesticazione, bensì la proposta di una costellazione sociale e storica che perturba e mette in crisi la comprensione istituzionale. Limitarsi a riconoscere nell’alterità la relatività delle precedenti rivendicazioni di un senso, di una conoscenza e di una verità assoluti non fa necessariamente slittare l’incessante pretesa del soggetto della realizzazione del sé attraverso l’oggettivazione dell’altro. La continuità di quella relazione, per quanto relativizzata e storicizzata, rimane fondamentalmente inalterata. Piuttosto, è l’osservatore, rinsavito dalle sue illusioni e dal suo egocentrismo, che alla fine consente all’osservatore “non di parlare di qualcosa, ma nelle vicinanze di qualcosa”15. 1 Dal film di Trinh T. Minh-ha Reassemblage (1982). IAIN CHAMBERS L’artificio della distanza intellettuale viene a essere sostituito dalla contingenza storica e culturale. È a questo punto che l’imperativo ideologico della modernità, bramosa di rendere tutto trasparente e soggetto al proprio razionalismo, subisce la più profonda dislocazione e ricontestualizzazione. Ecco spiegato perché quel “post-” di “postcolonialismo”, per esempio, è una metafora più di natura spaziale che cronologica: non si riferisce soltanto all’evento storico del colonialismo, ma racconta altresì una storia, soprattutto la “mia” storia, da un altro punto, da una locazione de-centrata relativamente al razionalismo sociotecnico che apparentemente governa la “ragione” della modernità. Recare testimonianza di questo altrove è al contempo un’appropriazione estetica ed etica del linguaggio e delle identità culturali in cui trovo il mio “sé”. Quanto detto impone un’interruzione interna – una denuncia e una critica – nei linguaggi che concedono autorità a me; i linguaggi della modernità occidentale che storicamente hanno consentito a me di autoproclamarmi soggetto della storia e di proclamare gli altri “oggetti” della storia. Mettere in discussione e demolire quella “distanza critica”, giustificata nel nome della scienza, della conoscenza e della “verità”, vuol dire ricontestualizzare il linguaggio in cui vivo e che costituisce la mia casa. L’intreccio e l’interrogazione degli orizzonti mi rende, nella mia storia e nella mia tradizione, vulnerabile, esposto a un mondeggiare il mondo nella ricerca di una risposta che sia anche accettazione di responsabilità. In tal modo diviene scomoda la precedente identità e, nello stesso tempo, si rende ingiustificabile la passione per l’assassinio, ossia lo sradicamento storico, culturare, mentale e, infine, fisico dell’altro. Significa anche opporsi alla tendenza teorica contemporanea, che valorizza lo spazio per volgere il pensiero all’instabile, quotidiano argomento del luogo, a quel rozzo e spesso resistente passaggio, che ci assorbe e ci eccede. Nello sregolato scambio tra il linguaggio e la terra, il genere e il terreno, l’etnicità e l’etica, esiste un’inquietante architettura che eccede la casa monolitica che il razionalismo continua a progettare. Essere inscritti in una voce, in un corpo, in un tempo particolari in cui vengono registrate le temporalità della “modernità” e della “globalizzazione” significa essere invitati a riconcepire, anziché limitarsi a sfollare, quel luogo. Parlando da un preciso luogo politico, storico, QUESTIONE DI STORIA culturale ed economico, invece che dall’“ovunque”, il tempo si piega, viene chiamato alla resa dei conti, e la sua superficie lineare si flette a rivelare altre modalità del divenire. Non riguarda solamente il momento contemporaneo, ma anche la formazione storica complessiva che mi ha creato. Al di là della rappresentazione La storia non si limita a smuovere i sedimenti del passato: la storia è la rappresentazione istituzionalizzata del passato. In quanto monografia, libro, documentario e archivio in via di sviluppo, la storia è un’attività del presente che rievoca il passato in una contestualizzazione in fieri del presente. La storia non è ciò che è stato, ma la testimonianza di ciò che è: in quanto conoscenza, discorso, dibattito, rappresentazione, interpretazione. Il ricorso reiterato al realismo come modalità privilegiata per la rappresentazione è particolarmente evidente nelle formazioni culturali anglosassoni, in cui il linguaggio tende a essere, pragmaticamente, considerato uno strumento “neutrale” e un mezzo sostanzialmente trasparente per la comunicazione. Soltanto nella sfera “dell’immaginazione”, la letteratura e l’estetica, viene concessa la licenza di violare queste asserzioni strumentali. Le indagini letterarie e poetiche del linguaggio vengono considerate decisamente avulse dalle pretese di verità perseguite in altre facoltà umanistiche per inclinazione più obiettive o “scientifiche”. Eppure, persino nella letteratura, così come nella narrazione chiave del ventesimo secolo, il cinema, il realismo continua a occupare una posizione centrale nel confermare il mondo del soggetto. Questa riduzione del linguaggio a una sintassi oggettivante non è né casuale, né arbitraria, bensì trova fondamento nella storia della professionalizzazione delle discipline che “ha fissato le norme della scienza del diciannovesimo secolo come epistemologiche e il romanzo realista come modello letterario” (Kellner 1995, p. 6). Un linguaggio di questo tipo, un realismo di questo tipo, non riflettono o impersonano il mondo di tutti, ma solo il mondo per alcuni1. 1 Sull’egemonia storica della visione incorporata nella narrazione realista con la sua percezione imperiale e il suo possesso del mondo, si veda Said 1994. IAIN CHAMBERS Questa contestualizzazione storica e culturale del linguaggio è ciò che ci permette di comprendere meglio il profondo impatto della “teoria francese” nel mondo anglofono a partire dagli anni Sessanta. Lacan, Barthes, Foucault, Kristeva, Derrida, Irigaray, Lyotard e Cixous sono tutte voci critiche che annunciano e asseriscono la centralità ontologica del linguaggio in ogni senso dell’azione umana. Raramente si è contemplato questo aspetto della “teoria” nella sua interezza. Negli ambienti anglofoni, la sfida ontologica del linguaggio viene sistematicamente ricondotta a una “svolta linguistica”, a una comprensione più tecnica e autoreferente, persino se la si definisce “semiotica” o “discorsiva”. Un’appropriazione non troppo lontana dall’idea del linguaggio quasi esclusivamente in termini di razionalismo espresso dalla massima “fare cose con parole” (Austin 1976). L’insistenza pragmatica insita nel rapprochement di Richard Rorty per l’ermeneutica, per non parlare dell’egemonia della logica autoreferenziale della filosofia analitica oxfordiana, confermano e sintomatizzano l’errore rivelato in questa traduzione culturale di una teoria “straniera”, in tal modo alterando e addolcendo l’impatto sulle correnti guida dell’accademismo angloamericano (Rorty, a cura, 1967)1. Eppure, non solo parliamo noi, ma il linguaggio anche, testimonianza storica e testimone represso, parla attraverso noi, fornendoci infine una casa e un senso, una direzione, un percorso nel mondo. Questo significa che il linguaggio apre la porta a una serie di implicazioni che non possono essere ricondotte alla linguistica o alle questioni di logica e comunicazione. L’illusione realista che postula che si passi direttamente attraverso il linguaggio per osservare, catturare, descrivere e spiegare il mondo esterno è stata messa in discussione direttamente nella storiografia da Hayden White. In Metahistory (1973) e Tropics of Discourse (1978), White punta giustamente i riflettori sul linguaggio represso della narrazione storica, insistendo sulla sua composizione letteraria e sull’ambiguità epistemologica del 1 Probabilmente l’espressione “svolta linguistica” è stata adoperata per la prima volta nel saggio di Gustav Bergemann del 1953, ristampato nella raccolta di Rorty. Si veda Ankersmit, Kellner, a cura, 1995, p. 241. QUESTIONE DI STORIA suo discorso. Questo lavoro rivoluzionario innesca il disfacimento consequenziale di un’oggettività che si fa forte della relazione soggetto-oggetto dell’umanesimo e della sua concezione strumentale del linguaggio. Rivolgendosi alla scrittura della storia, al linguaggio e alle strategie della narrazione del passato, non soltanto la natura artificiosa della realtà diviene raccontabile, ma anche le strutture della rappresentazione non possono più essere rinchiuse in una problematica squisitamente formale e retorica, come se la “realtà” fosse lì, pronta per essere recuperata dal soggetto. A questo punto, scrivere la storia si inserisce direttamente nella storicità del linguaggio stesso, ergo, come afferma perspicacemente Gregor McLennan (1981, p. 85), “la consueta distinzione tra la storia e la ‘filosofia della storia’ viene annullata”. In quest’ottica, la reiterata scelta del realismo come modalità privilegiata della rappresentazione si rivela essere più una costruzione culturale che una garanzia ontologica: la realtà della rappresentazione è la realtà della rappresentazione. Non significa addurre un’argomentazione di maniera sui simulacri e sulla scomparsa del vero (per quanto insistere sulla mancanza di fondamenti ci segnali qualcosa di potenzialmente importante), quanto asserire di doversi assumere la responsabilità storica ed etica per i linguaggi in cui la verità, la conoscenza e il senso di noi stessi trovano collocazione ed espressione. L’enfasi sull’abbinamento della rappresentazione e del realismo contiene l’asserzione che esiste una verità unica e omogenea. Suggerisce che mentre ci possono benissimo essere divergenze di opinione, dibattiti e dissenso, il lavoro intellettuale progredisce immancabilmente nella direzione della rivelazione del telos di una conclusione soggiacente e universale. Questo punto di vista putativo è unico, accoglie una sola razionalità, una sola verità apparentemente garantita nei protocolli centrati sul soggetto di un umanesimo universalizzante. Ma questo punto di vista onnipresente è esso stesso prodotto, schiavo di una precisa formazione storica e contestualizzazione culturale che, a sua volta, accoglie un regime di rappresentazione e le sue asserzioni sulla verità. Se il realismo consente di evitare un rapporto critico col linguaggio di cui dispone per spiegare il mondo (il passato, analogamente al presente, non fa che attendere di essere scoperto e IAIN CHAMBERS rappresentato), certamente una storiografia critica non può più rifuggire dal confronto con la disposizione del linguaggio e la rappresentazione in cui la storia e le sue spiegazioni fanno la loro comparsa. Imprigionato nel linguaggio del tempo, e nel tempo del linguaggio, non c’è alcun passato di per sé, c’è solamente il passaggio del presente eternamente aperto alla ricontestualizzazione che si attua interrogando il passato: sia il passato che viene interrogato che quello che interroga. Quanto detto significa che il passato non può né essere cancellato, né tanto meno negato. Anzi, riconoscendo che le procedure del ricordo e i regimi di rappresentazione sono l’unico modo in cui possiamo accedere al passaggio del tempo, il passato rimane il passato. È possibile rivisitarlo e riscriverlo in chiave di un realismo limitato e contestato, ma il suo ritorno può anche sfidare il rappresentabile e l’incommensurabile. La rappresentazione ha dei limiti, come dimostra drammaticamente, per esempio, l’Olocausto, la Shoah (Friendlander, a cura, 1992). La ragione non è in grado di afferrare in maniera esaustiva, o di registrare nella sua interezza, quell’evento storico – sia in termini di genocidio istituzionalizzato col benestare dello Stato o come burocrazia indolente e banalità quotidiana del male – quando esso sia esposto sotto forma di cifre astronomiche e terrore indicibile. Nell’incommensurabilità estrema tra l’evento e i significati successivi, l’Olocausto supera e frantuma i precedenti punti di riferimento (Lyotard 1983, pp. 81-83). Eppure, da questo punto di vista l’Olocausto non è più necessariamente un’eccezione unica, bensì un evento storico moderno di portata colossale che getta un’ombra raggelante sui limiti della ragione occidentale nel divulgare e spiegare le forze del mondo che apparentemente ha generato. Alla scioccante unicità dell’Olocausto è da aggiungere ciò che rivela come evento specifico nella formazione e nella realizzazione della stessa modernità1. Ciò nondimeno, registrare i limiti della ragione non significa consolidare il rifiuto a pensare, nemmeno a pensare all’impensabile. Registrare i limiti della ragione è quantomeno interrogare il razionalismo stesso che la modernità dovrebbe incarnare, e di qui incrociarne le ri1 Per una dettagliata disquisizione sulle implicazioni dell’“unicità” dell’Olocausto, si veda Brecher 1999. QUESTIONE DI STORIA vendicazioni di “progresso” con la testimonianza lampante di ciò che eccede la sua razionalizzazione. Al posto dell’“unicità”, forse, per dirla come Bob Brecher (1999), è la realtà inaudita dell’Olocausto che frantuma il pensiero, costringendoci a formularlo nuovamente. Se l’Olocausto è al di là della portata immediata del razionalismo, e se la tentazione di spiegare, secondo Primo Levi, scivola in direzione della giustificazione, esso non si colloca al di là della costellazione storica in cui ha avuto luogo (Levi 1987)1. Ciò significa trasporre la questione della storia al di là di un liberale ventaglio delle possibilità con cui l’universale si dispone ad assorbire punti di vista particolari e partigiani. Il riconoscimento di una storia femminista, di una storia nera, di una storia omosessuale e di una storia subalterna, di per se stesso non sfida necessariamente la “continua adesione all’empirismo comune e ai precetti realisti della rappresentazione e della verità” (Jenkins 1997, p. 1). Indugiare in quel regime della rappresentazione, cercare il riconoscimento per una narrazione repressa del mondo, significa rimanere intrappolati nel linguaggio insistendo su un’improbabile ridistribuzione dei poteri. Indugiare su questo punto vuol dire reprimere precisamente ciò che è emerso in queste varie storie inizialmente: un regime della rappresentazione le cui rivendicazioni di verità dipendevano dalla sistematica repressione degli altri. Vuol dire parlare di qualcosa di ben più radicale e dirompente del semplice adattamento. Vuol dire rendere un senso di rappresentazione e verità ricevuto in eredità, una modalità storica di ritrarre e inquadrare il mondo profondamente problematica, forse obsoleta. Mettere in discussione l’autorità di una disciplina come la storiografia, e ciò che intende propinarci sul passato, significa altresì mettere in discussione la comprensione del presente e di noi stessi. Esporre l’esecuzione di un tale progetto e desiderio non rende necessariamente impossibile il progetto storiografico, ma significa reclamare un altro tipo di storia, e che l’esercizio 1 L’autore si riferisce alla postfazione dell’edizione inglese di Se questo è un uomo e La tregua, assente nelle edizioni italiane. Per i dettagli, si rimanda alla Bibliografia (N.d.T.). IAIN CHAMBERS della sua autorità sia maggiormente ristretto e circoscritto1. In contrapposizione alla violenza astratta dell’oggettività storica, il problema della storiografia diviene quello di come rappresentare l’assenza, come superare il trauma. Riflettere su cosa una particolare storia rappresenti, per chi, quando e come, significa riconoscere la giusta affermazione di Arthur Danto (1962, citato in Vann 1995) secondo cui “gli eventi non esistono che in una qualche descrizione”. Chi parla si trova sempre in un qualche luogo: ci troviamo sempre in una data posizione, confinati nel tempo, collocati. Quanto appena detto ricorda il Dasein di Heidegger, ossia l’essere-nel-mondo senza garanzie di trascendentalità. La fuga intellettuale dal mondo, per farvi ritorno armato di critica come un essere separato, autonomo, non è che una perpetuazione di ciò che Alain Robbe-Grillet (For a New Novel, citato in Ermath 1992, p. 119) una volta definì il “terrore” dell’umanesimo, “tipico di un universo in cui la risposta a ogni domanda è ‘l’uomo’”. La trascendentale oggettività soggettiva dell’umanesimo cede il posto al riconoscimento della località culturale, all’essere già soggetto al mondo prima ancora di concepire il mondo e noi stessi. L’“io” isolato passa nella comunanza temporale dell’“evento”, in cui il confine tra corpo e linguaggio, soggetto e oggetto diviene sfocato (ib.). L’edificio disciplinare della storia, come moderno e continuamente rinnovato archivio delle discontinue e contraddittorie pastoie di un immanente “progresso”, si tramuta pertanto nella struttura, a un tempo inconcludente e assai più inquietante, di una rovina barocca: rovina che consapevolmente testimonia le rappresentazioni del mondo, le sue storie e la “verità”, proprio nei termini di limiti del linguaggio, della posizione, della vita. Rivalutare il regime della rappresentazione per mezzo del quale parla la storia, subordinare i “fatti” e gli “eventi” ai linguaggi nei quali compaiono, può rendere bene l’idea di “fonti primarie”, “documenti” e “archivi” instabili, nonché scatenare una vicinanza inquietante tra il “reale” e il “romanzesco”, ma il fulcro della 1 Si veda Berkhoffer 1995 per una dettagliata panoramica sulla tematica del mondo anglocentrico, scritta da uno storico, caratterizzata da limiti nelle proprie implicazioni culturali e politiche sulla comprensione linguistica, retorica e dialogica del linguaggio. Per un approccio di più ampio respiro e maggiormente interdisciplinare, si veda Ankersmit, Kellner, a cura, 1995. QUESTIONE DI STORIA questione resta insito nel ribadire che la conoscenza promana dalla narrazione in fieri del mondo che tenta di sanare le ferite della memoria. Gli straordinari film di Chris Marker riflettono lungamente sulla tematica della memoria (e dei suoi mezzi). Nel film Sans Soleil, dice: Chi l’ha detto che il tempo rimargina tutte le ferite? Meglio sarebbe dire che il tempo guarisce tutto, tranne le ferite. Col tempo, il dolore della separazione perde i suoi limiti reali, col tempo il corpo desiderato scompare repentinamente, e se il corpo desiderato ha già cessato di esistere per l’altro, allora non rimane che una ferita, disincarnata. Nel medesimo film, una cornice apparentemente unitaria, una serie di storie, di immagini, tenute assieme in un flusso temporaneo e uditivo, registrano l’impossibilità di ricondurre tutto alla comprensione comune. Vestigia di storie, miti e memorie trasformano la storia in iscrizioni, la storia in una ri-scrittura. Chi scrive di chi in questo spazio condiviso che abbraccia vari luoghi e tempi? Chi guarda chi, allorché lo sguardo viene restituito e il privilegio della macchina fotografica di immortalare la vita, il “fatto”, viene messo in discussione? Nelle sequenze visive che si riscontrano passando dall’Islanda a Tokyo, alla Guinea-Bissau, al Sahel, a Hokkaido, a Okinawa e all’Île-de-France, dov’è che si fa la storia, e chi, nel connubio tra politico e prosaico, fa la storia? Le inquadrature di attesa e spiegazione vengono interrotte da “cose che accelerano il battito cardiaco”. Si tratta di storie che entrano ed escono con moto ondivago dalle narrazioni ufficiali, disturbando la loro logica. In questa narrazione temporale, della storia emerge una ferita aperta nelle nostre vite, che propone un linguaggio che scaturisce dall’incertezza: la poesia. I limiti della politica e la poetica dei limiti Contestare l’ideologia umanista secondo cui il mondo, per quanto sregolato e turbolento, è soggetto in ultima analisi a un’unica ragione, per molti equivale ad abbandonare la propria casa. Se la politica rappresenta la volontà di costruire e ottenere IAIN CHAMBERS un’“abitazione” gestibile, allora ciò che essa non è in grado di cogliere, ciò che non riesce a sopprimere nel nome della chiarezza e della logica, potrebbe indurci a ritenere la poetica più prossima alla verità del nostro essere nel mondo. In quest’ottica, l’arte non è solo un ornamento frivolo apposto sulle strutture della vita quotidiana, qualcosa di estraneo alla necessità, bensì un requisito etico che ci invita a riformulare il nostro pensiero. Ripensando, è possibile che ritorniamo alle asserzioni del “politico” e che le esponiamo alla responsabilità di un mondo che non rispetta o riconosce necessariamente la sua ragione. In quel gesto, la storia del politico non viene né cancellata, né abbandonata, è tenuta a rendere conto di più della sua struttura esplicita. A questo punto, la verità non riguarda la mimesi, il realismo e la trasparenza della rappresentazione, bensì il sito quotidiano della rivelazione o della scoperta. Ecco che l’economia morale dell’analisi politica si ritrova intrappolata tra una verità non ancora realizzata e le strategie di sopravvivenza, tra la purezza del progetto e i risultati discontinui della mediazione, della trattativa e della trasformazione. La politica del razionalismo strumentale che si ritiene in grado di realizzare una volontà politica deve immancabilmente fare i conti con un’integrazione che rifiuta di conformarsi, che frustra e interrompe il suo desiderio. Però quell’integrazione sregolata non si limita a rappresentare il limite di una volontà politica o l’altra faccia della ragione strumentale, bensì interroga i fondamenti stessi su cui si poggia e opera una razionalità di questo genere. Andando al di là del mondo del politico, quest’altra faccia della ragione, una ragione non immediatamente soggetta al razionalismo e alla traduzione trasparente, mantiene una necessaria distinzione tra quanto è noto e quanto deve essere ancora realizzato, tra la prescrizione e l’iscrizione, e pertanto preserva i limiti del politico. Tutto può benissimo essere “politico”, ma non tutto può essere ricondotto, in un singolo istante storico, alla logica strumentale della politica istituzionale. Ciò che ottenebra e sfugge a quella logica (la natura inopportuna, inattesa e sregolata dell’essere individuato e collettivo nel mondo) è ciò che si potrebbe chiamare il poetico. Forse non v’è alternativa separata, autonoma, al capitalismo imperante che struttura il mondo odierno. La modernità, l’occidentalizzazione del mondo, la globalizzazione, sono le etichette QUESTIONE DI STORIA di un ordine economico, politico e culturale che apparentemente si è instaurato per un tempo di cui non è possibile prevedere la fine. Lo schema capitalista della modernità occidentale pone i termini e le condizioni politico-economiche, non i risultati, della produzione e della riproduzione. Nondimeno, è chiaro che esistono anche le possibilità (indubbiamente più di dimensione locale, di effetto transitorio, e di aspirazioni modeste) di farsi strada, penetrare e percorrere questa formazione storica. È possibile spostare la “logica” prevalente, frustrarne la natura feticista, criticarne la cultura, deviare dai suoi precetti, “tradurne” le traiettorie. Forse, e malgrado le asserzioni politiche del contrario, il passaggio storico da una modalità di produzione all’altra non è mai stato gestito e condotto in maniera consapevole. Sulla scia di un’eredità compressa e in divenire, scaturisce una scelta politica tra la fede (sia teleologica che teologica) in un’alternativa autonoma eppure futura e un’altra che cerca la redenzione nell’unico spazio e nell’unico tempo a nostra disposizione. Non si tratta di proporre una distinzione astratta tra idealismo e pragmatismo, che sarebbe uno scarso conforto e una prospettiva superficiale. Si tratta invece di esaminare una distinzione tra la presunzione di ricondurre il mondo a un umanesimo soggettivista che proclama l’oggettività nella riconferma dell’autorità del sé persino nelle proiezioni più utopistiche, e il tentativo di agire, pensare ed essere in maniera più partecipe, senza il sostegno di siffatte promesse. Se il primo atteggiamento fornisce la consolazione data dalla garanzia di un’autorità morale e di una distanza critica, il secondo tradisce il conforto della conferma intellettuale e cerca piuttosto di costruire una politica in cui ascoltare le voci, le storie, le esperienze… i silenzi, significa porsi di fronte a ciò che non è immediatamente reperibile per il desiderio e il progetto dell’ascoltatore. Porsi di fronte a ciò che supera il “politico”, al fine di metterne in discussione sia le pratiche istituzionali che i fondamenti teorici, vuol dire rendere vicino e inquietante ciò che non può essere reso cristallino, razionale e gestibile. Pertanto, registrare i limiti del politico non equivale solamente a reiterare i limiti più ovvi dell’organizzazione e della distribuzione del potere del governo e dei partiti politici nella società civile, ma anche a continuare a insistere storicamente su ciò che si trova al di là della lo- IAIN CHAMBERS ro portata e della loro comprensione: il mondo differenziato e la cornice terrena che eccedono i particolari passaggi in cui loro, tu e io ci muoviamo, viviamo e moriamo. Questo appello a ciò che va al di là conferma la nota asserzione di Emmanuel Lévinas sull’impossibilità etica della chiusura, del controllo, della totalità definitivi e del parallelo programma per rendere tutto (scientificamente, tecnicamente, politicamente, culturalmente) trasparente. Ciò che eccede il desiderio universale della chiusura, della conclusione e della conferma del sé è ciò che eccede e sfida la nostra comprensione. Una disposizione critica deve saper abitare questa soglia: da un lato prendere seriamente le asserzioni politiche, spingere i loro linguaggi multipli (emotivo, razionale, morale, tecnico, scientifico) verso la responsabilità del mondo; dall’altro lato, registrare il non rappresentato e il non rappresentabile. È una posizione in cui la stessa ontologia (il fondamento presunto e la base della formulazione politica e del riconoscimento del mondo) diviene soggetta a essere messa in discussione. Una volta che il pensare e l’agire vengono spostati dalle rassicurazioni astratte del razionalismo, si affacciano in un mondo in cui il sé è incapace di possedere completamente il sé (Schürmann 1990, p. 23). Ecco che la critica apprende a spostarsi entro i limiti storici che ne sostengono la voce, dato che il pensiero mina una conoscenza presunta. Rifiutare di operare una netta scissione tra poetica e politica apre la strada alla questione del potere economico e statale che dà luogo a una diversa maniera di accettare queste condizioni mettendone in discussione i loro fondamenti, il linguaggio e la logica. Una proposta di questo tipo non viene portata avanti come compromesso o come adattamento liberale allo status quo, bensì come un disfacimento radicale delle premesse stesse da cui dipende il breviario dell’azione politica. Ciò significa tentare deliberatamente di frustrare l’esigenza intellettuale della rappresentazione, confondere e confutare indirettamente un linguaggio avvezzo alla conferma e alla chiusura della “ragione” che ne consegue (Buchanan 1997). Mettere in discussione la possibilità stessa di interrogare significa indebolirne le premesse riportando alla luce i limiti. Ma davvero è tanto semplice? Riconoscere i limiti può anche rafforzare l’interrogativo, correggendo il tiro dell’indagine e registrando con maggiore precisione il campo QUESTIONE DI STORIA d’azione della critica che ne consegue. Nondimeno, questo è un approccio, una modalità critica, praticata senza apparati formali o metodologie esplicite (ib.), perché la preoccupazione qui non è la natura definitiva dei concetti, bensì il potere dell’articolazione, la formazione agonistica e politica della conoscenza, il linguaggio, la violenza grammaticale, che crea l’“oggetto” e la spiegazione che ne deriva. Nelle pagine e nei capitoli che seguono ho tentato di mantenere questa sregolata promessa. Capitolo secondo Cornici terrestri (…) Ciò che in ultimo ci copre è che siamo senza riparo, e che quell’assenza volgemmo verso l’aperto, quando lo vedemmo minacciare, per affermarlo nel cerchio estremo, in qualche luogo dove la legge ci tocca. (Rilke 1993, vol. II, p. 261) Da lontano, mentre lavorano nei campi di carciofi e di fragole sotto i cieli della California, oppure più vicino a noi, mentre fanno la fila per salire sull’autobus a Milano e alla cassa al supermercato, incontro le mani, le voci, i corpi precedentemente celati, che rafforzano il mio senso dello spazio. Si tratta di facce spesso scure, vite fluttuanti di emigrati, la cui attività quotidiana e il cui sfruttamento sistematico garantiscono la mia stabilità. Ora si sono inseriti nella mia vita, nel mio linguaggio, nelle poesie che leggo, “insoddisfatti” (Rich 1991, p. 44). Una donna nera, il capo chino, che ascolta qualcosa – la voce di una donna, la voce di un uomo oppure la voce dell’autostrada, notte dopo notte, metallo che scorre a valle sfrecciando accanto all’eucalipto, al cipresso, agli imperi dell’agriturismo (p. 3). Tutti noi, coscientemente o meno, viviamo la modernità alla “luce oltraggiata” di coloro che non sono sopravvissuti alla sua imposta indifferenza, di quelli che sono stati soggiogati, sovente immolati, al nichilismo delle sue razionalità strumentali. La luce dell’oltraggio è la luce della storia “che sgorga su di noi quando meno ce l’aspettiamo” (p. 49). Questa espressione di Adrienne Rich risuona all’unisono con l’enfasi che pone Lévinas sul senso della storia aperto al giudizio in ogni circostanza, ovvero, un’etica che precede ogni calcolo e verdetto, che anticipa l’azione del pensare alla storia, l’azione del pensiero. Non ci si può nascondere, non c’è una “piccola radura del tempo” in cui abbiamo sufficientemente autorità per sottrarci a questo giudizio. Siamo estremamente vul- IAIN CHAMBERS nerabili. Richiedere protezione equivale a rifiutare questa apertura, è pregare un Dio che ne nega un altro. All’affermazione di Rilke di questa legge dell’Apertura, Adrienne Rich aggiunge: Oltraggio: chi osa reclamare protezione per se stesso nel mezzo di una tale mancanza di protezione? Quale preghiera è mai? A che razza di dio? Che genere di desiderio? (ib.). In questo “atlante del mondo difficile”, un siffatto oltraggio ci ricorda dell’esposizione costante allo spazio vitale, privo di rassicurazioni. Posizionato nel linguaggio e nella proliferazione del ricordo, nessuno è nella condizione di richiedere protezione. Ai precetti della pedagogia della “civiltà”, della “società”, della “comunità” astratte, Homi Bhabha (1996) ha giustamente contrapposto un senso poetico e politico della “performatività”. La comprensione pedagogica è già al corrente di chi è il soggetto della storia, di che cos’è una società giusta, e “ardisce reclamare protezione per se stessa”. Differenza e diversità ricevono attenzione unicamente allorché riflettono la prescrizione, che si riflette nella comunanza cristallina di un’individualità priva di corpo, astratta. Il pedagogico sfugge alla possibilità che l’incerto si faccia strada, penetri e percorra le discrepanze storiche e culturali in cui avviene la nostra formazione. Se il pedagogico accumula memoria nel tempo omogeneo del progresso e nella cittadinanza speculativa dell’umanesimo, e qui dimentica, il performativo riaziona le posizioni fluttuanti dei ricordi, dell’agonismo, dell’interruzione e della sfida, dove le voci rifiutano di svanire e persiste la loro dissonanza e insoddisfazione. Negli scritti recenti sia di Homi Bhabha che di Judith Butler, l’insistenza foucaultiana sulla cornice pedagogica della formazione dell’identità e dei processi di identificazione spinge a riflettere sulla costituzione del soggetto, sia fisica e strumentale, che legale, politica (Bhabha 1996; Butler 1990). Contro la rigidità di una soggettività giuridica e istituzionalmente fondata, entrambi gli intellettuali sottoscrivono l’indifesa richiesta di una “performance” in cui un particolare soggetto storico enuncia una complessità che va al di là della regola pedagogica: il “dovrebbe”, costrutto legalizzato, si scontra con lo storico “è”. Le certezze astratte e metafisiche dell’identità (nazionale, etnica, di genere, sessuale) vengono affrontate, sfidate e violate dal continuo perpetrare di un divenire incerto, CORNICI TERRESTRI un divenire che riafferma (e qui il tono critico, sia di Bhabha che della Butler, nonché dei loro antesignani foucaultiani, certamente giustifica l’adozione di una tonalità heideggeriana) l’essere gettato in un mondo che “si rivela non essere pienamente tuo” (Thiele 1995, p. 177). Cercare di sentirsi a casa in un mondo ambiguo, arcano, non nostro, ci porta verso la libertà potenziale che scaturisce dalla comprensione dei propri limiti. Pertanto, gli incessanti interrogativi contenuti nella poesia di Adrienne Rich (1991) intitolata Eastern War Time, che vengono narrati drammaticamente dal punto di vista dell’Olocausto e degli ebrei, possono e debbono essere interpretati anche come un invito a penetrare in una dimensione della memoria (nonché dell’identità) in quanto spazio privo di tutela nel quale costruiamo la nostra casa. La memoria è ciò che rammenta continuamente che ci troviamo “sulla terra e sotto al cielo”, che ci ricorda la condizione di ritrovarci nel mondo privi di protezione. La memoria rivela questa dimensione, rifiutandosi di soddisfare il nostro desiderio di chiarezza soggettiva e di eternità temporale di una verità immutabile, perché quando parla, la memoria ci dice: Non è possibile ripristinarmi o inquadrarmi Non posso restare ferma – Sono qui nel tuo specchio – fianco a fianco con te Impicciona impertinente aspra balenante di ciò che mi rende impossibile da uccidere, anche se uccisa (Rich 1991, p. 43). Tutti vivono la memoria, eppure nessuno la possiede. La memoria non risiede semplicemente nelle nostre tradizioni, nei nostri rituali, nei nostri costumi, nei nostri corpi, nelle nostre istituzioni e nei nostri monumenti, e nemmeno nel profondo di noi stessi e dell’inconscio individuale. Questo sito di essenza concentrata è la sostanza storica del nostro ambiente terreno. Ecco che forze al di là della strumentalità immediata del mondo profferiscono parole e mi instradano verso l’altro lato del linguaggio. Vengo diretto verso l’insistenza tacita del terrestre e la presenza di un altro, e questo alimenta un pensiero che non è ostile né all’ascolto, né all’accettazione dei limiti. Mi ritrovo nuovamente sull’orlo del vuoto ontologico tra la rassicurazione dell’i- IAIN CHAMBERS dentico e lo slittamento indotto dall’alterità. Questo è il vuoto che si attraversa nel passaggio dal familiare al non familiare, dal consueto all’eccezionale. È contrassegnato dall’interruzione di un tempo cangiante ed estatico che, come eccesso di linguaggio (nella memoria, nella poesia, nella musica, nell’arte, nel terrore, nell’amore…) interrompe drasticamente il continuum del prevedibile, esortandomi a rivedere la relazione tra me e i linguaggi nei quali risiedo. Nuovamente, questo significa, se non sciogliere, quantomeno allentare i nodi che mi tenevano saldo nel mio senso dell’appartenenza, che in apparenza tenevano unite le differenze del mondo in una valutazione unilaterale e fornivano i legami che mi spingevano verso la conferma perenne della mia casa. Gli strettissimi legami tra lo storicismo, lo scientismo e l’imperialismo, la concezione della conoscenza che, fin dal tramonto del Rinascimento, hanno istituzionalizzato e diffuso l’egemonia dell’ego occidentale, si destano e cominciano ad avvertire la pressione del dubbio e dell’interruzione. Il desiderio purista che questi discorsi sorreggevano (è il sogno ancestrale di realizzare l’assoluto epistemologico e politico) è stato interrogato da ciò che la modernità ha represso nella collettivizzazione violenta e nell’oblio simultaneo delle storie, delle vite e dei corpi sfruttati, colonizzati, schiacciati, resi schiavi, sterminati. La tecnologia è l’umanesimo È proprio questo il punto in cui il nodo modernista stringe con maggiore forza metafisica, umanesimo e tecnologia. Contrariamente alla concezione popolare e al sentimento superficiale, la tecnologia e l’umanesimo coincidono e assumono la connotazione di termini equivalenti. Non sono antagonisti, l’una dipende dall’altro, perché la tecnologia rappresenta il culmine della metafisica occidentale e la sua appropriazione del mondo ruotante attorno a un “io” sovrano. La metafisica e la tecnologia occidentali coesistono in una volontà comune di mondeggiare il mondo in un’immagine soggettiva e soggiogata. Il mondo viene inquadrato cognitivamente, per apparire dinanzi al soggetto come oggetto, pronto per essere afferrato e dominato, condotto nella propria so- CORNICI TERRESTRI vranità e sotto il suo controllo. Questo soggettivismo è l’anticamera del successivo uso strumentale del mondo che ci circonda. Si tratta della struttura metafisica, del presupposto che il mondo sia subordinato alla volontà, al linguaggio e al dominio del soggetto “che esperisce la propria relazione essenziale come reificazione (intesa come padronanza) di ciò in cui si imbatte” (Heidegger 1939), che chiarisce nella maniera più succinta l’espressione di Heidegger (1962a, p. 5) secondo cui “l’essenza della tecnica non è affatto qualcosa di tecnico”. Ma il discorso non si limita al pensiero che rende straordinariamente vicini i poli in apparenza diametralmente contrapposti dell’umanesimo e della tecnologia. Soffermandosi sul soggettivismo che passa per oggettività estrema, Heidegger riconduce drammaticamente la nostra attenzione su quella tendenza della conoscenza e del potere, comunemente messa in relazione con l’opera di Michel Foucault, che ci garantisce la nostra centralità, il nostro mondo. Come dice Heidegger (1950a) in L’epoca dell’immagine del mondo: “il mondo diviene immagine e l’uomo subiectum” (p. 97), e questo costituisce “il tratto fondamentale del Mondo Moderno” (p. 99). Ridotte a una cornice comune, a un oggetto che riflette quelle che dovrebbero essere le mie necessità, le distanze e le tecnologie del mio alveo terrestre, le sue forze differenziate, incalcolabili e persistenti trovano immediata espressione nei calcoli, nelle tecniche e nelle tecnologie che rappresentano me e soltanto me: le altre modalità di pensare e di essere vengono bandite dalla narrazione. Leslie Paul Thiele (1995, p. 199) osserva giustamente: “l’immagine del mondo assurge al ruolo di principale misura dell’umanità. In pratica, si identifica con la realtà stessa”. E prosegue: A questo punto, con un ironico colpo di coda, l’oggettività stessa del mondo scompare. Tutto ciò che esiste ora viene a esistere, da un punto di vista tecnologico, perché è rappresentato o prodotto da noi. Come afferma Heidegger, “tutto ciò che si frappone al senso non si frappone più davanti a noi in quanto oggetto”. Pertanto, noi non parliamo più unicamente di un antropocentrismo che oggettiva il proprio mondo al fine di sfruttarlo: noi parliamo di un “antropomorfismo incondizionato” che crea un mondo a sua immagine (p. 200). IAIN CHAMBERS Tutto ciò che non si inquadra in questo “antropomorfismo incondizionato”, tutto ciò che non riesce a riprodurne la logica, viene escluso dal pensiero e bandito dalla comprensione1. Il mio divenire viene soppiantato e, infine, spostato dalla mia identificazione col mondo: l’umanesimo si rivela essere il soggettivismo occidentale. Tuttavia, quando il mondo diviene mio, ricondotto a una logica unica che serve unicamente per riflettere me stesso, la mia libertà subisce una drastica limitazione. Non si tratta dell’impetuosa libertà che mi consegna il mondo affinché ne disponga a mio piacimento, bensì della libertà di essere nel mondo e quivi di trovare la mia strada. Non è la libertà di dominare, bensì la libertà di essere nel mondo, di scontrarmi con i limiti del mio egotismo e provare la meraviglia che va al di là di esso. È la libertà di rispondere alla vita nel mondo, nonché assumersene la responsabilità, non in qualità di padrone, bensì come custode. O per dirla con Heidegger, in qualità di amorevole pastore. Evidentemente, ciò approfondisce l’annosa tematica della relazione tra metafisica, tecnologia e capitalismo nella creazione del sistema mondo contemporaneo. Se l’attenzione critica si è concentrata sul terzo termine dell’elenco, inteso come modalità fondamentale di produzione dell’epoca moderna, i primi due sono stati relegati all’ambito della sovrastruttura e delle relazioni sociali della produzione, entrambi assoggettati all’onnisciente pulsione del capitale. Nondimeno, la tecnologia non scaturisce semplicemente da un modello unico di produzione. Il sogno leniniano di coniugare elettricità e socialismo in una collettività futura, e la produzione di massa fordiana della mobilità individuale, pur indipendenti da un punto di vista ideologico, separati, erano affini da un punto di vista tecnologico (nonché metafisico). Quantunque la storia, in maniera cinica, abbia ribadito perentoriamente che si trattava sempre di capitalismo, non essendo altro il socialismo di Stato che un modo diverso di denominarne l’instaurazione, mi pare che ascoltando Heidegger relativamente alle tematiche della metafisica e della tecnologia sia possibile comprendere in maniera più precisa la volontà del capitale, al fine di metterlo in discussione, preve- 1 L’espressione “antropomorfismo incondizionato” è tratta da Heidegger 1961. CORNICI TERRESTRI dendo di interrompere la sua affascinante e, apparentemente, omogenea storia del “progresso”. Con questo si vuole proporre un senso dell’essere che non sia né un idolo, né una forza religiosa (per quanto possa attenere alla sfera del sacro); si vuole proporre un senso dell’essere che esiste al di là dell’umanesimo soggettivista dell’essere umano e che a esso non possa essere ricondotto. Questo perché ciò che esiste e che continua al di là di una ratio imposta sulla rivelazione calcolata, e la conseguente realizzazione di ciò che ormai è un progetto planetario, pone una domanda assillante. Fornisce l’occasione per interrompere un linguaggio la cui particolare differenziazione nella storia, nella scienza, nella tecnologia e nel mercato è secondaria al suo comune desiderio e progetto metafisico. Significa porre in discussione una logica astratta che si ritiene capace di trascendere ogni particolare, ogni luogo, ogni persona ed esperienza, al fine di giungere al quadro completo, alla spiegazione piena e totale. Per rifiutare di inquadrare il mondo in un reticolo unico concepito da un punto di vista unitario dobbiamo riconoscere, o meglio, ascoltare l’altra campana della particolare storia che ha inculcato questo desiderio e questa pulsione per l’omogeneità. Significa confrontare lo sterile conforto di fare ritorno a casa (la conferma delle premesse che disegnano la mappa e garantiscono il viaggio metafisico e la sua realizzazione tecnologica) con ciò che cozza con la spiegazione, ne fuoriesce e la disturba, con ciò che non trova una facile collocazione, con ciò che in questo particolare ordine di cose rimane senza tetto. Ecco che allora ciò che chiamiamo “storia”, l’ideologia della conoscenza che ritiene di poter afferrare, a livello globale, la dinamica del nostro essere, prende coscienza dei propri limiti. Di fronte a un mondo che pare sopraffatto dalla volontà di una razionalità strumentale che si chiama ragione, scienza, tecnologia, progresso, nonché loro configurazione globale nel capitalismo contemporaneo, esiste al contempo un ethos, un aspetto terrestre, una base che sfugga alla sua logica? Per Heidegger, come per i poeti, i musicisti, gli artisti e i custodi dello straordinario e dell’estatico, la risposta va cercata nell’erranza del linguaggio. Il linguaggio apre all’enigma di ciò che resiste e si ritira dalla struttura esclusivamente razionalista del mondo. IAIN CHAMBERS Proprio l’erranza del mondo rende possibile che la domanda perseveri in quanto domanda, facendo ripetutamente capolino per recare la promessa dell’interruzione. Un’altra modernità Uno scenario del genere richiede che si dia ascolto alle ombre, laddove l’orecchio interiore della storia percepisce il non detto e l’indicibile mentre il tempo divora se stesso nella ricerca di una salvezza irraggiungibile nelle prosaiche inezie del mondo (Buci-Glucksmann 1990, pp. 16-17). Forse la modernità ombreggiata del Barocco, un richiamo che si insinua continuamente nelle mie osservazioni, è proprio l’ambiente in cui si può scorgere e udire un’estetica alternativa, soggetta a manifestarsi tra l’inquadramento terrestre e il divenire del mondo. Il mutevole connubio tra corpo e mente, tra sensualità finita delle passioni e infinito agognato della ragione, tra l’insistenza fisica della danza e la geometria astratta del razionalismo, questione che il classicismo avrebbe poi risolto a favore del secondo elemento di ognuna di queste dicotomie, trova qui forte e continuo sostegno (Angoulvent 1994). Esplorando le contingenze mondane (si vedano El Greco, Caravaggio, Giordano, Ribera, Rubens, Rembrandt, Velázquez), ove la visione è sempre meno che trasparente, e il suono rievoca sensibilità indomabili, si riscontra una notevole eco dell’esperienza della tarda modernità. Che la si interpreti dall’una o dall’altra estremità dell’epoca storica, dai suoi inizi putativi e dalla presunta conclusione, è una vicinanza catturata, in maniera suggestiva, nell’assonanza del passaggio tra “barocco” e “rock”. Nel liuto di John Dowland e nella chitarra di Jimi Hendrix, si insiste nella promessa di inquadrare i suoni in maniera netta contro l’astrazione oltremondana dell’estetica classica, per la quale la forma è atemporale, il dettaglio esclusivamente femminile, l’ornamento decadente (Schor 1987). Inoltre, ascoltare il Barocco, esattamente come ascoltare il jazz, significa cogliere l’annuncio di un passaggio critico dalla visione unilaterale dello sguardo imperioso alla dispersione del tono, dalle fantasticherie della trasparenza in cui tutto si rivela all’interminabile odissea del suono e all’infinito del non finito. CORNICI TERRESTRI Ascoltare questo aspetto del linguaggio vuole dire trasgredire al rigido sistema della logica, nel quale ci troviamo apparentemente fissati. Significa evocare una risposta storica che si esprime in termini che non possono essere circoscritti a una sola epoca in particolare. Le generazioni trapassate scalpitano e incalzano. Parlare significa sempre parlare sulla scia del linguaggio. Il linguaggio registra e parla di questa quiescenza. In questo intervallo si profila la nostra casa. Il linguaggio fornisce il riparo e, in quanto poesia, musica, musa, memoria, canta “l’accordo, sempre lo stesso, sempre cangiante, che in ogni istante attraversa l’essere-nel-mondo nella sua interezza, modulando la differenza tra cose e mondo, tra Terra e mondo” (Harr 1993, p. 114). Nell’apertura del linguaggio mi imbatto nella fragranza di ciò che non potrò mai afferrare appieno: l’imperscrutabile cuore dell’abitare “la casa del mondo sulla Terra e sotto al cielo” (Heidegger, citato in Harr 1993, p. 115). È qui che si colloca l’etica. Questo arrivo imprevisto e inatteso riporta la storia ad ascoltare quell’aspetto della narrazione, spesso tacito, o forse percepito come mormorio incomprensibile, che riceve e riconosce l’altro. L’estensione della “mia” storia a un’altra equivale ad accettare questa integrazione nei suoi termini irruenti. È lì che l’astrazione dell’alterità viene resa vitale, concreta, e la mia narrazione temporale viene resa responsabile. Ciò significa far affrontare alla tradizione ciò che non è in grado di contenere, perché l’ospite è chiaramente l’ambasciatore delle “ambiguità della traduzione” (Clifford 1988, pp. 45-46). Una storia che si espone prevedendo un simile arrivo è una storia dell’interruzione introdotta dall’estraneo, dall’altro. Si tratta di una storia di passaggio e di traduzione, nella quale la continuità del regime della rappresentazione, mediante il quale comprendo il “politico”, la tradizione e la democrazia, la cittadinanza e lo Stato, i limiti e la legge, viene posta in un punto critico e privo di garanzie (Derrida 1996). L’altro introduce l’altro aspetto della politica, oppure un’altra politica: l’aspetto represso della mia rappresentazione. In questo discorso, in questa precisa situazione storica, culturale e politica, si insinua il fatto che non esiste più l’altro per me, ma soltanto l’altro accanto e al di là di me. Ecco, questa è la “tragedia” dell’ascolto, contrapposta al rilassamento della prospettiva chiusa, ed è proprio questo che, come IAIN CHAMBERS rileva Edmond Jabès (citato in Christine Buci-Glucksmann 1992), apre una relazione con l’infinito, l’impensato, proponendo di misurare il silenzio per mezzo dell’ignoto e dell’insondabile. È qui che l’estetico e l’etico divengono una sola cosa. La proposta di Lévinas è di instaurare una responsabilità tendente all’infinito. In prossimità di un altro, il fragile cerchio dell’autoconferma si spezza e il linguaggio rifugge dalla semantica del sé. Per Lévinas non è solo dai nostri limiti e dalla nostra finitezza, in ultima istanza dalla nostra morte, che dovrebbe scaturire il nostro pensiero, ossia l’ontologia, bensì da ciò che non potremo mai esperire o spiegare appieno. Se il primo tipo di origine riafferma l’unicità del pensiero e il suo potere anche sull’ignoto e sull’insondabile, il secondo abbisogna di una risposta che non viene mai ricambiata, che è incapace di parlare per una differenza inquietante e una distanza incolmabile, pur accettandone la responsabilità. È un ritorno alla ragione, al pensiero, dell’alterità che la ragione tenta di cancellare per confermare la sua sovranità. A questo punto ciò che appare più evidente non è una conclusione, un edificio pianificato della teoria che ammaestra la pratica, bensì un percorso nel mondo che rifugge sistematicamente da queste chiusure verso la regione aperta in cui apprendiamo che la nostra capacità di comprensione è sempre minore della storia che abitiamo, e che il linguaggio che abitiamo va al di là delle nostre aspettative. Un senso dell’essere che mi appoggia e al contempo mi supera in quanto individuo, attraversa e va oltre il pensiero che tenta di afferrarlo, che rimane irriducibile a una volontà strumentale. Questa è la situazione, per tornare ai versi di Rilke con cui si apre il presente capitolo, in apparenza tanto fragile e precaria, che ci può sostentare. Come apprendimento dei limiti questo inquadramento delle tematiche che mi configurano propone che le maniere di pensare che ho ricevuto in eredità dalla modernità siano procrastinate in maniera radicale e irreversibile. Il senso si lascia alle spalle una semantica rigida per apprendere la direzione, il movimento, l’incompleto: (…) non come ‘significato’ dell’essere, ma come la sua direzionalità. Il ‘senso’ va inteso qui come direzione nella quale si situa qualcosa, ad esempio il movimento (questa accezione sia dell’inglese sense che del francese sens ovvero dell’italiano ‘senso’ – senso di un fiume o CORNICI TERRESTRI del traffico – non deriva dal latino, ma da un verbo indo-europeo che significa viaggiare, seguire un sentiero) (Schürmann 1990, p. 41). I capitoli seguenti analizzeranno questo “senso” nel contesto sia della musica barocca che di quella contemporanea, nelle tematiche architettoniche, in varie letterature… nei ricordi della modernità affidati alla custodia del linguaggio, del suono, degli edifici e delle nostre vite che si dipanano tra di essi. Capitolo terzo La storia, il Barocco e il giudizio degli angeli Non c’è salute. I medici dicono che al meglio possiamo godere di una neutralità. C’è malattia peggiore del sapere che non c’è salute, né mai ci sarà? John Donne (1611a, p. 155) Le parole di Donne riecheggiano con la “caduta nel tempo secolare”, con la caduta in un mondo che “è frantumato in una serie di entità diverse, disgregato da un qualche presunto stato di trascendenza di unità primaria ed eterna” (Docherty 1986, pp. 37-38). L’universo antropomorfo, la cui verità conclusiva e irraggiungibile veniva garantita dalla rivelazione di Dio, si decentra per effetto di un eliocentrismo indifferente. L’umanità si ritrova imprigionata in uno stato di esilio perenne, esposta al morbo che impazza nel mondo, in cui il tempo, la verità e il corpo vengono violentati dalla storia e dall’errore dei suoi metodi1. Risuona col suo alveo nell’universo come arte della testimonianza. Dispersa nello spazio (Keplero, Pascal), decentrata, l’uniformità della logica e della natura è disseminata di aspetti accidentali: l’ornamentale, il decorativo e il monumentale. Il continuum dello spazio urbano viene interrotto e deviato dall’effimero e dalla sorpresa che minaccia di far persistere un siffatto ordine (Sarduy 1975). In qualità di “apparenza pura e semplice”, di facciata, l’ornamentale svela la “struttura della sensazione”, essenziale nel Barocco. Ecco che, nell’estetica dell’abbellimento, nel rifiuto di concludere e riconoscere un ordine naturale, nell’insistere su una testimonianza temporale e nella provocazione accidentale dell’evento, osserviamo i sensi all’opera mentre si dispiegano, si interrompono e dirottano il predestinato e l’ordinato. 1 Sul Barocco in quanto periodo di “crisi generale”, che l’assolutismo monarchico ha tentato di controllare e gestire, si veda Maravall 1975. IAIN CHAMBERS La facciata e l’ornamento Santa Maria del Giglio a Venezia è stata inaugurata nel 1683. Al cospetto dell’osservatore si presenta una facciata in cui i riferimenti religiosi vengono sostituiti interamente da un peana scultoreo (“statue nell’attitudine teatrale ormai consueta”, Ruskin 1853, p. 214) celebrativo di Antonio Barbaro e della sua famiglia1. Domina la facciata, opera di Giuseppe Sardi, la statua di questo ammiraglio della Serenissima. Ai suoi piedi si collocano sei scene di battaglie navali contro i turchi, statue dei suoi fratelli, e le carte topografiche di sei città (Zara, Candia, Padova, Roma, Corfù, Spalato) significative nella vita militare e diplomatica del comandante veneziano. Incorona l’opera intera la statua della Gloria, affiancata dalle Virtù Cardinali, e accompagnata dall’Onore, dalla Virtù, dalla Fama e dalla Saggezza. In questa ostentazione pubblica di trionfo storico, un’apparente trascendenza viene intenzionalmente compromessa da una pompa e da una vanità basate sugli emblemi effimeri della mortalità2. Ciò che vediamo è una facciata, uno spettacolo, una tela, uno schermo, nel quale osserviamo come il Barocco riflette se stesso. Inchiodata nella storia, senza alcuna garanzia a parte quella di morire, questa sensibilità fa scaturire un senso dell’essere dal dialogo continuo coi suoi limiti. Il suo scopo risiede all’interno di se stessa: l’erotismo del gesto, la frustrazione pianificata della forma e la funzione che integra e sovverte la chiusura del logos, e rende il linguaggio un evento la cui verità artificiale, storica riecheggia per tutta l’estensione della grammatica dell’epoca. Tra la melodia malinconica e i foschi accordi dell’opera di John Dowland Semper Dowland, semper dolens (1604), e il riecheggiante ostinato del basso e gli arpeggi inquietanti dell’opera di Silvius Leopold Weiss Tombeau sur la mort de M’ Comte d’Logy (1721), tra questi due componimenti per liuto, percorriamo per intero il prisma musicale del Barocco. Il liuto stesso, delicato e intricato nella sua struttura, nella melodia e nell’esecuzione della propria musica, è un’allegoria del traballante ponticello che 1 John Ruskin (1853, p. 230) considerava “le chiese erette in questo periodo (…) così basse e grossolane che persino i critici italiani (…) usano dei peggiori termini di rimprovero”. 2 Si veda Mario Perniola, “L’essere-per-la-morte e il simulacro della morte”, in Perniola 1983. LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI congiunge gli estremi del razionale e del non rappresentabile che caratterizza tanto profondamente questa epoca. Già nel 1750, nell’anno in cui si spensero sia Weiss che Bach, lo strumento era già un pezzo d’antiquariato, il suo ruolo essendo stato assunto dalla razionalità più resistente e più razionale della chitarra. I liutisti dell’Inghilterra, della Francia e della Germania hanno proiettato le loro sonorità nelle forme e nei ritmi forniti dalle danze preesistenti, raccolte in seguito sotto forma di suite: la gagliarda, l’allemande, il gigue, e poi la courante, il minuetto, la gavotta, la bourée e la sarabanda. Non si tratta di prestiti puramente imitativi, bensì di innovazioni che attirano l’attenzione sulla creazione della musica nel metro preso a prestito: L’atteggiamento consueto del virtuoso strumentale che adibisce i modelli metrici, armonici e melodici delle musiche da ballo ad un uso esclusivamente sonoro e cameristico (e non coreico) inclina volentieri, è vero, verso l’elaborazione artificiosa, la dissimulazione sottile del modello, la sua sublimazione nel giuoco delle figure e dei passaggi idiomatici: il musicista si impossessa della musica da ballo e, riproducendola sul suo strumento, tende a denaturarla, a farne il mero oggetto d’un trattamento esecutivo e compositivo al quale consegna l’interesse artistico del brano (Bianconi 1982, pp. 98-99) Accanto all’analisi di queste strutture preesistenti, un’analoga importanza ha avuto la libertà musicale dello stile e dell’esecuzione, sviluppata da Dowland a Weiss, da René Mésangeau a Denis Gaultier e Robert De Visée, nei capricci, nei preludi, nelle fantasie e nel loro fosco apice dell’orazione funebre del tombeau. Mi interessa del liuto e dell’ultima tipologia di composizioni il fatto che questi spartiti si avvalgono insistentemente della malinconia. Emblematica dimostrazione di questa sensibilità sono i titoli dei componimenti di Dowland: Lachrimae antiquae, Forelorne Hope Fancy, Farewell 1; tuttavia, è col tombeau secentesco dei liutisti francesi e tedeschi che tale tendenza raggiunge lo zenit. Queste composizioni (Monsieur Bianrocher di Dufaut, Monsieur de Lenclos di Gaultier, Baron d’Hartig di Weiss) contrassegnano il tempo 1 Lacrime antiche (latino), Fantasia della speranza perduta e Addio (inglese) (N.d.T.). IAIN CHAMBERS come dialogo perenne coi defunti. Interpretare il passato significa anche, come afferma Michel de Certeau, incorporarlo: onorarlo ed esorcizzarlo ascrivendolo alle potenzialità del linguaggio (de Certeau 1975, p. 120). Dare un nome e un contrassegno al tempo passato e recuperarlo per il presente significa produrre un tombeau, una commemorazione funebre che al contempo celebra la vita1. Perché significa fare un posto al morto, ma anche ridistribuire lo spazio dei possibili, determinare negativamente quello che c’è da fare, e dunque utilizzare la narratività [narrativité] che seppellisce i morti come mezzo per fissare un posto ai vivi (de Certeau 1975, p. 119; corsivo nell’originale). Forse è da questo connubio, lungo i confini di mondi differenti, di vita e morte, in cui le certezze si trasformano in limiti circoscritti e l’ego viene deriso, destabilizzato e temporaneamente preso dalla malinconia prima di essere disfatto in maniera irreversibile dalla mortalità, che la poetica del Barocco trova la sua risorsa principale. Nell’ornamentale, il Barocco svela la pietra angolare su cui poggia la sua struttura: “significazione sublime in luogo e al posto del non-essere soggiacente e implicito, è l’artificio che sostituisce l’effimero” (Kristeva 1987, p. 89). Un’appoggiatura sostenuta nella melodia, variazioni ritmiche nella parte del basso, una dissonanza indugiante che si libra sulle note (acciaccatura), un breve trillo o una breve nota accidentale, il tremolo, il mordente del morso, sono tutti ornamenti che registrano le incertezze tonali; ombre di una discordia potenziale che ci conduce nei meandri del suono. Per quanto in apparenza sembrino ausiliari, si rivelano essere obbligatori (Donington 1978)2. L’ornamentale, asserisce Lorenzo Bianconi (1982, p. 94), è “aggettivo, questo, che sarà non improprio usare soltanto a patto di riconoscere all’ornamento nella musica strumentale una funzione strutturale decisiva”. Come un gioiello, l’ornamento o “fioritura” non è un 1 Sull’eco dell’idea del tombeau nel ragionamento storico, si veda Chambers 1994. Si noti la risonanza illuminante nei commenti di Edward Said sulla musica classica araba nel capitolo seguente. 2 LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI ripensamento, un abbellimento successivo aggiunto all’opera finita, bensì è il punto fondamentale su cui si basa l’opera stessa1. Come le finestrelle alla sommità della cupola barocca, le note ornamentali gettano luce sull’interno, ci guidano tra le pieghe del corpo del suono. Attraversiamo la melodia e scendiamo nel basso continuo del mondo2. Un’incertezza fosca, che aleggia sull’abisso informe che costituisce il baratro dell’essere, ci trascina giù attraverso il suono per rilasciare una visione tragica del mondo e la redenzione musicale della verità3. Sopra di noi il “centro” continua a oscillare nell’arabesco della sua elaborazione che non è mai un “di più”, ma è fondamentale per l’esecuzione, nello spiegarsi che dissemina la tonalità (Buci-Glucksmann 1990, p. 202). Come un’apertura nel suono, di solito improvvisata, esso sorprende la forma con la responsabilità e la libertà individuali dell’esecuzione. Il corpo, in particolare la mano direttamente coinvolta nella musica dalla intavolatura del liuto, sostiene la produzione e il mantenimento dei suoni tra le dita e le corde, e fornisce anche un codice immediato e intimo per gli iniziati. Come afferma Marin Mersenne: Forse pensavano di ottenere maggiore gloria mantenendo segreta quest’Arte piuttosto che divulgandola: ecco perché i brani su cui mettiamo le mani non vengono mai eseguiti come erano concepiti in origine, a meno che non siano stati ascoltati e orecchiati4. Necessariamente, ciò ci ricorda che il linguaggio del Barocco è ellittico, non finge di essere trasparente, né pretende di essere eterno. Il senso si dispiega in una sensibilità, viene in-corporato in un “qui” temporale in cui il linguaggio diviene l’arte dell’interruzione. 1 La disquisizione sull’origine del termine “Barocco” nel contesto dell’oreficeria e della lingua portoghese (barrucco, perla di taglio irregolare) è bene espressa in Sarduy 1975. 2 Si veda la descrizione di Leibniz della “casa della risonanza” multipiano in apertura di Deleuze 1988, p. 17. Il basso continuo onnipresente e in continua evoluzione è paragonabile alla “sezione ritmica” odierna della chitarra, del basso, delle tastiere e della batteria sia nel jazz che nel rock; si veda Dart 1963, p. 78. 3 Buci-Glucksmann 1990, p. 230, “De la musique, comme art de l’émotion sans concept, comme Affect de tout affect”. 4 Citato nel libretto del compact disc di Denis Gaultier - La Rhétorique des Dieux. Suite pour le luth I, II, XII, Astrae, 1989, esecutore: Hopkinson Smith. IAIN CHAMBERS La magia, la mortalità e la sfiducia della mimesi L’idea platonica della forma perfetta, il cerchio che funge da garanzia trascendentale di un’armonia a cui si ritiene che corrispondano i cieli, viene infranta dalla scoperta di Keplero dell’orbita ellittica descritta dai pianeti. Il cerchio si spezza. Il centro si sdoppia e si disperde all’interno dell’ellissi. L’archetipo si infrange, l’orbita vacilla, la mente trasvola. L’ordine chiuso della cosmologia cede il posto all’infinito dell’astronomia1. Sospeso tra le certezze del passato – quelle dell’umanesimo rinascimentale – e del futuro – le convinzioni della logica e del razionalismo di matrice scientifica – il Barocco comporta l’atto cosciente di gettare le fondamenta del proprio edificio sul nulla. Solitari e responsabili delle nostre azioni e della creazione di noi stessi, riconosciamo l’“eresia” di Giordano Bruno nella gioia di Zarathustra. Nella parabola dell’eresia di Giordano Bruno sono insiti i semi del dilemma che proietterà un’ombra sul secolo che si apre con la sua esecuzione, avvenuta in pubblico a Roma, nel febbraio del 1600. Accanto al mito popolare dell’uomo di ragione e di scienza perseguitato, che alza la voce contro l’oscurantismo papale, forse è più significativo proporre, a suo nome, un’altra rivendicazione, ossia quella contro l’Inquisizione per una libertà che consenta a un mago di grande cultura di esprimere il proprio pensiero senza per questo finire bruciato sul rogo. Si tratta, ovviamente, del punto di vista espresso in maniera magistrale da Frances Yates nel suo libro Giordano Bruno e la tradizione ermetica (1964). Tuttavia, laddove l’autrice vede in Bruno (nonché in Campanella), per esempio, la conclusione pubblica di un discorso rinascimentale esoterico prima che scompaia tra le ombre, in un ambiente più sicuro (i Rosacrociani, i Framassoni) e la sua inevitabile sostituzione a opera della formazione scientifica e post-copernicana dell’era moderna, preferisco pensare che il pensiero di Bruno costituisca una perturbazione eterna. La provocazione di Bruno che pensa all’infinito attira la nostra attenzione sia sui linguaggi ambigui del Barocco che sulle ombre represse 1 Per i dettagli relativi a questa “frattura cosmologica” nella creazione della sensibilità barocca, si veda in particolare Sarduy 1975. LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI del razionalismo. In fondo, Giordano Bruno venne condannato in quanto “uomo di lettere”. I suoi “errori” derivavano dall’ermeneutica testuale, dalla sua interpretazione di certi testi gnostici, in particolare quelli che vanno, collettivamente, sotto il nome di Ermete Trismegisto. Era un semiotico cinquecentesco che proponeva una lettura erudita, per quanto mistica, di un infinito decentrato che formalmente coincideva con la geometria scientifica dello spazio che si stava affermando. Nondimeno, l’approccio magico alla lettura della logica dell’universo non si limita a scomparire, ma bracca e pedina l’indagine posteriore. Prima di morire, nel pieno del nuovo secolo, Isaac Newton consegnò i suoi manoscritti a un baule, che venne scoperto da Keynes nel 1936. Gli scritti in esso contenuti trattano di esegesi biblica e di opere di alchimia e magia e forniscono una chiara illustrazione di come il “fisico più famoso fosse altresì il più grande mago” (Verlet 1993). Ci troviamo di fronte, come afferma Loup Verlet stesso nel suo libro sul contenuto di quel baule, alla conclusione della discontinuità iniziale, con l’occultamento delle fondamenta lesionate del discorso. Ci viene fornita una versione che esclude fratture e rotture, una versione in cui i contenuti del baule vengono ignorati e negati. Gli anni che Newton trascorse a studiare il “linguaggio mistico” vengono inevitabilmente separati e in seguito cancellati dalla sua produzione scientifica. Tuttavia, come sostiene Verlet, la matematicizzazione della realtà trova forse il suo momento genetico nell’ambito della problematica religiosa da cui trae ispirazione e prosegue cercando risposte in altre forme “non scientifiche” della conoscenza. Ed ecco che, sospesi tra le coordinate della matematica e della magia, siamo ritornati a Bruno. Il senso di perdita, il rozzo dislocamento, la caduta dallo stato di grazia nell’immenso scenario di un (dis)ordine incomprensibile e infinito, nel quale “l’uomo rotola dal centro verso la X” (Nietzsche 1906, p. 8), dà certamente il via alla geografia della malinconia barocca, all’insediamento dell’ironia, nonché alla sensibilità moderna della secolarizzazione storica. Intrappolato nella fragilità di un anelito alla trascendenza, alla completezza, al ripristino della verità, il Barocco riconosce nel tessuto stesso del linguaggio, nell’accoglienza voluttuosa della perdita, un destino di interminabili peregrinazioni che rivela continuamente, in “tutte le mattine IAIN CHAMBERS del mondo”, la follia d’una siffatta presunzione1. Ogni affermazione, gesto o espressione viene immediatamente raddoppiato dal dubbio, ogni decisione dalle ombre incerte di una dissoluzione imminente. Si realizza “essenzialmente, una nozione temporale” (de Man 1983, p. 211) che anima così profondamente la divulgazione barocca dell’allegoria e dell’ironia. In questo raddoppiamento, in cui il soggetto rifiuta di rispondere in maniera inequivocabile alle proprie affermazioni, l’ironia ostenta sia il rifiuto di rinunciare al discorso espositivo che l’impossibilità di accoglierlo nella sua interezza. L’interazione tra le affermazioni sugli oggetti e la riflessione su queste affermazioni come oggetti è di natura ambigua. Il soggetto si pone in una posizione trascendentale relativamente al discorso, ma esclusivamente per negare la possibilità di essere il garante della trascendenza (Hallyn 1993, p. 22). Le orbite vuote di un teschio, fiori freschi tra i denti, fissano assenti la strada di tutti i giorni2. Il mondo, le parole, le donne… la verità, sono diventati incostanti, relitti di una cosmologia deposta: stelle cadenti, bambini generati con la radice della mandragora, il canto delle sirene. Segnali che riveleranno la falsità “prima ch’io venga, a due o tre” (Donne 1611b, p. 35). La quiescenza temporanea delle garanzie trascendentali, precedenti il razionalismo impetuoso che ribadisce le proprie pretese sull’universo a nome dell’umanità, consente di riconoscere la piena autonomia delle rappresentazioni, la cui unica ragione è insita in esse stesse. Ricaduti sulla terra, il linguaggio, le immagini e i segni “assordantemente uniti al nulla” non possono rispondere che al proprio passaggio e alla propria presenza in queste spoglie mortali (Hélène Cixous, con allusione a Shakespeare, in Cixous, Clément 1987, p. 98). Riconoscere l’immagine della costruzione temporale dell’artificio, del simulacro, in e per se stessa, “implica la chiusura della metafisica e l’accettazione piena del mondo storico” (Perniola 1983b, p. 122). Eppure questo trova alimento, invece che 1 Il riferimento è a Tutte le mattine del mondo di Pascal Quignard (1992) e alla successiva realizzazione filmica dello stesso, su sceneggiatura di Quignard, di Alain Courneau, 1992. Sulla “triste voluttuosità”, si veda Kristeva 1987. 2 Si tratta della chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio (1604), a Napoli, in via dei Tribunali. I fiori vengono cambiati ogni giorno. LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI contraddizione, nella simultanea insopportabilità della perdita, perché la feroce consolazione del Protestantesimo e l’aggressione dell’Inquisizione sono sintomi di una profonda riluttanza alla rinuncia, soltanto in apparenza contrapposti: entrambi operano l’istituzionalizzazione dell’insopportabilità della perdita. Rifiutando di cedere l’oggetto perduto, l’elemento primario, la garanzia dell’eterna verità, le firme terrestri dei segni e dei suoni continuano a gesticolare sull’abisso del tempo in un lutto continuo che apporta un contributo diretto all’animo Barocco: Come un tratto d’unione teso fra la Cosa e il Senso, l’innominabile e la proliferazione dei segni, l’affetto muto e l’idealità che lo designa e lo supera, l’immaginario non è né la descrizione oggettiva che culminerà nella scienza né l’idealismo teologico che si accontenterà di culminare nell’unicità simbolica di un aldilà. L’esperienza di una melanconia nominabile apre lo spazio di una soggettività necessariamente eterogenea, divisa tra i due poli co-necessari e compresenti dell’opacità e dell’ideale. L’opacità delle cose come quella del corpo disabitato dalla significazione – corpo represso pronto al suicidio – si trasferisce sul senso dell’opera, che si rivela a un tempo assoluto e corrotto, insostenibile, impossibile, da rifare. S’impone a quel punto una sottile alchimia dei segni – musicalizzazione dei significanti, polifonia dei lessemi, disarticolazione delle unità lessicali, sintattiche, narrative… – che viene immediatamente vissuta come una metamorfosi psichica dell’essere parlante tra i due bordi del non-senso e del senso, di Satana e di Dio, della Caduta e della Resurrezione (Kristeva 1987, pp. 89-90). Pertanto, il mondo non solo subisce un decentramento, ma anche un raddoppiamento a causa dell’insistenza coeva sul dogma e sul dubbio in ogni ambito. Aperto alla costruzione e al determinismo, il mondo diviene altresì soggetto a una poetica dell’ambiguità, a una fenditura nella ragione in cui il concetto razionale può scivolare nei contorni allitterativi del sogno1. Le linee rette di cui si avvalgono l’astronomia e l’architettura per la razionalizzazione 1 Il Sogno di Keplero, pubblicato postumo dal figlio nel 1634, descrive i fenomeni celesti come apparirebbero dalla luna. Sotto forma di manoscritto, anche precedentemente circolavano alcune versioni dell’opera, e sembra che John Donne fosse al corrente del pensiero di Keplero. Si veda al proposito Hallyn 1993. A Dream (Un sogno) è anche il titolo di una bella fantasia per liuto di John Dowland. IAIN CHAMBERS geometrica del tempo e dello spazio vengono sfumate, mimate e imitate dall’alchimia e dalla negromanzia, dalle equazioni magiche, dalle decorazioni emblematiche e dalle restrizioni terrestri della vita, prima che tutto evapori nell’ingannevole ordine della musica: la nota fluttua nell’aria, indi svanisce. Svanendo… in quel momento di transizione, di scomparsa, in quell’eccesso di rappresentazione, il funzionale e il razionale vengono esposti come credenze fragili: logiche che, malgrado la propria dichiarata neutralità, sono sempre circoscritte dal desiderio umano. In nessun luogo ciò si nota in maniera più forte che nell’applicazione reiterata della “scienza” alla musica che si riscontra nelle opere di Pierre Gassendi, Marin Mersenne e René Descartes. Nella ricerca di un’armonia universale nella geometria del suono e di un’aritmetica delle passioni, essi si avvalevano della matematica mitica di origine greca e bizantina, la quale tradisce inevitabilmente le pulsioni alchemiche, astrologiche e magiche che permeano perennemente la ragione barocca (si vedano Mersenne 1985 e Gassendi 1992)1. Se la distanza più breve tra due corpi è la linea retta, la scossa dell’allegorico fornisce il trasporto più celere dall’ovvio al geroglifico e all’altro fuoco oscurato dell’ellissi. Qui Nicholas Dyer, architetto, responsabile dell’edificazione di sette nuove chiese nelle città di Londra e di Westminster nel 1711, ci rivela una logica che si concilia con una concezione insospettata: E così completerò la Figura: Spittle-Fields, Wapping e Lime-house hanno composto il triangolo; Bloomsbury e St. Mary Woolnoth hanno poi creato il pentacolo maggiore e, con Greenwich, tutti quanti formeranno la dimora sestupla di Baal-Berith ovvero il Signore dell’Alleanza. A quel punto, con la chiesa di Little St. Hugh, la Figura dell’Ettagono s’ergerà dominando Black Step Lane e, in tal guisa, ogni linea retta verrà arricchita con un punto verso l’Infinito e ogni Piano con una linea verso l’Infinito. Chi è in grado, conti il Numero: le sette Chiese sono edificate in congiunzione coi sette Pianeti nell’Orbita Celeste inferiore, i sette Cerchi dei Cieli, le sette Stelle dell’Orsa Minore e le sette Stelle delle Pleiadi. Little St. Hugh è stata scagliata nell’Abisso assieme ai sette Segni sulle sue Mani, Piedi, 1 Descartes scrisse un Compendium Musicae, pubblicato postumo a Utrecht nel 1650, disponibile nella versione italiana del 1990. LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI Fianchi e Petto che mostrano i sette Demoni: Beydelus, Metucgayn, Adulec, Demeymes, Gadix, Uqizuz e Sol. Ho architettato un Ordine eterno, che posso contemplare ridendo: ora nessuno può eguagliarmi (Ackroyd 1985, p. 186). Nella sua oramai classica descrizione del pensiero intellettuale inglese di quel periodo, La cultura inglese del Seicento e del Settecento, Basil Willey (1953) ritorna a più riprese sull’ambiguità profonda insita nella sua voce. Egli mescola con cura discorsi sull’alba dell’era della ragione e sul trionfo della scienza, insistendo sulla qualità bifronte dell’epoca, con la sua capacità di vivere in “mondi distinti e separati” (Sir Thomas Browne, ib., p. 48). Perché ciò che era nuovo non sottintendeva necessariamente una frattura irreparabile del tempo, bensì una nuova contestualizzazione di elementi che al contempo incoraggiavano e sviavano la possibilità di una verità indivisibile da localizzare nell’ambito di un razionalismo meccanico che “immagina stabile ciò che invece è mutevole” (Francis Bacon, ib., p. 42). Scrivendo in un’epoca in cui, con Werner Heisenberg, l’incertezza era assurta al ruolo di principio nel paradigma delle scienze naturali, Willey (p. 48), giustamente, interroga la visione razionalista del periodo precedente, asserendo: Si iniziava solo allora la formulazione delle distinzioni che nelle età successive separarono la poesia dalla scienza, la metafora dal fatto, l’immaginazione dal raziocinio. L’aspetto più importante di questi mondi diversi non era che essi erano divisi, ma che erano validi contemporaneamente. Questo inquadramento del pensiero e della vita rimaneva sospeso in un equilibrio fluttuante e ambiguo tra luce e tenebre, tra l’impalcatura piatta e tabulare della ragione e le pieghe infinite e stratificate della spiegazione. Scrive Fernand Hallyn (1993, p. 20): Possiamo considerare il Seicento e il Settecento come il periodo di transizione dalla predominanza dell’asse verticale, che collega i vari livelli della realtà, alla predominanza dell’asse orizzontale, che riconduce tutto a un solo livello. Tra lo spiegare (ossia fornire una spiegazione, ma anche svolgere qualcosa di avvolto) e il piegare (avvolgere, avviluppare, incar- IAIN CHAMBERS tare), emerge lo spiegamento (spiegazione, apertura dell’involucro, svolgere un incartamento). Contrariamente al punto fisso del razionalista a priori, che cercava Cartesio, qui c’è il mutevole punto di vista del corpo, nel quale dare una spiegazione significa aprire l’involucro, svelando una complessità e rintracciando l’in-finito nelle pieghe, nelle sgualciture e negli anfratti del mondo, nella finitezza del nostro inquadramento fisico, del tempo e dello spazio, nel mondo delle nostre possibilità1. Piegare-spiegare non significa più semplicemente tendere-distendere, contrarre-dilatare, ma avviluppare-sviluppare, involgere-evolvere. L’organismo si definisce per la sua capacità di piegare le sue parti all’infinito, e di spiegarle, non all’infinito, ma fino al grado di sviluppo concesso alla specie (Deleuze 1988, p. 13). Ciò significa che la centralità della retorica del Barocco non è una questione frivola o “ornamentale”. L’arte di vedere e di comprendere deve essere montata e fabbricata, è distinta dall’informazione. Nella violenta instabilità della Controriforma e nel mondo incerto dovuto al nuovo ordine sociale, la conoscenza richiede una certezza articolata piuttosto che il semplice consenso2. Talvolta la costruzione, tanto in architettura quanto nel teatro e nel pensiero, pendeva più verso la luce, talvolta più verso l’ombra; senza fallo, riconosceva che la propria origine ibrida si situava in entrambe. I limiti della mortalità sono stati iscritti tanto nelle fughe razionali quanto nel vivido movimento di corpi e luci ritratti di sbieco da Caravaggio: catturati temporaneamente, ma non centrati, stanno per cadere fuori dalla cornice (Sarduy 1975, p. 50). Proprio nell’arte di Caravaggio si avverte, nella maniera più drammatica, il senso di incertezza che caratterizza il centro e la certezza. Ecco che la prospettiva della mimesi viene ribaltata e si annuncia la morte della rappresentazione. Il neoclassicista Poussin dichiarò che Caravaggio era venuto al mondo per uccidere la 1 “Il punto di vista si trova nel corpo”, Leibniz, lettera a Lady Masham, giugno 1704, citato in Deleuze 1988, p. 17. 2 Su questo punto concorda Marc Fumaroli (1994), secondo il quale la diversità del Barocco europeo tende in buona misura a fiorire sotto l’egida italianizzata della Controriforma. LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI pittura1. Frustrando un’appropriazione razionalista e la piacevole misura dell’ordine e dell’interpretazione classici, la pittura “dal vivo” di Caravaggio minaccia la nobiltà dello sguardo (theoria) mostrando ciò che si vede, invece di ciò che la ragione compone e condona. La “bellezza mortale della teoria”, la configurazione sepolcrale del discorso e il razionalismo di una rappresentazione che rende leggibile e possedibile il mondo, viene distrutta da Caravaggio, il quale rivolge lo sguardo all’interno di se stesso e della cornice mortale che annuncia (Marin 1977). Come sostiene Louis Marin, in Caravaggio non incontriamo la verità dell’oggetto rappresentato, bensì la verità della rappresentazione. Eliminando la distanza e intrappolando l’occhio nell’apparenza, tutto avviene sulla superficie del dipinto, il piano in cui l’esterno e l’interno si sovrappongono in una linea sfocata e indecifrabile. Ecco che l’esterno e l’interno raggiungono la maggiore intensità e il maggiore potere, un potere tanto schiacciante che non è possibile opporvisi (Marin 1977). L’“idea” della pittura come mimesi fedele, come “fedele” alla natura, come giudizio storico e prospettiva storica, viene sostituita dall’atto della pittura come “il momento in cui la vista prorompe dalla rappresentazione”. Marin conclude: ciò che si staglia dal fondo nero di queste tele è che “il momento di autoriflessione nei dipinti del Caravaggio rivela come la pittura sia una rappresentazione senza base, senza fondamenta”. In Caravaggio, “lo sguardo è un gesto che indica, un ‘questo’ che fa a meno dei discorsi e della descrizione integrativa, che ha luogo hic et nunc”. Come la nota agonizzante del liuto o della viola da gamba, la trama e la tonalità sono decentrate, transitorie, malinconiche. La visuale appassionata delle cose scaturisce dall’evento della storia sofferente (“apposto su una ruota di fuoco”), non dalla sigillata saldezza della logica. Nella sua violenta affermazione, questa disposizione annuncia altresì lo spazio precario dell’emergere del 1 Nella sua storia della pittura e dell’architettura del 1725, André Félibien scrisse: “Poussin non sopportava Caravaggio e diceva che fosse venuto al mondo per distruggere la pittura”, citato in Marin 1977. La citazione di Caravaggio in questa sede è solo un riflesso del suggestivo saggio di Marin. IAIN CHAMBERS mondo urbano moderno, e funge da precursore di ciò che, nei secoli futuri, verrà denominato “cultura di massa” (Maravall 1975). Lo stile e la sensibilità dell’eccessivo e dell’ornamentale acquisisce vieppiù una dimensione pubblica, parallelamente all’ascesa dell’assolutismo. Per tutto l’arco del Seicento, nella musica, per esempio, si delinea la distinzione tra esibizione privata ed esibizione di corte. La musicalità e l’accoglienza domestica della musica francese per liuto svaniscono dinanzi all’autorità dell’assolutismo. Il patrocinio crescente sulla musica da parte della borghesia cittadina, spesso in contrasto con gli stili che godono dei favori della corte, provoca un ulteriore spostamento del teatro dai contesti privati, di palazzo, verso la sfera pubblica. Nulla manifesta questa esplosione del pubblico più dello spettacolo offerto dall’opera. Se l’opera lirica come tipologia musicale ha inizio nel 1600 a Firenze, con l’Euridice di Ottavio Rinuccini, essa assurge per la prima volta al ruolo di spettacolo di massa a Venezia nel 1637, in occasione dell’inaugurazione del primo teatro pubblico. Nello slittamento dall’opera di corte a quella pubblica, si riscontra il passaggio dall’evento unico, dalla creazione una tantum, a un’esecuzione concepita per essere prodotta in serie, ossia concepita per essere riprodotta quasi tre secoli prima che Walter Benjamin applicasse la medesima definizione al cinema19. L’opera era un evento pubblico, con tutti gli annessi e connessi di natura ideologica, economica e politica che caratterizzano il “pubblico”. Dipendeva da un pubblico sia in termini estetici (per completarne il dramma partecipando al suo dispiegarsi) che economici: l’acquisto di biglietti, poltrone, palchi. Tra il 1600 e il 1637, l’opera sposta l’attenzione dall’antico (la presunta musica dell’antica Grecia) alla produzione teatrale moderna, commerciale, in cui l’antico si perde (Bianconi 1982, p. 166). Si tratta di uno spostamento dal tramonto della cultura umanista (e con essa, di Firenze) verso un’altra cultura moderna, urbana, pubblica (Venezia). Qui la società è in grado di contemplare se stessa (Clément 1988). Si ha un’ulteriore accentuazione nell’infrazione delle categorie estetiche precedenti con un ibrido di vernacolo e sublime, sempre più rielaborati nella mancanza generale di rispetto per i canoni precedenti del- 1 Gran parte di questa discussione è tratta direttamente da Bianconi 1982. LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI la composizione, del teatro e della rappresentazione. Non si vuole sostenere, come afferma Lorenzo Bianconi, che l’opera nel Seicento fosse un mezzo popolare (condizione che si verificherà soltanto nell’Ottocento), bensì si trattava di un mezzo popolarizzato e pubblicizzato come manifestazione attiva, pubblica del potere culturale e secolare (Bianconi 1982, p. 191). In quanto tale, accanto ai suoi sentimenti, alle sue strutture e ai suoi eccessi instabili, l’opera è stata il modello del Barocco. Accanto all’instaurazione sistematica del governo centralizzato e della vita di corte (Madrid, Versailles, Londra), nonché alla razionalizzazione pubblica del controllo finanziario, giuridico, militare e dell’istruzione, la rinnovata imposizione dei diritti feudali incoraggiò (e talvolta impose con la forza) la migrazione di contadini, coltivatori e piccoli proprietari terrieri dalla campagna verso le città. Ne derivò una crescita della popolazione urbana priva di proprietà: i volti anonimi delle future “folle”, “marmaglie” e “masse” urbane, nonché del sottobosco della criminalità urbana. Oltre a queste dislocazioni violente ci fu un’interminabile serie di guerre e persecuzioni religiose, a causa delle quali le regioni rurali furono flagellate da banditi e bande erranti di soldati in rotta e di ex mercenari. Si completi il quadro con periodiche riproposizioni della caccia alle streghe e delle pestilenze. In “un periodo ebbro di violenze immaginarie ed effettive” (Benjamin 1928, pp. 158-159), questi erano tutti campioni diretti della “pedagogia barocca della violenza” (Maravall 1975), spaventosi promemoria di un mondo fragile e di una mortalità precaria. Nella prima metà del diciassettesimo secolo, Londra è stata flagellata dalla peste (1603: 33.500 vittime; 1625: 35.500 vittime; 1636: 10.500 vittime), nonché, nel 1665-1666, dalla Grande Peste (69.000 morti), cui fece seguito il Grande Incendio del 1666 (Hill 1969, p. 278). Analogamente, la Napoli barocca pullula di guglie e obelischi allegorici eretti per esorcizzare le pestilenze, i terremoti e le eruzioni vulcaniche: l’eruzione del Vesuvio del 1631, le pestilenze del 1656 e del 1657, i terremoti del 1688 e del 1694 (Cantone 1992). Ciò che prima veniva tenuto a una certa distanza con la promessa di un’altra vita, di un altro mondo, della salvezza, si appropinqua in maniera drammatica: viene rappresentato (vor-stellen) e ri-cordato, in-corporato e incarnato. Diventa una “cosa” (res) che ci turba e ci sgomenta (Heidegger 1954a). In questo mo- IAIN CHAMBERS do le cose ultime (la morte e il giudizio) divengono cose dell’immediato (Heidegger 1950b, p. 7). Il filosofo italiano Mario Perniola mette in relazione questo riconoscimento barocco della traslazione storica e ontologica della morte nella vita, che si oppone a un concetto separato ed estraneo all’esistenza terrestre, con Loyola e i gesuiti. Non si tratta di una testa pensante, bensì di un corpo inscritto nei limiti terrestri, che risiede nel mortale rifugio della Terra ed è destinato ai vermi del tempo, che fornisce il corpus costante e tragico della teatralità barocca, dell’estetica e dell’ascesi dell’epoca. La malinconia e lo spazio coloniale Tuttavia, in questa potente vicinanza, includendo con forza la mortalità nella verità, emerge altresì una notevole fiducia1. Quasi come contropartita per la perduta centralità, il secolo del Barocco testimonia anche l’elaborazione violenta e capillare dell’egotismo in espansione, che cerca di modellare e foggia il resto del mondo a sua immagine e immaginario. Nel momento stesso in cui il pensiero europeo si considera prigioniero del tempo, gettato nelle sguarnite vicissitudini della storia, scopre una terribile libertà. L’“ansia coloniale” che immancabilmente accompagna la scoperta dell’alterità radicale in Africa, Asia e nel Nuovo Mondo ha rapidamente trovato accoglienza nell’ambito del linguaggio e della ragione europei (Hulme 1992)2. Negli ampi viali, nell’enorme piazza e nell’imponente facciata delle chiese realizzate durante il Barocco nelle zone urbane del Messico e nel Sud America, è stata eretta un’architettura che ha inglobato corpi e storie non europei solamente per negarli spietatamente, analogamente a quanto avveniva nelle piantagioni, nei disboscamenti, nelle stazioni commerciali più a nord. Il silenzio, l’intrattabile e l’intraducibile sono stati costretti a recare testimonianza di un narcisismo europeo che tentava “di rappresentare anche le esperienze che gli oppongono resistenza con testarda opacità” 1 Ringrazio di cuore Kathy Biddick per avermi ricordato questa “fiducia”. Sulle diverse iscrizioni cerimoniali dei possedimenti e delle conquiste inglesi, spagnole, portoghesi e olandesi nelle Americhe, si veda Patricia Seed 1995. 2 LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI (Chow 1993, p. 38). Questa presenza invisibile ha lasciato tracce nel lavoro, nella schiavitù, nel sangue, nella tortura e nella morte dei soggetti amministrati e reclusi dal governo coloniale, dalla repressione militare e dall’Inquisizione. Mantenuti ai margini nelle colonie con la forza, la paura e il terrore, i limiti dei possedimenti europei e della posizione europea venivano al contempo instaurati e repressi mentre l’Occidente insisteva, brutalmente, nel suo tentativo di identificarsi col mondo intero.. In Europa, il saccheggio iniziale, i metalli preziosi del Nuovo Mondo e il conseguente sfruttamento, per mezzo del lavoro degli schiavi, hanno fornito l’impalcatura immediata per l’ascesa dello Stato centralizzato, della cultura urbana moderna e del sistema economico-finanziario che avrebbe promosso la modernità europea. Questo incontro lacerante con l’alterità ha lasciato inevitabilmente il segno, sotto forma di segnali, suoni e ombre ambigui che caratterizzano sia l’economia politica che quella culturale dell’epoca. Ci si può persino azzardare a suggerire che la malinconia maschile dell’epoca (Donne, Dowland, Amleto…) sia meno una conseguenza del tramonto dell’umanesimo rinascimentale che non una risposta al progressivo restringimento del mondo conosciuto, ora spaesato dall’eliocentrismo e dalla nuova presenza costituita dall’America: quest’ultima sempre ritratta come una donna indomita, mostruosa, vergine, la cui presenza minacciosa deve essere sottomessa, conquistata e addomesticata. Non si riscontra alcuna correlazione necessaria o immediata tra una miniera d’argento peruviana e La resurrezione di Lazzaro del Caravaggio, tra il consiglio di guerra degli irochesi e la pavana sul liuto elisabettiano. Eppure, nella disillusione che parla del crollo di un ordine cosmico unitario che getta l’umanità nella sguarnita eterogeneità della differenziazione del mondo, emerge un linguaggio che, fatalmente, prende atto, sconsolato, dei limiti: ecco che la soggettività europea subisce una battuta d’arresto, potenzialmente slitta. Nell’anatomia della malinconia certamente risiede la concentrazione che consente agli occidentali di ricollocarsi al centro. Ecco che si registra un radicale spostamento nella percezione del tempo storico, accompagnata dal manifestarsi dell’individuo come soggetto circoscritto. Riconoscendo i limiti, la ragione e il tempo rispondono alla finitezza (Heidbrink 1994). In questa costellazione, ovviamente, si fa comunemente riferimento all’epoca barocca come epoca della malinconia. Dal celebre IAIN CHAMBERS trattato di Robert Burton sulla questione, datato 1621, allo studio di Walter Benjamin di questo “teatro del lutto”, tre secoli più tardi (1928), l’argomento si riscontra ovunque, e viene amplificato, in maniera più sintetica, nella musica di quel periodo. Tuttavia, se la malinconia rappresenta l’infinito del dolore, una perdita mai accettata come un lutto, cosa cerca di trattenere e incorporare esattamente la malinconia barocca nella sua incessante proiezione della sofferenza? Per quale motivo, in tutto il suo eccesso teatrale, la nota conclusiva è una nota diminuita, un’eco dissonante della privazione che scompare? Se le qualità del Barocco vengono generalmente ritratte nella malinconia maschile, che cosa traspira in questo lutto annunciato eppure incompleto? Ripudiando la sicurezza cosmica, la divinità sicura e la certezza religiosa, si ha certamente una perdita che non è mai possibile riconoscere pubblicamente o elaborare privatamente, poiché la proibizione è di natura culturale e storica. Per darne annuncio, non esiste alcuno spazio pubblico, fuorché l’eresia. L’eresia, come riconoscimento differito della perdita, comporta l’essere sospesi tra la mancanza e lo stato che deve essere ancora raggiunto. Muoversi in un ordine secolare che continua a negare la possibilità di seppellire il suo predecessore significa rimanere intrappolati nel trauma di “mimare la morte che non si può piangere” (Butler 1997, p. 142). Ma c’è dell’altro, qualcosa inerente alla malinconia maschile e al corpo barocco, che ha a che fare con la definizione di limiti e confini, dell’essere costretto entro il vincolo dell’ineluttabilità della morte, entro l’orizzonte potenziale della morte e dell’alterità, che, nella maniera più drammatica possibile, è strettamente connesso allo spazio coloniale. Tuttavia, questo è anche il corpo che oltrepassa i limiti precedenti, che sorvola e supera la sua posizionalità nell’epoca precedente, non si sente più limitato dalla geografia di un’autorità unica. Ormai questo corpo europeo è altresì l’oggetto dello sguardo dell’estraneo, e pertanto diviene al contempo un soggetto centrato e limitato: “io non vedo che da un punto, ma nella mia esistenza sono guardato da ovunque” (Lacan 1964, p. 74)1. Nei confini e 1 L’idea di essere contemporaneamente centrato e limitato viene discussa nella maniera più dettagliata nel racconto di Michel de Certeau di Jean de Léry, protagonista della modernità, il quale in Brasile, negli anni Sessanta del Cinquecento, fu testimone oculare di una scena primaria nella costruzione del discorso etnologico. Si veda al riguardo il capitolo intitolato Etno-grafia: l’oralità, o lo spazio dell’altro: Léry, in de Certeau 1975. LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI nei punti di contatto di questo “nuovo mondo”, un siffatto corpo viene “reso un altro” dal “nativo” (Chow 1993). In questo stato limite dell’ansia, lo sguardo europeo, per quanto imperiali siano le sue presunzioni, si piega nell’esercizio più frantumato e scomodo dell’egemonia coloniale nell’oscillante palcoscenico del potere: “noi siamo degli esseri guardati, nello spettacolo del mondo. Ciò che ci fa coscienza ci istituisce al tempo stesso come speculum mundi” (Lacan 1964, p.77). In questa oscillazione, nello spazio in cui ogni soggetto è potenzialmente un oggetto, e nel ritorno alle sue ansie, il Barocco offre “i rituali esecutivi del primo contatto interculturale” (Carter 1996, p. 229). Stando così le cose, Paul Carter continua dicendo che il Barocco annuncia: Una controtradizione nell’ambito della ragione occidentale, e noi abbiamo proposto che questa controtradizione sia profondamente invischiata nella poetica della colonizzazione e pertanto, forse, nella continua critica del Logos occidentale che caratterizzerà la nascita della politica e della poetica postcoloniale (p. 302). Ecco che si ritorna allo sguardo del nativo, alle origini mitiche della modernità occidentale, ai suoi miti di conoscenza; si fa ritorno a casa provvisti di un vantaggio fondamentale che mette in scena l’opposto dell’analisi antropologica, che ora si guarda alle spalle cercando le proprie “origini”. L’intrusione violenta dell’“estraneo” si attua in casa propria, nell’Occidente, provocando una disposizione critica che ricolloca la precedente strutturazione in un’altra storia. Inevitabilmente, questo ritorno non richiesto implica una revisione della storia e delle discipline che in precedenza reggevano lo spazio coloniale e che ora tentano di spiegarne le conseguenze (Lambert 1995). Nell’ostentazione pubblica del Barocco (il teatro, gli spettacoli pirotecnici, le fontane, gli obelischi, le chiese e, soprattutto, l’opera lirica) si riscontra l’orchestrazione culturale di una presenza eccessiva registrata in un potere che scende a patti per la prima volta col pubblico di massa, col pubblico urbano (Maravall 1975). Questa disposizione non viene semplicemente impartita a un pubblico passivo: lo spettatore, l’ascoltatore, viene richiamato perché faccia scattare la molla del dramma, la forza emotiva della musica, perché completi l’evento e non si limiti a osservarne il di- IAIN CHAMBERS spiegamento. È possibile interpretare questo sfoggio pubblico e stravagante come sintomo dell’ansia politica e culturale che insorge allorché si oltrepassa un precedente ordine conosciuto. Un’alleanza religiosa ed epistemologica è stata infranta dal dissenso, dalla guerra e dalla controconoscenza: tutto si riconduceva alla disagevole elaborazione di una politica decentrata alla ricerca di un nuovo assoluto. Qui, persino nella teatralità dell’emergente centralizzazione dello Stato e della sua monarchia assoluta, il Barocco rivela una disposizione ansiosa del potere, da cui derivano l’eccesso violento e l’istituzione drammatica in un mondo che minaccia di sfuggire a confini e controlli. Questa minaccia è sia interna (la scienza, la secolarizzazione e una modernità urbana che sboccia) che esterna: l’inquietante immissione di altri mondi. Cortés, dinanzi a Tenochtitlan (in seguito nota come Città del Messico) e prima della sua distruzione, la definì “la più bella città del mondo”. Lo spazio barocco è anche lo spazio coloniale, e l’intrusione di nuovi mondi, da dentro quanto da fuori, è un palinsesto dell’estetica barocca della meraviglia, del terrore, della paura, del dolore e dello spettacolo1. Lo stile del tempo La leggenda talmudica assegna a ogni istante del tempo un suo angelo specifico, cioè una sua propria qualità, delle insostituibili virtualità messianiche (…). Questa paradossale figura di pensiero, secondo la quale la fine può compiersi già ora, “nell’ambito storico”, sovverte i fondamenti stessi della Ragione storica. Essa implica, infatti, che il tempo non sia più pensato come un asse orientato lungo il quale il dopo succede inevitabilmente al prima, oppure come un fiume che scorre dalla sorgente alla foce, bensì come una giustapposizione di istanti sempre unici, non totalizzabili, che – dunque – non si succedono come tappe di un processo irreversibile. Il passato, il presente e il futuro non si dispongono, qui, in sequenza su di 1 In assenza di un ritorno domestico, e ritrovandosi perduto nell’El Dorado di un orizzonte nuovo, l’ego può essere trascinato via in un’economia infinita di segnali, da cui sgorga il linguaggio e i sensi scorrono, incontrollati, verso la morte. Forse l’esemplificazione migliore di quanto appena detto è data dalle inutili spedizioni di Sir Walter Raleigh e dal film di Werner Herzog, Aguirre. Furore di Dio (1972). LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI una linea retta che uno spettatore potrebbe osservare dall’esterno, bensì coesistono come tre stati permanenti della coscienza (Mosès 1992, pp. 24-25). Tutto il discorso manifesto è la repressione di ciò che non viene detto, che a sua volta mina alle fondamenta ciò che viene detto (O’Connor 1988, p. 59). Il complesso gioco di luci e di ombre del Barocco, coi suoi limiti e con le sue domande, apre uno spazio critico che torna ad abitare il nostro presente. Pone un quesito, crea un’apertura nella struttura della nostra comprensione, una lacerazione nel tessuto della nostra conoscenza. Ci trascina nelle ombre dell’illuminazione, nelle zone represse da cui il nostro essere tenta di tenersi alla larga, perché ci obbliga a confrontarci e a dialogare con ciò che più disperatamente tentiamo di ignorare: i nostri limiti e la nostra mortalità. La critica barocca della permanenza e dell’essenzialismo, integrata dal contemporaneo decentramento e ricentramento dell’Europa cinquecentesca secondo direttive coloniali, ricompare nelle vesti di un fantasma (“Ricordati di me”) per infestare il tramonto del modernismo occidentale e sfocia nella sfida eterotopica alla concezione razionale e utopistica di quest’ultimo. Invoca una risposta etica alle necessità di un’altra scena, di un’altra storia, di un’altra possibilità, che ci ricordi che la ragione storica deve essere, essa stessa, soggetta a giudizio, perché dietro all’“assolutismo perverso” (Lévinas) della conoscenza occidentale e al suo desiderio universale di una logica intatta, unitaria, di una teleologia razionale del tempo e della casualità, si pone l’evasione di un siffatto giudizio. Rifiutare di registrare le ombre enigmatiche, discontinue, represse e fameliche dell’oblio, e dissiparle nella violenta insistenza sulla coerenza, significa fuggire dalla vita e dall’angoscia della morte, nonché rigettare la responsabilità per queste situazioni (Robberechts 1992). Quando la terra viene rifiutata e ridotta violentemente a un accordo etereo tra il pensiero e la logica trascendentale, quando il mondo viene abolito e distillato nello spirito puro e nella trasparenza di una frase razionale, tutti quei linguaggi titubanti, mutevoli, incompleti, arcani, incrinati, silenziosi e disfatti che contribuiscono IAIN CHAMBERS all’insistente “mondeggiare il mondo” vengono negati (Heidegger 1954a). Ritirandoci da questa prospettiva miope, deviando da quell’angusto sentiero e assumendo nuovamente la responsabilità della nostra vita e di ciò che la sostiene, le altre vite, cogliamo gli echi degli antesignani del Barocco nella duplicità, nell’inquietudine, nell’eccesso, nelle pieghe e nell’opacità della conoscenza, mentre al contempo ascoltiamo il contrappunto dell’amnesia culturale e del narcisismo europeo. Ricordiamo, nel messaggio1 mortale e nella storia di quel periodo di ombre, le domande che ci consentono di continuare a domandare, di continuare a esistere. Ecco perché certuni ritengono che gli schemi sbrindellati e incompleti del chiaroscuro del Barocco siano assai più prossimi alle attuali sensibilità e configurazioni mondane della successiva fede nella ragione strumentale e nel fiducioso soggettivismo. Ricordare quell’intervallo precedente significa rammentare a noi stessi la complessa, talvolta indifferente, necessità del mondo prima che il positivismo si manifestasse e ci rassicurasse con gli dei secolari della “scienza” e dell’“informazione”. La vicinanza dei paesaggi allegorici del Barocco e delle esperienze radicali e distruttive della tarda modernità è stata colta elegantemente da Christine BuciGlucksmann: come si vede, dunque, prima dell’arte moderna, l’allegoria testimonia del predominio del frammento sul tutto, del principio distruttivo su quello costruttivo, del sentimento, come vuoto di un’assenza, sulla ragione come padronanza. Solo il frammento è in grado di mostrare che la logica del corpo, del sentimento, della vita e della morte non coincide con quella del potere né con quella del concetto. In essa si configura precisamente ciò che è muto (donde la musica), ciò che è nuovo (sia pure la morte), ciò che non è padroneggiabile ed è profondamente ingovernabile: le catastrofi, come messa in scena della stessa azione del rappresentare. Con ciò essa consegna la realtà a una perenne antinomia, al gioco illusorio della realtà come illusione, in cui il mondo è valorizzato e svalutato al tempo stesso: “Il mondo profano, considerato dal punto 1 Qui l’autore si avvale di un sottile gioco di parole: sillabando la parola inglese “message” (messaggio) in “mess-age”, induce il lettore a interpretare il termine come l’espressione “epoca della confusione” (N.d.T.). LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI di vista allegorico, è simultaneamente valorizzato e svalutato”. Di qui la specifica seduzione del barocco, in cui il primato dell’estetica – del gioco, delle apparenze – si unisce alla miseria metafisica su uno sfondo di afflizione e di melanconia. La metafora del teatro – del mondo come teatro e del teatro del mondo – raffigura la temporalità specifica del barocco (…). Su questo eterno rinvio delle apparenze regna uno spettatore onnipresente, ma già lontano: Dio. L’abisso tra realtà e illusione è tuttavia incolmabile: il teatro sa di essere teatro (BuciGlucksmann 1984, pp. 52-53, corsivo nell’originale; l’autrice cita Walter Benjamin). Ecco l’esposizione e l’avanzamento della barocchizzazione contemporanea del mondo in cui la pulsione razionalista e una semplicistica fede nell’accumulo lineare nel “progresso” vengono forse considerati un intervallo anormale. Inserito in un contesto assai più vasto, il Barocco seicentesco, con le sue allegorie dell’eccesso e della mortalità, con il suo malinconico riconoscimento dei limiti della ragione e della vita, viene messo in una relazione profonda con la ricomparsa di stili neobarocchi sul finire del ventesimo secolo, dove lo “stile”, come nel caso dell’ornamento nel primo Barocco, non è un elemento superfluo, bensì esemplifica il pathos autocosciente dei linguaggi nei quali risediamo. Nell’enfasi che pone sul nostro essere prigionieri del tempo, assoggettati alla storia e alla mortalità, nel rendere il senso dalla crisi e la fragilità dell’esistenza umana, la sensibilità barocca divampa in un’immagine che getta luce sul nostro mondo. Come l’irradiazione che promana dalle stelle morte, il Barocco giunge a far parte delle nostre vite, come qualcosa che al contempo è presente e assente (Benjamin 1928). L’instabilità palpabile di ciò che siamo usi chiamare “conoscenza” e “verità” fornisce un legame telescopico tra due costellazioni storiche, porta all’impressione che la specificità storica non risieda nel rilevamento fattivo del passaggio del tempo, ma nel ricevere e riconoscere un momento discontinuo interpretando esso e noi stessi alla luce del suo presente. Quel momento è sia unico che ripetitivo, irreversibile e ricorrente “nel punto di confluenza di due movimenti di senso assolutamente opposti” (Mosès 1992, p. 145), perché la sua verità non è insita in una “chiusura mediante i fatti”, bensì nell’evento e nella risonanza del linguaggio (Dori Laub, in Fel- IAIN CHAMBERS man, Laub 1992, p. 73). La verità non è una mia proprietà personale, non è limitata alle possibilità e allo scopo della mia volontà (Lévinas 1961), è qualcosa che mi investe e poi mi sfugge: è discontinua (Mosès 1992, p. 138). In questo modo il passato transitorio, in apparenza perduto per sempre, può ritornare e ritorna per azionare un altro senso, spesso nuovo, del presente, e con esso apre al futuro. Con questo si vuole suggerire un paradigma etico e complesso, piuttosto che positivista e distaccato, della conoscenza (p. 133). In questa maniera, il passato non viene mai ricatturato “così com’era”, sebbene, in un’inversione del tempo, possiamo semplicemente ritornare sui nostri passi lungo il sentiero dell’evoluzione omogenea di un momento precedente. Il passato non si limita ad arrivare a noi docilmente attraverso il passare del tempo, bensì esplode e riecheggia nel nostro tempo come evento sconcertante e separato: come la voce e il corpo dell’altro che sfida il nostro corpo e il nostro tempo. Il passato è la scena di tracce persistenti. Come segni, silenzi e risonanza, veniamo indirizzati verso ciò che è irrimediabilmente perduto, e che pure continua a perseguitare il nostro linguaggio e i nostri pensieri, e quindi interroga il nostro senso del presente. Tradurre (e trasformare) il passato in tal maniera può facilmente equivalere a tradire come le cose “erano davvero”, ma anche rifiutare di liberarsi del suo corpo. Se dovessimo ridurre il Barocco all’incedere uniforme, e all’oblio definitivo, del “progresso”, cancelleremmo la possibilità che esso ritorni: la possibilità delle generazioni passate di continuare a interrogare, inquietare e sfidare il nostro tempo e il modo in cui custodiamo il loro tempo. Temprare e mettere alla prova il tempo in questa maniera significa interromperlo di continuo per sentire il respiro degli altri modi di essere nel tempo. Significa riconoscere la nostra precarietà in cui il passato non è dato e il futuro non è prevedibile: tutto deve essere disfatto, inter-pretato, contestato, di continuo… Spalancare il corpo della storia ed esporlo alla rivendicazione del mondo implica l’adozione di un tipo di tempo, di conoscenza, che è anche un tipo di discorso, di scrittura, capace di mantenere sospesa l’ambigua “verità” che si appoggia sul linguaggio nella nostra riscrittura continua del passato mentre noi ricer- LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI chiamo il potenziale storico del presente. Questo perché lo stile è il corpo, la fisicità del linguaggio. Pertanto, noi riconosciamo nel gesto di uno stile (di pensiero, di scrittura, di discorso) la com-presenza e la responsabilità di passato, presente e futuro. Qui l’intrattabile qualità sibillina dell’allegoria barocca, come il discorso e la scrittura di una sensatezza, di un’espressione epocale, suggerisce ben più di una semplice tecnica letteraria o poetica arcaica. Scrive Walter Benjamin (1928, p. 141): L’allegoria mostra agli occhi dell’osservatore la facies hippocratica della storia come irrigidito paesaggio originario. La storia in tutto ciò che essa ha fin dall’inizio di immaturo, di sofferente, di mancato, si imprime in un volto, anzi: nel teschio di un morto. E se è vero che ad esso manca ogni libertà “simbolica” dell’espressione, ogni armonia classica della figura, ogni umanità, in questa figura – che è fra tutte la più degradata – si esprime significativamente sotto forma di enigma, non solo la natura dell’esistenza umana in generale, ma la storicità biografica di una singola esistenza. È questo il nucleo della visione allegorica, della esposizione barocca, profana della storia come via crucis mondana: essa ha significato solo nelle stazioni del suo decadere. Nell’interregno tra la fede religiosa garantita dalla stabilità divina dell’universo precopernicano e la successiva consolazione dell’idolatria della scienza, il Barocco ostenta un essere nudo, sguarnito, in cui ogni “persona, ogni oggetto, ogni relazione può significare assolutamente qualunque altra cosa. Con questa possibilità, viene emesso un giudizio distruttivo, benché giusto, sul mondo profano” (p. 149). Privato di un’ovvia funzione simbolica, intrappolato nella caduta del mondo, nella profanità della decadenza e della rovina, il Barocco indica un’altra direzione, scavando nel corpo, nella fisicità del linguaggio. Come sostiene Benjamin, gli estremi tipografici e le metafore pompose del Barocco sono soltanto i sintomi più ovvi di un linguaggio che tende verso il visivo, verso l’illuminazione che scaturisce da un’immagine indipendente e autonoma. Si tratta però di un’autonomia segnata, ferita, perché: Nel campo dell’intuizione allegorica, l’immagine è frammento, runa (p. 150). IAIN CHAMBERS L’immagine è sia frammento, rovina, che runa, geroglifico. La falsa apparenza della totalità si spegne. Poiché l’eidos si oscura, entra in campo la metafora, e il cosmo che vi è contenuto si inaridisce. Nelle rebus inaridite, che ancora rimangono, è presente un senso che si lascia cogliere solo da colui che medita, rimuginando (ib.). Dietro la facciata di questa profusione di fasti, il Barocco punta i riflettori sull’imperfezione e sull’incompletezza del mondo, insiste sulla nostra limitazione fisica e terrestre, sull’ineluttabilità della decadenza e della rovina, e così facendo conquista per se stesso, dagli abissi del suo linguaggio, un concetto destinato a permanere: “dove il simbolo riassorbe in sé l’uomo, dal fondo dell’essere l’allegorico va incontro all’intenzione sulla sua strada e la colpisce in fronte” (p. 157)1. L’idea che il tempo storico possa essere multiplo e discontinuo, che la storia sia un costrutto allegorico che espone le rovine del tempo, non è solo l’anello di congiunzione tra Benjamin e l’aspetto eccessivo e poetico del modernismo (Baudelaire, Kafka), ma è anche il trait d’union tra questo pensatore ebreo tedesco e il Barocco con la sua lettura meravigliosa e profondamente allegorica della modernità. I testi fondamentali al riguardo sono il volume sul teatro del lutto (Trauerspiel) del Barocco tedesco (pubblicato nel 1928), il solo libro che Benjamin abbia portato a compimento, il corposo e incompleto progetto sulle arcate parigine su cui lavorò durante gli ultimi anni della sua vita in esilio, e le Tesi sulla Filosofia della Storia (1955a). Sovvertire e scartare gli anelli della catena temporale della causalità irreversibile, riportare il tempo contro se stesso e far scaturire un’altra storia, nonché un altro modo di narrare: questa è la motivazione del continuo interesse di Benjamin per i linguaggi del tempo e dell’essere, per la scrittura della storia. Significa dare un nome agli sconfitti e ai defunti, ritornare nuovamente sui trascurati e sulle ombre, e rivelare in una diversa 1 José Maravall (1975) insiste altresì sulla centralità dell’interruzione e sull’incompletezza del Barocco, ipotizzando che offra, per esempio, una chiave di lettura per le ultime opere “incomplete” di Shakespeare. LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI scansione del tempo gli istanti dettagliati che compongono il pathos eterno dell’esistenza terrestre nelle ripetitive discontinuità della mortalità. Nel gesto ambiguo del collezionista (che salva e reifica a un sol tempo il passato), Benjamin tenta di ricordare attivamente, invece che ricordare soltanto, queste tracce e questi frammenti1. Come il tombeau barocco, egli tenta di ritagliare nel linguaggio e nel tempo uno spazio in cui possa comparire una nuova storia e, con essa, un futuro alternativo in cui ogni momento storico possa essere separato per rivelare un’apertura verso sentieri e possibilità non ancora intrapresi. Ecco che il tempo storico, contrapposto alla tirannia lineare del tempo fisico, diviene reversibile. Rende possibile un ricordo, un ritorno che produce il tempo “aperto” della scrittura, della politica, dell’estetica e dell’etica, pronto per essere giudicato in qualsiasi circostanza (Emmanuel Lévinas)2. È la storia degli “intempestivi, dolorosi, infruttuosi”, nelle storie discontinue, scartate e disperse degli sconfitti, che Benjamin tentava continuamente di strappare dalle mani dei vincitori, di strappare dall’oppressione della continuità del loro tempo e del “progresso”, perché questo “progresso” si basa sulla continuità della catastrofe, sulla sconfitta dei corpi negati e delle storie degli esclusi: le rovine della storia. In questo modo si stabilisce un nuovo tipo di intelligibilità storica che ci lega al tempo dell’altro, che ci lega a una risposta e a una capacità di rispondere per gli esclusi, per l’oblio (Shoshana Felman, in Felman, Laub 1992). Nell’atto di transizione della scrittura sotto il segnale eterno della redenzione etica, Benjamin, come Franz Rosenzweig (ma in questo contesto non dovrebbero essere sottovalutati nemmeno gli echi di Heidegger), cercava un’intelligibilità che non fosse chiusa, “scientifica”, o metafisica, bensì posta sotto la tutela del linguaggio, del dispiegamento vitale del mio essere nel linguaggio, e del mio linguaggio nell’essere, in cui il respiro dei viventi attizza le ceneri del passato che divampano per gettare luce sul futuro. 1 Sulle ambiguità politiche del collezionismo e sulla sua posizione nell’articolazione e sulla disarticolazione della modernità, si veda Chow 1993, pp. 43-44. 2 Ho tratto il concetto di “tempo vuoto” da Mosès 1992, p. 183. IAIN CHAMBERS Suoni impronunciabili Una nota di passaggio. Nella centralità della musica per le esperienze di modernità dell’Atlantico Nero, veniamo a contatto non soltanto con un archivio storico e culturale, un ripostiglio vitale di ricordi, ma anche con una contro-storia e con una costellazione di potenziale redenzione (Gilroy 1993a). È qui che passato, presente e futuro si fondono in un’interruzione brusca (la nota triste sulla corda della chitarra, l’urlo, il borbottio del sassofono, la storia del basso, il rap) che sfida le circostanze contingenti per svelare la presenza di altre storie. Qui il rap invoca un’interruzione del linguaggio, una spaccatura che ripiega il linguaggio su se stesso, quindi lo dispiega in una variante della lingua inglese, la musica rock angloamericana, in altre colonne sonore e stili urbani del mondo. Costituisce l’atto della testimonianza, della conferma, che svela una scansione diversa del tempo storico, una differente iscrizione culturale e una segnatura musicale. Affrancando questi linguaggi dai loro presunti referenti, l’integrazione del rap propone un altro centro. Normalmente considerata un’appendice, un ornamento rispetto alla centralità della musica rock, se vista da un punto di vista differente la musica rap attua una ricollocazione fondamentale e riposiziona la partitura musicale (nonché culturale) (Swedenburg 1992). In questa scissione del suono dal significato precedente, penetriamo nel “topos dell’Indicibilità” (Carl Dalhaus, Die Idee der absoluten Musik, citato in Bowie 1989, p. 70). Come l’enfasi del Barocco sull’ornamento, che ci consente di rivolgere lo sguardo verso l’interno e testimoniare il “sottosuolo del linguaggio” (Shoshana Felman, in Felman, Laub 1992, p. 15), la decorazione del rap e il decentramento dei linguaggi e degli stili prontamente disponibili suggeriscono che la musica rifletta più di quanto si possa carpire grazie alle categorie della riflessione, ed evoca lo “sforzo di dire ciò che non si può dire” (Theodor Adorno, citato in Bowie 1989, p. 80). Su questo punto, rileva Andrew Bowie (1989, p. 83): L’importanza della musica nella storia della modernità mi pare che si spieghi, almeno in parte, col ruolo che svolge in quanto oppositrice del discorso sulla modernità, il discorso che di fronte alla volontà di LA STORIA, IL BAROCCO E IL GIUDIZIO DEGLI ANGELI bloccare il soggetto con regole, codici e sistemi, palesa sempre fino a che punto questi sistemi non possono giustificare se stessi. Casa In esso [nel mondo] il pensiero ha diritto di cittadinanza, ma il mondo non è lui stesso il tutto, bensì una dimora (Rosenzweig 1971, p. 14). Fare ritorno all’armonia perduta del cerchio. Nel cerchio dell’indagine partiamo, fiduciosi di ritornare al punto di partenza, avendo completato l’analisi e reperito le soluzioni. Nell’ellisse diveniamo coscienti del nostro decentramento, non facciamo mai ritorno al punto di partenza. Come una colonna barocca che sale a spirale dando vita a una struttura vorticosa, ci troviamo imprigionati in un moto in cui inizio e fine non combaciano. Ci imbattiamo in altri centri, altre prospettive, sparse lungo l’ellisse spiralizzata della nostra traiettoria. Bloccato nella morsa del tempo, si apre uno spazio tra il passato e il futuro che svela il corpo del linguaggio, sempre presente: “l’essenza del linguaggio, il linguaggio dell’essenza” (Heidegger, L’essenza del linguaggio, in Heidegger 1959, p. 140). Io “così vivo, e sempre prendo congedo”, chiamato a porgere l’orecchio e il corpo al miracolo della chiamata terrestre: Non fu un miracolo? Stupisciti angelo, ché noi siamo così, e tu, Grande, raccontalo, che questo potemmo, ché il mio fiato non basta alla lode. Così non abbiamo nemmeno disperso gli spazi, questi spazi che ci proteggono, che sono nostri. (E quanto terribilmente grandi devono essere, se in millenni il nostro sentire non li ha potuti colmare) (Rilke 1922, p. 83)1. Il Barocco annuncia un confine, in maniera lampante sotto forma di linea di demarcazione tra gli “antichi” e i “moderni”, tra la cosmologia religiosa e la scienza secolare, ma anche nella sua 1 Dalla Settima delle Elegie duinesi. L’espressione “così noi viviamo, e sempre prendiamo congedo” è tratta degli ultimi versi dell’Ottava Elegia (p. 89). IAIN CHAMBERS costruzione drammatica di una soglia ambigua tra ciò che è conosciuto e ciò che rimane estraneo. Una presenza inquietante all’interno delle narrazioni della modernità, una modernità che apparentemente essa fonda e rinnega allo stesso tempo. Gli eccessi di energia e le diverse direzioni del Barocco commentano in maniera sregolata il “progresso” unilaterale consolidato successivamente dalla mitologia moderna. Tutta la conoscenza attiene alla narrazione, a una maniera di raccontare che ci riporta al conosciuto, in cui il nuovo, la scoperta, il “là” viene ricondotto a un “qui”, viene reso riconoscibile nell’economia condivisa del senso. Tuttavia, sarebbe stolto, e forse persino micidiale, negare, ignorare le voci perturbanti, instabili e percettive che ci chiamano a narrare la storia ripetutamente, nel tentativo di conciliare ciò che la narrazione precedente trascurava e reprimeva. Ecco perché la narrazione non è mai completa: la “verità” che contiene è sempre aperta a ulteriori interrogativi. La storia pensa di essere tornata a casa, ma solo per scoprire che ha fissato un nuovo punto di partenza. Capitolo quarto Voce nell’oscurità, mappa della memoria Música Dormida en el caracol de la memoria. Musica Dormiente nel guscio della memoria. Octavio Paz (1988) Car tout étant aujourd’hui “recorder” et la mémoire, la même toujours, n’étant plus tout la même. Perché oggi ormai si registra tutto, e la memoria, sempre la stessa, non è proprio più la stessa. Jacques Derrida (“Lettre à Peter Eisenman/Letter to Peter Eisenman”, in Moriarty, Neuman 1994, p. 31) “Quindi una frase musicale è un riferimento geografico?” “La musica” rispose Arkady “è una banca dati per trovare la strada quando si è in giro per il mondo”. Bruce Chatwin (1987, p. 147) La musica si basa sull’accordo tra oscurità e luce. Trinh T. Minh-ha (dal film Naked Spaces – Living is Round) Potrei cominciare Potrei cominciare da una tarda serata invernale inglese, nel 1967. In una città georgiana color panna lungo il fiume Avon, incastonata tra i pendii collinari del Somerset, mi ero recato al concerto pop che si teneva ogni settimana al Bath Pavillion. Avevo già visto Gene Pitney, Cliff Bennett e i Rebel Rousers, gli Animals, i Byrds… Quella sera avevo pagato cinque scellini per vedere l’ancora relativamente sconosciuto Jimi Hendrix Experience1. 1 Il chitarrista nero statunitense Jimi Hendrix giunse in Gran Bretagna ancora sconosciuto nel settembre del 1966. Venne invitato da Chas Chandler, chitarra basso degli Animals, durante l’ondata britannica che aveva invaso le classifiche del pop in America. Nei precedenti cinque anni, lo stesso Hendrix aveva suonato con frequenza discontinua negli Stati Uniti con molti gruppi itineranti e band R&B, accompagnando, tra gli altri, Little Richard, gli Isley Brothers e Curtis Knight. Nel giro di sei mesi dal suo arrivo in Inghilterra, aveva raggiunto il successo ed era destinato, in breve tempo, a diventare una star a livello mondiale. Negli ultimi tre brevi anni della sua vita consolidò la sua fama di chitarrista più importante del ventesimo secolo. IAIN CHAMBERS Era appena uscita Hey Joe e io avevo visto la prima, straordinaria esibizione televisiva su Ready, Steady, Go!, in cui un bellissimo nero indemoniato suonava la chitarra coi denti e produceva i suoni più ipnotici che si potessero immaginare. Quella sera, nell’arco di quaranta minuti, il terzetto sul palco eseguì molti dei pezzi che avrebbero fatto parte del primo album, Are You Experienced? L’immagine svanisce, i dettagli dell’abbigliamento e dell’esecuzione si fanno confusi. Rimane soltanto una sensazione di stupore, di sorpresa, un’emozione condensata nell’intensità viscerale della chitarra di Hendrix. La testimonianza di quella sconcertante elettricità, di quel temporaneo sovvertimento delle coordinate della cultura locale, avvampa ancora come fuoco vivo nei miei ricordi. L’evento, come gran parte della musica di quel tempo, ha aperto la porta alla possibilità di nuovi mondi, ha svelato che potevano esserci altri spunti più eccitanti, ritmi più intensi da cui attingere per costruire l’immagine della propria vita. Le lusinghe della città, non necessariamente quelle vere, ma quelle immaginarie, con le strade pullulanti di libertà trasgressiva, che va al di là della scuola, della famiglia, di ciò che ti è stato inculcato e ciò che ti è stato imposto di essere, coincidevano anch’esse, nel mezzo degli anni Sessanta, col tripudio della gioventù nella “Swinging London”. Il corpo, il mio corpo, smanioso di sesso, ma anche arso dal desiderio di soffrire per qualcosa di più dei ristretti orizzonti che potevano offrire la mediocrità e la compiacenza istituzionali, accettava di buon grado di entrare in sintonia con queste possibilità. Jimi Hendrix, come gran parte della musica pop dell’epoca, esprimeva la sensualità e la sessualità del corpo, particolarmente ma non esclusivamente per i giovani di sesso maschile, proponendo un percorso di significato culturale in cui suoni, desideri e ribellione si potevano fondere in uno stile di vita pronto a contestare, a fare a pugni con i codici del comportamento imposti. Ma perché proprio Jimi Hendrix, e non il sublime Otis Redding o l’esplosivo James Brown? Solo perché si trovava in Inghilterra, protetto dalla cricca del rock londinese, e riscuoteva successo per la prima volta in Inghilterra, come se fosse un figlio di questa terra, prima di essere riesportato negli Stati Uniti? Certamente, egli era un uomo di colore diverso da tutti gli altri uomini di colore. Era diverso da tutti i (pochissimi) neri che avevo incontrato in vita mia, nell’Inghilterra sud-occidentale, e non era nemmeno come VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA gli artisti americani di colore che avevo visto e sentito in televisione, che suonavano il blues, il rhythm and blues (R&B) e il soul. Forse solo il trasgressivo stile effeminato di Little Richard si poteva considerare un accenno stravagante alla possibilità di avere in futuro un Hendrix, ma lo stesso non si può dire, certamente, di Otis Redding, Sam e Dave o Wilson Pickett. Tuttavia, se avessi deciso di soffermarmi di più sui suoni della musica soul degli anni Sessanta, inevitabilmente avrei finito per incappare in varie delle traiettorie sonore e dei percorsi musicali che hanno contribuito alla costruzione dell’itinerario di Hendrix. Oggi ascoltare Hendrix apre a un tipo di esistenza in cui la musica testimonia una scansione del tempo alternativa (il tempo della modernità, della città e dell’Occidente), che mi trasporta in una narrazione, in una canzone, in un pianto, in cui il suono svela una storia che mette in discussione la propensione a ridurre la musica a una moribonda genealogia di influenze stilistiche. Se il linguaggio è la dimora dell’essere, allora gli stili musicali sono, essi stessi, dichiarazioni ontologiche: un’eco che rimbomba al di fuori delle circostanze che tradiscono ben più di una semplice modifica della sintassi musicale. Di questa più vasta potenzialità all’epoca coglievo soltanto un barlume, che pure ha continuato ad attirare la mia attenzione, a tormentarmi nei miei interessi successivi. Jimi Hendrix continua a perseguitare la mia vita. Al di là della tragedia della sua scomparsa improvvisa, c’è la questione del suono che ho ereditato, che continua a esistere, a vivere, ponendo un enigma che mi sprona a rispondere. Per molti di coloro che facevano parte del suo pubblico, all’epoca in prevalenza costituito da bianchi, la sua musica ribelle e la sua capigliatura altrettanto ribelle identificavano Hendrix con “il selvaggio” che da sempre popolava l’immaginario europeo, mettendone a repentaglio l’ordine. Provenendo da qualcosa che andava oltre l’esperienza immediata, il suo stile musicale e la sua sessualità rivelavano per alcuni la seduzione, per altri l’orrore dell’Es. Io però ritengo che ci fosse anche un sottile esotismo (ed erotismo) che avvolgeva questo chitarrista nero di Seattle, che contribuiva a confondere sia lo stereotipo eurocentrico che l’immaginario nero. Sul palco, nell’amplesso pubblico con la propria chitarra prima di raggiungere il culmine, in cui lo strumento veniva dato alle fiamme in un sacrificio simbolico, l’eccesso del rock IAIN CHAMBERS infiammava la notte e temporaneamente alludeva all’ibridazione musicale e culturale. Ciò toccava le corde più profonde della sottaciuta ambivalenza culturale nella musica popolare moderna e nella vita urbana contemporanea, in cui spesso all’amore per la musica nera non corrispondeva, talvolta in maniera violenta, l’amore per la gente di colore. Agghindato con caffettano, fascia attorno al capo e pantaloni a zampa di elefante, Hendrix venne tuttavia sulle prime messo in relazione agli smunti corpi psichedelici, al proliferare degli hippy e all’estate dell’amore. Verso la fine degli anni Sessanta, in Europa e nel Nord America, la gioventù e la sua musica avevano trionfato pubblicamente. C’erano una musica pop, una moda pop, una cultura pop, una pop art… una vita pop. Per quanto ancora frequentemente osteggiata, la cultura popolare americana al di fuori degli Stati Uniti, o per dirla con una parola sola, “l’americanizzazione”, imperava ovunque. Era sinonimo del trionfo della gioventù e dei suoi schemi di consumo. Eppure, questa apparenza scintillante e questa positività, tutti riflessi ironicamente nello specchio artistico dei dipinti in serie di Warhol e nelle tele a fumetto di Lichtenstein, presentavano anche un altro lato della medaglia. Quando, nello sforzo di perseguire l’autorealizzazione, il linguaggio della gioventù, il consumismo e l’individualismo vennero spinti fino al punto di frantumarsi, allora l’economia politica di queste stesse categorie venne messa bruscamente in discussione dalla portata ambigua del loro potenziale culturale1. Tra il festival di Monterey (1967) e quello di Woodstock (1969), si definì la parabola dell’odissea ribelle nel cuore dell’“Amerika”, nelle configurazioni psichiche, estetiche e politiche del capitalismo più sviluppato. Questa parabola era un tentativo di trovare uno stile di vita alternativo e più “autentico”, simulato in un simbolismo arcaico tratto dai mondi preindustriali dei nativi americani, del buddismo zen e di un’Arcadia immaginaria evocata dal ritorno ai ritmi naturali della terra. Ad aprire le porte a questa alternativa, paradossalmente, furono i frutti industriali degli elisir chimici e della riproduzione tecnica del suono. Nel suo campo d’azione totalizzante e consapevole di sé, nella sua 1 Questo capoverso e il seguente sono in buona parte tratti da Chambers 1985. VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA evocazione soggettiva dell’utopia e di un erotismo di liberazione, questa controcultura ha segnato un inconfondibile slittamento al di là della sua precedente acquisizione dei momenti stilizzati dai confini della settimana lavorativa. Insistendo sull’utopia, la parabola del movimento studentesco in Europa, del radicalismo universitario negli Stati Uniti e la generalizzazione di una cultura che “aveva dato forfait” per abbracciare esperienze on the road, era destinata a essere interrotta da altre versioni del sogno. Le quali altre versioni, poste nell’emarginazione quotidiana dei corpi incasellati per razza e per sesso, in origine si scatenarono nelle lunghe e afose estati, quando la pressione fuoriusciva dal Sud, nonché dai ghetti. È lì che le musiche nere, in particolare la richiesta assidua del soul, hanno creato il più poderoso “connubio di erotico e politico” (Lefebvre 1968)1. Proprio in questa imprevista congiuntura di utopismo occidentale e del ritorno del suo passato represso, la musica di Hendrix ci invita a considerare una scena che va al di là delle sue rappresentazioni della controcultura. È risaputo, e tuttavia significativo, che le origini dello stile “psichedelico” di Hendrix si possono identificare nella tradizione del blues urbano e del rhythm and blues presso gli afro-americani nel secondo dopoguerra. Si tratta di una tradizione che frustrava continuamente i tradizionalisti, dato che, in apparenza, passava irriverentemente da ciò che molti osservatori bianchi ritenevano “autentico” al “non autentico”: dall’immediatezza personale degli strumenti acustici all’anonima mediazione dell’amplificazione elettrica. Esplorata liberamente, questa tradizione nera rifiutava di restare prigioniera di un passato prescrittivo, e quindi si esponeva ai linguaggi del cambiamento, del catalizzatore culturale proposto dalla città e dalle sue culture urbane. Emerse così un’estetica urbana radicalmente innovativa. Nelle strade tortuose, improvvisate, del jazz o nelle autostrade diritte, elettriche del rhythm and blues, questa estetica forniva apertamente una risposta alla metropoli e alla modernità in maniera alquanto diversa dalla chiusura nervosa di un canone di derivazione europea che voltava sistematicamente le spalle alla città e cercava 1 Qui Lefebvre commenta Herbert Marcuse. IAIN CHAMBERS altrove la dimora della cultura. Furono i critici musicali e culturali bianchi, ansiosi di salvaguardare il proprio concetto di musica nera “autentica” (nonché la posizione subalterna che essa rappresentava) che, per esempio, persuasero Big Bill Broonzy, durante la sua tournée inglese negli anni Cinquanta, ad abbandonare la chitarra elettrica contemporanea e il suono della Chicago band per abbracciare uno stile acustico solista precedente. A questo punto, l’“autenticità” aveva chiaramente un significato maggiore per i guardiani della cultura egemone, bianca, e della sua estetica, piuttosto che per chi si supponeva la incarnasse. Passare al rhythm and blues equivaleva a passare a un tipo di musica in cui la presunta antitesi tra musica nera “autentica” (il blues rurale dell’anteguerra) e la diavoleria “artificiale” della città (la chitarra elettrica e la voce amplificata) veniva spesso volutamente ignorata da gran parte dei professionisti. Come pratica in fieri e interrogativo culturale delle possibilità storiche, questa musica formulava un’estetica che lasciava poco tempo alla nevrosi culturale sulla città e alle possibilità della riproduzione tecnica. Si rifiutava di subire limitazioni a opera di siffatte preoccupazioni. I suoni e gli stili delle cantanti blues urbane (Ma Rainey, Bessie Smith, Memphis Minnie, Billie Holiday), che usavano tutte il microfono e la cui musica veniva amplificata per mezzo dei dischi, della radio e della pubblicità, aprirono nuovi orizzonti nella creazione di questa cultura urbana moderna. Quantunque spesso aspramente biasimato per ragioni di razza e di classe, il blues non era un fenomeno isolato, autoctono, “folcloristico”, bensì parte integrante della modernità, centrale nella creazione della cultura contemporanea e urbana. Ma mentre talvolta l’incursione di Hendrix nella musica rock pare che evochi un ritorno al blues maschile errante degli anni Venti e Trenta (Charlie Patton, Robert Johnson) foraggiato dalla tecnologia, le musiciste nere (come testimoniano le assai più difficili parabole di Chaka Khan con Rufus, o di Nona Hendryx) raccontavano una storia diversa, e caratterizzata da un successo minore. Ancora una volta, la sottocorrente romantica dell’autenticità, il bluesman itinerante, forniva un’angusta apertura, mentre la centralità delle voci delle cantanti nere nella musica urbana moderna continuava a limitarsi alle categorie, in gran parte inquadrate per razza, della musica soul, oppure al successo dello spettacolo sfarzoso della VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA Tamla Motown, entrambi generi per lo più snobbati dalla comunità della musica rock bianca e dai suoi critici. Hendrix, in quanto chitarrista nero isolato nel mondo perfettamente bianco della musica rock, ha subito inizialmente un doppio ostracismo: scacciato dal contesto africano-americano della fine degli anni Sessanta e al contempo isolato nell’ambiente che l’aveva temporaneamente adottato della musica rock angloamericana. In quanto esecutore nero riconosciuto nel mondo del rock bianco, Hendrix era una presenza turbante, ma fortemente esotica, che nella sua vita è stata esclusa dalla possibilità di crearsi una propria identità all’interno degli schemi storici di entrambe le patrie potenziali. Il suo suono, la sua firma sonica iconoclasta, i graffiti che tracciava con la chitarra, rappresentavano una fastidiosa interruzione nel copione culturale prescrittivo. Era una costellazione culturale e musicale che sfidava i presupposti delle identità facilmente disponibili. A prescindere dallo sguardo culturale che si voglia adottare, la presenza di Hendrix disturba la vista del paesaggio culturale. Come la presenza e l’assenza simultanee della sua chitarra con distorsore che raddoppia, trasferisce e tormenta la festa della musica rock come un ospite indesiderato, la sua musica è un tratto obliquo che ha lasciato un segno inquieto, di disturbo, sulla storia dei nostri tempi. Il doppio scandalo della musica di Hendrix era che attingeva da tutte le risorse dell’eredità musicale nera per portare il rock più in là di dove potessero prevedere i suoi progenitori e, infrangendo i limiti e spingendosi fuori dal seminato, si apriva al contempo a un ulteriore insieme di possibilità per la musica nera contemporanea. Come l’interrogativo culturale e il disorientamento creato dai dipinti di Jean-Michel Basquiat nelle sale bianche del mondo dell’arte, Hendrix offriva una mascherata (e una maschera) culturale, azionava contemporaneamente l’espressione e la repressione di questa sua contestualizzazione culturale1. Come un’interruzione drastica, un lampo di perturbazione che tagliava trasversalmente le consuete creazioni sonore sia della musica bianca che di quella nera dell’epoca, trasformò quei linguaggi in un istante di libertà. 1 Sull’uso e sull’abuso dell’identità nera nell’arte mondiale contemporanea, si veda Mercer 2000. Su Jean-Michel Basquiat, si veda Hebdige 1992. IAIN CHAMBERS Proprio per questa ragione non mi sento spinto ad ascoltare la musica di Hendrix in termini di nostalgia, o semplicemente registrandone il significato storico nella narrazione della musica popolare, bensì a scorgere nel suo suono, nel suo acquisire la forma e il timbro nello stordimento culturale della fine degli anni Sessanta, una serie di passaggi sonori e culturali che continuano a proiettare una risonanza, nonché una dissonanza, sia nel passato che in avanti, verso il mio presente, per iscriversi in futuri possibili. Pur proiettato all’indietro, verso le sue radici blues, si riteneva però al contempo che Hendrix avesse generato le schiere di chitarristi neofiti che sono venuti dopo di lui e che sciamavano per gli altipiani della musica rock degli anni Settanta (da Jimmy Page dei Led Zeppelin a Eddie Van Halen), creando il genere di rottura dell’heavy metal. Tuttavia questo suono sperimentale, la sua forma libera e le tecniche estese elettronicamente (distorsione, feedback, risonanza, eco) sarebbero anch’esse divenute onnipresenti nelle musiche nere urbane: dal soul al jazz alle colonne sonore del cinema; da Sly Stone e Bobby Womack a Isaac Hayes, a Miles Davis, Ornette Coleman, Sonny Sharrock e James Blood Ulmer, e così via, passando per tributario di James Brown, a George Clinton e Bootsy Collins, a Prince e ai Living Colour. Se, dopo Hendrix, la musica rock bianca ha subito una radicale trasformazione, lo stesso si può dire del suono nero. Hendrix non era tanto una mina vagante nel mondo del rock bianco, quanto un complesso e traballante ponticello che mette in comunicazione opportunità nuove che prima viaggiavano in contesti culturali differenti e, in apparenza, del tutto separati. Ascoltare la sua musica in quest’ottica non mi consente soltanto di parlare di Jimi Hendrix negli ambiti, in apparenza distinti, delle musiche africano-americane e del rock bianco, ma anche di fare ritorno al tema delle culture urbane moderne e di mettere in discussione e rimodellare l’estetica contemporanea. In questo modo acquisisco i mezzi per spezzare il cerchio chiuso della caratterizzazione esotica (Hendrix il gitano nero, il “selvaggio” nomade), e di apprezzare al contempo la ricchezza del suo spirito musicale e culturale. In questo modo si estende la provocazione di Hendrix, che sfidava le autorità culturali esistenti su ambo i lati degli spartiacque culturali. L’ambiguità del talento musicale di Hendrix blocca e fa slittare la semplicistica applicazione delle contrapposi- VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA zioni binarie, non solo di quelle tra le musiche “autentiche” e “non autentiche”, ma anche di quelle tra identità “autentiche” e “non autentiche”. Una provocazione quasi contemporanea che si orienta su linee simili e che riceve l’influenza diretta di Hendrix è stata la posizione di sfida che Miles Davis ha assunto tra la musica nera urbana e il rock bianco dopo l’uscita di In a Silent Way (1969). Come sfidando “l’evidente inclinazione per la medesimezza e la simmetria” (Gilroy 1993a, p. 186), Hendrix e Davis fanno parte di un’avanguardia musicale nera alla quale si potrebbero aggiungere nomi e stili tanto eterogenei come quelli di Sun Ra, John Coltrane, George Clinton, Sly and the Family Stone, Prince, la quale ha perturbato l’ovvietà di siffatte distinzioni, alleviando la musica dalle pretese culturali (ed etniche) precedenti senza allentare la linea di basso, il “nero continuo”, della loro storia, delle loro cronologie, e la sua particolare maniera di raccontare. Diventa una musica che resta sospesa nelle configurazioni storiche e culturali dell’etnicità, perché indiscutibilmente è africano-americana, ma che non è più il punto di arrivo, bensì il punto di partenza di una serie di aperture che porta a una riconfigurazione radicale dell’estetica e dell’etica urbane. Accolta lungo questa direttiva, la predilezione di Hendrix per i suoni extraterrestri e per i mondi fantascientifici (in brani come Third Stone from the Sun, Up from the Skies, 1983… A Merman I Shall Turn To Be) riecheggia lungo uno spettro che certamente si estende dai viaggi cosmici della Solar Arkestra di Sun Ra a Interstellar Space di John Coltrane, e poi attraversa il funk cibernetico di George Clinton per arrivare alle “radici” ritoccate digitalmente e sintetizzate nel dirottamento contemporaneo del rap urbano e dell’hip hop. Nel sorprendente lirismo della “voce” musicale di Hendrix, veniamo costantemente attirati in un linguaggio che parla con accenti di un altro mondo di una redenzione culturale che in apparenza viene sempre rimandata a domani e spostata in altro luogo. Da questo disincanto (il blues in senso più profondo del termine come “struttura della sensazione”, Raymond Williams), e non semplicemente dalla figura musicale, Hendrix intesse una poetica elettrica che riesce a spezzare la sua eredità musicale e culturale e non formula soltanto una promessa, ma anche un’efficace rielaborazione delle condizioni che costituiscono la sua complessa collo- IAIN CHAMBERS cazione. Raggiunge il suo zenit musicale nella sua famosa scomposizione dell’inno americano dell’identità, La bandiera a stelle e strisce, portata in scena a Woodstock. Si potrebbe quindi ritenere che il fatto che Hendrix, Sun Ra e George Clinton abbiano rappresentato personaggi e scenari extraterresti suggerisca una duplice fuga: dalla rigida base etnica e storica, ma anche, più in profondità, verso le possibilità di abitare un sublime moderno, urbano. Qui è presente un’elaborazione di una tendenza musicale ironica in cui la prescrizione viene sopraffatta dall’iscrizione, la tradizione dalla traduzione e dalla trasformazione, mentre la musica migra altrove, oltre i confini della sua presunta identità e posizione culturale. Suoni che fondono l’eterogeneità delle esperienze, rigettano gli incontri storici e culturali nel particolare corpo e nel particolare respiro dell’evento, in tal modo confermando e infrangendo al contempo le regole della musica, della cultura e della storia. Andando alla ricerca del tuo posto nel mondo, è inevitabile che le norme imposte (i motivi musicali, i valori estetici, le collocazioni etniche) vengano punzecchiate, parodiate, sabotate e deviate. Non c’è tradizione, non c’è linguaggio immune da questo processo. Pertanto, quando Hendrix suona il blues (Red House, Voodoo Chile), inevitabilmente scava in profondità, mentre si spinge oltre col suono, espandendo l’orbita, prolungando l’interrogativo dell’odissea. Ecco che qui, sul ciglio della memoria culturale, mi ritrovo a considerare la musica non soltanto come suono che contrassegna e rende omaggio al tempo che fu, ma anche come un momento della narrazione continua che consente di ricordare e ri-raccontare, che rende possibili nuove configurazioni del senso e della sensibilità, capaci di interagire col mio tempo, di emergere. Difatti, sulla strada verso l’ascolto della musica di Jimi Hendrix, forse è necessario lasciare in sospeso alcune delle domande che inizialmente collocavano e interrogavano la figura di Hendrix in vita, al fine di udire meglio ciò che era stato passato sotto silenzio, o persino estromesso da questo schema. Che sia identificato come un menestrello nero le cui selvagge bizzarrie hanno confermato i peggiori stereotipi bianchi, o come uno Zio Tom che aveva tradito la sua razza, nell’eccesso del linguaggio ricevuto in eredità, quel che irrompe nella mascherata culturale che egli aveva messo in atto e penetra attraverso le maschere rituali che indossava, è il VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA suono; è la testimonianza poetica che non è possibile ricondurre all’argomentazione che cercavano di proporre i suoi commentatori e critici. Ovviamente il frastuono di queste controversie del passato non deve essere semplicemente messo a tacere come se oramai fosse uno statico anacronismo storico, ma invece di tenere in ostaggio Hendrix, adesso è possibile trasformare queste polemiche in un’ulteriore apertura: perché queste circostanze, queste contingenze, inevitabilmente fanno parte del linguaggio musicale eclettico di Hendrix, di quello che diceva musicalmente e della maniera in cui lo diceva. In ultima istanza, ciò che resta è il fardello del suono, il suo peso storico, che reca testimonianza di un tempo e di una figura che continua a parlarci. La musica di Hendrix deve certamente essere collocata nell’ambito degli sviluppi dell’estetica nera avanguardista e urbana che ha continuamente sfidato le conoscenze ereditate della cultura, della tecnologia e le possibilità storiche ed estetiche di vivere nella città moderna. A questo punto, la sua musica assume un ruolo centrale nella comprensione dell’emergenza del sublime urbano contemporaneo. Posta in questa maniera, la musica di Hendrix è cruciale nello slittamento dalla marginalità (blues, jazz, R&B, soul, rap) a una posizione centrale nella dispersione di un’estetica astratta e nella comprensione astorica della cultura. È a questo punto che il passaggio dai ritmi ipnotici della chitarra elettrica di Bo Diddley ai paesaggi sonori futuristi impressi lungo il manico della chitarra di Hendrix dieci anni più tardi potrebbe cominciare a essere considerato parte di un repertorio comune. In entrambi i casi, bisogna fare i conti con la città, con la vita urbana, con un immaginario metropolitano e una riproduzione tecnica. Probabilmente non c’era altra scelta, se non cercare di appropriarsi di quello spazio. Ma qui ciò che è significativo per la storia della modernità è come una cultura subalterna e discriminata sia riuscita nell’impresa di trasformare i linguaggi della presunta alienazione (quelli della città, delle sue tecnologie e delle sue tecniche) in un’affermazione inattesa. Nella sua codificazione sonora dello spazio urbano, nel renderlo un luogo intimo e protettivo, la musica nera ci ha insegnato a esperire e a vivere diversamente, ossia, al di là della condanna ossessiva della chiusura patriarcale rigida e del suo rifiuto della cultura urbana e delle tecnologie relative. IAIN CHAMBERS Ascoltando questa musica in quest’ottica diviene possibile considerare la storia delle moderne musiche africano-americane come una forma di dialogo perpetuo con le possibilità (nonché con i limiti, che quando vengono riconosciuti offrono nuove aperture o spaccature nella forma esistente) della città moderna: dal blues al jazz, dal soul al rap. Non sono forse tutte queste musiche modi diversi di esplorare la modernità (come lamento, protesta, gioia e rabbia, come poetica), invece che di respingerla categoricamente? Significativamente, ascoltare questa storia in questo modo significa invertire l’emarginazione frequentemente romantica delle sue voci. Qui le musiche nere non occupano più le annotazioni a margine dell’esotico, ma diventano centrate e centrali. Invece di essere considerate un abbellimento della colonna sonora urbana, un ornamento emozionante che rivive e scuote il prevedibile tran-tran della musica rock bianca del dopoguerra e la corrente principale per mezzo di una serie di “prestiti” e “ispirazioni”, in questi suoni neri, in questa “corrente nera”, si sente qualcosa di più. Scaturisce uno spostamento, un’altra versione culturale del “taglio” storico, che svela un altro centro della produzione musicale metropolitana, un altro modo di stare nella città e di abitare il mondo moderno. A questo punto le musiche africano-americane ribaltano il presunto modello dell’emarginazione sottoculturale e le loro culture della resistenza (in eterno destinate alla subalternità e alla negazione), e divengono istanti che decentrano e ricentrano la partitura della storia. L’ubiquità del reggae e del rap a livello globale, che si sparge in una miriade di varianti e traduzioni locali, è forse il sintomo più eloquente e resistente di questo riallineamento nella grammatica musicale metropolitana. Ma anche qualora venga riconosciuto questo adattamento strutturale, dando luogo a una differente mappatura e comprensione della scena culturale, la presenza di Hendrix continua a essere fastidiosa. Pur spostando il centro della musica moderna metropolitana, rimane una figura enigmatica. Come per il personaggio del gitano errante che egli aveva adottato per se stesso, talvolta è difficile mettere a fuoco o contestualizzare la sua posizione, tanto negli ambiti culturali degli anni Sessanta quanto in quelli odierni. Che sia proprio questa difficoltà, l’impossibilità di essere facilmente inquadrabile o scartabile, l’aspetto più istruttivo? VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA Questo perché la musica di Hendrix evoca una complessità e una molteplicità di forme che trapassa le distinzioni convenzionali: si pone al crocevia, e per quanto abbia percorso una strada particolare, una strada delineata dalla schiavitù e dalla sottomissione di stampo razzista, rifiuta di farsi incasellare in quel percorso. Elabora un’estetica urbana (in ambo i sensi) che non si limita a costruire particolari generi musicali, ma che suona ai limiti, vive tra mondi musicali e culturali, rielaborando e ridirigendo le loro possibilità nell’ambito dell’eredità storica della modernità. Se vogliamo insistere sul senso “radicato” della cultura e della tradizione come un continuum di identità ed esperienze autonome, allora Coltrane, Hendrix, Davis e Prince sono tutti “esiliati”. La loro musica ci intrappola nelle configurazioni slittanti, erranti, come insieme di suoni inter o transculturali, i quali esplorano i limiti ereditati, o da essi “sconfinano”, mentre di continuo ci trascinano altrove. Le comprensioni politiche ed etiche che si possono trarre da queste storie, da questi suoni, mentre percorrono la nostra vita e risuonano nel nostro senso del divenire non consistono soltanto nel fatto che essi proiettano l’ombra della loro influenza sulla modernità, ma anche che al contempo svelano una maniera differente e più sperimentale di vivere e di testare le possibilità dell’esistenza. Mentre cozzano contro le divisioni del nostro tempo, cui agognano, aprono spazi all’interno di quanto abbiamo ricevuto in eredità che estendono e strappano quanto abbiamo accettato, perturbano e ritagliano ciò che è pianificato, per suonare il mondo in una chiave diversa. Citare il passato Citare il passato vuol dire ricollocare il presente e rivelare all’interno dello stesso l’istanza di sentieri contingenti che ci riconducono indietro mentre ci trasportano avanti. I ricordi… dell’infanzia a Berlino, di un giardino zoologico, di una città dove “smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta, è una cosa tutta da imparare” (Benjamin 1950, p. 9)… dell’adolescenza a Belfast, “dove riesci ad avvertire il silenzio alle undici e mezza nelle lunghe notti estive, mentre parlava Radio Luxembourg, e sussurravano le voci dall’al- IAIN CHAMBERS tra parte di Beechie River” (Van Morrison 1991). Nel dicembre 1993, al Masonic Auditorium di San Francisco, Van Morrison canta In the Garden, che si trasforma in una canzone più datata, Real, Real Gone, che ricorda You Send Me di Sam Cooke. Qui c’è un corpo maschile che si adatta alla musica e poi si esprime per mezzo di essa, la “grana” di una voce che richiama i limiti dove si estende per superarli, mentre il canto scende nel respiro dell’essere, penetra nell’infinito del suono. Sempre in California, a sud di Big Sur, volgendo lo sguardo attraverso la pineta verso il mare, nella speranza di avvistare balene, sento dentro di me risuonare un’altra canzone: Sirene che suonano nella notte La salata aria di mare nella brezza mattutina Macchine che percorrono tutta la costa Dev’essere di questo che si tratta (Morrison 1990). Tentare di descrivere tale musica significa intraprendere un’impresa persa in partenza, destinata a fallire prima di raggiungere l’obiettivo: significa ritrovarsi a balbettare dinanzi all’ineffabile. E allora, a che serve scrivere? Forse soltanto a lasciare un segno, una traccia e quindi a cercare un sentiero nel mondo. E allora la canzone stessa non tratta necessariamente di nulla, è un evento sonoro in cui si combinano fortuito e intenzionale. Non si tratta quindi di approssimazione verbale, di spiegare il suono, come fosse contenuto nel guscio di un senso e di un scopo stabili, bensì di cercare in esso una risposta che faccia appello al mio senso dell’essere. Un altro momento. In fondo a un vicoletto scuro nei Quartieri Spagnoli di Napoli, in uno sfolgorio di luci si erge il teatro Galleria Toledo. Stasera sono venuto qui per vedere e ascoltare il ballerino algerino El Hadi Cheriffa, accompagnato dalla voce e dalle percussioni di Moussa Belkacemi. I suoni, il corpo, la poetica della grazia visiva e uditiva raccolgono la musica e le forme tradizionali in una commistione mutevole (beduino, berbero, tuareg), le cui caratteristiche e la cui composizione rientrano a ugual titolo nel Maghreb contemporaneo. La tematica della loro composizione e della composizione di una siffatta tematica permea la danza, risuona nel canto… VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA la voce che canta come la mano che scrive è il corpo nel linguaggio che risponde all’appello e alla cura dell’essere. Pensare Pensare. La maggior parte di noi ha ricevuto in eredità un modo di pensare che si basa sulla separazione fondamentale del soggetto dagli oggetti del mondo; una netta divisione tra il senso di se e le cose che in seguito il pensiero reclama e garantisce per se stessa. Per mezzo di questa distinzione, la ragione sfugge alla finitezza del pensatore, la conoscenza sfugge al tempo. Sebbene comporti libertà di pensiero e di autovalutazione, si tratta, paradossalmente, di un modo di pensare che, persino nei momenti di maggiore attenzione e riflessione, non può mai mettersi davvero in discussione. Il pensiero orbita attorno alla premessa e alle asserzioni prive di verifica del cogito. Si mette in discussione soltanto ciò che non rientra immediatamente nella soggettività: il mondo esterno degli oggetti e dell’alterità. Tuttavia, il pensiero critico, contrapposto al pensiero consolatorio, rinnega necessariamente il desiderio di questa completezza soggettiva. Cancellando la pulsione a essere “schiacciati dalla coerenza”, il pensiero critico non è affatto concettuale (Tsing 1993). Il suo rigore non è né egocentrico, né geometrico, perché viene a essere disciplinato da un imperativo ben più grande e ambiguo: quello di essere già e sempre al mondo. Da questo ha origine la nostra comprensione. La redenzione non è più in cima alla strada, ma ai nostri piedi, nei passi che facciamo tutti i giorni, nel linguaggio in cui viviamo, nella finitezza dei nostri corpi, nei limiti del nostro essere. Contestare i modi d’essere del mondo non può contemplare la procrastinazione, una conoscenza ancora da venire. Dove è giunto ognuno di noi, il posto che occupa, è il risultato di un dialogo continuo, che si estende attraverso le generazioni. Il nostro pote- IAIN CHAMBERS re, il nostro essere, viene da quel passato per incontrare e configurare il nostro futuro. L’asimmetria dei poteri, delle loro rappresentazioni politiche e culturali, nonché della loro appartenenza a discrepanze e discriminazioni di vario tipo, struttura un mondo in cui la coerenza e la conoscenza che esso sposa divengono inevitabilmente la metonimia di un’imposizione violenta. Per quanto collegata, in maniera esplicita, all’evocazione linguistica del plurale, questa tendenza sociale e politica costituisce necessariamente una sottile rete che cattura ed emargina sistematicamente la differenza, spesso, e in maniera alquanto sintomatica, nel nome del liberalismo, della politica dell’identità e del multiculturalismo. Trarre dalle situazioni che ricevo in eredità e in cui vivo un linguaggio che mi invita a pensare diversamente mi incoraggia a interrompere e a mettere in discussione questi precetti ereditati, anche quelli di provenienza radicale. In questo modo posso ammettere una diversa configurazione del “politico”, e forse anche risiedervi. La musica e i ricordi: la perenne traduzione dello spazio (lo spazio di un linguaggio, di un suono, di un’immagine, di una vita) nelle particolarità di un luogo, nell’asse dell’esistenza, costituito dall’“adesso” sfuggente, fa inevitabilmente appello alla traduzione della geografia in ontologia, della sintassi del suono e dell’immagine nell’evento del canto e della visione, dell’astratto nel corpo. Considerare queste tematiche nel contesto del suono, anche nell’epoca della riproduzione tecnologica globale, significa prestare attenzione al potere metaforico e cangiante della musica, che dà voce al dilemma. In quanto linguaggio, istituzione economica e insieme di pratiche culturali, in quanto modalità di ascoltare il mondo e farlo risuonare, la musica non contribuisce solamente alla creazione dei paesaggi, ma anche ai variegati orizzonti culturali in cui ci muoviamo. In questo senso è anche “un ricettacolo della nostra conoscenza e della nostra memoria” (Fry 1993, p. 12). Potremmo considerare la musica Potremmo considerare la musica uno dei linguaggi che viviamo, in cui risiediamo, e in cui noi, le nostre storie, culture e identità sono costituite. Come linguaggio è apparentemente incorpo- VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA reo, eppure profondamente terrestre (Celan 1978). Il linguaggio è la costellazione della presenza e dell’assenza, della perdita, che fornisce le coordinate invisibili del nostro essere: ciò che, dopo tutto, rimane come ferita della realtà è proprio il linguaggio, quel mai più e sempre più che ci spinge avanti lungo direttive raramente rilevabili esposte ai venti del mondo dove non c’è un punto di riferimento o di origine unico. Forse, come dice Foucault verso la fine di Le parole e le cose, questa è la nostra “origine senza origini”. A questo punto chiedersi che cosa sia la musica equivale a chiedersi che cosa sia la nostra cultura, chi siamo noi, che cosa ci facciamo qui? Come giustamente osserva Antoine Hennion (1993, p. 12): “la musica è una sociologia”. Proporre questo momento di riflessione, questo silenzio che precede il canto, significa contrapporsi all’acquisizione teorica del mondo, intenta a ridurre il linguaggio, che sia la musica o il discorso quotidiano, a un mezzo trasparente, disposto dopo il nostro arrivo, un semplice servo della nostra soggettività. Il linguaggio non viene dopo il soggetto: è già in attesa, e già ci chiama, perché i linguaggi, che siano letterari, musicali o quotidiani, o anche se spesso dipendono da sistemi tecnico-culturali alquanto precisi, non si accendono e spengono premendo un interruttore: essi persistono e permeano il nostro mondo, perseguitano la nostra presenza e circolano al di là della nostra volontà. In quanto parte integrante dell’economia delle nostre vite, precedono la nostra conoscenza e quindi informano il nostro essere e divenire. Non si possono ridurre a un mezzo o alla tecnologia: fanno parte della nostra comprensione. Per esempio, dove finisce l’immagine o il suono e comincia il sociale? Oppure, in un lessico diverso, dove comincia il commerciale e finisce l’estetico? L’impossibilità di delineare questi limiti ci porta al di là delle miopi distinzioni che tentano di prendere le distanze, critiche quanto sociali, da questi mezzi, linguaggi e tecnologie. Da loro non possiamo ritrarci, sono sempre a portata di mano. Siamo costretti a riconoscere la loro centralità ontologica rispetto a chi siamo, a ciò che potremmo voler diventare1. 1 Ho trattato diffusamente dell’economia politica della musica popolare nelle configurazioni storiche della modernità in Chambers 2000. IAIN CHAMBERS Forse questa mancanza di distanza, che determina una propensione a rimanere invischiati e trasformati in questi linguaggi di modo che, al di là dell’ovvia portata strumentale del profitto politico, entrano anche profondamente in risonanza con l’ambiguo peregrinare del nostro essere nel mondo, viene segnalata in maniera più acuta, per quanto raramente presa in considerazione, nel dominio del suono. Il passaggio del suono – e il pensiero inquietante dell’inconcludente – frustra le nostre pretese di afferrare e ridurre i nostri ambienti a una cornice comune. Questo è il luogo in cui l’immediatezza dei regimi visivi e la sorveglianza della vista sono usurpate dall’infinita alternanza di canto e silenzio, dove ascoltare può essere tanto significativo quanto cantare. Ciò che chiamo “trasgressione” è qualcosa di completamente letterale e secolare al contempo: quella facoltà che la musica ha di viaggiare, attraversare, fluttuare da luogo a luogo nella società, anche se molte istituzioni e ortodossie hanno tentato di porle un freno (Said 1992, p. XV). Per quanto continuamente inserito nelle apparenze dell’economia visiva, il corpo evade continuamente da questo schema quotidiano attraverso le migrazioni del suono. La memoria si aggrappa allo schema mentre segue le evoluzioni della musica. I suoni si fanno beffa delle costrizioni unilaterali dell’egemonia oculare e minacciano costantemente di spezzare i confini e di circolare senza destinazione o direzione. La feticizzazione visiva dell’oggetto viene trascinata via dal suono: le note, gli urli, il respiro, il parlato, il silenzio: lo spazio che offre ospitalità al futuro. La pulsione visiva che tenta di rendere tutto trasparente, scientifico, clinicamente comprensibile ed economicamente sfruttabile (qui risiede l’arcana vicinanza dei discorsi medici e dei media) necessariamente tenta di afferrare l’essere e il tempo, di trasformare la vita in un istante esemplare, un’astrazione, una “riserva” di significato sempre a disposizione (Heidegger 1962a)1. L’immagine, con tutta la sua ambiguità 1 Non si vuole negare che i linguaggi visivi possano fornire nuovi inizi in contesti in cui anche le immagini divengono testimonianze storiche e firme etnografiche per qualcos’altro e qualcun altro, stabilendo una differenza nell’ambito della crescente credenza globale nella visibilità della verità come “informazioni” oculari. Si veda Chow 1995. VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA potenziale, è strutturalmente più circoscritta e tende alla consolazione di un punto fermo semantico. È l’economia del suono, dal silenzio al grido, che in ultima istanza infastidisce i regimi visivi e la repressione che cerca di rendere tutto rappresentativo. Rivolgersi all’orecchio significa altresì riportare le immagini al piacere delle superfici, alla libertà (e ai limiti) della creazione, del camuffamento, del mascheramento della rappresentazione. Questo significa contestare il trionfo dell’immagine sull’azione, della forma incorporea sul flusso corporeo, della firma metafisica sull’evento sregolato, del segno sul suono1. Superando una tale immaginazione e un tale inquadramento del mondo, la conclusione visiva subisce un riposizionamento e l’immagine è costretta a svelare i propri impulsi logocentrici come potere e limite, promessa e minaccia, espansione e chiusura. Tra la “comprensione metafisica che tutta la verità è rappresentativa” (Thiele 1995, p. 25) e ciò che continua ad agitarsi al di là di una siffatta cornice c’è un sentiero lungo il quale la poiesi del suono mantiene la promessa dell’irreprimibile. Una voce nell’oscurità, la cadenza di un sassofono per strada, la saliva sulla lingua, il respiro che si fa strada tra le parole, la sospensione rappresentata dal silenzio: tutto questo è musica, e tutto questo muta le motivazioni immediate e le interrompe con la memoria, perché domandare il significato della musica, il significato del suono, significa forse distillare dalle profondità dei nostri sensi l’inafferrabile essenza dell’essere. Scrive George Steiner (1992, p. 55, corsivo nell’originale): “Nella musica, essere e significato sono inestricabili. Rifiutano ogni parafrasi. Ma essi sono, e la nostra esperienza di questa essenzialità è certa quanto quella di ogni consapevolezza umana”. Intessendo ritmo ed essere, musica e memoria, il desiderio, il rinvio del suono intona un contrappunto interno nello stato prelinguistico del linguaggio, nell’indeterminabile semiosi dei nostri corpi2. La musica ci permette di viaggiare. Soprattutto, ci trascina nei meandri della memoria e nella sua “disgiunzione improvvisa del 1 Per una discussione coraggiosa e ponderata delle implicazioni politiche e della cecità critica dell’egemonia oculare nel contesto della musica nera contemporanea, si veda Gilroy 1994. 2 Si tratta di un riferimento alla distinzione, a opera di Julia Kristeva (1984), tra semiotico e simbolico nel linguaggio. IAIN CHAMBERS presente” (Bhabha 1994, p. 300). Qui il tempo oltrepassa la restrizione dei nostri concetti, perché il tempo della memoria è un tempo reversibile che ci consente di ritornare, rivisitare e re-visionare altri tempi. La presenza coeva di questo tempo reversibile e della natura irreversibile dei nostri corpi provoca una lacerazione nella nostra esperienza, nelle nostre vite. Il tempo lineare, irrevocabile viene interrotto dall’intervallo e dall’intrusione del ritorno eterno del tempo trasversale: il ritorno del sintomo, del ricordo, della registrazione e del riordino del passato, e il desiderio perpetuo di ritornare a ciò che è stato registrato. Il luogo mutevole della memoria esplode nello spazio delle nostre storie come insieme di frammenti sospesi nel tempo, come perdita che viene vissuta come essenziale per la nostra comprensione del presente. La memoria viene alimentata e tenuta in custodia (sia catturata che difesa) dalle fragili catene del linguaggio, dalla cadenza e dalla respirazione del corpo che costituisce l’ambigua apertura e il programma della nostra identità. E la musica, in quanto canto, danza e ritmo, in quanto mappe musicali e versi di canzoni, forma uno spartito che fa da contrappunto interrogando la contingenza per la creazione di un’individuazione mobile e della collettività. Danza gitana sotto un albero Una giovane gitana balla sotto le fronde di un albero nel deserto del Rajasthan. Il suo abito chiaro e i gioielli che indossa scintillano nelle ombre della sera. La scena è ipnotica e allo stesso tempo emblematica. Mi ritrovo sulla soglia di qualcosa di diverso, che apre il mio mondo alla dirompente presenza di qualcosa che riconosco ma che si sottrae al mio desiderio di comprensione. Qui c’è un evento che sfugge alla chiusura della mia comprensione. È tutto chiaro (la figura danzante nel deserto, i suoni che ne accompagnano i movimenti), ma qualcosa rimane opaco, nascosto, fuori dalla mia visuale, muto. È la scena di apertura del film e del viaggio musicale intitolato Latcho Drom (1993) del regista algerino Tony Gatlif. L’itinerario ha inizio nel NordOvest del subcontinente indiano e prosegue attraversando un arcipelago di memorie storiche svelate nei suoni che emergono lungo il cammino: India, Egitto, Turchia, Romania, Ungheria, VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA Auschwitz, La Camargue, Andalusia. Questa storia di un popolo senza casa (i rom, gli zingari) illumina di colpo un’asserzione di Heidegger (1946), secondo cui il linguaggio è la dimora dell’essere. Questa storia periferica si mantiene e si nutre nel viaggio interminabile di una canzone cangiante che passa di orizzonte in orizzonte, trasformando il passaggio in musica, la terra in storia, uno spazio e un’identità nomadi in luoghi della casa del linguaggio. La storia “verticale”, che dipende dal terreno che troviamo sotto ai piedi, dal suolo ancestrale, qui viene fatta slittare dal persistente viaggio di un linguaggio (incorporato nel suono, nel canto e nella danza), che cerca una sistemazione nel mondo. Qui, paradossalmente, incontro una fenditura nel topos naturalista dell’identità mentre ciò che appare arcaico interseca le coordinate stabili della casa e della patria per trasformare la modernità in molteplici modernità, esponendo nel bel mezzo un altro senso della casa. In questa nomadologia del suono sono attratto ad ascoltare la scintilla della contingenza che si trova tra i regni consci e inconsci della storia. In questa iscrizione musicale della terra, acquisisco consapevolezza di uno stato in cui una musica e un mondo si incontrano e si intrecciano nel corpo, rendendo esplicita l’alterità che rende ognuno di noi soggetto. Questo perché l’identità stessa è uno slittamento, una figura combinatoria, una fase musicale nella partitura dell’essere. Cominciamo a udire il suono, nasciamo, ma una volta per strada esso non si conclude finché la mortalità impone una coda individuale. L’identità è una linea di basso sempre presente, in continuo dispiegamento, una figura rizomatica, una fuga tratta dai linguaggi che ci trasportano e ci sostengono, un assolo e un’improvvisazione sulle energie che si dispiegano e si trasmettono nel mondo (anziché un’opera isolata che ritratta e rielabora il mondo lungo la nota unica e costante del sé). Concepire la musica come memoria significa afferrare la natura vitale e fisica della ripetizione, e come, secondo Freud, il ricordo (Erinnerung) sia legato alla ripetizione (Wiederholen). Nel 1914 il padre della psicanalisi scrisse un breve saggio intitolato Ricordare, ripetere e rielaborare. Egli osservò l’importanza della ripetizione “al fine di orientarli [i processi psichici] verso la scarica grazie all’attività cosciente” (p. 353). Inoltre, egli sottolineò che la ripetizione può fornire sia l’accesso alla memoria che una IAIN CHAMBERS modalità di resisterle, rifiutarla e reprimerla. La musica, come linguaggio della ripetizione, propone di continuo questo gioco tra il ricordo e la resistenza al passato. Nel ritorno del suono, la musica riempie gli intervalli nella memoria, provocando un superamento temporaneo della resistenza alla sua presenza e al corpo che la incarna. Nell’istante della ripetizione, che non sia tanto il caso di ricordare ciò che è stato dimenticato, quanto di esporre l’atto stesso dell’oblio? L’oblio viene dimenticato, ma il linguaggio della ripetizione al contempo lo prende in mano e lo trasforma. Questa continuità del canto, “non va trattata come una faccenda del passato, ma come una forza che agisce nel presente” (Freud 1914, p. 357), fornisce coerente tutela della presenza-assenza della memoria dell’essere: rivelando nell’evento del suono quel contemporaneo dischiudersi e celarsi che è il ruolo fondamentale dell’arte secondo il filosofo della Foresta Nera1. La memoria, attorno alla quale La memoria, attorno alla quale orbita e fa ritorno gran parte del senso di noi stessi, è la pelle tesa sul mondo attraverso la quale scorrono il desiderio, le emozioni e l’espressione. La memoria evoca l’erotizzazione del passato, ma non esiste in quanto entità autonoma: viene sostenuta e ispezionata dal linguaggio. Giacché mette in discussione l’apartheid della memoria e gli agenti dell’oblio che tentano di consegnare il passato al complotto del silenzio, la musica sostiene una risonanza etica che ci consente di recuperare frammenti del suo corpo disperso. Al di là del monologo rigido della lettura, della catalogazione e dell’interpretazione del precedente, al di là dello smembramento accademico e istituzionale, la musica fonda un luogo potenziale che ispira una risposta: un lavorio della memoria che ci dirige altrove. La musica ci consente di invertire temporaneamente il corso del tempo e di considerare la storia una testimonianza reversibile (pertanto mai sicura, come sostiene Walter Benjamin) che reca testimonianza della re- 1 Sul “dischiudimento” e sul “nascondimento” dell’arte, si veda Heidegger 1950b. VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA denzione sciupata dell’umanità, di una fede tristemente messa alla prova eppure eterna nel nostro ambiente. Ascoltata in questa chiave, la musica dà vita a un’etica. Attirandoci attraverso il vuoto nell’implacabilità del tempo e nei dettami del significato, la musica ci consente di uscire temporaneamente dalle narrazioni che ci inquadrano per ri-negoziare la nostra “appartenenza” alle stesse. Noi accediamo alla memoria mediante il linguaggio, mediante la scrittura sulla pagina, mediante il corpo, e nello spazio in cui parliamo e ascoltiamo. Non solo ricordiamo il nostro passato nella musica, ma anche le tecniche stesse che ci consentono di farvi ritorno, le registrazioni, sono esse stesse una forma di scrittura. In The Aesthetics of Recorded Sound, il critico giapponese Shuhei Hosokawa (1990) scrive: “Non è un caso che, inizialmente, ai dispositivi come il fono-grafo e il grammo-fono siano stati dati nomi derivati dalla congiuntura delle radici ‘suono’ e ‘scrittura’”. La musica sopravvive, va avanti, perché viene ri-scritta, re-iscritta. Mostrati mediante i linguaggi immediati della fotografia, della pellicola, delle immagini registrate e digitali, i nostri ricordi si avvicinano sempre più a noi. Vengono catturati, amplificati e diffusi. Le tecnologie e le tecniche di riproduzione rendono possibile un “ritorno eterno”. Tuttavia, rimane anche una tensione più profonda che nessuna tecnica o tecnologia sarà mai pienamente in grado di tradurre. Anelando al tempo, alla vita, i nostri ricordi si protendono per proteggerci dall’oblio, e nelle modalità mobili ma ripetitive della nostra obbedienza al suono, quel desiderio chiaro ma indecifrabile raggiunge l’apice dell’ubiquità. La musica serve come mappa multidimensionale, a un tempo in relazione con la moda (ripetizione del nuovo) e con la memoria (momenti perduti nel tempo). Ci permette di mantenere un esile ponticello tra la coscienza e l’oblio, introduce la storia dell’evento nel regime fluttuante e atemporale della memoria consentendoci di segnare il tempo e di ricordarlo, ammettendo che il passato sia presente e permettendoci di rintracciare nella sua eco altri sogni, ulteriori futuri. La musica, pertanto, quantunque in origine sia espressione di un momento storico e culturale, comincia a compiere viaggi interminabili non appena compare nel mondo; non ha un luogo solo, continua a continuare, senza alcuna ragione apparente. Si trova ovunque e da nessuna parte: il buco nel tempo, la frattura nello spazio, l’apogeo dell’esperienza. IAIN CHAMBERS Ma per quanto onnipresenti, i suoni vengono sempre trascritti nella poetica particolare di un luogo. Come linguaggio, come scrittura, memoria, musica e mormorio dell’essenza, il suono implica sempre un atto di traduzione. Nel trasferimento, nel ricordo invocato nel passaggio, l’intenzione di rappresentare qualcosa che in precedenza esisteva altrove viene interrotta, superata in un processo (l’opera storica, l’opera immaginaria, l’opera del sogno) che trasforma, perché nel trasportare qualcosa da un luogo a un altro, la sostituisce1. L’auspicata mimesi tra realtà e rappresentazione, tra passato e presente, viene deviata dalla storicità radicale della situazione che esiste nell’eterno vuoto tra l’eccesso del senso e i limiti di ogni istante di traduzione, memoria, significato, narrazione e riconoscimento. La traduzione svela lo smantellamento nelle fondamenta stesse della traduzione, poiché essa non può parlare in termini di significato universale e trasparenza della verità, bensì può farlo con gli accenti delle contestualizzazioni culturali e degli interstizi sociali in cui il linguaggio, la rappresentazione e la realtà sono destinati a trovare continuamente trascrizione, trasformazione e ricomposizione nella loro ricerca di una sistemazione2. Non esiste un modo semplice o diretto per recuperare le cose “così com’erano”, ma solo come sono state ricordate e tradotte, non ciò che è avvenuto, ma ciò che sta avvenendo. Tutto, pertanto, viene sia ricordato che represso, ogni testimonianza è viziata, ogni ricordo è destinato a un altro ritorno, perché la memoria è anche l’arte dell’oblio, del sopprimere la perdita, negare la mancanza, cancellare l’insuccesso del linguaggio, registrare il destino incompleto dell’intenzione. La memoria non è quindi un’origine, un ordine o una destinazione, bensì una risorsa, una tavola di scrittura, un luogo di iscrizioni… in cui la pregnanza e il dolore del passato vengono sia enunciati che riscritti nell’insistenza psichica del presente. La memoria risiede in un paesaggio ambiguo che per Walter Benjamin si estende per inglobare la storia3. Vuol forse dire che la 1 Per un’importante trattazione di questa tematica nel contesto della traduzione culturale contemporanea, si veda Chow 1995, pp. 182-195. 2 “Anche la più grande delle traduzioni è destinata a entrare (e ad essere assorbita) nello sviluppo della lingua, e a perire nel suo rinnovamento” (Benjamin 1955c, p. 43). 3 Gran parte di questo capoverso si basa su una stimolante relazione su Walter Benjamin tenuta da Sigrid Weigel nella primavera del 1994 alla University of California a Santa Cruz. VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA memoria significativa è soltanto una configurazione storica collettiva che esclude qualsiasi padronanza dell’offuscante scivolamento e della repressione che tradisce l’inconscio dell’individuo? Oppure queste distinzioni sono troppo fumose, forse impossibili da fare? Se è così, rimango con un interrogativo che in entrambi i modi interferisce con la mia comprensione sia dell’“individuale” che del “collettivo”, per mettere in discussione il loro reciproco coinvolgimento e la loro reciproca iscrizione nel linguaggio che nomina queste divisioni. È possibile che ciò consenta altresì di proporre un inconscio storico in cui il racconto esplicito, razionale viene pedinato, raddoppiato e spostato permanentemente da un’altra storia, un’altra scena. Ma questa strada non consente anche di contemplare una configurazione individuale del passato nella maniera suggestiva ma differente di Proust o dell’infanzia berlinese di Benjamin? La storia non come scienza, bensì come memoria, non come legge, bensì come linguaggio. La storia come atto di testimonianza: l’atto di piangere la perdita irreparabile (perché non potremo mai più farvi ritorno) che sostiene il nostro divenire. La memoria non è né fissa, né eterna: si trasforma. Come costellazione culturale, rende possibile rivolgere uno sguardo obliquo che analizza diversamente il tempo storico, proponendo una redenzione in cui il discorso culturale e l’azione storica vengono ri-scritti mediante l’introduzione del potere instabile della metafora e lo spargimento e la distruzione contemporanei del linguaggio. Per esempio, questo è ciò che offre Benjamin col metodo di rivoltare la storia contro la sua stessa provenienza. (In ciò è insita la sua affinità con la poetica disincantata del Barocco del naufragio di parole che si schiantano contro l’innominabile, il vortice di note che scivola via verso l’infinito). Poiché, se la storia e la memoria hanno una struttura comune, allora la storia si fonde in un’ambientazione: non nelle regolarità prescrittive di una struttura fissa o rappresentativa, bensì nelle iscrizioni discontinue della scena. Pertanto, la lettura di Benjamin delle immagini implica necessariamente una rottura delle immagini, un risveglio critico per mezzo del quale tenta di recuperarle, raccoglierle e allentarle da un continuum mai messo in discussione. Anche questo ha a che fare con la memoria: è necessario penetrarvi, interromperne le consolazioni e “scoprire ciò che potrebbe essere stato il presente per mezzo di una ricognizione del passato” (Hays 1986, p. X). IAIN CHAMBERS Nell’accordo segreto tra passato e presente, il corpo della storia, la storia del corpo… la storia come corpo, fa irruzione nel passato per ri-contestualizzare e in-corpo-rare il presente non in termini di continuità e di conferma, bensì come interruzione. L’esteticizzazione della tradizione e la vita preindustriale (scialbo romanticismo la cui successiva confluenza nella “esteticizzazione della politica”, per avvalersi di una nota espressione di Benjamin, non si è affatto limitata al fascismo) si basano necessariamente sulle premesse di una società non alienata che in seguito è stata offuscata e oscurata1. L’essenza del presente è una carenza, un’assenza, perché non riesce a riportarci a un’unità perduta e organica. Ma se l’alienazione, come la contraddizione, non fosse tipica della vita industriale moderna e del capitalismo metropolitano? Se l’alienazione non provasse mai Aufhebung? Se l’alienazione fosse un limite terrestre destinato a frustrare il “progresso” implicato in tutte le teleologie? In altre parole, e se le contraddizioni fossero ontologiche, e ci tenessero prigionieri nel tempo del nostro essere? Riconoscere questa condizione, mentre al contempo la combattiamo, vuole dire avanzare meno e muoversi di più lateralmente, rifiutando di eseguire i precetti rielaborandoli e ri-programmandoli in maniera diversa. Significa proiettarsi non in avanti verso l’utopia (che è il bambino umanista di un “progresso” eurocentrico che si basa sulla scoperta di nuovi mondi), bensì lateralmente verso l’atopia: un altro luogo, una maniera diversa di stare al mondo. L’utopico viene usurpato dall’eterotopico, dalla proliferazione dello spazio in differenti luoghi, linguaggi, suoni, ritmi… Ecco che il ritorno al passato non è il ritorno a un futuro potenziale già conosciuto e perduto, bensì a una storia soggetta a interruzione, a una tradizione che prosegue inaugurando il discontinuo. L’ineffabile essenza della musica è forse il migliore aiuto a nostra disposizione per eludere temporaneamente l’insistenza razionale del “progresso” per mezzo di viaggi trasversali collaterali nell’espansione del presente, nell’architettura del suono utilizzato 1 Qui l’enfasi è su un romanticismo generico, non sul momento storico del Romanticismo. Andrew Bowie (1995) ha convincentemente asserito che il Romanticismo tedesco post-kantiano (Novalis, Jacobi, Fichte, Schlegel e Schelling) ha conferito una serie di risposte, raramente apprezzate, alla questione della nostra essenza nella tecnologia. VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA nella costruzione di patrie temporali, nella strutturazione degli ambienti e nella ricerca di una collocazione nel mondo. In quanto portatrice di alterità, la musica è in grado di rendere esplicita una relazione che altrove viene non di rado condannata al silenzio storico. I suoni e le voci che giungono dai margini della mia vita, dalle frontiere della mia esistenza, riescono a imporre un intervallo nella mia comprensione. Qui la musica mi proietta in un altro posto, aprendo una breccia nelle istituzioni e nei costumi quotidiani. Sospendendo le prescrizioni, la musica consente una possibile iscrizione in un vuoto in cui si può prendere congedo dal prevedibile per recitare, e quindi ricollocare, un linguaggio, una storia, in un altro contesto. Ascoltiamo brevemente cosa afferma Edward Said (1992, p. 98) di questo intervallo potenziale: La prima volta che assistetti a uno spettacolo musicale, quand’ero ancora un ragazzino (metà degli anni Quaranta) si trattava di un concerto ambiguo, che non finiva mai, eppure affascinante, di Umm Kalthoum, già allora esponente di punta della canzone araba classica. Non avevo modo di sapere che quel particolare rigore esecutivo derivava da un’estetica il cui segno distintivo era una variazione sfaldante, in cui la ripetizione, una specie di ponderazione meditativa su uno o due brevi schemi, e l’assenza quasi completa di tensione dello sviluppo (nel senso che le attribuisce Beethoven) erano gli elementi focali. Lo scopo del concerto, come ho capito in seguito, non era di arrivare alla fine di una struttura logica ben congegnata (elaborandola), bensì di abbandonarsi a ogni genere di deviazione, soffermarsi su dettagli e cambiamenti nel testo, digredire e quindi aprire una digressione in seno alla digressione. E, poiché la mia formazione eminentemente occidentale (sia musicale che accademica), sembrava destinarmi a un’etica della produttività e del superamento degli ostacoli, l’arte di cui era maestra Umm Kalthoum diminuiva di importanza ai miei occhi. La memoria è ciò che ci difende dal passato che altrimenti ci inonderebbe e provocherebbe il ristagno del presente. Come costruzione, rifugio che erigiamo, storia che narriamo, la memoria spezza e dà forma al caos che altrimenti ci schiaccerebbe. Nell’autoritratto intitolato Le ombre, scritto nel 1925 per Martin Heidegger, Hannah Arendt scrive: “Tutti i dolori possono essere sopportati se vengono messi in un racconto, o se si narra IAIN CHAMBERS di loro in un racconto” (citato in Elisabeth Young-Bruehl 1982, p. 79. La Arendt sta citando Isak Dinesen). Questo perché la memoria non viene semplicemente formata, viene inquadrata e, sottilmente, falsata, romanzata. Fornisce un luogo che apparentemente consente di accedere al passato, ma che non riesce mai a sfuggire all’interrogazione e alla forma del presente. La memoria è un meccanismo che opera una selezione. Nel nostro ricordo ri-portiamo alla mente certe cose, mentre ne dimentichiamo, neghiamo e sopprimiamo altre. La memoria è autentica (o priva di autenticità) come tutto ciò che facciamo. Tutte le memorie, tutte le scritture, tutte le storie sono fallaci e frammentate. Ogni ricordo è una versione di ciò che è perduto irrimediabilmente, è sempre un riassemblare, un mettere assieme temporaneamente i disparati elementi di un corpo che non può mai formare un intero, che è sempre interlocutorio, illuminato dalla luce dell’oblio. Perché la memoria non è un monumento immutato al passare del tempo, bensì una configurazione instabile che sfida il tempo e che si può raggiungere per vari sentieri, svelando lungo la strada storie diverse. La memoria, pertanto, è sempre in discussione, e quindi può essere altresì il luogo dell’amnesia e della cancellazione. Riconoscere il passato come economia scrivibile, blocco per gli appunti o palinsesto, significa altresì riconoscere che è sottoposto a interpretazioni variegate, sottomesse ai poteri che tentano di conferire autorità al passato e, mediante di esso, al presente. Il ritorno, la rappresentazione del passato è sempre soggetto agli “assassini della memoria” (Yosef Havim Yerushalmi, citato in Rossi 1991, p. 28), e quindi “ci obbliga a diventare sensibili al fatto dell’oblio” (Clarke, Doel, McDonough 1996). La musica come linguaggio (come tutti i linguaggi) mantiene questa tensione mediante l’uso comune e quello individuale. La sua facilità di fruizione, paragonata ad altri linguaggi caratterizzati da una istituzionalizzazione più formale, come la letteratura, la storiografia e le arti visive, consente di punteggiare ovunque e in maniera inattesa i copioni che dobbiamo recitare. La musica, nella sua fruizione anonima e negli innumerevoli momenti di articolazione (dalla cerimonia nel deserto alla radura nella foresta, al bar, all’angolo della strada, alla stazione della metropolitana e alla consacrazione moderna dello studio di registrazione) offre VOCE NELL’OSCURITÀ, MAPPA DELLA MEMORIA probabilmente una configurazione più estesa e indiscutibile di un linguaggio che canta il tempo e l’essere mentre registra la memoria. Se la musica sovente dà ospitalità alla nostalgia conservatrice e alla memoria ufficiale, essa propone altresì un ritorno a ciò che può costituire un insieme di nuovi punti di partenza. Rendendo l’ordinario straordinario, la musica provoca un’uscita dall’immediatezza opprimente del mondo quotidiano. Catturato in un vortice di suoni, ognuno di noi riconfigura quella presenza, quel presente. Iscrivere la memoria nella musica Iscrivere la memoria nella musica, nonché la musica nella memoria, significa riconfigurare l’esperienza estetica. L’esperienza estetica diviene una cosa opaca, composta di ciò che pensiamo di aver già vissuto, di quei frammenti di memoria che sono anche la memoria di ciò che si agita attraverso e al di là dello strumentale e dell’istituzionale. Nel ricordo e nel ripristino di ciò che supera la soggettività e la volontà individuale, scaturisce l’interrogativo dirompente e distruttivo dell’imperscrutabile. Questa tendenza fluttuante e indecifrabile (che non implica che non sia anche una composizione storica e culturale) è priva di fondamenta immediate, perché trascende la definizione, sfida l’intenzionalità e spezza la continuità della comprensione. Si situa al limite tra conscio e inconscio: un ritmo che risiede nel rumore del mondo tra le melodie sbrindellate del nostro essere e il battito strumentale del pensiero che porta quell’eccesso che minaccia di irrompere, schiacciarci, infastidirci e decentrarci nella nostra comprensione, in apparenza spiegandola. Ma l’arte non illumina il mondo, lo oscura, portando alla ragione ciò che la ragione respinge e ricusa. Non annuncia la rivelazione di ciò che si può dire, vedere e giudicare, bensì l’insistenza ritmica di ciò che non si può sempre rappresentare, bensì sentire. Nella musica è riposto il rifiuto della mimesi. Come costrutto nel tempo e attraverso il tempo, la memoria non è pertanto solamente un involucro trasparente che contiene (e limita) ciò che pensiamo di conoscere e che siamo in grado di ricordare, perché proietta la nostra attenzione verso il passato, ci spinge altresì nelle ombre, dove avvertiamo ciò che non possiamo IAIN CHAMBERS spiegare o annunciare pienamente. In questo trasferimento tra passato e presente, tra ciò che alla ragione è concesso e ciò che va al di là di essa, e dove ognuno dà un contributo alla costituzione dell’altro, come possiamo sapere ciò che pensiamo di sapere? Ciò a cui possiamo aggrapparci e a cui ci aggrappiamo sono i linguaggi che ci consentono di prendere in considerazione queste domande. La memoria dell’arte, e l’arte della memoria, vengono resi temporaneamente coerenti in questo interrogativo. Capitolo quinto Architettura, amnesia e il ritorno dell’arcaico Dopo aver dimorato, come essere concreto, in esso, andando al di là del sapere, del pensiero e dell’idea in cui il soggetto vorrà, a cose fatte, racchiudere il fato di dimorare che non ha misura comune con un sapere (Lévinas 1961, p. 156). Nel 1924 Walter Benjamin e Asja Lacis scrivevano, in un commento in seguito molto citato, che la città di Napoli è fatta di un’“architettura porosa” (Buck-Morss 1989; Burgin 1996; Leslie 1999). Il principale materiale da costruzione è il tufo giallo, materia vulcanica che scaturisce dagli abissi marini e si solidifica a contatto con l’acqua di mare. Trasformata in abitazione, questa roccia porosa riporta gli edifici all’umidità delle loro origini. In questo incontro drammatico con gli elementi dei tempi antichi (terra, aria, fuoco e acqua), sono già presenti gli estremi incalcolabili che coordinano la vita quotidiana dei napoletani. Il tufo friabile, figlio del violento connubio di vulcano e mare, fuoco e acqua, è sintomatico dell’instabile edificazione della città. Inoltre, l’utilizzo del tufo rivela un evidente imbroglio nella struttura stessa della città. Avendo le autorità spagnole, nel tentativo di tenere sotto controllo lo sviluppo urbano, proibito di importare materiale da costruzione, i napoletani hanno estratto la pietra vulcanica letteralmente da sotto i loro piedi, ricacciando nuovamente questo materiale verso il cielo. Il suolo sottostante la città è cavo, crivellato dalle caverne che ne sono derivate. Non soltanto la vita di oggi è costituita da materiali instabili e fisicamente inaffidabili, ma anche le sue fondamenta sono sospette da un punto di vista legale e geologico. Per citare il libro Il Dramma barocco tedesco del 1928, che Benjamin scrisse sul teatro barocco tedesco del lutto mentre si trovava a Capri, Napoli è un’allegoria delle forze precarie della modernità. Come negazione perpetua della presunta ineluttabilità del “progresso”, come continuo mettere in discussione le sue fondamenta, la città propone continuamente un suolo fisico e filosofico che IAIN CHAMBERS mette a dura prova i principi della stabilità1. Vissuta come un ambiente di “crisi”, anziché come un ambiente pianificato, Napoli si presenta sia come città barocca che come città abissale. I suoi innumerevoli edifici seicenteschi e le incerte fondamenta sono testimoni silenziosi della continua distruzione dello sviluppo lineare mentre il progetto urbano e architettonico si dissolve in suoni, strade e corpi che non si piegano facilmente alla stabilità strutturale cui anela la volontà moderna. Camminando per la città, percorro gli angusti vicoletti che si piegano verso l’interno, verso la piazza, verso una chiesa, o che mi portano ai monumenti eretti in nome della morte e della disgrazia (le guglie decorate o gli obelischi che commemorano eruzioni vulcaniche, terremoti e pestilenze); di rado le strade mi portano verso l’apertura del mare. È come se la città traesse le proprie energie dall’oscurità, dalle ombre, risucchiando la luce dalle cose in un riflesso di se stessa irreprimibile, che serve a illuminarne la passione e l’egocentrismo. Il mare è relegato al ruolo di accessorio, di appendice da cui un tempo giungeva il pesce e ora promanano gli effluvi urbani. Napoli è soprattutto una città verticale, che si riflette sia nella sedimentazione archeologica che nella stratificazione sociale. La scala sociale ha inizio con i monolocali al pianterreno (i bassi) e raggiunge gli attici e le terrazze delle classi di professionisti e dei residui di aristocrazia che rimangono aggrappati alla propria altezza. Il cielo e il mare vengono catturati in squarci, difficilmente è consentita la prospettiva laterale (democratica?); lo sguardo è bloccato dai vicoletti angusti oppure viene sviato verso l’alto, verso l’autorità laica e religiosa. Le aperture conducono con rapidità alla chiusura introspettiva: il luogo dell’iscrizione psicosomatica. Nell’etnografia dello spazio, la scena urbana dimostra di essere un ambiente sia fisico che psichico. Forse l’aspetto che a prima vista colpisce maggiormente il turista, lo straniero, è che Napoli è una città che esiste soprattutto 1 Prima Heidegger, poi Derrida hanno insistito sul fatto che sia un costrutto della metafisica a cercare di velare l’abisso e ignorare l’instabilità del suolo incerto su cui gli edifici occidentali poggiano la propria filosofia, i propri progetti e i propri principi; si veda Wigley 1996. Nella “demolizione critica” (kritischer Abbau, termine usato da Heidegger nelle sue prime lezioni nel 1920) o decostruzione, che scavano nella precarietà di quella tradizione, Napoli funge da luogo allegorico ideale. ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO nell’enigma del rumore. Oltre al mormorio perenne che l’intellighenzia locale riversa nei lamenti letterari e nel conservatorismo critico attorno alla rovina, la nostalgia e il decadimento urbani, ci sono i suoni che si levano dalla strada tra le sgommate interminabili dei motorini e gli stizzosi clacson delle macchine: le urla dei pescivendoli, le grida di saluto, i camion di passaggio e le voci amplificate dal megafono che offrono cocomeri, giocattoli, cristallerie e cassette pirata di canzoni napoletane; il fruttivendolo che commenta pubblicamente la sua merce e i suoi prezzi, a suo dire bassissimi, in terza persona: “Che belle pesche. Duemila lire… Ma questo è pazzo”; il venditore ambulante di bacche selvatiche alle sette di mattina a luglio che riempie i vicoli vuoti con le sue grida stridule. Queste lacerazioni del silenzio confermano la punteggiatura fisica dello spazio per mezzo della voce, del corpo, ed è il corpo che fornisce una grammatica fondamentalmente gestuale in cui le mani diventano punti interrogativi, le braccia segnali tormentati, e le facce maschere contorte. Scaturisce un’economia prelinguistica nello spazio urbano che rivela tra i suoni una sfiducia che affonda le radici nelle parole, la loro promessa di fornire una spiegazione e di custodire la ragione. Il piano nascosto della città è sito nell’architettura dell’introspezione che si rivela negli edifici che si sgretolano e nelle facciate rivestite di sudiciume, ma anche nelle facce silenziose e nei sentimenti scettici dei suoi abitanti. Qui, dove la linearità del tempo gira vorticosamente in ritmi differenti, il residuo, l’arcaico e il premoderno possono rivelarsi come dettagli viscerali e le distorsioni mettono a repentaglio la purezza sognata della pianificazione razionale e del design funzionale. Nella sua arte di arrangiarsi, accontentarsi e risistemare gli elementi disponibili come sostegno per una fragile esistenza urbana, la presenza di Napoli (come città europea, mediterranea e contemporanea) propone un ritorno eterno al lessico enigmatico della vita urbana moderna, alle contingenze di un linguaggio instabile in cui tutti gli abitanti della città trovano posto e contestualizzazione. Napoli è quindi altresì un paradigma potenziale della città dopo la modernità. Legata nei suoi ritmi diseguali e nelle sue abitudini effimere ad altre città non occidentali e all’emergente globalità metropolitana, propone un’interruzione nella comprensione della vita, dell’architettura e della pianificazione urbane lasciateci in eredità. IAIN CHAMBERS Partecipando al progresso senza sentirsi davvero assorbita nel suo programma, Napoli, in quanto città composita, reintroduce il diseguale e il non programmato, il contingente, lo storico. Vista e, soprattutto, vissuta in questo modo, l’interrogativo posto da Napoli riconduce la questione della città alla relazione tra politica e poetica nel determinare il nostro senso dell’etica e dell’estetica (ma si possono davvero separare?): il nostro senso del possibile e dell’immaginare la posizione che occupiamo all’interno di esso (Donald 1999). Le nostre prospettive e le nostre voci recano l’impronta di storie diverse, parlano di un luogo particolare. Pertanto, qualunque cosa io abbia da dire sulla questione dell’architettura risiede senza dubbio nella mia risposta all’ambiguo, finanche enigmatico contesto nel quale lavoro e vivo: la città di Napoli. Al contempo, tuttavia, nominare il luogo dove si trovano il mio corpo, la mia voce e i miei pensieri, desideri e ossessioni nei termini di una città particolare significa anche inevitabilmente mettere le mie osservazioni in relazione all’ambiente urbano come luogo privilegiato dell’esistenza moderna. Sia in termini economici che di esperienza, sembra che la città comprima, nella maniera più immediata, la storia, la cultura e le identità in configurazioni che richiedono l’attenzione critica. Ciò che viene escluso da questa comprensione metropolitana della nostra essenza (i mondi non urbani del nomadismo, della vita contadina, rurale, anche le frange periferiche), per quanto popolosi e necessari siano questi spazi per la nostra esistenza (dall’agricoltura al turismo, alla residenza, al sostentamento del nostro corpo e della nostra immaginazione), viene considerato secondario rispetto alla città, se non una semplice appendice della stessa. Ma se Napoli si ritrova involontariamente al centro dei riflettori critici e globali dell’indagine metropolitana, essa dona la propria forma di disturbo, un contributo speciale alla formazione simultanea di concentrazione e dispersione, quel Unheimlichkeit o ritorno perturbante – forse il sintomo più profondo della vita moderna – che raddoppia e sposta di continuo la geometria urbana con le storie insubordinate dei repressi (Vidler 1992). Spesso Napoli viene accusata di esistere, o perlomeno di sembrare di esistere, ai limiti dell’urbanesimo europeo e moderno, ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO aderendo in modo discontinuo agli stili di vita più ordinati di Londra, Parigi, Milano e New York. Tuttavia, nella sua apparente vicinanza alle città più “tipiche” del mondo e allo scompiglio civico del Cairo, di Città del Messico, di São Paulo e di Shanghai, questa città mediterranea, paradossalmente, si ritrova altresì trascinata in prossimità della struttura cosmopolita di una Los Angeles o di una Londra, dato che la sua storia interna viene sempre più interessata dall’intrusione dell’immigrazione extraeuropea e dalle imposizioni della mondializzazione sulle sue preoccupazioni locali. Nello spazio di questo “più alto sviluppo delle forze produttive, e per ciò stesso (…) il più ricco sviluppo degli individui” (Marx 1953, p. 183) che ci invita forzatamente a riconsiderare in maniera radicale le divisioni spaziali del centro e della periferia, tra un “Primo” e un “Terzo” Mondo, la particolare configurazione storica di una città come Napoli esercita un’insistenza di cui non è facile liberarsi. Per quanto drammaticamente impressa sullo sfondo di un vulcano e del mare Mediterraneo, l’interrogativo che Napoli inserisce nella tarda modernità e nel capitalismo globale non è affatto tipico soltanto di quella città, anzi si ripropone per porre in discussione e turbare l’omogeneità proiettata del programma delineato dagli ansiosi poteri metropolitani, che anelano a una simmetria impeccabile. Paradossalmente, questa tanto agognata simmetria si riflette, addirittura si amplifica in chiarezza, nelle versioni rispecchiate dei precetti dello spazio urbano moderno che ci offrono le letture marxiste contemporanee di Fredric Jameson, Mike Davis e, in misura minore, David Harvey. Queste interpretazioni tendono a rimuovere il poetico dal politico, giungendo così a una denuncia che non annuncia null’altro1. Consente all’osservatore, al critico, di raggiungere una simmetria mortale, ma rende ciò che è osservato una vittima pura e semplice del piano, del progetto, della logica 1 Jameson 1992; Davis 1992; Harvey 1989. La lettura di Harvey viene in qualche modo moderata dalla presenza dell’opera di Henri Lefebvre sulla politica dello spazio, sul quotidiano e sulla città. Ovviamente è possibile trasferire queste rappresentazioni apocalittiche del capitalismo catastrofico e le “ecologie della paura” che lo accompagnano a migliaia di città sparse per tutto il pianeta. Los Angeles, per quanto sia la più pubblica delle metropoli, non ha certo l’esclusiva al riguardo. C’è sempre un inevitabile provincialismo nelle mappe di cui ci avvaliamo individualmente nelle nostre spiegazioni; si veda al riguardo Davis 1999. IAIN CHAMBERS esposta dalla critica. Con questo rifiuto di considerare i linguaggi, lo stile, la realizzazione in fieri delle possibilità vissute della città, al termine della giornata non è ben chiaro che tipo di politica liberatoria venga proposta. La critica consente certamente di articolare alcuni racconti assai potenti della capitalizzazione dell’esistenza contemporanea, ma quel potere si ricava per l’appunto dal silenzio degli attori, dall’assenza critica degli agenti sociali e dalle vite di coloro che vengono rappresentati. Spinto dal desiderio utopistico di proporre un’alternativa autonoma (se non altro offrendo una totalità negativa), conduce ironicamente a un idealismo dematerialista. Tanto Marx quanto Gramsci ribadivano che il nuovo sarebbe scaturito dal ventre della società vecchia. Quanto detto sembrerebbe indicare una concezione atopica piuttosto che utopica, in grado di leggere nel presente un potenziale capace di modificarlo, e quindi di scardinarne sia la logica strutturale che le immediatezze verso un altro senso della posizione e della possibilità. L’economia politica dello spazio non rappresenta un punto d’arrivo finale, bensì un punto di partenza. Viviamo tutti certamente in “condizioni che non abbiamo scelto di nostra spontanea volontà”, ma da quel momento in poi che cosa succede? “L’arte del vuoto” Nella città, il mito e il desiderio perenni delle origini, di un luogo di spiegazione sicuro, di una stabilità delle fondamenta, vengono sempre procrastinati per mezzo della ri-scrittura e della ri-narrazione. Questo ritorno eterno ritaglia un intervallo, ossia “l’arte del vuoto” (Carter 1996), che rende possibile una riconfigurazione tale da intrappolare e sviare il “progresso”. Narrare la città nel passaggio fisico del nostro corpo, oppure percorrerla a piedi e misurarci con e contro di essa, significa indubbiamente cercare nei nostri circondari il paradigma ragionato dell’antica polis, la promessa primaria dell’agora. Ma quel disegno e desiderio viene ineluttabilmente attraversato da motivi e temi moderni: velocità, efficienza, razionalizzazione, in una parola, la parsimoniosa gestione della tecnologia, guidata dal telos dello sviluppo economico nella sua direzione politica. La maggior parte di noi non percorre la città a piedi, bensì con un mezzo di trasporto: la macchina, la me- ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO tropolitana, l’autobus. Il tempo viene considerato uniforme e lo spazio omogeneo: il luogo dei principi geometrici e di un terreno concettuale apparentemente autoesplicativo. L’intersezione di queste traiettorie metropolitane multiple – l’origine mitica del suo spazio e gli imperativi moderni della sua organizzazione – crea un luogo complesso e composito in cui ciò che pare arcaico può anche diventare la rabbia contemporanea degli sfruttati e dei diseredati. Il represso gorgoglia attraverso le fenditure nei marciapiedi e occupa il vuoto tra le case per increspare, contestare e talvolta lacerare la volontà amministrativa e architettonica. In questa prospettiva, l’architettura non si limita a possedere una metafisica, è essa stessa metafisica, perché progettare, razionalizzare lo spazio, incarna la promessa dell’escatologia: l’annuncio profetico del paradiso futuro, la negazione dell’alterità, dell’altro. Questo perché anche solo cercare di iscrivere l’alterità nel progetto, di rispondere alla presenza dell’altro, significa già negare questo altro riconducendolo al medesimo, ai protocolli del progetto (Lyotard 1996). Se “costruire è già in se stesso un abitare”, allora l’interrogativo dell’architettura non può che fuoriuscire dagli schemi disciplinari imposti. Criticare la pratica e i progetti dell’architettura significa inevitabilmente avere a che fare con modalità diverse di abitare, con modi differenti, talvolta persino conflittuali, di occupare, abitare e attraversare la terra (Heidegger 1954b, p. 97). Significa rompere uno stampo e rinnegare certe premesse. Rivisitare e rielaborare un’eredità non più limitata ai fiduciosi protocolli dell’architettura significa penetrare nel lessico assai più indefinito del vivere storico. In quanto linguaggio autoreferente che tenta di controllare la costruzione che articola, l’architettura viene infranta di continuo dalle contingenze del mondo che le danno inizio e la sostengono. Notare l’immancabile presenza della metafora del linguaggio nel discorso architettonico potrebbe voler dire prendere sul serio la metafora e insistere sull’altro lato del linguaggio (architettonico). Ci si chiede se il concetto del linguaggio sia sfruttato semplicemente per la comunicazione e la razionalizzazione codificate dello spazio, che rendono trasparente il mondo e lo sottomettono alla grammatica dell’architettura, o se segnali un ambito assai più ambiguo e poetico dell’abitare. Nella pragmatica del primo caso risiede l’immediatezza di un edificio finito, nell’indeterminazione del secondo caso esiste uno IAIN CHAMBERS sforzo che si concentra attorno al problema di abitare, incorporare ed elaborare uno spazio astratto in un luogo concreto. Nondimeno, l’architettura continua a insistere in una maniera che in gran parte si dimostra dimentica di quest’ultimo inquadramento. Perché mai? Impalcature invisibili, vite invisibili Per quanto l’arroganza della visione che annulla il mondo a seconda del suo disegno, definendo e destinando lo spazio per far fronte alle necessità che confermano un progetto, sia apparentemente infinita nelle sue variazioni, viene coerentemente riaffermata al singolare. L’egocentrismo dell’edificio che ne deriva riguarda molto da vicino la maniera in cui viene percepito lo spazio, e spesso ha poco a che fare con l’abitarci. Marcos Novak (1997, p. 75), critico d’architettura di Los Angeles, ha dichiarato che: “Le idee sono impalcature invisibili su cui si costruisce il vero. La storia dell’architettura è una storia dell’elaborazione crescente delle impalcature invisibili”. Questa asserzione riecheggia, sebbene dall’altro lato dello spartiacque della critica, la definizione dell’architetto giapponese Arata Isozaki (1995, p. VII) dell’architettura come “il nome del meccanismo mediante il quale la metafisica su cui poggia il pensiero occidentale inevitabilmente viene a esistere”. Una metafisica del genere, incarnata nel soggettivismo unilaterale dell’umanesimo occidentale che, come ci ricorda Heidegger, raggiunge il culmine nella tecnologia moderna, qui viene resa esplicita nel lessico del design e del desiderio. Gli edifici che accolgono carne, corpi, vivi e morti, svaniscono per essere sostituiti da impalcature invisibili e altrettanto invisibili… vite. Nell’ambito dell’architettura stessa il connubio metafisico di pensiero e tecnologia del giorno d’oggi ha un nome nuovo: TransArchitettura. Ha un programma gemello al Trasnmodernismo. La TransArchitettura cerca di superare la distinzione tra fisico e virtuale mediante la trasformazione di design e progetto, architettura e abitazione, in informazioni (Novak 1997). Ritiene che l’informazione sia la terza dimensione della materia (dopo l’energia e la massa). In questo aumento tecnologico dello spazio e nel- ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO la relativa frontiera della retorica delle infinite permutazioni digitali, non è possibile udire la reiterazione di quel perpetuo desiderio occidentale di incorporare tutto nell’ambito dell’illusione della gestione trasparente? Non si tratta della manifestazione finale di una metafisica che, nonostante la sua retorica di chiarezza e di accesso democratici (ma per chi, dove, quando e come?), si abbina in ultima analisi al dominio intellettuale, alla disciplina gerarchica e al controllo strategico? È un mondo popolato da corpi unidimensionali che rimangono, nello stato asessuale, atemporale e muto, del tutto subordinati al piano architettonico, al progetto e alle sue asserzioni. Il fisico viene nominato solamente per essere immediatamente classificato e subordinato nel potere del simulato. Il Panopticon di Bentham, la prigionia controllata di esseri insubordinati, ormai resa infinitamente modulare e flessibile nei contorni privi di resistenza dei corpi smaterializzati posti nel cyberspazio, viene qui tenuto saldamente al suo posto. Nella virtuosità dell’architettura virtuale, il disegno penetrante dell’occhio che tutto vede, che colloca e disciplina tutto nell’ambito del campo onnipotente della visione, rimane non solo indisturbato, bensì aumenta, e grazie alla tecnologia di cui si avvale, si affina ancor più e viene messo a fuoco con fermezza. In questa critica potenziale dello spazio generato al computer dell’abitazione simulata, non si intende avanzare l’invito a tornare indietro, ad abbandonare la tecnologia, e riappropriarsi dell’immediatezza fasulla del mondo “vero”. Piuttosto, c’è un’insistenza sulla tendenza critica – quell’eredità storica insita nei linguaggi che ci sostengono – da perseguire nell’ambito delle mediazioni che ci costituiscono nel mondo al quale rispondiamo. Contro la teleologia del “fondamentalismo tecnico”, questo atteggiamento potrebbe suggerire una serie ben più esitante e incerta di indizi, in cui l’entusiasmo iniziale viene stemperato dal disturbo di domande che rifiutano ostinatamente di promettere una rappresentazione e una risoluzione immediate. Quello che viene omesso ed escluso dal quadro, dalla cornice, dallo schermo, dall’immagine, dalla rappresentazione, dal piano, continua a disseminare interrogativi che ricollocano la tecnologia e continua a riposizionare il desiderio metafisico entro limiti temporali e terrestri. Seguire questa strada significa accedere a un progetto assai più incerto, perché le nostre risposte alla tecnologia e alle sue rappresentazio- IAIN CHAMBERS ni dipendono dalla contingenza del nostro essere in una situazione terrena che nessuna tecnologia, nessun anelito intellettuale potranno mai svelare o rappresentare appieno: Il cyberspazio non è una fatalità, è un dato di fatto. Fatale sarebbe rimanere nell’ignoranza teorica e critica del fenomeno attuale. Non siamo nemmeno pronti a delineare una tipologia dei cambiamenti apportati dalla “rivoluzione digitale” all’architettura. Tra un fondamentalismo tecnico che prospera nell’intossicazione estetica di nuove proposizioni precise e il disincanto scettico o catastrofico di fronte al potere del vero tempo digitale, è possibile che si faccia largo a forza una terza strada, basata su un atteggiamento critico, teorico e anche storico (Girard 1997). In questo modo si segue Heidegger nella questione della tecnologia, malgrado il pregiudizio comune secondo cui il filosofo tedesco si schieri contro la tecnologia in nome di un’autenticità rimossa. Per essere più precisi, e quindi per dire qualcosa di più inquietante e difficile da mandare giù, Heidegger prende posizione all’interno della tecnologia1. Egli riconosce che siamo sospesi nei linguaggi della tecnologia moderna, e questo conduce alla proposizione critica che da questo punto di partenza dobbiamo trovare la nostra strada. La volontà di architettare Come costruire, edificare, in un’epoca priva di telos? Che cos’è, esattamente, un edificio post-metafisico? Ponendo domande di questo tipo si opera già uno spostamento dall’Architettura alle architetture. Significa trasformare la tradizione in un luogo di traduzione, rendere la potenziale universalità del progetto particolare e specifica: dove costruire non vuol dire semplicemente impor1 Questo punto viene ribadito, ad esempio, nel lavoro, per altri aspetti interessante, di John Rundell 1997. Nell’intervista televisiva del 1969 a cui si è già accennato, Heidegger afferma in maniera inequivocabile di non essere avverso alla tecnologia. Il filosofo prosegue: “Si tratta invece di comprendere l’essenza della tecnica e del mondo tecnico. A mio avviso, ciò non può accadere fintantoché la filosofia si muove nell’ambito della relazione soggetto-oggetto” (Neske, Kettering, a cura, 1988, p. 57). ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO re una visione, bensì narrare e costruire un habitat (Isozaki 1995). Quanto appena detto richiede che si prendano le distanze dalla rassicurante grammatica dell’Architettura e si parlino i linguaggi condizionali delle architetture. Rendere critica una siffatta situazione capovolge sia la tradizione che la tendenza dello sguardo architettonico; tradotta nei sintomi di un potere messo in discussione, la storia dell’architettura si trasferisce da un editto allo stato di una cura, che somministra un farmaco e si prende cura del presente. Si tratta di un presente e di un futuro potenziali, di cui non è più possibile pretendere di avere una competenza totale. La contingenza terrestre, i problemi del mondo, impongono un vuoto, un’interruzione, che non è mai possibile chiudere o passare sotto silenzio, perché ormai l’architettura implica un incontro con l’altro “che, per definizione, non segue lo stesso insieme di regole” (Karatani 1995, p. XL). Il solipsismo del progetto architettonico, dell’edificio metafisico, dipende da “un’omissione dell’asimmetria che identifica l’io con il noi” (p. 137). Come afferma il critico giapponese Kojin Karatani (p. 112): Per interiorizzare l’altro, l’altro deve disporre di un insieme comune di regole. Ma l’altro non designa, per definizione, solo chi non dispone di un insieme comune di regole? Il dialogo non si instaura solamente con un altro di questo tipo? In quanto spazio moderno, la città viene considerata, in maniera opprimente, uno spazio razionalizzato. È un ambiente stabilito secondo la logica che la mobilità si può ricondurre “a spostamenti, origini e destinazioni prevedibili, provvisti di uno scopo” (Imrie 2000, p. 1644). Questa proiezione della vita urbana rivela che: i pregiudizi del movimento e della mobilità illimitati nelle società occidentali contemporanee sono egemoniche nello stabilire le priorità di corpi specifici e di modalità di mobilità e movimento. In particolare, la mobilità e il movimento vengono definiti mediante discorsi che servono ad alienare corpi menomati e a conferire la priorità del movimento di ciò che si potrebbe definire il corpo mobile (p. 1642). Nondimeno, in questo luogo esiste altresì ciò che trabocca e va al di là della struttura pianificata e progettata dell’edificio e della città. In questa integrazione insospettata, che si aggiunge al piano IAIN CHAMBERS e minaccia di distruggerlo, a volte capita che si contravvenga alla razionalizzazione, perché siamo io, tu, loro che esistiamo in questo spazio, in questo passo al di là degli schemi. È nel passaggio attraverso questo spazio, a piedi o su ruote, che il corpo diviene soggetto, che io divengo ciò che sono. Io, con i miei miti, la mia sensazione dell’essere, ho origine qui, in questo passaggio. Questo è il luogo dell’arché, l’instaurazione degli inizi, che costruisce e custodisce l’architettura. Costruire, Abitare, Pensare (Heidegger 1954b) diviene quindi una questione di come instaurare, come cominciare, come concepire, costruire ed edificare noi stessi. Sebbene non siamo noi a decidere le condizioni, non si tratta di un atto arbitrario. Questo spazio viene prodotto e costituito al contempo dai linguaggi, dalle storie, dalle culture e dalle tradizioni che ci avvolgono nella città, nella vita quotidiana. Il fatto che noi abitiamo in questa apertura costituisce gli strati mobili, le possibilità cangianti, la maniera variegata di abitare la città. Tuttavia, questo spazio è stato già configurato, in attesa del nostro arrivo, e contemporaneamente accompagnato da margini vuoti, da quel che resta radicalmente irriducibile sia alla chiusura che al controllo del piano e alla soggettività dell’abitante individuale. Si tratta pertanto di una familiarità spaziale che viene sempre perseguitata dall’alterità. In ultima analisi, seppure anche inconsapevolmente, tentiamo di adeguarci al perturbante. Nello scambio tra edifici e corpi, ciò che risponde a quest’ultima esigenza e la rappresenta è la potenziale continua interruzione del piano. Questo perché abitare, nel suo accogliere e promuovere il soggetto, annuncia altresì la frantumazione del mondo. Proprio questa intrusione spezza e si allontana da una concezione umanista dell’abitazione, in cui si sottintende che abitare abbia inizio e fine nell’ambito e nel consenso del soggetto. Si tratta di una condizione assai più esposta del soggetto che emerge e diviene. Quello che rende effettivamente umano l’essere umano consiste, come ci ricorda Heidegger, nella sua mancanza di fondamenta, di stabilità. C’è una persistenza non rappresentata, persino non rappresentabile, che interroga la città, la sua architettura e tutte le discipline che tentano di delimitarne e determinarne il destino. Il modo in cui rispondiamo a questo spazio suscettibile e ce ne assumiamo le responsabilità ci induce a porre interrogativi che ci riguardano tutti nella valuta- ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO zione del costruire, dell’abitare, del pensare e… del vivere nel mondo. Tenendo a mente queste osservazioni diviene possibile cominciare a formulare un interrogativo di più ampio respiro: mettere in discussione ciò che Kojin Karatani (1995) chiama “la volontà di architettare”. Interrogare il desiderio di costruire (sia fisicamente che metafisicamente) vuole dire soprattutto accorgersi di come la comprensione dell’uno sia indissolubilmente legata alla comprensione dell’altro. Al riguardo, prestando nuovamente attenzione a Heidegger, dissento dalla certezza dell’assioma cartesiano cogito ergo sum, per abbracciare l’incerta prospettiva di ciò che va al di là del mio pensiero dell’evento dell’essere: ich bin, “io sono” adesso equivale a “io abito” (Heidegger 1954b)1. A partire da ciò estendo all’architettura gli interrogativi che scaturiscono incessantemente dall’applicazione all’ambiente delle forze storiche, dello sforzo sociale e del desiderio individuale di fabbricare una domus, un habitat, una casa. L’architettura in quanto disegno programmato e pianificato, ossia come “fondo” (Bestand ) del tempo e del lavoro, delle energie storiche e culturali, come proiezione simultanea e conservazione delle risorse, come spazio di un piano, di una costruzione, di un edificio viene sempre trasformata in un luogo contingente, nell’edificio, precario il cui esito storico non può essere predetto da alcun progetto architettonico. L’architettura non comprende semplicemente la costruzione fisica degli edifici: risalta o si espone, svelando l’essenza di qualcosa in termini contemporaneamente economici, politici, storici ed estetici. Articola una posizione tra queste coordinate: dischiude e allo stesso tempo offusca la natura di questo luogo nel mondo. L’edificio, per quanto possa essere drammatico o monumentale, non si erge mai da solo, non è mai un fatto isolato: tutti, ma proprio tutti gli edifici, a prescindere dalle intenzioni dell’architetto e del costruttore, evocano la relazione che frustra di conti1 Queste considerazioni scaturiscono dall’analisi dell’etimologia del verbo bauen, “costruire”. Questa logica etimologica trova la seguente giustificazione: “L’uomo si comporta come se fosse lui il creatore e il padrone del linguaggio, mentre è questo, invece, che rimane padrone dell’uomo. Forse è proprio anzitutto il rovesciamento, operato dall’uomo, di questo rapporto di sovranità che spinge l’essere dell’uomo verso una condizione di estraniamento” (Heidegger 1954b, p. 97, corsivo nell’originale). IAIN CHAMBERS nuo la mera rappresentazione tecnologica (Heidegger 1962b, p. 29). Nel vuoto tra intenzione astratta e investimento corporeo si manifesta l’apertura coeva e il nascondimento della vita quotidiana, la cui portata va ben al di là delle categorie astratte o anche della voce radicale della soggettività. Queste vite annunciano una configurazione storica sostenuta in un habitat definito, sospesa tra passato e futuro, tra terra e cielo, perché gli edifici si avvalgono, nella maniera più evidente, di una tecnologia che come Gestell o “im-posizione” si erge al di sopra di noi e ci sfida, e tuttavia ci svela o ci espone alla verità della nostra situazione (Heidegger 1962a, pp. 14-16). La città, con i suoi edifici e la sua architettura, è una delle modalità principali che inquadrano la nostra posizione paradossale nello spazio chiuso e finito che al contempo costituisce un’apertura attraverso cui è possibile pensare a questi limiti e andare al di là di essi. Sebbene le nostre storie, culture, memorie e soggettività siano inevitabilmente proiettate nella sintassi e nei linguaggi della costruzione simbolica e fisica del nostro habitat, oggi sempre più inquadrato dalla città (essa stessa metafora della tecnologizzazione del mondo), la prosa quotidiana della vita metropolitana ci offre tuttavia l’opportunità di pensare e vivere diversamente la nostra condizione. Il problema della città e della sua architettura è un problema di costruzione: tanto la costruzione fisica che viene eretta quanto quella culturale, storica e simbolica che viene elaborata. Pertanto, il problema dell’architettura, come quello dell’estetica, è anche un problema di etica. L’architettura, per dirla con l’architetto americano Peter Eisenman, riguarda il significato, e ciò che noi intendiamo per “significato” è legato indissolubilmente a come rispondiamo alla domanda del senso del nostro essere al mondo, al nostro vivere la città costruendo un senso di dimora. Lettere del tempo Gli edifici in quanto abitazioni storiche sono lettere del tempo, destinate a deperire. In Europa e nelle culture comunque europee si è diffusa, dal Seicento e dall’epoca del Barocco, la pratica di sfruttare le potenzialità delle rovine. Di conseguenza, alcuni hanno abbracciato un’estetica che dà per scontato che un edificio ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO non sia mai nuovo, che le sue pareti e le sue decorazioni siano sempre già logore, battezzate dalla sporcizia e dal sudiciume, che non ci sia mai stato un punto zero o un giorno uno dalla costruzione dell’edificio. A questo punto la città, come sito di vite precedenti, diventa un accumulo mobile di tracce, un palinsesto da leggere e riscrivere di continuo. Ovviamente ci sono altri che hanno scelto di nascondere e reprimere queste iscrizioni della transizione nell’anonima trascendenza permessa dalle superfici piatte e dalle linee rette del modernismo, sempre nuovo e sempre bianco. Qui il tempo, privato del colore e dell’ornamento, viene reso invisibile. Scegliere di prestare attenzione alla prospettiva precedente, senza cadere nella nudità della disperata nostalgia o dell’ottundente storicismo, significa rifiutare di arrestarsi nella schiavitù emotiva o nella rassegnazione dinanzi allo spettacolo della mortalità. Significa, se diamo ascolto a Benjamin, cogliere nel Barocco un lampo che balugina in un momento di pericolo per illuminare il nostro presente, consentendoci di considerare una relazione tra costruzione ed essere. Qui l’architettura assurge al ruolo di arte del ricordo, che raduna le storie nella sua costruzione e nel suo progetto materiale, e svela nella concatenazione di regimi economici, politici e culturali un senso dell’abitare1. Tuttavia, non si può nemmeno negare che gran parte dell’architettura contemporanea – spesso autoreferente per stile e contenuto – si distingua e al tempo stesso venga inquadrata nel contesto che testimonia il rimpicciolimento del luogo, una diminuzione che si spinge fino a svanire del tutto nel vuoto tra le autostrade, i centri commerciali e il deserto al termine dell’Occidente, da qualche parte nella California meridionale. Qui le possibilità sregolate e arcane della città si trasformano in ciò che Edward Soja chiama exopolis, città senza “cittadinanza”, spazi intensi del capitale in apparenza intenti a confondere tutti i tentativi di trasformarli nell’incertezza sociale e nelle vicissitudini culturali del luogo (Soja 1992). Perché porre il problema dell’architettura significa interrogare la città come luogo simultaneo della memoria e dell’amnesia 1 Condensare il tempo nel momento del pericolo allude chiaramente alle Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin (1955a), nonché alla sua intuitiva disposizione delle logiche del Barocco nella sua lettura della modernità. IAIN CHAMBERS in un’epoca che spesso sembra voler fare a meno della società civile, che forse si ritira persino dai requisiti della democrazia, mentre i centri commerciali e le collettività controllate si riproducono nel bagliore paranoico della sorveglianza ininterrotta. Questi insediamenti, appollaiati tra il deserto e il Pacifico, ricordano stranamente le antiche fortezze collinari. Vivendo delle acque di sussidio delle Sierras e del sistema pubblico di collegamenti stradali (stato assistenziale non riconosciuto a capitale privato), questi insediamenti forniscono gli ambiti culturali agli sviluppi globali previsti nei mondi fantascientifici descritti in romanzi come Negromante di William Gibson e Snow Crash di Neal Stephenson, per non parlare dello sviluppo intensivo del capitalismo in altre zone del mondo d’oggi: da Santiago a Pechino. La riduzione del luogo è anche la riduzione della memoria. Ma poi esistono edifici privi di memoria? L’ultramodernismo ubicato ai limiti dell’Occidente, nel deserto della California meridionale, ci offre forse oggetti che incarnano unicamente la memoria sfuggente dei materiali di cui sono composti: vetro, acciaio, plastica, fibra ottica, cemento, madacam, neon. In questi deserta pragmatica i critici ci informano, amaramente, che la memoria, troppo dispersiva per iscrivere, che richiede troppo tempo per riconoscere, viene sbiancata, purgata. Soltanto la statua bronzea di John Wayne (dal film western di John Ford preferito da Jean-Luc Godard, Sentieri selvaggi) nel foyer dell’aeroporto di Orange County lascia una traccia. Ma forse l’apparente rigidità dell’oblio invita a ripensarci. Forse qui la memoria viene resa spaziale invece di sedimentarsi in strati verticali, pertanto la città apparentemente priva di memoria di Irvine viene sia duplicata che ombreggiata dall’insediamento prevalentemente ispanofono di Santa Ana. La luce razionale della pianificazione della memoria e la sua gestione dipendono dalle ombre che regolano coloro che la servono e la sostengono da dietro le quinte. Considerare la memoria in termini spaziali, come luoghi diversi, persino separati, significa inevitabilmente opporre all’esperienza della città verticale (Napoli) quella orizzontale (Irvine). La prima è in debito, e a volte oppressa, rispetto alla storicità: a Napoli il tempo è un suggello che non ci ricorda solamente il nostro corpo, la nostra mortalità, ma divora altresì ogni spiegazione, ragione e giudizio. Irvine, invece, è una città che in apparenza esiste alla fine del tempo; qui le spie- ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO gazioni non sono introspettive (memoria, narcisismo), bensì proiezioni (fantasia, desiderio). La città sedimentata, verticale viene governata dalle sue fondamenta (mitiche, storiche, culturali); l’altra dal suo orizzonte (deserto, mare, cielo). Si potrebbe essere tentati di suggerire che mentre l’una è una città, l’altra è un insediamento, provvisorio per natura: solo le autostrade hanno una parvenza di permanenza. Una città rappresenta il tempo, l’altra apparentemente lo reprime. Tuttavia, il rifiuto è anche l’affermazione inevitabile dell’impossibilità di scartare questi limiti temporali e storici. Sull’orlo del deserto, gli uffici, le autostrade, i complessi residenziali e i centri commerciali vengono a contatto con l’inviolato. Il deserto, in quanto suolo intrattabile e vacuità immaginaria, resiste all’appropriazione, va al di là della razionalizzazione, fornendo un’esperienza dell’impossibile, una memoria del perenne: “il deserto al di là di ogni deserto” (Derrida 1996). La sua apparente nudità blocca e disfa la visione calcolatrice, promettendo la possibilità di riscoprire qualcos’altro in noi stessi e nei piani e progetti che abitiamo. In apertura de Il disagio della civiltà, Freud (1930) si riferisce alla città, e in particolare alla città di Roma, come metafora della memoria, come illustrazione della vita psichica in cui tutto, in una maniera o nell’altra, si conserva. La stratificazione e le tracce, la sedimentazione e le rovine, rivelano la presenza e la persistenza della memoria. Tuttavia, una città concepita in tempi recenti, che si estende sulle sabbie del deserto, un insediamento come Irvine, nella Orange County (California meridionale), esiste in una scala temporale che esclude la memoria di una Roma, di un’Alessandria, di una Londra, di una Canton e persino di una New York. Se la città è anche il modello della psiche, che cosa risiede nella differenza tra la memoria sedimentata di Napoli e i ricordi giovanili di Irvine? La memoria, ancora una volta secondo il fondatore della psicoanalisi, non è mai un semplice continuum che permette di effettuare un repentino viaggio nel tempo dal presente al passato: è una costruzione affidata alla vigilanza del linguaggio, è determinata in maniera schiacciante dalla sua rappresentazione presente. La memoria implica la selezione, la repressione e la successiva articolazione, pertanto una conservazione sistematica del passato in una conservazione acritica di edifici, strade e quartieri coincide anche IAIN CHAMBERS con la repressione della salute ambigua e del potere guaritore della memoria, perché la memoria è sia il luogo della costruzione che della conservazione nonché della distruzione, della riformulazione. Una memoria che opera senza ricostruzione è una memoria sterile, incline alla nostalgia. Talvolta, dimenticare è importante quanto ricordare. Il terreno sotto i nostri piedi Dietro l’architettura si situa la spaccatura che inaugura la divisione tra le modalità di vita sedentaria e nomade, tra le pareti costruite e il soffitto della stanza e la membrana tesa di una tenda o di un equivalente rifugio coperto di foglie. Forse è più facile afferrare questo concetto di “casa” al di fuori delle coordinate europee e nordamericane. Le abitazioni sedentarie, anche nelle loro aspirazioni più umili, implicano un’azione di fondazione, inaugurano una struttura che coprirà il terreno, che modificherà fisicamente e trasformerà materialmente il suolo. Ciò comporta che un luogo venga trasformato e un edificio elaborato, modificato, esteso, decorato e rinnovato, o altrimenti rimosso per lasciare spazio a un altro edificio. Verranno conficcati pali nel terreno, si effettueranno scavi, si accumuleranno materiali, elementi ed energie sul posto, si provvederà a rimuovere il materiale di scarto, e così facendo si svilupperà un edificio, un villaggio, un paese, una città. Sebbene la prospettiva idealista che alcuni di noi hanno ereditato abbia incoraggiato un pensiero diviso tra la “naturale” domesticità dell’esistenza rurale e la presunta “alienazione” della vita cittadina, tanto la fattoria, il casolare di campagna e la pieve, quanto il grattacielo, il condominio e il terminal dell’aeroporto, sono caratterizzati dalla medesima relazione con il terreno su cui vengono edificati: dipendono da una relazione con la terra, il suolo, il terreno, che viene coltivato, lavorato, appropriato, sfruttato. Questa eredità profondamente ambigua accomuna la tutela e lo sfruttamento del terreno sotto i nostri piedi. Insistere su questa disposizione ambigua significa infrangere la distinzione netta tra un “naturalismo” romanzato del rurale e l’“alienazione” a scopo di lucro dell’urbano. ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO Sullo sfondo delle città industriose, il paesaggio rurale non può che essere considerato materiale muto, grezzo, la scorta resa, o la riserva residua, rappresentata dalla natura. Eppure il paesaggio contiene la storia della terra: sia la narrazione millenaria del tempo geologico che la storia sociale dell’insediamento umano. La razionalizzazione dello spazio è spesso immemore di entrambe. A livello più immediato si riscontra, come dice Don Mitchell richiamandosi a Marx, un “plusvalore del paesaggio” che si deposita sul terreno come “lavoro morto” (Mitchell 1999; si veda anche Henderson 1999). La prospettiva rurale, che provenga dal vecchio mondo o da quello nuovo, dall’Italia o dalla California, è anche il registro di uno scenario servito e rifornito dal sudore, dal sangue e dalla vita dei lavoratori, una volta di quelli che vivevano sul posto, oggi sempre più degli emigrati. Il regno rustico, sempre e comunque ritratto nelle grida nostalgiche della sintassi preindustriale e “autentica” del “primitivo”, è tanto una testimonianza complessa delle violente geografie dell’economia politica contemporanea (con i suoi fabbisogni di materie prime e di economia agricola, il turismo e lo sviluppo immobiliare) quanto la scena urbana più banalmente citata. Sia il rurale che l’urbano, nella loro costruzione, nella loro economia e nella loro organizzazione sociale, coltivano e sfruttano, elaborano e integrano il terreno su cui vengono edificati e da cui dipendono. La violenza di questa azione di appropriazione su cui si instaura l’architettura è ciò che, in ultima analisi, viene represso nella razionalizzazione della costruzione. Questo discorso vale tanto per il tempio antico quanto per il granaio o per i moderni uffici o per le metropolitane. Questo perché costruire non è soltanto abitare, come ci dice Heidegger, bensì riconoscere l’autorità dell’architettura. Ovviamente questa autorità passa in gran parte inosservata, sebbene sia ugualmente presente, nello schema profano delle abitazioni umili, i cui materiali, la cui costruzione e la cui proiezione raramente sopravvivono alla contingenza immediata. L’autorità architettonica, l’inaugurazione di nuovi materiali, di uno stile, dell’iscrizione di un ordine religioso, commerciale e politico nella pietra, tende a essere prerogativa dell’innovativo e del monumentale, di oggetti eretti sulla terra contro il cielo, che risaltano e durano nel tempo. Paradossalmente questi oggetti, il risultato IAIN CHAMBERS dell’esproprio razionale del terreno e delle sue risorse, aprono a una forma di soggettivismo acuto. Nell’oggettività della sua arte, nei numeri, nei calcoli, nei progetti, nelle misurazioni e nei materiali, l’architetto impone una logica unilaterale sul terreno che fornisce lo spazio per la costruzione finale. In questo umanesimo, cioè in questa riduzione del suolo all’appropriazione razionalista che conferma l’ego, l’architettura si difende dall’interrogativo che farebbe vacillare le fondamenta della sua pratica. Certamente un rapporto alternativo con la terra, in cui il suolo è il luogo di sentieri, percorsi, risorse stagionali mutevoli e abitazioni transitorie, non è un’opzione contemporanea, ma come esistenza vissuta, cultura sostenuta, modalità di vita, continua a porre una serie di interrogativi a tutti coloro che stanno sulla terra. Nondimeno, la decisione di stabilirsi e di costruire, di inaugurare l’architettura e di trasformare il suolo in una dimora fissa, e di conseguenza di definirlo e reclamarlo in termini sanguinosi, religiosi, militari, legali e politici, è ciò che per molti ha posto le fondamenta del senso di casa e di patria. La questione non si limita mai a passeggiare sulla terra in modo nomadico, si tratta sempre di subentrare e prendere possesso. La terra viene necessariamente considerata vuota, una tabula rasa, in attesa di essere inaugurata dall’insediamento e dall’edificio: è una pagina intonsa, su cui non è ancora stata scritta la storia: Fondare la colonia, inaugurare la storia lineare e il suo teatro delle marionette di soldatini in marcia e il lavoro meccanizzato ha significato abbracciare l’amnesia ambientale, dimenticare attivamente la saggezza che il suolo e la sua gente possiedono (Carter 1996, p. 6)1. La terra è benedetta, battezzata. Ricevere un nome “comporta la cancellazione del nome nativo – l’obliterazione dell’identità aliena, forse demoniaca – e dunque una sorta di rigenerazione” 1 La relazione della Camera dei Comuni del 1835 sulla colonizzazione dell’Australia rileva che gli aborigeni “di ogni terra hanno un diritto inalienabile al proprio territorio: un diritto semplice e sacrosanto, tuttavia, che non pare sia stato compreso. Gli europei hanno varcato i loro confini, senza invito, e una volta sul posto non solo si sono comportati come signori incontrastati della terra, ma hanno anche punito i nativi come aggressori qualora evidenziassero una tendenza a vivere nella loro terra”. (Citato in Pedersen, Woorunmurra 1995, p. 15). ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO (Greenblatt 1992, p. 140). Stephen Greenblatt prosegue rilevando che questa annessione e al contempo attribuzione d’identità si fonda formalmente nella nomina linguistica della conquista e nel prendere possesso del terreno selvaggio, incolto (ib.)1. La violenza di questi atti di inaugurazione, in cui lo spazio si svuota della sua storia precedente e viene azzerato, oggi si ripropone per infestare gli insediamenti contemporanei, mettendo in discussione la fiduciosa sistemazione apparentemente realizzata dall’architettura precedente. La stabilità della domus non è solo strappata alla terra, ma anche agli altri esseri la cui esternalizzazione, talvolta il cui sterminio, prende la forma di una subordinazione economica, culturale e politica che appoggia e conferma un luogo specifico nella sua separazione (che sia una regione, una città o una nazione) dai luoghi degli altri. La spazializzazione porta inevitabilmente all’evacuazione della contingenza e alla dispersione della storia lungo le linee guida neutrali di una geometria universale che riflette e incarna il tempo vuoto, omogeneo. O quasi, visto che la storia continua ad aleggiare su quel luogo. La terra, anche nella più nuda delle apparenze, come il deserto, la natura selvaggia e le distese desolate, è sempre e comunque già stata nominata da qualcun altro (Snyder 1990). La terra, come asseriscono sempre gli indigeni fin dai primi contatti, è sacra. Di sacralità è intriso il suolo, e questo rende impossibile che sia oggetto di proprietà individuale o che sia ceduto. Queste relazioni con la terra, non con una materia inerte di cui appropriarsi e da lavorare e sfruttare, bensì con un humus circoscritto che sostiene e rafforza il nostro modo di essere, sono gli spettri che risiedono nel terreno e fanno ritorno per contagiare l’edificio della modernità2. In questo modo si insiste su un’eredità più complessa di una banale differenza binaria o dell’opposizione tra agricoltura e nomadismo, perché spostarsi sulla terra, invece di rimanere fissi, non esclude né che si gestisca l’ambiente, né che se ne raccolgano i frutti (Darian-Smith, Gunner, Nuttal 1996, p. 8). 1 Per ulteriori analisi di questo “momento” formativo, si vedano de Certeau 1975, Todorov 1984. Sulla differenziazione nazionalista negli espedienti europei per prendere possesso retoricamente delle Americhe, si veda Seed 1995. 2 L’interrogativo posto dal nomadismo alla modernità viene discusso in maniera esemplare da Islam 1999-2000. IAIN CHAMBERS Non esiste lo stato puro, il grado zero. Lo spazio, come sostiene Gaston Bachelard (1957), è sempre saturato. Sebbene lo sguardo euroamericano di norma svuoti lo spazio per riempirlo con una teleologia dello sviluppo e del progresso, il territorio è sempre già connotato come luogo: anche il nomadismo, a prescindere dalla gittata dell’errare, si situa all’interno di una località. Lo spazio è già un habitat, un’abitazione per qualcun altro. È evacuando altre storie, e con questo gesto di inaugurazione del “nuovo”, che l’intreccio di modernità occidentale e colonialismo viene condensato nella maniera più impietosa. È questo che, alla fine, legittima l’instaurazione e il mantenimento violento dello Stato nazione moderno. Nella volontà di rappresentare (“l’architettura come oggettivazione del desiderio”) i linguaggi della pianificazione e della costruzione attingono necessariamente da questa grammatica (Lozanovska 1997)1. Non esiste cura per queste ferite, esiste solo la possibilità di fare i conti, comprendere e accettare gli spettri che rifiutano di sparire, che ritornano ripetutamente per infestare la costruzione delle identità e l’enunciazione del luogo e dell’appartenenza. Le certezze precedenti sperimentano aperture sgradite e le ferite rimangono ferite che sanguinano in una comprensione più sperimentale, meno sicura, del suolo fisico e simbolico che ci sostiene. La tecnologia e i limiti terrestri Nell’odierno distacco metropolitano del mondo del lavoro dal senso del luogo, la vita civica si svincola sempre più dalla presenza immediata e dalle pressioni della produzione organizzata, e il lavoro viene ristrutturato in altri corpi (solitamente femminili, non di razza bianca e non del “Primo” mondo) e poi disperso spazialmente nella specificità frammentata del servizio metropolitano e delle industrie del piacere, oppure trasferito in luoghi re1 Non che la volontà di rappresentare sia automaticamente compresa o abbia effetti omogenei. L’azione dell’architettura (chi viene rappresentato, che cosa viene rappresentato) chiaramente costituisce anch’essa il suolo contestato su cui opera l’architettura. Queste argomentazioni sono tratte da Gülsüm Bantoglu e dal suo intervento alla conferenza Global/Local: Postcolonial Questions, University of Western Sydney, 24 giugno1997. ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO moti della produzione trans-nazionale, nelle piantagioni di caffè dell’America Latina, nelle fabbriche tessili dell’Indonesia, nelle catene di montaggio di microchip a Singapore. In quest’economia, Napoli e Irvine sono effettivamente più vicine di quanto potrebbe inizialmente sembrare a una prima occhiata. Entrambe esistono sullo stesso piano, forniscono soluzioni storicamente diverse in un’ontologia occidentale condivisa in cui l’architettura dell’accumulo sedentario, pianificato è sia costante che centrale. Entrambe sono città per cui l’imperialismo europeo ieri e il neocolonialismo oggi sono stati centri focali dello sviluppo. La città contemporanea, che sia un insediamento storico sedimentato come Napoli o un modulo flessibile e orizzontale come Irvine, continua a schiudere e contemporaneamente a offuscare queste coordinate mentre vengono concentrate nel suo linguaggio, nei suoi edifici, nella sua prassi e nel suo stile quotidiani, nella sua sicura occupazione dello spazio. Se per Le Corbusier le case sono macchine in cui vivere, Heidegger (1950a, p. 72) ci ricorda che “la tecnica meccanica è il primo frutto dell’essenza della tecnica moderna, che fa tutt’uno con l’essenza della metafisica moderna”. Come schema, progetto e desiderio strumentale, l’architettura opera una mediazione tra la trasmissione dell’intenzione e la realizzazione e l’utilità, nonché la finalità culturale e l’iscrizione storica. In quanto tale, si ritrova intrappolata nella pulsione di ridurre la contingenza terrestre alla logica causale e controllabile di un linguaggio trasparente in cui il “politico” e il “sociale” vengono assorbiti pienamente in un regime mondano del razionalismo, che oggi si traduce sempre più nella neutralità, in apparenza leggera, dell’“informazione”. Ci sono però dei limiti che circoscrivono le proiezioni di questi futuri, tanto quello della trascendenza promessa dalla tecnologia che la sospensione relativa dell’educazione civica urbana e del conseguente ottundimento della scelta politica. Mentre la California meridionale fa parte dei nostri futuri, non è necessariamente il futuro, perché, e qui riecheggiano Martin Heidegger e Richard Sennett, il luogo non è semplicemente il prodotto dell’elaborazione globale. Nel suo celebre saggio chiamato Costruire, Abitare, Pensare (1954b), il filosofo tedesco scrive: “gli spazi ricevono la loro essenza non dallo spazio, ma dai luoghi” (p. 103). Lo spazio è una produzione sociale, ci ricorda Henri Lefebvre, avrà sempre una IAIN CHAMBERS storia: “Nessuno spazio scompare in fase di crescita e di sviluppo: il mondiale non abolisce il locale” (Lefebvre 1991, p. 86, corsivo nell’originale). Il luogo è sempre il sito di appropriazione culturale e trasformazione storica, il sito di una maniera e di un’economia specifiche di costruire, abitare e pensare. Per quanto sia l’oggetto di uno schema astratto, che si avvale della sintassi del capitalismo, della tecnologia, del governo, della pianificazione e dell’architettura, ciò che emerge non è mai semplicemente l’oggetto alienato di questi processi: ciò che emerge è un soggetto che introduce l’agonismo nell’agora, costruendo un luogo particolare fuori da questo spazio, confutando la regolata trasparenza del piano per mezzo dell’inattesa opacità dell’evento insubordinato (Sennett 1995). Ciò significa insistere sulla disposizione profondamente eteronomica della modernità, di ciò che rimane represso nelle strozzature della coerenza razionalista e nazionalista. Significa disfare i legami di linearità e la teleologia di un tempo chiamato “progresso”. Significa gingillarsi mentre si palesa l’inquietante presenza di ciò che la modernità reprime, pur effettivamente dipendendo da essa: lo sfruttamento di chi è stato dimenticato, privato della libertà, dell’alieno e del negato. Questi ultimi sono condannati a sobbarcarsi il fardello della modernità in nome del progresso, del sottosviluppo, dell’arretratezza, dell’illegalità e dell’inevitabile attivazione dei paradigmi della privazione economica, del pregiudizio sessuale, della discriminazione etnica e del razzismo che tendono a imporsi in uno scenario di questo tipo. Iscrivere direttamente queste discontinuità nel racconto contemporaneo del tempo, nello stato patrimoniale della modernità, investe altresì la tematica dell’architettura. L’architettura, nella maniera in cui è stata istituzionalizzata, praticata e insegnata, incarna la scommessa razionalista (sia in ambito empirico che idealista) che la conoscenza sia rappresentazione, che la conoscenza riguardi la capacità di vedere per rappresentare il mondo in una logica e in una struttura misurabili e immediatamente accessibili. L’architetto modello è Iddio onnisciente che tutto vede e tutto comprende, come prescrisse Isaac Newton e dipinse William Blake. Alla palese configurazione dell’architettura nelle economie emergenti dell’urbanesimo, del colonialismo e del capitalismo occorre pertanto aggiungere la sua appartenenza alle modalità egemoni della conoscen- ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO za e del potere. In questa formazione moderna, occidentale, l’architettura è sorella dell’antropologia, dell’anatomia e dell’arte abietta, ossia “l’arte del dissotterratore dei cadaveri” 1. Queste relazioni foucaltiane, legate alle possibilità panottiche di disciplinare, se non anche di “disegnare e ripartire” il corpo della città, il corpo del cittadino, tentano di ridurre tutti i movimenti e le rotture potenziali alla cornice classificatoria e al tavolo dell’autopsia di una “natura morta”. Tuttavia il corpo, in quanto carne, sangue e ossa, in quanto storia e fecondità individuali, è il “dire”, come ribadisce Emmanuel Lévinas, che precede e va al di là della coscienza, del sistema, della struttura e della rappresentazione. Nell’incarnazione del soggetto è l’alterità radicale del corpo stesso, relativamente al desiderio e allo schema atemporale del pensiero, che rende quest’ultimo vulnerabile ai limiti e alla ricusazione, perché “mette perennemente in discussione la prerogativa della coscienza di ‘fornire un senso’” (Handelman 1991, p. 253). L’architettura moderna, occidentale, ha dato un contributo diretto alla diffusione di un’egemonia visiva che non solo nega altre forme non rappresentative della conoscenza, ma ottiene, anche nella sua trionfale razionalizzazione del punto di vista unilaterale e della prospettiva astratta, di far passare nel dimenticatoio ciò che il suo discorso prevede di spiegare e accogliere: corpi e vite diverse. L’occhio architettonico si concentra sulle tecniche e sulla tecnologia dell’inquadramento che rende lo spazio e il terreno una realtà vantaggiosa, configurandola nell’identità dell’inquadratore, del soggetto. Lo sguardo apparentemente obiettivo viene restituito e trasformato nel punto di vista interno, soggettivo. Ancora una volta, diviene possibile afferrare l’apparentemente paradossale affermazione che la tecnologia è l’umanesimo. La presunta antitesi tra questi due termini, che struttura in profondità tanta parte del pensiero moderno relativo alla tecnologia, prevede effettivamente una collaborazione tra due corpi concettuali in apparenza contrapposti e separati, catturati in un balletto i cui passi espongono le asserzioni universali del pensiero occidentale. Quando si tratta un punto di vista come ugualmente valido in 1 Per questa suggestiva relazione mi sono ispirato a McCarthy 1997. IAIN CHAMBERS qualunque posizione, di modo che ogni cosa dia il medesimo risultato, e venga meno il disturbo dell’alterità, allora la coscienza soggettiva passa direttamente nell’oggettività “neutrale” della forma calcolata. Non ci vuole una grande immaginazione per mettere in relazione questi segni relativi al potere dell’aspetto, nonché il suo ruolo di custode della conoscenza, con il potere del piano e del punto di vista architettonico. Lo sguardo architettonico è altresì lo sguardo antropologico: costruire, classificare e definire lo spazio per gli altri; spalleggiato ulteriormente nella pragmatica delle culture anglosassoni dal pregiudizio che il linguaggio stesso sia cristallino, un semplice strumento per mezzo del quale la ragione riflette la realtà nella strumentalità neutrale del mezzo. Come l’occhio nudo, le lenti della macchina fotografica o la simulazione al computer, questi esempi di potere visivo traducono la verità direttamente in regimi di rappresentazione, da cui deriva la presunta vicinanza dell’osservatore a Dio, dell’architetto secolare al progettista divino. Ciò che non riesce a rientrare nel campo ottico, le sue procedure di classificazione e la sua logica della rappresentazione, non riesce nemmeno a divenire conoscenza. Qui lo spazio continua a essere concepito come realtà antropomorfica i cui limiti (l’orizzonte, il limite del campo visivo, l’oscurità) vengono riconosciuti unicamente per essere resi insignificanti relativamente a ciò che rientra nel campo di una visione ingrandita. La relativa stabilità di questa cornice e dell’inquadramento o rappresentazione del soggetto (“l’immagine del mondo”, come dice Heidegger, che fa sì che l’occh-ìo sia sempre al centro della visione e del mondo, come stabilito per la prima volta con la modernità) consente di rigettare un punto di fuga o il vuoto che, alla fine, farebbe slittare e sopraffarebbe la soggettività. Come afferma Victor Burgin (1990, p. 118): il punto di fuga non è parte integrante dello spazio della rappresentazione; posizionato sull’orizzonte, viene continuamente spinto in avanti di pari passo con l’espansione dei limiti del soggetto. Il linguaggio della trasparenza e l’egemonia oculare qui si fondono in una relazione di soggetto-oggetto, in una concezione cumulativa del significato e della verità che riafferma eternamente il ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO soggetto. Si tratta di una concezione che valorizza lungo un movimento unilaterale: dall’occh-ìo verso il mondo, di cui ci si appropria in quanto oggetto esterno. Ora vorrei affiancare a questa generalizzazione epocale e geopolitica un’affermazione più precisa che riguarda direttamente il campo dell’architettura. Si tratta di una citazione da Urbanistica (pubblicato per la prima volta nel 1925), di Le Corbusier (1929, p. 77), che recita: Combattiamo la trascuratezza, il disordine, l’abbandono, la negligenza dalle fatali conseguenze; aspiriamo all’ordine e lo raggiungiamo con il richiamo al nostro principio fondamentale: la geometria. “La geometria è il nostro principio fondamentale”, ci dice l’architetto francese proprio in apertura del suo libro (p. 5). Ma al di là della frustrazione costante della geometria a opera delle coordinate storico-politiche, per non citare le pressioni dirette del mercato e della commercializzazione spesso scoordinata degli immobili, c’è una tensione maggiore dove i progetti rimangono permanentemente intrappolati nel passaggio tra costruzione e abitazione, tra la risposta funzionale all’abitazione umana e la proiezione immaginaria della stessa. Questo perché il potere dello sguardo si accompagna altresì a un’intrinseca incapacità: l’incapacità di ascoltare, udire e rispondere. L’occhio osserva una forma di sapere che né attende né accetta una risposta. Il piano progettato e contemplato dalle tecnologie dell’appropriazione oculare e dalla loro gestione della conoscenza, del potere, può essere lacerato, perforato o semplicemente superato da ulteriori regimi del senso individuale e collettivo che, inaspettatamente, confutano le prospettive amministrative. L’esito della battaglia per avere un terreno comune di significato, o un quadro condiviso di senso, è insolitamente inevitabile; la sua politica penetra fin proprio nel cuore della materia a portata di mano, nel cuore stesso del nostro essere nella città, nella vita moderna. Inoltre, è possibile che venga restituito lo sguardo per far sentire a disagio l’osservatore, o per rendere tendenziosa la sua verità. L’osservatore viene osservato. Registrare la possibilità di una simile reciprocità significa introdurre una distinzione dirompente IAIN CHAMBERS tra l’oggettività soggettiva di una visione che abbraccia tutto e un occh-ìo che reagisce, che incontra resistenza e opacità, disturbo e offuscamento, un riflesso fosco nella retina. Questo opera un sabotaggio della distanza critica tra il soggetto che tutto vede e l’oggetto inerte, la distanza che permette il possesso, con un’interruzione che rimane insuperabile, una separazione instaurata e mantenuta dalla finitezza della mortalità, dai limiti della posizione, dai fastidi dell’inconscio e dalle circostanze della differenza: voci diverse, corpi diversi, storie diverse. È questo passaggio non rappresentabile che forma la materialità che Platone chiama chora, che Derrida e altri considerano il luogo eterno e infinito della traduzione, e che Elizabeth Grosz (1995a) significativamente identifica come lo spazio del femminile. Proprio qui lo schema avviluppante dell’architettura incontra la presenza inquietante del non rappresentato. È qui che la purezza del progetto viene frantumata dall’apertura ai mutevoli linguaggi del luogo. Pertanto, l’archeologia della moderna architettura non svela semplicemente il suo contratto con una particolare épisteme, bensì stabilisce anche, e più appropriatamente, limiti storici e soglie culturali. Abitare nei limiti tra l’architettura e ciò che va al di là di essa, nell’eccesso, nell’integrazione, che rifiuta la sua logica o la contravviene, significa anche incontrare le altre architetture, o controarchitetture, che ne disturbano le prescrizioni e scelgono di vivere progetti, edifici, città, secondo pratiche ulteriori, impreviste. Sull’orlo della costruzione A queste necessità si deve aggiungere l’irrefrenabile costanza di un interrogativo di cui l’architettura pare sempre immemore. Non troppo tempo fa, in una Lettera a Peter Eisenman, Jacques Derrida (1994; la lettera è datata 12 ottobre 1989) ha elencato una serie di relazioni che, in stile heideggeriano, espongono l’architettura alla provocazione del suo inquadramento terrestre, a ciò che va al di là del suo discorso e lo avviluppa: l’architettura e la povertà, l’architettura e la condizione dei senza tetto, l’architettura e le rovine, e questo ci riporta al punto di partenza dell’interrogativo: la questione della terra e la provocazione fondamentale sostenuta dal nostro abitare. ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO Le pietre, l’acciaio, il cemento e il vetro che in apparenza forniscono la conclusione di un discorso, di un progetto, di un piano, di un edificio, di una città, sono necessari, ma non sufficienti, punti materiali di partenza nei processi che trasformano lo spazio in un luogo, perché ogni spazio incarna pratiche storiche e culturali, riceve il sigillo individuale e collettivo di corpi, storie, culture, ricordi e vite irreprimibili. L’architettura come “sintesi spaziale dell’eterogeneo” non è quindi solo la sintesi di forme e materiali, come propone Paul Ricoeur (1996): è anche sintesi di forze e relazioni sociali, storiche e culturali. In quanto testo non è soltanto una trama da leggere, è anche una storia che raccontiamo e in cui veniamo raccontati. In questo modo si conferiscono alle discipline e alle pratiche che concepiscono e progettano la città (l’architettura, l’urbanistica e l’amministrazione comunale, l’investimento e la speculazione finanziari, l’oligarchia del capitale globale e locale) una ricezione e un ascolto che consentono alle altre città che esistono all’interno della città di divenire visibili e udibili: gli edifici di classe, genere, sesso, etnia e razza che costituiscono e investono lo spazio urbano. Tracciare la mappa della città seguendo questi assi significa integrare, e talvolta sovvertire, la concezione di un habitat inteso esclusivamente in termini di popolazione astratta, spazio civico generico, insieme di forza lavoro anonima o concentrazione commerciale. Comprendendo la città in quest’ottica si attua un radicale spostamento dell’enfasi dai protocolli prescrittivi del piano urbano, del progetto architettonico, dell’intenzione amministrativa e della strategia economica verso quelli iscrittivi: verso la città che parla, che si racconta nella diversità. Se a questo punto si presta attenzione a Lévinas, nel passaggio dall’interdizione del detto all’esposizione del dire, nell’oscillazione tra l’astrazione della legge e l’evento non previsto, esiste l’insistenza dell’etica, dove il prescrittivo viene reso responsabile. Ma che cosa significa: nessuna pianificazione, nessuna architettura fintanto che non sia possibile recuperare ciò che non è pianificato eticamente? Per frustrare l’obbligo, il piano viene congelato in eterno, aspettando che il futuro faccia giustizia? L’architettura viene dunque ridotta a opere di restauro, di rattoppo dell’ambiente urbano, dilettandosi in esperimenti localizzati, mentre attende un nuovo mandato? Certamente anch’essa ha subito la critica delle aspirazioni del passato, una critica che, insistendo IAIN CHAMBERS sull’“al di là”, sul supplemento della sua impetuosa razionalità, rende irreperibile quel progetto precedente. Qui la città, in quanto esistente, si erge come oggetto e generatore di un gran numero di futuri possibili, ognuno calcolato a seconda della natura della sua opposizione a siffatti futuri. Il progetto architettonico, mentre cristallizza uno o più di questi futuri, viene poi presentato alla città, per così dire, come un intero, non come una sostituzione o un rimpiazzo, come nell’urbanesimo utopico del modernismo, bensì come materiale da sottomettere alla vita e al potere consumante del contesto. I “tipi” apparentemente onnicomprensivi vengono pertanto frantumati dalla controforza del luogo (Vidler 1992, p. 200)1. Le città, la vita urbana, l’architettura, come le nostre essenze sociali, di genere, etniche, nazionali e locali, per quanto possano essere costruite per decreto pedagogico e disciplinare, in ultima analisi dipendono da una performance o stile d’essere, dall’articolazione storica e da un’etica iterata nel nostro divenire. La verità del nostro essere è qui, nel fatto che ascoltiamo e rispondiamo a quel linguaggio. In quello spazio, per quanto eccessivamente determinato dall’assalto apparentemente irresistibile di capitale e controllo corporativo (che in questi anni si sostituisce sempre più alle politiche istituzionali), esiste un eccesso culturale e poetico che non si può ricondurre al razionalismo e alla logica calcolatrici di coloro che intendono sovrintendere al nostro futuro. Questa integrazione interrompe e mette in discussione il desiderio politico della conclusione, della comprensione universale e l’asservimento razionalista del mondo. Questo desiderio si disperde nello spazio tra gli edifici, nel vuoto tra proclami misurati, nel silenzio che la geometria non riesce a codificare, nelle ombre che offuscano la trasparenza. Infine le energie si riversano per le strade e per i territori dell’incertezza dove i corpi e le voci storici, muovendosi in uno stato mutevole, ora “arcaico” e ora “cyborg”, coniugano la tecnologia e l’essenza in un interrogativo comune. Qui la chiarezza accattivante e il potere dell’informazione sono traditi nel perenne transito e nella traduzione che accompagna un adattamento differenziato nel mondo. Qui c’è la possibilità di varcare i confini 1 Qui Vidler descrive l’architettura sperimentale di Wiel Arets. ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO del calcolo per correre il rischio di pensare diversamente. Pensare a ciò che il calcolo non può rappresentare, ciò che i numeri e le linee reprimono, significa esporre il piano ai rischi incalcolabili che nasconde, nonché al terreno mobile, la terra, che immancabilmente trascura. L’architettura, in quanto tentativo di configurare lo spazio, di trasformarlo in luogo, edificio, habitat, deve sempre fare i conti con l’instabilità, l’eruzione narrativa, dell’essenza storica quotidiana e di una finitezza costellata dalla contingenza terrestre. La cognizione di queste coordinate scaturisce forse nella prospettiva di un’architettura più transitoria o di un’“architettura debole”: un’architettura in grado di adeguare, o quantomeno registrare, l’intervallo tra piano e luogo. Non si vuole suggerire di costruire strutture meno sicure, bensì che la loro necessaria logica e razionalità vengano a essere riconosciute come linguaggi limitati invece che leggi universali. Chiaramente, questo vorrebbe dire ridurre e ridisegnare il campo d’azione dell’architettura spostando l’attenzione dalla tendenza di una razionalità omogenea e insistendo sulle storie eterogenee che la costruzione è destinata a ospitare. L’architetto smette di essere un progettista universale e assume i connotati di costruttore attento, che edifica l’abitazione umana, se ne prende cura e la nutre1. Il piano, il progetto, l’edificio diviene una costruzione più leggera: meno monumentale, meno metafisica nelle sue aspirazioni, più modesta, aperta e disponibila nella sua risposta al luogo in cui è destinata ad acquisire vite, storie… ricordi, significati. Un’architettura di questo tipo diventerebbe forse più vulnerabile a un senso dell’abitare ricevuto dall’eredità storica e dalle contingenze terrestri che noi chiamiamo mondo (Heidegger 1954a, p. 119). In questo modo, l’architettura si metterebbe anche in comunicazione con le dimore più semplici che rappresentano l’abitazione e il rifugio per la stragrande maggioranza della popolazione mondiale che non dispone né dell’economia, né della stabilità quotidiana per permettersi la qualità architettonica degli edifici occidentali. Questo potrebbe proporre un ponte tra le op1 “L’uomo non è il padrone dell’ente. L’uomo è il pastore dell’essere” (Heidegger 1946, p. 295). IAIN CHAMBERS zioni individuali circoscritte dalla responsabilità teorica (e dai costi) di edifici domestici come quelli proposti, per esempio, dall’architetto australiano contemporaneo Glenn Murcutt, e le soluzioni standardizzate che prestano attenzione alla storia del luogo. Tra le opere di Murcutt si distingue la famosa casa Marika-Alderton (1991-1994) nella comunità di Yirrkala nei Territori Settentrionali: una reinterpretazione dello stile aborigeno del rifugio proposta come alternativa al bungalow governativo standard (Flora, Giardiniello, Postiglione, a cura, 1999). Qui, per quanto si stia sempre parlando di una soluzione su misura, non collettiva, non si esclude la possibilità che quest’ultima venga a essere eticamente ed effettivamente influenzata dalla prima. A questo punto, sarebbe possibile chiedersi se gli architetti siano le vittime o gli esecutori del capitale globale e dei suoi teatri locali del potere. I commenti di cui sopra sulla locuzione storica e sui limiti della volontà architettonica occidentale (ora trasposta negli skyline di tutto il mondo, da Siviglia a Sydney a Shanghai) vogliono proporre per gli architetti il ruolo di mediatori, che esercitano il loro potere di riflettere e di deflettere le relazioni strutturali in cui loro, le loro pratiche e noi veniamo catturati. L’architettura, come ambito dell’opera critica, non è soltanto il luogo in cui si visualizzano e progettano edifici e città, ma è anche il luogo dove diviene possibile ascoltare ciò che i protocolli della professione tendono a passare sotto silenzio o a reprimere nella sua economia politica di razionalizzazione dello spazio. L’architettura si sviluppa necessariamente a partire da un punto di vista che, a prescindere dal grado di liberalità e pluralismo delle sue intenzioni, è destinato ad attrarre tutto ciò che incontra nella logica del suo piano. Non solo è unilaterale nella sua astrazione (come si traccia o progetta il contingente e il trasgressivo?), ma richiede altresì una chiusa arbitraria, un’omogeneizzazione della visione, se deve passare da un tavolo da disegno al luogo della costruzione, all’edificio abitato e all’edificazione dello spazio. È vero che, nella città di tutti i giorni, nella mobilità della vita quotidiana, le cose non vanno tanto lisce: i detriti lasciati dalle altre storie e dalle altre maniere di abitare lo spazio urbano possono lasciare il loro segno sui muri, i loro ripari di cartone nel parco, le loro ombre distese sui marciapiedi, o concentrare altrove la diffe- ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO renza – dal linguaggio e dalla religione alla musica, alla cucina e all’abbigliamento – in particolari enclavi del reticolo urbano. In che modo risponde l’architettura? E soprattutto, può l’architettura rispondere affatto? Oppure tra coloro che non rientrano nel piano, la cui presenza ne infastidisce e sfida la logica, è già innestata un’altra architettura? Certamente emerge di frequente una maniera di abitare che intorbida la logica imposta, che riscrive i termini dell’ospitalità secondo un altro design culturale. La tradizione del discontinuo Come pianificare, concepire e costruire in risposta a queste pressioni e presenze fluttuanti, come rispondere agli indisciplinati vortici e mulinelli di una storia che non è né omogenea, né vuota, bensì occupata con tenacia? Non dispongo di una risposta chiara e precisa. Ma forse l’architettura riuscirebbe a rispondere meglio a queste condizioni, che sono intrinseche alle condizioni strutturali della modernità occidentale stessa, sforzandosi meno di “risolvere” questi “problemi” e tentando maggiormente di presentarli. Quello che potrebbe voler dire implica un cambiamento distinto ed esplicito nelle fondamenta intellettuali e nel linguaggio dell’architettura stessa, perché l’architettura tende a identificare il terreno soltanto nell’istante dell’edificazione. Prima di quel momento uno spazio di questo tipo è letteralmente privo di significato, privo di costruzione e quindi non rappresentabile né in termini propri, né in termini dell’epistemologia nella quale è intrappolato. Che cosa succederebbe se l’architettura dovesse costruire senza la sicurezza aprioristica che la protegge da ciò che la sua ragione non è in grado di contenere? A questo punto l’astratta priorità della geometria verrebbe sfidata dal terreno impregnato di storia e cultura su cui agisce l’architettura, tanto fisicamente quanto metafisicamente. Com’è ovvio, si potrebbe semplicemente obiettare che tutto ciò non è che un ozioso esercizio in un ilare gioco di parole, che strappa la metafora dell’“architettura” per renderne l’autorità intellettualmente sospetta e per insinuare che le sue innovazioni siano semplicemente la decorazione di una ripetizione mondana di edifici che hanno poco di nuovo da dire sull’abitare, ma molto da IAIN CHAMBERS guadagnare nella produzione in serie di case, uffici, centri commerciali e supermercati. Tuttavia mi pare che domande di questo tipo ci costringano a ritornare alla questione dell’architettura, a prendere sul serio la storia dell’edificio e dell’abitazione, per non parlare della forza della metafora stessa, sia per quanto riguarda i suoi scopi che i suoi limiti. Questo perché costruire, edificare e abitare un luogo significa inevitabilmente stabilire dei limiti: come minimo tra un interno e un esterno, tra i confini controllati della domesticità curata e l’inclemenza insubordinata del disabitato, del selvaggio. Ovviamente, da Freud in poi, o meglio, come ci ricorda Lyotard, dalla tragedia greca, sappiamo che questa architettura è illusoria, che il selvaggio, l’indomato, il represso, si infiltra sempre nella scena domestica: la porta è porosa (Lyotard 1997). Attraverso la porta, “il limitato e l’illimitato si uniscono reciprocamente, non nella forma geometrica morta di un semplice muro separatore, bensì come possibilità di un interscambio permanente” (Simmel 1997, p. 68). Eccoci di ritorno al luogo in cui si deve erigere l’edificio, uno spazio che non è vuoto ma saturato, un terreno che non è neutrale e muto, ma che si trova già iscritto, già vissuto. Lo ribadiamo: prendiamo alloggio nel perturbante. Ma in che modo, dato che l’autorità dell’architettura è insita nel gesto della fondazione, dato che apparentemente occorre uno spazio vuoto per realizzare le sue ambizioni, si può costruire su un terreno assai più compromesso, irregolare e infestato, ovverosia, com’è possibile prenderlo in considerazione invece che negarlo? La risposta va cercata nella tradizione. Non nell’angusta tradizione di un’architettura occidentale, che è diventata la pratica globale delle tecniche e della tecnologia della costruzione che è assurta al ruolo di dominatrice della realizzazione dell’habitat moderno e della “clonazione degli skyline americani per tutto il mondo” (Morris 1990). Piuttosto, la tradizione che si evoca qui è quella inquietante e interrogativa dell’abitare la terra sotto il cielo, in cui le tematiche della “libertà” e dell’“azione” esistono in prossimità del mondo invece che essere in debito nei confronti dell’umanesimo astratto del soggettivismo occidentale (e del suo culmine metafisico rappresentato dal razionalismo tecnologico). Questo implicherebbe uno spostamento da un’architettura dedita a progettare edifici a un’architettura impegnata nell’identifica- ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO zione dei luoghi (Unwin 1997). A questo punto, gli architetti potrebbero essere visti come mediatori tra l’ordine, la disciplina che incarnano e il dis-ordine e il mondo extra-disciplinare cui tentano di dar casa e sistemazione. Vorrebbe dire suggerire, in particolare nella cultura eccessivamente determinata, pragmatica, anglosassone, che gli architetti operano, consapevoli o meno, con un programma “intellettuale” ed etico. In questa visione radicalmente diversa della tradizione, la particolare osservazione architettonica di una disciplina e della tradizione che, per esempio, auspica ardentemente l’architetto italiano Vittorio Gregotti (1999), non può più essere considerata con compiacenza il luogo di una continuità referenziale, circoscritta da contorni storici, geografici e politici precisi. Diventa piuttosto un esempio di traduzione e transito. Chiaramente, fare appello alla tradizione significa fare appello a un contesto culturale specifico e alla spazialità storica nella realizzazione del piano. Ma se si cerca un dialogo coi presupposti dell’edificio, l’edificio che ne deriva viene costruito secondo linee radicalmente diverse da quelle associate unicamente alla conservazione della continuità. Una differenza effettiva scaturisce dal linguaggio utilizzato nell’appropriazione dello spazio e nella sua trasformazione in un’identità specifica. Quando la sintassi utilizzata nell’articolazione del progetto architettonico viene considerata cristallina, di modo che la ragione si manifesta direttamente nella costruzione, allora ne scaturisce un edificio (nonché un senso del luogo) molto diverso rispetto al prodotto di una grammatica più incerta e di una sintassi sperimentale che dialoga con i limiti del locale e con i limiti della stessa ragione architettonica. Un fatto paradossale è che la critica e la crisi contemporanea dell’architettura europea non derivino dal suo insuccesso e dalla minaccia della sua estinzione, ma precisamente, così come per molte altre pratiche occidentali, dalla sua ubiquità, dal fatto che il suo linguaggio e la sua ragione sono divenuti universali. Nella razionalizzazione della tecnologia e della tecnica, la sfida dell’indecifrabile viene inevitabilmente sostituita dal concetto dell’immediatamente disponibile, la poetica viene sostituita dal pragmatismo. In questo modo si arresta pericolosamente lo sviluppo del discorso architettonico, riconducendolo alla razionalizzazio- IAIN CHAMBERS ne egemonica dell’oggettivazione soggettiva del mondo. Ma se l’architettura riguarda la narrazione della tradizione e del luogo, o del tempo e dello spazio, e se è contigua all’iscrizione e alla scrittura in corso della terra, allora non può mai semplicemente instaurare una relazione “organica” con ciò che sorge dal terreno locale della cultura europea. La cultura stessa è storicamente una formazione ibrida e transitoria che prende a prestito e modifica stili e soluzioni che sono stati imposti, importati, imprestati, assemblati, adottati e adattati. In questo sganciamento dalla prospettiva rigida e omogenea dell’umanesimo, all’architettura si richiede di rispondere a ritmi differenziati e a storie che complicano e confondono i suoi desideri di costruzione. Ma può bastare il riorientamento generale? La risposta è chiaramente no, perché inevitabilmente mi porta a mettere in discussione il desiderio di un insediamento che inevitabilmente trasforma il luogo nell’ambiente di un’acuta xenofobia quando l’idea di domus si traduce in quella di dominio. Ecco che emerge il compito intellettuale, politico di identificazioni che si spostino dal chiuso ossario storicista di rivendicazioni ancestrali verso un linguaggio ben più incerto e aperto di siti, traduzioni, transiti e percorsi. Si vuole auspicare una trasposizione dall’insistenza violenta delle fondamenta alla transizione che accompagna una migrazione di corpi e storie, e alla consacrazione dell’abitazione provvisoria colta nella cuspide di una perenne ri-collocazione. Questo tipo di calcoli, ovviamente, non può essere incorporato in modo immediato. L’atto dell’architettura è sempre un problema, una provocazione: interrompe radicalmente, o più modestamente, ricontestualizza un luogo già esistente. Anche se si potessero accantonare gli imperativi del capitale e del mercato della proprietà globale, l’architettura non può comunque ritirarsi dal suo compito. Però la consapevolezza che essa incarna anche qualcosa che va al di là dei suoi calcoli, qualcosa che esemplifica ed espone quella condizione supplementare, e che quindi oltrepassa sempre le tecniche più ovvie del design dell’ingegneria e della pianificazione, significa paradossalmente insistere sui suoi limiti. Perché l’architettura avviene sempre in un luogo, mai in uno spazio vuoto. Lo spazio dell’architettura è sempre iscritto, situato, compreso e costruito, mai vuoto e innocente. È già il sito di qualcuno, di qualche essere. L’architettura costruisce sempre su terreno ARCHITETTURA, AMNESIA E IL RITORNO DELL’ARCAICO frantumato, instabile. Questo significa intersecare l’arte della costruzione razionale (la volontà di costruire un edificio: la metafisica della costruzione e la costruzione della metafisica) con l’intercessione e la salvaguardia della questione del nostro essere differenziato nel mondo. Ci sono forze all’interno dei linguaggi dell’essere, del costruire e del pensare che interrompono, irrompono e vanno al di là dell’imposizione violenta di soluzioni tecniche, “scientifiche”, “razionali” e unilaterali all’antica e alla più presente delle necessità: la domanda in fieri di come abitare. Capitolo sesto Estraneo in casa Vorrei cominciare trattando un problema che, in un modo o nell’altro, ci riguarda tutti, tanto nella nostra attività intellettuale quanto nella vita quotidiana: forse la sovranità nazionale non si sta sgretolando in quel modo così spettacolare previsto dai profeti del capitale trans-globale e del flusso di informazioni. Né tantomeno si sta sfaldando per lasciare il posto a un senso d’identità trans-nazionale. I curdi, i baschi, i palestinesi, i tibetani, reclamano tutti quanti il loro diritto all’autogoverno. Si scopre che “la nazione è sempre una realtà in divenire, piuttosto che una realtà già consolidata” (Hage 1996, p. 477). Per quanto già istituita, pare sempre che la nazione stia sempre a un passo dal compimento, ma senza mai arrivarci del tutto (p. 478)1. Di certo, come ha asserito Arjun Appadurai (1996), i media e l’emigrazione dei nostri tempi hanno alterato profondamente sia l’immaginazione pubblica che quella privata, in ogni luogo, modificando profondamente gli orizzonti potenziali dell’identità. Eppure, in un mondo in cui la volontà di combattere, uccidere, e persino di morire per un’astrazione chiamata “patria” o “nazione”, è spesso indissolubilmente legata a una precisa appartenenza etnica o fede religiosa, le forze complesse che configurano sostanzialmente il senso dell’appartenenza e della “casa” rimangono prepotentemente al loro posto. Continua a esistere una vicinanza inquietante e, come osserva Ghassan Hage, persino un “immaginario nazionalista strutturato in maniera simile” che accomuna le identità etniche, spesso costituite come “na1 Qui Hage commenta Žižek, definendo la nazione come una fantasia lacanica, come qualcosa su cui si deve sempre lavorare. IAIN CHAMBERS zioni” e “pulizia etnica”. In altre parole, c’è una vicinanza inquietante tra apparentamento e sterminio (Hage 1996, p. 466). Il mistero della casa Il mistero del senso di appartenenza depositato nel desiderio, nella necessità di far parte di un’unità storica, sociale e culturale cui ci si riferisce come “casa” o “patria”, malgrado le teorie ottimistiche elaborate sul nomadismo e sul divenire rizomatico, stenta a scomparire. Come si è già rilevato, la casa in quanto domus è etimologicamente affine a dominus: dominio (Benveniste 1973, citato in Hage 1996, p. 473). La casa è il luogo in cui è possibile dominare e addomesticare, governare e articolare le cose e le relazioni, i materiali e i corpi, la fantasia e la realtà. Eppure, siamo tutti ben consapevoli di quanto sia alto il prezzo che l’umanità paga per questo desiderio: dall’ostracismo sociale, lo sfruttamento economico e la discriminazione razziale alla guerra, l’eliminazione fisica e, perfino, il genocidio pianificato e industrializzato. Non siamo nella posizione per risolvere questo mistero, il quale chiaramente va al di là delle nostre capacità di raziocinio. Questo significa che lo stato “irragionevole” della nazione e del nazionalismo è irrazionale? Oppure esprime una disposizione di sentimenti con cui potremmo imparare a convivere diversamente?1. Una volta Alejandro Morales, romanziere chicano, mi ha domandato: dove finisce l’esilio e ha inizio la migrazione?”. Chiaramente questa matura alla luce di quello, ma fluttuare tra i due termini forse rende possibile focalizzarsi meglio sullo spostamento politico e ontologico dal restare nelle ombre lunghe di una patria che si è stati costretti ad abbandonare e il sopravvivere nei complessi meandri di un paese ospitante che sta anche diventando casa tua. Il passaggio dall’esilio alla migrazione, per quanto inevitabilmente sfumato, implica il movimento dalle certezze perdute della casa precedente che devono essere preservate dalla dispersione del viaggio, all’assai più ambigua e incerta sistemazione del nuovo habitat; questo perché se anche chi emigra si aggrappa ancora a una comunità im1 Per una discussione su questa tematica, si veda Rose 1996. ESTRANEO IN CASA maginaria, si tratta di una comunità ancora legata alle trasformazioni della sua cultura, della tradizione, del linguaggio, persino dei riti e dei miti religiosi, nello spazio traslato in cui sia essa che la comunità ospitante subiscono una trasformazione. In questo contesto, raccontare la nazione significa anche narrare un’ulteriore storia e applicare ulteriori interrogativi nel mosaico dell’identità individuale e comune. Al di là delle distinzioni fenomenologiche che si potrebbe essere tentati di delineare cercando di localizzare la differenza tra esilio e migrazione, vorrei considerare la tematica dell’esilio, della migrazione e dello straniero come argomento che riguarda la comprensione stessa della modernità occidentale: il suo senso della storia, della cultura, del luogo e dell’identità. Significa trarre, dai presunti margini della modernità, la testimonianza insistente dello spostamento coatto di genti e culture, che si segnala nella maniera più drammatica nell’instaurazione violenta, e nella successiva interazione, di schiavitù a sfondo razzista, capitalismo, nazionalismi moderni e genocidio. Le economie atlantiche e i rampanti Stati nazionali europei inizialmente venivano sostentati dal commercio degli schiavi africani. L’attività del colonialismo a livello mondiale che ne conseguì spaziava da episodi metropolitani come lo svuotamento delle Highlands scozzesi operata nel diciottesimo secolo alla deportazione dei galeotti verso remote colonie penali, alle migrazioni di massa del secolo successivo, originate dalla povertà rurale dell’Europa meridionale, dell’India e della Cina. Tutto questo costituisce una traiettoria che svolge un ruolo cruciale nella dominazione sistematica che conduce ai pogrom, al genocidio e al tentativo di sradicare intere popolazioni dal cuore delle Americhe, dell’Europa centrale, dell’Australia e di altre regioni. Nel complesso miscuglio di storie inter-etniche e intersubalterne, il problema di chi sia l’estraneo nella composizione assilla ogni revisione storica e politica. Gli scozzesi delle Highlands che, espulsi dalle loro case e stabilitisi in altre zone di altri continenti (America settentrionale, Australia, Nuova Zelanda) espellono altri dalle loro case, contribuiscono alla subalternità storica che semplicemente non è uguale per tutti1. Il colono bianco, a prescindere da 1 Si veda al riguardo il lucido resoconto della mostra da lui stesso curata, “River Deep Mountain High: Then and Now – A Story of Cultural Collision using Native American sources, Commentary from the Highlands of Scotland and Artists from Both Sides of the Atlantic”, Inverness Museum e Art Gallery (luglio-agosto 1997), in Amery 1997. IAIN CHAMBERS quanto sia povero e sfruttato, rimane sistematicamente un usurpatore. La catena del dislocamento globale inaugurata dall’imperialismo moderno è complessa e codificata, producendo subalternità che sono allo stesso tempo collegate eppure spesso incommensurabili. Oggi queste storie multiple, represse e ineguali ritornano per dislocare radicalmente le pretese unilaterali di possedere un linguaggio, una cultura, una storia, una città, una nazione, una “casa”, abitando e strutturando diversamente questi linguaggi, raccontando la modernità con un altro lessico in un’altra chiave. L’“indigeno” sterminato, l’“esule” bandito, lo “straniero” disprezzato ritorna continuamente per infestare la modernità e la confortante protezione della stabilità e della continuiità. Ma non semplicemente per proporre la disseminazione e la disperzione della grammatica euroamericana del potere da parte del subalterno e di chi prima era escluso; ma, soprattutto, e più precisamente, per chiedere con insistenza l’interruzione della pretesa della privativa storica e culturale e del “progresso” (chi ha costruito questa casa, e di chi è questa casa?); un interruzione che mi costringa a riflettere su come non ci sia storia, cultura o identità che sia immune dall’esposizione alla risposta e alla responsabilità dell’interrogativo che scaturisce dalla presenza dell’estraneo, dalla vicinanza dell’altro. Come ci ha ricordato Johannes Fabian (1999), nell’incontro con l’alterità, lo sforzo di mantenere una distanza gerarchica impedisce di ricordare da dove veniamo: una casa ibrida, infestata da riti storici, pregiudizi culturali e superstizioni sociali. Per citare il suggestivo lavoro di Paul Carter (1996) intitolato The Lie of the Land, questa prospettiva potrebbe implicare un’inversione o un rovesciamento delle connotazioni generalmente negative della migrazione e dell’esilio, perché la migrazione e l’esilio vengono immancabilmente considerati eccentrici, indice di impoverimento culturale. Questo verdetto, asserisce Carter, deriva da: un programma politico, dalle ambizioni centraliste della polis ateniese e dai suoi apologisti. La sfida, quantomeno per la poetica postcoloniale, è vedere in che modo la migrazione potrebbe comportare una forma di collocazione, potrebbe essere effettivamente costituzionale e rappresentare una modalità del sentirsi a casa nel mondo. La storia della cultura occidentale si limita a una sequenza di recinzioni scientifiche e tecnologiche sempre più astratte che progressivamente ESTRANEO IN CASA ci separano dal contatto col suolo e che caratterizzano il moto fisico come primitivo? Oppure c’è, all’interno di quella sequenza, una controtradizione, una modalità dell’errare che segna il terreno? Pallade Atena potrà mai prendere il controllo della tempesta? (p. 336). In questa prospettiva sbalzata, l’oggetto del mio sguardo, l’oggetto del mio linguaggio, l’estraneo silenzioso, l’emigrante muto, diviene un soggetto storico, che non solo risponde e quindi non esiste limitatamente al mio discorso, alle mie parole e al mio mondo, ma offre altresì un significato che non mi appartiene necessariamente, e nemmeno riconosce le mie pretese sul suo senso. In questa ricusazione della distinzione soggetto-oggetto, avviene sia che la padronanza del linguaggio venga messa in discussione, sia che la distanza critica, che fornisce ospitalità alla mia sicurezza ontologica, si disperda e si elimini. Se si scopre che il mondo che nomino non mi appartiene, non soggiace al mio controllo, allora il movimento da casa e dall’ambiente domestico verso un ambiente estraneo in cui, come dice Edmond Jabès, viaggio ora come ospite, non dipende dalla mia volontà, bensì dall’ospitalità del linguaggio. Questo altro luogo, questa alterità, non è soggetta ai miei imperativi, non mi nutre e non alimenta il mio ego. Non fornisce più la strada per fare ritorno attraverso l’altro. Sostiene Emmanuel Lévinas (1961, p. 37) Né il possesso né l’unità del piano, né l’unità del concetto, possono legarmi allo Straniero [l’Étranger] (…) lo Straniero che viene a turbare la mia casa [le chez soi]. Ma Straniero significa anche il libero. Su di lui non posso potere. Sfugge alla mia presa per un fatto essenziale, anche se dispongo di lui. Non è interamente nel mio luogo. Il problema dell’altro è sempre il problema dell’estraneo, dell’outsider, di chi viene da un altro luogo e inevitabilmente reca il messaggio di un movimento che minaccia di perturbare la stabilità dell’ambiente domestico. Ciò che cerchiamo di tenere a debita distanza viene reso vicino, l’esterno (per il quale in passato si costruivano le mura, e oggi si emanano le leggi) diviene interno, ineluttabile. Nello scambio ontologico, il mio senso dell’essenza si ritrova ad affrontare un interrogativo, viene reso vulnerabile. Riconoscere questo stato invece che negarlo, sottometterlo o annientarlo significa porre non soltanto il problema della tolleranza IAIN CHAMBERS liberale e della coesistenza pluralista, ma anche un interrogativo profondo e perenne. Sempre Emmanuel Lévinas aggiunge: La relazione etica, che sottende il discorso, non è infatti una varietà della coscienza che si irradia dall’Io. Essa mette in questione l’io. Questa messa in questione parte dall’altro (p. 201). Nel viaggio nel futuro, si rivela determinante anche il viaggio a ritroso, verso il focolare. Il passaggio tra passato e futuro si accompagna sempre alla ricerca della conferma di casa. Per alcuni si tratta di un punto di riferimento saldo, di una stabilità rassicurante rappresentata in termini economici, sociali e storici, per altri è spesso un’immagine fragile, sbiadita e spesso strappata, nutrita più dal barlume immaginario della memoria che dall’immediatezza della conferma materiale. In questo intervallo tra la casa che mi invita ad andare avanti e quella che mi richiama indietro, emerge la forza di attrazione multipla del tempo, un tempo che non è semplicemente lineare e progressivo. Se il tempo, come osserva Akhil Gupta (1994), viene considerato immancabilmente un bene di consumo, allora il tempo di alcuni viene necessariamente considerato più ricco e potente del tempo di altri. Contro l’enfasi occidentale posta sul tempo lineare, che misura assiduamente lo sviluppo e il sottosviluppo sulla scia del “progresso”, c’è il tempo della migrazione, e la migrazione del tempo da una modalità unica di misura (Bhabha 1994). È mediante la ricombinazione multipla del tempo, Salman Rushdie ci ricorda nei Versi Satanici (1988), che la novità emerge nel mondo. Il concorso di ritmi differenti nell’ambito della modernità deforma, svia e distorce la sua unilateralità. Dimensioni diverse perturbano e interrompono la temporalità produttiva dell’accumulo misurato, lineare. Nella giustizia della differenziazione, il tempo vissuto della modernità va al di là della singolarità parziale e astratta del “progresso” (Gupta 1994, pp. 172-175). Ciò perturba, pone in discussione e porta via il terreno su cui si sono storicamente costruite le distinzioni nella narrazione occidentale del progresso, le distinzioni che continuano a giustificare, sotto le mentite spoglie dello “sviluppo”, la subordinazione e la gestione del “terzo mondo” di oggi (p. 179). ESTRANEO IN CASA Se l’Occidente è diventato il mondo, in questo processo ha anche subito uno spostamento. Se i suoi linguaggi, le sue tecnologie e tecniche ormai abbracciano tutta la terra e forniscono il senso contemporaneo dell’abitare, la sua storia e i suoi poteri vengono vissuti da altri che vi esprimono le loro storie, identità, ragioni. Il mio (ego)centro viene interrotto, perché qui, quali che siano i miei desideri, sono costretto ad affrontare, nel linguaggio stesso che presumo di possedere, l’incommensurabile, l’intraducibile, il cuore di un’essenza che rifiuta di essere ricondotta a una misura comune; ossia, alla mia misura e alla mia concezione del mondo. A prescindere da quando e dove lo si nomini, emerge il legame represso che rende la “casa” possibile per alcuni, impossibile per altri. Viaggiando tra l’alloggio e la condizione di senza tetto, le categorie stesse con cui generalmente si costruisce la “casa” (la tradizione, il linguaggio, il costume, l’affinità) fanno i conti con altre versioni inattese. Quando le coordinate di un luogo e di una storia particolari (quelli dell’Occidente) si disseminano per il mondo, allora la particolare connotazione locale della tradizione e della lingua si ritrova in un viaggio interminabile. Qui, nel transito e nella traduzione, la natura stessa del luogo e della casa subisce una mutazione irreversibile. Il vicino, ciò che si trova a portata di mano nella costruzione della mia casa e del senso di me stesso, non può più essere legato al sangue, al suolo, e all’orizzonte chiuso dell’immediato e del locale. Il mito delle “origini” pure si fonde ormai con altri, proiettando osservazioni sull’appartenenza (a cosa? dove? come?) verso l’esterno, in uno spazio vulnerabile. Il tempo e la tradizione di un’economia culturale locale sono scalfiti da una serie di interrogativi che toccano tutti, ma proprio tutti i luoghi. Sono nato tra due onde e la mia pelle diventa ancora più scivolosa. Così scrive il poeta iraniano emigrato Majid Nafici (1996, p. 199). Quando il mondo si comprime e il remoto si congiunge al vicino, il non domestico al domestico, si scatena la repressione che perseguita e infrange ogni rappresentazione della casa, della cultura e del sé. IAIN CHAMBERS Nel disfarsi del mito della casa, in cui il viaggio conferma sempre il punto di partenza fissato dall’illusione che alla fine si tornerà a casa, l’archetipo occidentale di Ulisse viene dirottato e mandato alla deriva. Il senso greco e omerico di “casa”, esaminato da Horkheimer e Adorno (1947) nella loro famosa analisi dell’Illuminismo, non fornisce solamente l’ovvia rassicurazione della familiarità, ma anche la formazione culturale e il sostegno psicologico che strutturano la conseguente ragione dell’ego. Armato di certezza domestica, l’individuo è in grado di avventurarsi nel mondo, di affrontare tormenti e vicissitudini, indagarne le manifestazioni e tornare a casa con la conoscenza che ha guadagnato, perché: le avventure dànno a ciascun luogo il suo nome; e il loro risultato è il controllo razionale dello spazio. Il naufrago tremebondo anticipa il lavoro della bussola. La sua impotenza, a cui nessun posto del mare è più ignoto, tende insieme a destituire le potenze (Horkheimer, Adorno 1947, p. 55)1. Una coscienza centrata nell’Io, una ragione tesa al controllo: un uomo solo traccia la rotta verso casa. La casa, per lui, non è necessariamente un rifugio o un riparo fisico; è la casa della conoscenza la cui forza propulsiva gli promette l’accesso a ciò che deve conoscere, scoprire e assimilare. Ciò che intendo è che un viaggio del genere (in cui la ragione autonoma e patriarcale percorre un tragitto attraverso il mondo, immemore della voce e delle storie degli altri, rifiutando, per dirla con Paul Carter “di cedere l’autorità a qualcosa di diverso dalla propria rappresentazione”) oggi è intellettualmente impossibile: al termine del viaggio non si fa ritorno a casa, non c’è un’Itaca che aspetta, non c’è Penelope, il viaggio non ha fine (Carter 1996, p. 309). La prospettiva di addomesticare il mondo al fine di confermare la struttura e l’avarizia dell’ego è interrotta per sempre. Il mondo, il senso del luogo e dell’appartenenza, del domestico e dell’estraneo, della stessa modernità occidentale, viene riconfigurato in modo irreversibile. Il momento di sconcerto indotto 1 Ho lasciato la trattazione della figura cruciale di Ulisse al capitolo seguente. ESTRANEO IN CASA dal primo contatto e dall’asservimento di altre storie alla teleologia dell’Occidente ritorna a infestare la casa della conoscenza e gli assetti politici e psicologici che pretende di avere fissato. L’esperienza perturbante della modernità non è più una sensazione empirica periferica o transitoria. Di certo non lo è mai stata. La messa in questione è fondamentale sia per la riproduzione economica e sociale della modernità sia per le resistenze che diffonde. Significa abitare una formazione storica differenziata ma condivisa che rielabora e riprogramma radicalmente il nostro senso dell’essere al mondo. Ecco che il riconoscimento della problematicità e della dislocazione non è costituito unicamente da una sensazione heideggeriana di non avere una casa, indotta dall’oblio tecnico e strumentale delle modalità dell’essere, ma trova anche e più precisamente espressione nel senso della casa che si costruisce nelle coordinate temporali delle storie incerte e che rendono incerti. Spesso sottovalutate e più in generale represse nell’acquisizione del benessere locale, sono queste coordinate che costituiscono in maniera più profonda la nostra precaria dimora nel mondo. Proprio la consapevolezza di una siffatta cognizione non può più essere negata con facilità. Il trauma della traduzione Sia l’essere estraneo, migrante, che un profondo senso di appartenenza dipendono dalla definizione di luogo. Ci sono sia il luogo in cui l’esiliato, l’emigrante si presenta come estraneo sia il luogo o la “casa” che si lascia alle spalle. Affrontare questo problema, come asserisce l’antropologo urbano messicano Néstor García Canalini (1995) nel suo libro intitolato Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity, significa confrontarsi con qualcosa di più radicale e di portata maggiore del multiculturalismo e della politica dell’identità. Non si tratta semplicemente di riconoscere, in ritardo, il corpo precedentemente negato della storia, la storia di corpi negati, in una narrazione nazionalista ora intenta a ospitare la diversità. Questo perché al di là della risposta immediata che può offrire temporaneamente ospitalità all’alterità, una risposta più adeguata e meno episodica alla questione dell’esilio, della migrazione e del dislocamento può IAIN CHAMBERS emergere senza dubbio solo dalla cosiderazione del terreno stesso evocato dal luogo: il luogo precedente da cui proviene l’emigrante e il luogo presente che ospita il corpo dell’emigrata, la storia dell’esiliato, la loro cultura. Nel movimento attraverso i vettori economici e politici della modernità, è la concezione diversa del tempo e del luogo, al pari di passaporti e permessi di lavoro, accento e religione, che identifica l’emigrante, l’estraneo che “si integra” o meno. Il passaggio della migrazione comporta il trauma di essere tradotto in un oggetto. Questo trova forzatamente conferma nell’essere successivamente posto ai margini, in una posizione “minoritaria”, in quanto migrante: l’estraneo la cui presenza riconferma la non posizionalità, il movimento liberale di chi abita il centro nazionale, la principale corrente politica, il consenso culturale. Se, per definizione, l’emigrato, il migrante e l’estraneo evocano uno spazio liminale, la loro presenza ha anche la conseguenza compensatoria di relegare la “casa”, la sensazione di luogo e di appartenenza, in un particolare luogo storico e ontologico. L’arrivo dell’estraneo genera un confine, una frontiera, sia immaginari che effettivi. I limiti imposti, le barriere erette, non creano solamente l’estraneo, che resta fuori: costruiscono, limitano e definiscono la natura stessa di ciò che sta “dentro”. Pertanto, mi sembra importante esaminare come si colloca il luogo sul terreno, come viene costruito e concepito. Tali elementi potrebbero contribuire a fornire una risposta e un linguaggio in cui considerare l’esilio e la migrazione, l’arrivo dello straniero. Vorrebbe dire pensare non in termini di minaccia di fronte alla quale cerco un riparo immediato, bensì di una risposta improcrastinabile nei confronti delle storie represse che mi consentono di sentirmi al sicuro mentre mantengo il mio terreno definendo ed escludendo l’altro. Il luogo. La cosa più ovvia parlando del luogo in compagnia di stranieri è di riferirsi al suo nome in un linguaggio e una storia inevitabilmente istituzionalizzati nella grammatica culturale nevrotica della nazionalità. Il senso moderno del luogo, per quanto rechi ancora i segni di concezioni arcaiche (villaggio, dialetto locale, città o regione) trova la sua premessa, sia per l’estraneo che per chi lo ospita, nella nomenclatura nazionale. I particolari degli abiti, nella lingua, dell’accento, del cibo, della ESTRANEO IN CASA religione e delle tradizioni trovano un riscontro in questo senso d’appartenenza. Tuttavia, sappiamo che spesso si tratta di un’approssimazione, talvolta di una lettura erronea. Molti di questi particolari precedono il moderno stato nazionale e, per quanto siano stati smussati per rispettare i requisiti dell’identità nazionale, inevitabilmente debordano da quella limitata cornice pedagogica. Lo spagnolo non appartiene alla Spagna, come l’Islam non appartiene all’Iran, né l’inglese è prerogativa dell’Inghilterra. Pertanto, quando si nomina la propria identità, si accetta e allo stesso tempo si rifiuta una storia di appartenenza omogenea e nazionale. La grammatica prescrittiva del nazionalismo che tenta, sia a casa che all’estero, di contenere la potenziale eterogeneità e di appianare la contestazione in nome del consenso pubblico, è potenzialmente superata e sfidata nell’idioletto che parla di appartenenza individuale1. Ma di quale “luogo” sto parlando? Quello dell’emigrante, dello straniero, o quello dell’indigeno, del locale, del padrone di casa? Il senso di terreno che si propone qui, non l’astratta unità del tempo lineare e dello spazio vuoto occupato dalla “nazione”, ma il terreno aspro, sconnesso, resistente e sregolato del quotidiano in cui la storia lascia tracce, proposte e direzioni multiple e aggrovigliate, non investe forse sia il luogo dell’estraneo che il luogo del residente? Queste osservazioni perturbano il tempo omogeneo di un’identità nazionale unica, deviando il tracciato lineare della freccia del “progresso”, facendo un passo lateralmente nei multipli luoghi della temporalità coeva e nelle storie che ci collocano in una collettività variegata. Qui l’aborigeno australiano, il chicano di città e l’inglese che abita in periferia occupano un mondo condiviso, anche se asimmetrico. Tutti e tre rientrano nella modernità senza essere riducibili alla narrazione unitaria che la modernità spesso finge di offrire. Tuttavia, anche questo senso del territorio che rifiuta la cornice nazionale e mette in discussione la presunta posizione tanto dell’emigrante che del residente è soltanto il primo capitolo di una contronarrazione che promette di riscrivere la comprensione stessa del terreno, del luogo e dell’identità. Al movimento laterale che rende multipla la modernità ed eterotopico il mondo, occorre ag1 Una brillante e pregnante versione di questa argomentazione si trova in Ang 1994. IAIN CHAMBERS giungere un ritorno in cui le narrazioni privilegiate della modernità schiudono una formazione ibrida. La migrazione, inevitabilmente rafforzata dalla schiavitù, dall’imperialismo, dal colonialismo, dal dominio tecnologico, dall’egemonia economica e politica, è sempre stata presente come elemento costitutivo della modernità occidentale fin dalla sua origine, cinque secoli fa (Gilroy 1993a). Antropologizzare l’antropologo A questo punto, il problema si manifesta non tanto nello spazio della congiunzione, nell’“e” posto tra “casa” e ibrido, tra ambiente domestico e migrazione, tra il “residente” e l’“estraneo”, bensì nello sforzo di imparare a vivere nell’ibridità come se fosse casa. Qui viene meno la scelta tra il domestico e la diaspora, si ha piuttosto la possibilità di occupare un ulteriore spazio in cui familiare ed estraneo si coniugano e si interrogano scambievolmente. Qui forse esito di più nel pronunciarmi su dove finisca il domestico e dove cominci l’estraneo. Qui i lucidi verdetti di “globalizzazione” vengono deviati e travasati nelle assai più complesse incertezze di un “mondeggiamento” che è materiale e immaginario, politico e poetico. Quanto detto cozza, nella maniera più ovvia, con un’interpretazione cosmopolita superficiale localizzando le storie e le identità in una posizione che al contempo ci sorregge e va al di là di noi; in una cornice terrena che sfugge alla logica della spiegazione ovvia e alla trasparenza riduttiva… Qui la storia della casa/nazione, concepita in termini nazionali e nazionalisti, viene intersecata dal problema dell’abitazione. Intrappolati in queste coordinate, i linguaggi dell’identità e della nazione vengono collocati entro confini che ne limitano le pretese sul mondo. Tra questi linguaggi, primario è il mezzo metropolitano dei mass media: la stampa, la radio, il cinema e la televisione. Proprio questi media consentono e avvalorano la base astratta del “luogo” nella narrazione della “collettività immaginata” della nazione. Proprio questi media operano la fusione di memoria e identità in iscrizioni che acquistano la firma della storia. Tuttavia allontanarmi dallo schermo, abbassare gli occhi e ritirarmi dalla presunzione ontologica, tanto cara a molti in Occi- ESTRANEO IN CASA dente, che la verità sia rappresentazione, significa rivolgere l’attenzione a un senso del luogo, della storia, dell’identità provvisto di fondamento. Significa rivolgersi a un senso del luogo meno presente nello spazio piatto, bidimensionale della mimesi e del campo visivo panottico della conoscenza, del potere, ma più presente nell’ineguale configurazione della terra, in cui vengono innalzati questi schermi e le loro particolari proiezioni. Localizzando la rappresentazione, processo in cui l’ambiente impregnato di storia sostiene ben più della sua concezione astratta, il linguaggio non è un’imposizione unilaterale su uno spazio vuoto, bensì riecheggia sulla terra, rimbomba in un ambiente, riverbera nel ritmo terreno, si piega in sonorità sociali e nella risonanza terrestre (Gilroy 1993a). Ciò detto, mi rivolgo all’opera visiva di Hélène Hourmat: artista contemporanea, di origini marocchine, cresciuta in Francia. Donne in abiti nordafricani, uomini in abiti occidentali, scene familiari e ritratti di strada: le composizioni miste della Hourmat, eseguite mediante fotografia, pastello, cartoline e inchiostro, raffigurano il viaggio, tanto il viaggio fisico quanto i complessi itinerari culturali, dell’identità nazionale, etnica e di genere da una costa all’altra del Mediterraneo, di un mondo (ebreo, marocchino e magrebino) all’interno di un altro (europeo, francese, cosmopolita), tra i linguaggi e i limiti dell’inquadramento visivo. Questa corrispondenza visiva insiste sulla traiettoria storica precisa di una configurazione culturale apparentemente periferica nella grammatica deterritorializzata della modernità. Prende in considerazione entrambe trasformandone le rispettive storie in un elemento di libertà. Opere di questo tipo invitano a penetrare nell’inconsueto, non nel nome di un’eccitazione passeggera per l’esotico e dell’attrazione temporanea per l’alterità, bensì per defamiliarizzare i linguaggi che ci fanno conoscere il mondo, che lo sottomettono e lo rendono nostro; in questa maniera i linguaggi rendono l’ordinario straordinario, perturbante, e incontrano la repressione violenta che legittima il nostro discorso. Significa intercettare la discussione del nesso globale-locale, e la glossa esplicativa della modernità e della modernizzazione, con atteggiamento scettico nei confronti della teleologia inevitabilmente implicata nella comprensione di questi processi. IAIN CHAMBERS Poi c’è un video (Chambers 1993). C’è un video in cui compaiono sullo schermo le seguenti scritte: In un’epoca in cui l’antropologia si trasforma sempre più in autobiografia, l’osservatore, cercando di catturare, inquadrare un altro luogo, viene ora imprigionato nella rete dell’osservazione critica. L’occh-ìo (organo fisico e stato soggettivo) raggiunge il linguaggio in esilio. La nostra casa linguistica viene disfatta, le parole migrano e il linguaggio si fa ibrido per mostrare lacerazioni nelle mappe e balbuzie nei discorsi che noi in Occidente siamo soliti utilizzare. È come se fossi precipitato in una piega del tempo, inciampando in un punto brusco della narrazione, mentre la mia presenza, che una volta scorreva in apparenza senza sforzo sulla carta geografica, viene accorciata, sviata, distrutta, dispersa. Il viaggio, sia in campo metaforico che fisico, non può più essere considerato una cosa che conferma le premesse della mia partenza iniziale, che si concluda con una conferma, una sottomissione della differenza e della deviazione. Questa dichiarazione si accompagna con l’immagine costante di un uomo provvisto di telecamera, riflessa nei finestrini di un treno: l’osservatore osservato, la prospettiva, esterna, oggettiva restituita e trasformata nel punto di vista interno, soggettivo. Queste parole e immagini provocano la posa autoriflessiva da parte dell’interrogativo dello sguardo antropologico. Oppure, forse la voce di cui sopra è soltanto il luogo ingannevole di uno stratagemma teorico: la sottile messa in atto del proprio decentramento per potersi nuovamente centrare. Senza dubbio, svela l’ambiguità di un potere che parla della propria perdita. Proprio su questa ambiguità, sul valore dell’incertezza, occorre insistere. Poi c’è l’uomo con la telecamera che cerca di catturare e inquadrare visivamente il mondo. La telecamera, il video, introduce l’esempio preciso del potere visivo in cui la realtà e la rappresentazione della verità vengono considerati una cosa sola nella metafisica del realismo. Ciò che non rientra nel campo visivo, nelle sue procedure e nella sua logica della rappresentazione, non riesce a diventare conoscenza. Il linguaggio della trasparenza e l’egemonia oculare si uniscono in una relazione di soggetto-oggetto, nonché nella comprensione ESTRANEO IN CASA unilaterale del significato e della verità, che riconferma il soggetto; si tratta di una comprensione che ha moto unidirezionale, dall’occh-ìo al mondo percepito come oggetto esterno. Tuttavia al potere dello sguardo si accompagna anche un intrinseco insuccesso, l’incapacità di ascoltare, di sentire e di rispondere. Si tratta di una forma di conoscenza che né chiede né accetta una risposta. Percorrere criticamente questa strada significa dare il via al processo di antropologizzazione dell’Occidente, al fine di “dimostrare quanto sia stata esotica la sua costruzione della realtà (Rabinow 1986). Vorrebbe dire scavare nella tendenza teorica che ha tentato, storicamente, di catturare e spiegare la realtà senza esserne incorporata. Si perseguono la distanza critica, l’oggettività scientifica e l’ordine estetico, mentre si evita il paradosso dell’“oggettività” di un punto di vista specifico ubicato nella parzialità di una storia e del linguaggio partigiano di una cultura (Geiger 1998). L’apparente libertà dell’osservatore svela involontariamente i confini intellettuali in cui viene trattenuto a sua insaputa. Storicamente, è la logica visuale che emana dal centro che guida la visione delle cose, la quale è stata unilaterale e oggettivante nei suoi effetti. Lo sguardo, però, può essere restituito, per mettere a disagio l’osservatore. Registrare la possibilità di un siffatto ritorno significa aprire la distinzione dirompente tra lo sguardo che tutto abbraccia (l’oggettività soggettiva del cogito) e la visione reattiva, la quale incontra resistenza e opacità, fastidio e confusione, un riflesso sporco nella retina. Significa disfare la distanza critica tra il soggetto che tutto vede e l’oggetto inerte (la distanza che rende possibile il possesso), con un intervallo che rimane incolmabile, una separazione instaurata e mantenuta dalla finitezza della mortalità, dai limiti della collocazione e dall’ubicazione di un corpo, di una voce, di una storia. Nel passaggio tra l’appropriazione fiduciosa del mondo, associata alla scienza moderna, e un riconoscimento assai meno fiducioso, più barocco, emerge una modalità della percezione che fa appello all’abitare e al movimento del mondo che non si limita al cogito. Si tratta di una prospettiva che tende a guardare al di là della tirannia strumentale di un punto di vista unico che vede nella terra, nelle storie e nei corpi degli altri semplici oggetti di cui disporre a piacimento (Carter 1996, pp. 303-304). IAIN CHAMBERS Questo ci riporta all’assillante domanda dell’antropologia, che non si può semplicemente ridurre a una questione di colpa o responsabilità. Si tratta piuttosto di un sintomo significativo delle tradizioni istituzionali e disciplinari dell’Occidente: quell’insieme eterogeneo di tesi e orientamenti critici che, però, acquista un’unità contingente e un’epistemologia condivisa nelle configurazioni della modernità e del “progresso” occidentale e porta il resto sotto gli occhi dell’Occidente. L’antropologia occidentale è il legislatore storico del traffico tra i mondi. Una disciplina di confine, che ha centrato nella maniera più esplicita il soggetto occidentale stabilendo la distanza temporale e culturale tra un “noi” e un “loro”. Nondimeno questa tendenza del desiderio e della paura, per quanto esposta in maniera più evidente nei protocolli dell’antropologia, non è prerogativa di questa disciplina: è sedimentata nel cuore stesso delle scienze umane e sociali, nei metodi, nelle modalità e nei mezzi per comunicare e spiegare il mondo. Ne consegue che la crisi dell’antropologia (nonché il richiamo della vicinanza etimologica della crisi nella pratica e nella teoria critica) diventa significativa per tutti coloro che agiscono nell’ambito di questa disposizione della conoscenza. Se, a questo punto, l’antropologia occidentale diventa l’antropologia dell’Occidente, o forse più precisamente l’antropologia dell’occidentalizzazione del mondo, la possibilità che ci resta non è solo quella di contemplare narcisisticamente il nostro ombelico e riprodurre la nostra centralità in un linguaggio elegante. Si apre anche la strada al più arduo e ambiguo lavoro e impegno che consiste nell’indebolire e dislocare quella tendenza della conoscenza e del potere che, con le sue tecniche e tecnologie per catalogare e riordinare la realtà, ha storicamente mondeggiato il mondo per creare le categorie e le “verità” di centro e periferia, progresso e sottosviluppo, civiltà e primitivismo, “Primo” e “Terzo” mondo, Occidente e resto del mondo. Non è possibile cancellare una storia del genere, ma è possibile riscriverla e rielaborarla. È possibile ri-citarla per ri-situarla, per cavare dai denti della modernità occidentale la sua potenziale critica e la suo potenziale dislocazione. Vorrebbe dire registrare e ascoltare come i suoi linguaggi, le sue tecnologie e le sue tecniche vengono vissuti in altro modo, e infine vissuti dagli altri. ESTRANEO IN CASA La sfida dell’incompleto Naturalmente, possibilità e potenzialità di questo tipo devono trovare la loro collocazione nello scambio iniquo iscritto nella differenziazione di capitale economico, culturale, storico e politico. La risposta dalla periferia, il silenzio del subalterno, dipende da un’economia del riconoscimento che esclude mentre include. Non tutti vengono compresi in questo racconto. Non tutti sono nella posizione storica di tradurre, trasformare, sopravvivere e tirare avanti. Ci sono sconfitte, perfino la minaccia e la consapevolezza di cadere nell’oblio, di rimanere nel vuoto dei margini, nel silenzio dei linguaggi che vengono parlati, cantati, scritti e registrati. Eppure, la persistenza di queste tematiche, i limiti insuperabili del luogo da cui si parla, ci attirano in quegli spazi, verso i vuoti e i silenzi che interrogano il nostro linguaggio e ci investono con la richiesta di una risposta. Perché è anche possibile che le risorse del silenzio rendano gli altri, nella loro separatezza, irriducibili a una sintassi comune (Cheung 1993). L’intervallo del taciuto, le ombre dei subalterni, degli usurpati, vengono gettate contro la trasparenza di un linguaggio avvezzo a ignorare l’ontologia del silenzio, un silenzio che inevitabilmente viene colonizzato come assenza pura, carenza pura. Al di sotto delle carte geografiche, delle topografie e delle geografie del potere e dello spazio, si palesa ciò che sfugge o rifiuta di essere segnato sulla carta: la sfida del luogo nei confronti dello spazio, del suono nei confronti della visione, della proliferazione delle ragioni nei confronti del razionalismo, del silenzio sulla scia di ciò che viene detto. Tra la cornice visiva, tra ciò che viene rappresentato, ritratto, e la contingenza di ciò che non riesce a essere rappresentato, compare un vuoto, un intervallo, un’interruzione. È il luogo inquietante di questo nello spazio della cornice che svela l’incidenza storica e l’individuazione dell’essere variegato. C’è un’enorme differenza, direi, tra un soggetto stabile, anche se in continuo movimento, e un soggetto irrimediabimente sconvolto. Le soggettività sicure di sé possono spostarsi per il mondo, e lo fanno, da uomini d’affari cosmopolitani e da intellettuali, sperimentando interazioni simboliche in cui la propria cultura e identità viene messa raramente in discussione. Ma allora, la psiche occidentale è davvero in crisi? Il suo modo di pensare e il suo IAIN CHAMBERS slancio istituzionale risultano davvero indeboliti? Oppure si tratta soltanto di una messinscena per riprodurre sotto forma di contraddizione le egemonie prevalenti? Qualunque sia il verdetto finale, ciò che ho da dire vuole mettere a fuoco i limiti e le località dei processi della globalizzazione e identificazione, rendendo discutibili le premesse umanistiche da cui dipende gran parte di questa modalità di pensiero, di razionalismo e di politica. Avvezzi a riferirci alla complessità, apparentemente crescente, dei linguaggi dell’identità e dell’identificazione, dell’essere e del divenire, al contempo veniamo attratti verso la costanza della psiche, quell’“io” che racconta la narrazione del sé, la quale comunque sia interpellata, trasformata, frustrata, danneggiata, prosegue in una maniera resa certa dai meccanismi della memoria, dalla repressione e dalla sublimazione: continua a insistere, a prescindere da quanto sia frantumato il mondo che abita. In questo modo si apre una prospettiva in cui forse devo chiedermi se le identità di oggi siano davvero più complesse, per esempio, di quelle della modernità emergente dell’Europa seicentesca e delle certezze tentennanti del mondo barocco, con le sue violente affermazioni e il suo dissenso su argomenti cosmologici, religiosi e secolari; e questo solo per parlare di un mondo, di una storia, di una cultura di cui in qualche modo sono consapevole. Pertanto, io provo una certa esitazione dinanzi alla teleologia proposta per il progresso, secondo cui il mondo d’oggi sarebbe automaticamente più complesso di quello di ieri, e quindi anche le identità. Forse, è più prudente esprimersi in termini di articolazione e configurazione, di complessità mobili che esprimono certe verità mentre ne annebbiano altre, dei linguaggi modificati delle identità, di orizzonti d’attesa diversi anziché di un semplice accumulo di conoscenza. Anche l’inconscio (la ragione che viene, alla fine, repressa dalla ragione) non è uscito armato dalla testa di Freud: aveva già trovato espressione, come lo stesso Freud ha ribadito a più riprese, nel linguaggio poetico. A questa oscillazione della modernità, forse potrebbe essere utile aggiungere la voce del compianto Raymond Williams, che ha incoraggiato a riflettere sulle impari e complesse combinazioni culturali di elementi emergenti e residuali, che conducono a nuove configurazioni, in cui sia la “tradizione del nuovo” che le tradizioni del passato vengono rielaborate spesso secondo combinazio- ESTRANEO IN CASA ni inattese, svelando una grande gamma di poteri e possibilità (Williams 1977, pp. 110-118). Tra la costanza psichica e la posizione storica, l’identità non emerge come una serie di abiti da indossare e buttare a piacimento, bensì come una composizione mobile in cui elementi differenti vengono portati in primo piano o spostati sullo sfondo, a seconda delle circostanze, delle coincidenze, talvolta per scelta consapevole. L’identità non è né libera di fluttuare, né eternamente fissa sul posto. Proprio nell’intervallo tra questi poli ha luogo la storicità radicale dell’identità, in cui le strutture forniscono la scena per ciò che non è sempre prevedibile, e l’istanza dell’essere storico turba la coesione di qualsiasi razionalità singola. È qui (ora arriviamo al nodo cruciale della mia argomentazione), proprio qui che affrontiamo l’oggettività incentrata sul soggetto dell’umanesimo, nonché la presunzione che la conoscenza sia qualcosa da immagazzinare e accumulare a beneficio dell’“io”, e la conseguente rivelazione nella ragione istituzionale. Di fronte all’“unità immaginaria” dell’identità che cerca di controllare e di limitare i linguaggi del mio divenire, mi trovo a ribadire non soltanto la persistenza interrogativa dell’inconscio, ma soprattutto la connessa insistenza sull’essere del linguaggio che mi precede e va al di là di me, che rimane irriducibile alla volontà di volere, alla volontà di potere e di conoscenza. In termini intellettuali, tentiamo tutti di catturare la pienezza, la totalità delle cose, rifuggendo dal non finito, da ciò che, citando Adrienne Rich (1991, p. 44), rimane là, insoddisfatto, nei nostri racconti. Tutti aneliamo a questa immagine coerente e alla soddisfazione della nostra mappa cognitiva, ma forse esistono anche il modo e la necessità di registrare i limiti di queste immaginazioni. Questo renderebbe possibile a ciò da cui ci allontaniamo – il mondo mai finito in cui viviamo – di insistere sul suo diritto di esistere: ciò che non siamo in grado di quantificare e definire immediatamente, ciò che oppone resistenza alla rappresentazione tecnica della realtà, e che pure insiste e persiste a interrogarci. Questo eccesso o supplemento che sta al di sotto, lungo e al di là della nostra appropriazione delle diverse identità storiche (da quella nazionale a quella sessuale), è un’alterità che rimane in attesa di tendere un’imboscata alle procedure fiduciose della rappresentazione culturale, distruggendone la grammatica e i codici IAIN CHAMBERS prescrittivi: un potenziale pronto a turbare l’impianto esistente del “politico”. Qui il linguaggio cinge la centralità della narrazione – narrare la nazione, narrare noi stessi – nel problema dell’identità. Benedict Anderson, Stuart Hall e Homi Bhabha: nei loro diversi approcci rimane l’attenzione comune alla continuità della narrazione nella comprensione dell’identità nazionale. Proprio questa continuità consente alla coerenza di manifestarsi, tiene a bada il turbamento e struttura la contestazione, consentendo che una vasta serie di elementi venga assorbita nel quadro organico e nella crescita naturale della nazione. L’organico, col suo senso delle radici, delle origini, della crescita, del cambiamento e della continuità, della tradizione e della trasformazione, offre la costellazione mitica che, come ha affermato una volta Roland Barthes (1973), trasforma la storia in natura. Forse questa è una configurazione apparentemente più consona al Vecchio Mondo, in cui il linguaggio, il sangue e l’appartenenza sembrano sgorgare già maturi dal suolo natio, dove le identità nazionali vengono concepite in termini di sovranità anziché di diritti, di affinità invece che di contratto. Tuttavia l’eredità egemonica è all’opera ovunque: una cultura nazionale acquisita (il suo linguaggio, la sua storia, le sue tradizioni e i suoi riti) viene sempre considerata meno di quella che si ha dalla nascita (Hage 1996, p. 467). Le linee di sangue e l’etnicità hanno sempre la meglio sul contratto e sul consenso. Estraniare l’Occidente Il punto centrale, quando si pensa alla narrazione della nazione, in tutte le sue varianti, è il modo in cui, nel rendere conto del passato, si finisce con l’espungere l’insita violenza su cui si fondano la nazione stessa e la modernità occidentale. La violenza viene sempre scaricata altrove, su un altro paese, su un altro mondo. Nel suo lavoro intitolato Storm from Paradise: The Politics of Jewish Memory, Jonathan Boyarin (1992) si sofferma sul paradosso dell’obliterazione e della dislocazione del genocidio nella creazione di uno Stato nazionale, in questo caso il genocidio dei nativi americani in un paese nella cui capitale si trova un museo dedicato all’Olocausto. ESTRANEO IN CASA Nella ben architettata coerenza delle identità nazionali traspare la necessità strutturale dell’“altro”. Al di là della brutale ovvietà del potere imperiale, questo fatto conferisce alla formazione e all’esperienza del colonialismo e dell’imperialismo un ruolo cruciale nella comprensione della modernità e delle identità moderne, sia nazionali che culturali, sia pubbliche che private, sia storiche che esistenziali. La migliore descrizione di quanto appena detto ci viene fornita da Catherine Hall (1992) nelle sue analisi della costruzione del concetto di virilità bianca britannica nel diciannovesimo secolo. Il discorso che vorrei fare, tuttavia, non è di natura morale, bensì strutturale. La modernità occidentale è una formazione ibrida fin dalle origini, come testimonia la magistrale ricostruzione di Paul Gilroy (1993a) della centralità delle culture schiave dell’Atlantico nero in tale formazione. Oppure, in scala diversa, sulle rive di un oceano diverso, c’è la costituzione ibrida della California, in cui le storie celate e le narrazioni taciute del lavoro fisico, economico, culturale e politico dei nativi americani, dei messicani, dei chicani e delle chicane assumono un ruolo centrale, come nell’opera storica di Beth Haas (1995) e nei romanzi di Alejandro Morales (1992). In questo modo, quindi, si asserisce tra le righe che il tanto discusso postcoloniale non riguarda tanto l’ibridazione della cultura contemporanea, la diversità che emerge dall’analisi metropolitana – che sia nell’apparente innocuità di stili musicali, letterari, sartoriali e culinari, oppure nella più immediata insistenza di una politica della minoranza – ma è l’imperativo di rivisitare e riscrivere la stessa modernità occidentale: farla parlare nuovamente, farle dire qualcosa che non vuole né desidera dire. Come ribadisce a più riprese Hannah Arendt ne Le origini del totalitarismo (1951), il cuore del moderno, del metropolitano, è stato costituito dallo sfruttamento esterno imperialista. È proprio questa storia deviata, in cui l’etica cede il posto all’economia e il diritto e il liberalismo cedono alla licenza in luoghi apparentemente remoti, che perseguita come un fantasma l’Euroamerica nelle sue tendenze razziste e totalitarie (Prakash 1996, p. 187). In questo ritorno del represso, l’impatto tra mondi e culture diversi che penetrano nell’Occidente cede il posto alla sfida ben più radicale dell’estraniazione dell’Occidente. È a questo punto che noi potremmo considerare il passaggio dal multiculturalismo e da un IAIN CHAMBERS adattamento liberale della diversità a un diverso modo d’essere nel mondo in cui si punti sul vivere nella diversità, in un’epoca planetaria in cui l’Occidente che è diventato il mondo si scopre, malgrado i suoi inalterati poteri economici, politici e cultuali, che non è più padrone di se stesso. Per dirla con Gyan Prakash (1996, p. 201): Sulla base della convinzione che non possiamo dire di no alle condizioni determinate della storia (la modernità capitalista, i principi di libertà, cittadinanza, diritti individuali, Stato-nazione), la critica postcoloniale tenta di identificare nello slittamento del funzionamento storico di questi principi la base per altre articolazioni. Nel mondo del capitale transglobale e dei flussi di informazione, l’accelerazione della vicinanza non conduce necessariamente a un indebolimento delle identità precedenti: il contatto può anche implicare una ripresa delle distanze e un rafforzamento, da ambo le parti. Oggi siamo testimoni di certe identità nazionali, regionali e persino di carattere più circoscritto che vengono annunciate e sostenute dall’inserimento e dalla resistenza alla globalizzazione. Analogamente, gli esperti di scienze politiche e i teorici del diritto dubitano spesso che i moderni Stati nazionali come gli Stati Uniti o i paesi dell’Europa occidentale stiano effettivamente cedendo la propria sovranità, e non stiano invece dispiegando, strategicamente, in maniera diversa i propri poteri nell’ambito del gioco globale (Bromley 1996). L’utilizzo delle zone di confine (per esempio, tra gli Stati Uniti e il Messico), che consentono esperimenti e sfruttamento economici, e al contempo riconfigurano e confermano la sovranità nazionale su ambo i lati della frontiera, è un caso emblematico. Analogamente, il concetto del nazionale rimane un elemento fondamentale per rivendicare un luogo nella struttura internazionale del globale, segnatamente per assicurare posti di lavoro, mercati e ciò che per molti resta l’ultima, disperata, soluzione: gli aiuti internazionali (Buchanan 1995). Naturalmente si tratta ancora una volta di una configurazione complessa, in cui il potere non si sposta semplicemente con moto unidirezionale, dall’alto verso il basso. Tra il martellamento pedagogico dell’identità nazionale promossa dallo Stato e le realtà quotidiane di identificazione con le possibilità mediate che si riscontrano nei linguaggi delle strutture economiche, storiche e cul- ESTRANEO IN CASA turali, essa indica che, per quanto possa essere potente, la globalizzazione si accompagna sempre con procedure di ri-localizzazione (Kevin Robins, citato in Hall 1996, p. 623). Analizzando il ruolo delle telenovele californiane (utopie d’importazione) nella televisione italiana, Lidia Curti ha studiato la trasfigurazione del globale in termini e in ambiti locali, nella presentazione (contingente eppure abituale e materiale) della vita quotidiana italiana e napoletana. Una cultura nazionale e locale non è solo soggiogata, ma a sua volta soggioga e trasforma ciò che importa o che addirittura sembra che le venga imposto (Curti 1990). Avviene, come sostiene Rey Chow nel suo studio del cinema cinese contemporaneo, una traduzione reciproca, in cui la disparità di potere tra l’Occidente e il resto del mondo rivela nondimeno la trasformazione di entrambi i membri dell’equazione assieme alla ricollocazione di globale e locale, moderno e tradizionale; nessuno dei due rimane solamente oggetto dell’altro, ognuno è soggetto alle iscrizioni prive di sicurezza della traduzione culturale e del transito storico (Chow 1995). La modernità diviene locale e il locale pone le basi della modernità. Sia in Le vie dei canti (1987) di Bruce Chatwin che in Bad Aboriginal Art (1994) di Eric Michaels, sottotitolato Tradition, Media, and Technological Horizons, si trovano ampie descrizioni e osservazioni della cultura aborigena australiana, intenta a negoziare le proprie entrate e le proprie uscite dalla modernità occidentale, a trasformare lo spazio occidentale in luogo locale (tele destinate a gallerie d’arte internazionali scambiate per una Toyota Land Cruiser). Le opere che ritraggono i sogni sacri ancestrali divengono opere d’arte, i loro significati locali sono trasformati in altri linguaggi mentre al contempo continuano a esistere, proprio come la tecnologia occidentale viene trasformata per fornire i mezzi di sostentamento di una cultura locale nell’ambito della modernità in termini che non sono tutti opera della modernità. L’artista Cherokee Jimmie Durham, definendosi “primitivo postmoderno”, ci costringe a pensare a una traduzione che non è unilaterale, che attiva e sfida entrambi i versanti dello spartiacque culturale. Quanto detto sembrerebbe indicare, come asserisce Stuart Hall (1996), che invece di concepire il globale come un’imposizione sul locale da parte dell’Occidente, sia meno debilitante e importante considerare il modo in cui il globale emerge e si articola nel locale IAIN CHAMBERS (p. 623). In altre parole, in che modo il potere del globale contribuisce all’articolazione del locale e come, in questo processo, affronti la trasformazione, la resistenza, il sovvertimento e la dispersione. Ecco che insistono e persistono altre storie nella configurazione stessa della terra, per citare Paul Carter (1996), nell’aspetto delle cose che costituiscono un luogo occupato, una località in cui la storia e il linguaggio si amalgamano con il paesaggio, per citare il lavoro di Kathleen Stewart (1996). Questo ci aiuta a concentrarci sulla differenziazione della traduzione nella negoziazione e nella vita nelle geometrie del potere. Esistono contatti e contratti ben diversi tra le élite metropolitane e nella vita, le popolazioni rurali nullatenenti, per fare un esempio ovvio, e le loro rispettive relazioni con la modernità nella fase attuale della globalizzazione. Ho detto la fase attuale della globalizzazione perché considero questo processo parte integrante della modernità, dove la modernità, come insiste Heidegger, segna l’avvento dell’“immagine del mondo”: non una nuova immagine del mondo, bensì la possibilità di concepire il mondo, per la prima volta, come un’immagine, di incorniciarlo, di ridurlo a un unico punto di vista. Si tratta del punto di vista unico su cui l’umanesimo soggettivo, il cogito razionale, basa la sua oggettività e intende la realtà. Qui l’intera realtà viene inquadrata cognitivamente perché appaia dinanzi al soggetto come oggetto, pronto a essere afferrato e soggiogato, ricondotto nell’ambito della sua sovranità e del suo controllo. Tutto viene reso immediato nei calcoli che rappresentano me e soltanto me. È quella narrazione e la sua grammatica dell’agire, in cui il soggetto storico non può mai essere estraniato, che il ripensamento del mondo, o un diverso modo di mondeggiare il mondo, cominciano a interrompere. A questo punto si ripropone drammaticamente il giudizio di Jean-Paul Sartre (citato in Prakash 1996) sull’opera di Frantz Fanon, definita uno “spogliarello del nostro umanesimo”. L’occidentalizzazione del mondo, ossia la modernità occidentale e la formazione del suo soggetto storico (che oggi talvolta viene sfidato, minacciato, esposto al dubbio, ma che è sempre al centro di quella narrazione che si chiama Storia, e si sta ri-storicizzando) viene anche paradossalmente localizzata, spinta contro i suoi limiti. La sua voce, il suo occhio, ciò che le permette di parlare e di definire, scaturisce da una posizione culturale e da una formazione storica particolari, che una volta consideravano, e spesso ESTRANEO IN CASA ancora considerano, il loro linguaggio “universale”, e spesso, a beneficio dell’egotismo, confondevano, e ancora confondono, il razionalismo con la ragione. Insistere su questi limiti storici, che sono anche limiti ontologici, significa dis-locare e ri-allocare l’Occidente e i suoi linguaggi (la sua modernità, l’universalismo, l’umanesimo, l’identità, la soggettività e l’agire) in un’altra storia. Quantomeno, significa registrare come questi concetti, nonché le storie della loro appropriazione dello spazio globale e del potere storico, vengono vissuti variamente, esperiti seguendo ritmo e accenti diversi. Inserite nel mondo eterotopico per divenire parte di un luogo, le asserzioni iniziali diventano soggette a enunciazioni multiple e contemporanee, che non offrono una soluzione semplice, bensì richiedono un passaggio politico tra conservazione e riconfigurazione, tradizione e traduzione, esclusione e inclusione. Capitolo settimo Sulla soglia Dinanzi a noi si apre una nuova strada, alle nostre spalle si chiude un sentiero. La neve ricopre le nostre tracce e continua a muoversi come la marea. Non c’è traccia di dove eravamo, né alcun segnale che indichi la nostra destinazione. Ora siamo il battito senza passato, la luce invisibile, il pensiero senza parole da dire. Acqua versata, fiammifero acceso. Dinanzi al nulla, noi siamo l’istante. Louise Erdrich (1995, p. 259) Non posso né prenderla né perderla Quando taccio, essa proietta Quando proietto, essa tace. Trinh T. Minh-ha (dal film Naked Space – Living is Round) Agosto, più di quaranta gradi all’ombra. Mi trovo sul limitare del Canyon di Chelly nell’alto deserto dell’Arizona e osservo la Roccia della Donna Ragno. Il terreno sotto di me si apre drammaticamente in un burrone a forma di Y che solca per miglia la faccia della terra. Fu proprio la Donna Ragno a insegnare ai Navaho l’arte della tessitura. Tutti i pellerossa del mondo sembrano concentrati in questo stretto sperone di roccia che si erge per centinaia di metri direttamente dal fondo del canyon. Un falco si libra in cielo prima di scomparire oltre il confine del mondo. Questo incontro di terra e cielo, di divinità e mortali (la “quadratura”, o das Geviert di cui parla Heidegger) sembra alludere all’indivisibilità dell’essere. Eppure questo spazio in apparenza comune, questo tempo condiviso, questa risonanza arcana tra un luogo sacro dei navaho e Martin Heidegger svela un’impossibilità: quella di ridurre ciò che non si può ridurre, di appiattire le differenze del paesaggio, del linguaggio, della cultura e della storia sui contorni condivisi di una carta geografica comune. Forse proprio questa irriducibilità è ciò che palesa nello stato stesso del nostro divenire quanto tutto ciò sia meraviglioso. In questo luogo, riconoscendo nei campi coltivati e nelle abitazioni o hogans dei Navaho sul fondo della vallata, come nelle rovine antiche degli Anasazi attaccate alle pareti del canyon, la comune e più intrattabile IAIN CHAMBERS di tutte le necessità umane – la vita – il mio tempo e il mio spazio si interrompono bruscamente: vengono messi in discussione da una presenza che non ha nulla di mio. Mentre mi allontano in macchina sotto un cielo che ci sovrasta tutti, questa spaccatura che taglia la traiettoria del mio percorso, questa piega nella carta geografica, mi trascina al di fuori di me stesso. Viaggio attraverso una fessura nel mio tempo, un vuoto nei concetti di identità e posizione, tentando di estrarre dai miei limiti le possibilità di nuove partenze. Sull’orlo della cornice A una mostra tenutasi a Houston nel 1995, intitolata Cultural Baggage (Bagaglio culturale) e organizzata nell’ambito di un simposio su House, Home, Homeland (Casa, abitazione, patria), mi imbattei in due opere che mi hanno aiutato a localizzare il punto di partenza del mio pensiero in questa fase della mia vita1. La prima è The South/Missing (Il Sud/Assente 1993) di Silvia Malagrino, l’altra è Re:Locations (Ri: Posizioni, 1995) di Monica Chau. Nel trittico della Malagrino vediamo fotografie di volti appena visibili: si tratta dei visi, delle identità di chi generalmente viene dimenticato dalle statistiche dell’immigrazione illegale e nei rapporti delle pattuglie di frontiera. Si tratta di foto che svaniscono, accartocciate nel tempo, eppure le loro tracce rimangono impresse in maniera indelebile nella gelatina argentea della stampa, come fossero spettri che rifiutano di scomparire. Continuano a occupare la scena, gettando l’ombra di un altro mondo che si ripropone per sfondare e increspare le superfici lisce di una coerenza desiderata. Nella serie di fotografie digitali di Monica Chau, si incontra la testimonianza della sovrapposizione di immagini di un’epoca precedente su un paesaggio desolato che riconfigura lo spazio in un luogo storico particolare. Le figure che vediamo sono quelle di cittadini statunitensi di origine giapponese che nell’aprile del 1942 furono rinchiusi in campi di concentramento come quello di 1 House, Home, Homeland: A Media Studies Symposium on Exile, Rice University, Houston (Tex), 26-29 ottobre 1995. L’evento in questione ha dato il via a queste riflessioni. Vorrei approfittare di questa occasione per ringraziare Hamid Naficy per avermi invitato a prenderevi parte. SULLA SOGLIA Manzanaa, presso Lone Pine, vicino alla Valle della Morte, nel deserto californiano. Questa particolare configurazione dello spazio e della memoria mi è tornata prepotentemente alla memoria vedendo l’installazione di un campo di concentramento (provvisto di caserma, torre di guardia, riflettore e filo spinato), collocata di fronte al Museo Americano Giapponese nel centro di Los Angeles nell’autunno del 1995. Questa collocazione proprio accanto al Museo Temporaneo Contemporaneo ha posto ancor più in rilievo le coordinate inquietanti della memoria e dell’oblio, della rappresentazione e della repressione, dell’arte e dell’agonismo dell’identificazione. Vorrei aggiungere a queste inquadrature visive alcune espressioni, alcune parole, attinte dal romanzo di Leslie Marmon Silko Ceremony (1977) sulla sopravvivenza dei nativi d’America nella modernità: “Mi sembra buffo” disse lo sciamano, scuotendo la testa, “che la gente si chieda perché io viva così vicino a questa sporca città. Ma, vedete, questo hogan era qui da prima. Costruito molto prima che arrivassero i bianchi. È quella città laggiù che è fuori posto. Non questo vecchio sciamano” (p. 131) Passando da Gallup, New Mexico, ai Caraibi, posso aggiungere anche la voce di Vidiadhur Surajprasad Naipaul, il quale fonde le storie dei bucanieri elisabettiani, dei rivoluzionari dell’America Latina e dei radicali neri “ai confini del mondo” (1995, p. 207). Lì i diversi, gli spossessati, i diasporici – coloro che sono fuoriusciti dal mondo conosciuto o che ancora non vi sono entrati – recano testimonianza dell’altro lato della modernità, i cui confini sono segnati dallo sterminio, dalla schiavitù, dal massacro, dalla follia, dall’avidità, dall’insuccesso e dalla perdita. Qui si svolge la conversazione immaginaria tra il nativo americano Don José e il sacerdote spagnolo Fray Simón. Don José, nato in Guyana, è stato fatto prigioniero dagli inglesi a San Thomé sull’Orinoco e accompagna Sir Walter Raleigh nel viaggio di ritorno in Europa, fino all’arresto e all’esecuzione dell’inglese. A quel punto ritorna in America Latina. Fray Simón sta scrivendo una storia della Nuova Spagna. La conversazione ha luogo nel 1619: IAIN CHAMBERS Fray Simón disse: “Avete attraversato due volte l’oceano, e adesso rieccovi a Nuova Granada, la vostra città natale. Non vi siete perso. Le navi sapevate sempre dove andavano. Pensando al terrore che avevate un tempo degli oceani, come vedete le cose, adesso?” “Ci ho pensato molto, padre, e credo che la differenza tra noi indiani, o mezzo indiani, e gente come gli spagnoli, gli inglesi, gli olandesi, i francesi… gente che sa andare dove va… credo che la differenza stia nel fatto che per loro il mondo è un luogo più sicuro” (p. 251). Sapere dove si va, tracciare fiduciosamente la carta geografica del mondo e renderla uno spazio domestico e un “luogo più sicuro” è l’espressione di una particolare formazione storica. Qui la rappresentazione del soggetto e le rappresentazioni del mondo diventano una cosa sola: un solo quadro racchiuso nella cornice astratta della ragione e nella rassicurazione universale di un umanesimo che ha per centro il soggetto. La descrizione di Naipaul perfora quella carta geografica e le sue fiduciose appropriazioni del mondo, invitandomi a considerare ciò che si trova sull’altro lato del quadro. Qui, nell’infrangere la legge soggettiva di un’egemonia visiva, viene spiazzata in maniera determinante la premessa che “la verità diventa certezza del rappresentare stesso” (Heidegger 1950a, p. 84). Nella riscrittura, nel cambio di rotta di una particolare storia caraibica, l’evento letterario svela una deviazione nella logica della rappresentazione: questo mi spinge a considerare non solo ciò che viene esposto, rappresentato, ma anche ciò che sta dietro la visuale, che rimane nell’ombra, che continua a non essere rappresentato. In ciò che sta dietro e che non viene rappresentato, l’evento dell’arte rivela un’interruzione nella linearità del “progresso” temporale, che perturba la rappresentazione della “verità” come accumulo cristallino e razionale della “conoscenza”. Su questo ciglio, lungo questo confine fra tranquillità e dispersione, si palesa uno spazio distruttivo, un territorio esotico, una soglia in cui la comprensione precedente cede il posto a una nuova configurazione: Cuando vives en la frontera la gente ti cammina accanto, il vento ti ruba la voce, sei una burra, buey, capro espiatorio SULLA SOGLIA precursore di una nuova razza, mezzo e mezzo (sia donna che uomo, nessuno dei due) un genere nuovo… (Anzaldúa 1987, p. 194). Possesso La scrittura, le parole, il linguaggio… tutti propongono viaggi in uno stato di vulnerabilità in cui le storie subiscono l’influsso di controcorrenti di un mondo più ampio e ambiguo. Qui, nell’inclemenza del potere e della gerarchia, alcune storie sopravvivono, sospinte verso la spiaggia del riconoscimento istituzionale, in cui vengono riconosciute, tradotte, travestite, contestate, assimilate, incorporate. Altre rimangono alla deriva, apparentemente perdute nel pelago della memoria incerta, lungi dalle coste del riconoscimento, fuori dalla vista e dall’ascolto. Forse proprio la metafora della terra firma e del mare, della relativa stabilità del terreno sotto ai piedi contrapposta alle correnti e agli umori ondivaghi delle acque, dimostra nella maniera più efficace i limiti del mio linguaggio. Questo perché mi è stato insegnato a pensare alla storia, alla cultura, al potere e all’identità, nonché al fatto che io vivo in questa eredità, nell’ambito di istituzioni in cui il metafisico e il fisico si sovrappongono nella stabilità razionale della logica strumentale. Nondimeno, questo senso della verità forse sottende l’obbedienza a una serie di asserzioni che all’atto pratico minacciano la possibilità della libertà. Nella critica che Lévinas muove a Heidegger, troviamo il seguente brano: Riunendo la presenza sulla terra e sotto il firmamento del cielo, l’attesa degli dei e la compagnia dei mortali, nella presenza presso le cose, che equivale a costruire e a coltivare, Heidegger, come tutta la storia occidentale, concepisce la relazione con altri come ciò che si svolge nel destino dei popoli a dimora stabile, possessori e costruttori della terra. Il possesso è la forma per eccellenza nella quale l’Altro diventa il Medesimo diventando mio (Lévinas 1961, p. 44). Che cosa succede a questo senso della verità, quando “il destino dei popoli a dimora stabile”, e il suo culmine nella chiusura della narrazione della nazione, viene interrotto e messo in discus- IAIN CHAMBERS sione da popoli, storie, culture e linguaggi formati e foggiati nel movimento per il mondo?1. Che cosa accade quando un’economia scritturale si ritrova a confronto con un’economia orale? Il mondo apparentemente arcaico delle steppe, delle savane, delle praterie e dei deserti, che era ed è abitato, ma non posseduto, dai nomadi, trasmette una domanda che continua ancora a farsi sentire nei nostri tempi. Ovviamente, si riflette anche alla luce dei territori usurpati degli emigrati moderni. Viaggiare e attraversare i limiti arbitrari di un tempo e di uno spazio imposti (l’instaurazione geopolitica della nazione, la frontiera e la comunità astratta dell’identità etnica) è altresì la caratteristica più evidente del bagaglio dell’emigrante. Qui c’è indubbiamente una modalità di abitazione cui Heidegger non ha prestato attenzione. Forse, come osserva Lévinas, la sua indole rustica non gli ha fornito gli strumenti per andare col pensiero al di là dei limiti del sedentario al massimo costituito dal sentiero nella foresta che unisce insediamento a insediamento, casa con casa. Tutto questo per insistere sulla posizione del pensiero e sulla geografia del discorso. Come sostiene Franco Cassano (1996) trattando della posizione subalterna e della forza sovversiva del “pensiero meridiano”, le coordinate materiali in cui ha luogo, parla e ha effetto il pensiero hanno conseguenze profonde. L’autore prosegue asserendo che nell’ambito dell’episteme occidentale, la distinzione che emerge tra una prospettiva ancorata alla terra e una sfiorata dall’infinita provocazione di un orizzonte marino non è priva di conseguenze. Quanto appena detto trova una chiara esemplificazione, per dirne una, nell’identificazione, operata da Luce Irigaray (1980), di Friedrich Nietzsche come “amante del mare”. Tra la stabile continuità del terreno e l’oscillazione ondeggiante dell’acqua salata, la prospettiva marittima rimane sempre aperta. L’instabile orizzonte marino dà adito a una critica delle coordinate terrestri perenni annunciate nel Geviert o “quadratura” di Heidegger. La presenza del mare vanifica la possibilità di chiudere e controllare la visuale, nonché di fissare una posizione stabile. Le culture, le città e la cittadinanza rimangono sospese in 1 Si veda l’ottimo saggio di Homi K. Bhabha su questa scissione del nazionale e su questa duplicazione della modernità, intitolato DissemiNazione, in Bhabha 1994. SULLA SOGLIA uno stato liquido. Sulla costa, tra il moto incessante del mare e la stabilità ancestrale del terreno, le gerarchie verticali di potere e di conoscenza slittano in un piano orizzontale dispersivo (Cassano 1996, p. 26). Contro il canto perenne del suolo, emerge il percorso della tecnologia, necessaria per tracciare la rotta, navigare e solcare i mari. Nell’ostilità verso il mare è insito il rifiuto della sua mobilità distruttiva e della sua minaccia alle rassicurazioni erose dal tempo del sentiero nella foresta e ai contorni immutabili della terra. La presenza permeante del mare che unisce e al contempo separa l’arcipelago della geografia ellenica del pensiero manca del tutto nell’evocazione di Heidegger di quella tradizione. Egli insiste sulla forza d’attrazione della terra, sul terreno fisico che fornisce le strade dell’essenza, e in questo modo contrasta in maniera evidente con l’abbraccio filosofico di Nietzsche del “mare aperto”. Dato che proprio il mare determina la moderna tecnologia (l’ultima e più radicale realizzazione della metafisica occidentale), Heidegger ha ragione a condannare la filosofia marinara di Nietzsche come espressione dell’ultimo metafisico. Nel Geviert di Heidegger il pensiero trova sostegno nell’asse verticale tra la terra e il cielo, i mortali e gli dei, e l’interruzione di quest’asse a opera del moto instancabile delle onde e la spaccatura orizzontale di un infinito secolare viene bandita dalla rotta terrestre del nostro essere sulla terra. Naturalmente questo significa spingere al punto estremo quel che rimane assai più ambiguo. È bene ribadire che Heidegger stesso sosteneva di non essere contrario alla tecnologia, bensì che la sua posizione fosse interna alla tecnologia. Pertanto, mentre certamente riconosceva la sua nostalgia rurale, il pensiero di Heidegger era anche accarezzato da brezze marine, sebbene fosse estremamente restio a prendere pienamente in considerazione il mondo marino. Forse una riluttanza del genere, senza l’evocazione della vita rurale e la luce antica della radura delle foreste settentrionali, serve anche a farci tirare indietro di fronte alla scelta apparentemente semplice tra le tracce stabili del conservatorismo radicato e l’errare eternamente per mare della rotta priva di approdo. Imparando sia dal mare che dalla terra ferma si ha l’idea di un approfondimento dell’arte della navigazione, in cui né la forza d’attrazione verticale delle radici, né l’infi- IAIN CHAMBERS nito orizzontale delle rotte riescono mai a rendere davvero certa la carta geografica. Ma allora qual è la questione che Heidegger non ha udito? La costrizione e la recinzione delle genti e degli animali erranti per tutta la faccia della terra non implica altresì la più profonda violazione della terra stessa? Dico questo perché arrestare un simile movimento al fine di costruire significa stabilire una gerarchia e prendere possesso del terreno. Significa accumulare le energie umane e le possibilità terrestri per edificare e coltivare, nonché inaugurare quella “riserva” di Gestell che oggi culmina nella metafisica moderna dell’informazione pura, capace di inquadrare il mondo in un calcolo unico, in un costrutto sempre pronto per essere rappresentato e sfruttato1. Se la metafisica è essenzialmente quel pensiero che trasforma la terra in qualcosa di disponibile per l’umanità, un oggetto della razionalizzazione tecnologica, allora nemmeno l’antico ponticello di legno che attraversa il fiume o il mulino a vento che cattura l’energia eolica con le sue pale possono sottrarsi a questo processo di appropriazione2. In questa storia, che non è semplicemente la storia dell’Occidente (per quanto a partire dal 1500 abbia esteso la propria egemonia e razionalità in quel contesto geopolitico), è sita una gerarchizzazione della vita, un accumulo di potere, che ha represso la sua responsabilità per lo stato terrestre che ha stabilito. Come strada in apparenza scelta tanto tempo fa, la storia dell’insediamento agrario e dello sviluppo industriale, la fondazione della città e della polis, nonché la fusione di queste forze per formare territorio, nazione e impero, sembrano irreversibili. Insistere, tuttavia, sul fatto che si tratta di una storia particolare che mi porta nel luogo da cui parlo oggi, significa insistere su un’eredità problematica, soggetta all’interrogativo di altre storie, altri modi di essere; dove 1 Sull’apogeo del “pensiero rappresentativo” nella “cibernetica”, che porta all’attuazione della metafisica e alla “fine della filosofia”, si veda Heidegger 1962c. 2 I due esempi sono tratti dalla peana di Heidegger su una tecnologica più naturale, meno arrogante, preindustriale in La questione della tecnica (1962a), nonché dalla figura cruciale del ponte che riunisce la posizione de das Geviert, ossia la quadratura, in Costruire, Abitare, Pensare (1954b). SULLA SOGLIA ciò che esiste al di là della mia rappresentazione si ripropone per rendere precarie le mie pretese. La casa del linguaggio Lévinas ha ragione a ribadire i limiti del pensiero di Heidegger relativamente alla tematica dell’abitazione, e a criticare il suo implicito appello a una dimora sedentaria radicata in un terreno che può anche generare orrore e demoni omicidi intenti a difendere ed estendere la loro casa a spese degli altri. Nondimeno, la piega radicale che dà Heidegger alla nostra concezione del linguaggio porta verso un’apertura irreversibile nel pensiero del nostro luogo nel mondo. Nella sua Lettera sull’umanismo (1946), quella sintesi della sua opera che ci riporta verso Essere e il Tempo (1927) mentre delinea le future strade del pensiero, Heidegger (1962a, p. 193) proferisce la famosa asserzione secondo cui: “Il linguaggio è la casa dell’Esserci. Nella sua casa vive l’uomo”. Leggere questo saggio, assieme a Costruire, abitare, pensare (1954b) e alla successiva raccolta di saggi In cammino verso il linguaggio (1959) significa sentire, nelle parole di questo pensatore, il racconto di una maniera di abitare i cui limiti, paradossalmente, mi salvano: mi liberano dalle ambizioni illimitate della metafisica, da una modalità del pensiero e dell’esistenza che ritiene di essere anche in grado di dominare e svelare la logica del mondo. Pensare con questi limiti e nell’ambito di questi limiti consente di “liberarci dall’interpretazione tecnica del pensiero” (p. 268). Se diamo ascolto a Borderland/La Frontera di Gloria Anzaldúa, il linguaggio, in quanto essere, in quanto casa che risiede nella mia lingua e nel mio corpo (“io sono la mia lingua”, scrive la scrittrice chicana), diviene il percorso di un serpente mitico che si contorce nel tempo e nel corpo, nelle parole e nella storia, oltrepassando i confini, riscrivendo le aspettative dell’espressione linguistica, resistendo alla prescrizione e alla riconfigurazione dell’espressione linguistica nell’atto del divenire (Anzaldúa 1987, p. 59). Nel linguaggio e del linguaggio, intrappolata nel flusso del significato, la mia essenza non è né soggetto, né oggetto (Minh-ha 1991). Il corpo scrive, viene scritto, dice, è detto (Cixous 1997). Il mio essere nel linguaggio, il mio linguaggio nell’essere, supera la logica sin- IAIN CHAMBERS golare della grammatica. L’idea del linguaggio come semplice strumento, trasmissione cristallina della mia volontà, viene qui infranta in una maniera che smantella radicalmente e irreversibilmente un’intera tradizione dell’agire storico e di comprensione intellettuale. “Soggetto” e “oggetto” sono infatti denominazioni improprie della metafisica, che fin dall’inizio si è impossessata dell’interpretazione del linguaggio nella forma della “logica” e della “grammatica” occidentali. Ciò che si nasconde in questo accadimento, oggi lo possiamo solo sospettare (Heidegger 1946, p. 268)1. Il linguaggio trasmette sempre di più di quanto io voglia o possa comprendere. La sua storia precede e supera sempre qualunque cosa “io” (la voce e il corpo contingenti) riesca ad articolare e a infondervi. Ciò che va al di là di me è l’alterità del corpo, il mondo che mi rende sia un soggetto che un altro, che al contempo mi investe e mi eccede. Il linguaggio parla e al tempo stesso rimane indecifrabile, conturbando la linearità del pensiero e la sua convinzione di avere afferrato la verità. Per dirla come la saggista e regista Trinh T. Minh-ha, “la vita è rotonda”. Seguire l’arco di un siffatto pensiero significa registrare l’impossibilità di nominare un punto di partenza o di arrivo definitivi, e con ciò registrare una potenziale dispersione del dominio. Tra i suoni e i silenzi del linguaggio passano il ritmo, l’andatura del basso, il canto della terra (Haar 1993). Significa affrontare una libertà che Lévinas definisce come infinito. Si tratta di una modalità di pensiero non più intenta a costruire l’oggetto di un discorso che si autoconferma da solo nel quale io, il soggetto, sono il centro che monopolizza e controlla l’esito del pensiero (Heidegger 1950a, p. 93). Alla deriva Prestiamo nuovamente ascolto a Heidegger. Nella quarta Appendice che correda L’epoca dell’immagine del mondo (1950a), si 1 L’argomento è stato trattato diffusamente da Nietzsche 1886a. SULLA SOGLIA intravede inequivocabilmente il nucleo della critica dell’antropologia nella frase: “Con l’interpretazione dell’uomo come subiectum, Cartesio crea il presupposto metafisico per la successiva antropologia di ogni specie e indirizzo” (p. 84)1. In seguito, nella decima Appendice, si delineano in maniera inequivocabile le implicazioni della genesi metafisica dell’antropologia: L’antropologia è quell’analisi dell’uomo che, in fondo, già sa ciò che l’uomo è, e quindi non può porsi il problema di che cosa esso sia. Se si ponesse questo problema, essa dovrebbe infatti riconoscersi rovesciata e oltrepassata. Ma come si potrà esigere questo dall’antropologia, quando essa non si propone altro che l’assicurazione dell’autocertezza del subiectum? (p. 98). Nel potere scientifico dello sguardo e nell’insistenza neutrale dell’osservazione, la verità è stata assunta come qualcosa di inaccessibile. In questo contesto è di rigore declinare il verbo al passato, perché proprio questa tematica è diventata la preoccupazione principale dell’etnografia contemporanea, conferendole un significato per tutte le scienze sociali. Il linguaggio (quello dell’osservazione sul campo, quella della descrizione nel testo) era neutrale, puramente mimetico, il riflesso diretto della realtà, in grado, osservati alcuni protocolli disciplinari, di aprire la porta alla verità della situazione individuata dallo sguardo critico. Eppure, l’oggettività universale di questo presunto realismo dipende, paradossalmente, da un soggettivismo intellettuale che rivela inevitabilmente il suo lignaggio nell’autorità locale (nonché nei limiti) del razionalismo occidentale. Nella crisi contemporanea di questa particolare struttura della conoscenza, occorre altresì registrare la più grave crisi 1 L’impossibilità di andare al di là del terreno che offre alla disciplina una voce è stata perseguita, come è noto, da Michel Foucault (1966), ma è centrale anche nella critica all’antropologia a opera di Johannes Fabian (1983). Fabian scrive: “L’uomo non ha ‘bisogno’ del linguaggio; l’uomo, nella sua comprensione dialettica e transitiva dell’essere, è il linguaggio (così come non ha bisogno di cibo, riparo e così via, ma è il proprio cibo e la propria casa)” (p. 188). Le parole e le cose di Foucault (1966) può essere interpretato come un’orchestrazione storica dettagliata della critica elaborata da Heidegger (1946) contro “l’umanismo” in quanto epistemologia focalizzata sul soggetto che, per dirla come Foucault, inventa “l’uomo” per confermare tutti gli episodi della storia dello stesso. IAIN CHAMBERS della critica occidentale e delle sue pretese sul mondo. Questo perché, qualunque rappresentazione sia oggetto di osservazione (la vita contemporanea nei villaggi dell’Indonesia meridionale, il primo contatto tra l’Europa e le Americhe nel Cinquecento, le vestigia eterne della magia nella metropoli moderna), l’analisi è costretta ad affrontare una relazione con l’alterità che non è possibile contenere nell’ambito del linguaggio disponibile (Tsing 1993). Quello che viene afferrato, carpito, concettualizzato (“concetto” deriva dal latino cum-capio, ossia “afferrare”) non può essere considerato isolatamente, perché ingloba qualcosa che permea ed eccede la voce del critico. Analizzare significa rendere il proprio linguaggio soggetto al dubbio, aprirlo a un processo di mondità che non può essere controllato da un autore o da un’autorità individuali. L’analista e l’oggetto di analisi vengono uniti e mediati attraverso il mondo rappresentato: la comprensione del secondo (ossia “l’oggetto” dell’indagine”) non è separabile dalla comprensione del primo (il “soggetto” che indaga). Essi esistono in un processo di iscrizione nel mondo, ma né come oggetto, né come soggetto. Sebbene negati sistematicamente nella neutralità dell’esposizione critica, ognuno autorizza l’altro in un linguaggio che nessuno dei due possiede del tutto. Non c’è una realtà testuale (o etnografica) che attende di essere interpretata, bensì un’esperienza testuale (o etnografica) in cui chi vi prende parte viene iscritto e articolato nell’atto che precede e supera l’interpretazione (Clifford 1988). Le differenze culturali, storiche ed economiche, le questioni di potere, subalternità e discriminazione, per quanto sovente distinte in categorie e realtà non comunicanti, vengono incessantemente avvicinate. Non c’è bisogno di notare che la vicinanza cui ci si riferisce in questa sede trova di rado riconoscimento in termini politici o economici; gli interessi che godono del mantenimento delle distanze sono troppo potenti per consentirlo. Alla fine, persino l’etnologo, persino il critico, in quanto rappresentanti limitati dell’autorità occidentale, hanno sempre l’ultima parola. Tuttavia, al di là dell’immediatezza di questi risultati, il dialogo inaugurato persevera come presenza sregolata, destinata a fare ritorno a più riprese, per mettere alla prova, distruggere e superare i limiti del discorso che tenta di limitarla. La verità che SULLA SOGLIA si incontra nella conversazione spezzettata consentita dal linguaggio e che porta verso un testo (antropologico, storico, letterario, critico) non è una verità che si limita a riflettere il soggetto o l’oggetto del linguaggio, bensì è il luogo di “uno strutturale differenziale di potere e di un substrato di violenza” (p. 97) che rendono possibili le condizioni per cui quell’incontro viene registrato e pensato. La soglia del pensiero Trasformare l’indagine dal semplice riflesso della mia soggettività individuale (essere) a un linguaggio che mi precede e mi eccede (Essere) significa cercare di rispondere alla problematica dell’abitazione non più in termini soggettivi, utilitaristici o razionalistici, come semplice “fare e costruire” che già sa che cos’è l’abitazione e pertanto non può mai metterla in discussione, soltanto confermarla. Mi si richiede, piuttosto, di rispondere in termini di ciò che Heidegger chiama “e-sistenza”, nella quale l’Essere non può venire controllato e manipolato da singoli esseri, non può essere fermato in un linguaggio che credo di possedere e controllare. In quanto potere del possibile, questo senso dell’Essere, al pari del linguaggio stesso, eccede e al contempo precede la mia esistenza. Ecco ciò che mi consente, mi istiga a essere: in un modo che nessuna logica, linguistica o tecnologica che sia, può mai spiegare completamente1. Seguire questa strada e rifiutare la comprensione puramente razionale della realtà significa sottrarre il pensiero a una filosofia che “domina il destino della storia occidentale e di tutta la storia intesa in senso europeo” (Heidegger 1946, p. 282). Significa sforzarsi di uscire dalla casa del pensiero occidentale, una casa edificata sull’abbandono dell’Essere e che pertanto è veramente il sito della moderna condizione di senzatetto, perché si erge sull’incapacità di fare il 1 Forse questo ci aiuta a superare la difficoltà iniziale dovuta all’avere a che fare con frasi apparentemente criptiche come “l’e-sistenza così intesa non è solo il fondamento della possibilità della ragione, ratio, ma è ciò in cui l’essenza dell’uomo conserva la provenienza della sua determinazione”, in Heidegger 1946, p. 277. IAIN CHAMBERS punto della situazione nel mondo (pp. 293-298)1. Separarsi da questo scenario vuole dire ritirarsi dal puramente razionale che rende possibile l’illusione di essere i padroni del linguaggio e che tutto si riveli nella rappresentazione. Chi oltrepassa questo limite, in certo senso, “misconosce che c’è un pensiero più rigoroso di quello concettuale” (p. 308). In questo supplemento che eccede e nega la logica della mia spiegazione, i limiti del mio habitat vengono inscritti e la sua storia diviene una storia. La struttura del mio pensiero, la struttura che mi posiziona come soggetto della storia, si rivela essere la verità di una posizione, la peculiarità di una voce, la posizione di un corpo, di una cultura, di una storia. Ciò che rimane impensabile nell’ambito del mio sistema di rappresentazione, che ne è esterno eppure lo investe e lo supera, dissemina una verità che non sono in grado di possedere, che sospende l’autorità della mia spiegazione (Purdom 1995). Ciò mi conduce sulla soglia di un altro pensiero e mi spinge per la mia strada. La logica unilaterale, e la sordità alla risposta, che viene ora stabilita nel brusio generalizzato del dominio del mondo, può essere intersecata da una narrazione, da un logos diverso che dipende dall’ascolto2. Vuol dire opporsi a una modalità di pensiero che prescrive, che ignora l’ascolto, ovvero una cultura che nega “le premesse stesse della cultura perché si propone di predicare invece che coltivare” (Corradi Fiumari 1985, p. 21; corsivo nell’originale). Ritirarsi dall’accecante trasparenza di una logica che parla senza attendersi o richiedere una risposta significa incontrare nelle ombre del discorso occidentale la perdita della propria nomina a “sog- 1 Come si sforza di spiegare Heidegger, questo senso di mancanza di una casa è anche di natura profondamente ontologica. Non ha nulla a che fare con la casa nel senso di appartenenza a una “patria” o nazione. La mancanza di una casa “riposa nell’abbandono dell’essere proprio dell’ente” (pp. 291-292). 2 A questo punto sto semplicemente chiosando la dettagliata trattazione di questa tematica offerta da Gemma Corradi Fiumari (1985). Questo pensiero aveva già fatto la sua comparsa nel 1951, in un articolo chiamato Logos, relativo al concetto del Leghein che, come ribadisce Heidegger, fornisce una comprensione più radicale del logos, dato che intende sia parlare che narrare, pronunciare e anche unire, raccogliere, radunare. L’altro lato del leghein è andato, a poco a poco, perduto e abbandonato. Il concetto che contiene è fondamentale anche per l’idea della narrazione come modalità di conservazione che trattiene nel suo significato ciò che raduna, ricorda e riunisce l’ascolto. In altre parole, un logos dipendente dall’ascolto. SULLA SOGLIA getto” nei confronti di un “oggetto”. Questo differire e deferire della logica filosofica è altresì uno slittamento, un moto di allontanamento dal linguaggio dispotico del centro nel quale le illusioni soggettiviste dell’umanesimo mi avevano collocato. Questo perché implica l’abbandono di quella metafisica che propone “un’interpretazione già stabilita della natura, della storia, del mondo, del fondamento del mondo, cioè dell’ente nella sua totalità” (Heidegger 1946, p. 275). In un linguaggio soggetto alla possibile interferenza di una risposta, ciò che sostiene il discorso è il silenzio. Il silenzio avviluppa continuamente il linguaggio. Il silenzio oppone resistenza alla comprensione puramente razionale del linguaggio, dato che alimenta le ombre che mettono in discussione e frustrano la logica che l’interesse strumentale vorrebbe imporre. I significanti slittano via nella significazione fluttuante, il linguaggio si fa opaco, si ripropone il mistero, perché il silenzio non è sinonimo del nulla: è una domanda sita nell’intreccio del linguaggio. Il silenzio è il ponte tra il respiro, il suono e l’espressione, è la sonorità che rende possibile all’essenza del linguaggio di distinguersi (Sciacca, citato in Corradi Fiumani 1985, p. 136; si veda inoltre Luce Irigaray 1983). Il silenzio non è residuale, è essenziale. Naturalmente, istintivamente ci distraiamo dall’attesa che accompagna la risposta, perché la “tragedia” dell’ascolto, contrapposta alla comodità della prospettiva circoscritta, è, per citare nuovamente le parole di Edmond Jabès, che esso apre una relazione con l’infinito, l’impensato, che propone una misura del silenzio per mezzo dell’ignoto e dell’imperscrutabile (Jabès, citato in Buci-Glucksmann 1992, pp. 179-180). Questo ci porta vicini alla suggestiva asserzione dei sacerdoti delle colline Matopos dello Zimbabwe: “Dio è il Linguaggio” (Ranger 1996, p. 158). Tutto ciò comporta una perdita di egocentrismo che può produrre un inatteso beneficio di natura etica1. Si tratta però anche di un passaggio di vulnerabilità estrema: una strada delicata 1 Si tratta altresì di un passaggio che può portare al chiuso narcisismo di un’interminabile malinconia, alle ambiguità della nostalgia che va alla ricerca in un passato immaginato di un futuro migliore, oppure al lutto che contrassegna il termine di una certa storia e l’apertura verso un’altra. Sia la malinconia che il lutto rimangono pervicacemente sospesi nelle ambiguità del ritorno contemporaneo del Barocco. Un’interessante discussione di questi termini è contenuta in Wheeler 1995. IAIN CHAMBERS e perigliosa da intraprendere, perché è possibile perdere le proprie connessioni, smarrirsi. Il mio linguaggio e la mia ragione, la dimora del mio essere, viene esposta all’eterogeneo, all’incalcolabile, al discontinuo, alle configurazioni sconosciute e non rassicuranti di una diversa “mondità del mondo”1. Per riecheggiare l’enfasi critica di Antonio Gramsci (in «L’Avanti», 1917): “Il mondo è grande e terribile e complesso. Ogni azione nella sua complessità desta echi inattesi”. Oltre alla relazione etimologica, nell’antico norreno, tra casa e dimora, il termine dwelling (dimora) in antico inglese si riferiva anche all’idea di essere fuorviato, indotto in errore e in eresia, e quindi, paradossalmente, esprimeva il concetto di vagabondare (Onions 1996)2. La semantica arcana di dimora risuona nella maniera più evidente nel famoso commento di Freud sul familiare o heimlich che si trasforma bruscamente nelle sembianze fastidiose del perturbante o unheimlich. In questa vicinanza, all’interno della stessa parola si concentra l’attenzione sul concetto di linguaggio iscritto nel vagabondare; non soltanto iscritto in ciò che vaga relativamente alla comprensione convenzionale e linguistica, ma anche in ciò che viaggia e quindi ci avvia sul sentiero non segnato. In questo modo, sia la costruzione linguistica che quella storica della nostra dimora e del nostro essere nel linguaggio divengono un po’ meno familiari e un po’ più precarie. Lo spaesamento Facendo i conti con i limiti del mio linguaggio, il mio senso della casa, e con esso il senso della proprietà culturale che lo comprende e rafforza, vengono a essere perseguitati dal ritorno 1 Il concetto è di Heidegger 1950b. Tuttavia, è stato sfruttato spesso e in maniera strategica nella critica postcoloniale da Gayatri Chakravorty Spivak; si veda, ad esempio, Spivak 1990. 2 Le medesime connotazioni si riscontrano anche nell’antico altotedesco twellan, nell’antico svedese e nell’olandese medio, risalendo alla radice ariana nel sanscrito shwö; si veda la seconda edizione dell’Oxford English Dictionary. SULLA SOGLIA di ciò che ritarda, distrugge e devia quel senso. Nel rifiuto di questa prospettiva, e del senso di vulnerabilità che va di pari passo con essa, è insita la passione per lo sterminio che ha caratterizzato la modernità occidentale. Dal suo incipit sanguinario in Africa e nelle Americhe, nella schiavitù e nel genocidio, fino all’estrema razionalizzazione dello sterminio razziale costituito dalla Shoah, la relazione con lo spaesamento, con ciò che si crede minacci il senso occidentale di sentirsi a casa nel mondo, ha prodotto inevitabilmente conseguenze efferate. Soffermarsi sulle atrocità del ventesimo secolo a opera delle SS o dei nazionalisti dei Balcani può attirare la nostra attenzione, con troppa facilità, sulla falsa eccezione dell’orrore, consentendoci quindi di evitare l’ottundente banalità della tendenza assai più consueta di escludere e distruggere tutto ciò che non possiamo possedere, contenere o comprendere: Non possiamo essere umani fintanto che non percepiamo in noi stessi la possibilità dell’abiezione, oltre alla possibilità della sofferenza. Non siamo soltanto vittime potenziali del boia. Il boia è il nostro prossimo. Dobbiamo chiederci: c’è qualcosa nella nostra natura che rende impossibile un tale orrore? Domanda a cui sarebbe corretto rispondere: no, nulla (Bataille 1991, p. 18). Sradicare l’alterità è un tentativo di abolire tutto ciò che resiste all’esercizio del potere che mi consente di rimanere salvo nell’assolutezza della mia autonomia: “L’omicidio esercita un potere su ciò che sfugge al potere” (Lévinas 1961, p. 203). L’altro minaccia di contaminare e di frustrare questa eventualità, invitandomi “a una relazione che non ha misura comune con il potere che si esercita” (ib.). L’affermazione violenta del potere non è né eccezionale né estranea a coloro che abitano la modernità e che in essa si sentono a casa; essa disciplina coerentemente il passaggio tra l’inclusione e l’esclusione nella costruzione di un habitat che conferma e riproduce il senso di sè. La faccia dell’altro “non sfida la debolezza del mio potere, ma il mio potere di potere” (ib.). Avvezzo a esprimermi senza limiti, in un linguaggio che annulla tutto ciò che non è in grado di assimilare, la presenza dell’altro invoca l’assassinio di ciò che nega il mio dominio: IAIN CHAMBERS Io posso desiderare di uccidere solo un ente assolutamente indipendente, quello che è assolutamente al di là del mio potere e che perciò non vi si oppone, ma paralizza lo stesso potere di potere. Altri è il solo essere che posso desiderare di uccidere (pp. 203-204). Il senso sicuro del sentirsi a casa nel mondo moderno è il luogo di un’estorsione micidiale. Una tradizione dell’appartenenza, dell’essere localizzato nelle radici apparentemente atemporali di sangue, lingua e suolo, può chiudere violentemente la porta contro le storie degli altri; è sempre per questo che si uccide. Per avere voce in capitolo, esercitare un potere, quelle altre storie vengono costrette a minare e a riprodurre l’economia rivendicativa del nazionalismo moderno, disseminato in gran parte del romanticismo europeo1. Si tratta di una tradizione che in quanto tradizione raramente si mette in discussione. Si dà per scontato che i valori della continuità e della comunità, che la tradizione e la trasmissione della stessa siano i valori da pretendere e da difendere. Proprio con questi valori confermiamo la nostra autenticità. Che si trovi nei cicli rurali della civiltà contadina oppure nei rituali dei “nativi”, questa collocazione e citazione dell’immutabile viene considerata sacrosanta. Ma non è un mito conservatore e reazionario quello che noi, di origini europee, ci raccontiamo per aggrapparci alla nostra centralità nella casa divenuta mondo? Mentre il resto del mondo è costretto ad adeguarsi al cambiamento e all’interruzione, la continuità della tradizione viene preservata come valore universale da coloro che detengono il potere di definire “l’universale”. Ma se ascolto gli antropologi e i romanzieri moderni, che non sono sempre facili da distinguere, sento spesso qualcosa di alquanto diverso. Ecco ancora Betonie, lo sciamano Navaho del romanzo di Leslie Silko Cerimonia, che spiega la natura dei rituali che esegue: In un certo periodo le cerimonie, così come erano state celebrate, bastavano per il modo in cui il mondo era fatto allora. Ma dopo l’arrivo dei bianchi alcuni elementi di questo mondo hanno cominciato 1 Gilroy 1993a fornisce un’esposizione geniale di questo legame storico e culturale nel contesto dei nazionalismi neri. Si veda altresì Achebe 1988. SULLA SOGLIA a spostarsi ed è diventato necessario creare nuove cerimonie. Io ho apportato cambiamenti ai rituali. La gente ha grande diffidenza di questo, ma soltanto questa crescita mantiene salde le cerimonie. Lei mi ha insegnato questo più di ogni altra cosa: le cose che non si spostano e non crescono sono cose morte. Sono queste le cose che vuole la stregoneria. La stregoneria lavora per spaventare la gente, per far sì che abbiano paura della crescita. Ma è stata sempre necessaria e lo è più che mai ora. Altrimenti non ce la faremo. Non sopravviveremo. È su questo che conta la stregoneria: che ci attacchiamo alle cerimonie così com’erano, così il suo potere trionferà e la gente non esisterà più (Silko 1977, pp. 139-140). Opporsi a un potere che considera la tradizione (sia la propria che quella di un altro) un’essenza immobile significa opporsi alla stretta di una stregoneria apparentemente in grado di possedere e ridurre il mondo all’unità dei suoi fini. L’abrogazione di questa narrazione dell’autenticità mediante la mutazione, il travestimento e la traduzione consente che si palesino spiragli attraverso cui compare un altro mondo: “Questo è un mondo in cui tutti devono assumersi la responsabilità di una immaginazione limitata” (Tsing 1993, p. 289). La passione di sradicare l’alterità dalla terra è anche la passione per la casa, la patria, la dimora, che autorizza e premia questo desiderio. Nel suo razionalismo, provincialismo e razzismo, costituisce una nevrosi pubblica e privata (Nairn 1981, p. 359). Pertanto, sciogliere la nozione rigida di luogo che apparentemente mi consente di parlare, che garantisce la mia voce, il mio potere, non vuole dire semplicemente disperdere la mia località nelle più ampie coordinate di un contesto in ultima istanza planetario. Ciò mi assolverebbe semplicemente dalla responsabilità in nome di un globalismo astratto e generico, consentendo alla mia eredità di continuare ininterrotta nelle vaghezze di una nuova configurazione. Riguarda qualcosa di assai più preciso e urgente, perché nell’orrore dello spostamento pulsa il terrore della dispersione dell’umanità occidentale: il terrore di una razionalità che deve fare i conti con ciò che la eccede, che non riesce ad afferrare. Essere presi da ciò che sfugge alla nostra comprensione immediata significa correre il rischio di avere, in fin dei conti, ben poco da dire (Heidegger 1946, p. 273). Liquidare la metafisica di un sapere “universale” IAIN CHAMBERS che vede nella “casa” la conferma di un edificio unico e unilaterale di guadagno significa rivelare le particolarità della voce e del luogo, della storia e del corpo, del dolore, della memoria e del silenzio. Tutto ciò suggerisce qualcosa che va al di là di una semplice correzione teorica sul piano del pensiero, perché ascoltando l’insistente supplemento del silenzio – a ciò che in precedenza era considerato privo di senso, incomprensibile e indecifrabile prima della traduzione – comincio a recepire che il mio linguaggio, la mia identità, la mia storia, la mia voce dipendevano solo dal consegnare violentemente all’oblio tutto ciò che le turbava. Sebbene non possa, chiaramente, parlare di questo silenzio, questo altro lato represso del mio essere, posso concedergli uno spazio, come il respiro tra le parole, l’aria nella respirazione: essenziale, ma perennemente trascurato (Irigaray 1983). Ecco che la faccia dell’altro emerge da una carta geografica, per irrompere nell’anonima, astratta cartografia della ragione occidentale. È proprio l’evitare la faccia dell’altro, sostiene Lévinas, che rende possibili l’omicidio anonimo e il massacro astratto: l’apice tecnologico di un razionalismo mortale in passato concentrato nel proverbiale dito sul pulsante, questi giorni più probabilmente consegnato alla risposta programmata di un microchip. La faccia invita a una risposta che non può essere semplicemente ipotetica: chiede una cura che non sia solo teorica. “Per questo c’è un abisso tra il ‘filosofare’ sul naufragio e un pensiero che davvero naufraga” (Heidegger 1946, p. 296). Esporsi Pensando all’evento del pensiero in un mondo in cui il pensiero accade e al contempo occlude, mi sento costretto a sottoscrivere un senso del luogo che ecceda le connotazioni limitative del “locale”, dello “storico” e del “tradizionale”. Senza dubbio, questo significa prestare scarsa attenzione alle soglie disciplinari. Insistere sulle conseguenze ontologiche di pensare al locale, di pensare al luogo e alla dimora, significa insistere sui limiti potenti di uno spazio esecutivo in cui non vengono soltanto sanciti il linguaggio, la storia e la tradizione che mi costituiscono come “sog- SULLA SOGLIA getto”: qui, nella carne, la mia identità (sessuale, di genere, etnica e sociale) è collocata, mobilizzata, disciplinata, ma anche superata1. In risposta al mio essere che è in debito ma irriducibile a quelle categorie individuali, questo “io” storico si costituisce nell’ambito dei limiti che mi configurano ma non mi riducono in catene. In questa proposta non esiste una soggettività o un universalismo nuovo e “migliore”, bensì esiste l’intersezione di quel desiderio di interezza, di completezza mediante la messa in discussione della dimora, mediante l’istanza in cui lo spazio, le istituzioni e i linguaggi vengono tradotti e in-corporati in un corpo particolare e un luogo precario. Quanto detto mi getta in un altro spazio: né “originale” né imitativo. Non esiste alcun punto stabile in cui trova ospitalità il significato, bensì soltanto un transito in cui i miei punti di arrivo impostati e agognati sono soggetti a uguali interrogativi. Criticare la grande disparità tra l’Europa e il resto del mondo non significa semplicemente decostruire l’Europa come origine o semplicemente ripristinare quell’origine che è l’altro dell’Europa, ma uno smantellamento accurato sia del concetto di origine che del concetto di alterità come lo conosciamo noi oggi (Chow 1995, p. 194). Rey Chow prosegue (p. 195): In altre parole, la traduzione culturale genuina è possibile unicamente quando ci spostiamo al di là dei cambiamenti apparentemente infiniti ma effettivamente riduttivi, cambiamenti dei due termini (Oriente e Occidente, originale e traduzione) e invece li vediamo entrambi come protagonisti pieni, materiali, e con ogni probabilità ugualmente corrotti, ugualmente decadenti della cultura mondiale contemporanea. Mi ritrovo in un viaggio destinato a trascinarmi lontano dalle latitudini del mondo contemporaneo, nonché verso il passato, verso le origini della modernità occidentale, se non verso i miti che lo hanno segnato profondamente fin dal principio. 1 Si tratta di una tematica che, sulla scia di Michel Foucault, ha prodotto i risultati maggiori in buona parte della teoria femminista recente. Si vedano in particolare i lavori di Judith Butler. IAIN CHAMBERS Viaggio interrotto Rieccoci a Ulisse. Legato all’albero maestro delle sue intenzioni, mentre gli uomini del suo equipaggio, le orecchie tappate con la cera, rimangono sordi al canto delle sirene, Ulisse conferma, per coloro che verranno dopo di lui, l’idea dell’alterità come minaccia mortale, l’ignoto che ci separa da noi stessi e ci porta all’annientamento e all’oblio. Ulisse, una volta che tutto è stato detto e fatto, è un uomo che sa dove tende il suo vagare: verso casa, verso se stesso. Il suo viaggio per gli spazi vuoti di cui il logos non si è ancora impossessato apre quel passaggio della conoscenza e del potere che illumina la storia dell’Occidente, gettandone l’ombra sul mondo. Tornare a quel viaggio mitico al giorno d’oggi, ma senza seguirne la linea d’ombra, mi costringe a far fronte a un supplemento, un eccesso del senso, che blocca la possibilità di fare ritorno a casa. Nella rivendicazione drammatica degli altri, dei repressi e degli sradicati, odo voci che il viaggio dell’Occidente ha storicamente messo a tacere ma che adesso emergono in maniera inequivocabile dentro di me. Miti di viaggi si manifestano ormai come “‘favole’ che gettano luce sull’‘originale’ che è la violenza del nostro mondo, e contrassegnano i passaggi che non conducono all’‘originale’ che è l’Occidente o l’Oriente, bensì alla sopravvivenza nel mondo postcoloniale” (Chow 1995, p. 202). Le fondamenta stesse della modernità occidentale (il mio senso della storia, il mio senso del mondo e il mio sé) si basano sull’idea del viaggio. L’epoca dell’“immagine del mondo”, dove il pianeta, ricondotto in una cornice unica, reso trasparente da una sola fonte di conoscenza che viaggia, “scopre” e raccoglie, ha inizio simbolicamente nel 1492. Non è che l’immagine del mondo da medievale che era divenga moderna; ma è il costituirsi del mondo a immagine ciò che distingue e caratterizza il Mondo Moderno [deer Neuzeit] (Heidegger 1950a, p. 89). Qui, nell’incontro con nuovi mondi, con l’alterità, si fissano un centro e una periferia epistemologici in cui il viaggiatore europeo è sempre il soggetto, mai l’oggetto della Storia: “La storia è omogenea ai documenti dell’attività occidentale” (de SULLA SOGLIA Certeau 1975, p. 220). Organizzato attorno alla supremazia oculare, attorno a un punto di vista unico che raggiunge nella tecnologia della scrittura e della cartografia la sua presenza universale, è il viaggio stesso a fissare i principi della conoscenza. Nel movimento ripetitivo centripeto da un centro saldo, da casa, verso l’ignoto, il soggetto inalterato “conquista lo spazio moltiplicando gli stessi segni” (p. 230). La conquista e il viaggio sottoscrivono altresì un senso di transito in un universo sempre più autonomo e secolare. La conoscenza non è più rivelata direttamente da Dio, bensì è qualcosa da acquisire e accumulare, sovente con l’uso della forza, e quindi portata a casa per essere catalogata e classificata nelle istituzioni della ragione e del profitto. La lingua, il discorso e l’oralità (il corpo che parla), la “presenza esorbitante” (Lévinas 1961) che minaccia l’oggettività, viene esiliata dal pensiero come oggetto esotico e incontenibile: è così almeno che si manifesta una delle regole del sistema che si è costituito come “occidentale” e “moderno”: l’operazione scritturale, che produce, preserva, coltiva “verità” non periture, si articola su un brusio di parole svanite non appena enunciate, perse dunque per sempre. Una perdita “irreparabile” è la traccia di queste parole nei testi di cui sono l’oggetto. È così che sembra scriversi una relazione con l’altro (de Certeau 1975, pp. 222-223). Ma come ribadisce in seguito lo stesso Michel de Certeau: L’altro ritorna: con l’immagine della nudità, “presenza esorbitante”; con lo spettro della vagina dentata, che abita la rappresentazione della voracità femminile; o con l’irruzione danzante di piaceri proibiti. Più fondamentalmente, il mondo selvaggio, come il mondo diabolico, diventa Donna. Si declina al femminile (p. 252). Tale concezione che sottende una ferma conoscenza virile ci accompagna tuttora. Nel passaggio apparente dal religioso al secolare, il paradigma metafisico rimane immutato. La fede nell’incondizionato non si esprime più mediante un Dio defunto, bensì nell’ambito delle certezze patriarcali delle scienze, nella rappresentazione tecnica della verità e nell’idealismo dell’assolutismo estetico, tutti fissati dall’autorità dell’iscrizione, della IAIN CHAMBERS scrittura. Il mondo viene ricondotto al dominio della parola scritta e della conseguente organizzazione in discipline, competenze e informazioni. Questo è il contesto in cui lo gnosticismo occidentale trova la sua celebrazione e la sua riconferma. Pensare in termini di un quadro globale, di un sistema globale, di un copione e di un inquadramento unico delle diverse esperienze della modernità significa paradossalmente indebolire le asserzioni relative all’identità omogenea e autonoma. Insistere su un’identità razziale, etnica o nazionalista come qualcosa di non connesso o inquadrato nell’eterogeneità storica di un mondo condiviso significa negare le forze stesse che hanno determinato l’ascesa di detti concetti (la razza, l’etnia) e che sostengono e permettono a una siffatta identità di esprimersi. Enfatizzare la genesi eterotopica che accompagna tacitamente le fiduciose asserzioni dell’identità moderna scardina il catenaccio della “casa” e della “tradizione” e mina la base da esse fornita al razzismo, alla paura e all’omicidio. La netta distinzione tra un “qui” e un “là”, tra un “primo” e un “terzo” mondo, tra il “Nord” e il “Sud”, tutti impegnati a mantenere l’altrove al di fuori del mondo a portata di mano, separato e a una debita distanza fisica, culturale e storica, viene interrotta in maniera irreversibile (Fabian 1983). Siffatte distinzioni, e le differenze effettive nel patrimonio economico, politico e culturale che evocano, sono interne all’inaugurazione dell’“immagine del mondo” e alla nascita della modernità. Si trovano su questo lato, sul mio lato del confine storico, e non altrove in una pre-modernità o non-modernità. Il periferico e il sottosviluppato – la nomenclatura stessa rivela i poteri ineguali in siti nella disposizione teorica e strumentale della connessione – sono i prodotti della formazione storica che rende possibile questa particolare ripartizione spaziale del mondo. Essa porta all’abbandono del tempo che interrompe, e all’oblio delle storie distinte, corporee, che cadono nelle griglie di una geometria atemporale, persa nello spazio reificato del tempo vuoto, omogeneo che ospita la teleologia1. Tuttavia, in quanto rappresentazioni della provoca1 Questo è il ben noto verdetto emesso da Walter Benjamin (1955a) sul “progresso”, riassunto in maniera sintetica nelle sue Tesi sulla filosofia della storia. Lo stesso concetto è stato reiterato in tempi recenti da Laclau (1990, p. 42). SULLA SOGLIA zione dell’occidentalizzazione, o risposte specifiche, queste storie negate si sovrappongono e diventano intrinseche alle responsabilità della modernità. Pertanto il viaggio, per quanto possano essere sicure la destinazione, la gestione e le ambizioni, rappresenta sempre un passaggio che espone chi vi prende parte al turbamento dell’inatteso. Malgrado tutti gli sforzi per dominare la traduzione, c’è sempre qualcosa che oppone resistenza, che sfugge alla logica del linguaggio adoperato, che rimane inspiegabile nell’economia della scrittura che si sforza di renderlo trasparente. Se il viaggio è il mito fondamentale della modernità, e forse addirittura dell’Occidente, esso rivela altresì un paradosso strutturale, in cui si fondono lontananza e vicinanza. Il viaggio è costellato da ciò che si trova a portata di mano, la dimora interrogata dallo spaesamento. Vengono tenuti assieme nel ritorno “perturbante” che fa scaturire la repressione che insegue e spezza qualsiasi rappresentazione della casa, della cultura e del sé. La casa in rovina Nel suo celebre saggio sul perturbante, Freud si riferisce alla costernazione e al terrore che accompagnano l’incontro con l’estraneo, l’ignoto, che suscita sentimenti di spaesamento e di estraniamento. Tuttavia, l’orrore del das Unheimlich, come egli evidenzia accuratamente, è dato dal fatto che non riguarda qualcosa che ci giunge da lontano, bensì qualcosa che è già con noi e che “risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare” (Freud 1919, p. 82). Ciò che appare intimo viene bruscamente integrato dalla drammatica vicinanza di quel paese familiare che è il passato, il mio passato. Il mio centro viene intersecato da un altro centro, da una parabola ellittica che promette di portarmi altrove. Il concetto della certezza viene perseguitato dallo spettro di una domanda che parla un linguaggio che riconosco mentre si sottrae alla spiegazione. Nella mia ansia viene a galla ciò che ho cercato razionalmente di reprimere, in ultima istanza la paura primordiale dell’annientamento (pp. 96-105). Questo turbamento persistente nel cuore della ragione ha indotto Wendy Wheeler a ipotizzare che tanto il sublime quanto il IAIN CHAMBERS perturbante, per quanto assolutamente non limitati alla modernità, acquisiscano le loro forme più immediate in una “soggettività moderna” che viene: perseguitata da qualcosa che – con l’avvento della modernità dell’Illuminismo – diviene impossibile da collocare e, in termini strettamente logici, non rappresentabile nel tramonto di un mondo inserito nello schema del sacro. Per Lyotard e Žižek, lo si denomina ricorrendo alla categoria del sublime. Per Dolar, appare nella modalità del perturbante (Wheeler 1995, p. 84). Scrive Mladen Dolar: Pare che, quando parla del perturbante, Freud parli di un “universale” dell’esperienza umana, eppure i suoi esempi indicano tacitamente la sua posizione in una congiuntura storica particolare derivata dall’Illuminismo. C’è una dimensione specifica del perturbante che emerge con la modernità (Dolar 1991, citato in Wheeler 1995, p. 84; enfasi nell’originale). Presentato in termini scientifici, nei linguaggi della conoscenza, della verità, “l’interrogativo primo: qual è la natura dell’inquietudine umana” (Chatwin 1988, p. 216) diviene una fantasticheria che riporta la modernità all’interrogativo che rivela, nei desideri di scrittori, storici, sognatori e viaggiatori occidentali, un altrove eccessivo e insopprimibile1. Nuovamente, non si tratta soltanto di riflettere sull’esistenza di altri mondi, o semplicemente di ingrandire il mio affinché ne contenga altri: significa metterlo in discussione per esporre le radici stesse, nonché i percorsi, del mio pensiero. La mia libertà di pensare, il senso di esserci sono circoscritti da questo senso di casa e dalla sua versione della storia e dell’appartenenza. Rimanere qui a questo punto, come sottolinea Lévinas nella sua critica a Essere e tempo di Heidegger, equivale a limitare la libertà a una libertà egocentrica di pensare, e quindi a indurre il mondo a una comprensione soggettiva, a un’ontologia occidentale che riduce l’altro 1 Sulla relazione tra testi storici e sogni, si veda Michel de Certeau 1975. SULLA SOGLIA allo stesso1. In questo caso, ciò che incontro rimane asservito ai concetti che rendono la mia casa riconoscibile come casa mia. Per evitare di costruire un ulteriore edificio liberale, ora decorato con tinte multiculturali, devo affrontare l’altro in quanto altro, “che supera l’idea dell’Altro in me” (Lévinas 1961, p. 48, corsivo nell’originale). Questo significa mischiare il mio tempo con un altro tempo, piegare il mio pensiero dinanzi la presenza di un altro, introdurre una dinamica che non posso possedere. Quell’eccesso è ciò che, trascinandomi al di là di me stesso, segnala la strada tra la totalità e l’infinito, tra ciò che è possibile possedere e dominare e ciò che mi interroga con la sua libertà. La voce dell’altro è “esiliata ai bordi del discorso [che] rifluirebbe e, con essa, il mormorio e i ‘rumori’ da cui si distingue la riproduzione scritturale. Così un’esteriorità senza inizio né verità tornerebbe a visitare il discorso” (de Certeau 1975, p. 257). Quest’apertura verso l’alterità, verso ciò che va oltre me, è un’apertura al desiderio, lontana dall’economia ristretta del pensiero; è il riconoscimento di ciò che eccede la comprensione neutrale della verità e invoca qualcosa di più, qualcosa di diverso: un’infinità prodotta dal desiderio. Non un desiderio di possedere, bensì un desiderio di infinito che invece di essere appagato viene stimolato (Lévinas 1961, p. 48). Essendo stimolato e costretto a pensare al di là di me stesso e del possesso della storia, della cultura e dell’identità che lo rende in1 In Totalità e Infinito, Lévinas (1961) critica in toto l’oeuvre di Heidegger, non soltanto Essere e tempo, a causa di una conoscenza reificata della libertà costantemente subordinata all’appropriazione dell’Essere che è in grado di riconoscere l’altro, e quindi la tematica della giustizia, dell’etica, unicamente in termini del suo sé. Una tale riconciliazione tra “la libertà e l’obbedienza, nel concetto di verità, presuppone il primato del Medesimo nel quale vive abitualmente tutta la filosofia occidentale e dal quale essa è definita” (p. 43). Lévinas prosegue: “Filosofia del potere, l’ontologia, come filosofia prima che non mette in questione il Medesimo, è una filosofia dell’ingiustizia. L’ontologia heideggeriana che subordina il rapporto con Altri alla relazione con l’essere in generale – anche se si oppone alla passione tecnica, venuta dall’oblio dell’essere nascosto dall’ente – resta all’interno della obbedienza dell’anonimo e porta, fatalmente, ad un’altra potenza, al dominio imperialista, alla tirannia. Tirannia che non è l’estensione pura e semplice della tecnica e degli uomini deificati. Essa risale a degli ‘stati d’animo’ pagani, al radicamento nel suolo, all’adorazione che gli uomini ridotti in schiavitù potevano consacrare ai loro padroni” (pp. 44-45). Tuttavia, Lévinas stesso presta il fianco allo stesso tipo di obiezioni. Come osservano sia Elizabeth Grosz (1995b) che Simon Critchley (1991), l’evitamento di Lévinas dell’alterità femminile ne restringe il campo del pensiero a ciò che ha coerentemente tentato di evitare: l’economia dello stesso. IAIN CHAMBERS telligibile solamente ai miei interessi, mi ritrovo in un’apertura che rende la mia comprensione, le presunzioni della mia storia, il mio senso dell’essere, raccontabili a un altro, che li rende differenti. La mia storia viene interrotta, le sue pretese sul mondo sradicate; non più unica, è portata a rendere conto di un incontro che non è più in grado di controllare, di rappresentare appieno, ma che non può più escludere. Mettendo in atto un significato indipendente dal mio potere, l’incontro con l’alterità supera radicalmente la semplice estensione del mio mondo che include l’altro, perché ricevo dall’altro una storia che non è mia, una storia che mi insegna ad accogliere ciò che fuoriesce dagli argini del mio egoismo e che quindi, come ribadisce Lévinas, incoraggia la mia libertà: “chiamandola alla responsabilità, la instaura e la giustifica” (p. 202). In ciò che rifiuta di essere contenuto è sita la disgiunzione radicale tra il domestico e l’estraneo, tra il viaggio di ritorno verso la casa e l’interminabile apprendistato dell’eterno movimento oltre il mio sé. Lo straripamento del perturbante, l’eccesso del sublime, trabocca in uno specchio scuro che svela un tormento storico radicato nelle pieghe stesse della modernità. I volti, i corpi degli altri rifiutano di svanire: persistono, ritornano, eppure, la tentazione è di ritrarsi. Ci sentiamo minacciati da ciò che non siamo in grado di contenere. La ragione consiglia la resistenza. Avvertiamo la necessità di appartenere, di essere residenti, abitanti di un luogo sicuro. La casa ci attira verso questo senso dell’appartenenza. Sentirsi a casa significa possedere sia lo spazio fisico che quello simbolico in cui ci si muove, nonché dipenderne per il senso del sé. Per questo lo spaesamento è raramente il benvenuto. Il mondo dell’ibridazione e dell’incertezza interstiziale è raramente una scelta, piuttosto una condizione in cui ci si ritrova. Ma, a questo punto, che cos’è esattamente “casa”? Casa per chi, e per cosa? Inevitabilmente considerata il sito della continuità, della tradizione e della famiglia, del sangue e dell’appartenenza, la casa è il sito in cui si conserva una concezione narcisista della vita. In questa riproduzione dello stesso, l’evocazione della “quadratura” di Heidegger, che insiste sul fatto che siamo sulla terra e sotto il cielo, può attirarci in un senso di casa che varca i ristretti confini del conservatorismo egocentrico. Questo perché qui il locale non SULLA SOGLIA viene relegato entro i limiti della famiglia, degli amici e degli ambienti che frequentiamo, bensì nei confini imposti dall’esistenza terrestre, dalla storia e dalla mortalità. Il suolo natio non è un luogo di nascita individuale, bensì il luogo di una provenienza terrena e un modo di abitare che, per riecheggiare le parole di Zarathustra, afferma “rimanete fedeli alla Terra” (Nietzsche 1886b, p. 6). Lo spazio tra la familiarità desiderata del primo e la perturbante disseminazione del secondo è altresì lo spazio in cui le memorie e i corpi repressi prorompono per dare voce alla sopravvivenza e alla promessa di continuare a vivere: uno spazio per il crescente numero di persone per le quali la casa non è un luogo semplice o ovvio. Rispondere agli scritti contemporanei di Toni Morrison e di Derek Walcott significa riconoscere che il mio senso dell’essere a casa e la fiduciosa affermazione del mio posto nel mondo sono inevitabilmente un beneficio goduto al prezzo dell’esilio, dell’estraniamento, della diaspora di qualcun altro. Ascoltare il linguaggio di autori del genere significa registrare un senso di casa che complica le semplicistiche frontiere delle appartenenze, a livello nazionale quanto a livello più locale. Un poeta creolo esce dai margini della Storia per passeggiare sulle coste caraibiche e annunciare una verità scomoda: Ora non avevo altra nazione che l’immaginazione. Dopo l’uomo bianco, i negri non mi vollero quando il potere girò dalla loro parte. Il primo mi incatena le mani e si scusa, “La Storia”; gli altri non mi giudicavano nero abbastanza per il loro orgoglio. (…) Ho incontrato la Storia, una volta, ma non mi ha riconosciuto, un creolo incartapecorito, pieno di verruche come una vecchia bottiglia di mare, che strisciava come un granchio nei buchi d’ombra proiettati dalla rete di un balcone a inferriata; color crema il vestito e il cappello. Lo abbordo e grido: “Sono Sabine, signore! dicono che sono suo nipote. Si ricorda la nonna, la sua cuoca nera?”. La troia si raschiò la gola e sputò. Uno sputo così vale tutte le parole. Ma questo ci hanno lasciato quei bastardi: parole (Walcott 1992a, p. 123). IAIN CHAMBERS Rispondere a questo linguaggio, alla necessità che emerge nella dimora linguistica, storica e culturale in cui risiedo anch’io (l’inglese) non significa cercare l’espiazione per mezzo della spiegazione della colpa (e del beneficio del perdono che ne consegue), bensì sollecitare un risposta, e una responsabilità per le condizioni che costituiscono la mia identità, permettendomi di sentirmi “a casa”. Ascoltare e cercare una risposta in questa condizione significa chiaramente mettere in discussione l’ovvietà della mia “identità” e la naturalezza delle mie “origini”. In una particolare storia e in un particolare corpo, mi ritrovo nella temporalità coeva, gettato in uno stato di transito privo della garanzia di un punto di origine e di arrivo fissi. La mia storia, la mia identità, il mio linguaggio, la mia casa si dispiegano. Le radici mettono i rami, si avvinghiano ad altre. Un luogo nel mondo La svolta del linguaggio e nel linguaggio è un passo iniziale dalle conseguenze incalcolabili. Comprende qualcosa che non può essere contenuto nell’incipiente formalismo dell’idea, frequentemente nominata, di una “svolta linguistica”. Perseverare nel sostenere che una trasformazione del pensiero sia un argomento linguistico significa evitare di riconoscere l’irreversibile disfacimento di tutte le concezioni linguistiche del linguaggio, della comunicazione e del significato, e di conseguenza la profonda radicalità di questa “svolta”1. In questo disconoscimento critico, il linguaggio, in quanto discorso, scrittura, rappresentazione, articolazione, in quanto annuncio del nostro essere e del nostro divenire, vira dalla rassicurante conferma che riduce il mondo a un mezzo trasparente e alla sua grammatica della certezza. Nel linguaggio, ognuno di noi salpa per il mare aperto, seguendo varie correnti, esposto nella vulnerabilità delle sue storie, navigando verso i limiti della casa, dell’abitazione. 1 Si tratta di una “svolta” sostenuta da molti nomi (da Heidegger e Lévinas a Foucault, Derrida, Irigaray e Cixous) e movimenti: dal decostruzionismo al femminismo, nonché tutti i vari “post-” che raccolgono l’eredità della critica di Nietzsche dell’idealismo filosofico e delle concezioni soggettive del linguaggio. SULLA SOGLIA Alla fine di questa frase, comincerà la pioggia. All’orlo della pioggia, una vela (Walcott 1992b, p. 151). A Barbès, a dieci minuti a piedi dalla Gare du Nord a Parigi, recentemente ingrandita per comprendere anche la Gare du Londres da cui partono i treni Eurostar ad alta velocità per Waterloo in un viaggio attraverso la Manica della durata di due ore e cinquanta minuti, è possibile vedere scribi arabi seduti agli angoli delle strade. I loro clienti, come i clienti di chi era attorno agli uffici governativi negli anni Cinquanta a Porto di Spagna, Trinidad, descritti da V. S. Naipaul oppure, per restare in tema, nella Napoli di oggi, sono gli analfabeti. Per una piccola cifra, gli scribi compilano i moduli per le richieste ufficiali e mettono in moto la macchina burocratica. Tuttavia questo scriba sulla strada parigina, con il suo banco portatile contenente carta, penne e inchiostro, seduto su un basso sgabello pieghevole, attende di scrivere lettere di tipo più personale, perché non scrive le richieste nella lingua ufficiale, il francese, bensì lo fa adoperando la calligrafia araba, con movimenti attenti, solcando il foglio da destra a sinistra. Non l’ho praticamente mai visto all’opera. Forse l’oralità transnazionale del telefono ha preso il posto che una volta competeva alla corrispondenza dettata. Forse l’analfabetismo e la necessità di queste capacità formali stanno scemando. Qualunque sia la ragione, resto colpito dalla presenza di questa scrittura in una strada parigina moderna che apparentemente è così distante dai linguaggi metropolitani che la circondano e minacciano di sommergerla: treni ad alta velocità, il Métro, il traffico, la calca dei pedoni. Con i sandali ai piedi, il turbante in testa, avvolto nella djellaba per ripararsi dal freddo autunnale, seduto di fronte a una scuola nuova di zecca, un’opera architettonica postmoderna fatta di tubi d’acciaio multicolore, la dignità immobile di questo scriba pubblico sottolinea la presenza inquietante dell’estraneo. La sua penna, la sua lingua, il suo essere sono a me contemporanei. Potrei girarmi dall’altra parte e fingere che non esista più: si tratta solamente di un curioso residuo della recente immigrazione dal “Terzo” mondo, dal Maghreb. Posso decidere di vedere nella sua presenza null’altro che l’intrusione dell’esotico e dell’arcaico nel mondano della modernità. Tuttavia, posso altresì rilevare un segno, non soltanto di un altro mondo in gran parte precluso ai miei sguardi e alla mia IAIN CHAMBERS comprensione, quanto di un linguaggio, e di una storia, che vanno in cerca di una risposta, e di una responsabilità, all’interno del mio mondo. In apparenza estraneo, questa città è chiaramente anche sua, certamente più di quanto non sia “mia”. Costretto a considerare la realizzazione composita dello spazio moderno per come viene a essere nello spazio cosmopolita chiamato Parigi, rilevo sia l’alterità che ne è parte integrante che la modernità che pretendo di possedere, perché lo scriba arabo seduto pazientemente in un angolo della città moderna occidentale non è un’anomalia storica. Separata, eppure collegata in maniera indissolubile, la sua presenza interrompe e al contempo ristruttura la mia storia, traducendo la chiusura della mia “identità” in un’apertura in cui incontro un altro che è nel mondo e che pure risulta irriducibile alla mia volontà. Adesso questa scena parigina non si limita a replicare la celebre descrizione, rievocata con tanta maestria da James Clifford ne I frutti puri impazziscono (1988), in cui Claude Lévi-Strauss, emigrato in tempo di guerra, rimane stupefatto vedendo un nativo americano con il capo ornato di piume che prende appunti con una Parker nella Biblioteca Pubblica di New York. Dalla ripetizione inattesa, eppure strutturalmente coerente, scaturisce qualcosa di più, che turba la conoscenza e il potere di cui si riveste la mia osservazione. Ma che cosa è successo a questo punto? Ho soltanto reso vicino e metropolitano ciò che era esotico? Ciò che una volta era una delle meraviglie di New York che attendeva di essere osservata e commentata, oggi può essere annoverata tra le meraviglie di Parigi? Questo scriba arabo è ancora una volta la testimonianza silenziosa, l’oggetto inerte del mio discorso, un semplice prodotto dello sguardo occidentale intento a spiegare il mondo che lo circonda in termini tali da riconfermare la centralità della propria soggettività? Oppure nei linguaggi della metropoli, della modernità, ha luogo un incontro che va al di là di qualsiasi significato che io cerchi di attribuire all’evento? In questo spazio ambiguo, nel quale il passaggio storico tradisce e sconcerta l’agognata trasparenza della traduzione, rilevo i limiti storici e culturali della mia voce, delle mie pretese sul mondo. Lo scriba arabo come referente del mio discorso si protende verso di me e si ritrae da me al contempo, funge sia da oggetto della mia narrazione che da soggetto in un mondo che non sarà mai semplicemente SULLA SOGLIA mio. Testimonia non soltanto il potere del mio sguardo, bramoso di una conferma egocentrica, ma anche l’intervallo che scaturisce tra di noi in quanto soggetti e che rende il mio linguaggio localizzabile e limitato. Forse un commento di Judith Butler (1997, p. 149) può contribuire a ricondurre su terreno familiare questa prospettiva: Questo solleva la questione politica del costo dell’articolazione di un’identità coerente producendo, escludendo e ricusando quegli spettri aberranti che minacciano il dominio arbitrariamente chiuso delle posizioni del soggetto. Forse soltanto rischiando l’incoerenza dell’identità diviene possibile la connessione, un punto di vista politico che mette il relazione l’intuizione di Leo Bersani secondo cui solo il soggetto decentrato è disponibile per il desiderio. Non si tratta, è bene ribadirlo, del desiderio di possedere, bensì del desiderio di infinito che viene stimolato anziché appagato. Abitare in questa maniera in un posto, come luogo di storie represse che consentono alla mia di essere rappresentata, dove si registrano le tacite crudeltà dell’identità coerente, quindi anche luogo che citerà eternamente il perturbante, significa cercare di attingere dalla storia una politica del soddisfacimento il cui esito non è mai dato conoscere appieno in anticipo (Gilroy 1993c). Sono queste le condizioni per una partenza critica incerta, non per un arrivo garantito. In questo supplemento, in cui si incrociano e contaminano estetica ed etica, cultura e politica, progetto e desiderio, luogo e limitazione, quello che va al di là delle parole, l’indecifrabile, il non rappresentabile e l’incoerente mette in imbarazzo l’identificazione con la prevedibile omogeneità di ciò che è noto, facendoci intravedere qualcos’altro, qualcosa di ulteriore, qualcosa di più. Queste sono le ombre silenziose che ci accompagnano e che a volte prorompono in canto, trovano forma nella danza, palpitano nel ritmo. I linguaggi di questo supplemento, questa cosa che va al di là del razionale e dello strumentale, vengono sottratti agli artigli della storia nell’istante in cui il politico e il poetico non soltanto coesistono, ma si intersecano e si rielaborano reciprocamente in una mutua configurazione. Una siffatta apertura, momento di creazione, non è solamente ciò che scaturisce dagli interstizi ibridi della vita tra mondi, tra la IAIN CHAMBERS tradizione stabile e il progresso, tra l’essenza “autentica” e gli stili di vita “corrotti”. C’è piuttosto una rielaborazione in entrambi i termini dell’equazione, di modo che la tradizione stessa diviene un elemento di modifica, un “elemento di libertà” (Gadamer 1965). Seppure sempre interrotta dalla modernità, la tradizione fornisce le risorse per interrompere e al contempo imporre alla modernità i suoi particolari imperativi. Nel film di Lee Tamahori sull’identità Maori contemporanea, Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri (1994), due fratelli celebrano un passato Maori maschile: uno riappropriandosi dei rituali tradizionali dei guerrieri dell’isola, l’altro riscrivendo e riproducendo questi rituali nei tatuaggi (essi stessi simboli ereditati della cultura dell’Oceania) e nei riti di iniziazione di una subcultura urbana. In ambedue i casi, le storie coeve, la relazione sincretica, sono registrate fortemente sia nella sintassi locale che in quella globale. Tale effetto viene ulteriormente amplificato nella musica reggae, che imperversa per tutta la durata della pellicola. In un ghetto urbano della Nuova Zelanda, una musica di questo tipo è sia modernità che tradizione, riguarda sia le comunicazioni (e i capitali) trans-nazionali di massa che la maniera in cui un siffatto spazio, offerto dalla musica rock internazionale, diviene anche un luogo particolare: una scena della memoria, del ricordo, in cui il suono caraibico dei non emancipati viene riprodotto nuovamente, ripetuto ed elaborato per avanzare un’altra promessa, sulle coste di un altro mare, in un altro emisfero. Torniamo adesso al romanzo Cerimonia di Leslie Silko e concludiamo. La cerimonia effettuata da Betonie, lo sciamano, è coerente con entrambe le tradizioni, eppure le ripudia: sia quella tribale che quella della modernità occidentale. Le storie, le narrazioni che operano su entrambi i lati del presunto spartiacque, che tentano di legittimare i miti e i saperi rispettivi, sia quelli che portano il nome dell’arcaico che coloro che recano il nome del progresso, sono fatalmente incomplete. Da questo fatto scaturisce un interrogativo che si muove in entrambe le direzioni, turbando contemporaneamente le presunzioni sia del “tradizionale” che del “moderno”. In entrambi i casi, emerge un’identità in cui non si garantisce più una relazione con la terra per mezzo del sangue, della razza e del suolo, né delle pretese del possesso. Ormai è la storia, la narrazione, la maniera di raccontare che riafferma la me- SULLA SOGLIA moria, e quindi la perdita, mentre rappresenta e propaga l’iscrizione – sul corpo, nella cerimonia, nella voce, nel silenzio che accompagna e rafforza ogni espressione – che ricorda e allo stesso tempo trasforma il mito della nostra casa e delle nostre origini in un insediamento incerto in divenire. Bibliografia Nel testo, l’anno che accompagna i rinvii bibliografici secondo il sistema autore-data è sempre quello dell’edizione in lingua originale, mentre i rimandi ai numeri di pagina si riferiscono sempre alla traduzione italiana, qualora negli estremi bibliografici qui sotto riportati vi si faccia esplicito riferimento. Achebe, C., 1988, Anthills of the Savannah, London, Heinemann. Ackroyd, P., 1985, Hawksmoor, London, Abacus. Agamben, G., 1970, L’uomo senza contenuto, Milano, Rizzoli. Alberti, L. B., 1436 (1975), De pictura, Roma-Bari, Laterza. Althusser, L., 1965, “Marxisme et humanisme”, in id., a cura, Pour Marx, Paris, Maspero; trad. it. di F. Madonna, 1967, “Marxismo e umanesimo”, in Per Marx, Roma, Editori Riuniti. Amery, T., 1997, The Map is Not the Territory, «Third Text», 40, autunno. Anderson, B., 1983, Imagined Communities, London, Verso; trad. it. di M. Vignale, 1996, Comunità immaginate: origini e fortuna dei nazionalismi, Roma, Manifestolibri. Ang, I., 1994, On Not Speaking Chinese, «New Formations», 24, inverno. Angoulvent, A. L., 1994, L’esprit baroque, Paris, Presses Universitaires de France; trad. it. di G. Nesi, 1996, Il barocco, Bologna, il Mulino. Ankersmit, F., Kellner, H., a cura, 1995, A New Philosophy of History, London, Reaktion Books. Anzaldúa, G., 1987, “To Live in the Borderline Means You”, in Borderlands: La Frontera: The New Mestiza, San Francisco, Aunt Lute Books. Appadurai, A., 1996, Modernity at Large, Minneapolis, University of Minnesota Press; trad. it. di P. Vereni, 2001, Modernità in polvere, Roma, Meltemi. Arendt, H., 1952, The Origins of Totalitarianism, New York, Hartcourt Brace; trad. it. di A. Guadagnin, 1996, Le origini del totalitarismo, Milano, Edizioni di Comunità. Austin, J. L., 1976, How to Do Things with Words, Oxford, Oxford University Press; trad. it. 1978, Gli atti linguistici: aspetti e problemi di filosofia del linguaggio, a cura di M. Sbisa, Milano, Feltrinelli. Bachelard, G., 1957, La poétique de l’espace, Paris, Presses Universitaires de France; trad. it. di E. Catalano, 1975, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo. Barthes, R., 1973, “Myth Today”, in Mythologies, London, Paladin. Bataille, G., 1991, Reflections on the Executioner and the Victim, «Yale French Studies», 79. Benjamin, W., 1928, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. it. di F. Cuniberto, 1999, Il dramma barocco tedesco, Torino, Einaudi. BIBLIOGRAFIA Benjamin, W., 1950, Berliner Kindheit um Neunzehnhundert, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. it. di M. Bertolini Peruzzi, 1981, Infanzia berlinese, Torino, Einaudi. Benjamin, W., 1955a, “Uber den Begriff des Geschichte”, in Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. it. di R. Solmi, 1995, “Tesi sulla filosofia della storia”, in Angelus Novus, Torino, Einaudi. Benjamin, W., 1955b, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”, in Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. it. di E. Filippini, 1991, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi. Benjamin, W., 1955c, “Die Aufgabe des Übersetzers” in Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. it. di R. Solmi, 1995, “Il compito del traduttore”, in Angelus Novus, Torino, Einaudi. Benjamin, W., 1955d, “Charles Baudelaire”, in Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag; trad. it di R. Solmi, 1995, “Di alcuni motivi in Baudelaire”, in Angelus Novus, Torino, Einaudi. Benveniste, É., 1973, Indo-European Language and Society, London, Faber & Faber. Bergemann, G., 1967, “Logical Positivism, Language and the Reconstruction of Metaphysics”, in R. Rorty, a cura, The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, Chicago, University of Chicago Press. Berkhoffer, R. F., Jr., 1995, Beyond the Great Story: History as Text and Discourse, Cambridge (Mass.), Harvard University Press. Bhabha, H. K., 1994, The Location of Culture, London-New York, Routledge; trad. it. di A. Perri, 2001, I luoghi della cultura, Roma, Meltemi. Bhabha, H. K., 1996, “Unpacking My Library… Again”, in I. Chambers, L. Curti, a cura, The Post-colonial Question. Common Skies, divided horizons. London-New York, Routledge; trad. it. di L. Curti, M. M. Parlati, 1997, “Togliendo i libri dalle casse… di nuovo”, in I. Chambers, L. Curti, a cura, La questione post-coloniale: cieli comuni, orizzonti divisi, Napoli, Liguori. Bhabha, H. K, 1998, “Anish Kapoor: Making Emptiness”, in Anish Kapoor, Los Angeles-London, Haywood Gallery/University of California Press. Bhaskar, R., 1975, A Realist Theory of Science, Leeds, Leeds Books. Bianconi, L., 1982, Storia della musica. Volume quarto. Il Seicento, Torino, E.D.T. Blau, J., 1999, Illusions of Prosperity: America’s Working Families in an Age of Economic Insecurity, New York, Oxford University Press. Bowie, A., 1989, “Music, Language and Modernity”, in A. Benjamin, a cura, The Problems of Modernity: Adorno and Benjamin, London-New York, Routledge. Bowie, A., 1995, Romanticism and Technology, «Radical Philosophy», 70, luglio/agosto. Bowie, A., 1997, The Philosophy of German Literary Theory, London-New York, Routledge. Boyarin, J., 1992, Storm from Paradise: The Politics of Jewish Memory, Minneapolis, University of Minnesota Press. Brecher, B., 1999, Understanding the Holocaust: The Uniqueness Debate, «Radical Philosophy», 96. Bromley, S., 1996, Globalization?, «Radical Philosophy», 80, novembre/dicembre. BIBLIOGRAFIA Buchanan, I., 1997, De Certeau and Cultural Studies, «New Formations», 31. Buchanan, R., 1995, Border Crossings: NAFTA, Regulatory Reconstructing, and the Politics of Place, «Global Legal Studies Journal», 2 (2). Buci-Glucksmann, C., 1984, La Raison Baroque: de Baudelaire à Benjamin, Paris, Éditions Galilée; trad. it. di C. Gazzelli, 1992, La ragione barocca, Genova, Costa & Nolan. Buci-Glucksmann, C., 1990, Tragique de l’ombre, Paris, Éditions Galilée. Buci-Glucksmann, C., 1992, L’Enjeu du beau: Musique et Passion, Paris, Éditions Galilée. Buck-Moss, S., 1989, The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project, Cambridge (Mass.)-London, MIT Press. Burgin, V., 1990, “Geometry and Abjection”, in J. Fletcher, A. Benjamin, a cura, Abjection, Melancholia and Love: The Work of Julia Kristeva, London-New York, Routledge. Burgin, V., 1996, In/Different Places, Los Angeles-London, University of California Press. Burke, E., 1759, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful; trad. it. 1985, Inchiesta sul bello e sul sublime, Palermo, Aesthetica. Butler, J., 1990, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, London-New York, Routledge. Butler, J., 1993, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”, LondonNew York, Routledge; trad. it. di S. Capelli, 1996, Corpi che contano: I limiti discorsivi del sesso, Milano, Feltrinelli. Butler, J., 1997, The Psychic Life of Power, Stanford (Ca.), Stanford University Press. Canclini, N., 1995, Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity, Minneapolis, University of Minnesota Press. Cantone, G., 1992, Napoli barocca, Bari, Laterza. Carchia, G., 1982, La legittimazione dell’arte, Napoli, Guida. Carter, P., 1996, The Lie of the Land, London, Faber & Faber. Cassano, F., 1996, Il pensiero meridiano, Roma, Laterza. Celan, P., 1978, The Meridian, «Chicago Review», inverno. Chambers, I., 1985, Urban Rhythms, London, Macmillan; trad. it. di P. Prato, 2003, Ritmi urbani, Roma, Arcana. Chambers, I., 1993, The Interruption, Napoli, CILA (Centro Interdipartimentale dei servizi Linguistici e Audiovisivi, Istituto Universitario Orientale). Chambers, I., 1994, Migrancy, Culture, Identity, London-New York, Routledge; trad. it. 2003, Paesaggi migratori, Roma, Meltemi. Chambers, I., 2000, “At the End of This Sentence a Sail Will Unfurl”, in P. Gilroy, L. Grossberg, A. McRobbie, a cura, Without Guarantees: In Honour of Stuart Hall, London-New York, Verso. Chatwin, B., 1981, “Introduction”, in R. Byron, a cura, The Road to Oxiana, London, Picador; trad. it. 1993, “Lamento per l’Afghanistan”, in La via dell’Oxiana, Milano, Adelphi. Chatwin, B., 1987, The Songlines, London, Picador; trad. it. di S. Gariglio, 1988, Le vie dei canti, Milano, Adelphi. BIBLIOGRAFIA Cheung, K. K., 1993, Articulate Silences: Hisaye Yamamoto, Maxine Hong Kingston, Joy Kogawa, Ithaca (N.Y.)-London, Cornell University Press. Chow, R., 1993, Writing Diaspora, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press. Chow, R., 1995, Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Ethnography, and Contemporary Chinese Cinema, New York, Columbia University Press. Chow, R., 1998, “Theory, Area Studies, Cultural Studies: Issues of Pedagogy in Multiculturalism”, in Ethics After Idealism, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press. Cixous, H., 1997, Rootprints, Memory and Life Writing, London-New York, Routledge. Cixous, H., Clément, C., 1987, The Newly Born Woman, Manchester, Manchester University Press. Clarke, D. B., Doel, M. A., McDonough, F. X., 1996, Holocaust Topologies: Singularity, Politics, Space, «Political Geography», 15 (6/7). Clément, C., 1988, Opera, or the Undoing of Women, Minneapolis, University of Minnesota Press. Clifford, J., 1988, The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, Cambridge, Harvard University Press; trad. it. di M. Marchetti, 1993, I frutti puri impazziscono: etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri. Clifford, J., 1997, “Palenque Log”, in J. Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge (Mass.), Harvard University Press; trad. it. 1999, “Diario di viaggio a Palenque”, in Strade: viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri. Connery, C., 1998, The Empire of the Text: Writing and Authority in Early Imperial China, Lanham (Md), Rowman & Littlefield. Corradi Fiumari, G., 1985, La Filosofia dell’ascolto, Milano, Jaca Books. Critchley, S., 1991, “‘Bois’ - Derrida’s Final Word on Levinas”, in R. Bernasconi, S. Critchley, a cura, Re-Reading Levinas, Bloomington-Indianapolis, University of Indiana Press. Curti, L., 1990, “Imported Utopias”, in Z. Baransky, R. Lumley, a cura, Culture and Conflict in Postwar Italy: Essays in Popular and Mass Culture, London, Macmillan. Danto, A., 1962, Narrative Sentences, «History and Theory», 2. Darian-Smith, K., Gunner, L., Nuttal, S., 1996, “Introduction”, in id., a cura, Texts, Theory, Space, London-New York, Routledge. Dart, T., 1963, The Interpretation of Music, New York, Harper & Row. Davis, M., 1992, City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, London, Vintage. Davis, M., 1999, Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster, New York, Vintage. de Certeau, M., 1975, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard; trad. it. di A. Jeronimidis, 1977, La scrittura della storia, Roma, Il Pensiero Scientifico. Deleuze, G., 1988, Le Pli: Leibniz et le Baroque, Paris, Éditions de Minuit; trad. it. di V. Gianolio, 1990, La Piega: Leibniz e il Barocco, Torino, Einaudi. BIBLIOGRAFIA De Man, P., 1983, “The Rhetoric of Temporality”, in Blindness and Insight, London, Methuen; trad. it. di E. Saccone, 1975, “La retorica della temporalità”, in Cecità e visione: linguaggio letterario e critica contemporanea, Napoli, Liguori. Derrida, J., 1994, “Letter to Peter Eisenman”, in W. Lillyman, M. Moriarty, D. Neuman, a cura, Critical Architecture and Contemporary Culture, New YorkOxford, Oxford University Press. Derrida, J., 1996, discorso tenuto all’Institut Français, Napoli, 4 novembre. Descartes, R., 1650, Compendium musicae, Utrecht; trad. it. di L. Zanoncelli, 1990, Breviario di musica, Firenze, Passigli. Docherty, T., 1986, John Donne, Undone, London-New York, Methuen. Dolar, M., 1991, “I Shall Be with You on Your Wedding Night”: Lacan and the Uncanny, «October», autunno. Donald, J., 1999, Imagining the Modern City, London, Athlone Press. Donington, R., 1978, A Performer’s Guide to Baroque Music, London, Faber & Faber. Donne, J., 1611a, “An Anatomie of the World: The First Anniversary”; trad. it. di R. Tavelli, 1995, “Un’anatomia del mondo: il primo anniversario”, in Poesie sacre e profane, Milano, Feltrinelli. Donne, J., 1611b, “Song”; trad. it. 1992, “Canzone”, in Liriche sacre e profane. Anatomia del mondo. Duello della morte, Milano, Mondadori. Eisenstein, Z., 1998, Global Obscenities: Patriarchy, Capitalism and the Lure of Cyberfantasy, New York, New York University Press. Elliot, G., 1998, On the Posthumous Editing of Althusser’s Writings, «Radical Philosophy», 90. Erdrich, L., 1995, The Bingo Palace, London, Flamingo. Ermath, E., 1992, Sequel to History: Postmodernism and the Crisis of Representational Time, Princeton (N.J.), Princeton University Press. Fabian, J., 1983, Time and the Other: How Anthropology Makes its Object, New York, Columbia University Press; trad. it. di L. Rodeghiero, 2000, Il tempo e gli altri: la politica del tempo in antropologia, Napoli, L’ancora del Mediterraneo. Fabian, J., 1999, Remembering the Other: Knowledge and Recognition in the Exploration of Central Africa, «Critical Inquiry», 26 (1). Fanon, F., 1952, Peau noire, masques blanches, Paris, Seuil; trad. it. di M. Sears, 1996, Pelle nera, maschere bianche: il nero e l’altro, Milano, Marco Tropea. Felman, S., Laub, D., 1992, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York-London, Routledge. Flora, N., Giardiniello, P., Postiglione, G., a cura, 1999, Glenn Murcutt: Disegni per otto case, Napoli, Clean Edizioni. Foucault, M., 1966, Les mots et les choses, Paris, Gallimard; trad. it. 1967, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano, Rizzoli. Freeman, B. C., 1995, The Feminine Sublime, Los Angeles-London, University of California Press. Freud, S., 1914, Erinnern, Wiederholen, und Durcharbeiten, «Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse», 2; trad. it. 1989, “Ricordare, ripetere e rielaborare”, in Opere, 7. 1912-1914, Torino, Bollati Boringhieri. BIBLIOGRAFIA Freud, S., 1919, Das Unheimliche, «Imago», 5 (5-6), pp. 297-324; trad. it. di S. Daniele, 1986, “Il perturbante”, in Opere, 9. 1917-1923, Torino, Bollati Boringhieri. Freud, S., 1930, Das Unbehagen in der Kultur, Wien, Internationaler Psychoanalytischer Verlag; trad. it. 1985, Il disagio della civiltà, Torino, Bollati Boringhieri. Friedlander, S., a cura, 1992, Probing the Limits of Representation: The Holocaust Debate, Cambridge (Mass.), Harvard University Press. Fry, T., 1993, “Introduction”, in id, a cura, R/U/A TV? Heidegger and the Televisual, Sydney, Power Publications. Fumaroli, M., 1994, L’École du silence, Paris, Flammarion. Gadamer, H. G., 1965, Wahrheit und Methode, Tübingen, J.C.B. Mohr; trad. it. 1972, Verità e metodo, Milano, Fabbri. Garlake, P., 1995, The Hunter’s Vision: The Prehistoric Art of Zimbabwe, London, British Museum Press. Gassendi, P., 1992, Initiation à la théorie de la musique, Aix-en-Provence, Édisud. Geiger, J., 1998, The Camera and Man: Colonialism, Masculinity and Documentary Fiction, «Third Text», 42, primavera. Gifford, P., 1998, African Christianity: Its Public Role, London, Hurst. Gilroy, P., 1993a, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, London, Verso; trad. it. di M. Mellino, L. Barberi, 2003, The Black Atlantic: l’identità nera tra modernità e doppia coscienza, Roma, Meltemi. Gilroy, P., 1993b, Small Acts: Thoughts on the Politics of Black Cultures, London, Serpent’s Tail. Gilroy, P., 1993c, “Art of Darkness: Black Art and the Problem of Belonging to England”, in Small Acts: Thoughts on the Politics of Black Cultures, London, Serpent’s Tail. Gilroy, P., 1994, “After the Love has Gone”, Biopolitics and Ethopoetics in the Black Public Sphere, «Third Text», 28/29, autunno/inverno. Girard, C., 1997, “Traversing the Screens”, nel catalogo di film+arc.+graz. 3 Internationale Biennale, Graz. Greenblatt, S., 1992, Marvellous Possession: The Wonder of the New World, Oxford, Oxford University Press; trad. it. di G. Arganese, M. Cupellaro, 1994, Meraviglia e possesso: lo stupore di fronte al Nuovo Mondo, Bologna, il Mulino. Gregotti, V., 1999, L’identità dell’architettura europea e la sua crisi, Torino, Einaudi. Grosz, E., 1995a, “Women, Chora, Dwelling”, in S. Watson, K. Gibson, a cura, Postmodern Cities and Spaces, Oxford-Cambridge (Mass.), Blackwell. Grosz, E., 1995b, Ontology and Equivocation: Derrida’s Politics of Sexual Difference, «Diacritics», 25, estate. Gupta, A., 1994, “The Reincarnation of Souls and the Rebirth of Commodities: Representations of Time in ‘East’ and ‘West’”, in J. Boyarin, a cura, Remapping Memory: The Politics of Time Space, Minneapolis, University of Minnesota Press. Haar, M., 1993, The Song of the Earth: Heidegger and the Grounds of the History of Being, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press. BIBLIOGRAFIA Haas, B., 1995, Conquests and Historical Identities in California, 1763-1936, Los Angeles-London, University of California Press. Hage, G., 1996, The Spatial Imaginary of National Practices: Dwellings - Domesticating/Being - Exterminating, «Environmental and Planning D: Society and Space», 14 (4). Hall, C., 1992, White, Male and Middle Class: Explorations in Feminism and History, Cambridge, Polity Press. Hall, S., 1988, “New Ethnicities”, in K. Mercer, a cura, Black Film, British Cinema, BFI/ICA Documents 7, London, Institute of Contemporary Arts. Hall, S., 1996, “The Question of Cultural Identity”, in S. Hall, D. Held, D. Hubert, K. Thompson, Modernity: An Introduction to Modern Societies, Oxford-Cambridge (Mass.), Blackwell. Hallyn, F., 1993, The Poetic Structure of the World: Copernicus and Kepler, New York, Zone Books. Handelman, S. A., 1991, Fragments of Redemption: Jewish Thought and Literary Theory in Benjamin, Scholem, and Levinas, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press. Haraway, D., 1991, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, London, Free Association Books; trad. it. di L. Borghi, 1995, Manifesto Cyborg: donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Milano, Feltrinelli. Harvey, D., 1989, The Condition of Postmodernity, Oxford, Blackwell. Hays, M., 1986, “Foreword”, in P. Szondi, On Textual Understanding and Other Essays, Minneapolis, University of Minnesota Press. Hebdige, D., 1992, “Welcome to the Terrordrome: Jean-Michel Basquiat and the ‘Dark’ Side of Hybridity”, in R. Marshall, a cura, Jean-Michel Basquiat, New York, Whitney/Abrams. Heidbrink, L., 1994, Melancholie und Moderne: Zur Kritik der Historischen Verzweiflung, München, Wilhelm Fink. Heidegger, M., 1927, Sein und Zeit, Halle, Nyemeyer; trad. it. di P. Chiodi, 1970, Essere e tempo, Milano, Longanesi. Heidegger, M., 1939, “Vom Wesen und Begriff der ‘Physis’ Aristoteles, Physik B, 1”; trad. it. di F. Volpi, 1987, “Sull’essenza e sul concetto della Fusis Aristotele, Fisica, B, 1”, in Segnavia, Milano, Adelphi. Heidegger, M., 1946, “Brief über den Humanismus”, in Wegmarken, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann Verlag; trad. it. 1987, “Lettera sull’umanismo”, in Segnavia, Milano, Adelphi. Heidegger, M., 1950a, “Die Zeit des Weltbildes”, in Holzwege, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann Verlag; trad. it. di P. Chiodi, 1968, “L’epoca dell’immagine del mondo”, in Sentieri interrotti, Firenze, La Nuova Italia. Heidegger, M., 1950b, “Der Ursprung des Kunstwerks”, in Holzwege, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann Verlag; trad. it. di P. Chiodi, 1968, “L’origine dell’opera d’arte”, in Sentieri interrotti, Firenze, La Nuova Italia. Heidegger, M., 1954a, “Das Ding”, in Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, Verlag Günther Neske; trad. it. di G. Vattimo, 1976, “La cosa”, in Saggi e Discorsi, Milano, Mursia. Heidegger, M., 1954b, “Bauen, Wohnen, Dichten”, in Votraege und Aufsaetze, Pfullingen, Verlag Günter Neske; trad. it. di G. Vattimo, 1976, “Costruire, abitare, pensare”, in Saggi e Discorsi, Milano, Mursia. BIBLIOGRAFIA Heidegger, M., 1959, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, Verlag Günther Neske; trad. it. di A. Caracciolo, M. Caracciolo Perotti, 1990, In cammino verso il linguaggio, Milano, Mursia. Heidegger, M., 1961, Nietzsche, Pfullingen, Verlag Günter Neske; trad. it. di F. Volpi, 1994, Nietzsche, Milano, Adelphi. Heidegger, M., 1962a, “Die Frage nach der Technik”, in Die Technik und die Kehre, Pfullingen, Verlag Günther Neske; trad. it. di G. Vattimo, 1976, “La questione della tecnica”, in Saggi e discorsi, Milano, Mursia. Heidegger, M., 1962b, “Die Kehre”, in Die Technik und die Kehre, Pfullingen, Verlag Günther Neske; trad. it. di M. Ferraris, 1990, La svolta, Genova, Il melangolo. Heidegger, M., 1962c, “Die Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens”, in Zeit und Sein, conferenza del 1962, poi in AA.VV., 1968, L’éndurance de la pensée, Paris, Plon; trad. it. di E. Mazzarella, 1980, “La fine della filosofia e il compito del pensiero”, in Tempo ed essere, Napoli, Guida. Henderson, G., 1999, California and the Fictions of Capital, Oxford-New York, Oxford University Press. Hennion, A., 1993, La Passione musicale: une sociologie de la médiation, Paris, Éditions Métailié. Hill, C., 1969, The Century of Revolution, 1603-1714, London, Sphere. Horkheimer, M., Adorno, T. W., 1947, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Amsterdam, Querido Verlag; trad. it. di L. Vinci, 1966, Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi. Hosokawa, S., 1990, The Aesthetics of Recorded Sound, Tokyo, Keisõ Shobõ. Hulme, P., 1992, Colonial Encounters: Europe and the Native Carribean 14921797, London-New York, Routledge. Imrie, R., 2000, Disability and Discourses of Movement and Mobility, «Environment and Planning A», 32. Irigaray, L., 1980, Amante marine: de Friedrich Nietzsche, Paris, Éditions de Minuit; trad. it. 1981, Amante marina. Friedrich Nietzsche, Milano, Feltrinelli. Irigaray, L., 1983, L’Oubli de l’air, Paris, Éditions de Minuit. Islam, S., 1999-2000, Forming Minoritarian Communities: Nomadic Ethics for the Postcolonial World, «New Formations», 36, inverno. Isozaki, A., 1995, “Introduction: A Map of Crises”, in K. Karatani, Architecture as Metaphor: Language, Number, Money, trad. ingl. di Sabu Kohso, Cambridge (Mass.)-London, MIT Press. James, C. L. R., 1938, The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution, London, Allison & Busby; trad. it. di R. Petrillo, 1967, I giacobini neri: la prima volta contro l’uomo bianco, Milano, Feltrinelli. Jameson, F., 1992, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, London-New York, Verso. Jebb, M. A., a cura, 1996, Emerarra: A Man of Merrara, Broome, (Wash.), Megabala. Jenkins, K., 1997, “Introduction: On Being Open about our Closures”, in The Postmodern History Reader, London-New York, Routledge. Kant, I., 1790, Kritik der Urteislkraft; trad. it. di A. Gargiulo, 1982, Critica del giudizio, Bari, Laterza. BIBLIOGRAFIA Karatani, K., 1995, Architecture as Metaphor: Language, Number, Money, trad. ingl. di S. Kohso, Cambridge (Mass.)-London, MIT Press. Kellner, H., 1995, “Introduction: Describing Redescriptions”, in Ankersmit, Kellner, a cura, 1995. Kellner, H., 1997, “Language and Historical Representation”, in K. Jenkins, a cura, The Postmodern History Reader, London-New York, Routledge. Kristeva, J., 1984, The Revolution in Poetic Language, New York, Columbia University Press. Kristeva, J., 1987, Soleil noir: Dépression et mélancolie, Paris, Gallimard; trad. it. di A. Serra, 1988, Sole nero: depressione e malinconia, Milano, Feltrinelli. Kristeva, J., 1988, Étrangers à nous-même, Paris, Fayard; trad. it. di A. Serra, 1990, Stranieri a se stessi, Milano, Feltrinelli. Lacan, J., 1964, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Éditions du Seuil; trad. it. di S. Loadli, I. Molina, 1979, Lacan. Il seminario. I Quattro concetti fondamentali della psicanalisi, Torino, Einaudi. Laclau, E., 1990, New Reflections on the Revolution of our Time, London-New York, Verso. Lambert, G., 1995, The Culture of the Stranger: Reflections on European Aesthetic Ideology in the “New World”, tesi di dottorato, University of California, Irvine. Lazare, D., 1998, America the Undemocratic, «New Left Review», 232. Le Corbusier, 1925, Urbanisme, Éditions Vincent, Fréal & C.; trad. it. di A. Beltrami Raini, 1974, Urbanistica, Milano, il Saggiatore. Lefebvre, H., 1961, The Production of Space, Oxford, Blackwell. Lefebvre, H., 1968, L’irruption de Nanterre au sommet, Paris, Éditions Anthropos. Lefebvre, H., 1974, La Production de l’espace, Paris, Éditions Anthropos. Leslie, E., 1999, Space and West End Girls: Walter Benjamin versus Cultural Studies, «New Formations», 38, estate. Levi, P., 1987, “Afterword”, in If This is a Man e The Truce, London, Sphere (postfazione alla versione inglese di Se questo è un uomo e La tregua). Lévinas, E., 1961, Totalité et infini: essai sul l’exteriorité, La Haye, Biblio essai; trad. it. di A. Dell’Asta, 1980, Totalità e infinito: saggio sull’esteriorità, Milano, Jaca Book. Lipsitz, G., 1990, Time Passages, Minneapolis, University of Minnesota. Lozanovska, M., 1997, “Emigration/Immigration: Maps, Myths and Origins”, in Building Dwelling Drifting: Migrancy and the Limits of Architecture, conferenza tenuta alla University of Melbourne, 27 giugno 1997. Lyotard, J.-F., 1983, Le différend, Paris, Éditions de Minuit; trad. it. di A. Serra, 1985, Il dissidio, Milano, Feltrinelli. Lyotard, J.-F., 1996, “Otherness and the Postmodern Imagination”, in Identity and Difference, Triennale di Milano, XIX Esposizione internazionale, Milano, Electa. Lyotard, J.-F., 1997, “Domus and the Megalopolis”, in N. Leach, a cura, Rethinking Architecture, London-New York, Routledge. Maravall, J. A., 1975, La cultura del barroco: análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel; trad. it. di C. Paez, 1985, La cultura del barocco: analisi di una struttura storica, Bologna, il Mulino. BIBLIOGRAFIA Marin, L., 1977, Detruire la peinture, Paris, Galilée. Marx, K., 1953, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie: (Rohentwurf) 1857-1858, Berlin, Dietz Verlag; trad. it. di E. Grillo, 1968-70, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica: 1857-1858, Firenze, La Nuova Italia, vol. II. McCarthy, C., 1997, “Drawing and Quartering, ‘Mort Safes’ and Dissection Rooms: Divisions of the Anatomical and the Criminality of the Architectural Section”, relazione distribuita durante la conferenza Building Dwelling Drifting: Migrancy and the Limits of Architecture, University of Melbourne, 27 giugno 1997. McLean, I., 1998, Documenta X and Australians in Oxford: Thinking Globally from Europe, «Third Text», 42. Mercer, K., 2000, “A Sociography of Diaspora”, in P. Gilroy, L. Grossberg, Angela McRobbie, a cura, Without Guarantees: In Honour of Stuart Hall, London-New York, Verso. Mersenne, M., 1985, Questions Inouyes, Paris, Fayard. Michael, E., 1994, Bad Aboriginal Art: Tradition, Media and Technological Horizons, Minneapolis, University of Minnesota Press. Minh-ha, T. T., 1991, When the Moon Waxes Red, London-New York, Routledge. Mitchell, D., 1999, Dead Labor: Mobility, Violence, and the Political Economy of Landscape, relazione tenuta al Second Colloquium of the Centre for the Study of Spaces in Modernity, Gregynog, Newtown, Powys, 26-28 novembre 1999. Morales, A., 1992, The Brick People, Houston, (Tex.), Arte Publico Press. Moriarty, M., Neuman, D., a cura, 1994, Critical Architecture and Contemporary Culture, New York-Oxford, Oxford University Press. Morris, M., 1990, Metamorphoses at Sydney Tower, «New Formations», 11, estate. Morrison, V., 1990, “So Quiet in Here”, in Enlightenment, Polydor. Morrison, V., 1991, “On Hyndford Street”, in Hymns to the Silence, Polygram. Mosès, S., 1992, L’Ange de l’histoire: Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Paris, Seuil; trad. it. di M. Bertaggia, 1993, La storia e il suo angelo: Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Milano, Anabasi. Nafici, M., 1996, On the Sandy Surface of an Intertidal Zone, «Literary Review», 40 (1). Naipaul, V. S., 1995, A Way in the World, London, Minerva; trad. it. di M. Dallatorre, 1995, Una via nel mondo: Una sequenza, Milano, Adelphi. Nairn, T., 1981, The Break-up of Britain, London, Verso. Neske, G., Kettering, E., a cura, 1988, Antwort: Martin Heidegger im Gespräch, Pfullingen, Verlag Günther Neske; trad. it. di C. Tatasciore, 1992, Risposta: A colloquio con Martin Heidegger, Napoli, Guida. Nietzsche, F., 1886a, Jenseit von Gut und Bose; trad. it. di F. Masini, 1996, Al di là del bene e del male, Milano, Adelphi. Nietzsche, F., 1886b, Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen, Leipzig, Fritzsch; trad. it. 1988, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Milano, Adelphi. Nietzsche, F., 1906, Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe, Taschenausgabe, Nauman, vol. IX-X; trad. it. di A. Treves, 1996, La volontà di potenza, Milano, Bompiani. BIBLIOGRAFIA Novak, M., 1997, “TransArchitectures”, nel catalogo di film+arc.gra. 3 Internationale Biennale, Graz. O’Connor, N., 1988, “The Personal is Political”, in R. Bernasconi, D. Wood, a cura, The Provocation of Levinas, London-New York, Routledge. Onion, C. T., a cura, 1996, The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford, Clarendon Press. Page, C., 1998, Pasolini’s “Archaisms”: Representational Problematics from Naples to Calcutta, «Third Text», 42. Paz, O., 1988, “Fire by Friction”, in A Tree Within, New York, New Directions. Pedersen, H., Woorunmurra, B., 1995, Jandamarra and the Bunuba Resistance, Broome (Wash.), Magabela. Perniola, M., 1983a, La società dei simulacri, Bologna, Cappelli. Perniola, M., 1983b, “Icone, visioni, simulacri”, in Perniola 1983a. Prakash, G., 1996, Who’s Afraid of Postcoloniality?, «Social Text», 49, inverno. Purdom, J., 1995, Mapping Difference, «Third Text», 32, autunno. Quignard, P., 1992, Touts les matins du monde; trad. it. di G. Cillario, 1992, Tutte le mattine del mondo, Milano, Frassinelli. Rabinow, P., 1986, “Representations are Social Facts: Modernity and Postmodernity in Anthropology”, in J. Clifford, G. Marcus, a cura, Writing Culture, Los Angeles, University of California Press; trad. it. 1997, “Le rappresentazioni sono fatti sociali. Modernità e postmodernità in antropologia”, in Scrivere le culture, Roma, Meltemi. Ranger, T., 1996, “‘Great Spaces Washed with Sun’: The Matopos and Uluru Compared”, in K. Darian-Smith, L. Gunner, S. Nuttal, a cura, Text, Theory, Space, London-New York, Routledge. Ranger, T., 1999, Voices from the Rocks: Nature, Culture and History in the Matopos Hills of Zimbabwe, Harare, Bloomington-Indianapolis, Oxford, Baobab/Indiana University Press/James Currey. Reader, J., 1998, Africa, Harmondsworth, Penguin; trad. it. di M. Nicola, 2003, Africa: biografia di un continente, Milano, Mondadori. Rich, A., 1991, Eastern War Time, in An Atlas of the Difficult World, New YorkLondon, W. W. Norton. Ricoeur, P., 1983-84-85, Temps et récit, I, II, III, Paris, Seuil; trad. it. 1986-88, Tempo e racconto, Milano, Jaca Book Ricoeur, P., 1996, “Architecture and Narrative”, in Identity and Difference, Triennale di Milano, XIX Esposizione Internazionale, Milano, Electa. Rilke, R. M., 1922, Duineser Elegien, Frankfurt am Main, Insel Verlag; trad. it. di F. Rella, 1994, Elegie Duinesi, Milano, BUR. Rilke, R. M., 1993, “Für Helmuth freihern Lucius von Stoedten”, in Sämtliche Werke I-III, Frankfurt, Insel Verlag; trad. it. di G. Cacciapaglia, 1995, “Per il barone Helmuth Lucius von Stoedten”, in Poesie II (1908-1926), Torino, Einaudi-Gallimard. Robberechts, E., 1992, Savoir et mort chez F. Rosenzweig, «Revue Philosophique de Louvain», 90. Rorty, R., a cura, 1967, The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, Chicago, University of Chicago Press; trad. it. di S. Velotti, 1994, La svolta linguistica, Milano, Garzanti. BIBLIOGRAFIA Rose, J., 1996, States of Fantasy, Oxford, Clarendon Press. Rosenzweig, F., 1921, Der Stern der Erlösung, The Hague’s, Martinus Nijhoff; trad. it. di G. Bonola, 1986, La stella della redenzione, Casale Monferrato, Marietti. Rossi, P., 1991, Il passato, la memoria, l’oblio, Bologna, il Mulino. Rundell, J., 1997, Beyond Crisis, Beyond Novelty; The Tensions of Modernity, «New Formations», n. 31, primavera/estate. Rushdie, S., 1988, The Satanic Verses, New York, Viking; trad. it. di E. Capriolo, 1988, I versi satanici, Milano, Mondadori. Rushdie, S., 1991, Imaginary Homelands, London, Granta-Penguin; trad. it. di C. di Carlo, 1991, Patrie immaginarie, Milano, Mondadori. Ruskin, J., 1843, Modern Painters: their superiority in the art of landscape painting to all the Ancient Masters proved by examples of the True, the Beautiful, and the Intellectual from the works of modern artists, especially from those of J. M. W. Turner Esq., R.A., London, Elder & Co.; trad. it. di G. Leoni, 1998, Pittori moderni: volume primo, Torino, Einaudi. Ruskin, J., 1853, The Stones of Venice, London; trad. it. 1962, Le pietre di Venezia, Torino, UTET. Said, E., 1992, Musical Elaborations, London, Vintage. Said, E., 1994, Culture and Imperialism, London, Vintage; trad. it. di S. Chiarini, A. Tagliavini, 1998, Cultura e imperialismo: letteratura e consenso nel progetto coloniale dell’Occidente, Roma, Gamberetti. Saldívar, J. D., 1997, Border Matters: Remapping American Cultural Studies, Los Angeles-London, University of California Press. Sarduy, S., 1975, Barroco, Paris, Seuil; trad. it. 1980, Barocco, Milano, il Saggiatore. Schürmann, R., 1990, Heidegger: On Being and Acting: From Principles to Anarchy, Bloomington, Indiana University Press; trad. it. di G. Carchia, 1995, Dai principî all’anarchia: essere e agire in Heidegger, Bologna, il Mulino. Seed, P., 1995, Ceremonies of Possession in Europe’s Conquest of the New World, 1492-1640, Cambridge, Cambridge University Press. Sennett, R., 1995, Something in the City: The Spectre of Uselessness and the Search for a Place in the World, «Times Literary Supplement», 22 settembre. Silko Marmon, L., 1977, Ceremony, New York-London, Penguin; trad. it. di P. Ludovici, 1981, Cerimonia, Roma, Editori Riuniti. Simmel, G., 1997, “Bridge and Door”, in N. Leach, a cura, Rethinking Architecture, London-New York, Routledge. Snyder, G., 1990, The Practice of the Wild, New York, North Point Press. Soja, E., 1992, “Inside Exopolis: Scenes from Orange County”, in M. Sorkin, a cura, Variations on Theme Park, New York, Hill & Wang. Sontag, S., 1992, The Volcano Lover, New York, Farrar Straus Giroux; trad. it. di P. Dilonardo, 1995, L’amante del vulcano, Milano, Mondadori. Soussloff, C. M., 1997, The Absolute Artist, Minneapolis, University of Minnesota Press. Spivak, Chakravorty G., 1990, The Post-colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, a cura di S. Harasym, London-New York, Routledge. Steiner, G., 1978, Heidegger, London, Fontana; trad. it. di D. Zazza, 2002, Heidegger, Milano, Garzanti. BIBLIOGRAFIA Stewart, K., 1996, “An Occupied Place”, in S. Feld, K. H. Basso, a cura, Sense of Place, Santa Fe (N. Mex.), School of American Research Press. Striano, E., 1997, Il Resto di Niente, Cava dei Tirreni, Avagliano. Swedenburg, T., 1992, Homies in the Hood: Rap’s Commodification of Insubordination, «New Formations», 18. Thiele, L. P., 1995, Timely Meditations. Martin Heidegger and Postmodern Politics, Princeton, Princeton University Press. Todorov, T., 1984, The Conquest of America, New York, Harper & Row. Tsing, A., 1993, In the Realms of the Diamond Queen: Marginality in an Out-ofthe-Way Place, Princeton (N.J.), Princeton University Press. Unwin, S., 1997, Analysing Architecture: The Architecture Notebook, LondonNew York, Routledge. Vann, R. T., 1995, “Turning Linguistic: History and Theory and History and Theory, 1960-1975”, in Askersmit, Kellner, a cura, 1995. Verlet, L., 1993, La Malle de Newton, Paris, Gallimard. Vidler, A., 1992, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, Cambridge (Mass.)-London, MIT Press. Walcott, D., 1992a, “The Schooner ‘Flight’”, in Collected Poems 1948-1984, London, Faber & Faber; trad. it. di B. Bianchi, G. Forti, R. Mussapi, 1993, “La goletta ‘Flight’”, in Mappa del Nuovo Mondo, Milano, Adelphi. Walcott, D., 1992b, “Map of the New World: Archipelagoes”, in Collected Poems 1948-1984, London, Faber & Faber; trad. it. di B. Bianchi, G. Forti, R. Mussapi, 1993, “Mappa del Nuovo Mondo: Arcipelaghi”, in Mappa del nuovo mondo, Milano, Adelphi. Wellmer, A., 1993, Endspiele: Die unversohnliche Moderne: Essays und Vortrage, Frankfurt am Main, Suhrkamp. Wheeler, W., 1995, After Grief? What Kinds of Inhuman Selves?, «New Formations», 25, estate. Wheeler, W., 1998, In the Middle of Ordinary Things: Rites, Procedures and (Last) Orders, «New Formations», 34. White, H., 1985, Tropics of Discourse, Baltimore, Johns Hopkins Univ.ersity Press. Wigley, M., 1996, The Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt, Cambridge (Mass.)-London, MIT Press. Willey, B., 1953, The Seventeenth Century Background, New York, Doubleday; trad. it. di A. Dal Farra, 1975, La cultura inglese del Seicento e del Settecento, Bologna, il Mulino. Williams, R., 1977, Marxism and Literature, Oxford, Oxford University Press; trad. it. di M. Stetrema, 1979, Marxismo e letteratura, Roma-Bari, Laterza. Wolfarth, I., 1998, “The Measure of the Possible, the Weight of the Real and the Heat of the Moment: Benjamin’s Actuality Today”, in L. Marcus, L. Nead, a cura, The Actuality of Water Benjamin, London, Lawrence & Wishart. Yates, F., 1964, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London, Routledge & Keagan Paul; trad. it. di R. Pecchioli, 1981, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Roma-Bari, Laterza. Young-Bruehl, E., 1982, Hannah Arendt: For Love of the World, New Haven (Conn.)-London, Yale University Press; trad. it. di D. Mezzacapa, 1990, Hannah Arendt 1906-1975: per amore del mondo, Torino, Bollati Boringhieri. Stampato per conto della casa editrice Meltemi nel mese di novembre 2003 presso Arti Grafiche La Moderna, Roma Impaginazione: Studio Agostini
Scarica