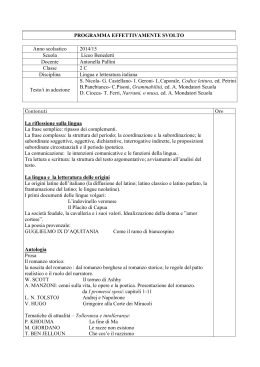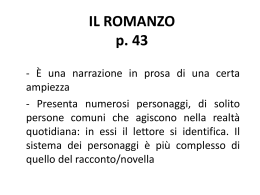n.2 2 The Godfather Raymond Queneau di JACOPO CIRILLO C ’è un esempio famoso di Umberto Eco che più o meno dice: i parenti sono serpenti solo per la rima e non per la consanguineità. Nella poesia è il suono che comanda. Nella letteratura no, perché la letteratura crea dei mondi. È una cosmogonia. Ovviamente i mondi creati dai libri non sono reali, né veri. Basti pensare alla fantascienza o, più semplicemente, al Codice da Vinci. Però devono essere possibili. Rappresentazione di stati di cose alternativi allo stato di cose reale. Quindi si può volare, si può essere comandati dai robot e così via. L’unica cosa che si chiede a questi mondi è uno dei fondamenti della logica: devono rispettare il principio di non contraddizione. Se a un certo punto Harry Potter perde i suoi poteri, allora qualche mago cattivo glieli ha tolti. Non è che si può fare finta di niente e dire che non li ha mai avuti. Creare un mondo possibile significa creare un universo narrativo con una coerenza interna, capace di stipulare con il lettore un patto finzionale per il quale, riassumendo, non è vero ma ci credo. Raymond Queneau, che nella sua opera ha fatto mille cose incredibili, riesce a mettere in scena continuamente questa operazione. In Suburbio e fuga (Einaudi, 204 pp. 9 euro) il protagonista, Jacques, vive mille vite differenti. Da figlio di un semplice calzettaio e «di una madre insignificante», diventa capitano dell’esercito olandese, campione del mondo di scacchi, fachiro nel cristallo, cercatore d’oro, attaché all’ambasciata di Pechino, «lord inglese (per adozione), gran lama (per vocazione), presidente della repubblica di Nicaragua (per elezione), presidente della repubblica di Costa Rica (per rivoluzione) e presidente della repubblica di Guatemala (per occupazione)». E tante altre cose. Tutto il libro è un susseguirsi di vite possibili che iniziano e terminano in ogni pagina, in un turbinio che spesso ne sporca il discernimento: non si capisce bene quando inizia il sogno o ricomincia la realtà. I mondi possibili si rincorrono uno dopo l’altro rendendo la realtà di partenza una semplice possibilità come tutte le altre. Qualsiasi altro autore, per delimitare i confini, avrebbe usato un espediente linguistico come shift tra mondi, anche solo un e Jacques si immaginò di… o un e Jacques vorrebbe diventare… Oppure avrebbe usato un accorgimento visivo, una riga vuota tra il primo paragrafo e il secondo, o un carattere tipografico diverso. Queneau invece, da buon avanguardista e sostenitore dell’avanguardia (il suo amico italiano era Enrico Baj, mica Calvino), usa la velocità. Velocità narrativa, si intende. Il mondo possibile “originale”, quello della storia iniziale, è costruito con un andamento narrativo canonico: avvenimenti salienti diluiti da digressioni e descrizioni, di modo che, in 10 pagine, succedono due o tre cose rilevanti, non di più. I mondi possibili derivati invece proliferano a diverse velocità, di modo che ogni vita viene descritta dalla successione dei due/tre avvenimenti centrali attorno ai quali si impernia. Una intera carriera di boxeur in pochi paragrafi; le peripezie d’acrobata in due righe. Lo shift tra i mondi è la velocità. E non a caso lo shift, il cambio della macchina in inglese, fa esattamente questo. 3 Sommario Sui labirinti La citazione del mese Beaten Beatitude Letterature Involontarie Biografie Edulcorate Le città letterarie Oh, Scena! L'angolo del cinematografo Recensione/1 Recensione/2 Viaggi 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 Nobel minori Scheda Libro Deja lu Pillole di Scienza Recensione/3 Charlie VS Proust I ferri del mestiere La posta dei lettori Graffetta Ghost World Iperboloser 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 Editoriale Questo è il primo editoriale tradizionale di Finzioni. I precedenti, mettendoli insieme, erano il manifesto teorico ufficiale di questa rivista. Adesso ci sembra giusto iniziare a parlare di come stanno e di come vanno le cose. cui vogliamo continuare a dimostrare la grande letteratura. Iperboloser diventa la chicca finale e tre recensioni sono sparse tra le pagine, per ricordare a tutti che parlare di libri è bello ma leggerli è meraviglioso. Finzioni cambia. È in continua evoluzione. Dall’abbozzato numero zero al consapevole numero due, lo scheletro si sta formando e la ciccia comincia ad attaccarsi. Ci sono due rubriche nuove, che ovviamente proseguiranno nei prossimi numeri. Le città letterarie, che questo mese celebra Trieste, e le Biografie edulcorate, inaugurata da John Fante. C’è poi Ghost world, messa in sistema dei discorsi sulle graphic novel che portiamo avanti fin dall’inizio e di Finzioni cresce. Sul web e su carta. Il nostro sito è aggiornato quotidianamente con contenuti nuovi e inediti. La rivista cartacea sarà presto ordinabile on-line e distribuita in più città. Noi continuiamo per la nostra strada, e orgogliosamente vi presentiamo il secondo numero di Finzioni, approcci leggeri a contenuti pesanti. La redazione 4 C chi l’ha attraversato (nel saggio “La ome si entra in un labirinto? sfida al labirinto” ne Il Menabò n.5 Certo è facile perdersi, nei 1962). Il labirinto è allora il percorlabirinti di Robbe Grillet, ma come so: solo così riusciamo a spiegarci entrare in quella confusa narraziocome sotto lo stesso termine, la ne che sposta costantemente ogni mitologia comprenda spirali a una punto di riferimento? Parliamo sola via che dall’esterno portano al naturalmente di Dans le labyrincentro e meandri a infinite possibithe, Paris, Editions de Minuit 1959, lità. Movimento contraddittorio e 223 pagine, 14 euro. All’ io-qui-ora, ritmato. punto centrale da cui si dipana ogni narrazione, manca la stabilità Come si legge dunque un romandel contesto. E al lettore i punti di zo di Robbe Grillet? Quale il fil rouriferimento cui aggrapparsi per poge (d’Arianna) che ci conduce nei ter procedere nella comprensione. suoi meandri permettendoci, una Come il lettore, il narratore tenta di costruire dei mondi fittizi in cui situarsi, in cui dare corpo alla propria astrazione, ma il contesto contraddice ogni tentativo di fissità. Le interminabili descrizioni degli interni creano degli indizi, che richiamano altri indizi che li contraddicono e si perdono. Ecco allora che l’identità del soldato, protagonista del romanzo (ma che poi di MATTEO TRELEANI sia veramente un soldato?), si costituisce in base all’ambiente esterno, ambiente puramente buona volta, di uscirne, o meglio, materiale, ma contraddittorio. Un di finire il libro? Ancora una volta, soldato ha forzatamente una misin fatto di labirinti, si richiede un sione. L’identità di partenza, l’iocambio di prospettiva. Si noti che qui-ora, si riconosce allora nel percome in un puzzle, Nel labirinto desonaggio militare per avere un fine costruisce man mano, ogni punto verso cui tendere. Ma anche questo di riferimento su cui tendiamo ad fine cede. Nel labirinto è una sorta appoggiarci per continuare la letdi anti-narrazione in cui non si detura. Come in un gioco sadico, noi scrive una linearità degli eventi ma ci aggrappiamo a qualcosa, penun movimento continuo. sandola stabile, e quella si sposta, costringendoci a cercarne un’altra Il movimento, dicevamo nello e così via. Basta qualche decina di scorso numero di Finzioni, è l’espagine per rendersi conto che quesenza stessa del labirinto (parole sto gioco ruota su se stesso. E’ una di Curt Sachs, storico della danza). spirale: il labirinto ci porta al cenLabirinto che, appunto, si danza. tro, e questo, lo sappiamo coincide Tanto che, siepi, giardini e resti con l’uscita (come il labirinto del archeologici sembrano i residui Jardin des Plantes metteva abilsvuotati della loro linfa vitale: il mente in scena: una collina con la movimento. Perché ci sia labirinto sommità al centro e da qui la posci vuole anche qualcuno per persibilità di vedere il labirinto stesso. correrlo. E’ Italo Calvino a ricorVederlo significa possederlo, comdarci che il labirinto non esiste per prenderne la mappa e quindi le sue vie di fuga). Solo che uscirne non risolve il suo enigma. Una volta fuori, ci rendiamo conto di come Nel labirinto non era che la messa in atto di tutti i mondi possibili, di quelli che la narrazione tradizionale, nel suo svolgimento, dovrebbe contribuire a narcotizzare poco a poco. Inutile rimarcare che con il suo caposaldo del nouveau roman, Robbe Grillet riflette sulla narrazione stessa, ne mostra i meccanismi decostruendoli. Ma non è questo che ci interessa al momento. In questa rubrica sui labirinti ci interessiamo proprio di labirinti. E del modo in cui sono stati interpretati. Sui labirinti Dentro il labirinto 5 Dunque la prima caratteristica è la contraddizione. Il movimento labirintico è quello che mi fa girare a destra per andare a sinistra così come il romanzo di Robbe Grillet mette in dubbio ogni appiglio materiale contraddicendolo nei passi successivi. Costruisce un’immagine, un contesto, per poi metterlo in dubbio. La seconda caratteristica, che ci riporta alla danza del labirinto, è il ritmo. Periodicamente le stesse frasi, le stesse situazioni ritornano, ma diverse. Ritmo e contraddizione uniti al cambio di prospettiva sono principi della mètis, parola che nella Grecia antica indicava un particolare tipo di intelligenza. La mètis è il pensiero utile a uscire dal labirinto (il pensiero degli insight di Dedalo), a leggere Robbe Grillet e i flussi di coscienza… I l romanziere in carne ed ossa non è l’enunciatore del suo romanzo. E’ un personaggio di un altro racconto, per esempio quello di uno storico, di un critico letterario, di un giornalista venuto ad intervistarlo. Appena incominciamo a nominare l’enunciatore, a designarlo, a dargli un tempo, un luogo e un volto, cominciamo un racconto. Bruno Latour La citazione del mese La sonata a Kreutzer & Lunar Park di JACOPO CIRILLO L a sonata a Kreutzer (Giunti, 160 pp. 7 euro) è un libriccino di Tolstoj. Parla di un uomo che ha ucciso la moglie per gelosia e lo racconta tranquillamente a uno sconosciuto sul treno, mentre si fuma duecento paglie e beve un tè talmente forte da dover allungarlo con l’acqua (probabilmente un eufemismo per dire vodka) (nel senso che il tè l’allunga con la vodka). Il reo confesso assassino ha le idee molto chiare sul matrimonio e sul grado di decadenza della società russa del tempo e non manca di articolarle con molta chiarezza all’attento interlocutore, che sorbisce le farneticazioni di un uxoricida per tutta una notte, fino al mattino. Le idee sono forti e coinvolgono il sesso con o senza procreazione, l’insolenza dei dottori e la condotta delle mogli dei soldati che avevano la leva obbligatoria di 20 anni. Ma non è questo il punto. Questo è un libro di denuncia di Tolstoj, che non era d’accordo con la moralità del suo tempo e lo faceva dire a un suo personaggio. Tanto più che alla fine del libro c’è una postfazione dell’autore che esordisce con una cosa del tipo: molte persone vogliono sapere come la penso e che cosa volevo dire con questo racconto. Benissimo, nessun problema. Ma allora qui è Tolstoj che parla; per capire questo libro bisogna per forza sapere chi è Tolstoj, sapere che è russo, sapere il ruolo degli intellettuali russi di quel periodo eccetera. Ecco allora che la figata detta da Latour riesce a coniugare tutto ciò con una concezione “apaternalistica” della letteratura. Nonostante si sia ripetuto così tanto che l’autore empirico non interessa, che i libri circolano nella cultura e che acquistano valore dalle loro relazioni e dai discorsi che si fanno attorno ad essi. Bruno Latour è antropologo, sociologo della scienza e importante teorico dei STS (Science and Technology Studies). Si dirà, cosa c’entra uno scienziato. Non lo so, ma l’idea è davvero intelligente. E soprattutto consente di uscire dall’empasse precedente: il Tolstoj che ci interessa non è quello nato nel 1928 in provincia di Ščëkino. O quello scomunicato nel 1901 per le sue 6 idee anarchico-cristiane. Il Tolstoj che ci interessa è il protagonista di un’altra storia, quella di uno scrittore che, per diffondere le sue idee, usa i personaggi dei suoi libri. E’ un personaggio di cui si può discutere o fantasticare, al pari di Pozdnysev, l’assassino redento del libro. Un esempio più chiaro? Lunar Park, di Bret Easton Ellis (Einaudi, 336 pp. 12 euro). Un romanzo incredibile che ha come protagonista uno scrittore che si chiama Bret Easton Ellis, che ha scritto tutti i romanzi di Bret Easton Ellis, che ha moglie e figli che somigliano e hanno lo stesso nome di quelli di Bret Easton Ellis ma non è Bret Easton Ellis. Questo è lo svelamento palese del meccanismo di cui parla Latour: il romanziere in carne ed ossa, Bret Easton Ellis, non è l’enunciatore del suo romanzo ma il personaggio. E l’enunciatore di Lunar Park allora chi è, si potrà chiedere? È questo il problema. Non si può chiedere. Perché appena lo si chiede, appena si prova a designarlo, quello scompare e restituisce solo un’altra rappresentazione. Che, guarda caso, si chiama Bret Easton Ellis. Beaten Beatitude Tropico del Cancro di JACOPO DONATI N el primo numero di Finzioni accennai ad un autore che prese le difese di Kerouac contro le accuse di oscenità che gravavano su I soterranei. Era Henry Miller, che a cause del genere aveva ormai fatto il callo fin dalla sua prima opera. Miller parte per Parigi nel 1930 e resta in Francia sino alla seconda guerra mondiale. È qui che ambienta, scrive e pubblica, nel ’34, Tropico del Cancro, romanzo crudo che gli procurerà in seguito, oltre a diversi guai giudiziari, il titolo di “padre dei beat”. Non perché fosse il più anziano (avendo 31 anni di differenza con Kerouac avrebbe potuto essere tranquillamente suo padre) ma perché fu un autore che li ispirò tutti inserendo nei suoi romanzi le stesse atmosfere, gli stessi ideali e le stesse paure che avrebbero riempito le pagine dei beat. In Tropico del Cancro si parla della vita quotidiana, della scelta del protagonista (l’autore) di condurre una vita principalmente a scrocco, una vita povera che abbia come unico agio la libertà individuale. E poi sesso, tanto sesso, descritto in maniera cruda, volgare, vibrante. Sarà infatti questo il motivo per cui negli Stati Uniti verrà pubblicato solo nel 1961. I confini statunitensi, però, li varca ben prima: tanti americani esuli in Francia lo portano con sé al loro rientro in patria e in questo modo il romanzo comincia a circolare. Non c’è trama perché si parla di vita e la vita non ha trama, e non c’è alcun climax. Una storia strana, fat- ta di tante scene, dove il protagonista è asociale, egoista e sfruttatore, dove si fatica a capire cosa ci sia di tanto affascinante in un personaggio del genere, finché non si comprende che in ogni pagina Miller vive realmente alla giornata, nel vero senso delle parole. Lui stesso, nelle prime righe, afferma: «non ho soldi, né progetti, né speranza. Sono l’uomo più felice del mondo». In un passo del libro descrive New York, la città in cui nacque. I grattacieli divengono prigioni bianche, nei marciapiedi strisciano i vermi e tutto è monotono, persino i volti dei passanti. È una città crudele eretta sul nulla e brulicante di energia senza scopo, «quanto più frenetico il ritmo, tanto più sminuito lo spirito» dirà Miller ad un certo punto. Ma Parigi è differente: a Parigi non occorre essere ricchi per sentirsi in paradiso, anzi, non occorre neppure essere parigini per sentirsi a casa tra le sue strade. Parigi fa sentire a casa anche se non si possiede un centesimo, New York fa sentire una nullità anche il più ricco. Che cos’è che conta di più? È più importante essere ricchi ma spiritualmente vuoti e intrappolati in prigioni bianche, o essere poveri ma stare bene e sentirsi a casa? Miller la risposta la conosce bene quando scappa dagli Stati Uniti e raggiunge Parigi. Forse, una volta partiti, le città che ci hanno trattenuto paiono peggiori di quel che sono realmente, mentre le città che ci accolgono sembrano paradisi in terra quando non sono molto diverse dalle altre, 7 ma è ciò che simboleggiano ciò che davvero fa pendere l’ago della bilancia da un lato piuttosto che da un altro. New York era il simbolo di una natura umana vuota e debole, di un’umanità che si incensa per i grattacieli costruiti con fatica per poi rinchiudersi al loro interno senza comprendere ciò che davvero dovrebbe essere importante. E non si tratta di soldi, fama o potere: «Fai quello che vuoi», dice Miller tra le pagine di Tropico del Cancro, «purché produca gioia. Fai quello che vuoi, purché porti estasi». Letterature involontarie Alloprassìa, o dell’ingombra e cieca pienezza dell’Altro. di EDOARDO LUCATTI R elativo è lo sguardo che pondera, che flette e riflette l’unità e la sua misura, l’isola e chi vi è relativamente perso. Assoluto è lo sguardo che impondera, non già cogliendo più toni ma cogliendosi nel tono, in un tono che diventa il tono e si avoca l’originario. Assoluta è l’incoscienza, che non è vuoto di coscienza ma internità della stessa, sua ingombra pienezza, in-coscienza – appunto – che non fa pratica di sé al di là del proprio involucro, che non si relaziona a nulla e semplicemente promana. Dio è incosciente, ed è proprio per questo che non voglio credergli. Non voglio credere all’Uno cui tutto è promesso, all’impasto definitivo di me e dell’altro, entrambi risucchiati in cielo su per l’avida cannuccia del Padre. No. Sono abbastanza affezionato alle mie oscillazioni, alla mia piccola danza fra relativo e assoluto. Si inspira follia e si espira ragione, perché gli occhi si aprono e chiudono, di continuo e con ritmi variabili, senza poter fare altrimenti: assolutamente pazzi, geni, depressi, vivi e relativamente strani, intelligenti, tristi, in forma. È un respiro. Io non sono promesso alla vita. Sono solo abbastanza vivo. 8 E solo finché ne ho voglia, modo, forza. Dopodichè ciao. Per fortuna, mia e di voi finziofili lettori, l’assoluto conosce anche forme terrene, il che – per altro – ci porta a considerare la probabilità che Dio non sia stato poi così originale. Sapete infatti cos’è un alloprassico? Un malato. Ma sapete di cosa è malato? Leggendo Günther Anders, gustosissimo detrattore di Franz Kafka, ho appreso che l’alloprassìa è “l’azione coatta di un malato che, invece dell’azione da lui stesso voluta o richiesta, ne esegue un’altra”. Non si tratta di un semplice errore, di una défaillance: non è che ci si alzi di notte per andare in bagno e poi ci si trovi a pisciare nel frigorifero. No. Si tratta di fare davvero Altro. Si tratta di voler o dover andare in bagno (non necessariamente di notte) e, invece, di raggiungere la tromba della scale per cantarvi in perfetto tedesco tutto l’Inno alla gioia. Questa è una buona alloprassìa. L’idea di Anders è che Kafka soffra di un’equivalente allologìa, la quale – invece della parola o della frase da lui stesso voluta o richiesta – gliene farebbe scrivere un’altra. Ma come tutti gli alloprassici, egli non sa di esserlo. Dal suo punto di vista, Kafka non traduce ciò che avrebbe da dire in un linguaggio altro. “Ciò che egli ha sempre nominato – spiega Anders – l’ha nominato di già con il suo pseudonimo.” Insomma: nei panni dell’alloprassico si canta l’inno alla gioia nella tromba delle scale non perché non si sia riusciti a orinare nel bagno bensì proprio perché lo si sta facendo, perché la tromba delle scale è il bagno e Beethoven è l’urina. Ed ecco l’assoluto. Non si è qualcosa d’altro che si giustappone a qualcosa di proprio, si è nell’altro, nell’internità dell’alterità. Per questo Kafka è insostenibile: non perché sia strano ma proprio perché rinnega la stranezza di ciò che scrive, la spiana, la assume dal suo di-dentro e, così facendo, non la vede più in quanto tale. Di qui l’ac- cusa di Anders, per il quale Kafka sarebbe non già un visionario bensì un realista, perché normalizzerebbe una condizione ignobile cui l’uomo dovrebbe invece ribellarsi. Anders, insomma, non è d’accordo con Kafka. Mica male l’idea di non essere d’accordo con Kafka: prima gli dai del pazzoide e poi prendi le distanze da quello che dice. Mah. Sarebbe come accusare un muto di starsene zitto allo scopo di nascondere qualcosa. Voglio dire: è muto, ti credo che non parla. Comunque. Il libro di Anders è bellissimo: non sempre centra il vaso ma anche quando la mira lo tradisce il buontempone mantiene uno stile impeccabile. In appendice è riportato un breve scambio di polemiche con Max Brod che aggiunge pepe al sale. Per cui leggetevi tutto quanto e finiamola qua. Perché questa non è una rubrica su Günther Anders, e nemmeno su Franz Kafka. Lungi da noi. Questa è una rubrica di letterature involontarie che, per l’occasione, si occupa di alloprassìa e alloprassici, dell’internità dell’alterità, delle forme terrene dell’assoluto. A dispetto delle apparenze, è però – e in certo modo soprattutto - una rubrica utile, che serve a trarvi d’impiccio. A dotarvi, per così dire, di un salvacondotto che il più grande di tutti gli Imperatori non potrebbe garantirvi. Perché qualunque cosa vi contestino, di qualunque cosa vi accusino, chiunque siate e dovunque andiate, bè, se quello che state facendo risulta per qualche ragione offensivo, improprio o anche solo inopportuno, se state rubando gli addobbi natalizi dalla porta del vicino e costui - tornando a casa vi tocca la spalla per chiedervene conto o se durante un colloquio di lavoro appiccicate le caccole del naso sotto il tavolo del responsabile risorse umane ed è troppo tardi quando vi accorgete che il tavolo è di vetro trasparente, bè, se questo e se quello, c’è una cosa che potrete sempre dire: “Io sono alloprassico, porti rispetto!” Mentireste, perché nessun alloprassico è davvero consapevole di essere quel che è, e dunque mai e poi mai potrebbe autenticarsi come tale. Ma dubito che l’originalità del frangente consentirebbe al vostro basito interlocutore di cogliere una sfumatura tanto delicata. È già difficile penetrare il problema della volontà, della sua costitutiva praesentia in absentia. Figuriamoci il problema di una volontà che non si sa volere ciò che pure dà1 a vedere. E se di tanto fosse poi capace questo vostro interlocutore, allora staccate la caccola dal vetro e rimangiatela in tutta fretta, ricomponetevi come meglio potete e usate ogni mezzo per farvi assumere. Perché a quel punto una sola cosa sarebbe veramente certa: che il suo è il vostro lavoro, e che da domani mattina il vostro compito è fargli le scarpe. 1 Non ero sicuro che su “dà” andasse l’accento. Allora l’ho digitato su google e il nome del primo sito in elenco, a beneficio di eventuali lettori avvezzi alla linguistica hjelmsleviana ma a generale vantaggio del buonumore di tutti, ricorda in forma piuttosto divertente la prova di commutazione. Verboso metro 20 15 10 5 0 Ritaglia il verbosometro e attaccalo sulla schiena del tuo amico verboso 9 E Verboso metro L’eloquio deloquia: lo si parametri, dunque, in funzione di soglie di verbosità che ne dipanino l’evolvere, l’involvere e l’avvolvere. Da 0 a 5 espressioni verbose. Latenza del verboso. Il singolare riluce nel pauperismo dei villici, ramingo dinoterio prosodico scampato all’impudente glaciarsi del dire. Da 5 a 10 espressioni verbose. Brezza verbosa. Distendesi l’eloquio lungo plaghe d’orpelli musabili, muscovite di senso che rattiene la voce in gibigiana. Da 10 a 15 espressioni verbose. Telluria verbosa. Ciacchero clivo del sema che incerona l’abisso a meta, liberando legioni d’una lutulenza che ‘l pudore tenea per ascosa. Da 15 a 20 espressioni verbose. Verbocrazia. Tripudio fulgente della lingua: di fuètto s’agguizzano i nervi palatali; ne promana un sentire che mal s’addice al fucato anelito del frasaio e ben si predica, invece, d’un dire-miele la cui voce per ovunque - si dissipa. Più di 20 espressioni verbose. Verborrimìa. Il nulla s’attarda nel discorso e ne fa vano asfodelo. cco John. Sfanghiamocela così. Quattro chiacchiere tra di noi, come due vecchi amici. Garcon. Due bicchieri del chiaretto di Angelo Musso. Ma che dico due bicchieri. Portaci una bottiglia. Anzi. Portaci una caraffa. Che siamo uomini di pietra noi. Siamo italiani. Anche se, per dirla tutta, hai giocato tutta la vita a fare l’americano, John. A fare lo Smith, il Jefferson, il Richards, il Brown. Nascere da Nick Fante e Maria Capoluongo a Denver non è stato tà. La molli quasi subito. Attacchi con i lavori precari. Cerchi di restare a galla. E scrivi. Scrivi racconti. Hai Henry Louis Mencken dalla tua. Il grande Mencken. Il critico letterario. Ti apprezza, ti esorta a continuare. American Mercury e Atlantic Monthly ti pubblicano con regolarità. Ma i soldi scarseggiano. La mamma spedisce dieci dollari di tanto in tanto. Non bastano. Mangi solo arance. Hai lo stomaco corroso. E allora cedi. Cedi alle luci di Hollywood. Al profumo dei verdoni. Diventi una puttana. Vendi le Biografie edulcorate John Fante di ANDREA MEREGALLI facile. Com’è che ti chiamavano i tuoi compagni di scuola? Dago. Terrone. Mangiaspaghetti. Così ti chiamavano. Perché tuo padre, il vecchio Nick, veniva da un paesino sui monti abruzzesi. Torricella Peligna. Già, tuo padre. Violento. Fedifrago. Ignorante. Blasfemo. Prepotente. Giocatore. Muratore. Scalpellino. Tu, il primo di quattro figli. Nato l’8 Aprile 1909. Testardo di un John. Tu volevi leggere, volevi scrivere. Ma il babbo non era d’accordo. Trovati un lavoro. Diventa un uomo. I libri sono da froci. Quindi via, John. È il 1930 e tu scappi. Scappi da Boulder, Colorado. Tenti con Los Angeles. La metropoli. La città delle opportunità. Della ricchezza. Dei vestiti. Delle belle donne. Ti iscrivi all’universi- 10 parole. Sei uno sceneggiatore, film di serie B. Non ti piace, ti consideri uno scrittore. Un nobile scrittore. Cerchi il tuo posto tra Hemingway e il grande Fedor. Ma ne arrivano di soldi, John. E allora continui. Ti adatti. Il tuo primo romanzo lo concludi nel 1936. La strada per Los Angeles (Einaudi, 218pp. 11 euro). Ma viene bocciato. Rifiutato. E non importa se il grande Arturo Bandini nasce in queste pagine. Nessuno lo conosce, ancora. E lui ammazza i granchi. Si fa le pippe. È maschilista. È vile. È un po’ troppo poco politically correct. Te lo stroncano. Non ti arrendi. Nel 1937 finalmente ti pubblicano. Aspetta primavera, Bandini (Einaudi, 238pp. 11,50 euro). La storia della tua infanzia a Boulder, Colorado. In prima pagina c’è tuo padre che scalcia nella neve e bestemmia. C’è la difficoltà di essere immigrato. Di essere italiano. C’è la tua penna, il tuo stile. L’ironia drammatica delle tue parole semplici. L’attesa della primavera per Arturo e Svevo Bandini. Nel 1939 ce la fai. Ottieni l’immortalità. Esce quello che in molti considerano il tuo capolavoro. Chiedi alla polvere (Einaudi, 234pp. 11,50 euro). Arriva Camilla Lopez. La messicana. La cameriera. E tu, che sei ancora Arturo Bandini, cerchi di diventare uno scrittore. Cerchi di farti la Camilla. Cerchi di essere un bravo cattolico. Dimmi una cosa, John. Come ti è venuta Camilla Lopez? Dimmelo! È perfetta. È dannatamente perfetta. La vostra storia. Che diventa un triangolo. Niente di nuovo, certo. Tu ami lei lei ama lui lui scopa lei. Ma tu, hai il coraggio di mostrarti nudo. Sei nudo e lo racconti. Racconti la tua nudità. Sei un gigante. Nel 1940 esce Dago Red (Einaudi, 221pp. 11 euro). Una raccolta di racconti. Nel frattempo sposi Joyce. Sei uno sceneggiatore. Guadagni bene. Ti adagi. Arriva la guerra e non scrivi più. Fai solo il tuo lavoro. Ti godi i dollari hollywoodiani e inizi con il golf. Compri una villa a forma di y sull’oceano. Hai 4 figli. Viaggi per lavoro. Europa. Italia. Francia. Perdi del gran tempo. Nel 1952 sei in crisi e pubblichi Full of life (Fazi, 151pp. 8,50 euro). Lo fai per dovere. Il libro non ti piace. Ironico, sì. Scritto da Dio, ok. Ma manca qualcosa. È troppo sereno. Non c’è l’urgenza. Non c’è la fame. Ti senti finito. Gli anni passano, i figli crescono, i soldi si moltiplicano. Ti ammali. Diabete. Proprio come tuo padre. Due gocce d’acqua. John e Nick. Nick e John. Il tempo stringe, lo senti premere alla gola e capisci che è arrivato il momento per entrare nella storia. E allora lo scrivi. Scrivi il più grande romanzo famigliare di sempre. Scrivi un atto d’amore per tuo padre. Ti riconcili. Cedi al sentimento. Partorisci una meraviglia. È il 1977 e La confraternita dell’uva (Einaudi, 232pp. 11,50 euro) vede la luce. Un anno dopo Charles Bukowski, il poeta alcolizzato, ti rende giustizia. Dice che sei il suo Dio. Ristampa i tuoi libri con la sua casa editrice, la Black Sparrow. Butta giù una meravigliosa prefazione a Chiedi alla polvere. Ti godi la cresta dell’onda. Ma sei vecchio e sei malato. Scrivi ancora, pieno di speranza. Un anno terribile (Einaudi, 122pp. 11 euro) e A ovest di Roma 11 (Einaudi, 214pp. 10,50 euro). Nel 1982 sei cieco e senza gambe. Detti a Joyce il tuo testamento letterario. Torni ventenne e torni Arturo Bandini. Sogni di Bunker Hill (Einaudi, 158pp. 9,50 euro). Te ne vai in un letto d’ospedale. È l’8 Maggio 1983. Al tuo capezzale Joyce, i ragazzi, gli amici di sempre. La beffa è che verrai riscoperto con violenza dopo la tua morte. Con Joyce che pubblica inediti su inediti. Con La strada per Los Angeles, il romanzo rifiutato, che fa conoscere all’Italia il sublime Arturo Bandini. Ma non fai in tempo a goderti tutto questo. Muori sceneggiatore. Muori da scrittore minore. La riscoperta la vivono i tuoi figlioli. La tua Joyce. Chissà come te la godi da lassù, adesso. Tra Fëdor Michajlovič Dostoevskij e Ernest Hemingway. Hai dovuto sgomitare, certo. Ma gli immortali hanno fatto posto. Hanno fatto spazio. Signore e signori, hanno detto, Arturo Gabriel Bandini è in mezzo a noi. Le città letterarie Gli squali di Trieste e i gialli di Heinichen di Matteo Treleani C ittà strana, Trieste. Da quando, circa un secolo fa, la frenesia del porto asburgico l’ha abbandonata, non fa che contemplarsi. I triestini, si dice, non vivono Trieste, la visitano. Una sua sineddoche, parte per il tutto, è l’immagine di piazza dell’Unità dal Molo Audace. Le navi hanno abbandonato le rive, e il molo, persa la sua funzione primaria, serve a passeggiare e dunque a guardare la città dal mare. Da qui la si vede specchiarsi nell’Adriatico. Anticamente le navi impedivano alla piazza di riflettersi sull’acqua. Ora il mare da infinito dei possibili, tutti i luoghi verso cui una nave potrebbe portarci, é divenuto uno specchio. E lo specchio, si sa, é il più meschino dei limiti, perché ci inganna dando un senso di profondità con la nostra stessa immagine. Per una città di frontiera avere molti limiti é uno stimolo in certi casi, lo è perlomeno, quando quei limiti sono delle spinte all’attraversamento, dei richiami dell’Altrove. Ma persa quell’attrazione marittima, Trieste diventa una sorta di isola, non provinciale, ma marginale, che borbotta osservandosi. Invece di guardare l’Altro e l’Altrove, guarda se stessa, il proprio passato e la propria identità (italiana ? proprio qui ?). Trieste resta tuttavia una città letteraria, appunto perché é bello passeggiare e riflettere senza far nulla. In questa ossessione dello specchio e dell’attitudine autoreferenziale, il Comune ha pensato bene di pietrificarne la letterarietà. Joyce, Svevo e Saba passeggia- no per le vie sotto forma di statue. Eppure, quest’alimentazione del proprio stereotipo produce alcuni risultati. D’altra parte Magris continua a scrivere al caffè San Marco e Boris Pahor, il più grande scrittore di lingua slovena ha ben preferito la città dell’alabarda a Lubiana. Se la sua immagine riflessa pretende un’italianità presunta, la città letteraria viaggia da sempre nello spazio liscio dell’Altrove, multinazionale e plurilinguistica. Non per primo dunque, é arrivato in città lo scrittore di polizieschi austriaco Veit Heinichen. E sono una ventata d’aria fresca i suoi polar ben ritmati e piacevolmente imperfetti. Letteratura minore, si direbbe, nel senso deleuziano, perché in lingua tedesca in terra italiana e in quello letterale. Comunque gradevole; di quella letteratura che rende il suo attore principale (la città, appunto) più vitale e leggero. Il polar sembra ciò di cui aveva bisogno questa Trieste assopita e borbottante che rimpiange le proprie glorie. La città che ha dato vita al romanzo moderno (e al flusso di coscienza joyciano) non conosceva il giallo. Genere che le sembra tuttavia straordinariamente adatto. Il commissario Proteo Laurenti, protagonista dei romanzi, poi, é un salernitano, uomo di mare dunque, ma di certo non abituato alla borghesia triestina e a quell’improbabile miscuglio di architettura viennese e paesaggi mediterranei. Primo episodio delle avventure di Laurenti è A ciascuno la sua mor- 12 te (Edizioni E/O 2005, 207 pagine, 9,50 euro), storia di squali e criminalità internazionale, con tanto d’infiltrazioni mafiose, di quelle a cui qualsiasi triestino mettendo la mano sul fuoco si dichiarerebbe immune. Attraverso il polar, dunque, Heinichen smuove l’immagine di una città congelata nel proprio riflesso. Scava dietro quel riverbero dando linfa vitale a un simbolo assopito. Ora, raccontano le cronache che Heinichen sia perseguitato da qualche maniaco che invia lettere alla borghesia locale denunciando una presunta pedofilia. Indipendentemente da chi sia l’autore e quali le sue vere intenzioni, l’atto della denuncia resta segno di chiusura, di una volontà di mantenere lo stato delle cose (polizieschi? In città? E’ dall’Assassinio di via Belpoggio di Svevo che non se ne vedeva!). La città reale continua a non assumere una città letteraria che l’ha superata da tempo. Il fantomatico squalo, ricorrente in A ciascuno la sua morte, d’altra parte, sembra avvisare che a Trieste, ci sono più squali sulla terra ferma che in mare. Per una città che ha fatto del mare uno specchio, è allora quanto mai attuale Foucault, che in un saggio sulle eterotopie (Spazi altri. I luoghi delle eterotopie, Mimesis 2001, 104 pagine, 8,30 euro) ricordava che “nelle città senza navi, i sogni s’inaridiscono, lo spionaggio sostituisce l’avventura e la polizia i corsari”. Oh, Scena! Ubu Re di SIMONE ROSSI T itolo di questo spettacolo: Ubu Re. Sottotitolo: Dramma in cinque Atti in prosa. Restituito nella sua integrità quale è stato rappresentato dalle marionette del Teatro delle Phynanze nel 1888. Esergo1: “Ordunque il Padre Ubu scosse la pera, onde fu poi chiamato dagli inglesi Shakespeare, e di lui, sotto questo nome, avete assai belle tragedie per iscritto”. Senza firma. Segue, a tutta pagina, il Ritratto Autentico del Signor Ubu, disegnato da Alfred Jarry. Prima battuta di questo spettacolo: PADRE UBU Merdra! (Con due erre, sì.) Ultime battute di questo spettacolo: PADRE UBU Mare fiero e inospitale che bagna il paese chiamato Germania, così denominato perché gli abitanti di questo paese sono tutti cugini germani. MADRE UBU Questa sì che la chiamerei erudizione. Dicono che sia un paese molto bello. PADRE UBU Ah, signori! Per bello che sia non vale la Polonia. Se non ci fosse la Polonia, non ci sarebbero i Polacchi. Fine. Capirete che quello che succede nel mezzo è assolutamente irrilevante. Capirete che l’Insegnamento Fondamentale della Patafisica è… scusate, non vi avevo ancora salutato. Bentornati a Oh, Scena!, una rubrica che tratta i testi teatrali come se fossero libri, e non viceversa. Che cosa ci insegna Padre Ubu? E che ne so, chiedetelo al Collegio di Patafisica. Che cosa ci insegnano questo esergo, questa prima battuta e questo finale? Ecco, parliamo di questo. Ubu è Shakespeare. Affermazione platealmente falsa, spacciata come citazione da un libro (inesistente) in cui si parla di un personaggio che (ancora) non esiste. Ce n’è abbastanza per chiudere il libro. Poi il libro inizia sul serio, e Ubu nasce. La sua prima parola è una parola inventata: tutti capiamo che si parla di cacca, ma in quella R aggiunta c’è qualcosa di perturbante. Ubu dice Merdra. Dice “merdra” e lo fa dire anche a te, lettore, che leggi, e pure a te, attore, che reciti, e pure a te, eccetera. Nessuno dice mai la parola “merdra”, come nessuno dice mai le parole “telrefono cellurlare”. Cosa succede quando tutti quanti diciamo una parola che non esiste? Succede che gettiamo i boccioli di una lingua nuova. Una lingrua. E possiamo dire qruello che ci pare. Usiamo la lingua di Ubu: chiameremo “ventraglia” la nostra pancia, tanto per incominciare. Poi useremo la più terribile delle minacce: “Vattene, cialtrone, o t’intasco con decollazione e 13 torsione delle gambe” (atto terzo, scena settima). T’intasco. La tasca di Padre Ubu è l’Abisso: nero, insondabile, portatile. Terrificante non è la decapitazione o la frattura delle gambe (se è per questo, Padre Ubu dispone anche di una Pompa da Merdra con cui, ehm, svuota gli avversari). Terrificante è la tasca, la tasca di Padre Ubu in cui prima o poi finiremo tutti, ma nessuno ci è mai finito veramente. Un po’ come Fonzie di Happy Days: nessuno l’ha mai visto fare a botte, ma nessuno fa a botte con lui perché sa che perderebbe. Ecco, Padre Ubu è Fonzie. No, Padre Ubu è Shakespeare. Con la testa a forma di pera. Merdra. Se non ci fosse la Polonia, non ci sarebbero i Polacchi. Ma che finale è? Esatto, che finale è. L’unica verità dello spettacolo è una verità talmente ridicola da farci concludere che la verità è veramente ridicola. E ora, tutti in tasca. “Tutto questo è molto bello, ma nessuno mi ascolta” (atto quarto, scena quarta). 1 La citazione che di solito si trova all’inizio di un libro si chiama “esergo”. Sapevàtelo! L'angolo del cinematografo "Lasciami entrare" di Tomas Alfredson di JACOPO SGROI P rima di essere spettatore del film ho deciso di essere spettatore delle scene eliminate di “Lasciami entrare”, cioè di quelle scene che, per un motivo o per un altro (e qui non mi interessa saperlo), non sono state inserite nel montaggio finale. Un esercizio di pura curiosità per capire qualcosa del film andando a cercare tra le immagini bandite. bra che al “biondissimo” le cose stiano andando meglio. C’è qualcosa però che non mi convince e a suggerirmelo sono alcuni dettagli: 1) i bambini stanno giocando di notte; 2) nessun rumore riempie il cortile deserto, c’è solo neve e silenzio; 3) la ragazza ha un aspetto misterioso, è più pallida di lui, ha i capelli bagnati, gli occhi enormi color ghiaccio e i piedi scalzi sulla neve. Scena Bandita n. 1 Scena Bandita n. 3 Interno Giorno. E’ tutto maledettamente bianco e spoglio… sembra il bagno di una scuola. Un ragazzo sui dodici anni sfonda con un calcio violento una delle porte dei servizi. Chi starà cercando di stanare? Non faccio in tempo a chiedermelo che la risposta mi arriva dal fiero bulletto: “Abbiamo trovato il maiale!”. Ad essere trascinato fuori dallo stanzino non è un animale, ma un esile ragazzino, biondissimo, pallido, impaurito e costretto a grugnire. Che disagio. Andiamo avanti. Scena Bandita n. 2 Esterno Notte. Il “biondissimo, pallido e impaurito” di cui sopra è sereno: seduto sopra un cumulo di neve intona una filastrocca, al suo fianco c’è una ragazzina. I due sono amici e giocano insieme. Ok, sem- Interno Giorno. Una signora di mezza età parla da sola, cerca di rassicurarsi, dice: “Ora andrà tutto bene”. Deduco che deve esserci qualcosa che è andato storto. Boh. Vediamo. Piccola pausa. Noto che la signora non ha una bella cera. I suo lenti ed impauriti movimenti si risolvono in uno scatto improvviso verso il lavandino della cucina: rimette un liquido rosso sangue. Beh, in effetti aveva ragione ad essere tanto preoccupata. Scena Bandita n. 4 Interno Alba/Crepuscolo. Ecco ancora il “biondissimo” che tiene bloccata a terra la “più pallida di lui, dai capelli bagnati, con gli occhi enormi color ghiaccio e i piedi scalzi”. Stanno giocando? Lui mi 14 sembra piuttosto nervoso; la prende a schiaffi! Le chiede subito perdono e mettendosi al suo fianco, le sfiora la mano e le sorride… Sto per assistere allo scambio di un tenero bacio? No. Lui ringhia e lei le risponde allo stesso modo. Sono felici. Sconcerto [il mio, ovviamente, dato che loro sembrano innamorati l’uno dell’altra]. Bene, arrivato a questo punto non sta a me trarre delle conclusioni, ma posso ammettere che la deriva disturbata e misteriosa verso cui ogni “scena bandita” tendeva mi ha catturato. Decido di guardare il film; 110 minuti; titoli di coda. Fine. Non vi racconterò la trama, ma posso anticiparvi che “Lasciami entrare” è un film ben costruito, con un’ottima sceneggiatura, scelte stilistiche e di regia mai lasciate al caso, un cast terribilmente perfetto, un silenzio necessario e una rara abilità nell’attraversare i generi horror, thriller e di cinema arthouse. Cari lettori/spettatori, sperando di avervi incuriosito con le “scene bandite” del film vi lascio alle parole recitate nel trailer (selezione e sintesi delle “scene elette”): “In ogni pausa si nasconde un desiderio. Lascia entrare l’amore, o… l’orrore. Ma lascia che accada adesso” Buona visione! LASCIAMI ENTRARE (Let the right one in) di Tomas Alfredson con Kare Hedebrant, Lina Leandersson - Svezia, 2008 (Dvd edito da Perseo Video, 2009) dall’omonimo romanzo di John Ajvide Linqvist (Marsilio, 2006) Vincitore del TRIBECA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 26° Torino Film Festival - Selezione Ufficiale Recensione/1 After Dark Sara Reali S uccede che ti ritrovi a passeggiare per mercatini in un sabato mattina affollato, trovi distese di libri usati a un euro e spulciando tra i titoli noti Sotto il segno della pecora di Murakami Haruki e ti senti fortunata: forse perchè avevi sentito dire che in Italia è fuori catalogo o semplicemente è ardua impresa trovarlo. Allora mi viene in mente quanto sia stata bella la mia prima volta con Murakami: After Dark mi è stato regalato poco tempo fa e la dedica che l'amica aveva scritto appositamente per me non poteva essere più azzeccata nel dire “... ti fa sentire come un gigantesco puntaspilli... riesce a pungere ogni singola emozione...”. Aveva ragione e l'ho scoperto subito dopo essermi addentrata nei primi capitoli. La scrittura di questo autore cult giapponese è lineare e cristallina, meticolosa nelle descrizioni che presentano le vite dei personaggi come quasi fossero anestetizzate in un universo bianco, minimal e senza tempo. Avete visto Lost in Translation? L'atmosfera che si respira leggendo e che mi sono figurata nella mente è proprio così: leggera, naïve, quasi passiva in contrasto con la frenesia metropolitana. La telecamera dell'autore è puntata su stanze solitarie, case d'appuntamenti e bar aperti 24 ore su 24 nell'intento di registrare ogni singolo movimento degli attori che inconsapevolmente iniziano ad 15 incastrarsi l'uno nelle vicissitudini dell'altro. After Dark parla di come ci si possa chiudere dentro se stessi tanto velocemente da non rendersene conto, ma anche in che modo una notte possa inaspettatamente portare chiarezza: l'oscurità del proprio profondo è in netto contrasto con le insegne luminose al neon dei quartieri di Tokyo che non dormono mai, dove la protagonista Mari vive di notte per fuggire la luce dei problemi che la abbagliano quotidianamente. Prima che nuovamente ritorni la notte, ci troviamo davanti ad un romanzo che lascia tutto in sospeso e forse questa è la sua debolezza: non perchè sia un amante dell'happy-ending o perchè non riesca a vedere al di là di un finale incompiuto, ma avrei immaginato un altro tipo di commiato. Incompiuta bellezza, ecco come potrei riassumere in due parole quello che mi ha fatto pensare l'ultima facciata di questo mio primo Murakami e potete starne certi, non sarà l'ultimo, perchè mi sento come un gigantesco puntaspilli. After Dark di Haruki Murakami Einaudi, 2008, 178 p. Recensione/2 Né di Eva né di Adamo Simone Rossi L e magnifiche stanze tradizionali profumavano di tatami fresco, e ciascuna aveva la sua immensa vasca da bagno zen, riempita ininterrottamente da un bambù che vi versava acqua bollente. Per evitare che debordasse, nella pietra cruda del bagno era stato praticato un orifizio, sopra il quale campeggiava l’ideogramma della balla di fieno incendiata, simbolo del nulla. – Metafisico! – esclamai. Il guaio di leggere un libro di Amélie Nothomb ambientato in Giappone senza conoscere né Amélie Nothomb né il Giappone non è di per sé un guaio. Lo diventa se uno pensa a tutti i nerd di Amélie Nothomb che ci sono là fuori, e a tutti i nerd della Millenaria Cultura Giapponese, banzai, e a tutti i nerd delle due cose messe insieme, cosa ne vuoi sapere tu di Amélie Nothomb e della Millenaria Cultura Giapponese. Ecco, io non ci ho pensato. Per questo – ok, anche per questo – il libro è stato una lettura, come dire, posso dirlo? Lo dico: emozionante. Trama del romanzo in cinque secondi, pronti via: Amélie va in Giappone, conosce Rinri, si innamorano, lui ha una limousine bianca e le chiede di sposarla, lei scappa e torna dopo cinque anni (nel frattempo è diventata una scrittrice famosa. Lui nel frattempo è diventato un ciccione), si abbracciano. Fine. Ma da quando in qua ci frega qualcosa della trama? C’è più trama in un episodio di una serie tv che in tutta la letteratura del Novecento (ba-boom!). Infatti, le cose belle di questo libro sono altre. Per lo meno quindici. Ne dirò sette. 1. Il verbo asobu. Asobu vuol dire giocare, nel senso di non-lavorare, come l’otium latino, ma non proprio, come il cazzeggio, ma non proprio, ah, l’intraducibilità dei concetti della Millenaria Cultura Giapponese. A Rinri piace giocare, giocare nel senso di asobu, e Amélie s’innamora di questa cosa. Oddio, innamora non è il verbo giusto. 2. Il verbo koi. No, non è un verbo. E’ un concetto. Significa: diletto. Amélie non ama Rinri, perché l’amore ha una faccia torbida, e con il ragazzo dalla limousine bianca tutto è molto pulito. Prova per lui il koi, puro piacere-di-condividere-il-tempo. Il koi è una parodia dell’amore, ne imita i gesti per gioco (asobu). Il koi è una figata. La fregatura è che Rinri, invece, è innamorato. Innamorato normale. Ah, e poi koi vuol dire carpa, il pesce, e Amélie odia le carpe. 3. La cultura di Amélie. La tipa ascolta Bach, Liszt e Brassens, cita Schopenhauer e Hiroshima Mon Amour, penetra nei concetti scardinando le loro etimologie. Non registra un gran punteggio sul Verbosometro (cit.), ma si dà il suo bel 16 da fare. Il tutto, con leggerezza. Velocità. Ironia. Non te la fa pesare. Verrebbe voglia di invitarla fuori a cena, se non fosse una quarantenne disadattata. 4. L’elogio del movimento: “O meraviglia della corsa! Lo spazio ci libera da tutto. Non c’è tormento che resista all’espansione di sé nell’universo. Il mondo sarebbe così grande per niente? La lingua dice una cosa giusta: darsela a gambe vuol dire salvarsi. Se stai morendo, scappa. Se stai soffrendo, datti una mossa. Non esiste altra legge che il movimento”. 5. Almeno due scene incredibili: lei che piscia nuda in una tempesta di vento / lei che mangia un polipo vivo, e il polipo le afferra la lingua. 6. Amélie è ossessionata dalla scrittura. Questo la salverà nell’ora dell’Apocalisse. 7. A Natale in Giappone maturano i cachi. Nevica, ed è un vero koi vedere il bianco sopra l’arancione. I cachi con la neve. Quanto devono essere buoni? Il frutto dell’albero, i due innamorati, la rovina: la volta del serpente e della mela fu colpa della femmina, Eva. Invece qua (cioè là, in Giappone nel 1990), è il maschio che porta il dono alla donna, perché vuole farla sua. Ah, già: il libro s’intitola Né di Eva né di Adamo. Dura 150 pagine e si legge in due ore, di mattina, sulla panchina di un parco di Bologna, circondati dalle signore che scendono i cani e li pisciano, alzando gli occhi ogni tanto per sorridere ai bambini nelle carrozzine, oh, che carini. Almeno, a me è successo così. E non vi servirà essere dei nerd di Simone Rossi per capirlo. Né di Eva né di Adamo di Amélie Nothomb, Voland, 2008, 160 p. O scar Pistorius parla di sé e del suo deficit fisico in maniera semplice, diretta e delicata. Occorre più autocritica per le volte nelle quali ci si chiude nella dicotomia diversità vs. normalità senza cogliere la peculiarità delle situazioni. Riempirsi la bocca di buonismo e pietismo crea handicap maggiori del deficit stesso. La storia del corridore senza gambe é splendida e commuovente. Fa riflettere ed emoziona nonostante l’essere un semplice libro-intervista senza alcuna pretesa letteraria. Oscar Pistorius non é straordinario, fà quello che fanno tante persone fuori dai riflettori. Non é normale, né diverso. È semplicemente sé stesso. In uno dei romanzi più sinceri, duri e disincantati che abbia letto, José Saramago immagina la nostra società cadere nel buio di una cecità abbagliante. Non é il deficit a spaventare. Non fa paura la diversità. Ad atterrire é la paura e la meschinità del vivere quotidiano, la perdita dell’umanità di una società in grado di accettare uno scivolamento, dal quale neppure il lettore può esimersi, nella normalizzazione di un orrore vissuto dall’interno come inevitabile. Non spaventa diventare ciechi, spaventa l’essere uomini in mezzo ad altri uomini. In una notte senza pause in cui tutte le vacche sono nere, mi sorprendo girare in tondo come un derviscio inseguendo una originalità che di fatto accetto solo se massificata. La diversità spaventa allo stesso modo in cui spaventa l’essere unici, lo stare in piedi sulle proprie gambe. Guardo ad Oscar Pistorius con lo stupore di chi vede per la prima volta le proprie gambe solo quando sorpassato di corsa da una persona priva delle stesse. Dicono che fare da specchio faciliti in sé stessi la consapevolezza e nell’altro la riflessione. Lo stesso mecca- nismo psicologico interessa il libro, l’atto creativo dello scrivere e quello parimenti creativo del leggere. Normale e diverso, reale e fantastico, dovuto e voluto. Christopher John Francis Boone, nel romanzo di Mark Haddon, é un ragazzino autistico che sfida le proprie difficoltà e parte alla ricerca dell’assassino del cane del vicino. Dopo aver empatizzato con lui nel dipanarsi della vicenda, orgogliosi lo vediamo infine congedare la propria figura con Viaggi Normale vs. diverso di ALESSANDRO POLLINI la capacità di sognare un po’ più in alto. Jean-Baptiste Grenouille vive tra le pagine create da Patrick Süskind con la vocazione a comprendere gli odori ed a penetrarne la matematica con la quale giungere al cuore degli uomini. È un escluso, un emarginato. Vive fuori dalla società una vita intera, utilizzando l’olfatto come senso principale per muoversi nel mondo. Grazie a questo dono si salva dalla morte per scegliere di essere divorato in un atto di amore. Baratta invece la vita con la percezione del reale il ragazzo che, sopravvissuto ad un naufragio nell’Oceano Pacifico, divide lo spazio della scialuppa di salvataggio con una tigre, dopo che questa si è cibata della zebra, dell’orango e della iena. Restano lui e la bestia, entrambi affamati, isolati dal resto del mondo. Solo alla fine dell’alle- 17 goria narrata da Yann Martel viene rivelata la chiave di lettura dell’intera vicenda, quando il sopravvissuto Pi Patel apostrofa il lettore attraverso la figura del funzionario del Dipartimento Marittimo del Ministero dei Trasporti Giapponese, affermando di aver capito che ciò di cui si é in cerca é solo una storia che non sorprenda, che confermi quello che già sappiamo, che non faccia vedere le cose in un modo più profondo o semplicemente diverso. Piatta, immobile, sterile, insipida realtà. Nel Giardino dei Ciliegi, Liuba suggerisce a Lopachin che nella vita grigia che facciamo e tra le cose inutili che diciamo, bisognerebbe lasciar perdere le commedie e guardare più dentro a noi stessi. Credo si debba stare attenti a leggere il mondo con la lente della contrapposizione attribuendo le etichette di normale e diverso. Scrive Alessandro Bergonzoni che «Pavido la mattina alzava le braccia ma alzava anche le gambe per non farle sentire arti inferiori». Mi sono venuti in mente in questo articolo: Oscar Pistorius - Dream Runner (Rizzoli, 237 pp. 16,50 euro); José Saramago - Cecità (Einaudi, 315 pp. 16,53 euro); Mark Haddon - Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (Einaudi, 247 pp. 16 euro); Patrick Süskind - Il Profumo (Longanesi, 259 pp. 17,60 euro); Yann Martel - Vita di Pi (Piemme, 379 pp. 15,90 euro); Anton Čechov - Il Giardino dei Ciliegi (Rizzoli, 135 pp. 5 euro); Alessandro Bergonzoni - Le balene restino sedute (Garzanti, 150 pp. 18,60 euro). Nobel minori "La Perla" di J.Steinbeck di VIVIANA LISANTI I l concetto di “morale dell’ostrica” si riferisce a quella visione fatalista della vita che fa da sfondo ai più famosi romanzi di Verga, in particolare quelli del cosiddetto “ciclo dei vinti”, come I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. La “morale dell’ostrica” suggerisce che finché l’ostrica sta ben ancorata al suo scoglio nulla di male può accadere; nel momento in cui se ne stacca è destinata a naufragare, inghiottita dalle onde del mare. Verga, in totale contraddizione con la filosofia del suo tempo, il positivismo, sosteneva che il progresso fosse una macchina spietata, pronta a stritolare nei suoi meccanismi i membri più deboli della società. I poveri, gli emarginati, non avevano alcuna possibilità di cambiare in positivo il corso del proprio destino. Avrebbero fatto meglio ad adattarsi alla propria condizione, aspirare a qualcosa di più, oltre che risultare vano, significava perdere quel poco che già si possedeva. Nel caso del romanzo breve di Steinbeck, edito nel 1947, si può parlare di una “morale della perla”. Il pescatore messicano Kino trova infatti una perla di rara bellezza e viene insidiato dal pensiero di poter diventare ricco. Riflessi nella lucente superficie della perla, osserva sfilare i sogni di una vita: vestiti nuovi, un fucile, una casa, un’istruzione per il figlioletto. La perla, simbolo di una possibile felicità legata al benessere materiale, di un tentativo disperato di emancipazione dalla propria condizione sociale, si rivelerà però una completa illusione. Non solo Kino non diventerà ricco, ma sarà travolto da una maledizione che la perla sembra portare con sé. Perderà se stesso, i suoi sogni, la sua casa, il suo unico e amato figlio. “Chi si accontenta gode” sembra essere la morale suggerita da questa favola nera, nella quale il personaggio di Kino potrebbe facilmente risultare condannabile, emblema di un’umanità avida e insoddisfatta, accecata dalla propria ambizione, per la quale è disposta a sacrificare i propri valori e affetti. Una breve riflessione, però, ribalta il punto di vista sulla vicenda e getta una luce di tenera comprensione su Kino, riportandoci allo Steinbeck che conosciamo, troppo profondo per poter concepire che la felicità dell’uomo risieda in un atteggiamento da bestia rassegnata: “Poiché sta scritto che gli uomini non sono mai sazi, che se date loro qualcosa essi vogliono qualcosa di più. E questo lo si dice per disprezzo, mentre è una delle più belle doti della specie, quella che ha reso superiore l’uomo agli animali, che si accontentano di quello che hanno.” La Perla di J. Steinbeck, Bompiani, 109 pp., 5.94 euro A sinistra: Alfred Nobel con orecchie da somaro 18 Scheda Libro Storia delle rivolte Perché è utile leggere Q al liceo di ANDREA RINALDI «H istoria magistra vitae», ci ripetono, tutti, incessantemente. Ecco perché si studia la storia a scuola, per imparare da quello che è accaduto molto prima di noi. La materia non deve suscitare molte simpatie perché gli errori del passato continuano a ripetersi e così la storia, da linea, diventa “uroboro”, un serpente che si mangia la coda, un eterno ritorno. Se frequentate il terzo o quarto anno di scuola superiore vi troverete ad affrontare periodi storici molto complessi, dove guerre, incoronazioni, pontificati e regni sprizzano come schegge dal cozzare tra il principale attore dell’epoca, la Chiesa, e altri comprimari. Diciassette anni sono un buon traguardo per capire come la storia sia anche politica, ma soprattutto trama di palazzo («La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi», diceva Karl Von Klausewitz). Ecco perché questa volta vi consiglio un libro di storia: si chiama Q (Einaudi, 643 pp. 16 euro) ed è stato scritto nel 1999 da un collettivo bolognese di scrittori, quattro per la precisione, trincerati dietro lo pseudonimo di Luther Blissett (nome che celava anche un’intero movimento di controcultura sul finire del ventesimo secolo). La forza del romanzo sta nel suo focus contemporaneo: la storia di un ribelle senza nome, che passa da una rivolta all’altra in piena Con- troriforma, è in realtà la storia di come nascono i movimenti rivoluzionari e di come muoiono, repressi nel sangue, soffocati sul nascere, avvelenati da sobillatori, pugnalati alle spalle da spie. Cambiamenti e trasformazioni li vediamo con gli occhi del protagonista nella disputa tra Melantone e Lutero, nella diffusione della dottrina di Giovanni Calvino, nel sangue che sgorga durante la battaglia dei contadini di Frankenhausen e dove trovò la morte il capo dei rivoltosi Thomas Muntzer. Q è thriller e romanzo storico, racconta l’archetipo della rivoluzione, la delinea partendo dall’idea principe e poi giù “giù per li rami”, scontri, schemi, viagggi, sostenitori, detrattori, imprevisti, traditori. Che qui, come in tantissime altre ribellioni, non mancano, anzi sono – ahimè – l’ingranaggio che causa gli spostamenti del nostro eroe in giro per l’Europa, rapido a stringere nuove e insperate alleanze, pur di sovvertire i diversi poteri che tiranneggiavano l’Europa del 1500. Luther Blissett con questo romanzo ci dice che la rivoluzione non si attua solo accanto a Jan di Leida sguainando una daga o dopo interminabili discussioni seduti al tavolaccio di una birreria in Sassonia: la rivoluzione ha mille teste – meglio, è mille idee – e nasce anche da un contrabbando di libri nelle paludose pinete di Cervia o con la riproduzione esatta di un sigillo in grado di truffare i più potenti banchieri d’Europa, i Fugger. 19 Oggi, nel 2009, a dieci anni di distanza dall’uscita di Q e con i nostri occhi, abbiamo visto musica che può arrivare gratis sul nostro computer (impensabile!), ma anche sull’orlo di quale voragine ci abbia condotto lo strapotere delle banche (il famoso e pericoloso «Il denaro genera denaro») e quanta preoccupazione stia montando sulla testa di chi – scrittori, copywriter, best-seller, editori - teme la libera circolazione di un libro, accapigliandosi per pdf di romanzi interamente scaricabili da internet. Si continuano ancora a combattere guerre insanguinate, accuratamente pianificate in palazzi ben protetti (che cosa è il G8, se non una teatralizzazione dell’assedio della folla al castello del principe?), leader e capipopolo vengono ora innalzati, ora trascinati nel fango dopo la disfatta proprio come accadde a Thomas Muntzer e al suo sogno di libertà. E la storia va avanti, ma nella bocca del serpente. Questo è il nuovo “classico” che vi consiglio per la vostra lettura a scuola. Quando lo avete finito voglio la scheda libro sulla mia cattedra. S e nel numero scorso abbiamo parlato di Proust, in questo presentiamo uno scrittore spesso citato nella Recherche e da Proust considerato un maestro: Jean Racine. Siamo circa nel 1640 e Racine, orfano, viene spedito dalla nonna a studiare al collegio di Port-Royal, austero covo del giansenismo e della logica di Antoine Arnauld. Volevano far di lui un prete ma Jean si oppose ed anzi, dopo che i suoi compagni definirono i drammaturghi “avvelenatori pubblici” li mandò al diavolo e proseguì la sua carriera nel teatro, tanto da essere gere, ad impressionare ed appassionare il pubblico. Con Racine muore la tragedia umana e sorge invece l’uomo tragico. Un po’ l’uomo mezza-pippa, per capirci. Egli predilige l’incertezza, le lacrime, la dolcezza di un essere umano irrimediabilmente peccatore e gravido di malvagità. Atalia, accecata dal suo odio incontrollato per la morte del figlio, fa strage di tutta la stirpe reale. L’uomo di Racine, zuccone come nessuno prima, non riesce a reagire alle proprie passioni, vi si butta a forza per precipitare in maniera volontaria verso l’abisso. Ma, come in tutte le belle storie, NON PUO’ finire così. «L’opera è satura di avvenimenti: la tragedia politica di un popolo, il destino di una stirpe. Le predizioni della schiavitù in Babilonia, del Messia, della Nuova Gerusalemme...» suggerisce Mendri nell’introduzione. E perché questo proliferare di eventi? In molti hanno collegato il teatro di Racine alla sua rigorosa formazione giansenista, ma raramente ne viene sottolineato il legame con la logica di Port-Royal. Tale logica non è formalista: oggetto non è infatti lo studio dei nomi, bensì il modo di formarsi della conoscenza e delle idee. Scrive Artaud: «La logica è l’arte di condurre bene la propria ragione nella comprensio- Déjà lu Racine e la logica del teatro di GRETA TRAVAGLIATI oggi considerato il più illustre rappresentante del classicismo. Una crisi esistenziale dopo una condotta definita nella prefazione delle Edizioni Paoline “poco edificante” (la prefazione non scende in dettagli, ma noi sappiamo che Racine aveva burrascose storie d’amore con le più famose attrici del periodo) lo portò a riavvicinarsi alla religione e ad abbandonare le sue passioni. Comporrà in seguito altre opere di stampo moralista di cui l’ultima è Atalia, su cui ci concentriamo ora (e da non confondere con Alitalia, benché rappresentino entrambe un grosso fallimento). Fatalismo Il giansenismo fu condannato come eretico perché privava l’uomo del libero arbitrio: egli è mosso solo dal peccato e sempre indotto a fare del male. Solo per grazia divina possiamo ambire alla salvezza. In Racine è quindi una forza superiore all’uomo che domina gli eventi e fa sì che ogni passione non domata finisca per essere punita dall’unico vincitore, il volere divino. Alla fine dell’Atalia Gioas, salvato in fasce da Josaba, viene riportato al suo trono ed Atalia uccisa: il popolo di David ha di nuovo il suo re. E Dio sia lodato. Classicismo Disdegnando l’ispirazione barocca del suo predecessore Corbeille, Racine adotta un impianto classicista. Non sono più quindi il vigore e le virtù dell’uomo ad emer- Metodo L’Atalia fu considerata un flop tale da indurre Racine ad abbandonare definitivamente il teatro. Non piaceva perché la vittoria del bene sul male è percepita solo di striscio. 20 ne delle cose…è necessario in essa considerare le idee come indiscernibili dalle parole, e le parole dalle idee». Racine non può spiegare l’idea del volere e dell’amore divino se non tramite il succedersi di intrighi e pasticci attraverso i quali esso si realizza. Il dispiegarsi di un ordine divino è identico alle conseguenze tremendamente terrene che questo ordine genera, e su cui Racine si concentra per mostrarci come l’uomo è, e non come deve essere, aspetto invece prediletto da Corbeille. Sembra in sostanza che Racine prediliga strilli e stramazzi a ricercate pose da super-eroe, ed in fondo anche noi. L’assoluta vittoria del bene dunque non consola, non rasserena fino in fondo, lascia un po’ l’amaro in bocca. Ma come spiega Foucault in Storia della follia nell’età classica (Bur, 566pp 11 euro), è tutta una questione di luce: gli uomini di Racine abitano «grandi facce di notte…quartieri d'ombra che frequentano il giorno senza lasciarsi mai da esso annientare». Banalità T utti noi da bambini abbiamo chiesto almeno una volta perchè il cielo è blu. O perchè il vetro è trasparente. Ricevendo sempre risposte approssimative (perchè lo spazio ha il colore della notte, mi diceva la mia maestra...), poi da grandi ci siamo talmente abituati un bel rompicapo). Quando la luce ci sbatte contro viene riflessa in una direzione casuale, i secchioni dicono che la luce viene diffusa secondo lo scattering di Rayleigh, e quindi in seguito a tantissime riflessioni arriva a noi da una direzione del tutto casuale e non più direttamente dalla direzione del sole. Pensiamo un attimo a un banco di nebbia improvviso in una giornata di sole: la luce ci arriva da tutte le parti perchè è appunto deviata miliardi di volte dal suo percorso originale e “imbeve” tutta la nube. Il trucco è che non tutte le radiazioni interagiscono allo stesso modo con questi piccoli corpuscoli, ma con una probabilità diffusione della luce, ma in questo caso in maniera un po’ diversa. Il vetro è una specie di liquido iperviscoso, disordinato (amorfo) mentre il marmo è un materiale cristallino. Ora, i cristalli del marmo fanno da microscopici specchi per la luce. Ed essendo tanti (miliardi di miliardi in un piccolo pezzettino) e orientati in maniera casuale, la riflettono casualmente. Non vediamo più immagini ma solo il colore perchè ogni raggio ci arriva storto. Il vetro invece i cristalli non li ha. È tutto uguale a livello nanoscopico, tutto un casino. La luce quindi non ha nulla con cui interagire e prosegue dritta per la sua strada (ci sarà un Pillole di scienza (per topi da biblioteca) di FABIO PARIS e non ci abbiamo pensato più. Che peccato! Le abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi ma non sappiamo il perché. Ecco che Finzioni vi corre in aiuto! In effetti non è affatto semplice capire perché il cielo sia blu. Di solito una cosa è colorata perchè assorbe un colore, e noi la vediamo del colore complementare. La luce bianca del sole infatti è la somma dei vari colori, dal rosso al blu, passando per il giallo e per il verde. Ovvero: la radiazione bianca è la somma di radiazioni di diverso colore (frequenza), dal rosso (frequenze più basse) al blu (frequenze più alte). Torniamo al cielo. L’atmosfera è piena di corpuscoli nanoscopici come polveri o goccioline d’acqua, o più semplicemente punti in cui casualmente l’aria è per un istante più densa che attorno (fluttuazioni, proporzionale alla quarta potenza della loro frequenza (spocchia). Capiamo quindi che la componente blu della luce del sole, frequenze più alte, viene diffusa molto di più della luce rossa, frequenze più basse. Quindi l’atmosfera risulta “imbevuta” della luce blu, che ci arriva da tutti gli angoli possibili. Ecco perchè il cielo ci appare blu. La luce rossa invece non viene quasi diffusa dall’aria e procede dritta. Quando poi i raggi del sole attraversano più atmosfera (ovvero quando il sole è basso, questione di geometrie) la componente blu viene totalmente diffusa e a noi ci arriva solo la rossa. Un bel tramonto. E perchè il vetro è trasparente mentre il marmo è bianco? Nessuno dei due assorbe la luce! Entrambi dovrebbero essere uguali! Bhe, ancora abbiamo a che fare con la 21 po’ di scattering di Rayleigh, ma in bicchiere è talmente sottile per cui il fenomeno non ha praticamente importanza). Così il vetro è trasparente. Se lo righiamo diventa bianco però! Uh. Che confusione! Se il vetro è amorfo perchè dovrebbe diventare bianco? Semplice! Rigandolo creiamo una superfice scabra, che riflette la luce di nuovo a caso come un sacco di specchi disposti casualmente. Il vetro passa da trasparente ad opaco, e la nostra finestra smerigliata del bagno può proteggerci dai guardoni. Bhe, ora quando un bambino impertinente vi chiederà il perchè di una di queste ovvietà potrete lederne l’autostima con una spiegazione piena di “probabilità direttamente proporzionale alla quarta potenza della frequenza...”. Diventerà un pittore. Recensione/3 Sputerò sulle vostre tombe Andrea Meregalli U n nero che vuole fare il bianco. Due bianche che si vogliono fare il nero che vuole fare il bianco. Un nero che vuole fare il bianco che vuole farsi tante bianche, magari anche ucciderne un paio, per vendicare un nero che voleva fare il nero. Tosto vero? Tosto sì. Tosto e censurato. Nel 1946, in Francia, le case editrici erano a caccia di romanzi americani da pubblicare. Successo garantito. Vendite alle stelle. Soldi. Soldi. Soldi. Nel 1946, in Francia, un tale Boris Vian propone alla casa editrice Le Scorpion un romanzo a tinte forti. Quando dice “tinte forti” intende sesso e alcol. Intende razzismo e pedofilia. Intende macchine veloci e musica rock. Intende prostituzione e omicidi. Intende, insomma, un fottuto bordello in piena regola. Piccolo particolare. Boris Vian non è americano. Non è nemmeno anglosassone. È francese. Di Ville d’Avray. Nord del paese. Come fare quindi? Come aggirare la severa censura d’oltralpe? Idea semplice. Pseudonimo. Pseudonimo studiato. Pseudonimo con storia annessa. Pseudonimo tipo Vernon Sullivan. Lo scrittore negro purgato, causa razzismo, negli Stati Untiti d’America. Nasce così, Sputerò sulle vostre tombe. Il romanzo di fretta. Pensato in poche ore. Scritto in pochi giorni. Diventato best-seller in poche settimane. Censurato in pochi mesi. Dimenticato in pochi anni. Storia a “tinte forti”, diceva Boris Vian. Come non essere d’accordo? Il protagonista è un finto bianco. Un nero con la pelle chiara. Assolutamente uno schiavo del sesso. Nonché un pericoloso killer vendicativo. Nonché un alcolizzato. Nonché un simpatizzante pedofilo. Nonché un sorridente bibliotecario. Si scopa una donna. La sorella della donna. Svariate ragazzine. Una bambina di colore costretta alla prostituzione nel capitolo dieci. E il capitolo dieci turba. Spaventa. Vorresti non ci fosse. Assomiglia tanto a un calcio nelle palle. Un calcio di punta. Punta di ferro. Protagonista e amico del protagonista “contro” due bambine prostitute. Una bianca e una nera. Voi magari nel vostro bel lettino. Sotto le coperte. Appena finito di parlare al telefono con l’amica o il fidanzato o l’amante o la nonna. E tutto ad un tratto siete in un bordello a leggere le gesta di due pedoputtanieri. La tentazione di scagliare lontano il piccolo libro potrebbe essere tanta. Ma non fatelo. Andate oltre. Certo Boris Vian non risparmia dettagli. E loro sono bambine. E una piange. E si leggono le seguenti parole: tanfo, grossa negra, undici o dodici anni, gonna troppo corta, culetto rotondo, cominciava ad ansimare, bere, mano in mezzo alle gambe, ti faccio picchiare, troppo grosso, lacrime, spogliati, piccolo grido, entrai dentro, bruciava come 22 l’inferno. Scena e parole che, credo, resteranno vivide nella memoria del lettore. Forse più dell’intero libro. Dove la ricerca del proibito, dell’atroce, del meschino, della vendetta a tutti i costi, immalinconisce non poco. Ti viene da dire. Che mondo di merda. E poi ci pensi, realizzi che è vero. Realizzi che non avresti voluto realizzare. Realizzi che probabilmente domani passerà. Spegni la luce. Buonanotte. Sputerò sulle vostre tombe di Boris Vian, Mondadori, 2006, 138 p. Commento all'opera di JACOPO CIRILLO C i sono due modi per raccontare le storie: la noiosa verità e la mirabolante esagerazione dei fatti. La morte di Boris Vian, legata al suo libro “Sputerò sulle vostre tombe”, si può raccontare solo con un’iperbole. Vian, eclettico scrittore, ballerino, jazzista, critico musicale, giornalista, inventore, satrapo patafisico, si era stancato della moda degli autori americani in Francia (siamo a metà del 1940); per scommessa con il suo editore, si impegnò a scrivere un hard boiled di qualità, meglio degli americani, in quindici giorni. in anteprima per l’autore. Questi, a metà proiezione si alzò e disse: “Ma che cazzo, e questi sarebbero americani?”. Il libro fu un successo. Un regista volle trarne un film e, continuamente punzecchiato dalle raccomandazioni di Vian sull’autenticità degli attori, lo produsse e lo proiettò Se volete sapere come sono andati davvero i fatti, leggete la postfazione del libro. Ma è molto meno divertente. E morì. Charlie VS Proust Scene di vita vissuta di CARLO ZUFFA È curioso notare come passano gli anni ma certe dinamiche familiari non accennano a mutare. E così ci introduci Combray e i suoi frequentatori, nonni, zie e prozie. È curioso come certi atteggiamenti non vadano perduti: pettegolezzi, riverenze e convenevoli vengono mutuati dalle epoche che si susseguono senza lasciare che la polvere del tempo si adagi su di essi. Quelle che ci narri - Marcel - sono scene di vita vissuta come se ne vedono tutt'oggi. Solo il bacio della buona notte di una mamma rimane un gesto estemporaneo. E tu spasimi per quel momento! Lo descrivi come il momento per cui vale aspettare tutta la giornata, il tuo piccolo Sabato del villaggio quotidiano. Eh già, come cambiano i Tempi! Se fossi nato qualche decennio dopo difficilmente avresti sfogato così le tue ansie adolescenziali. Già ti vedo - Marcel - a piangere solo nel buio della tua cameretta sotto il poster dei Nirvana, allegato al numero di maggio di Rolling Stone come inserto centrale che tu hai estratto con molta cura alzando le alette delle graffette che lo tenevano unito alla rivista, sbuffando con la testa sul cuscino "Nessuno mi capisce". E con questo cosa voglio dire? 23 Assolutamente niente, le cose succedono e il Tempo passa e ciò che leggo per un momento è quasi a fianco a me mentre un attimo dopo si trova a chilometri di distanza. Sono così le vicende narrate nella Recherche e nella stragrande maggioranza dei romanzi familiari, così perchè stimolano ricordi. E i ricordi sono la parte tenera della memoria, la parte più pregiata di essa, che nella prossima puntata tu, Marcel, ci mostrerai come stimolare... I ferri del mestiere Quelle dei diritti di AGNESE GUALDRINI U na volta, probabilmente in uno di quei blog in cui chi scrive tenta di condividere la propria passione/frustrazione con persone che come lui lavorano nello stesso ambito, mi ricordo di avere letto righe particolarmente divertenti. Il pezzo si intitolava Quelle dei diritti, e illustrava in maniera giocosa una serie di cliché su quelle che in una casa editrice si occupano dei diritti esteri. Quasi sempre donne, quasi sempre giovani e quasi sempre magre. Se mai vi capiterà di andare alla Buchmesse di Francoforte vi troverete circondati da giovani ragazze che corrono da un padiglione all’altro con pile di cataloghi in una mano e un bicchiere di caffè nell’altra. Corrono perché gli appuntamenti sono fissati a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro – e mentre la collega portoghese illustra i titoli della nuova collana di filosofia offrendoti deliziosi stuzzichini dell’Algarve, il pensiero che minacciosamente incombe nella tua mente è che in quel preciso momento dovresti già essere al tuo prossimo appuntamento con l’editor praghese tre piani più in basso. Quanto al caffè, beh, quello è un tocco di stile – che varia a seconda delle dimensioni del bicchiere, dettato a sua volta dalla nazionalità (in questo senso quelle dei diritti italiane le riconosci subito dal piccolo, si fa per dire, bicchiere di espresso; quelle americane dalla disinvoltura con cui tengono tra le dita un bibitone di caffeina super size). Quelle dei diritti indossano certi abiti un po’ retrò, dal sapore bohe- mien, e calzano scarpe che provocano invidie vicendevoli. Vivono in un mondo a sé in cui tutti si conoscono: hanno le e-mail dell’agente di New York e dell’editore scozzese, dello scrittore di Singapore e della foreignrights di San Paolo del Brasile. Si scrivono ogni giorno per tutto l’anno e così, quando si incontrano, sembra che si conoscano da sempre: sorridono, si chiamano per nome e si rivolgono l’un l’altra con amichevoli “tu”: Hi Monique, Hi Angela! Quelle dei diritti hanno borse e borsette colme di cataloghi perché stare con il naso in mezzo a quelle pagine è il loro mestiere. Li sfogliano, li osservano…si incuriosiscono, scelgono quali leggere e suggeriscono ai capi quali sarebbe opportuno acquistare. Del resto il loro lavoro è captare, intercettare discorsi sui libri…e se sono sufficientemente accattivanti fare di tutto per acquisirli. A settembre mi hanno fatto un contratto per occuparmi dei diritti esteri nella casa editrice per cui lavoro. Molte volte la giornata si risolve a spedire libri agli editori stranieri sperando che facciano un’offerta per tradurlo. In altri casi si esaurisce spacchettando i libri che gli editori stranieri mandano a te sperando che sia la tua casa editrice a fare un’offerta per acquisirli. Alcuni giorni stai ore a scrivere email per cercare di alzare le royalties o gli anticipi (se i libri sono tuoi – ovviamente, in caso contrario, per cercare di abbassarli). Spesso 24 ti rendi conto di come tutti, su tutto il pianeta, pubblichino ormai le stesse cose…e di quanto l’arguzia di questo lavoro stia nella difficoltà di scegliere tra milioni di variazioni sul medesimo tema il taglio più originale. Questa sostanziale uniformità ti permette tuttavia di stupirti di fronte a quei pochi titoli realmente curiosi e originali, salvo poi rimanere delusa perché l’asta per ottenerlo nove volte su dieci la perdi, perché la tua casa editrice non è quasi mai di manica kimono e i grandi gruppi editoriali vincono sempre (o quasi). Alcune volte ti chiedi come mai quel libro su cui tutti in casa editrice hanno puntato in realtà non se lo fili proprio nessuno. Altre volte scopri con sorpresa che su quel titolo che pensavi sepolto si sono invece posati inattesi interessi stranieri. Alla fine mi piace essere una di quelle dei diritti. Mi piacciono i vestiti un po’ retrò e l’odore dei cataloghi. Mi piace, appena entro in ufficio, ricevere e-mail da New York e scartare i pacchi di libri appena arrivati. Oggi ne ho aperto uno mandato da Hachette, una casa editrice di Parigi. Conteneva un divertente libro per bambini pieno di illustrazioni deliziose. Ovviamente un errore che dovrò rispedire al mittente. Ma nel frattempo, leggendolo, ho passato qualche minuto davvero spassoso. La Posta dei Lettori di Matteo Bettoli di MATTEO BETTOLI S e parliamo di senso di colpa e frustrazione, colore e ripensamento, inevitabile corre il pensiero a Non ascoltare il rumore rosa, storia di una telefonata di un'ora, libretto ipoinchiostrico, confessione sussurrata e col naso chiuso di quella che è stata una delle più celebri telefonate-summa di meucciana memoria. Un dialogo secco, impostato su domande e silenzi continui, insistiti e invadenti, tra il pittore Ogiunna-Lehr e la sua assistente Roaks. Quest'ultima registrò nel 1978 (su indicazione di un Ogiunna-Lehr particolarmente patetico) una conversazione telefonica a bassa fedeltà e la ripropone oggi per iscritto, editata da Acquitrini, con poche note chiarificatrici. Ora le chiedo, perché tanto rumore, e perché rosa. Stefano, Enna D ai Stefano, su. *Hey bimba, non ascoltare il rumore rosa* sono le ultime parole pronunziate da Ogiunna-Lehr prima del *click* cornettale finale, quello con cui congedandosi da Evangeline Roaks si congedò pure dal mondo tutto. Inamovibile la scelta miliare di *parlare solo col pennello*, scelta esplicitata a più riprese, mai rinnegata e insistentemente perseguita (anche più volte al giorno, a dar retta alle donne della sua vita). Ora Evangeline Roaks prova a tirar su dù soldi speculando sulle sordide sortite di un vecchio mezzo stordito, ma in fondo che male c'è e chi non l'ha fatto (o avrebbe voluto farlo) almeno una volta. Evangeline sa ben farsi capire, meno intervistare e scrivere: le domande che porge al suo mentore sanno di posticcio lontano un exametro, nonostante riguardino temi fondamentali della vita di un uomo, come l'amore, l'amicizia, la visione, la pretenziosità, il tempo, la cottura della carne sul barbecue e le curve. Solcando linee diagonali col suo pensiero trasposto, OgiunnaLehr scava a fondo in sé stesso, riconoscendo i momenti che hanno reso possibili svolte, innovazioni, *trasposizioni* per l'appunto. Questi momenti sono, invero, pochi. Le risposte che il calvo pittore dà sono di quelle da grattarsi la testa, e visto che di dialogo è fatto il libro, abbiate la cura di tenere il vostro gratta-testa preferito a tiro. Joyciano perché fluttuante in stato di semi-incoscienza, proustiano perché c'aveva fame e sveviano perché aveva smesso di fumare da poco, Ogiunna-Lehr libera parole come pennellate secche, costruendo su una tela di seconda mano un'autoanalisi da fumetto di Popeye. Mancano però gli spinaci ed inutile è l'attesa di Poldo coi panini -menchemeno compare Trinchetto col fiaschetto di barbera-, OgiunnaLehr torna a dipingere e 'sto libro a fare un rumore tedioso. Tra l'altro, Le déjeuner sur l'herbe di Manet c'entra poco con *sta strappona cò dù zinne de fora*. Non ascoltare il rumore rosa è insomma una farsa con una frase conclusiva sparata a mò di scena-confusione, tipo urlare BOMBA se sei ciccio e 25 ti tuffi in una piscina in posizione raccolta, snocciolare HO SOFFERTO TANTO se sei al bancone del bar con un'intellettuale scandinava, sciorinare HO MOLTI AMICI INDUSTRIALI se arrivi col booster ad una festa di minorenni rotariane, exeterà exeterà. Ogiunna-Lehr in un attimo di presenza tra noi, non assorbito dal suo genio maldestro, realizza di aver detto solo puttanate per un'oretta buona e non trova altro modo di uscire dal pantano che provare un *up and under* rugbystico, calciando la palla ovale e correndo come se avesse rubato, spostando l'attenzione dalla luna al dito che la indica, scancellando con una frase sconclusionata una lunga serie di zibibbate. Bella zio, ma a citare i kulaki azeri che sfruttano inopinatamente manovali sono bravi tutti. Tenete bene a mente queste parole: troppo spesso assistiamo ad un'escalation di artrosi blu magenta. • A hhh Bettoli il giuoco del pallone. Ahhh lo sguardo di chi perde. Ahhh il cuore rimbalzante di chi vince. Ahhh gli scontrincontri tra rivali. Ahhh le bandiere. Ahhh chi ritorna sempre. Ahhh gli sfottò. Ahhh le tifoserie fedeli. Ahhh chi non ce la fa. Ahhh chi sta da solo. Ahhh chi c'ha i piedi girati al contrario. Ahhh la rustichella in autogrill. Ahhh i mercenari. Ahhh chi viene dimenticato. Ahhh la gradinata. Ahhh chi sta male. Ahhh chi ne parla. Ahhh il caffé borghetty. Ahhh chi è rovesciante. Ahhh chi alza coppe. Ahhh chi alza il livello. Ahhh il decoder. Ahhh l'erba tagliata. Ahhh i bar del centro. Ahhh la sublimazione *pulita* dello scontro bellico. Ahhh. Dranco, Alassio A hhh calcio (di Palletti, già in economica su edizioni Lolli) affresca gocce di hinterland milanese e di Hinter, squadra immaginaria forse ispirata al Milan. Il riferimento, non immediatamente coglibile, si straccia le (già poche) vesti che indossa e apre la via *ad una storia che è la mia... ma un po' anche la tua*. A parlare è Rodan, tifoso slavo di origine ma con un cuore pieno di mille stelle intergalattiche, quelle che gli fanno sbraitare in curva *corri dietro a un pallone, ahhh, nel campo laggiù / vola con l'aquilone, ahhh, nel cielo lassù*. Sempre a chilometrare in autostrada, in solitaria, a bordo di una Ritmo Blu. Rodan vive lo sport come avrebbe potuto farlo il re di Beozia Atamante l'Eolio (che era stato lì lì per sacrificare Frisso, il figlio avuto da Nefele) se solo fosse esistita all'epoca altra squadra di pallasassi oltre alla Vellodoro -che vinceva hands down- e la Beozia avesse avuto un preparatore atletico all'altezza. Frisso era un bambino impegnativo, Nefele una donna esigente -ma su questo torneremo quando parleremo della pratica ancestrale della pallasassi descritta dallo stesso Palletti in Pahhhllasassi. Sport come manichéismo dentro-fuori, come buono-cattivo, come linea-campo, come lucetralegambe-nonlucetralegambe, come Billionaire-Hollywood, come torosimulatòro. Certo non basta un pollice voltato in giù à la Commodo per sacrificare uno scarpone indigesto -magari- ma tutt'una riflessione lancinante di chi vive il calcio come rivincita viene espressa da Rodan quando rinunziando alla riduzione fenomenologica di Husserl afferma *se c'è qualcosa di peggio di bere da solo, behhh, è bere cantando*. Rabbia cieca a pugni chiusi viene espressa osservando tifosi poco metodici, attenti alla birra più che al gesto tecnico, poco informati sulle statistiche, incapaci di commutare schema e donne attente -più che al fuorigioco- ai muscoli femorali dell'attaccante col frontino. Il calcio di Ahhh calcio è metodo, rigore, corner. • C aro Bettoli, fiorisce con la primavera tutta una serie di libri-inchiesta atti a farci sentire di merda (e.g. Italiettari della Pavoni, Le presento mio nipote di Brancoli, Schadenfreude a go-go di Scelpi). Ci sentiamo un po' male per il nostro essere uomini, donne, ragazzini, ragazzette, amanti, nerds, parenti dei VIPs, persone informate sui fatti, mangiatori di fibre, autisti in preda alla sobrietà, politici iracondi, tossicomani, stripper strippate, evasori, evasi, DJ di radio, VJ di allmusic, PJ di Una bionda per papà, metallari ben oltre la soglia critica dei 20 anni, gatti etero, soggetti etero-confusi, cristiani convertiti, cristiani malgiogli, matti osceni in luoghi pubblici, pintori di fontane, condannati in terzo grado, sconfittari, ballerine di varie-età, party animals, animali super pelosi, medici alla *viva il parroco*, paramedici, paracarri, io-non-ragiono-inquesti-termini, storti, marescialli, spiriti liberi, futuristi, tonni in scatola, figli della rivoluzione, figli dei fiori, figli di puttana, padri, padri padroni, ragazzi padri, freaks, minorati per scelta anti-sociale & maggiorate nate per recitare. In queste categorie, da lei formalizzate su Caspita un anno fa, ci cade l'Italia intera. Sentendo (TUTTI QUANTI) il dovere di giustificarci per essere ciò che siamo, cerchiamo redenzione perpetuando la nostra pre- 26 senza a presentazioni radical-chic di libri-inchiesta: ci sguazziamo vestiti in stile metro-sexual, pronti a fare domande volpesche, e poi va a finire che in-chiediamo sette Bellini o polibibite similari al camarero. Ultimamente va forte la fatica di Ganessa, elefantiaco leader dei Consumatori Scelti, che col suo Bere meno, bere tutti (edito da Ghianda) ci rimbrotta, ci allarma e ci atterrisce sul nostro essere consumatori alla benemeglio, poco informati, ingenui. Ma è vera questa storia delle bottiglie d'acqua? Alfonso, Livorno S i, è vera. Fonti (d'acqua) autorevoli, messe alle strette dalla penna aguzza di un Ganessa in bretelle, hanno ammesso che le bottiglie di plastica vanno riempite con moderazione, pena l'irrefrenabile librarsi nell'acqua rubinettéa di pericolose particelle nane di PVC. Il numero impresso sotto la bottiglia indica il numero massimo di ririempiaggi consentito, espresso in codice binario. Paura. Ora. Che il riempire le bottiglie di plastica fosse attività spiacevole ce n'eravamo già accorti quando ci schizzammo -nel novembre 1989- i pantaloni di velluto a coste e la sorella del sosia del nostro cuginetto di secondo grado (deriva: alle festicciole di fine anni 80 i bambini erano meri figuranti assunti da genitori-broker, cambiavano a seconda della disponibilità locale mantenendo solo alcune caratteristiche basiche, somatiche e attitudinali: c'era il genio delle scienze, il piccolo gnomo appassionato di fantasy, la bambina trecciolina piena di amici e amiche di penna) ecco dicevamo CI PERCULÒ. Ciò che potevamo solo temere era la crassa esistenza di altri limiti per evitare il librarsi di altre -e più funeste- particelle di malvagità. Sui gelati tra i biscotti Cucciolony, ad esempio, la prova d'acquisto più volte dileggiata e ignorata (*ste machi da strapazzo nelle sale dei bottoni, il caro-affitti ai Parioli visto da chi le case le affitta e i concorsi di bellezza in Lombardia. Auguri a chi, come me, legge libriinchiesta, sussulta e poi fa finta di nulla. prove d'acquisto non servono ad una sega, ahr ahr* è la tipica reazione di chi non sa) indica in realtà il numero di morsi (2) adeguato per inglobarlo e deglutirlo senza subire pericolose devianze vanigliee. Si rischia l'indigestione di inchieste: l'opinione pubblica italiettara è ancora scossa dalla scoperta dell'inattendibilità gallinacea delle ali di pollo di KJY che non sono di pollo ma di cane. ALI DI CANE pergiuda. Segue a ruota quella sui Graffetta La rivincita dei Numeri Secondi di LIVIA FAGNOCCHI A ncora. In pochi la capivano, ma quei pochi capivano i numerosi perché. Durante i pranzi a più di una portata, Graffetta mangiava prima il Secondo e poi il Primo. Prima la tagliata all’aceto balsamico e poi i tortelli burro e salvia. Prima il branzino a vapore, e poi gli spaghetti con le vongole. A meno ché non ci vogliamo perdere in culinaria, c’è poc’altro da aggiungere ai fatti. scrivete a: [email protected] inconsolabilmente ignorano. Se ci sono i numeri primi, e se per di più ne consacrano la Primarietà con un libro sulla loro solitudine, “avete mai pensato” - rilancia Graffetta - “alla frustrazione perenne vissuta dai Numeri Secondi?”. Sono come tutti piccoli Playmobil con il capello a caschetto e l’aria inebetita. Sono talmente tanti i Secondi, che non ce ne rendiamo pure conto. Ci sono Secondi sparsi ovunque, sui marciapiedi, appesi alle pareti, nelle I motivi di Graffetta non hanno niente a che fare con la salute, con le allergie alimentari, con la disobbiedienza, con la stravaganza, con la cocciutaggine. In generale, questa sua mania ha qualcosa a che vedere con la sintassi delle cose, con l’ordine temporale in cui esse sono disposte, esposte e trasfigurate. Più in particolare, la primarietà dei Secondi di Graffetta deriva da un’esigenza sua personale di rendere omaggio ai quei poveri Numeri Secondi che esistono, devono pur esistere, pensa lei, ma che tutti 27 scatole dei giochi, nella musica. L’azione controcorrente di Graffetta - di cenare o pranzare a partire da un Secondo - segue quei piccoli sguardi di premura già attivati nei confronti dei Numeri Secondi, che sono, per esempio, la Sindrome dell’Eterno Secondo, e la lancetta dei Secondi. E mentre Graffetta si gode la sua bella tagliata di manzo con i pinoli, la rucola, i pomodorini e l’aceto balsamico, pensa di urlare a squarciagola “I Will Wait!” (fino a che i secondi saranno i primi), la breve passeggiata militare sgangherata e ribelle dei Pere Ubu. (liberamente ispirato a Père Ubu - Dub Housing) Ghost World “Ghost World” di Daniel Clowes di MARINA PIERRI D opo due numeri dedicati alla graphic novel, questa paginetta diventa finalmente una rubrica, con il suo bel nome e tutto. È quello che vedete qui su, “Ghost World” e ci sono due ragioni per cui l’ho scelto. La prima: se avete letto i due numeri precedenti di Finzioni, sapete che ho iniziato un piccolo discorso su questa forma di letteratura. Credo che la GN sia una via di mezzo tra parola (aperta, immaginattiva, stimolante l’immaginazione) e immagine (chiusa, repressiva, esclusiva, discriminante in quanto frammento di realtà). Proprio per questo ipotizzo che lo sforzo del lettore di fumetti sia inferiore a quello del lettore di libri. Implica meno fantasia del testo scritto, ma ancora richiede la traduzione del disegno in realtà, a differenza per esempio del film. I personaggi delle GN mi sembrano intrappolati in un limbo, una terra di mezzo, il virtuale e l’attuale: la vita della parola e la morte dell’immagine intesa come realizzazione e chiusura. I personaggi delle GN, insomma, assomigliano a fantasmi. Da qui, “Ghost World”. La seconda ragione per cui ho scelto il titolo è molto più banale e riguarda il libro di cui vi voglio parlare in questo numero, Ghost World di Daniel Clowes. Che è percepito da molti come testo emblematico del genere. Il mondo di fantasmi di Clowes è estremamente calligrafico, a partire dalla scelta stilistica di usare solo due colori per le tavole, il verde e il nero (così è nell’ultima ristampa, l’originale era blu e nero). L’autore, a sua detta, ha voluto imbevere il racconto di una luce artificiale, riflessa, come quella che viene da un televisore: il risultato è uno scenario sempre allucinato e sonnolento, pallido e irreale, dove tutto è ombra, caricatura e, abbastanza paradossalmente, disegno. I due personaggi principali, Enid Coleslaw e Becky o Rebecca Doppelmayer, vivono il loro rapporto tra comparse saltuarie, maschere grottesche dai cervelli fini come ostie, partorite dalla matita di un Dio sadico che gli ha negato tridimensionalità (Clowes stesso). Tutte queste sagome e tutte le relazioni che intrattengono con il resto del ambiente-spettro si equivalgono agli occhi delle ragazze: una paratassi estenuante senza alti e bassi, senza profondità, senza umanità. Vite perfette, o perfettamente patetiche, talmente prive di spessore che non ci si potrebbe entrare neppure se lo si desiderasse. Ho detto “scenario” perché tutto questo, davvero, non è che la scenografia di Ghost World. Tavole dipinte davanti alle quali si svolge la storia delle due protagoniste, che non è altro che la storia, anzi, la fotografia dinamica, di un rapporto esclusivo. La GN di Clowes, del resto, è considerata il ritratto perfetto di un preciso (e piuttosto inflazionato) momento della post-adolescenza: la separazione tra grandissimi amici 28 che viene dopo gli anni del liceo, il breve istante in cui si è ancora insieme prima che le proprie strade si separino forse per sempre. E ci si stringe uno all’altro più che mai. Argomento di non facile rappresentazione, l’autore usa una serie di marche per unire Enid e Becky in un legame simbiotico e (dolcemente) morboso: le protagoniste vivono in una specie di relazione sintattica di valore, come un sostantivo e un aggettivo o due virgolette; ed è l’essere l’una per l’altra che dà loro corpo in un microcosmo scorporato, quasi fuor di metafora. Se avete tra le mani la versione in inglese, osservate come il lessico colorito e idiosincratico delle ragazze, più di ogni altra cosa, sia capace di separarle dall’esterno. Non è un caso che Becky viva l’introduzione, da parte di Enid, di parole come “taciturn” o “contentious” (che impara studiando per il college) come una specie di stupro: da un lato, sono il sintomo dell’ingerenza/penetrazione del “ghost world” che si è tanto faticato per tenere distante e dall’altro quello dell’allontanamento verso l’università, cioè della rottura del legame. Vero principio della sparizione, o conversione in fantasma. Una curiosità: Enid Coleslaw è l’anagramma di Daniel Clowes. C i sono due modi per raccontare storie: la noiosa verità e la mirabolante esagerazione dei fatti. L’esagerazione dei fatti, o iperbole, è bella perché è una caricatura. Wittgenstein (yawn) diceva che fare una caricatura non è altro che privilegiare e mettere l’accento su una parte in rapporto con il tutto, creando dunque, dico io, una sproporzione. O meglio, un’assimmetria. L’asimmetria fa ridere e fa pensare, perché non è regolare, dunque buffa, e va messa a posto gestalticamente con la propria testa. L’iperbole, la storia esagerata, segue esattamente questa dinamica: è divertente e fa lavorare il cervello. Fa ridere e fa pensare. Ci sono poi due ruoli che si alternano nelle storie: la banalità dei vincitori e il sorprendente spessore dei perdenti. Le storie dei vincitori sono retroattivamente incastrate nel rasoio di Occam: la soluzione è spesso la più semplice e ovvia. Quando le leggi, sembra che tutto sia andato liscio, che sia successo quello che doveva succedere e niente altro. L’eroe ha vinto perché è buono, la soluzione più semplice è che vinca. Non si scappa. dono per costituzione. Le storie dei perdenti invece sono più belle perché i perdenti, per tirare acqua al loro mulino, si raccontano in modo più personale, più soggettivo, si guardano dentro non potendo ovviamente aggrapparsi alla rassicurazione dei fatti oggettivi. Trovano la verità dentro di sé, non fuori, come Karate Kid. Solo che loro per- In questa rubrica accoppieremo felicemente questi due fenomeni, raccontando storie esagerate di grandi perdenti. Quel ganzo di Walter Benjiamin ha detto che la storia è il bottino dei vincitori. L’iperbole, allora, è la risorsa, forse l’ultima, dei perdenti. E la verità soggettiva è infinitamente più interessante: come diceva qualcuno (quel qualcuno era Kierkegaard ma avevo paura di annoiarvi ancora di più), con soggettivo non si intende un attributo relativistico ma una appropriazione della verità in termini esistenziali. La verità per me. Iperboloser Pete Best P ete Best, erroneamente noto per essere quello che ha scaldato il seggiolino a Ringo Starr quando non aveva ancora una base d’asta, in realtà dovrebbe essere ricordato per la sua rara sensibilità e il suo carattere introverso ma profondo. Il figlio che tutte le mamme vorrebbero avere. Pensate, il dolce e tenero Pete aveva la sua mamma come manager quando, nel 1960, fu scelto come batterista dei già affiatati Beatles. Era un musicista preparato e un bel ragazzo ma Allan Williams lo scelse solo perché non trovava nessun altro che volesse sorbirsi una tournée ad Amburgo praticamente a gratis. Tutto andava bene tra i quattro amici: quando John, Paul e Gorge si divertivano nel modo sfrenato e di JACOPO CIRILLO senza inibizioni che solo i giovani possono sostenere, il tenero Pete stava in un angolo, guardando il cielo e gioendo per ogni stella cadente, limitandosi a raccogliere i cocci delle bottiglie di wiskey che quei burloni gli tiravano addosso, mancandolo quasi sempre. Tornati a Liverpool, i ragazzi erano pronti a incidere Love me do. Era il 1962. Pete era molto entusiasta ma gli altri tre minimizzavano, Ma che sarà mai, è anche un po’ lagnosa, eppoi troppo facile fare rima con “do”, sono capaci tutti e, mentre lo dicevano, si facevano l’occhiolino e il gomitino tra loro. A un certo punto, durante le prove, il manager Brian Epstain entrò con quel capellone che suonava la batteria con Rory Storm & The Hur- 29 ricanes, dai quello con un nome chiaramente inventato, e disse, guardando Pete, Qui c’è qualcuno di troppo e non è Ringo Starr. E neanche io, visto che sono il manager. Il cerchio si restringe. Grazie alla sua profonda sensibilità, Pete capì all’istante e, mogio, tornò dalla sua mamma che immediatamente si autoriqualificò come manager delle coccole, consolando l’inconsolabile. A somma beffa, qualche anno fa i Beatles superstiti consegnarono un assegno da un milione di sterline al vecchio Pete che, guardandoli con tanta sensibilità, gli disse, Eh grazie, proprio adesso che è da una vita che non ci ho manco gli occhi per piagne. Accettò tuttavia l’assegno. Contributi da: Jacopo Cirillo non è mai riuscito a spiegare a sua nonna cosa fa nella vita. Prima per colpa della semiotica, adesso per colpa di una casa editrice. Ha co-fondato questa rivista solo per poterle dire: faccio il co-fondatore di una rivista. E anche, ma secondariamente, per poter dire quello che gli pare sui libri che legge. pensarci, passa buona parte del suo tempo a scrivere, a leggere e a inseguire innumerevoli passioni che, per lo più, svaniscono nel giro di pochi giorni lasciando il posto a nuove manie. Livia Fagnocchi è curiosa, entusiasta e dentro tante storie. Si ossessiona facilmente di canzoni, di mongolfiere, di take-away indiani, di zucca, di misteri, di treni. Cerca analogie, coincidenze, e stare bene. Carlo Zuffa nelle ultime due decadi non ha raggiunto traguardi degni di nota e ritiene che la sua infanzia sia stata traviata dal finale di "Marcellino Pane e Vino". Ora, di notte nel buio della sua cameretta, studia piani segreti per i C.O.B.R.A., i quali gentilmente gli hanno concesso un pò di tempo libero per co-fondare Finzioni. Agnese Gualdrini, 27 anni, laureata in Filosofia nel lontano 2005. Da ormai un anno vive e lavora a Roma in una casa editrice con un non ben definito ruolo di giano bifronte (saltella tra l’ufficio diritti esteri e la valutazione degli innumerevoli dattiloscritti che ogni giorno invadono la posta). Adora il caffè amaro, il lungotevere, i libri di Natalia Ginzburg e cantare anche se violentemente stonata. Matteo Bettoli nasce in epoca reaganiana su un carro di bovini, dal quale eredita la passione per la dinamicità. Scostante, ombroso e pretenzioso - questo dicono di lui gli amici - a 21 anni controlla i principali media di casa: 3 televisioni, 2 computer, l'abbonamento all'Espresso e la radio ricevuta in regalo per la cresima. Decide allora di trasferirsi. Passa un po' di tempo a zonzo occupandosi di robe politiche. Ultimamente lavora a Bruxelles dove viene spesso bollato con l'espressione *lobbista*. Viviana Lisanti è laureata in scienze storiche e studia cultura editoriale all'Università Statale di Milano. Momentaneamente si guadagna da vivere spacciandosi per grafica nonostante non possa vantare alcuna conoscenza in merito. Nessuno fin'ora se ne è ancora accorto, quando verrà smascherata sarà costretta a far futtare una laurea a detta di molti "inutile" Alberto Cocchi è laureando magistrale in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Modena-Reggio Emilia. Concentra i suoi studi sull'uso dell'immagine, soprattutto fotografica. È un avido lettore. Edoardo Lucatti. Edo. Ode. Deo. Un essere flesso nell’edibile, nella lirica e in un soprannaturale deodorante. Performer di incauta protervia, aruspice della significazione e calciapalle di poca morale. Semiònte per alcuni, semiòta per altri, è una piccola fucina di omaggi al vostro personale sconcerto teoretico Jacopo Donati studia Filosofia estetica a Bologna. La sua carriera universitaria gli permetterà, al massimo, di suonare l'organetto per strada: conscio di ciò, per non n. 2 / Maggio 2009 [email protected] www.finzionimagazine.it Stampa: Tipolitografia Castello - Castel Bolognese 30 Andrea Rinaldi è giornalista professionista e vive a Bologna dove scrive per le pagine culturali del Riformista e dell'edizione locale del Corriere della Sera. Comincia a credere che Hemingway avesse ragione quando affermava che "la metà degli italiani scrive e l'altra metà non legge". Andrea Meregalli è un pensatore di quasi venticinque anni. In questo istante medesimo si arrovella su quesiti del tipo: “Cosa farò da grande?”. Assiduo frequentatore di autostrade nonché massimo esperto in campo internazionale di prodotti quali friggitrici, scalda patate, piastre per panini e salamandre, ama molto abbinare correttamente i boxer con le calze. Passa buona parte della sua giornata a leggere le scritte oscene sulle porte dei cessi nei centri commerciali. Come secondo lavoro, Simone Rossi scrive di musica, teatro e amenità varie per un noto quotidiano romagnolo. Il primo lavoro lo sta cercando. Nel frattempo, una volta, è stato in Etiopia. Il viaggetto è diventato un libretto, La luna è girata strana (Zandegù, 2008). Stonatuccio musicista da marciapiede, suona l'ukulele e ha un gatto di nome Chomsky. Tende a scrivere sui muri palindromi intellettualoidi tipo in girum imus nocte et consumimur igni. Fabio Paris nasce impagliato, e così finirà, per evitare che gli amici ballino sulla sua tomba. Zingaro, in accezione monicelliana, ha studiato chimica, seguendo la sua passione per la geopolitica. Ora vive facendo l'inviato da Pittsburgh per Finzioni e spacciandosi per esperto di nanotecnologie. Jacopo Sgroi ha un cognome siciliano, catanese, ma è nato in Trentino, ha vissuto a Firenze, ma è cresciuto a Faenza, ha studiato a Bologna ma è a Milano che è riuscito a fare della sua passione, il cinema, il suo lavoro. Alessandro Pollini é laureato in Psicologia ma non legge nella mente delle persone. Da quando ha iniziato a seguire Voyager é convinto che l’uomo non sia mai andato sulla luna, ma i Templari si. Ha ventisette anni ed é bellissimo. Greta Travagliati, semiotica appassionata di arte, Proust e culturalizzazione della merce. Si interessa di tendenze e chincaglierie del contemporaneo anche se avrebbe preferito vivere nell'800. Attualmente vive a Milano dove lavora in un centro ricerche e dove spera aprano presto Starbucks colorati, una pasticceria turca ed un centro di gravità permanente a forma di pera. Marina Pierri ha 28 anni e vive a Milano, dopo dieci gloriosi anni passati a studiare/lavorare/fare radio/fare la dj in quel di Bologna. Si occupa a tempo pieno del portale musicale Vitaminic.it ma scrive anche su Rolling Stone, PIG Magazine e Blow Up. Ascolta una media di tre nuovi dischi al giorno, legge, guarda un sacco di film e serie televisive americane. Matteo Treleani è dottorando in semiotica a Paris Diderot e ha una curiosa passione per i campi non affini. Amante dei miti greci e della musica barocca, è un sommo sostenitore dell'arte dell'insignificanza, ovvero del non voler dire nulla. Sara Reali, puoi trovarla in mezzo al pubblico di un concerto, dove tutti sono inevitabilmente molto più alti di lei, ma non le importa: adora emozionarsi per due accordi ed una voce calda quanto per un bel film visto in compagnia. Se non esce la sera, è perchè sta leggendo una storia appassionante e magari ride o tiene il fazzoletto a portata di mano. Nel prossimo numero: Franz Kafka 31 www.finzionimagazine.it
Scaricare