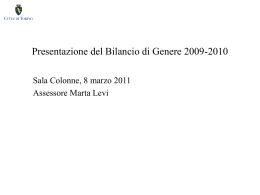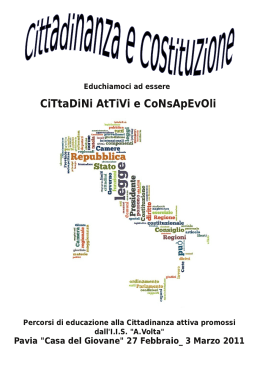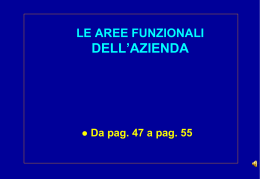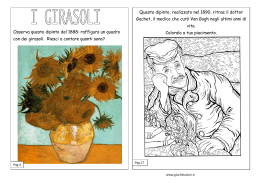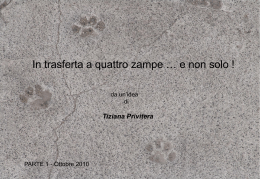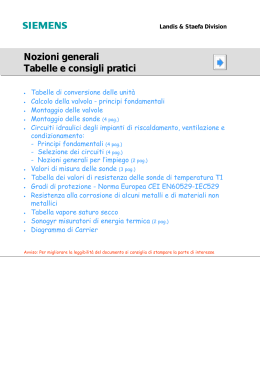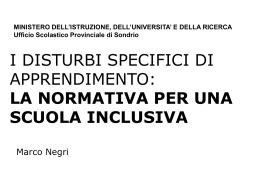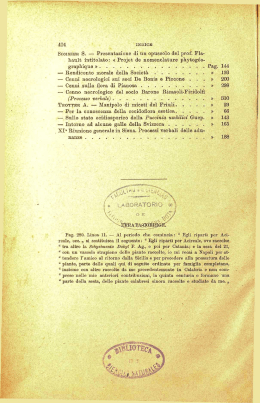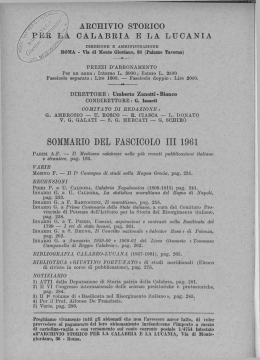ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe III C risulta composta da 23 alunni (18 ragazze e 5 ragazzi) e piuttosto marcata è la presenza di pendolari (ben 11 provenienti da località limitrofe e non: Busso, Vinchiaturo, Cercemaggiore, Gambatesa, Castelvetere). Nel corso del corrente anno scolastico c’è stato l’avvicendamento degli insegnanti di Lingua e Letteratura Latina e di Storia dell’Arte, con i quali il dialogo educativo, dopo la fase di adattamento iniziale, è risultato positivo ed efficace. Il percorso formativo liceale è stato caratterizzato da luci ed ombre. Sebbene i ragazzi provengano tutti dallo stesso corso ginnasiale, non si è creata una forte coesione, probabilmente per la difficoltà di potersi incontrare e frequentare al di fuori della scuola; l’iter didattico è stato caratterizzato da risposte eterogenee all’interazione educativa: collaborativa e più costruttiva per alcuni, recettiva per la maggior parte degli allievi, discontinua in qualche caso. Non mancano certo belle intelligenze e si può comunque affermare che, nel complesso, gli alunni sono gradualmente cresciuti in termini di disponibilità, strategie di apprendimento, impegno, acquisizioni culturali. Apprezzabile, inoltre, è risultata nel corso del triennio la partecipazione degli allievi, individualmente o in gruppo, alle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa extracurricolari (alternanza scuola-lavoro, precorsi universitari, olimpiadi delle neuroscienze, olimpiadi della cultura e del talento, olimpiadi d’italiano dell’ Accademia della Crusca, progetto ARACNE, esperienze di orientamento presso atenei d’eccellenza, Giochi di Archimede, Giochi d’autunno). L'autonomia nell’assimilazione dei contenuti e nella capacità di pensiero riflesso e critico si presenta differenziata a seconda delle materie, delle conoscenze e/o lacune pregresse, della serietà e proficuità nel lavoro, del bagaglio culturale acquisito. Pertanto il profitto risulta diversificato e caratterizzato dalla presenza di qualche ottimo profilo; anche se permangono delle incertezze in merito ad alcune competenze disciplinari , rispetto ai livelli di partenza, si sono registrati progressi e significativo risulta l’impegno profuso nello studio del patrimonio letterario greco e latino a compensazione delle difficoltà incontrate negli scritti. A conclusione del triennio si può affermare che i docenti della classe sono soddisfatti del grado di preparazione generale e di maturazione conseguito dagli studenti. 2 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’,COMPETENZE In linea con le indicazioni del P.O.F., circa il potenziamento del pensiero induttivo, deduttivo e critico degli alunni, al fine sia di fornire loro gli strumenti necessari alla decodificazione ed alla comprensione di ogni tipo di testo, sia di attivare processi di apprendimento funzionali ad una crescita culturale riflessiva e consapevole, i docenti hanno perseguito e raggiunto gli obiettivi indicati nel seguente paragrafo. OBIETTIVI TRASVERSALI 1) CONOSCENZE (sapere): la classe nel complesso: - conosce i nuclei concettuali fondanti delle discipline studiate; - conosce i linguaggi, i fatti ,le teorie, i sistemi concettuali delle varie aree disciplinari; - conosce una lingua straniera 2) ABILITA’ (saper fare): la classe nel complesso: - sa utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline - sa fare uso di comunicazioni adeguate al contesto, agli interlocutori, alle situazioni, attraverso l’ausilio, talora, della lingua straniera - sa osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti 3) COMPETENZE ( essere in grado di):la classe nel complesso: - sa istituire correlazioni interdisciplinari di vario genere - sa operare confronti e collegamenti tra la conoscenza del mondo passato e la valutazione di quello contemporaneo - sa effettuare autonomamente, sulla base di interessi specifici, indagini e ricerche approfondite. 3 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE CONOSCENZE Italiano Latino/greco Storia e Filosofia Inglese Matematica Fisica Scienze Storia dell’arte Ed. fisica Religione - conoscenza della lingua italiana, della sua grammatica e della organizzazione semantica e lessicale; - conoscenza della storia letteraria dell'Ottocento e di parte del Novecento, articolate nei movimenti letterari e negli autori più rappresentativi ; - conoscenza dei testi più significativi della letteratura italiana. - conoscenza delle strutture morfosintattiche delle lingue classiche; - conoscenza dei lineamenti della storia letteraria latina e greca, attraverso un'attenta analisi degli autori e dei testi; - conoscenza delle principali nozioni di prosodia e metrica relative ai testi tradotti; - conoscenza delle principali figure retoriche e stilistiche; - conoscenza di tematiche e problematiche di cultura classica. - conoscenza dei principali aspetti del pensiero degli autori trattati; - conoscenza dei principali eventi storici dell'800 e del 900. - conoscenza dei meccanismi della lingua straniera nelle sue manifestazioni morfosintattiche , semantiche e fonologiche e dei lineamenti della storia letteraria del diciannovesimo e del ventesimo secolo - conoscenza dei poliedri, misura dei solidi geometrici, definizione di angolo e ampiezza, di funzioni goniometriche, formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione degli argomenti, formule geometriche, identità ed equazioni goniometriche, teoremi dei seni e del coseno. - conoscenza della termodinamica e dell’elettromagnetismo. - conoscenza degli ecosistemi terrestri; - conoscenza della Terra e dell’Universo; - conoscenza della dinamica e della struttura della terra. - conoscenza degli artisti e delle principali del XIX secolo; - conoscenza dei movimenti d'avanguardia e delle tendenze dell'arte nel primo '900; - conoscenza della terminologia specifica di base (tecniche, forme, effetti percettivi, etc.). - conoscenza dei principi generali dell'allenamento sportivo; - conoscenza delle norme e delle regole degli sport di squadra e individuali praticati; - conoscenza della funzione del movimento nel mantenimento dell'armonia fisica ed emozionale. - conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico; - conoscenza dei contenuti essenziali del cattolicesimo nelle grandi linee del suo sviluppo storico e delle espressioni più significative della sua vita 4 ABILITA’ Italiano Latino e greco Storia e Filosofia Inglese Matematica Fisica Scienze Storia dell’arte Ed. fisica Religione - utilizzare un lessico proprio del linguaggio letterario; - analizzare e comprendere varie tipologie di testi; - produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici" - intendere, tradurre (talora in maniera elegante e personale) e commentare un testo in lingua originale - analizzare varie tipologie di testi; - usare opportunamente sia la lingua italiana, sia lessici specifici della storia e della filosofia per esprimere in modo chiaro e preciso le proprie idee; - condurre un ragionamento coerente con le premesse e logicamente “serrato”; - sapere operare valutazioni personali su quanto appreso. - utilizzare le strutture cognitive attraverso il confronto con altri sistemi linguistici e nella realizzazione di testi scritti e di un colloquio orale. - definire, enunciare e dimostrare teoremi e proprietà con vari metodi; definire e descrivere graficamente le funzioni goniometriche; risolvere equazioni goniometriche; estensione e volume dei solidi, risoluzione dei triangoli; nelle applicazioni della trigonometria. - 'analizzare fenomeni termici, elettrici e magnetici da un punto di vista macroscopico e microscopico; - rappresentare algebricamente e/o graficamente le leggi che regolano tali fenomeni e formulare le relative giustificazioni. - comprendere la realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita; - identificare le relazioni intercorrenti tra le Scienze della terra e le altre discipline scientifiche; - comprendere la funzionalità ed i limiti dei modelli interpretativi dei fenomeni scientifici. - comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici dell'opera dell'arte.. - coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; - realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – temporali, - organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; - praticare, nei vari luoghi, almeno due discipline individuali e due sport di squadra. - confrontare il cattolicesimo con le altre confessioni cristiane, le religioni non cristiane e i sistemi di significato. 5 COMPETENZE Italiano Latino e greco Filosofia e Storia Inglese - capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana, anche in relazione con quelle classiche e con quelle straniere; - capacità di analisi e contestualizzazione dei testi letterari; - capacità di cogliere, nelle trasformazioni del tempo, i caratteri specifici o comuni dei movimenti letterari nel loro sviluppo sincronico e diacronico. - capacità di cogliere eventuali relazioni con lingue e letterature moderne; - capacità di rielaborare i contenuti acquisiti in modo autonomo e personale; - capacità di interagire costruttivamente e, talora, con contributi personali in ambito di discussione libera o guidata. - acquisizione graduale della capacità di “problematizzare”, cioè di scorgere un problema dove altri vedono qualcosa di ovvio e “naturale”; - capacità di migliorare gradualmente il proprio spirito critico; - capacità di divenire consapevoli che è sempre necessario selezionare e valutare criticamente le testimonianze storiche, nonché i vari apporti della storiografia; - capacità di divenire consapevoli della storicità di tutti i fenomeni riguardanti le società umane. - capacità di comprendere, interpretare e commentare i testi letterari contestualizzandoli opportunamente, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di altre letterature classiche e moderne. Matematica - capacità di possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiare l'organizzazione complessiva, soprattutto sotto l'aspetto concettuale; - capacità di individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche della matematica; - capacità di assimilare il metodo deduttivo e recepire il significato di metodo assiomatico; - capacità di comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; - capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio;: - capacità di elaborare informazioni e di utilizzare consapevolmente metodi di calcolo; Fisica Scienze Storia dell’arte Ed. fisica Religione - capacità di acquisire le strutture concettuali della materia ed il linguaggio scientifico ad essa connesso; - capacità di acquisire l'abitudine a osservare, interpretare descrivere e rappresentare fenomeni fisici; - capacità di comprendere il rilievo storico di alcune importanti scoperte e le potenzialità e i limiti delle scoperte scientifiche; - capacità di analisi a sintesi. - capacità di padroneggiare le moderne teorie scientifiche, anche al fine di decodificare i messaggi dei mass-media; - capacità di padroneggiare il linguaggio scientifico e le modalità di indagine; - capacità di discernere, nell’ambito dell’informazione scientifica, tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche consolidate; - capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nell’impostazione razionale dei problemi di carattere ambientale. - capacità di riconoscere le opere, i movimenti, le correnti, individuandone le coordinate storico-culturali; - capacità di raccordo con altre discipline, rivelando come nell'opera confluiscano aspetti e componenti dei diversi ambiti del sapere (umanistico, scientifico, tecnico). - capacità di trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate; - capacità di socializzare e rispettare le regole di gioco e le regole sociali; - capacità di riconoscere i valori etici del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura, sulla vita individuale e sociale; - capacità di rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa 6 METODI RELATIVI ALL’INTERAZIONE DOCENTISTUDENTI ita Analisi testuale Lezione frontale Lezione interattiva e partecipativa Attività individuale di lavoro domestico Lavori di gruppo Insegnamento individualizzato Lezioni in laboratorio Simulazioni lat gre sto fil ing mat fis scie arte Ed.fis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Didattica per problemi Attività di recupero in itinere * * * * * * * * * * * * * 7 STRUMENTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA ita lat gre sto Fil ing mat fis scie arte edfis Libri di testo Consultazione altri testi Dispense o appunti del docente Cd o cassette audio Giornali - riviste Documenti autentici Dizionari Videocassette Materiali dei lab. Scientifici Attrezzatura sportiva Lavagna multimediale * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA ita lat gre sto fil ing mat fis scie arte edfis Biblioteca Palestracampo polivalente Sala proiezione-tv Laboratorio multimediale Laboratori scientifici * * * * * * * 8 - STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE tipologie di prove Tema tradizionale Analisi testuale Saggio breve Articolo di giornale Sviluppo argomento storico Problemi applicativi ed esercizi Traduzioni Prove strutturate e semistrutturate di varia tipologia Colloqui in itinere Colloqui al termine di unità didattiche ita lat gre sto fil ing mat fis scie arte Ed.fis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Per verificare il grado di apprendimento complessivo ed individuale sono state usate le seguenti tipologie di prove: 1. prove scritte ( per la loro valutazione i docenti si sono serviti di apposite griglie riportate in appendice). 2. prove orali 3. per esercitare gli alunni alla terza prova scritta sono state proposte due prove strutturate riportate in appendice. 9 La valutazione degli alunni si è articolata in: • valutazione formativa, effettuata in itinere con lo scopo di individuare difficoltà eventualmente incontrate dai discenti ed indirizzare la strategia didattica di recupero; • valutazione sommativa, che esprime il giudizio sul livello di profitto globale raggiunto da ogni singolo alunno in ordine a: • • • • • • • • • interesse motivazione miglioramento rispetto alla situazione iniziale metodo di lavoro conoscenza dei contenuti abilità capacità di collegare i contenuti fra loro capacità di analisi e sintesi capacità di rielaborazione personale e critica dei dati culturali acquisiti • capacità di esprimersi con chiarezza e proprietà di linguaggio Questi elementi hanno concorso alla definizione dei voti quadrimestrali secondo la seguente tabella di valutazione, elaborata dagli organi collegiali, che esprime le relazioni fra giudizio ed espressione numerica: • • • • • • • • eccellente (10) ottimo(9) buono(8) discreto(7) sufficiente (6) insufficiente non grave (5) gravemente insufficiente (4-3) del tutto insufficiente (2-1) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO La programmazione annuale prevista dal Consiglio di Classe è stata articolata secondo la scansione quadrimestrale che ha tenuto in considerazione i momenti della comunicazione alla famiglia del grado di apprendimento degli alunni, sia tramite apposite schede infraquadrimestrali , sia mediante colloqui generali pomeridiani che si sono aggiunti agli incontri con i singoli docenti nelle ore antimeridiane. 10 ATTIVITA’DIDATTICHE E COMPLEMENTARI ATTIVITA' Viaggio di istruzione a Bruxelles e Amsterdam Partecipazione alla “Notte Europea dei Ricercatori 2014 “ presso il Parco tecnologico dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli Incontro con i medici dell’AIDO per affrontare il tema “Donazioni Organi”Sportello Conferenza del giornalista Dott. Giuseppe Tabasso sulla vita e gli scritti di Gaetano Scardocchia Partecipazione all’evento “Orienta Giovani” di Montesilvano Anno scolastico 2014/2015 Conferenza del Prof. Lorenzo Canova dell’UNIMOL sulla Mostra “Gioco e gioia della Neometafisica” di G.De Chirico Visita guidata della mostra di De Chirico presso l’ex GIL Incontro Orientamento UNIMOL Incontro con Sua Eccellenza Mons. Bregantini Incontro Orientamento con il Prof. Salvatore Gerbino, docente della Facoltà di Ingegneria della UNIMOL Illustrazione del progetto “C.I.C.”- Incontro Orientamento Scuola Sportello d’Ascolto” Superiore per Mediatori Linguistici del Molise Incontro con una volontaria del Incontro Orientamento NABA C.A.L.T. (Centro Assistenza Lotta (Nuova Accademia Belle Arti di Tumori) sulle tematiche concernenti Milano) un corretto stile nutrizionale. Incontro con il Colonnello dell’Esercito Santomarco (orientamento) Partecipazione allo spettacolo Teatrale “Finzioni” Partecipazione ai “Giochi di Archimede” Partecipazione alla “Giornata delle Eccellenze” Partecipazione alle “Olimpiadi della Cultura e del Talento” Incontro di orientamento"LUISS" Incontro con lo stilista Pierluigi Fucci, ex studente del liceo Cineforum : la “Medea” di Pierpaolo Pasolini a cura del prof. Mario Pucci Partecipazione alle “Olimpiadi di Italiano” (Gara di Istituto) Partecipazione allo spettacolo “Io non so odiare” in occasione della “Giornata della memoria” 11 CONSIGLIO DI CLASSE Religione Don Peppino Cardegna Italiano Vittoria di Zinno Latino De Lisa Antonia Greco Iannaccone Maria Giovanna Storia e filosofia Giuseppe Simonelli Inglese Valeria D’Elisa Matematica e fisica Giuseppe Piacente Scienze Patrizia Paradiso Storia dell’arte Giulia Severino Educazione fisica Carla Sammartino IL PRESIDE (Prof. Antonio Venditti) CAMPOBASSO, lì 12 maggio 2015 12 INDICE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ................................................................ 2 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’,COMPETENZE .................................................................................. 3 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE ...................................... 4 METODI RELATIVI ALL’INTERAZIONE DOCENTI-STUDENTI ............... 7 STRUMENTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA ................................................ 8 SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA ............................................................ 8 STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE ..................... 9 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO ...................................................... 10 ATTIVITA’DIDATTICHE E COMPLEMENTARI ......................................... 11 CONSIGLIO DI CLASSE .................................................................................. 12 APPENDICE: CONTENUTI DISCIPLINARI GRIGLIE DI VALUTAZIONE (ITALIANO/LATINO-GRECO) SIMULAZIONI TERZA PROVA 13 PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE III C ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Libri di testo: Letteratura Italiana:Hermann Grosser : “Il canone letterario” volume 4 “Il primo Ottocento”, volume 5 “Tra Ottocento e Novecento “, volume 6 “Novecento” Dante Alighieri, La Divina Commedia, Il “Paradiso”, a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio. ( E' stato consentito anche l'uso di altre edizioni critiche) LA PRODUZIONE LETTERARIA DELLA FINE DEL SETTECENTO E DEL PRIMO OTTOCENTO a. .Ugo Foscolo Profilo: una vita romantica. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis:genere letterario, trama, stile, motivi tematici (da pag 92 a pag 97) Il carme “Dei Sepolcri”:motivo occasionale della stesura, il significato della tomba,esempio di poesia civile, la vittoria della poesia ( da pag101 a pag 105). “ Notizia intorno a Didimo Chierico”:oltre Jacopo Ortis, una nuova maschera che anticipa la poesia delle “Grazie” (pag 105/106).Le”Grazie”: contenuto dell’opera, capolavoro neoclassico:esaltazione della bellezza come valore capace di educare gli uomini ad essere migliori ( da pag106 a pag 109) ◊ Dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il sacrificio della patria” (pag.113) “Il bacio di Teresa”(pag.123/125), “L’incontro con il Parini”(pag.127), “La terra è una foresta di belve”(pag130) ◊ Dalle “Odi”: “All’amica risanata” (pag.134) ( una riflessione filosofica sul valore della bellezza e un esempio di poesia neoclassica) ◊ Dalle “Poesie”: “Alla sera”, (pag. 138) “A Zacinto” (pag.141), “In morte del fratello Giovanni” (pag. 143) (la novità del sonetto foscoliano., motivi romantici e neoclassici) ◊ Il carme “Dei Sepolcri” vv.1/295 (pag145 e seguenti) ◊ Dalla “Notizia intorno a Didimo Chierico”: “I silenzi di Didimo” (pag.160) ◊ Dalle “Grazie”, “Il velo”, libro III, vv144/203 (pag.167) c. Il Romanticismo. ◊ Il Romanticismo come rivoluzione culturale: rapporto Romanticismo/Illuminismo e Romanticismo/Classicismo, origine del termine, la malinconia romantica, carattere nazionale, popolare, storico della letteratura ( da pag 172 a pag180) ◊ W.A.Schlegel, dal Corso di letteratura drammatica:Poesia cristiana poesia melanconica (pag.190) ◊ La polemica classico-romantica in Italia: posizioni a confronto: ◊ M.me de Stael, dalla “Biblioteca italiana” : “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (pag 194) ◊ Pietro Giordani,” Le ragioni dei classicisti:immutabilità dell’arte e genio italiano” (pag 196) Solo il brano A ◊ G. Berchet, dalla “ Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo”(pag.203): Il nuovo pubblico dei Romantici d. Alessandro Manzoni. Profilo:valore dell’esperienza parigina e della conversione (pag 476). Il concetto del “positivo romantico” (lettera “Sul romanticismo” (fotocopia); la novità degli “Inni sacri”; la poesia civile dell’ode “Marzo 1821”, “Il 5 maggio”: una riflessione storica sul ruolo di Napoleone, ma soprattutto una riflessione morale e religiosa;la poesia tragica: la novità della tragedia manzoniana (da pag a pag ) I “Promessi Sposi”:un romanzo storico, la provvidenza come categoria della coscienza, un romanzo problematico ( da pag 501 a pag 505) ◊ Dagli Inni sacri "La Pentecoste" (pag 519) ◊ Dalle Liriche: “Marzo 1821”,(pag. 510) “Il Cinque maggio” (pag.515) ◊ Primo coro dell’Adelchi: “Dagli atri muscosi…” (pag.544)(esempio di vero storico e vero poetico, il punto di vista di tre popoli) ◊ Secondo coro dell’Adelchi:”Sparsa le trecce morbide” (pag.556) (il motivo della “provvida sventura”) ◊ ◊ “Lettera sul Romanticismo” a Cesare D’Azeglio (fotocopia) Dal “Fermo e Lucia”: “L’uscita di scena di don Rodrigo”,(pag 576) (confronto tra la prima e l’ultima stesura del romanzo) IL MODELLO LIRICO DEL LEOPARDI a. Giacomo Leopardi. Profilo:la cognizione del dolore (pag.246) La fase del pessimismo storico e la poetica del vago e dell’indefinito. I primi idilli: “situazioni, affezioni, avventure storiche” dell’animo del poeta: “L’Infinito”, “Alla luna” La fase intermedia del pessimismo: “Ultimo canto di Saffo” (da pag270 a pag275)L’approdo al pessimismo cosmico: la stagione delle “Operette morali”( da pag 275 a pag279) I “Grandi Idilli”:nonostante la nuova filosofia, la poetica dell’indefinito e del vago vive ancora nel motivo della rimembranza e nei quadretti di vita borghigiana (pag 281/282) L’ultimo Leopardi: una nuova,combattiva consapevolezza di sé e del valore del proprio pensiero e una poetica eroica e aspra come corrispettivo dell’”arido vero” (“A se stesso”, “La Ginestra”) (da pag282 a pag 287) ◊ Dalle “Operette morali”: “Dialogo della natura e di un Islandese”, “Dialogo di un Folletto e di uno gnomo” ,”Dialogo di Tristano e di un amico” , "Dialogo del passeggere e del venditore di almanacchi"(pag 280) ◊ Dagli Idilli: “L’infinito” (pag.300), “Alla luna” (pag 304) ◊ Dalle Canzoni: “Ultimo canto di Saffo” (pag. 306) ◊ Dai Grandi Idilli: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag351), “Il passero solitario (368), “Il sabato del villaggio” (pag. 348), “A Silvia”.(pag 337). ◊ L’ultimo Leopardi: “ A se stesso” pag 377,“La ginestra o il fiore del deserto” ( versi: 1/86; 111/201; 297/317) (pag 382) DAL ROMANZO STORICO AL ROMANZO VERISTA A Tardo-romanticismo e Scapigliatura:due modalità diverse di rapportarsi alla realtà borghese e postrisorgimentale; il giudizio della critica (pag 64/65 fino a “dirompente” e da pag 70 a 72) Naturalismo e verismo:affinità e differenze (da pag 160 a pag165) ◊ E.e J.De Goncourt, da “Germinie Lacerteux”: “Prefazione a Germinie Lacerteux”(pag.161). ◊ Luigi Capuana, “Poetica del verismo” (pag 170) ◊ Cletto Arrighi, Scapigliatura, pandemonio del secolo (pag73) ◊ Emilio Praga, “Preludio” (pag79) b. G. Verga:Il problema della conversione: da “Nedda” a “Vita dei campi”: la poetica dell’impersonalità, il mondo rusticano tra Eden e Inferno (da pag 225 a pag230) “I Malavoglia” ( prefazione,trama,stile, coralità, ideologia ( da pag230 a pag 235)), Novelle Rusticane e “Mastro don Gesualdo”:la ferrea legge economicistica e il fallimento sul piano umano ( da pag 236 a pag239 fino a “diverse”) ◊ Da “Vita dei campi”: “Lettera prefazione all’Amante di Ggramigna”(pag 245) , “Rosso Malpelo” (pag 247) ◊ Da “I Malavoglia”: “Prefazione” (pag 263); “La vaga bramosia dell’ignoto”(brani a e b)(pag 266/269); “Il futuro del mondo arcaico” (solo la parte relativa all’addio di ‘Ntoni) (pag277/279) ◊ Da “Novelle rusticane”: “La libertà”(pag 287); “La roba” ◊ Dal “Mastro-don Gesualdo”La solitudine di Gesualdo”(pag 301) Da “I Malavoglia” :”Prefazione” (pag 263) “Il futuro del mondo arcaico”(pag 275 ) L’ETÀ DEL DECADENTISMO E IL ROMANZO DEL NOVECENTO a. Simbolismo e decadentismo:una nuova visione del mondo misticheggiante ed irrazionalistica trasmessa attraverso un nuovo linguaggio poetico e particolari tipologie umane (da pag366 a pag370) b. Oscard Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, “L’arte al di là del bene e del male” (pag377) c. Baudelaire:“Corrispondenze”(pag 53) , “L’albatro” (pag 52); Rimbau: “Vocali” (pag.348), Verlaine : "Languore" (pag 396) d. Pascoli.Profilo:un vita segnata dal dramma familiare (pag 426), Un innovatore del linguaggio poetico (da pag 429 a pag432) ◊ Dalle “Prose”: “Il fanciullino”( pag.439) ◊ Da “Myricae”: “Lavandare”(pag 442), “L’assiuolo” (pag 446) “Temporale”, “Il Lampo”, “Il tuono” (pag. 450 e 451), “X Agosto”(pag. 435); “Novembre” (pag434) ◊ Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”(pag. 463) “Nebbia” (pag.461), "La mia sera”(pag 465) ◊ Da “Primi poemetti”, “Digitale purpurea” (pag 454) ◊ D’Annunzio :L’ideale dell’estetismo:il personaggio di Andrea Sperelli ( trama del romanzo “Il Piacere”, la figura dell’esteta imperfetto) (pag 481/483 escluso “Il Trionfo della morte” e “Il Poema paradisiaco); Il superamento della figura dell’esteta: il mito del superuomo nel romanzo “Le vergini delle rocce” ( pag 484/486 ) “Le laudi”:culto del passato, fusione con la natura, trasfigurazione mitica della propria esperienza individuale(pag 487/489 (ecluso il documento ed il teatro) ◊ “ Il Piacere”: “ Il ritratto di Andrea Sperelli”, (pag.504) ◊ Da “ Le vergini delle rocce”: “Il compito dei patrizi” (pag 518) ◊ Dalle “Laudi” (Alcyone): "La sera fiesolana" (pag 522); “La pioggia nel pineto” (pag.525) DANTE: PARADISO: CANTI I, III, VI (lettura integrale) Dal 13 maggio al termine dell’anno scolastico si intende trattare gli argomenti di seguito indicati: e.Pirandello e la crisi dell’identità personale ◊ Da “ Il fu Mattia Pascal “:L’ombra di un morto: ecco la mia vita” (pag108) ◊ Da “Uno, nessuno, centomila”: Com’io volevo esser solo e Non conclude (pag 116 e seguenti) ◊ Da “ L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” e L’umorista, un uomo” fuori di chiave” (pag 99) ◊ Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” (pag 120) f.Italo Svevo:La figura dell’inetto attraverso i tre romanzi ( da pag146 a pag154) ◊ Da "La coscienza di Zeno":"Il fumo" (pag 165); "La salute di Augusta" (pag 175); “La vita è inquinata alle radici” (pag185) LA POETICA DELLA PAROLA E LA POETICA DEGLI OGGETTI ◊ Ungaretti e il primo Montale ◊ Da “L’Allegria”: “Mattina”/pag 243) “Veglia” , “Fratelli” , “Soldati” (pag 245). “San Martino del Carso”,,(pag 247);“I fiumi”(pag 252); “Non gridate più” (pag 261) ◊ Da “Ossi di seppia”: “I limoni” (pag 350), Non chiederci la parola”(pag 355), “Spesso il male di vivere” (pag 357); Il motivo della memoria in “Cigola la carrucola del pozzo” (pag 338), “Non recidere, forbice, quel volto” (pag370), “Ho sceso dandoti il braccio” (pag 382) DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO: CANTI XI, XVII, XXXIII (passi scelti) CAMPOBASSO, 12 maggio 2015 L’INSEGNANTE di Zinno Vittoria ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CLASSE III C PROF.SSA ANTONIA DE LISA PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO FINO AL 10 MAGGIO 2015 LIBRO DI TESTO: G. Garbarino – “Nova Opera” (Letteratura, Testi, Cultura Latina – Vol 3) LETTERATURA VALERIO MASSIMO L’ETA’ GIULIO – CLAUDIA L’autore e l’opera Il principato gentilizio CURZIO RUFO 1) Gli ultimi anni del principato di Augusto 2) La dinastia Giulio – Claudia 3) Vita culturale e attività letteraria nell’età Giulio – Claudia L’autore e l’opera SENECA FEDRO e la favola in poesia L’autore, l’opera: i Dialogi, i Trattati, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis, gli epigrammi, lo stile L’autore, i contenuti e le caratteristiche dell’opera Antologia dei testi tradotti dal latino: La prosa nella prima età imperiale VELLEIO PATERCOLO L’autore e l’opera 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, Capitolo 1) Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) Esempi di occupazioni insulse (De brevitate vitae, 12, 1-3) Come devono essere trattati gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) Gli umili compiti degli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47,5-9) I veri schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 10-14) Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium, 7, 1-3) La poesia nell’età di Nerone L’ETA’ DEI FLAVI LUCANO e l’epica antitradizionale Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del principato L’autore, i contenuti e le caratteristiche dell’opera, lo stile 1) L’affermazione della dinastia flavia 2) Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi Letture antologiche in italiano: 1) 2) 3) 4) L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani I ritratti di Pompeo e di Cesare Catone e Marcia Una scena di necromanzia PERSIO e la satira L’autore, i contenuti e le caratteristiche dell’opera, lo stile Letture antologiche in italiano: 1) Un genere contro corrente La poesia nell’età dei Flavi SILIO ITALICO L’autore e l’opera VALERIO FLACCO L’autore e l’opera STAZIO L’autore e l’opera: la Tebaide, l’Achilleide, le Silvae MARZIALE e l’epigramma PETRONIO e il romanzo L’autore, i contenuti e le caratteristiche dell’opera, lo stile L’autore, l’opera: il Liber de spectaculis, gli Xenia e gli Apophoreta, gli Epigrammata, lo stile Letture antologiche in italiano: Letture antologiche in italiano 1) La matrona di Efeso 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Obiettivo primario:piacere al lettore! Libro o libretto La scelta dell’epigramma Matrimoni di interesse Fabulla Betico Il console cliente Senso di solitudine La bellezza di Bilbili Il profumo dei tuoi baci Auguri a un amico La prosa nella seconda metà del I secolo PLINIO IL GIOVANE QUINTILIANO L’autore, l’opera: il Panegirico di Traiano, l’epistolario, lo stile L’autore, i contenuti e le caratteristiche dell’opera, lo stile Letture antologiche in italiano: Antologia dei testi tradotti dal latino: 1) Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 2) La risposta di Traiano 1) Il maestro come “secondo padre” (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) Letture antologiche in italiano: SVETONIO e la biografia L’autore, l’opera: il De viris Illustribus, il De vita Caesarum, lo stile 1) Giudizio su poeti latini TACITO PLINIO IL VECCHIO L’autore, l’opera, lo stile L’autore, l’opera: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae, gli Annales, lo stile Antologia dei testi tradotti dal latino: L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 1) Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30, 1-31, 3) Il principato adottivo e il ritorno della libertà Letture antologiche in italiano 1) Nerva e Traiano 2) L’assolutismo illuminato di Adriano 3) Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e Adriano 1) I villaggi, le case, i rifugi La letteratura nell’età di Traiano e Adriano GIOVENALE e la satira Nel periodo compreso tra il 9 maggio e la fine delle lezioni saranno trattati i seguenti argomenti: Antologia dei testi tradotti dall'italiano Agricola capitolo 31 ''Continuazione del discorso di Calcago''. L’autore, l’opera e le sue caratteristiche, lo stile Letture antologiche in italiano: 1) L’invettiva contro le donne 2) L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli Dal latino: Germania: lettura del capitolo IV ''Caratteri fisici e morali dei Germani''. Historiae: inizio capitolo I paragrafo 1. Annales XV, XXXVIII ''L'incendio di Roma''. CULTURA E LETTERATURA NELL'ETA' DEGLI ANTONINI APULEIO e il romanzo ''Le Metamorfosi''. Letture antologiche in italiano: Metamorfosi ''Funeste conseguenze della magia'' ''Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca'' ''Psiche vede lo sposo misterioso'' ''Il significato delle vicende di Lucio'' LA LETTERATURA CRISTIANA: MINUCIO FELICE e l'apologetica TERTULLIANO: opere apologetiche e antiereticali 10 maggio 2015 L'insegnante Programma di greco Prof.ssa Iannaccone III C 2014/2015 ISOCRATE • • • • T1 T2 T3 T6 - Il manifesto di Isocrate: contro i sofisti Il compito della letteratura morale Autobiografia di un educatore I caratteri dell’antica democrazia PLATONE • T2 - Socrate non teme la morte (in greco) ARISTOTELE • • • • • T1 - La definizione di tragedia T2 - Confronto tra poesia e storia T3 - I tre generi della retorica T4 - Le materie pratiche utili ai giovani T5 - Princìpi di una giusta educazione MENANDRO 1. • • • • • La donna di Samo T1 - L’antefatto T2 - La generosità di Criside T3 - Un brutto sospetto T4 - La verità è svelata T5 - Il lieto fine 2. • • • • La fanciulla tosata T6 - La dea ignoranza racconta l’antefatto T7 - Polemone ubriaco T8 - Il riconoscimento T9 - Il lieto fine CALLIMACO 1. • • • • Aitia T1 - Il prologo dei Telchini T2 - I fondatori delle città siciliane T3 - Un “aition” genealogico: la mela di Aconzio T4 - La Chioma di Berenice 2. • • • • Inni T6 T7 T8 T9 - L’Inno a Zeus: l’inno più antico L’Inno ad Apollo: la polemica letteraria Per i lavacri di Pallade L’Inno a Demetra: il racconto delle vicende di Erisittone TEOCRITO 1. • • • • Gli idilli bucolici T1 - L’invenzione del genere: Licide e Simichida T2 - L’eroe bucolico: il mito di Dafni T3 - La serenata del capraio T4 - Il Ciclope innamorato 2. I mimi • T5 - Le donne alla festa di Adone • T6 - Incantesimi d’amor APOLLONIO RODIO • • • • • • • • • T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 - Il proemio La partenza della nave Argo L’episodio di Ila La battaglia con i Bebrìci La conquista del vello La conclusione del poema Donne in vista L’amore di Medea per Giasone Incontro tra Medea e Giasone L’EPIGRAMMA ELLENISTICO 1. • • • Anite di Tegea T1 - Autoepitafio di un delfino T2 - Epitafio per un gallo T3 - Momento di riposo 2. Nosside di Locri • T4 - Dolcezza d’amore • T5 - Un dono per Afrodite 3. • • • • Leonida di Taranto T6 - Un falegname ‘in pensione’ T7 - I caprai ringraziano Zeus T8 - Epitafio per un pescatore T9 - Epitafio per una tessitrice 4. • • • • • Asclepiade di Samo T10 - Il lume castigatore T11 - Gli Amori giocano a dadi T12 - Il “paraklausithuron” T13 - Il vino consolatore T14 - Affanno d’amore 5. • • • • • • Meleagro T20 - Promesse caduche T21 - Zanzare fastidiose T22 - L’alba T23 - Messaggio d’amore T24 - Costante tormento d’amore T 25 - Eros senza frecce ERODA 1. • • • • I miambi T1 - Il sogno T2 - A scuola T3 - Le donne al tempiodi Asclepio T4 - Dal calzolaio POLIBIO • • • • • • • • • T1 - Premessa e fondamento dell’opera T2 - La critica dei predecessori T3 - Contro Filarco: i limiti della drammatizzazione T4 - Contro Teopompo: la storia non è un encomio T5 - L’esperienza del politico al servizio della storia T6 - Inizio, causa e pretesto di un fatto storico T8 - Scipione piange davanti alle rovine di Cartagine T9 - Il ritorno ciclico delle costituzioni T10 - La costituzione romana ANONIMO DEL SUBLIME • • • • T1 T2 T3 T4 - Vibrazioni dell’anima tra natura e arte Due “grandi” a confronto La giustificazione “naturale” del “classico” Grandezza imperfetta e mediocrità impeccabile PLUTARCO • • • • • • T1 T2 T3 T4 T5 T6 - Ritratto di Demetrio Demetrio e Lamia Ritratto di Antonio La passione di Antonio per Cleopatra La morte di Antonio Le Idi di marzo e la morte di Cesare LUCIANO • • • • • • • T6 - Le pretese della filosofia T7 - I ‘falsi’ filosofi a confronto con i grandi del passato T8 - Menippo e Hermes (in italiano) T9 - Menippo, Eaco e alcuni illustri abitanti dell’Ade (in italiano) T10 - La terra vista dalla luna (in italiano) T11 - Il proemio (in italiano) T13 - La balena (in italiano) LONGO • T2 - La scoperta dell’amore: Dafni e Cloe MEDEA (in greco) • • • • • • • vv. 1-48 da pag. 33 a 35 (in italiano) vv. 214-266 vv. 271 - 291 vv. 446 - 519 vv. 522 - 575 vv. 1063 - 1080 PLATONE 1. Protagora • Parte introduttiva da pag. 30 a 35 • vv. 320c8 - 324d1 (pag. da 42 a 60) • pag. da 64 a 73 (in italiano) LICEO CLASSICO “M. Pagano” – CAMPOBASSO STORIA DELL’ARTE CLASSE III^ - SEZ. C A.S. 2014/2015 Programma L’ARTE DELL’OTTOCENTO IL NEOCLASSICISMO: J.L. David; J.D. Ingres; A. Canova IL ROMANTICISMO: F. Hayez; T. Gèricault; E. Delacroix; C.D. Friedrich; J. Constable; W. Turner LA CITTA’ DELL’OTTOCENTO Sventramenti e ricostruzioni L’architettura degli ingegneri IL REALISMO IN FRANCIA J. F. Millet; G. Courbet; H. Daumier L’IMPRESSIONISMO E. Manet; A. Sisley; C.Monet; P.A.Renoir; E.Degas DOPO L’IMPRESSIONISMO G.P.Seurat; P.Cèzanne; H. de Toulouse Lautrec; P.Gauguin; V. Van Gogh L’ARTE IN GIAPPONE NEL PERIODO EDO: cenni L’ARTE IN ITALIA LA PITTURA DEI MACCHIAIOLI IL DIVISIONISMO SIMBOLISTA IL PRIMO NOVECENTO IL MODERNISMO: Secessione viennese (G. Klimt); V. Horta; A. Gaudì LE AVANGUARDIE STORICHE: Un precursore: E. Munch L’ESPRESSIONISMO; Fauves; Die Brücke; Der Blaue Reiter IL CUBISMO: G. Braque; P. Picasso IL FUTURISMO L’ASTRATTISMO IL DADAISMO IL SURREALISMO LA METAFISICA Testo: Carlo BERTELLI - Storia dell’Arte La storia dell’arte dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, vol 3a, Pearson - edizione verde LICEO CLASSICO “M. PAGANO” CAMPOBASSO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PROGRAMMA DI MATEMATICA 1. LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE -Che cosa sono le funzioni -Classificazione delle funzioni -Il dominio di una funzione -Gli zeri di una funzione -Funzioni crescenti e decrescenti -Le funzioni periodiche -Funzioni pari e dispari -La funzione inversa 2. I LIMITI -Gli intervalli e gli intorni -Limite finito per x che tende a un valore finito -Limite infinito per x che tende a un valore finito -Limite finito per x che tende a un valore infinito -Limite infinito per x che tende a un valore infinito 3. IL CALCOLO DEI LIMITI -Le operazioni sui limiti -La forma indeterminata +∞ -∞ -La forma indeterminata ∞/∞ -La definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo -Asintoti orizzontali e verticali -Asintoti obliqui e loro ricerca 4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE -Il problema della tangente -Il rapporto incrementale -La derivata di una funzione -Il calcolo della derivata -La derivata sinistra e destra -La retta tangente al grafico di una funzione -I punti stazionari -Punti di non derivabilità -La continuità e la derivabilità -Le derivate fondamentali -I teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim) -Le derivate di ordine superiore al primo -Teorema di Rolle (senza dim) -Teorema di Lagrange (senza dim) -Teorema di De L’Hospital (senza dim) 5. LO STUDIO DELLE FUNZIONI -Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate -I massimi, i minimi e i flessi -Massimi, minimi e flessi orizzontali e derivata prima -Flessi e derivata seconda -Lo studio del grafico di una funzione polinomiale -Lo studio del grafico di una funzione razionale fratta CLASSE III C LICEO CLASSICO “M. PAGANO” CAMPOBASSO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PROGRAMMA DI FISICA CLASSE III C ELETTROMAGNETISMO Le cariche elettriche • L’elettrizzazione per strofinio • I conduttori e gli isolanti • La carica elettrica • La legge di Coulomb • L’elettrizzazione per induzione Il campo elettrico e il potenziale • Il vettore campo elettrico • Il campo elettrico di una carica puntiforme • Le linee del campo elettrico • Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss • L’energia potenziale elettrica • La differenza di potenziale • Il condensatore piano La corrente elettrica continua • L’intensità della corrente elettrica • I generatori di tensione • I circuiti elettrici • Le leggi di Ohm • Resistori in serie • Resistori in parallelo Il campo magnetico • La forza magnetica • Le linee del campo magnetico • Forze tra magneti e correnti • Forze tra correnti • L’intensità del campo magnetico • La forza magnetica su una corrente e su una carica in moto • Il campo magnetico di un filo e in un solenoide • Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss L’induzione elettromagnetica • La corrente indotta • La legge di Faraday-Neumann • Il verso della corrente indotta PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI ANNO SCOLASTICO 2014\2015-05-15 Classe 3^ Sez C Insegnante: Prof.ssa Patrizia Paradiso a) Chimica organica: idrocarburi, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e derivati, ammine, isomeria e chiralità, polimeri. Nomenclatura dei principali composti. b) le biomolecole: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; lipidi, colesterolo; vitamine e derivati lipidici. Le proteine: amminoacidi, rapporti struttura-funzioni nelle proteine; emoglobina; gli enzimi; gli acidi nucleici. c)il metabolismo: le trasformazioni chimiche all'interno della cellula;il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi, degli amminoacidi; il metabolismo terminale; la produzione di energia nelle cellule. La regolazione delle attività metaboliche: ilcontrollo della glicemia. d) le biotecnologie, con particolare riferimento alle biotecnologie mediche: la terapia genica, oncogeni e oncosoppressori, nuovi tipi di vaccini. e) elementi di tettonica globale: tettonica delle placche, terremoti, vulcani, orogenesi. Cenni di dinamica esogena. Patrizia Paradiso LICEO CLASSICO “M. PAGANO” - CAMPOBASSO PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE CLASSE III C DOCENTE: prof.ssa D'Elisa Valeria A. S. 2014/2015 Programma effettivamente svolto alla data del consiglio per la stesura del documento del 15 maggio. The Victorian Age: historical and social background; The main features of literature in the Victorian Age; The Victorian novel: main features. Fiction texts from the Victorian Age: C. Dickens: life and works. From Oliver Twist: “Oliver wants some more”; “ the enemies of the system” From Hard Times: “ Nothing but facts”. E. Brontë: life and works. From Wuthering Heights: ; “Catherine’s ghost”; “Catherine’s resolution”. C. Brontë: life and works. From J. Eyre: “I care for myself”. R. L.Stevenson: life and works. From The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde: “Jekyll's experiment” W. Whitman: life and works. From Leaves of Grass: “I hear America singing”, “ Oh Captain, My Captain”. English Aestheticism: main features. O. Wilde: life and works. From The Picture of Dorian Gray: “Preface”; “Dorian's Death”. The Modern Age: historical and social background; the main features of literature in the Modern Age; the stream of consciousness and the interior monologue technique; Fiction texts from the Modern Age: T.S. Eliot: life and works. The Waste Land: structure and themes; lines from “What the Thunder Said”/”Meriggiare pallido e assorto” J. Joyce: life and works. From Dubliners: structure and themes; “Eveline”. V. Woolf: life and works. From Mrs. Dalloway: “Clarissa and Septimus”;“Clarissa's party”. Argomenti da trattare: G. Orwell: life and works. From Animal Farm:”Old Major's speech”. From 1984: “How Can You Control Memory?” PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Classe 3^ (Liceo) sez. C Insegnante Prof.ssa Carla Sammartino OBIETTIVI GENERALI 1. Potenziamento fisiologico: forza, resistenza e velocità; 2. Consolidamento delle capacità coordinative; 3. Formazione della socialità e del senso civico tendente ad una cultura delle attività motorie che oltre a favorire una conoscenza specifica ha stimolato il processo di socializzazione e cooperazione; 4. Educazione alla salute 5. Conoscenza e pratica delle Attività Motorie. La metodologia applicata si è riferita ai metodi induttivi e deduttivi attraverso lavori di gruppo ed individuali. Le lezioni si sono svolte in ambiente naturale ed in palestra. Gli obiettivi sopra menzionati sono stati raggiunti con adeguate conoscenze, competenze e capacità. PROGRAMMA ANALITICO • • • • • Esercizi di tonificazione dei vari distretti muscolari; Esercizi tendenti alla sinergia tra abilità e struttura muscolare; Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi; Giochi Sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Calcio a cinque; Tennis-Tavolo, (Fondamentali, Schemi e partite); Elementi di Atletica Leggera come acquisizione di base della polivalenza motoria sportiva. Carla Sammarrtino Liceo Classico “Mario Pagano”, Via Scardocchia - CB PROGRAMMA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) Anno scolastico 2014-2015 Classe del Triennio: 3 C Orientamenti generali L’insegnamento della religione cattolica (IRC) si svolge in continuità e in collaborazione con l’azione educativa della famiglia, delle altre istituzioni e delle agenzie che interagiscono con la scuola; tale insegnamento offre il suo specifico contributo affinché l’istituzione scolastica realizzi appieno il suo processo educativo unitamente agli altri insegnanti per il raggiungimento dei successi formativi. L’attenzione per ciascun alunno è orientata allo sviluppo delle potenzialità individuali e alla promozione dell’identità e dell’autonomia personale. Natura e finalità L’IRC si inserisce nel quadro della finalità della scuola e contribuisce alla formazione integrale degli alunni con particolare attenzione alla loro dimensione religiosa, attraverso contenuti di valenza storica e culturale. La cultura religiosa è parte integrante di un curricolo attento alle esigenze fondamentali della persona, al suo sviluppo socio-affettivo, psicologico e spirituale. Obiettivi • • • • • • • Conoscere le linee ecclesiali del Vaticano II nel dialogo con il mondo, nel dialogo ecumenico ed interreligioso. Conoscere la Chiesa e i tratti delle principali confessioni cristiane. Conoscere le risposte che l’uomo, nelle diverse culture e religioni, ha elaborato dinanzi al mistero della morte e dell’aldilà. Conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà umana. Sapersi muovere nell’orizzonte dell’etica attraverso una personale rielaborazione dei contenuti. Conoscere le forme d’impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia, della solidarietà, dei diritti umani e sapersi confrontare con il Magistero sociale della Chiesa. Ricercare e rielaborare personalmente i significati dell’esistenza nell’incontro con l’esperienza religiosa e comprendere le tematiche bioetiche. Aree tematiche I AREA. La Chiesa: comunità in dialogo. Il Concilio Vaticano II: Koinonìa, Diakonìa, testimonianza. I fratelli cristiani ortodossi e protestanti. Le iniziative a favore dell’ecumenismo. I testimoni: La Comunità di S. Egidio. La Chiesa dei giovani: don Bosco. Papa Francesco e l’Enciclica Lumen Fidei. II AREA. Le domande dell’uomo. La morte e la vita nell’aldilà. La medicina e il pensiero umano di fronte alla morte. Morte, immortalità, autotrascendenza. La resurrezione dei morti e la reincarnazione. I testimoni: David Maria Turoldo. La storia di Giuseppe in Egitto. 1 III AREA. La coscienza, la legge, la libertà. Lo sviluppo della coscienza morale. I valori. La libertà: sogno o realtà? La libertà della creatura. La libertà di aderire al bene: Decalogo e Beatitudini. I testimoni: Dietrich Bonheffer. Laboratorio: Il male. IV AREA: Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità. Pace, giustizia, carità, solidarietà, mondialità. Il fondamentalismo islamico (attualità). L’economia solidale. Vincere il razzismo. Le relazioni, innamoramento e amore. Dieci tesi per una scuola di pace. I testimoni: I testimoni di pace. Laboratorio: I Nobel per la pace. V AREA: L’etica della vita. La vita e il concepimento. La vita prenatale. L’antropologìa cristiana. La clonazione e l’eutanasìa. La pena di morte. I testimoni: Cristina Cordero Caudas e Laura Tangorra. Laboratorio. Il rispetto della vita umana. Strumenti di lavoro Libri di testo (Nuovi Confronti 2, Ed. Elledici-Eurelle), Bibbia, Documenti del Concilio Vaticano II, articoli di giornale, VHS e DVD, test, social network, schede interattive. Metodologia Costruzione di percorsi didattici coerenti con le finalità, con gli obiettivi e con le aree tematiche; attraverso lezioni, lavori di gruppo, discussioni guidate, riflessioni personali e confronti. L’intenzione è quella di rendere le lezioni di religione sempre più attive, coinvolgenti partecipate al fine di suscitare negli studenti quella motivazione e attenzione necessarie a innescare la molla della domanda e quindi la ricerca di una possibile risposta. Le proposte didattiche scaturiscono dalle esigenze, dalle esperienze, dal mondo interiore e da ciò che circonda l’alunno reso protagonista dell’azione educativa. Valutazione Per formulare il giudizio di valutazione per ciascun alunno si terrà conto: • Dell’impegno e dell’interesse con cui gli allievi partecipano alle lezioni • Dei comportamenti tenuti dagli alunni nei confronti dei compagni e dell’insegnante • Delle conoscenze dei contenuti della religione nell’ottica storico-culturale, della comprensione e dell’uso del linguaggio specifico, dell’apprezzamento dei valori religiosi, dell’accostamento corretto alle fonti bibliche e ai diversi documenti. Campobasso: 9 maggio 2015 Il Docente: don Peppino Cardegna 2 ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO TABELLA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE Alunno________________________ Conoscenza dei contenuti e pertinenza alla traccia (p.2,5) Competenza nell’analisi dei livelli e nel commento del testo(p.2,5) Capacità di approfondime nti personali e critici (p.1) Sviluppa i contenuti ed aderisce alla traccia in modo <> Esauriente e approfondito (2,5) Analizza i livelli del testo ed interpreta Dà apporti personali <> In modo assai preciso, articolato e coerente (2,5) <> Originali e brillanti (1) <> Esauriente <> In modo (2,3) preciso, articolato e coerente (2,3) <> Corretto <> In modo (2,1) preciso e coerente (2,1) <> Nel <> In modo complesso preciso (1,9) corretto (1,9) <> Essenziale <> In modo (1,7) schematico, con sufficiente precisione (1,7) <> Limitato <> Con alcune (1,5) imprecisioni (1,5) <> Validi e significativi (0,9) <> Molto impreciso e/o molto limitato (1,2-0,9) <> In modo scorretto e fuori tema (0,6-0,3) <> Non pertinenti (0,40,3) <> In modo inadeguato ed inesatto (1,20,9) <> In modo gravemente inadeguato ed inesatto (0,60,3) <> Assai significativi (0,8) <> Significativi (0,7) <> Abbastanza significativi (0,6) <> Poco significativi (0,5) <> Non presenti (0,20,1) Correttezza, proprietà, efficacia linguistica ed espressiva (p.4) Si esprime Valutazione Voto in 10mi Punteggio in 15mi <> In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace (4) <> In modo perfettamente appropriato e corretto (3,5) <> In modo appropriato e corretto (3) <> In modo corretto (2,5) <> Eccellente 10 15 <> Ottimo 9 14 <> Buono 8 13 <> Discreto 7 12-11 <> Con qualche inesattezza e/o genericità (2) <> In modo elementare e/o con alcuni errori (1,5) <> In modo trascurato e con molti errori (1,2-0,9) <> In modo molto improprio e scorretto (0,60,3) <> Sufficiente 6 10 <> Insufficiente non grave 5 9-8 <> Gravemente insufficiente 4-3 7-5 <> Del tutto insufficiente 2-1 4-1 <> fuori tema/plagio N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai successivi parametri di verifica e valutazione e comportano l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. PUNTEGGIO: da da da da 1 a 2,5 a 4,5 a 5,5 a 2,4 = del tutto insufficiente 4,4 = gravemente insufficiente 5,4 = insufficiente non grave 6,4 = sufficiente da 6,5 da 7,5 da 8,5 da 9,5 a a a a 7,4 = discreto 8,4 = buono 9,4 = ottimo 10 = eccellente SAGGIO BREVE - TABELLA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE Alunno________________________ Conoscenza dei contenuti e pertinenza alla traccia (p.2) Competenza nello sviluppo dell’argomentazione (p.2) Sviluppa i contenuti ed aderisce alla traccia in modo <> Esauriente e approfondito (2) Sviluppa la tesi Dà apporti personali interpretativa ed argomenta in modo <> Ricco, bene articolato, <> Originali e brillanti coerente e coeso (2) (2) <> Esauriente (1,8) <> Articolato, coerente e coeso (1,8) <> Coerente e coeso 1,6) <> Corretto (1,6) <> Nel complesso corretto (1,4) <> Essenziale (1,2) <> Ordinato e chiaro (1,4) <> Non sempre ordinato, ma complessivamente adeguato (1,2) <> Limitato e/o <> Talvolta confuso e poco ripetitivo (1) ordinato (1) <> Molto impreciso e/o <> Confuso, spesso molto limitato (0,8 incoerente (0.8 – 0,6) 0,6) <> In modo scorretto <> Molto disordinato ed (0,4 – 0,2 ) inconsistente (0,4 – 0,2) Capacità di approfondimenti personali e critici (p.2) Correttezza, proprietà, efficacia linguistica ed espressiva (p.4) <> Eccellente 10 15 <> Ottimo 9 14 <> Buono 8 13 <> Discreto 7 12-11 6 10 <> Con qualche inesattezza <> Sufficiente e/o genericità (2,4) <> Poco significativi (1) <> In modo elementare e/o con alcuni errori (2) <> Non pertinenti (0,8 – <> In modo trascurato e con 0,6) molti errori (1,6 – 1,2) <> Non presenti (0,4 – 0,2) Voto in 10 Punteggio in 15 Si esprime <> In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace (4) <> Validi e significativi <> In modo perfettamente (1,8) appropriato e corretto (3,6) <> Assai significativi <> In modo appropriato e (1,6) corretto (3,2) <> Significativi (1,4) <> In modo corretto (2,8) <> Abbastanza significativi (1,2) Valutazione <> Insufficiente 5 non grave <> Gravemente 4 - 3 insufficiente <> In modo molto <> Del tutto improprio e scorretto (0,8 – insufficiente 0,4) 2-1 9-8 7-5 4-1 <> fuori tema/plagio N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai successivi parametri di verifica e valutazione e comportano l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. PUNTEGGIO: da 1 a 2,4 = del tutto insufficiente da 6,5 a 7,4 = discreto da 2,5 a 4,4 = gravemente insufficiente da 7,5 a 8,4 = buono da 4,5 a 5,4 = insufficiente non grave da 8,5 a 9,4 = ottimo da 5,5 a 6,4 = sufficiente da 9,5 a 10 = eccellente ARTICOLO DI GIORNALE - TABELLA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE Alunno________________________ Competenza di regole e tecniche giornalistiche (p.2) Segue regole e tecniche in modo <> Pieno, efficace e sicuro (2) <> Pieno e sicuro (1,8) <> Pieno (1,6) Conoscenza degli argomenti dell’articolo (p.3) Sviluppa i contenuti in modo <> Esauriente e approfondito (3) <> Esauriente (2,7) <> Corretto (2,4) <> Nel complesso corretto (2,1) <> Essenziale (1,8) <> Adeguato (1,4) <> Nel complesso efficace (1,6) <> Preciso(1,4) Correttezza espressiva (p.3) Valutazione Voto Punteggio in in 15mi 10mi <> Eccellente 10 15 <> Ottimo 9 14 <> Buono 8 13 <> Discreto 7 12-11 Si esprime <> In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace <> In modo perfettamente appropriato e corretto (2,7) <> In modo appropriato e corretto (2,4) <> In modo corretto (2,1) <> Con qualche inesattezza e/o <> Sufficiente 6 10 genericità (1,8) <> Limitato e/o impreciso <> Schematico (1) <> In modo elementare e/o con <> Insufficiente 5 9-8 (1,5) alcuni errori (1,5) non grave <> Molto imprecisa e/o <> Inadeguato (0.8 – <> A volte <> In modo trascurato e con molti <> Gravemente 4 - 3 7-5 molto limitato (1,2 – 0,9) 0,6) incongruente (0,8 –0,6) errori (1,2 – 0,9) insufficiente <> In modo scorretto (0,6 – <> Del tutto <> Inconsistente (0,4 – <> In modo molto improprio e <> Del tutto 2 - 1 4-1 0,3) inadeguato (0,4 – 0,2) 0,2) scorretto (0,6 –0,3) insufficiente <> fuori tema/plagio N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai successivi parametri di verifica e valutazione e comportano l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. PUNTEGGIO: da 1 a da 2,5 a da 4,5 a da 5,5 a <> Sostanzialmente adeguato (1,2) <> Parziale (1) Capacità nella scrittura giornalistica (p.2) Elabora il discorso giornalistico in modo <> Brillante ed efficace (2) <> Efficace (1,8) <> Accettabile (1,2) 2,4 = del tutto insufficiente 4,4 = gravemente insufficiente 5,4 = insufficiente non grave 6,4 = sufficiente da 6,5 da 7,5 da 8,5 da 9,5 a a a a 7,4 = discreto 8,4 = buono 9,4 = ottimo 10 = eccellente TEMA - TABELLA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE Alunno________________________ Conoscenza dei contenuti e pertinenza alla traccia (p.2) Sviluppa i contenuti ed aderisce alla traccia in modo <> Esauriente e approfondito (2) <> Esauriente (1,8) <> Corretto (1,6) <> Nel complesso corretto (1,4) <> Essenziale (1,2) Competenza nello sviluppo dell’argomentazione (p.2) Organizza il discorso in modo <> Ricco, bene articolato, coerente e coeso (2) <> Articolato, coerente e coeso (1,8) <> Coerente e coeso 1,6) <> Ordinato e chiaro (1,4) <> Non sempre ordinato, ma complessivamente adeguato (1,2) <> Limitato e/o <> Talvolta confuso e poco ripetitivo (1) ordinato (1) <> Molto impreciso <> Confuso, spesso incoerente e/o molto limitato (0.8 – 0,6) (0,8 – 0,6) <> In modo <> Molto disordinato ed scorretto (0,4 – 0,2) inconsistente (0,4 – 0,2) <> fuori tema/plagio Correttezza, proprietà, efficacia Capacità di approfondimenti linguistica ed espressiva (p.4) personali e critici (p.2) Dà apporti Si esprime personali Valutazione Voto Punteggio in 15mi in 10mi <> Originali e brillanti (2) <> Validi e significativi (1,8) <> Assai significativi (1,6) <> Significativi (1,4) <> Abbastanza significativi (1,2) <> In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace (4) <> In modo perfettamente appropriato e corretto (3,6) <> In modo appropriato e corretto (3,2) <> In modo corretto (2,8) <> Eccellente 10 15 <> Ottimo 9 14 <> Buono 8 13 <> Discreto 7 12-11 <> Con qualche inesattezza e/o genericità (2,4) <> Sufficiente 6 10 <> Poco significativi (1) <> Non pertinenti (0,8 – 0,6) <> In modo elementare e/o con alcuni errori (2) <> In modo trascurato e con molti errori (1,6 – 1,2) <> Insufficiente non grave <> Gravemente insufficiente 5 9-8 <> Non presenti (0,4 – 0,2) <> In modo molto improprio e scorretto (0,8 – 0,4) <> Del tutto insufficiente 2 - 1 4-1 4 - 3 7-5 N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai successivi parametri di verifica e valutazione e comportano l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. PUNTEGGIO: da 1 a da 2,5 a da 4,5 a da 5,5 a 2,4 = del tutto insufficiente 4,4 = gravemente insufficiente 5,4 = insufficiente non grave 6,4 = sufficiente da 6,5 da 7,5 da 8,5 da 9,5 a a a a 7,4 = discreto 8,4 = buono 9,4 = ottimo 10 = eccellente GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERSIONE DI LATINO /GRECO Conoscenze morfosintattiche (p.3) o Totali (3) o Quasi totali (2,7) Competenze lessicali ed espressive (p.3) o Appropriate ed efficaci (3) o Appropriate (2,7) Capacità di comprensioneinterpretazione del testo (p.4) o Complete e sicure (4) o Complete (3,6) o Con qualche errore circoscritto (2,4) o Compless. soddisfacenti (con pochi errori) (2,1) o Parzialmente accettabili (con errori) (1,8) o Limitate (1,5) o Generalmente corrette (2,1) o Parzialmente imprecise (1,8) o Imprecise (1,5) o Solo parziali (2) o Carenti (1,2-0,9) o Inadeguate (1,2-0,9) o Inadeguate (1,6-1,2) o Gravemente carenti (0,60,3) o Non rilevabili (0,6-0,3) o Non rilevabili (0,8-0,4) 1 - 1,2 = 1 1,3-1,7 = 1,5 1,8-2,2 = 2 2,3-2,7 = 2,5 o Valide (2,4) TRIENNIO 2,8-3,2 = 3 Del tutto insuff. Grav. ins. 3,3-3,7 = 3,5 3,8-4,2 = 4 4,3-4,7 = 4,5 4,8-5,2 = 5 Grav. ins. Non grav insuff. 5,3-5,7 = 5,5 5,8-6,2 = 6 6,3-6,7 = 6,5 o Quasi complete (termini isolati non compresi) (3,2) o Globalmente soddisfacenti (2,8) o Parzialmente accettabili (2,4) Non grav insuff. Quasi suff. 6,8-7,2 = 7 Discreto 8,8-9,2=9 7,3-7,7=7,5 9,3-9,7=9,5 Sufficiente Più che sufficiente 7,8-8,2 = 8 8,3-8, =8,5 Più che discreto Buono Più che buono Ottimo Eccell. 9,8-10=10 VOTO
Scarica