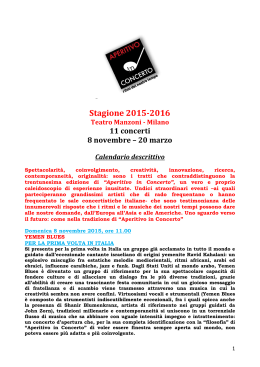Domenica l’attualità Non ci resta che la cassaforte La di DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 SILVANA MAZZOCCHI S MILANO i paragona a un condannato a morte «che viene ammazzato dopo vent’anni». E lo fa per spiegare quanto sia cambiato in un quarto di secolo. Insiste che, proprio come quel deadman walkingdestinato a lasciarci la pelle, è anche lui «ormai un altro uomo. Non innocente sia chiaro, ma certo tutta un’altra persona». Lui è Patrizio Peci, cinquantacinque anni, l’ex terrorista che con le sue ammissioni fece arrestare nel 1980 oltre settanta brigatisti e favorì lo smantellamento di decine di covi. Il primo pentito di quegli anni bui, colui che causò il terremoto delle dissociazioni e dette il via alla legge che le tutelò. Il collaboratore di giustizia che contribuì più di ogni altro a disintegrare la stella a cinque punte. Un ex brigatista, corresponsabile di sette omicidi, condannato grazie alla normativa che lui stesso provocò a soli sette anni dei quali quattro scontati in carcere. Ma anche l’unico che in quel tempo di piombo «abbia abitato entrambi i gironi dei dannati: sia fra le vittime che fra i carnefici» per aver dovuto piangere la morte del fratello, Roberto, catturato e ucciso dalle Brigate rosse per vendetta trasversale a venticinque anni e mentre sua moglie era incinta. «E se anche di questo non voglio parlare, di- la memoria Repubblica Vita pentito da PIERO COLAPRICO e PINO CORRIAS Il soldato Monelli alla Grande guerra MICHELE SMARGIASSI Esce con nuovi capitoli il libro “Io l’infame” di Patrizio Peci L’ex br ha raccontato a “Repubblica” la sua seconda esistenza clandestina co che quei brigatisti li odio ancora per quello che hanno fatto. E io non li perdono». Da allora Patrizio Peci vive una seconda vita. In silenzio e senza identità. Più precisamente con un’altra identità, rimasta sconosciuta. Ma con la stessa faccia. Lui, la plastica per cambiarsi i connotati non l’ha mai voluta fare. Ha un lavoro «equivalente a quello di un operaio», non ha scorta né stipendio da protetto, «mai avuti questi privilegi», e un fisico che, dicono, se si escludono i chili in più, non è poi così cambiato, compresi i baffi appena ingrigiti dall’età. «La plastica non sarebbe servita. Uno come me, con un’esperienza da clandestino nelle bierre, sa che per sparire il miglior nascondiglio è vivere tra la gente». Patrizio Peci non si presenta all’incontro organizzato da settimane. Un dolore alla schiena gli impedisce di muoversi. «Il male è grande, ma non muoio, sono sopravvissuto a tante situazioni...». Dice che, pur avendo sperato fino all’ultimo momento di poter viaggiare (da dove, resta un comprensibile mistero), non può arrivare nella sede della casa editrice che pubblica la nuova edizione di Io l’infame, il libro scritto anni fa con Giordano Bruno Guerri e che, arricchito di qualche decina di pagine inedite, torna in libreria lunedì 21 ottobre per Sperling e Kupfer nella collana diretta da Luca Telese. L’appuntamento diventa telefonico e Peci stavolta è puntuale. (segue nelle pagine successive) con un brano inedito di PATRIZIO PECI cultura Twilight, ecco il vampiro gentiluomo LOREDANA LIPPERINI e STEPHENIE MEYER spettacoli Grafica & jazz, metti l’arte in copertina GINO CASTALDO i sapori Assaggiare il mondo a Terra Madre LICIA GRANELLO e CARLO PETRINI Repubblica Nazionale 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 la copertina Vita da pentito Si definisce “non innocente, sia chiaro”, ma un’altra persona. Diversa da quella che uccise da brigatista e da quella che pentendosi diede il via allo smantellamento delle Brigate rosse. Da allora ha moglie e un figlio e lavora in una località segreta Lo racconta a “Repubblica” e in un suo nuovo scritto SILVANA MAZZOCCHI (segue dalla copertina) «O rmai sono un’altra persona, che vive e fa cose diverse, che ha una famiglia, un figlio. È stata una scommessa, una delle tante. La mia contro le bierre. Nessuno avrebbe creduto che mi sarei salvato. All’inizio è stata dura, molto dura. All’epoca le Brigate rosse erano ancora forti e il rischio che mi trovassero era concreto; solo col tempo mi sono convinto che ce l’avrei fatta». Peci e la sua seconda vita. La moglie l’ha conosciuta in carcere, per corrispondenza. «Mi sono sposato poco dopo essere uscito di galera, è stata una scelta. Rientrare nella legalità, avere un’altra vita. Il matrimonio, un figlio, il lavoro, la normalità… era quello che cercavo. Mia moglie ha sempre saputo chi io fossi, e ho sempre condiviso con tutti i miei parenti quello che stavo diventando, quello che ho fatto». E non si sente senza macchia. «Sono quello che sono. Ma chi mi ha accettato ha riconosciuto la mia buona fede, sempre, dalla lotta armata alla dissociazione. Tutte scelte trasparenti, compiute senza condizionamenti». È il suo modo per respingere ancora una volta «le balle» circolate intorno al suo doppio arresto e al suo ruolo di infiltrato, «balle» appiccicate dalle Brigate rosse addosso a suo fratello in quei giorni di strazio. si ammorbidisce solo per descrivere le sue reazioni. «Dolore, sofferenza. Mio fratello era anche un amico, la persona sulla quale avrei potuto fare affidamento, appena uscito dal carcere. Con lui avrei potuto risolvere tante cose, consigliarmi. Invece in me è scattato un tale odio per i responsabili… Un odio che è rimasto uguale da allora e che mi porto sempre dentro, anche se non guardo i giornali che ne parlano, anche se, quando mi capita di incrociare una qualche trasmissione tv, subito spengo». Sospira, cambia voce e torna a parlare di sé. «Se ho accettato di scrivere una parte nuova del mio libro è stato solo per dimostrare che si può cambiare veramente vita e diventare un altro. Che si possono avere degli affetti e perfino qualche bene materiale. Volevo dimostrare che è possibile farcela». Peci, lei non è senza identità, ne ha una doppia. «È vero, ho avuto nuovi amici che non sanno e non hanno mai saputo chi io fossi. E vecchi amici, pochissimi, che sanno e che vedo raramente perché tutto è cambiato e tutto cambia. È passato talmente tanto tempo e, se io sono un’altra persona, anche loro sono diversi, non ci sono più le affinità di una volta». Un’esistenza sdoppiata: da una parte una moglie, un figlio, qualche vecchio amico, e due carabinieri, uno soprattutto, Creso, con cui suo figlio è cresciuto. «Li ho conosciuti e ci siamo trovati bene. Un rapporto di verità». Dall’altra la finzione: gli amici nuovi, i rapporti di lavoro, i conoscenti. Come fa a insistere che tutto questo è normale? Si risente: «Non capisce? Io sono stato abituato a vivere la clandestinità. L’ho fatto “Io sono Patrizio Peci carnefice e vittima” Lei aveva provocato tanti arresti, poteva immaginare una vendetta di quel genere? «No di certo, non era in preventivo, ovviamente. Ero tranquillissimo per tutta la mia famiglia, Roberto non era responsabile di nulla… fu un fulmine a ciel sereno. Mi aspettavo che l’avrebbero fatta pagare a me. Ma io sarei stato in grado di difendermi». Sul come lui si sia difeso e nascosto per decenni, minimizza. «Sono stato, semplicemente, tra la gente. Avevo la mia vita, gli amici, la maggior parte dei quali ignorava la mia vera identità. Negli anni ho cambiato lavoro un paio di volte, e anche città. Ma non per sfuggire a qualcosa, solo perché avevo trovato un posto migliore, più remunerativo. I primi tempi sono stati difficili, adesso lavoriamo in due e va molto meglio». La famiglia e quella parola ricorrente, «normalità», che Peci usa perfino da lente per guardare il figlio. «Ha ventiquattro anni e adesso vive praticamente da solo. Non gli avevamo detto nulla su di me, l’ha scoperto da ragazzino quando vide una mia foto su un giornale. Alla fine ammisi di essere io quello e, insieme a mia moglie, piano piano gli abbiamo raccontato tutto. Non gli ho mai chiesto di mantenere il segreto sulla mia vera identità, ma lui lo ha fatto automaticamente e se ne è assunto la responsabilità. Ha capito la buona fede del padre». Patrizio Peci e la paura. Non ne ha avuta mai? «Una volta è capitato. A Milano. Ero con mia moglie per strada e ho temuto un agguato. Un’altra volta, ricevetti una segnalazione secondo la quale le Br mi avevano scovato. Si rivelò falsa. Del resto non ho mai avuto una scorta, se non quando mi dovevo presentare in posti ufficiali, dove si sapeva che sarei andato. Ho sempre vissuto qui e non ho mai fatto la plastica. A che cosa sarebbe dovuta servire? Sembra incredibile, ma, in questi venticinque anni, ho fatto sempre la stessa vita, mimetizzato in mezzo alla gente. È il modo migliore per sparire. Certo, problemi ce ne sono stati e tanti. Soprattutto quelli legati all’identità, a cominciare dal libretto della mutua». Una second life quasi banale quella che Peci descrive. Tranne che per l’assassinio del fratello Roberto, che lui vuole tenere fuori. E per quattro anni, prima di finire in carcere». Si è mai rammaricato di aver provocato tanti arresti? «Durante il carcere è stato tutto molto difficile, dal punto di vista psicologico e da quello pratico». Come decise di saltare il fosso e di collaborare? «Dubbi all’inizio ne avevo tanti, e anche sofferenza, già prima di essere arrestato. Non ero più convinto di quello che avevo fatto e, dopo Moro (il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro è del 9 maggio 1978, cinquantacinque giorni dopo la strage di via Fani, ndr), non sapevamo più come andare avanti. Quella non era la mia crisi, era quella di tutte le Brigate rosse. Lo so, io sono stato il primo, ma se la mia scelta fosse rimasta singola, isolata, non si sarebbe creato il fenomeno della dissociazione. E quindi le bierre non si sarebbero disintegrate. La mia dissociazione fu un po’ quella di tutti. Non fu lo Stato a distruggere le Brigate rosse, siamo noi che ci siamo autodistrutti. La nostra strategia non era giusta, non lo era la violenza in Italia, in quelle condizioni. Non lo era aver provocato tanti danni, morte e dolore». Progetti per il futuro? «Sei anni fa ho avuto un tumore, ora diciamo che è superato, almeno sembra. Vorrei invecchiare tranquillamente. Per il resto anche prima vivevo nella normalità: facevo la spesa, parlavo con la portinaia, andavo al bar, al supermercato». Eccezioni? «Una volta, ero a Torino per un processo; a Porta Palazzo un ragazzo mi ha riconosciuto e me l’ha detto in faccia. Ti stai sbagliando, gli ho risposto. E lui: “Io, al posto tuo, starei attento”. E io: “Lo farò”. È stato uno dei pochissimi casi. Per il resto, normalità». Ancora questa parola? «Non ci crede? Beh, glielo dico, all’epoca sono tornato perfino a San Benedetto qualche volta, la città dove ho vissuto, la mia città. Fu qualche anno dopo; sono stato a trovare mia madre, i miei parenti. E ho anche dormito in casa di mia madre. E senza i miei amici carabinieri che qualche volta lasciavano correre, altrimenti non campavo più. La mattina andavo al mare e una volta il padrone dello chalet mi ha perfino riconosciuto, abbiamo pranzato insieme. Ci pensi, se fosse venuto fuori: Peci sta al mare a San Benedetto, ci avrebbe forse creduto qualcuno? È tutto lì il bluff». ALLA SBARRA Patrizio Peci scortato in aula durante il processo e, a sinistra, l’ex brigatista mentre depone IL DISEGNO Il disegno che illustra queste pagine è Commiato di Sergio Toppi, uno dei maggiori illustratori italiani Toppi ha lavorato tra l’altro per Il Corriere dei Piccoli, Il Corriere dei Ragazzi, Linus, Il Giornalino, Corto Maltese, L'Eternauta. Commiato è uno dei lavori esposti alla galleria d’arte Tricromia di Roma fino a domani nella mostra dal titolo Città sirena. Per informazioni: www.tricromia.com Repubblica Nazionale DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 LE TAPPE L’INFANZIA L’ASCESA L’ARRESTO IL PENTIMENTO Nasce a Ripatransone (Ascoli) nel 1953 Vive a San Benedetto e frequenta l’istituto tecnico a Fermo. Nel 1974 è a Milano. Primo contatto con le Br Nel 1976 inizia la carriera di brigatista nella colonna torinese “Mara Cagol”. Nome di battaglia Mauro. In poco tempo diventa il responsabile Il 19 febbraio’79 viene arrestato Tra le accuse, sette omicidi, tra cui quelli del vicedirettore della Stampa Casalegno e dell’avvocato Croce Peci decide di collaborare con la Giustizia Nel 1981 le Br uccidono il fratello Roberto Nel 1986 esce dal carcere e da allora vive sotto falso nome PATRIZIO PECI atrizio Peci è morto il 18 maggio 1983. Patrizio Peci ero io. Il 18 maggio 1983, a Torino, l’uomo conosciuto con il nome di Patrizio Peci entrava in un’aula del tribunale di Torino per testimoniare contro i suoi ex compagni, principale teste d’accusa nel processo contro le Brigate rosse. Fino a quel giorno ero stato un brigatista, dopo di allora divenni il più feroce nemico dei brigatisti, l’uomo che aveva reso possibile lo smantellamento della più importante organizzazione armata degli anni di piombo. Peci “l’infame”, perché aveva tradito il codice di omertà che lega tra di loro gli ex terroristi, spesso anche dopo la cattura. Peci “l’infame”, perché aveva vuotato il sacco, chiuso ogni margine di ambiguità possibile, perché si era bruciato i ponti dietro le spalle; infame perché aveva fatto i nomi, perché aveva collaborato con il generale, perché aveva scelto quegli stessi carabinieri che gli avevano dato la caccia. Infame perché era passato dalla parte dei suoi ex nemici, che adesso erano destinati a diventare i suoi unici compagni di vita. Peci, l’ex combattente convinto che la guerra sia finita. P *** «Perché non ti fai una plastica?». Se dovevo restare in questo paese, bisognava immaginare come. Se non dovevo trasferirmi all’estero, era indispensabile trovare un modo per vivere in Italia. Ci pensai a lungo e giunsi a un’unica con- venivano a fare visita, non mi faceva domande sullo “zio Creso” e sullo “zio Picciotto”, i due carabinieri che dopo avermi dato la caccia erano diventati i miei migliori amici. Quello era il suo mondo, la sua famiglia, la normalità, i volti delle persone che conosceva da sempre. Certo, come una premonizione, c’era la sua passione per gli anni di piombo, per i programmi di Giovanni Minoli e per gli articoli dei giornali. Non ci eravamo dati regole perentorie, io e mia moglie, se non questa: quando lui faceva domande, noi rispondevamo sempre. La verità iniziò a farsi largo a poco a poco, per gradi, come se si fosse trattato di un destino ineluttabile, di una necessità. Un giorno, improvvisamente, ogni filtro cadde. Mio figlio mi venne incontro con in mano una copia di un giornale, credo La Stampa. Non ebbi bisogno di leggere per sapere di cosa si trattasse. C’era un articolo su Peci e una foto dei tempi del processo. Era una vecchia immagine in bianco e nero, per giunta un po’ sgranata, dove apparivo molto diverso da come ero in quei giorni. Ma se la regola dello sguardo ha un senso per chi ti ha conosciuto bene, figuratevi se uno sguardo può mantenere un segreto di fronte a un figlio. Disse semplicemente: «Papà, questo sei tu». Io provai a scherzarci su, e risposi ridendo: «Sì, figurati, sono il terrorista Peci…». Lui continuò, senza farsi scoraggiare dalla mia battuta: «Papà, Peci sei tu, io lo so». *** Mi sono accorto solo per caso che io sono l’unico. L’unico che negli anni di piombo abbia abitato entrambi i gironi dei dannati: sia fra le “Clandestino da sempre non ho cambiato faccia” IL DOCUMENTO Io l’infame uscì nel 1983 È il racconto di Patrizio Peci a Giordano Bruno Guerri: la storia del primo pentito delle Br, quello che diede un colpo forse decisivo al partito armato. Il 21 ottobre ritorna in libreria per Sperling & Kupfer in una versione aggiornata con quattro capitoli inediti (un estratto è pubblicato in queste pagine). Premessa di Luca Telese, prefazione di Giordano Bruno Guerri (288 pagine, 15 euro) clusione. La sola cosa della vita di Patrizio Peci che poteva servire anche alla vita del nuovo Patrizio era quello che Peci sapeva fare meglio. Ovvero vivere nelle città, dissimularsi tra mille esistenze anonime, vivere da clandestino. Sfuggire alla condanna a morte delle Brigate rosse con gli stessi strumenti appresi alla scuola delle Brigate rosse. L’ultima scelta, se possibile, fu ancora più importante. Vivere con la mia faccia di sempre, l’unica che conoscevo. Quella a cui ero affezionato. Uno a cui capita di morire, una volta nella vita, può cambiare tutto. Tutto, ma non l’immagine che guarda la mattina quando si ritrova davanti allo specchio. Era un azzardo, mi dicevano. Ma sentivo che potevo farlo. Ero convinto di aver imparato una regola, nel periodo della mia prima latitanza. Un giorno, al mare, mi ero ritrovato in spiaggia. Ero bardato, senza baffi, apparentemente irriconoscibile rispetto all’identikit diffuso dai giornali. Mi capitò di incrociare lo sguardo di un amico di infanzia, dietro un ombrellone, di esserne come attraversato, di avere la certezza matematica di essere stato riconosciuto. Quel giorno mi ero convinto che se qualcuno ti riconosce non è per la forma del naso, o per il modo in cui la mascella si appoggia sul tuo collo, o per il taglio delle sopracciglia. Se uno ti riconosce, quando sei latitante, è perché ti sa guardare negli occhi. Ma siccome gli occhi sono quelli, e nessuno te li può cambiare, decisi che già che c’ero avrei corso il rischio, che avrei tenuto anche la mia faccia. Il primo anno fu durissimo. Il secondo migliore. Dal terzo iniziai a pensare che ce l’avrei potuta fare. Scegliere di fare un bambino, insieme, fu la traduzione di questa certezza acquisita, fu il passo di non ritorno nella normalità. Il ritorno alle responsabilità era un altro passo che mi separava dalla mia vita precedente. Essere responsabile di una vita è la cosa che più ti allontana da un’esistenza in cui le vite non contano. *** Oggi mio figlio ha ventiquattro anni, e un segreto. Non è stato sempre così. Non gli avevamo detto tutto, quindi per molti anni anche lui ha coltivato il dubbio. Quando era piccolo non si faceva troppe domande. Non ci chiedeva chi fossero gli “amici” con la pistola che spesso ci vittime sia fra i carnefici, sia fra chi ha amministrato la morte sia fra chi ha conosciuto la morte, quella di una delle persone più care, quella che ti fa conoscere il senso della perdita irrevocabile. Sono l’unico, e non è certo un privilegio. È come se queste due parti della mia storia e della mia personalità si inseguissero in tondo dentro di me, in un moto perpetuo, e non si incontrassero mai. Come se aver impugnato una pistola per sparare mi rendesse ancora più difficile, e non più facile, capire le ragioni di chi ha sparato. Ogni volta che penso a mio fratello, e a quello che gli hanno fatto, alla squallida messa in scena allestita a beneficio dei giornali, alla foto dell’esecuzione scattata come se si trattasse di un film, al canto di Bandiera rossamandato in onda mentre gli leggono la sentenza di morte, sento ribollire il sangue nelle vene per l’ira. Anni fa, come ho già raccontato, credevo che avrei trascorso quello che mi restava da vivere a inseguirli con la pistola in mano. Oggi che l’idea della vendetta è passata come una febbre tropicale dentro di me, sento solo un grande vuoto: il senso della perdita e dell’assenza. Non potrò perdonare mai. Mai. Perché non si può perdonare quello che non ha senso. E forse è per questo che i parenti delle vittime non riescono a spiegare mai, a chi non lo ha conosciuto, il senso del lutto. Non puoi perdonare la perdita irrevocabile, soprattutto quando sai che non c’era motivo, soltanto odio e ferocia animalesca in chi ha premuto il grilletto. Ancora oggi, di questi brigatisti del presunto Fronte delle carceri, quelli che realizzarono il sequestro, penso un’unica cosa: che sono delle bestie. *** Oggi, a distanza di tanti anni, non so dire se davvero sono io quello che ha smantellato le Brigate rosse. Non sono un presuntuoso, non mi interessa appuntarmi medaglie sul petto, non è nel mio carattere. Ma di una cosa sono sicuro: io ho anticipato, con la mia scelta, qualcosa che doveva accadere. Sono stato lo strumento che ha reso possibile qualcosa che era già nella storia. Oggi, dopo che è passato un quarto di secolo, e che il tempo ha misurato il peso delle scelte, penso semplicemente questo: non ho rimpianti, non ho rimorsi. Sono felice di avere fatto quello che ho fatto, perché era giusto farlo. © 2008 Sperling & Kupfer Editori Spa Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 l’attualità Insicurezza sociale Mentre i consumi e la produzione crollano, in Europa le vendite di serrature elettroniche, armadi blindati, cripte con la combinazione aumentano repentinamente È la contromisura individuale alla paura della crisi e dell’anarchia: una risposta illusoria, gretta e primitiva FOTO LEEMAGE FOTO CORBIS FOTO MONDADORI ELECTA ma tutto sommato più innocua delle risposte collettive Non ci resta che la cassaforte P PINO CORRIAS sei per cento del loro valore, più o meno, quanto le azioni della Cirio e le promesse di carta della Parmalat. Tanto vale premunirsi. Ritirare se non tutto almeno un po’. Installare la propria doppia spanna di aria sicura, dentro la quale infilare un po’ di soldi, un po’ di gioielli, una via d’uscita. Troppo ingenuo? Infantile? Inadeguato? Può darsi. La cassaforte nasce con questo destino di argine della paura incorporato. Le sue pareti blindate compaiono un paio di secoli fa, subito dopo il telegrafo e poco prima del motore a scoppio, tra i fumi frastornanti della Rivoluzione industriale. Da allora proteggono le banche dagli assalti. Proteggono le case dei ricchi. Proteggono il malloppo. Ispirano desideri. Producono intrecci narrativi e avventure poliziesche. Diventano il sigillo della ricchezza e del potere, mentre la città si allarga a dismisura, molto oltre i bordi dei capannoni industriali, con la sua confusione carica di promesse, di conflitti collettivi e pure di inganni. La sua epopea si rialimenta ad ogni crisi. Insicurezze sociali fanno parte della sua combinazione. Sempre le sue vendite salgono quando sale lo spavento. Come è accaduto nell’Italia delle congiunture economiche e negli anni più sanguinosi del terrorismo. Oppure in Francia nei giorni di sotterranee turbolenze generate dall’ascesa di Mitterrand, anno 1981 e seguenti, potere socialista all’Eliseo, minaccia alla proprietà privata, si mormorava, con scarso senso del ridicolo. Stessa funzione psicologica (o psichiatrica) dei box antiatomici scavati in tutta Europa sotto le ville d’alta borghesia, quando ancora ruggiva l’orso sovietico, negli inverni di Guerra fredda. E che adesso vengono buoni per seppellirci il tesoro, casseforti anche loro, come più di altri dimostrano, in questi giorni, i cantieri che gli svizzeri stanno allestendo dentro al massiccio del Gottardo, che un tempo riempivano di paranoia nucleare e oggi solamente di lingotti d’oro e di fondi pensione non ancora intossicati (forse) dai subprime. Persino lo Stato del Vaticano, pure depistando coi vocativi di papa Benedetto Sedicesimo («Il denaro è nulla»), ha sigillato per tempo le serrature dei suoi forzieri installati nel mezzo chilometro quadrato del suo territorio di pietre, palazzi e pini marittimi. Riempiendoli, con previdenza, di molto nulla. Mille miliardi, secondo l’inchiesta del settimanale cattolico inglese The Tablet, che i suoi addetti alle casseforti hanno incassato vendendo (cattive) azioni dal 2007 in poi, per comperare eccellente valuta, bond e oro. Tutto da custodire per i suoi 804 abitanti esentasse, ben al riparo dalla crisi. Dicono gli analisti che sia finita un’epoca, quella che il Financial Times ha battezzato del «Capitalismo Casinò». Che si sia dissolto il modello di una finanza planetaria e senza regole a caccia di profitti massimi e immediati. Quella che il segretario al Tesoro Usa Hank Paulson ha definito: «Capitalismo selvaggio». Che sia deragliata per sempre l’economia fondata sul debito che veniva moltiplicato, finanziato, assicurato e infinite volte rivenduto. Che sia tramontata l’era dei manager pagati come le star del cinema. Tutto possibile. FOTO ALINARI FOTO ALAMY erché poi dovrebbe stupirci l’idea (e la voglia) di nasconderci tutti dentro a una cassaforte Sentinel con serrature elettroniche, pannelli blindati, timer, e doppia chiave? C’è davvero qualcuno che sa cosa diavolo stia succedendo, da un mese e mezzo, alla (bella) vita dell’Occidente che diventa grigia, alla sua linfa vitale, il denaro, che d’improvviso si assottiglia, e alla nostra roba che dilegua? Roba accumulata con la voracità del formicaio e la frenesia delle cicale, azione per azione, mutuo per mutuo, estraendo il necessario e soprattutto il superfluo dai due terzi del pianeta che stava andando in malora, un tempo, e che adesso invece ci minaccia con le sue braccia a buon mercato, i suoi container pieni di scarpe e di giovanissimi ingegneri appena laureati a Bangalore, e informatici nuovi di zecca, tutti pieni di energia e di ottimismo della ragione in corsa verso il futuro che sarà loro e non nostro, o almeno sembra, vai a sapere. A Londra e dintorni, nelle ultime cinque settimane si è venduto il venticinque per cento in più di casseforti casalinghe, armadi blindati, cripte con la combinazione. Lo stesso accade nel resto d’Europa, Italia compresa, più o meno dai giorni in cui si sono sbriciolati i forzieri della Northern Rock e della Branford & Bingley, le prime due banche nazionalizzate dal governo britannico dopo settanta anni di libero mercato, crisi periodiche, aggiustamenti periodici e soldi, soldi, soldi, secondo la regola aurea del: vinca il migliore e ad- na per contenere il cappello dei New York Mets, la foto della ex fidanzata, la pergamena del Master, ma nessuna spiegazione su questo strano presente che sbriciola il futuro. Perché l’economia, anche se è fatta di numeri, di formule, di teorie matematiche, non è una scienza esatta. Come la sociologia, spiega magnificamente quello che è già accaduto. Ma in quanto a previsioni future vale un oracolo. Perché asseconda il caso. Perché ha infinite variabili. Perché è massimamente emotiva, genera euforia, genera il panico, e da entrambi si lascia influenzare. Possibile pure che con i suoi logaritmi e i suoi forzieri, i suoi guerrieri in grisaglia & sushi, le sue cattedrali di marmo, i suoi summit di banchieri centrali ieratici come sacerdoti che officiano, su schermi digitali, un rito che quotidianamente insanguina l’altare dello Stock Exchange, sia un pensiero magico. Una pratica magica. Che a volte si avvera e altre volte no. Persino l’economista Paul Krugman, giusto un paio di giorni prima di vincere il Nobel, aveva sigillato la sua analisi sull’economia «che corre senza progetto e senza guida, se non l’avidità» con la confessione di una resa: «Ovviamente nessuno può sapere cosa accadrà domani». E di domani, da allora, ne sono arrivati parecchi. Ognuno con il suo imprevisto. Ovviamente. E allora? Meglio le casseforti di quelle scatole di cartone, finché si è in tempo. Meglio una serratura Bramah con i cilindri ben chiusi, che il rimpianto a cielo aperto. Come ai tempi in cui si sono volatilizzati nel nulla i bond argentini, che oggi stanno tra il venticinque e il trenta- Anche se non probabile. Come se un giorno venisse annunciata la fine delle speculazioni, il tramonto dell’avidità. Ci credereste? Ha una fibra migliore la riflessione del finanziere Warren Buffet, che ha appena superato Bill Gates nella classifica dei super ricchi. Dice che la crisi genererà più danni dell’11 settembre, ma non altrettanta coesione sociale. L’attacco alle Due Torri ha riunificato il Paese e l’Occidente contro un nemico, il terrorismo. Mentre i mercati, crollando, diffonderanno il panico e l’anarchia, «moltiplicando le risposte individuali». La cassaforte fa parte di queste risposte. È il perimetro privato in un mondo che ha cancellato i confini e dunque anche i luoghi. È il baluardo contro l’assedio. La serratura magica. L’incremento della sua diffusione ha a che fare con la sicurezza: parola sommamente pericolosa, secondo James Hillman, perché illusoria. Illusoria perché ha un fondale che non si colma mai. Eppure le risposte individuali potrebbero non essere affatto peggiori di quelle collettive. Le quali, sulle macerie delle Torri Gemelle, hanno elaborato le mappe dei bombardamenti in Iraq e Afghanistan. Il sangue che ne è già scaturito, i conflitti che seguiranno. E la strategia della paura perpetua, alimentata da una spesa altrettanto perpetua. La cassaforte, in fondo, è una risposta assai meno sanguinaria. Magari più gretta, o primitiva, di sicuro insufficiente, ma almeno innocua. FOTO AFP FOTO ROGER VIOLLET dio ai perdenti. Piccole casseforti contro l’immensa volatilità del destino e il rischio numerico dei crolli. Contro il colpo di vento che in un giorno disperde migliaia di famiglie e di aziende. Contro il naufragio che in un’ora distrugge milioni di azioni. Che inghiotte cifre iperboliche, mai pensate prima, nel tempo di un lancio di agenzia: «Bruciati ieri 1300 miliardi di dollari». Ma poi materializzandone altrettanti, estratti da misteriosi caveau sovranazionali: «Immessa liquidità sui mercati per 750 miliardi»; «Varato un piano da 400 miliardi», tutto raccontato da un iperuranio di tecnocrazie finanziarie di cui non sappiamo nulla, ma che da quella immensa distanza, moltiplica le nostre bollette, svuota i frigoriferi, rimodella la nostra vita. In questo mese e mezzo di portenti sono sparite nel nulla quotazioni da tripla “A”. Il Fondo monetario internazionale ha lanciato allarmi catastrofici: «Siamo sull’orlo del collasso». La Banca centrale europea ha vacillato. E l’intera Islanda è arrivata a un soffio dalla bancarotta per troppi debiti bancari. Poi le Borse sono ripartite alle stelle, con guadagni a due cifre, prima di tornare a scendere in picchiata. E si sono visti i ragazzi magri e belli della Lehman Brothers andarsene in fila, tutti e ventiseimila, ma ognuno per sé, lungo i marciapiedi soleggiati della Sixth Avenue e della giovinezza, con la carriera e la giacca infilate dentro a una scatola di cartone, fragile come sa esserlo il destino, buo- Repubblica Nazionale DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 Il nascondiglio perfetto PIERO COLAPRICO er trovare il nascondiglio giusto bisognerebbe imparare dai ladri. Una volta un vecchio bandito, della cosiddetta gang dei Milords (siamo negli anni Sessanta, epoca post teddy-boys, un impasto di rapinatori e truffatori), spiegava che nascondeva soldi, orologi e «altro materiale» in un ombrello chiuso. Aveva mutuato il trucco dell’ombrello da un capomafia, che nei suoi primi anni di Milano faceva il ricettatore. «Riceveva» in via Canonica, una casa di ringhiera, e il bandito, dopo aver svuotato la casa di un’attrice, gli portò un cofanetto di gioielli. Il mafioso contava anelli e bracciali, teneva da parte le collane, ma a proposito di qualche oggettino diceva: «È tolla», e lo lanciava giù dalla finestra. «Insomma — raccontava il ladro — uscii con molti meno soldi di quelli che pensavo. Quando feci un altro colpo, tornai da lui e si ripeté la scena. Quando lanciò giù dalla finestra un anello che mi sembrava bello e che, al limite, avrei regalato a una delle mie amiche, corsi a vedere dov’era caduto, per recuperarlo nel cortile. E alle prime non capii, non credevo ai miei occhi. Appeso a un filo sotto il davanzale, c’era un ombrello aperto. Quello non voleva pagare il prezzo giusto, diceva che qualche gioiello non valeva niente, fingeva di buttarlo via e, invece, gli bastava tirare dentro l’ombrello quando noi ladri andavamo via sconsolati per recuperare l’oro e le pietre preziose…». Lo shock fu reciproco, l’ex «Milord» però venne folgorato dall’idea dell’ombrello: «Ne usavo per me uno vecchio scassato, messo in ripostiglio. Intorno alle stecche avvolgevo i rotoli di banconote, gli orologi erano impacchettati verso il puntale. Non so se mi spiego, ma chi apre un ombrello nero in casa?». Altri tempi, altre storie, altri uomini. Oggi chi non ha la cassaforte, le guardie giurate e le telecamere (e cioè la maggior parte dei cittadini) s’arrangia. Lo stile di occultamento è trasversale. Qualche giorno fa è stato trovato a Palermo il tesoro di un uomo di Cosa Nostra: 496mila euro, oltre duemila dollari e quattro chili di preziosi. Dov’era? Dentro quattordici barattoli, sepolti nelle aiuole del giardino della casa del boss a Carini. Lo stesso schema, degno dei pirati, è adottato da non poche casalinghe: quando partono per le vacanze scavano buche nei vasi di geranio. Spesso, per non fare fatica, lasciano il sacchettino a pochi centimetri di profondità: i ladri svuotano comunque i vasi. Altro classico nascondiglio è quella cosa che più in una casa assomiglia alla cassaforte: il frigorifero. C’è chi svuota il contenitore dei ghiacci e, avvolgendo nella plastica l’anello con il brillante, lo piazza nel congelatore. Il trucco ha funzionato per anni, ma è da un decennio circa che i razziatori di appartamento spesso non sono professionisti abili, ma poveracci affamati. Quando entrano in una casa, se possono, si preparano da mangiare. Qualcuno voleva bere. E, nell’acqua gelata, ha visto galleggiare qualche cosa. La voce dei gioielli sotto ghiaccio in Italia si è ormai sparsa tra i serbi-montenegrini. Qualcuno ha anche progettato una casa a prova di ladro, trasformandola in una baita: legno dovunque sui muri, librerie di legno inchiodare alle pareti, corrimano intarsiati. Ma, anche qua, non è durata: schiodate le librerie, schiodati i panelli, la baita s’è rivelata una specie di forziere di zio Paperone. Carabinieri e polizia, che raccolgono le denunce, hanno trovato nascondigli scoperti dovunque, dagli aspirapolvere ai finti termosifoni, alle cucce dei cani sul balcone. Tanto che, nell’eterna guerra tra vittime e ladri, non sono pochi quelli che hanno fatto una scelta di rassegnazione. Lasciano sul comodino qualche biglietto da cento euro: va a dire, se non trovi, oh ladro, non insistere a spaccare tutto, qualche cosa ti ho lasciato. Da evitare il comportamento di un anziano pensionato di Milano. Lui e la moglie, terrorizzati dai ladri, hanno nascosto i gioielli di famiglia nella pattumiera e l’hanno lasciata lì. Saggia idea: nessuno è andato a frugare. Purtroppo, appena rincasati, la moglie si è lamentata per il cattivo odore, ha ordinato al marito di scendere a buttare immediatamente l’immondizia. Brontolando, l’uomo ha eseguito. Salvo ricordarsi che cosa aveva fatto la mattina dopo, quando il camion dell’Amsa era già passato. La storia si è scoperta, così pare, grazie al rapporto di una volante accorsa per «litigio in famiglia». FOTO LE EMAGE S FOTO AK G FOTO GETTY P LE IMMAGINI Nella foto grande, un’antica cassafortegiocattolo. Nelle foto piccole, una sintetica storia della cassaforte, da uno scrigno romano (in alto a sinistra) a un box a combinazione elettronica (qui accanto) Nelle due stampe qui sopra, un banchiere veneziano del Cinquecento e un’illustrazione tratta da Vent’anni dopo di Alexandre Dumas Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la memoria Album ritrovato DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 A novant’anni dalla fine del primo conflitto mondiale, una mostra a Borgo Valsugana raccoglie le foto mai viste scattate al fronte dal giornalista-scrittore. Un diario visivo in diretta dalla trincea: tra noia e attese, bicchieri di vino, risate e sfide a palle di neve. Il racconto per immagini delle atmosfere descritte dall’autore ne “Le scarpe al sole” Il soldato Monelli alla Grande guerra MICHELE SMARGIASSI A La mostra 1915-1918: al fronte con Paolo Monelli (nel novantesimo anniversario della fine della Grande guerra) sarà inaugurata il prossimo 2 novembre allo Spazio Klien, Borgo Valsugana (Trento), a cura di Pino Ielen e Luca Girotto La mostra, promossa dall’Associazione storico-culturale della Valsugana orientale e del Tesino, e dalla Biblioteca Statale A. Baldini di Roma, resterà aperta fino al 7 dicembre BORGO VALSUGANA (Trento) ppena dieci anni dopo, l’«inutile strage» era già una cartolina sorda. Nel 1928, ripubblicando Le scarpe al sole, il suo libro più celebre, Paolo Monelli s’accorse che la memoria s’era già mutata in fotografia: «Mentre ho ancora ben nette nella memoria le linee del terreno, e i sassi, i mughi, i soldati, i feriti, i morti, le masse tedesche avanzanti, il sangue colante dalla fronte del caporalmaggiore De Boni, gli occhi sbarrati di Altin, nulla mi è rimasto delle voci, degli urli, dei rumori, degli scoppi, come se la scena l’avessi vissuta, immagine vana tra altre immagini vane, sullo schermo d’una pellicola muta». E sullo schermo di un muto computer oggi la riviviamo noi. Con i suoi stessi occhi. Vediamo i suoi «buoni alpini», i veci e i bocia, come li vide lui, che finita la guerra li avrebbe trasfigurati, con le parole, da ruvide macchiette militaresche a eroi di un’epica; ma che allora, col tapum degli obici nelle orecchie, li guardava solo con curiosità, simpatia e burbera tenerezza. E li fotografava con lo stesso sguardo. Dieci, cento volte li fotografò: quasi settecento, per la precisione. Tante sono le foto di guerra prese da Monelli, scrittore e giornalista di successo, ma fotografo privatissimo, così privato che quasi nessuno in novant’anni le ha viste, quelle immagini. Non che si fossero perse, o sepolte chissà dove: erano rimaste, semplicemente, appartate. Assieme ad altre centinaia di scatti, a pacchi di lettere, ritagli e manoscritti, a migliaia di libri, dal 1983 sono affidate alle cure della Biblioteca statale Baldini di Roma, a cui le consegnò pochi mesi prima di morire la vedova dello scrittore, Palma Bucarelli, bella figura di intellettuale, energica e colta direttrice della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. Un tesoro taciturno, al limite dell’afasico. Profili di montagne, luoghi, volti: tutti senza nome, rari e imprecisi gli scarabocchi sul retro. Davvero «immagini vane tra immagini vane». Forse anche Pino Ielen sente disagio per l’inquietante silenzio di queste immagini, e cerca di esorcizzarlo versandoci sopra un diluvio di spiegazioni minuziose, nomi di montagne, di alpini, date, quote, cifre, che può sapere a memoria solo un appassionato di Grande guerra come lui: «Ecco, qui tre alpini del terzo plotone stanno leggendo un giornale, si legge anche il titolo, “Si lotta oltre il monte Cimone”, dunque siamo attorno al 15 luglio 1916...». Vorresti dirgli, a costo di offenderlo, zitto un momento Pino, guardiamocele in silenzio; ma poi capisci che è il suo modo di salvare quei ricordi, richiamarli a vita. Del resto se non ci fossero lui e i suoi cinque o sei amici dell’Associazione storico-culturale Valsugana orientale e Tesino, tutti volontari, questo tesoro non sarebbe utilizzabile. Quando hanno saputo della sua esistenza, hanno chiesto all’archivio che lo conserva di poterci lavorare. Hanno avuto le copie Repubblica Nazionale DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 I TEMPI MORTI GLI AMICI In basso, il barbiere di trincea; a sinistra, sorrisi, pose e pause di lettura a ridosso della prima linea immortalati da Paolo Monelli A sinistra, i commilitoni di Paolo Monelli fotografati in Val Cismon; sotto, Monelli, in posa tra due compagni, regge la sua macchina fotografica elettroniche di tutte le immagini. Hanno cominciato a riconoscerle una per una, a ri-battezzare le cime e le facce, ce l’hanno fatta quasi sempre. Faranno in tempo a farne una grande mostra per il novantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale, il 2 novembre, qui a Borgo Valsugana, che è un po’ il baricentro dell’avventura di Monelli, in questo piccolo e curioso museo della Grande guerra dove dietro le vetrine convivono spallina a spallina le divise degli alpini e quelle dei Kaiserjäger, perché questa fino al 1915 era Austria, quasi ogni casa qui ha appesa al muro la foto di un nonno in divisa asburgica; in questa valle la storia orizzontale, quella dei confini e delle guerre, è volubile, «solo il rapporto con la verticalità è stabile», dice l’assessore Emanuele Montibeller indicando col dito le cime eterne. In «questa benedetta valle Sugana che ha le cantine piene di vino e i granai colmi di mele odorose» Monelli era arrivato ventunenne volontario negli alpini, lui borghese di pianura; nato nel Modenese, già pronto a fare «malinconicamente l’avvocato nella curialesca Bologna», rinnegò il dandy annoiato che era, cercando il bagno rigeneratore tra «uomini nuovi, che hanno veduto il confine della vita e ne sono ritornati». Suona un po’ dannunziano, ma era l’aria. Il commilitone Angelo Manaresi, che sarà sottosegretario alla guerra nel Ventennio ma finirà badogliano, lo descrisse «freddo e incaramellato, sottile come un giunco, caustico, mordace, freddurista impenitente, gran conquistatore di donne». Un signorino della città fra gli ispidi guerrieri dalla penna nera: eccolo proprio così, sbarbatello in divisa, aria un po’ saputa, in una fotografia che evidentemente gli ha fatto qualcun altro. Ha una macchina fotografica al guinzaglio, una macchina a soffietto. Forse una Vest Pocket, la folding camera di cui «ogni ufficiale e soldato dovrebbe provvedersi», come recita lo slogan che proprio nel 1915 la Kodak pubblica sui giornali accanto al disegno di un alpino. E quanti soldati fotografarono. Forse più di quanti già sappiamo: altri tesori probabilmente giacciono nascosti nei bauli dei nonni. Ufficiali, più che altro, perché la fotografia negli an- ni Dieci era ancora un po’ costosa. Ma anche fantaccini, cappellani, medici: fu la prima guerra fotografata da dentro. Dicevamo: quel damerino incaramellato, una volta assegnato al terzo plotone della 265ª compagnia del battaglione Val Cismon del 7° Reggimento alpini, ricevette subito un perentorio consiglio: «Si tagli i capelli, si lasci crescere la barba e cominci a bere vino». Eseguì. Dopo poche settimane: pizzetto, fiasco, pipa. Mimesi esteriore, metamorfosi interiore. Quel che ha di prezioso questo finora ignoto romanzo per figure di Monelli, è la sua evoluzione nel tempo e nello spirito, una mosaico di tessere che Ielen e i suoi amici con pazienza da trincea stanno rimettendo in ordine come fossero le illustrazioni mancanti di Le scarpe al sole. Quel che ci si vedrà alla fine sarà forse in grado di dare un’altra vita a un libro quasi sparito dalla circolazione, di cui sembra sopravvissuto solo il titolo-proverbio. I suoi personaggi ora hanno un volto. Ecco la «vecia Vendramin», locandiera-mamma di Feltre; ecco alle falde del Setole il De Lazzer con addosso quell’inverosimile frac rosso trovato nel baule di una casa devastata, che s’ostinava a indossare per servire a mensa gli ufficiali; ecco Zanella, l’attendente del tenente Monelli, con cui «avrò scambiato duecento parole in tre anni», muto anche in foto mentre guarda il lago di Costabrunella; ecco il sottotenente Marni che non si stanca mai (lui no, i commilitoni sì) di strimpellare alla chitarra sperticate canzoni napoletane. «Ci sono tutti», s’intenerisce Ielen, «come ce li aspettavamo». Eroi senza Omero, nelle Termopili ghiacciate di un fronte che «non era neppure il più importante», tiene a spiegarti Luca Girotto, medico e storico della guerra sul Lagorai, «non decise le sorti del conflitto», ma non per questo fu un minore massacro di popoli. Nell’album Monelli, però, battaglie nessuna: in battaglia si spara, non si scatta. C’è invece il diario visivo della guerra dei tempi mor- ti, della noia nervosa dietro i ripari, del barbiere di trincea, del bicchiere di vino identitario, della messa da campo, dei muli fedeli, di una guerra che ha anche spazio per le risate, le battute sconce, le sfide a palle di neve. Anche la «cronaca di gaie e tristi avventure» di Monelli fu comunque arruolata nel tronfio reducismo del regime fascista, ma francamente non ci stava. Non perché Monelli fosse un pacifista, anzi era stato interventista e non si pentì; tantomeno un dissidente politico: la sua carriera di giornalista, dal Carlinoal Corriere, fiorì tra le due guerre. Ma l’ironica e commossa epopea alpina che Monelli scolpisce ha ben poco di imperial-romano, è un’epica barbuta e ruvida di bestemmie e di bevute che passa sotto la retorica, forse ne fonda un’altra tutta sua, ma di certo diversa da quella che gli “imboscati”, i borghesi, i politici, gli alti ufficiali cercavano di costruire addosso agli alpini già allora, mentre quelli ammazzavano e si facevano ammazzare per cento metri di pietraia chiamata “patria”. Nel libro, Monelli racconta di una licenza spesa andando al cinematografo, a Castelfranco Veneto. A vedere cosa? Un film sulla guerra, «che era qualche cosa di buffo, una concezione quarantottesca, truppe al Savoia! per quattro sullo stradone, piume di bersaglieri e trombe che suonavano l’attacco», roba da ridere, e Monelli infatti ci ride forte in sala, e grida: «Io che faccio la guerra vi dico che la guerra non è così!». Lo zittisce seccato un borghese: «E cosa me ne importa? Lasciate che me la goda riprodot- ta come me la figuro io». Grandissimo, preveggente apologo mediatico, questo. La guerra vista a casa non è mai la guerra vera, vale per l’Ortigara come per l’Iraq. Come se la “godevano” la guerra, i civili? Nelle tavole acquerellate di Beltrame, dove gli alpini sembravano una baldanzosa squadra sportiva. Nelle fotografie ben scelte dell’Illustrazione italiana, dove la guerra somigliava a una passeggiata naturalistica tra le dentate scintillanti vette. A Monelli, roba così faceva venire l’itterizia. Lui che pure fu accusato, all’opposto, di aver messo in pagina «poco odore di morte e di piedi», si sarebbe vendicato di quella retorica con un libro di sorprendente sarcasmo, La guerra è bella ma è scomoda, che sembra scritto per liberare la memoria dei “suoi” alpini dalla morsa degli «utopisti della pace perpetua» e degli «eroi da retrovie». È un libro illustrato con le feroci vignette satiriche di Novello, chiaramente suggerite dallo scrittore. Monelli dunque sentì il bisogno di contrapporre immagini a immagini. Perché allora non usò le sue fotografie? I suoi bozzetti di vita e di umanità, ma anche le foto più simboliche e astratte, le croci di legno nella neve, il tunnel scavato nel ghiaccio alla cui imboccatura s’affaccia un sogno di montagne assolate e senza sangue? Per la verità, Monelli non scrive mai di aver fotografato al fronte. Se nel fondo familiare non ci fossero anche i negativi, se la scia di immagini non corrispondesse passo passo ai suoi trasferimenti, se la serie non s’interrompesse bruscamente quando Monelli fu catturato dagli austriaci, si potrebbe perfino dubitare che le abbia scattate lui. Pensava forse che le fotografie fossero penosamente incapaci di reggere il peso della memoria? Di trasmettere l’emozione? Eppure lasciò che si ricavasse un film, dal suo libro, nel ‘35: andò pure a fotografare il set. Eppure qualche descrizione di fotografia spunta, proprio nelle pagine delle Scarpe al sole. Ma sono altre fotografie, sono quelle che i soldati portavano nel portafogli, sul cuore. Il ritratto che gli arriva dalla «perfetta bambina diciannovenne lontana», per sognarci su. Un’altra fidanzata, trovata nel portafogli di un commilitone falciato dalla mitraglia. E un’altra foto ancora, «cinque ragazze floride», forse le sorelle, «nel mezzo la madre con così accorata mestizia negli occhi», questa volta uscite di tasca al cadavere di un much, un soldato asburgico, ungherese per la precisione; a gridare che anche il nemico ha mamme fidanzate e sorelle come tutti i Ceschin, gli Zanella, i Rossetto di questa parte della barricata. Forse, vuol dirci Monelli, sono le fotografie della pace perduta le uniche davvero capaci di smontare la guerra: non le «immagini vane» che la replicano. Mute come sono, le foto degli affetti fanno esplodere le parole dentro, aprono la porta a certe «zaffate di dubbio» rarissime ma feroci come quella che prende di sorpresa autore e lettore a pagina 128 delle Scarpe: «Se valga, dunque, questo tradizionale concetto di Patria, tanto stento, tanta rovina». Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 CULTURA* Otto milioni e mezzo di copie, di cui cinquecentomila solo in Italia. Adesso nelle librerie sta per arrivare il quarto e ultimo volume della tetralogia di Stephenie Meyer che ha per tema l’amore tra una teenager e un “non-morto” Ne abbiamo parlato con l’autrice e ne pubblichiamo in anteprima un brano. Aspettando il film, che sarà presto nelle sale di tutto il mondo LOREDANA LIPPERINI a domanda che assilla migliaia di lettrici italiane è una sola: riuscirà Bella Swan a diventare un vampiro? Quel che si può dire è che il 30 ottobre troveranno la risposta in Breaking Dawn, ultimo volume della fortunatissima saga ideata da Stephenie Meyer. Strana e felice sorte, quella toccata alla giovane madre americana, nata trentacinque anni fa ad Hartford (che, per ventura, è la stessa cittadina del Connecticut citata da Stephen King nel racconto The Mist) e considerata ormai la fondatrice del cosiddetto New Gothic, o Gothic sentimentale. Tutto è avvenuto rapidamente: l’anno è il 2003, il libro è Twilight, cui seguiranno New Moon e Eclipse. La storia è semplice: Bella, adolescente di provincia, ama Edward Cullen, splendido vampiro dai muscoli d’acciaio, ma di volto e di animo talmente gentili da renderlo impermeabile alle tentazioni del sangue umano e del sesso prematrimoniale. Bella ha cercato di offrirgli collo e verginità nel corso di tre libri (di quanto avviene nel quarto, occor- L conquista con la sua bellezza e dolcezza un vampiro, la sua famiglia (i Cullen), un licantropo (Jacob), un padre tirannico che dipende dalla figlia per ogni attività casalinga. Sembra la vecchia storia della Bella (appunto) che ammansisce la Bestia: e che crede saldamente nei valori della famiglia. Meyer lo nega: «Le mie storie non contengono messaggi: sono solo intrattenimento, e il personaggio di Bella non riflette le mie idee. Il modo in cui interagisce con suo padre si deve semmai a una sua naturale inclinazione a prendersi cura degli altri. Bella è accudente. Si comporta allo stesso modo con sua madre. Prova a farlo con Jacob. Farebbe lo stesso con i Cullen se avessero bisogno di qualcosa: anzi, una delle cose che la mandano in crisi con Edward e la sua famiglia è proprio il fatto che non necessitano di attenzioni. Quanto alla propensione al matrimonio della mia coppia, ho lavorato sul contesto temporale. Bella è una ragazza moderna e diffidente, dopo il divorzio dei suoi genitori. Edward è un ragazzo del secolo scorso, e per lui il matrimonio è un passo logico. Il loro conflitto su questo punto era interessante, e da scrittrice cerco sempre di lavorare sui conflitti». Purché si risolvano con il trionfo dell’amore? «Beh, io penso che tutti, ragazze e ragazzi, uomini e donne, sognino l’amore. L’amore romantico non è la sola cosa buona nel mondo, ma è una delle più grandi ed eccitanti. Per questo motivo ha tanta parte in letteratura, musica e film. E per questo i miei libri hanno tutti un elemento romantico». A rendere diversa la saga di Twilight da un romanzo rosa c’è l’elemento sovrannaturale, sia pure addolcito. E i vampiri hanno il loro peso sul successo dei libri, dal momento che da sempre esercitano il proprio fascino letale sulle lettrici: non è un caso che la cultura popolare recente ne abbondi, in film come Underworld o in serial televisivi come Buffy. Lecito chiedersi quale sia il vampiro letterario cui Meyer si è ispirata. Il luciferino Lestat de Lioncourt creato da Anne Rice? Il seducente Jean-Claude che appare nei libri di Laurell K. Hamilton? Sorpresa. Niente di tutto questo. Stephenie Meyer non ama i vampiri: «Non c’è un vampiro che preferisco in letteratura, perché non sono mai stata appassionata di horror e non leggo libri sui vampiri: grazie a questo, sono stata libera da nozioni preconcette quando ho cominciato a “Edward è un personaggio di vecchio stampo. Bello, ricco, innamorato: insomma “Nei miei romanzi horror non ci sono citazioni Semmai a ispirarmi il principe azzurro” sono stati i supereroi” re tacere), e le lettrici del pianeta hanno palpitato con lei: la saga, tradotta in quaranta lingue, ha venduto otto milioni e mezzo di copie, cinquecentomila solo in Italia. Dopo l’uscita del film (21 novembre), si pronosticano ulteriori record. Ma il fenomeno interessante è ancora un altro. Si cerchi Twilight su DeviantArt, che è il sito dove gli appassionati di tutto il mondo postano disegni amatoriali sui loro personaggi preferiti: oltre trecentomila risultati. Su Fanfiction.net, il più importante sito in lingua inglese dove vengono raccontate le storie alternative dei lettori, Twilight vanta il maggior numero di fan fiction (quarantamila) dopo Harry Potter, a pari merito con Il Signore degli anelli. In parole povere, la saga di Meyer ha un numero impressionante di fan che commentano, disegnano, scrivono. E a volte combinano guai: è avvenuto di recente, quando i capitoli di Midnight Sun(che doveva raccontare la vicenda dal punto di vista di Edward) sono stati diffusi sul web, costringendo la scrittrice ad annullare il progetto. Un fandom da paura, è il caso di dirlo. «Io sono meravigliata, più che altro — racconta a Repubblica Stephenie Meyer —. Continuo ad essere sorpresa dall’entusiasmo che i lettori dimostrano verso i miei libri e i miei personaggi. Tuttavia, trovarsi di fronte a duemila fan urlanti è un’esperienza decisamente surreale e, sì, fa anche paura. Uno scrittore non è preparato a una cosa del genere: abitualmente siamo tipi solitari, e io sono molto più felice chiusa in una stanza tranquilla con il mio computer». Bersaglio numero uno dell’entusiasmo, Edward Cullen. Un metro e ottantasette. Capelli color bronzo. Legge il pensiero, adora la musica e le macchine veloci. Nasce nel 1901, muore diciassette anni dopo di febbre spagnola, rinascendo in forma vampiresca. Bello, galante, ricco: il principe azzurro degli anni Duemila? «Edward — dice Stephenie Meyer — è sicuramente il maggior punto di attrazione per il fandom. Ma credo che il suo fascino sia antico: Edward è un gentiluomo di vecchio stampo, qualità difficile da trovare di questi tempi. Certamente possiede bellezza e ricchezza, ma nessuno di questi aspetti conta realmente: anzi, sono entrambi difficili da accettare per Bella, che sarebbe più rassicurata nel rapporto con lui se Edward fosse meno spettacolare. Comunque sì: è un principe azzurro. Incarna l’ideale romantico perché ama Bella più di quanto ami se stesso: la felicità di lei è la sua priorità». Anche l’altra metà della coppia risponde in pieno alle caratteristiche del romanzo sentimentale da cui, erroneamente, le nuovissime generazioni si ritenevano immuni. Bella, o Isabelle Marie Swan, è goffa e timida all’inizio della storia, ma costruire la mitologia di Twilight. Penso di essere stata influenzata, semmai, dalle storie di supereroi. Per questo non mi sono preoccupata di lavorare sugli stereotipi del non-morto: Twilight è una storia fantastica e i personaggi sono come io li ho fatti. I Cullen sono vampiri, ma hanno scelto di controllare la loro indole nella maggior parte del tempo: ecco, mi piaceva l’idea di raccontare creature che vogliono essere qualcosa di meglio di un mostro». Ma perché proprio i vampiri? «Non li ho scelti io. Sono stati loro a scegliere me. Ho sognato un vampiro, e ho cominciato a scriverne: ma non so perché». Stephenie Meyer ha scritto anche di alieni, nel romanzo L’ospite. E la sensazione è che, dopo il punto di non ritorno costituito da Breaking Dawn, la sua strada di scrittrice possa conoscere una deviazione. Almeno per un po’: «Ci sono molte possibilità per libri futuri sui Cullen: tuttavia penso di aver bisogno di prendermi una pausa dai vampiri. In questo momento, non ho voglia di tornarci: esistono altre storie oltre a quelle dei non-morti. E io voglio raccontarle». I LIBRI Stessa copertina, stesso titolo dell’originale americano: a prima vista l’edizione italiana dei libri di Stephenie Meyer non si distingue da quella madre Dopo Twilight, New Moon ed Eclipse, l’editore Fazi manda in libreria il 30 ottobre Breaking Dawn (traduzione di Luca Fusari, 688 pagine, 19,50 euro), quarto e ultimo titolo della serie, di cui negli Usa in prima edizione sono state stampate quasi quattro milioni di copie Repubblica Nazionale DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 ANGELI E DEMONI Qui accanto, Bela Lugosi, storico Dracula cinematografico In basso, i poster del film Twilight. Nella pagina di sinistra: in alto, i libri di Stephenie Meyer e, in basso, una sua foto Scorre il veleno nelle mie vene STEPHENIE MEYER e avevamo discusso circa un milione di morti prima, io, Edward e Carlisle. Loro speravano che la giusta dose di sedativo bastasse a controllare il dolore del veleno. Carlisle ci aveva già provato con Emmett, ma il veleno aveva iniziato la sua opera prima del farmaco e gli aveva sigillato le vene. L’analgesico non aveva avuto tempo di diffondersi nel corpo. Sforzandomi di mantenere un’espressione tranquilla, avevo annuito e ringraziato la mia piccola buona stella per il fatto che Edward non potesse leggermi nel pensiero. Perché mi era già successo di assumere morfina e veleno insieme, e sapevo la verità. Sapevo che l’insensibilità causata dal farmaco era completamente irrilevante fintanto che il veleno mi scorreva nelle vene. Ma non mi ero mai azzardata a parlarne. Non volevo rafforzare la sua ritrosia a trasformarmi. Non avevo immaginato che la morfina avrebbe avuto quell’effetto, che mi avrebbe immobilizzata e imbavagliata. Paralizzata, mentre bruciavo. Conoscevo tutte le storie. Sapevo che Carlisle era rimasto abbastanza silenzioso da evitare che lo scoprissero mentre bruciava. Sapevo che, secondo Rosalie, urlare non era utile. E avevo sperato di comportarmi come Carlisle. Dovevo credere a Rosalie e tenere la bocca chiusa, perché sapevo che ogni urlo che mi fosse sfuggito dalle labbra sarebbe stato un tormento per Edward. Ora che il mio desiderio si stava avverando, sembrava uno scherzo spaventoso. Se non potevo urlare, come potevo implorarli di uccidermi? Non desideravo altro che morire. Non essere mai nata. La mia intera esistenza svaniva di fronte a quel dolore. Non valeva la pena di sopravvivere a un altro battito del cuore. Fatemi morire, fatemi morire, fatemi morire. E, per un intervallo infinito, non ci fu nient’altro. Solo la tortura incandescente e le mie grida mute che imploravano l’arrivo della morte. Nient’altro, neanche il tempo. Al suo posto l’infinito, senza inizio e senza fine. Un infinito momento di dolore. L’unico cambiamento giunse quando all’improvviso, incredibilmente, il dolore raddoppiò. La parte bassa del mio corpo, insensibile già prima della morfina, di colpo s’incendiò. Qualche giuntura rotta si era saldata grazie alle lingue di fuoco. L’incendio infuriava, interminabile. Passarono secondi o giorni, forse settimane o anni, ma a un certo punto il tempo tornò ad avere senso. Successero tre cose insieme, sovrapposte, tanto che non capii quale fosse la prima. Il tempo ricominciò a scorrere, l’effetto della morfina scomparve e riguadagnai le forze. Sentivo di riprendere il controllo sul mio corpo un passo alla volta, e ogni passo era il segno che il tempo si riattivava. Mi accorsi che ero in grado di contrarre le dita dei piedi e di stringere i pugni. Ne ero consapevole ma non volli farlo. L’intensità del fuoco non diminuì di un solo grado. Tuttavia, iniziai a percepirlo diversamente, con una sensibilità nuova che analizzava una per una le fiamme urticanti che mi riempivano le vene. E malgrado tutto, capii che potevo ricominciare a pensare. Ricordavo perché non potevo urlare. Ricordavo la ragione per cui mi ero impegnata a sopportare quell’agonia insopportabile. Ricordavo che, per quanto mi sembrasse impossibile, c’era qualcosa che valeva quella tortura. Questo accadde appena in tempo perché mi ci potessi aggrappare quando i pesi abbandonarono il mio corpo. Nessuno, dall’esterno, si sarebbe accorto del cambiamento. Ma per me che lottavo per trattenere le grida e i colpi chiusi nel mio corpo, dove non potevano far male a nessuno, era come passare dall’essere legata al rogo mentre bruciavo, ad afferrare il rogo per reggermi nel fuoco. Ero forte quel tanto che bastava per restare immobile a incenerirmi viva. Il mio udito si fece sempre più acuto: riuscivo a contare i battiti frenetici e accelerati del mio cuore che segnavano il tempo. I respiri corti che tossivo fra i denti. E quelli bassi, regolari, che venivano da qualcun altro al mio fianco. Erano più lenti e mi concentrai su di essi. Tramite loro, scandivo una quantità maggiore di tempo. Meglio di un pendolo, quei respiri mi spinsero, un secondo infuocato dopo l’altro, verso la fine. Divenni sempre più forte, con i pensieri più chiari. Riuscivo a udire ogni nuovo rumore. Ci furono passi leggeri, il mormorio e lo spostamento d’aria di una porta che si apriva. I passi si fecero più vicini e sentii una pressione nell’incavo del polso. Non avvertii il gelo delle mani. Il fuoco aveva cancellato ogni mia memoria del freddo. © 2008 by Stephenie Meyer Published by arrangement with Berla & Griffini Rights Agency N Vampiro gentiluomo Il Intitolato Twilight come il primo romanzo, il film tratto dalla serie di cui è autrice Stephenie Meyer è in arrivo nelle sale di tutto il mondo, con la promessa di sbancare il botteghino Uscirà il 21 novembre prossimo, ma un’anteprima di quindici minuti verrà proiettata il 30 ottobre a Roma durante il Festival internazionale del film Appena messi in vendita, gli 850 biglietti per l’evento sono andati esauriti in sole tre ore FOTO CORBIS Romantica e dark, la saga che appassiona le ragazze Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 “Il secolo del jazz”, una mostra che apre a novembre al Mart di Rovereto, racconta gli intrecci tra il genere musicale che ha dominato il Novecento e le altre forme d’arte: pittura, letteratura, fotografia, grafica. Una sezione raccoglie un centinaio di confezioni di dischi che mettono in evidenza il meglio di una collaborazione creativa durata una settantina d’anni: dal 1939 ai nostri giorni. Con firme del calibro di Dalí, Warhol, Pollock... SPETTACOLI i t t e M e t r a ’ l a n i t r e p o in c GINO CASTALDO i dice grafica di copertine e si pensa subito al rock, a quell’esplosione colorata che negli anni Sessanta disegnò un nuovo immaginario visivo a uso e consumo della rivoluzione giovanile. Quasi fosse la nascita della grafica musicale. Nulla di più falso. In realtà fu tutt’altro che un’invenzione del rock. Il jazz aveva già definito molto tempo prima uno straordinario universo visivo legato alle copertine dei dischi, l’aveva letteralmente inventato, dal nulla, trascinando con sé tutto il resto dell’industria musicale. È una delle storie, una delle più avvincenti e documentate, comprese nella grande mostra Il secolo del jazz in programma al Mart di Rovereto dal 15 novembre 2008 al 15 febbraio 2009. La mostra segue i percorsi del jazz in relazione alle altre arti, verso la pittura (con opere di Mondrian, Basquiat, Pollock), la letteratura, la fotografia, ma dedica una parte consistente alla storia della grafica, probabilmente la meno conosciuta, almeno in Europa, tra queste fitte e intense trame di relazioni tra linguaggi nate sotto la spinta immaginifica del jazz. La ricostruzione è allo stesso tempo meticolosa e scintillante. Sotto gli occhi del visitatore scorreranno decenni di sfrenata creatività, differenti tipologie, toni elevati e ingenue costruzioni artigianali, manipolazioni fotografiche e perfino, in alcuni casi, copertine firmate da autori famosi. Come quella di Salvador Dalí, o quelle di Andy Warhol. «Quello della grafica jazz è una arco di circa sessant’anni, di cui quaranta molto attivi, e a volte incontra il mondo dell’arte vero e proprio», racconta il curatore Daniel Soutif, «Andy Warhol, ad esempio, agli inizi della sua carriera venne chiamato dall’etichetta Blue Note e tra i suoi primi lavori ci sono una decina di copertine di jazz, debitamente firmate, come fossero quadri». Ma a quell’epoca eravamo già in piena esplosione creativa. La storia in realtà inizia molto prima, addirittura nel 1939. «Oggi la gente è talmente abituata a S a c i f a r G Jazz & pensare i dischi con una copertina ben definita graficamente, che è difficile rendersi conto che le copertine disegnate sono arrivate quasi quarant’anni dopo la nascita del disco. Prima erano semplici anonime buste, tombstones, pietre tombali, così le chiamavano gli anglosassoni. Il primo ad avere questa semplice ma efficacissima idea fu un grafico di ventitré anni, Alex Steinweiss. Chiamato dalla Columbia nel 1939 intuì subito che una confezione più seducente poteva aggiungere qualcosa al prodotto musicale e così disegnò la prima copertina in assoluto. Era un disco di canzoni, Smash Song Hits by Rodgers & Hart, ovviamente un 78 giri. Non era proprio un disco jazz, ma quasi, nel senso che quelle canzoni erano poi il cibo quotidiano dei jazzisti. È stato un evento commerciale, e da quel momento è stato immediatamente chiaro che il disco doveva avere una copertina disegnata». Dopo quella prima copertina fu un vero diluvio, rapi- PIONIERE L’immagine grande è di Alex Steinweiss, il primo art director della Columbia Records e inventore delle copertine illustrate Repubblica Nazionale DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 ART&SOUND Le illustrazioni di queste pagine sono tratte dalla mostra Il secolo del jazz. Sono tutte di artisti famosi Per esempio, in prima fila la prima a sinistra è di Salvador Dalì; l’ultima di Ben Thompson; in seconda fila, la prima e la quinta da sinistra sono foto di Lee Friedlander, la penultima è di Andy Warhol; di Jim Flora sono la terza e quarta in prima fila e la prima e la sesta in terza fila damente tutte le etichette si attrezzarono e l’abbinamento divenne ovvio, scontato, immancabile. Riguardò tutti i generi ma il jazz ha mantenuto sempre un netto primato. Erano i dischi che suggerivano più creatività, che invitavano a sperimentare con inedita libertà ogni possibile soluzione cromatica, grafica e pittorica, incluso l’uso della fotografia, spesso anche quelle firmate da grandi fotografi. «Non c’è dubbio», continua Soutif, «che il mondo della grafica sia stato molto coinvolto nel mondo del jazz. Lo stesso Steinweiss disegnò qualcosa come settecentocinquanta copertine di jazz. Era alto artigianato, che coinvolgeva le più sofisticate tecniche tipografiche. Dopo la guerra, quando nasce il 33 giri, arrivarono migliaia di copertine con un’inventiva straordinaria, e tutti i grandi grafici prima o poi furono coinvolti. Ma ancora prima c’è una dimensione del tutto dimenticata ma non meno appassionante, che è la grafica delle partiture, che andò avanti dalla fine dell’Ottocento agli anni Quaranta del Novecento, un vero e proprio mondo, geniale, con grafiche moderniste, spesso create da autori rimasti anonimi». Inutile dire che l’abbinamento tra grafica e jazz ha prodotto vere e proprie scuole, differenti tipologie spesso legate allo stile musicale che le coperti- ne dovevano illustrare. Il cool jazz ispirava disegni concettuali e astratti, l’hard bop colori forti. Il caso del free jazz è esemplare. «In generale si può dire che i rimandi sono reciproci. La pittura americana degli anni Cinquanta è molto jazzistica, Pollock ascoltava jazz, in fondo le sue erano improvvisazioni quasi corporee, e quando Ornette Coleman incise il disco Free jazz venne naturale scegliere per la copertina un quadro di Pollock. Lì cominciavano gli anni Sessanta, ma anche dopo l’esplosione del rock, il free jazz ispirò una grafica per alcuni versi più interessante, anche perché si tornò alla ricerca di un certo artigianato elevato, e così accadde anche nel jazz europeo di quegli anni. Diciamo che erano copertine più artistiche». Il catalogo, ricchissimo, divide per autori e per generi l’immenso repertorio. A volte a prevalere sulla grafica è l’uso della fotografia. «Molti non lo sanno, ma collezionando dischi jazz hanno anche collezionato fotografie importanti. È il caso di Lee Friedlander, una star del mondo della fotografia che a un certo punto si dedicò al jazz: ci sono molte sue foto nelle copertine, in particolar modo in quelle della Atlantic record, spesso anche trattate o maltrattate dai grafici, a volte usate nella totale purezza del segno fotografico. Poi ci sono casi eccezionali, vissuti a margine LA MOSTRA Il tema della mostra Il secolo del jazz, in programma al Mart di Rovereto dal 15 novembre 2008 al 15 febbraio 2009, è la relazione tra arte e musica, seguendo l’evoluzione storica del jazz. In esposizione quadri, fotografie, suggestioni letterarie e una sezione interamente dedicata alla grafica, dalla quale sono tratte le immagini di queste pagine dell’evento jazzistico. Uno dei più celebri è quello di Langston Hugues e Roy DeCarava. Nei primi anni Cinquanta Hugues era già uno scrittore affermato e Roy DeCarava, uno dei maggiori fotografi del secolo, era ancora sconosciuto. Al suo esordio ottenne una borsa di studio dal Guggenheim e per due anni si mise a fotografare scene del quartiere nero di Harlem. Alla fine non sapeva cosa fare e allora inviò le foto a Hugues, il quale gli rispose che ci avrebbe fatto un libro a patto che potesse usare le foto come gli pareva, costruendo storie di sua invenzione. DeCarava accettò immediatamente e il libro che ne venne fuori, The Sweet Flypaper of Life, oggi è uno dei libri mitici, più ricercati nel mondo della fotografia. Questo è un esempio di stile jazz applicato ad altre cose. Poi lo stesso DeCarava ha realizzato una copertina per il disco del pianista Kenny Drew. Ma le suggestioni di queste trame arrivano fino ai giorni nostri. Verso la fine della mostra c’è una delle opere più importanti degli ultimi dieci anni, ovvero la fotografia di Jeff Wall ispirata al romanzo L’uomo invisibile di Ralph Ellison. Wall è una delle stelle dell’arte contemporanea ma, quando mostrò nel 2002 questa foto, il pubblico non capì molto il significato dell’immagine. In realtà era ispirata al prologo del romanzo e, se si guarda bene, al centro esatto della foto c’è un vecchio giradischi, e questo allude al pezzo che il protagonista del libro ascolta, che è Black and Blue, cantata da Louis Armstrong». A scartabellare nel catalogo si trova la copertina che Pistoletto disegnò per un disco di Enrico Rava, altre opere di Altan e di Crepax (che si dedicò appassio- natamente alla creazione di copertine jazz), si passa dai toni alti delle copertine firmate da artisti o fotografi famosi alla ingenuità quasi naif delle copertine di Sun Ra, costruite in famiglia, in un esempio di autogestione creativa che però era perfettamente funzionale al significato della musica che illustrava. «Forse è arrivato il momento di considerare la grafica della musica nell’ambito più generale della storia dell’arte e della grafica», conclude Soutif. «E in ogni caso, quando si racconta questa storia, di solito il punto di vista è strettamente europeo, non si capisce come l’hanno vista gli intellettuali americani, in special modo quelli neri. Ci si dimentica che ci fu un movimento chiamato Harlem Renaissance, in cui entrava il jazz ma c’erano anche la letteratura, la pittura, la fotografia. Da questo punto di vista la mostra ha l’ambizione di mostrare molte cose su artisti che in America sono studiati ma che in Europa non sono conosciuti. A dirla tutta, nessuno conosce bene questa storia, ed è strano perché ormai in America ci sono libri, studi, questo materiale è ormai ampiamente storicizzato, però più approfondisci più scopri che è una miniera inesauribile, ci sono molti nomi conosciuti ma anche tanti sconosciuti di cui si è persa ogni traccia. Questo si deve a una distorsione culturale, ovvero al fatto che l’Europa ha mantenuto a lungo la convinzione di essere stata lei a scoprire il jazz come cultura, mentre per gli americani era solo intrattenimento, e invece è esattamente il contrario, questo lavoro di storicizzazione è cominciato molto tempo fa e ora dobbiamo trarne le giuste conclusioni». Tema in classe: “Il freddo” Con vitamine e minerali le difese di tuo figlio rispondono correttamente Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 i sapori Un doppio appuntamento per amanti del “giusto, pulito e sano” a Torino. Prodotti da tutto il pianeta, dal Tibet all’Amazzonia, al Marocco, all’Etiopia, che si incrociano con il meglio della gastronomia italiana. Per scoprire che il cibo e la cura nel coltivarlo e metterlo in tavola uniscono gli uomini 1 1 Brasile RISO ROSSO DELLA VALLE DEL PIANCÒ Nello stato semi-arido del Paraíba resiste la coltivazione del gustoso riso rosso integrale, di cui a inizio Settecento i portoghesi avevano vietato la produzione, ritenendolo di poco valore 2 3 2 Francia FORMAGGI DI MALGA DEL BÉARN Il trionfo delle produzioni a latte crudo, lavorate sugli alpeggi dei Pirenei francesi. Le suadenti tome miste a pasta pressata vengono poi stagionate per quattro mesi nelle grotte Assaggiare il mondo 5 MIELE D’ERICA DI WENCHI All’interno del parco che si apre sui pascoli a sud di Addis Abeba, la cooperativa Weta produce un originale miele di erica, color arancio carico, profumo e gusto intensi LICIA GRANELLO envenuti alla tavola di Madre Terra. Quattro giorni è un tempo risicato per organizzare una gita. Ma se non lo farete, perderete l’appuntamento alimentare più originale, grandioso, commovente del biennio che verrà. Ogni due anni, infatti, Salone del Gusto e Terra Madre, sempre più intersecati e interdipendenti, irrompono nel quieto tran tran della città provinciale più metropolitana d’Italia, per regalarle cinque giorni di frenesia etico-gustativa, una sorta di gigantesco frullatore di sentimenti e golosità, che tutto trasfigura, rallegra, ridisegna. Difficile da raccontare, facile da vivere. Basta varcare i saloni del Lingotto e non fermarsi prima di essere esausti. Tanto, le pause rigeneratrici non mancano, che sostiate allo stand dei produttori di nettare delle api Canuto in Amazzonia o a quello dei monaci tibetani che lavorano il latte di yak. Così da godere del cibo e, insieme, imparare un pezzetto di eco-gastronomia applicata. Questa è la grande scommessa vinta dai boys di Carlin Petrini: aver dimostrato che due rette parallele possono incontrarsi ben prima dell’infinito. Giorno dopo giorno, dall’inaugurazione alla chiusura, decine di migliaia di visitatori hanno la chance di scoprire un’incredibile quantità di frammenti del pianeta-cibo, e di farli propri. In una sorta di circolo vir- B Etiopia 6 Mali SOMÈ DEI DOGON Fiori, frutti e foglie degli orti familiari vengono trasformati in condimenti per insaporire zuppe, carni e verdure: kamà (acetosella), gangadjou (gombo) e oroupounnà (foglie di baobab) Terra Madre 3 Spagna EXTRAVERGINE DI OLIVI MILLENARI DEL MAESTRAT È datato solo cinque anni il commercio dell’olio ottenuto a freddo dalle olive di queste meravigliose sculture viventi assiepate nella comarca del Maestrat, in terra valenciana 4 Svizzera KIRSCH BRENZERKIRSCH È= il nome delle antiche varietà di ciliegi che accompagnano il paesaggio dei cantoni di Basilea e Lucerna I frutti, dolci e neri, sono pressati e distillati subito dopo la raccolta tuoso, si assaggia un cibo che conosciamo poco o che non conosciamo affatto. Ci attira, lo gustiamo, ci piace (poco o tanto). Ma soprattutto, con una sola domanda, un cenno, un commento felicemente stupito, sveliamo gli incanti delle storie, delle facce, delle lontananze che diventano fratellanze, abbattendo con un solo morso barriere e pregiudizi. I cibi e chi li rappresenta raccontano tutto questo. Nel corridoio che unisce le due parti della manifestazione, i Mercati della Terra dimostrano che la rete di piccoli produttori locali — qualità accertata, filiera corta, giusto reddito, basso impatto ambientale — funziona da una parte all’altra del mondo. Le sorprese vi stordiranno. Mai assaggiato i datteri dell’oasi di Siwa? Trecentomila palme prosperano in una striscia di terra benedetta dall’acqua nel deserto egiziano che confina con la Libia. I loro frutti sono soavi, profumati, dolcissimi. Peccato che la produzione non soddisfi le quantità imposte del mercato. Farle conoscere al grande pubblico significa salvarle dall’abbandono e dall’estinzione. Oppure il riso rosso del Madagascar, incrociato tra il bianco giapponese e il selvatico autoctono: a perpetuarne la coltivazione, è la cooperativa che si occupa del parco di Andasibe. Salvaguardarla, vuole dire proteggere dalla speculazione il più lungo corridoio di foresta primaria intatta del Paese. E ancora, il lavoro delle donne. Quelle marocchine, che spaccano una a una le bacche di Argan, per ricavarne i semi da cui ottenere un olio speziato e prezioso, o raccolgono i fiori di zafferano dell’altopiano di Taliouine e li seccano nei cortili delle case. Quelle mauritane, che estraggono le sacche ovariche dai muggini e le trasformano in bottarga. A loro la Maison della Nocciola Igp del Piemonte e lo chef Davide Scabin dedicheranno una splendida cena di solidarietà. A dimostrazione di come si può facilmente chiudere il cerchio delle produzioni agricole, Lavazza presenterà la nuova puntata del progetto “Tierra!”, una nuova tecnica per riciclare i fondi di caffè come fertilizzanti naturali nella coltivazione dei funghi. Il resto, che è tanto, tantissimo, dovrete scoprirlo da voi. Ricordate solamente di fare spazio in frigorifero e dispensa prima di partire. I cibi del mondo aspettano solo di venire ad allietare le vostre cene: buone, pulite e giuste. 7 Uzbekistan MANDORLE DI BOSTANLYK È il paradiso delle mandorle la valle di Tchatkal: all’interno di un incredibile bosco ancora poco esplorato finora ne sono state individuate cinquanta varietà, tra dolci e amare 8 Afghanistan UVETTA ABJOSH DI HERAT Da oltre cinque secoli in tutta la provincia si produce uvetta di altissima qualità, a partire da viti affondate in trincee profonde due metri Ventisette le tipologie selezionate Repubblica Nazionale DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 4 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 5 6 7 8 I segreti del miele sotto il vulcano CARLO PETRINI l presidio Slow Food difende un prodotto: esotico, sicuramente debole, ma in grado di conquistare al primo assaggio. Al Salone del Gustosi avrà riprova di tutto questo. Ma un Presidio difende soprattutto le condizioni ambientali necessarie affinché quel prodotto possa trasmettere, una volta in bocca — o anche soltanto ben raccontato — tutta la sua carica di gusto e cultura. Un Presidio dunque difende gli uomini e le donne che sanno fare quel particolare alimento, le loro conoscenze, il territorio in cui vivono, le delicate economie locali in cui si è sedimentato nel tempo, nel rispetto degli ecosistemi e dando chance importanti alle comunità. Il presidio va visto al di là dell’eccellenza gastronomica che può comunicare e che al Salone del Gustosarà sicuramente in vetrina: esso rappresenta la nuova gastronomia che non si limita al gusto organolettico, è il gusto di una rinascita della cultura — in gran parte contadina — che sa produrre un sistema virtuoso per la terra. È la cultura di cui sono portatori i rappresentanti delle comunità di Terra Madre, molto diversi tra loro, provenienti da ogni parte del pianeta, ma accomunati da questa sensibilità per la natura e l’armonia delle cose con gli uomini. Ogni prodotto delle comunità di Terra Madre — anche il più semplice e povero, sfama la comunità e rispetta la biodiversità: è come un Presidio; di economia locale e reale, di civiltà contadina, di valori non più tanto presenti nella nostra società italiana; come lo scambio, la memoria, il rispetto e la pace. Le comunità del cibo (anche quelle dell’urbanizzato Nord Italia o degli opulenti Stati Uniti) hanno una strada tracciata da seguire: produrre il cibo come hanno sempre fatto, all’interno di un sistema virtuoso e locale. Niente viaggi intercontinentali, futuressulle commodities alimentari, sprechi (dal campo al cassonetto sul retro del supermarket); niente avvelenamenti del suolo né alienazione da cemento. Nelle vallate pirenaiche dell’Aquitania come in Tabasco, Messico, c’è il segreto per ricostruire il sistema del cibo nel mondo, partendo dai singoli luoghi, da ciò che le comunità di contadini, pescatori, nomadi e piccoli artigiani fanno I ‘‘ L’agricoltura è non solo la più antica ma anche la più importante attività umana È la base della cultura e della civiltà stessa CARLO D’INGHILTERRA itinerari dove dormire dove mangiare dove comprare TERRES D’AVENTURES SUITE LA BARRIQUE Via S. Maria 1 Tel. 340-7014125 Camera doppia da 100 euro, colazione inclusa Corso Dante 53 Tel. 011-657900 Chiuso domenica e lunedì, menù da 65 euro IPERMERCATO EATALY (CON PUNTI FOOD E RISTORANTE) LA DIMORA DI SARA LOCANDA MONGRENO Via Sant’Anselmo 8 Tel. 339-3219801 Camera doppia da 100 euro, colazione inclusa Strada Comunale Mongreno 50 Tel. 011-8980417 Chiuso lunedì, menù da 65 euro HOTEL DE CHARME DOLCE STIL NOVO ALLA REGGIA Via Nizza 230 Tel. 011-19506811 GASTRONOMIA BAUDRACCO Appuntamento a Torino a partire da giovedì prossimo fino a lunedì 27 Per la prima volta i percorsi del Salone del Gusto e di Terra Madre si incrociano tra il Lingotto e l’Oval, tra presìdi, stand, convegni, dibattiti, laboratori Saluzzo Paesana 1718 Via del Carmine 1 Tel. 011-440722 Camera doppia da 104 euro, colazione inclusa Piazza della Repubblica 4 Venaria Tel. 011-4992343 EMPORIO GOURMAND PAISSA Piazza San Carlo 196 Tel. 011-5628364 PASTICCERIA DOLCE&SALATA ELSY Via Fratelli Carle 46/F Tel. 011-5817880 LATTERIA GELATERIA TESTA LA CREDENZA B&B VIA DELLA ROCCA Corso Vittorio Emanuele ll 62 Tel. 011-545582 Via della Rocca 10 Tel. 348-8829485 Camera doppia da 95 euro, colazione inclusa Via Cavour 22 San Maurizio Canavese Tel. 011-9278014 Chiuso martedì e mercoledì, menù da 60 euro A CASA DI GRIFFI FLORIS HOUSE Via Cordero di Pamparato, 7 Tel. 011-19711240 Camera doppia da 80 euro, colazione inclusa Via Cavour 16 Palazzo Marenco Tel. 011-8126909 Corso Re Umberto I 56 Tel. 011-599775 PANE, GRISSINI&BISCOTTI IL FORNAIO Via San Massimo 49 Tel. 011-884667 VINI&CHAMPAGNE ENOTECA DEL BORGO da secoli: economia locale. Il loro stile dovrebbe essere lo stile di tutti, anche delle industrie alimentari più globalizzate e globalizzanti. Tutto ciò lo si vede ancora in molte regioni italiane, ma in tanti paesi del mondo, almeno quanti sono quelli da cui provengono le comunità del cibo di Terra Madre, centocinquantatré. Tra tutte, ho avuto la fortuna di vedere l’esperienza di Wenchi, nella regione Oromia, a non molti chilometri da Addis Abeba, in Etiopia. Gli abitanti di questo villaggio situato sulle pendici di un monte vulcanico, nel cui cratere c’è oggi un lago, fanno sì un miele strepitoso, ma sono anche e soprattutto il Presidio del loro territorio e della loro felicità. Vivono in decorose capanne, mantengono tutto pulito e ordinato: non ho visto rifiuti di nessun tipo. Ci tengono all’accoglienza e sono rimasto esterrefatto quando mi hanno salutato con le chioccioline di Slow Food appuntate al bavero delle loro giacche da festa, lise. Gli erano state regalate da qualcuno durante la scorsa edizione di Terra Madre, nel 2006. Ti accompagnano volentieri con dei piccoli cavalli ad ammirare dall’alto lo spettacolo del lago e poi ti offrono, dispensando sorrisi, insegnandoti i loro canti e balli, un pasto eccellente in una piccola costruzione che è il ritrovo del paese, il luogo della socialità. Alimenti semplici e poveri, un po’ di preparazioni di carne e intingoli da consumare con le mani, servendosi dell’injera, un pane piatto, spugnoso e acidulo, ricavato con il teff, il cereale etiope: tutto degno di un’ottima cucina da ristorante, come ho potuto poi constatare nei migliori locali della capitale etiope. Ecco, a me piace pensare che dietro al loro miele ci sia tutto questo: il loro orgoglio, la loro capacità di produrre, il loro attaccamento al luogo in cui vivono, che rispettano e conservano. E mi piace pensare che tutto questo, con diversi colori, climi, facce, colonne sonore, c’è dietro a ogni prodotto di ogni comunità di Terra Madre, anche se non l’ho mai assaggiato, non l’ho mai visto, non ne conosco le caratteristiche e neanche ne immagino l’esistenza. Le comunità di Terra Madre sono 1.678 e non si può conoscerle tutte, e nel mondo ce ne saranno ancora molte altre che producono e vivono il territorio con questo stile, che ha i piedi per terra, la memoria del passato e la testa nel futuro. Via Monferrato 4 Tel. 011 -8190461 Repubblica Nazionale DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 le tendenze Materiali di moda LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 Motivi floreali, geometrici, optical; colori scintillanti; contaminazioni tra liscio e ruvido, lucido e opaco; travestimenti perfetti a simulare stoffa, pelle, legno Nel settore delle piastrelle il made in Italy resta leader quanto a qualità e innovazione, e in tempi di crisi la ricetta è sempre quella: stupire con gli effetti speciali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. DAL MAROCCO 6. LUSSO IN BAGNO Ait Manos brevetta lastre pre-assemblate di zillji, tessere di mosaico sagomate e tagliate a mano secondo antiche tradizioni marocchine In Italia sono distribuite in esclusiva da Vicano Pareti scintillanti con la collezione Le Murrine Gold di Ceramiche Settecento Le tessere, impreziosite dall’oro, sono in tre intensità e quattro colori, da combinare a piacere 2. ROSA RASHID 7. COME SETA La serie R+evolution trasferisce sulle superfici delle ceramiche colori, texture e grafismi che riflettono il tratto del designer Karim Rashid Di Ceramiche Refin Si chiamano Le vie della Seta le piastrelle in ceramica che citano nei cromatismi l’effetto delle pieghe del prezioso tessuto. Lavorate e decorate a mano, di Pecchioli L’importante è esagerare 3. DETTAGLI PREZIOSI Per il bagno, Cerim Ceramiche sperimenta con Le preziose l’accostamento tra ceramica e pietre, per superfici luminescenti e iperdecorate 4. DI CARATTERE Sfondo rosa e delicati decori per la linea Kilim di Naxos Ceramiche La fascia Kasmir, in particolare, ha decorazione con motivi floreali 5. TESSERE FLOREALI Particolari, con la loro forma floreale, le tessere in vetro Murano del mosaico Petit Flower di Sicis. Disponibili in quindici colori, nella combinazione cromatica desiderata AURELIO MAGISTÀ iori, decori, motivi grafici e inganni optical, swarovski, tatuaggi, mimetismi con materiali di affine freddezza come il marmo e la pietra, o all’opposto caldi come il legno e perfino la pelle e il tessuto. L’incredulità è legittima. In tanti si avvicinano e la toccano: è davvero ceramica? Sì, è davvero ceramica. Perché il made in Italy, assediato dai paesi emergenti, prima ovviamente la Cina, fa quello che fanno da sempre gli assediati: si rifugia più in alto, dove il nemico non può arrivare. O almeno dovrà metterci tempo e fatica. In questo caso per salire più in alto chiede l’aiuto del design e della moda. È una corsa che dura da qualche anno. Ogni balzo in avanti viene presto imitato. E ogni balzo ha caratteri un po’ diversi. L’innovazione e la biocompatibilità hanno segnato gli ultimi cicli: con piastrelle che integrano led luminosi per effetti sorprendenti ma anche per l’utile funzione di segnare di notte i percorsi all’aperto; o rettangoli ceramici lunghi fino a tre metri e spessi tre millimetri grazie all’estrusione, tecnica che “spreme” il materiale come il dentifricio dal tubetto; o, ancora, piastrelle che assorbono l’anidride carbonica o hanno virtù antibatteriche. F Quest’anno, come ha decretato il Cersaie, il salone bolognese della ceramica che rappresenta il punto di riferimento mondiale (perché l’Italia non è più leader per quantità, ma lo resta per la continua ricerca che la incorona trendsetter), è il momento degli esercizi di stile. Gioca la sua parte la congiuntura: sembra che nei tempi di crisi le forme (gli abiti, gli arredi, le automobili) interpretino una funzione consolatoria con colori vivaci, curve morbide e sinuose, iperdecorativismo e poesia. Forse non è proprio una legge, ma in questo caso funziona alla perfezione. I motivi floreali tornano ossessivamente, e perdura il revival anni Settanta: si osservano motivi geometrici con effetti optical, ma anche mix cromatici, potremmo dire, alla Emilio Pucci. In generale, si ricercano gli effetti sorprendenti e magici, le contaminazioni fra opposti: liscio e ruvido, lucido e opaco, freddo e caldo. Lea ceramiche, per esempio, propone Makò, che inganna la vista e il tatto fingendosi lino o cotone, oppure Streets, una maglia geometrica di linee lucide che si incrociano su una base opaca, chiara citazione di una mappa cittadina. Ragno punta con Hi-Line sui toni cangianti e scintillanti, come in certi rossetti e hi-liner di stagione. Al- falux trapunta le sue piastrelle Glitter con cristalli swarowski. Sicis conduce alle estreme conseguenze l’arte del mosaico, componendo grandi figure umane in un bianco e nero in controtendenza, che tuttavia richiama un lusso da corte ravennate o bizantina. Refin, per DesignTaleStudio, crea la collezione R+volution affidandosi alle idee del designer Karim Rashid. E se la grande firma del design non è certo una novità (per verificarlo basta fare un giro all’archivio storico del quartier generale di Confindustria Ceramica, a Sassuolo), interessante è l’esito; un “design poetico”, come lo definisce Rashid, che sceglie pennellate lucide, anche con effetti naturalistici (fiori, foglie) su superfici opache. Alle estreme conseguenze arriva il mimetismo che stava già affermandosi lo scorso anno: le ceramiche che imitano alla perfezione venature e trama del legno sono ormai un’ovvietà, e la mimesi della pelle, con un passaggio surreale, giunge a proporre vera pelle montata su supporto in gres, liscia oppure decorata con trame fantasiose. L’idea è del gruppo Priante e funziona da perfetto epilogo: va bene essere creativi per conservare la supremazia, ma attenti a non esagerare. 8. MAPPE URBANE Street di Lea Ceramiche è la reinterpretazione su ceramica del groviglio di strade di una mappa urbana (a scelta tra Kyoto, Melbourne, Tangeri), ottenuta con smalto bianco 9. ARTIGIANALI Sono il risultato di un lungo processo di lavorazione artigianale le tessere del mosaico Pecchioli, che riscoprono l’iper-decor grazie ai loro motivi floreali blu e oro 10. EFFETTO OPTICAL Grandi bolli in gres porcellanato a impasto decorato per la serie New York di Marazzi La sovrapposizione di segni e trame la rende esteticamente simile a una carta da parati Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 l’incontro Splendidi quarantenni Per una vita è stato solo due cose: il figlio di Vittorio e un bel ragazzo Poi “Caos calmo”, il grande pubblico che si accorge di lui e del suo talento.Adesso si racconta: il rapporto col padre, l’amore per il teatro, la lotta con l’ansia, la famiglia: “Sono fidanzato da quindici anni, sposato da dieci e sapere che posso tornare da mia moglie e mio figlio è la sola certezza che ho” FOTO OLYCOM Alessandro Gassman P ROMA er alcuni attori il successo arriva al primo film. Un’esplosione improvvisa che li trascina nell’Olimpo e poi, costantemente, li fa vivere nel terrore di ricadere nell’anonimato. Un’ansia maledetta che prende alla gola e può rovinare l’esistenza. Ad Alessandro Gassman è successo l’opposto. Per una vita è stato solo due cose: il figlio di Vittorio Gassman e un bel ragazzo. Bello di una bellezza singolare, quel tipo di fascino che le donne sognano e gli uomini invidiano. Occhi carbone e un metro e novanta di flessuosa longitudine. In realtà era anche bravo, ma di una bravura cresciuta in piccoli teatri di provincia, di ruoli nelle retrovie oscurati dalle foto per un calendario di cui ancora si pente. Poi, quasi per caso, è arrivato il film Caos calmo, tratto dal libro di Sandro Veronesi. Non si aspettava molto, se non l’opportunità di lavorare con Nanni Moretti. Il ruolo era quello scomodo di non protagonista, del secondo dietro al gigante. E invece gli è cambiata la vita. Il grande pubblico, non solo quello dei teatrini polverosi, si è innamorato di lui. Gli ha riconosciuto il talento e, soprattutto, l’umanità. Con novanta minuti di proiezione ha cancellato l’immagine del figlio d’arte privilegiato e inevitabilmente antipatico. Con Caos Calmo Alessandro Gassman è nato una seconda volta: vero, naturale, semplice. Come è nella realtà, quando si aggira in felpa verde e jeans per la casa che ha comprato dieci anni fa appena è nato il figlio Leo. «Eravamo troppo stretti nel mio buco di Trastevere e ci siamo trasferiti», spiega sorridendo tra una sigaretta e l’altra, gli occhi cinesi che si stringono, «sono contento perché abbiamo saputo scegliere un quartiere autentico, mio figlio va a piedi alla scuola pubblica, noi giriamo in motorino». E in effetti qui, in questo angolo di Roma dietro piazza Navona, la domenica mattina tutto sembra sorprendentemente normale: per le scale odore di pasta al ragù, nel portone biciclette e passeggini, in lontananza il rintocco delle campane. Anche casa Gassman è normale: divani di pelle e tante foto. Una cucina spaziosa, l’aria vissuta e felice. «In realtà felice per quel che mi riguarda è una parola impegnativa, diciamo che sono molto attivo, ho tanti programmi e la consapevolezza di essere uno che ha avuto un gran culo». Neanche troppo vera questa storia del culo. Anzi. Questi primi quarantatré anni, per lui, non sono statati sempre allegri. «Dai quattordici ai quindici anni sono cresciuto di venti centimetri, ero altissimo, fuori misura nel corpo e nella mente, mi sentivo diverso e aggressivo, un vero freack». Poi è arrivata la boxe, un modo per scaricare il negativo e farsi del bene. Pugni e sudore. Rabbia e riscatto. «Mi ha convinto mio padre spingendomi ad andare in palestra perché aveva capito che ero una mina inesplosa, un potenziale pericolo». Dopo la boxe, e gli studi terminati senza troppa passione, è arrivata la decisione di fare l’attore. «Ho sempre dichiarato onestamente di aver provato a recitare solo perché mi chiamavo Gassman, altrimenti avrei tentato la strada del perito agrario. Per fortuna nel mio primo spettacolo temevo talmente tanto di fare la figura del bamboccione, di quello che non si è guadagnato niente, che ho dato il meglio e il pubblico mi ha apprezzato». Un’altra cosa lo ha salvato: la voglia d’indipendenza. «Avere soldi miei è sempre stato importante, non sopporto di essere di peso per nessuno, neanche di andare ospite in casa di amici, se m’invitano mi prenoto l’albergo più vicino». Certo, non è facile essere indipendenti se tuo padre è Vittorio Gassman. «Nella realtà era l’opposto dei suoi personaggi fanfaroni e sopra le righe, un uomo timido e molto riservato, assolutamente silenzioso. Una volta abbiamo fatto un viaggio in macchina da Roma a Milano senza dire una sola parola. Il risultato è che da quando è morto la cosa che mi manca di più sono i suoi silenzi». Un’eredità preziosa. Non a caso il drammaturgo spagnolo Lope de Vega diceva che, se fosse stato re, avrebbe istituito una cattedra per insegnare a tacere. «Io riesco a rivivere quei mutismi pieni di armonia solo con mia moglie Sabrina, amiamo entrambi la natura e ci siamo comprati una piccola casa in Austria dove camminiamo per ore senza dire nulla». Il silenzio di Vittorio Gassman non era però solo dovuto al carattere schivo. Era il risultato di una natura difficile, devastata da continui sbalzi di umore. Di quella tristezza opaca che trascina in un vortice senza via d’uscita. «Quando mio padre era depresso era terribile per sé e per tutta la famiglia. Una volta in tournée stava così giù che, contro la sua disperata volontà, ho dovuto costringerlo a fermarsi e tornare a casa perché era impossibile continuare. Mi sono sentito malissimo». Nei giorni di serenità, invece, aveva il grande dono dell’ironia. Sapeva ridere della sua malattia. «Il suo compagno di lamentele preferito era Ugo Tognazzi, altro gran depresso. Discutevano di continuo su chi era il più ango- Se sono felice? Per me è una parola impegnativa ‘‘Jazz & wine Diciamo che sono molto attivo e ho tanti programmi of peace sciato e poi si facevano delle gran risate». Alessandro in questo non ha ripreso da suo padre. Ha una natura solare. Però ha avuto anche lui i suoi tormenti. «Pensavo che non sarei mai andato in analisi ma poi, un giorno, ero a Torino per uno spettacolo e mi è venuto il primo attacco di panico: inaspettato, crudele, devastante e allora sono finito dall’analista». È iniziato un percorso doloroso, durato qualche anno, e intriso di quella sensazione indefinita che conosce solo chi gli attacchi di panico li ha vissuti: «Vivevo nella paura che mi potesse tornare quella paura, i medici la chiamano ansia anticipatoria. Giravo con il Lexotan in tasca e ho provato di tutto: analisi junghiana, transazionale e, soprattutto, tante medicine». Il risultato? «Decisamente sto meglio. Comunque, il miglior medico che conosco è Carlo Verdone. Un mago della chimica, in grado di dosare il Lexotan come nessun altro». Se il cinema si è accorto di Alessandro Gassman quando era già uno “splendido quarantenne”, con il teatro è stata tutta un’altra storia. «Nel palcoscenico ti premia il rigore e io per fortuna ne ho tantissimo, forse per reazione a questa società pressappochista. Ogni sera bisogna essere perfetti e lo stimolo continuo è il pubblico che ti chiede sempre di più di quello che potresti dare». Per alcune commedie Gassman è anche regista. «È quello che mi piace di più, anche quando recito guardo gli altri attori e vorrei dare suggerimenti. Spero un giorno di avere la possibilità di dirigere e basta. Sono bravissimo soprattutto nel gestire i provini perché li ho sempre odiati, intuisco quel terrore che può condizionare e far sbagliare tutto e tranquillizzo gli attori». Il peggiore provino della sua vita è stato proprio quello per il miglior film: Caos calmo. «Ho sempre considerato Nanni Moretti un mito, conoscevo tutti i suoi film a memoria e avevo il terrore di rimanere deluso e soprattutto di deluderlo». Invece è andata bene, la strana coppia ha funzionato sul set e anche fuori. «Quando giravamo insieme tutti mi chiedevano l’autografo, Nanni si stupiva e io gli rispondevo che ero più ‘08 famoso di lui solo perché avevo fatto un calendario». Un errore, quello di mettersi in posa per dodici mesi seminudo nelle spiagge messicane, in cui è scivolato sempre per quel maledetto desiderio d’indipendenza economica. Quando ne parla, anche se cerca di riderci sopra, gli occhi si stringono di più e diventano fessure: «Non lo rifarei mai». Ultimamente è spesso all’Aquila dove ha fatto una scelta coraggiosa: la direzione del Teatro Stabile. «Abbiamo in programma uno spettacolo, Le invisibili, scritto da Lidia Ravera sulla violenza alle donne pakistane acidificate, un delitto mostruoso e ancora senza una pena. Poi ci sarà uno spettacolo che, partendo dalla realtà dei portoricani a New York, affronta la condizione dei romeni a Roma». Durante il mese di novembre, invece, sarà la volta di Milano con La parola ai giuratial teatro Manzoni. Nel suo modo di lavorare c’è molto del rigore di Vittorio. Adesso più di prima. «Ho cominciato ad assomigliare a mio padre dopo che è morto, è come se la sua anima mi avesse posseduto». In una cosa però sono diversissimi: «Lui viveva per lavorare, io lavoro per pagarmi le vacanze». Ma, soprattutto, per godersi la famiglia. Uno come lui, che avrebbe potuto avere mille donne, ha sempre scelto la fedeltà senza rimpianti. «Sono fidanzato da quindici anni e sposato da dieci e sapere che posso tornare da mia moglie e mio figlio è la sola certezza della mia esistenza. Come padre sono molto giocoso, ludico, purtroppo mi manca la pazienza ma supplisce Sabrina». ‘‘ IRENE MARIA SCALISE Cormòns 23-24-25-26 ottobre Teatro Comunale e altri luoghi XI edizione Concerti a teatro; concerti aperitivo in giro per la città; le notti jazz di “Round Midnight”; la suggestiva incursione in musica nella vicina Slovenia; il “Body and Soul” dove anche il vino ha la sua parte. Venti concerti per quattro giorni di festa. Tra i musicisti ospiti: Michel Portal, Henry Threadgill, Trygve Seim, Frode Haltli, Wolfgang Haffner, [em], William Parker, Sakari Kukko, Nicolas Simion, Randy Weston, Marc Ribot... tel. +39 347 4421717 +39 348 4466770 www.controtempo.org [email protected] Repubblica Nazionale
Scarica