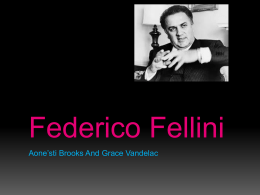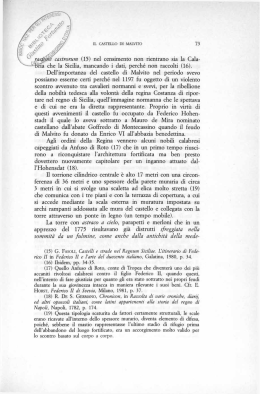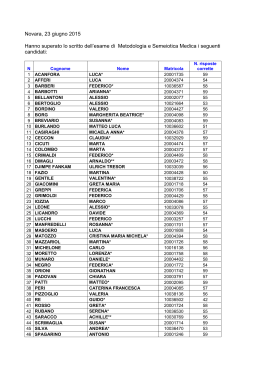Terza Pagina 39 Corriere della Sera Martedì 31 Marzo 2009 Elzeviro Incontri Parla la giovane scrittrice: una narrativa spregiudicata, lontana da ogni nostalgia o esotismo Il diario di Tullio Kezich sulla «Dolce vita» Iran, l’altra diaspora liberal e scurrile FELLINI COME GOYA CRITICO DELLA SOCIETÀ di FERNANDO PROIETTI di LIVIA MANERA Tullio Kezich, autore di «Noi che abbiamo fatto La dolce vita» (Sellerio), è stato appena nominato presidente onorario della Fondazione Federico Fellini di Rimini. Kezich, autore, sceneggiatore e critico del «Corriere della Sera», ha dedicato (tra l’altro) al regista riminese una biografia edita da Rizzoli. D ieci anni dopo l’uscita del film nelle sale, Ennio Flaiano, che dell’opera era stato il principale ispiratore e sceneggiatore, scriveva a Federico Fellini con il quale, nel tempo, i rapporti si erano andati sciupando tra lo sconforto degli amici: «Ieri sera ho rivisto La dolce vita. Ti confesso che c’ero andato col lugubre presentimento di trovare tutto abbastanza offeso dal tempo (…) Invece sono caduto nel film come se non l’avessi mai visto prima…». Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, il capolavoro felliniano è giustamente ricordato come un «film-emblema» (Alberto Asor Rosa). Una pellicola che, secondo la critica (e non solo), fa da spartiacque tra il cinema del neorealismo del primo dopoguerra e quella che sarà un’altra straordinaria stagione politico-culturale. Una rottura «epocale» che, caso raro in Italia, fu subito colta e recepita dal mondo intellettuale (Calvino, Moravia, Arbasino, Pasolini per citarne alcuni). Il che con il passare del tempo non ha obbligato, cosa altrettanto rara e desueta, ad autocritiche, riletture o revisioni. Una messe di lodi non soltanto dal fronte della sinistra (con qualche riserva nel Pci), ma da parte, per esempio, di voci al tempo insospettabili. Dopo aver assistito ad una proiezione privata del film, Indro Montanelli scrive entusiasta: «Fellini (…) non vi tocca vette meno alte di quelle che Goya toccò in pittura, come potenza requisitoria contro la sua e la nostra società». Ecco perché è meritevole che Tullio Kezich, critico cinemato- Porochista Khakpour contro «il perbenismo neocon» di Azar Nafisi grafico del Corriere della Sera e testimone di quell’avventura, abbia rovistato a fondo nei cassetti della sua memoria per ampliare e mettere a punto il suo journal di lavorazione. Un viaggio che egli considera, a ragione, un vero e proprio «bagno di pellicola». Un amarcord in presa diretta, rimontato alla moviola del tempo che passa, sui lunghi mesi in cui Kezich fu imbarcato da mozzo provetto sulla nave governata dal maestro Federico. Un diario oggi riproposto con il titolo da reduce un po’ nostalgico di quell’avventura tra Cinecittà e la Roma notturna e magica degli anni Sessanta: Noi che abbiamo fatto La dolce vita (Sellerio, pp. 252, e 13). Un volumetto ricco di aneddoti, curiosità intellettuali, annotazioni soavi, ricordi e memorie. Dove la storia di un film diventa a sua volta un racconto per immagini. O forse qualcosa di più importante e profondo. «Dobbiamo fare il montaggio dei nostri ricordi, il girato della memoria, per ricreare una continuità, per farne un racconto», ha osservato Marc Augé nel delizioso incipit al suo libro Casablanca (Bollati Boringhieri). Un altro film memorabile interpretato da un’altra mitica coppia di attori, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, di cui, appunto, il grande antropologo francese si serve per rievocare non solo gli anni della sua infanzia, della sua giovinezza e della guerra. Per l’autore dei Nonluoghi, le immagini di Casablanca restano ancora oggi un «detonatore di ricordi». Anche Tullio Kezich s’illudeva di essere stato soltanto testimone e spettatore de La dolce vita prima di accorgersi che era dentro la storia sua e della nostra vita. L a protagonista di questa storia è una ragazza esotica, minuta e molto graziosa in un abitino di seta senza maniche e stivaletti spavaldi, che dice: «Il primo ricordo della mia vita risale a quando avevo due anni e mezzo e ho visto i missili della contraerea nel cielo di Teheran. Era l’epoca della guerra Iran-Iraq, e i missili erano nostri, ma questo non lo sapevamo. Nel mio ricordo sono in braccio a mia madre davanti a un rifugio antiaereo, e lei sta piangendo. Da allora ho sempre avuto il terrore di qualunque cosa voli nell’aria. Per cui immaginatevi lo choc dell’11 settembre. Pensavamo di esserci trasferiti in una terra senza terroristi, e di colpo era come se il Medio Oriente ci avesse raggiunti». Siamo a New York nella sala da pranzo déco di un club per signore e l’allegra originalità di questa ragazza a metà tra Amy Winehouse e Audrey Hepburn, è un torrente in piena. In due ore eccola raccontare della sua passione per la cultura pop, della vivacità dei blogger iraniani, di un incidente in taxi che nel 2005 le ha portato via parte della faccia (ricostruita alla perfezione), dell’esperienza di giornalista al Village Voice e a Spin, di quando ha fatto la modella, la barista, la commessa, la critica di ristoranti e la cavia per un parrucchiere, di una quantità di fidanzati benestanti che hanno sempre pagato l’affitto, dei periodi di penuria e da single, del corso di scrittura creativa che sta tenendo alla Bucknell University, della fuga in autobus con i genitori attraverso la Turchia, e del fatto che quando l’editore americano Grove/Atlantic ha comprato i diritti del suo romanzo d’esordio (in uscita da Bompiani col titolo Figli e altri oggetti infiammabili), e ha voluto pubblicarlo in tutta fretta senza revisioni, le è venuta una tale crisi d’ansia da farla precipitare in uno stato di anoressia grave. Così è Porochista Khakpour (pronuncia Porocista Hakpur): ambiziosa, talentuosa e fragile. Una ragazzina di trent’anni dal complicato nome zoroastriano, che dice: «Quando mi presento, tutti dicono: hai un soprannome? E io rispondo: No, fai uno sforzo e impara a dire: P, o, c...». Suo padre è un fisico nucleare con un dottorato al Mit di Boston. Sua madre è la figlia del presidente della National Iranian Oil Company e la nipote del vice primo ministro e fondatore del programma nucleare della Persia dello Shah. Po- rochista è nata a Teheran, è scappata con i suoi in California quando aveva tre anni, e crescendo americana ha trovato una voce letteraria piena di umorismo, intelligenza, ingenuità, allegria, tristezza, onnipotenza e frustrazione. Una voce che si potrebbe definire massimalista (ma si potrebbe anche ripescare la definizione di «realismo isterico» coniata da James Woods per la Zadie Smith della prima ora), se non rappresentasse anche la metà più spregiudicata, giovane, innovativa, scurrile e liberal della diaspora intellettuale iraniana. Dove l’altra metà è rappresentata dai romanzi anglo-iraniani che ostentano il proprio conformismo fin dal titolo «speziato» (tipo: Pollo allo zafferano), e dal conservatorismo di Azar Nafizi, il cui bestseller Leggere Lolita a Teheran, con la sua educata nostalgia per il passato pre-rivoluzionario dell’Iran e la sua rappresentazione di un Paese che chiede di essere salvato dalla più abbietta censu- Esordio ra culturale, ha portato per anni acqua al mulino della destra neocon che invocava la necessità di «esportare la democrazia in Iraq» con le maniere forti. Quella voce spregiudicata è la prima cosa che colpisce fin dal titolo in Figli e altri oggetti infiammabili, un romanzo d’immigrazione politicamente scorrettissimo, i cui protagonisti sono un ragazzo traumatizzato e ribelle che si chiama Xerxes come Serse il figlio «perdente» di Dario, e il suo cinico e disilluso padre Darius come Dario il re dei persiani. Di cognome farebbero Odd-damn, ma in America diventano Adam, e come dice Darius a Xerxes bambino: «Se ti chiedono se sei parente di Adamo tu digli di no». Colmo dell’ironia, Darius e Xerxes e Laleh la mamma, in fuga anche loro dai missili di Teheran, si ritroveranno a vivere in un condominio californiano che si chiama «Giardino dell’Eden». Questo, s’intende, prima che padre e figlio litighino e Xerxes se ne va- Pioniera Alfonso Gianni e la crisi del liberismo Dibattito a Milano sull’imperatore svevo Il nuovo «libretto rosso» di chi spera nella Cina Lo strano mito di Federico II un sovrano un po’ federalista P lo hanno presentato a Bari Q uando un gruppo di guide di Castel del er molti la crisi finanziaria internazionale è fonte di angoscia, ma Alfonso Gianni la vive con un certo sollievo, visto che «oggi il confronto fra destra e sinistra potrebbe essere meno impari di un tempo». L’autore del saggio Goodbye liberismo (Ponte alle Grazie, pp. 361, € 16,50) ritiene che siano venuti al pettine i nodi di uno sviluppo distorto, sul quale si era innestata l’egemonia culturale dei paladini del mercato. La trascorsa fase di espansione produttiva era contraddistinta in America, nota Gianni, «dalla sostanziale invarianza, se Alfonso Gianni, ex deputato di Rifondazione comunista, ha scritto diversi libri con Fausto Bertinotti non diminuzione, del valore reale delle retribuzioni e dalla crescente precarizzazione della forza lavoro», per cui l’unico modo di proseguire sulla via dei consumi di massa era praticare il «credito su larga scala» alle famiglie. Un meccanismo che si è inceppato con il disastro dei mutui subprime. L’altro punto su cui il libro insiste è la coincidenza tra l’esaurimento di una «fase della globalizzazione capitalistica» e «la fine dell’egemonia americana e l’inizio di quella asiatica e cinese in particolare», dato che ormai non è più l’Occi- dente «a trainare il sistema su scala mondiale». Proprio questo mutamento sembra però inficiare non poco la praticabilità delle ricette suggerite da Gianni: rilancio e riforma dell’Onu (senza più diritto di veto delle grandi potenze), governo globale della finanza, ripresa del conflitto sociale, assunzione dei contenuti proposti dal movimento «altermondialista» (o no-global). Infatti la Cina resta un Paese ferocemente geloso della sua sovranità nazionale, con un regime a partito unico che nega le libertà politiche e sindacali. Il suo sarà forse, come scrive Gianni, un inedito «capitalismo entro una crisalide statuale socialista», ma certo appare quanto meno azzardato sostenere che «ricorda abbastanza da vicino il modello europeo degli anni Sessanta». E non sembra molto realistico confidare nei fermenti di «nuova sinistra» che si agitano a Pechino. Se l’alternativa viene dal gigante asiatico, conviene usare qualche cautela nel rallegrarsi per il declino dell’influenza americana. C’è il rischio concreto di rimpiangerla. Anche a sinistra. Antonio Carioti R Il saggio di Alfonso Gianni «Goodbye liberismo» sarà presentato a Milano domani alle 18 presso la libreria Feltrinelli di piazza Duomo. Interverranno: Dario Di Vico, Onorio Rosati, Cristina Tajani, Ferdinando Targetti Monte è andato a manifestare contro l’autore, reo di avere messo in dubbio le teorie esoteriche legate all’edificio e al suo principale inquilino, Federico II di Svevia, da sempre pezzo forte delle visite guidate per turisti. Succede anche questo, quando i grandi della storia sopravvivono ai secoli per diventare miti, piegando la propria realtà ad uso di situazioni e conflitti moderni. E del rischio che si corre adattando la storia alle necessità dell’oggi hanno diL’imperatore Federico II di Svevia (1194-1250), re di Sicilia, ritratto in una miniatura del XIII secolo scusso ieri a Milano, nella sala Guicciardini della Provincia, il presidente della Provincia Filippo Penati, il direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, lo scrittore Piero Colaprico, il presidente dell’«Associazione regionale pugliesi» Dino Abbascià e Marco Brando, giornalista e autore del libro Lo strano caso di Federico II di Svevia (edito da Palomar). Lo stesso incorso nella furia delle guide di Castel del Monte. Brando, genovese con alle spalle diversi anni a Bari al Corriere del Mezzogiorno, si è divertito a raccontare l’inna- moramento della Puglia per l’imperatore svevo. Una cotta dura a morire ma non condivisa né dai tedeschi, smemorati connazionali di Federico, né dai leghisti nostrani, che lo hanno eletto a simbolo di uno statalismo pernicioso. «Usare la storia per giustificare il presente», chiamando in causa, magari dopo l’11 settembre, l’accordo tra l’imperatore svevo e il sultano di Gerusalemme come esempio di concordia tra Oriente e Occidente, «si può fare — ha messo in guardia Mieli — ma solo a prezzo di bestiali nefandezze. Perché la storia, e solo se analizzata con strumenti sofisticati, può insegnare casomai a capire le complicazioni del presente». La tentazione però è forte se Federico, «moderno nella sua capacità di leggere le diverse realtà territoriali», nelle parole di Penati diventa portabandiera di un federalismo che «se ben interpretato, può essere un incentivo alla coesione sociale e all’unità nazionale». Un modello da maneggiare con cura. Il resto è folklore, e un mito tanto radicato nel cuore dei pugliesi da partorire — e Brando li ha scovati con cura — decine di istituti, alberghi, negozi di ferramenta che, nel nome, rendono omaggio all’imperatore amante della poesia e della caccia col falcone. Anche una compagnia aerea dalla vita breve, la Federico II Airways. Lo slogan? «I fagiani volano, perché i foggiani no?». Giulia Ziino Sotto a sinistra, Porochista Khakpour, autrice del romanzo «Figli e altri oggetti infiammabili» in uscita domani da Bompiani (traduzione di Licia Vighi, pp. 424, e 19) Qui sopra, Azar Nafisi (foto Basso Cannarsa). È stata la prima donna ad essere eletta al parlamento iraniano. Il suo «Leggere Lolita a Teheran» è stato tradotto da Adelphi da a studiare in un college della East Coast, per finire a vivacchiare a New York fino a quella splendida, tersa mattina di settembre del 2001, in cui, insieme alle Torri, andrà in frantumi anche la sua fragile identità. «Non so cosa sia stato più inconcepibile — ricorda Porochista che ha visto la tragedia delle Torri dalla finestra —, se assistere in prima fila al più devastante spettacolo cinematografico della mia vita, o diventare cittadina americana due mesi dopo, giurando fedeltà alla bandiera in un palazzo di Brooklyn dove si sentiva ancora puzza di bruciato». Scriverne, dice, è stata la sua terapia. E scegliere la forma di un romanzo brillante e maleducato, è stata la sua ribellione all’ondata di narrativa e memorialistica «etnica e melensa» che ha invaso il mercato americano da Leggere Lolita a Teheran, in poi. «Dovrebbero prendersi un po’ meno sul serio e scrivere un po’ meglio! Non se ne può più della zuccherosa sincerità di questi libri, del loro ammirevole contegno e calcolata accettabilità. Non se ne può più di quello che scrivono gli iraniano-americani — che poi son tutte donne. I loro memoir sono pieni di donne velate e stereotipate, di orientalismo e colonialismo». Così, dice, stanno le cose a «Terangeles», ovvero nella sontuosa Beverly Hills dei fedeli allo Shah. E anche se la famiglia di Porochista abita più modestamente a Pasadena, lei ammette che ciò che l’ha salvata dal diventare «la Ann Coulter iraniana», è stato partecipare con i genitori a una manifestazione di protesta a Washington nell’87, ed essere strappata alla noia dall’improvvisa visione di un uomo che si dava alle fiamme (era lo scrittore pacifista Neush Farrahi e morì due settimane dopo). In sostanza, è come se in Figli Porochista ci dicesse: venite a vedere cosa significa crescere in una famiglia che ha nostalgia del Paese da cui è fuggita, e vive in uno da cui si sente estranea. Sperimentate anche voi «come sono soffocanti per i figli degli immigrati i ricordi dei genitori, e come si desideri solo ricominciare da zero». Ma soprattutto venite a vedere come, quando da un lato ti vergogni della violenza degli ayatollah e dall’altro ti senti morire scoprendo che mamma e papà bevevano Martini al country club mentre la polizia segreta dello Shah torturava e uccideva — venite a vedere come l’unica salvezza dal naufragio dell’identità sia la capacità di giocare con un idioma semplice e ricchissimo come quello inglese, che è l’unico, vero, potente strumento di reinvenzione, almeno da Nabokov in poi.
Scaricare