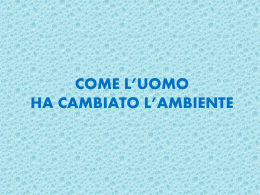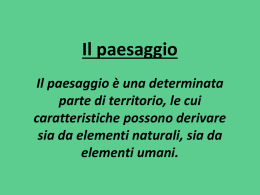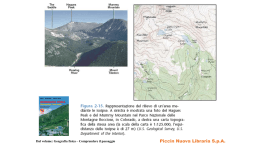[email protected] [email protected] www.culturacommestibile.com www.facebook.com/cultura.commestibile direttore simone siliani redazione gianni biagi, sara chiarello, aldo frangioni, rosaclelia ganzerli, michele morrocchi, barbara setti progetto grafico emiliano bacci Con la cultura non si mangia N° 10 Per noi la sinistra è storia e valori, certo, è Berlinguer e Mandela, Dossetti e Langer, La Pira e Kennedy, Calamandrei e Gandhi 1 Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a madre Teresa, passando da Malcom X attraverso Gandhi e San Patrignano arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano Jovanottismo malattia infantile del renzismo editore Nem Nuovi Eventi Musicali Viale dei Mille 131, 50131 Firenze Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012 Da non saltare Gianni Biagi g,[email protected] di M 29 novembre 2014 pag. 2 Campana eil paesaggio atteo Meschiari, antropologo e scrittore. Scrittore militante per la difesa dell’ambiente, traduttore e divulgatore culturale, autore di poesia e narrativa, ha insegnato nelle Università di Lione, Avignone e Lille in Francia e dal 2008 insegna Antropologia culturale e Antropologia del paesaggio all’Università di Palermo. Dal 1990 svolge ricerche sul paesaggio in arte, letteratura, etnologia e geografia. Ha contribuito allo studio del concetto di paesaggio nella storia delle idee, nell’antropologia culturale, nelle scienze cognitive e in filosofia. E’ in particolare impegnato nella divulgazione in Italia della Landscape Anthropology anglosassone. Caro professore lei ha tenuto recentemente una conferenza sul lavoro di Dino Campana. La conferenza si è svolta nell’ambito delle iniziative organizzate da Teatro Studio Krypton di Scandicci per il centenario della pubblicazione dei Canti Orfici. Il titolo della sua conferenza, che si è tenuta alla chiesa di Santa Verdiana in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, era Una nuova melodia selvaggia con il sottotitolo Geografie Campaniane. Lei ha scritto, alcuni anni fa, per i tipi di Liguori un libro importante su Dino Campana: Dino Campana. Formazione del paesaggio. La tesi di fondo del libro è che il paesaggio e la sua descrizione sono la struttura portante del libro unico di Campana, i Canti Orfici appunto. Nella sua premessa lei scrive: «Pochi libri sono così vasti, così geograficamente vasti nello spazio e nel movimento da essere una dichiarazione non poetica, ma di paesaggio». In questa frase c’è credo il senso del libro. Si parla di spazio, di movimento, di vastità. Quale è stato l’avvio di questa sua riflessione su Campana? Da vari anni riflettevo sul paesaggio ed ero attratto in modo particolare da quegli autori che non si limitano a inserire frammenti di paesaggio nei loro testi, un po’ come intarsi contemplativi distribuiti qua e là nell’opera, ma che, come diceva Calvino, cercano di “tradurre il paesaggio in ragionamento”. Presto mi sono reso conto che esistono testi con paesaggio, testi di paesaggio e “testi-paesaggio”. Gli ultimi sono quelli che m’interessano, perché usano il paesaggio come matrice strutturante, come funzione letteraria. Nella mia interpretazione i Canti Orfici sono uno di quei testi, paesaggistico a tutti i livelli, nella struttura, negli enunciati, perfino nella sintassi che, secondo me, riproduce una fenomenologia dello sguardo, un modo di vedere che è proprio di chi i paesaggi li ha frequentati veramente. Non panorami estatici collocati sullo sfondo, in secondo piano, ma spazi complessi, attraversati con il corpo, vissuti in prima persona. Campana è un viaggiatore, anzi, un camminatore. Lui parla del paesaggio che vede chi cammina. C’è un rapporto diretto fra il movi- mento del cammino e quello dello sguardo? Fra il piede e l’occhio? Un modo di percezione diverso? È questa la singolarità del testo di Campana e del suo racconto del paesaggio? Il problema fondamentale nella nostra percezione del paesaggio è che siamo portatori di una temporalità troppo umana, se messa a confronto con i tempi geologici della Terra. In altre parole, vediamo immobile ciò che di fatto si muove: i ghiacciai in lenta discesa, le migrazioni vegetali, l’orogenesi. Un po’ come nel dilemma geografico che accompagna la storia culturale dell’Occidente, pensare una terra rotonda che invece ci sembra piatta, allo stesso modo percepiamo e rappresentiamo i paesaggi come immobili quando invece si muovono. Ora, un uomo che cammina, che vede le cose in movimento perché sta camminando, è come se prestasse al paesaggio un supplemento di vita, gli trasmette un impulso, imprime ad alberi rocce terreni il proprio dinamismo. Molti autori descrivono paesaggi statici, cristallizzati, imbalsamati, altri cercano di rendere la complessità dinamica della percezione propria di uno sguardo in movimento, e questo muove dall’interno i luoghi scritti. Campana è uno di questi autori-camminanti. Chi cammina condivide necessariamente il paesaggio. Lo condivide nel senso che lo attraversa anche. Non è lo sguardo da altrove. È lo sguardo da dentro. Condividere e non contemplare. Anche uno sguardo al di dentro del proprio io. C’è in Campana una lettura del paesaggio interno oltre che di quello esterno? Passeggiare per costruire paesaggi interiori? Il concetto di “paesaggio dell’anima” accompagna la riflessione sul paesaggio dal tempo in cui i pittori del Quattro e Cinquecento hanno cominciato a usare e a diffondere la parola (landskip, landscape, paysage, paesaggio) in un’accezione puramente estetica. Già allora il paesaggio non era più un terreno sotto i piedi ma una mera immagine, e le immagini, lo sappiamo bene, sono contenitori che possiamo riempire come ci pare. La mente dell’uomo è fatta così: ipotizza sempre un messaggio nascosto, interroga le cose senza sosta, cerca la polpa dietro la buccia. Ma non sempre la polpa c’è, e non tutti sono interessati a portarla in luce. Dino Campana, ad esempio, è attratto dal mistero, ma non vuole esplicitarlo, vuole che agisca nella vita dell’uomo con la sua forza not- Da non saltare 29 novembre 2014 pag. 3 turna, prelogica, prelinguistica. Se Campana costruisce paesaggi interiori è forse in questo senso: non paesaggi che aiutano a chiarire una visione del mondo, non paesaggi-risposta, ma paesaggi che approfondiscono le domande, che le rendono più oscure e risonanti. Quello che mi ha sempre stupito di Campana è che è uno dei pochissimi autori italiani, forse l’unico, che ha abbozzato una riflessione intuitiva sulla selvatichezza, quella che gli Americani chiamano wilderness: luoghi dove il senso non si svela, dove l’uomo culturale è messo in crisi, e dove l’accesso è consentito solo a chi è disposto a perdersi, a spogliarsi di una natura troppo umana. Nella presentazione del film su Dino Campana, girato in “super8” nel 1974 da Marco Moretti, l’autore ha detto che Campana introduce «i colori nella poesia». Nel senso, credo, che Campana racconta un paesaggio totale, fatto di sensazioni, di emozioni e non solo d’immagini. È anche una sua sensazione? Certo. Si potrebbe parlare in questo senso di paesaggio dinamico, multisensoriale, sinestesico. La lingua di Campana non si accontenta di registrare il fenomeno, vuole riprodurlo, e la visione è un elemento portante ma non esclusivo. Pensiamo al lavoro fonostilistico, alla parola-suono, o alla sintassi, che con riprese, salti, vuoti, tagli, ellissi, avvicinamenti asintotici, montaggi bruschi o morbidi tenta di ricreare un’esperienza cognitiva, diventa una strategia per fare entrare il lettore in un flusso dinamico, narrativo. Campana conosceva il cinema. Certamente introduce «i colori nella poesia», ma io direi anche che ci ha messo movimento, tensione muscolare, rumore, e l’universo tattile, la grana sotto le dita. I percorsi di Campana per l’Appennino, verso la Verna ad esempio, sono oggetto di attenzione da parte delle amministrazioni pubbli- Intervista a Matteo Meschiari Una mostra per i 100 anni dei Canti Orfici Attorno al manoscritto proto-orfico “Il più lungo giorno”, si è inaugurata, giovedì 27 novembre, la mostra “Dino Campana. Canti Orfici 1914-2014”, nella più campaniano delle biblioteche fiorentine, la Marucelliuana. Manoscritti, documenti, libri (tutti quelli di Dino e alcune, preziosissime, copie dell’edizione del 1914, come quella che Dino regalò a Sibilla Aleramo nel 1916), immagini curata con che quasi a voler ipotizzare un “Appenino campaniano”. Percorsi che portano a ripercorrere la strada di Campana con gli occhi di oggi, con occhi diversi, per comprendere anche l’opera. Sarà utile? I parchi letterari, i percorsi reperiti e ridisegnati nei luoghi reali fissati dallo sguardo di un autore, dalle pagine di un libro, sono un’esperienza suggestiva e al tempo stesso fragile, in balìa di maestria da Francesca Castellano. La parte editoriale è senz’altro quella più completa e interessante: appunto, le edizioni dei Canti Orfici dal 1914 ad oggi, gli scritti su Campana e le monografie suil poeta marradese. E il manoscritto “Il più lunghi giorno”, con la sua storia di spargimenti, ritrovamenti, dolore, rabbia, è il “pezzo” più emozionante. Il catalogo della mostra è stato curato e realizzato dal Comune di Firenze ed è disponi- bile in rete. Franco Contorbia ha introdotto e presentato la mostra. La mostra, ad ingresso libero, è visitabile dal lunedì al giovedì 9-13 e il venerdì 8,30-13,30, fino al 31 dicembre. Sempre all’interno del centenario della pubblicazione dei Canti Orfici, va in scena presso il Teatro Studio Krypton di Scandicci oggi sabato 29 novembre alle ore 16, la piece teatrale “Sibilla Aleramo. Così bella come un sogno” di Lorenzo Bertolani. interpretazioni dall’alto, di commercializzazioni turistiche e, forse peggio, di traduzioni museali en plein air che riducono la poesia a un prodotto-spettacolo. Ma ci sono anche esempi virtuosi, come quello su Jean Giono in Francia o quello che si sta progettando su Francesco Biamonti in Liguria. Personalmente sento di entrare in connessione con un autore visitando i suoi luoghi da solo, senza itinerari predisposti, cartelli o scritte che mi dicano cosa guardare e cosa pensare. Ma se il paesaggio non viene sovrascritto, se viene rispettato al massimo, se tutto questo può avvicinare alla poesia del corpo e della terra, allora mi trova d’accordo. Il paesaggio è oggi un bene collettivo. La stessa Costituzione lo tutela come matrice fondamentale della identità nazionale. In Campana il paesaggio è intimo, personale. C’è quindi la possibilità di condividere il paesaggio? Di avere una visione collettiva del paesaggio? C’è un paesaggio condiviso? Oppure ci sono infiniti paesaggi personali la cui sommatoria è un immaginario paesaggio collettivo? Credo entrambe le cose. La Convenzione Europea del paesaggio ha chiarito e sancito una cosa importante, che un paesaggio non è soltanto un territorio condiviso, inscritto in una memoria collettiva, non è solo un ambiente di qualche pregio, pieno di storia con la maiuscola o universalmente bello come le Dolomiti o certi tratti d’Appennino. Il paesaggio è anche il modo in cui un luogo concreto viene percepito dalle comunità locali e, aggiungerei io, dai singoli individui. In questa prospettiva anche un paesaggio “brutto” ha senso, ha un valore identitario per chi lo vive: è “casa”, è l’“aperto”, è una storia minore inscritta nelle cose. Il paesaggio è un luogo reale da tutelare, ma è anche un bene culturale immateriale depositato nella mente di chi lo abita da sempre o di chi lo sta attraversando per la prima volta. I paesaggi sono depositi d’immaginario. Quando li si tocca, li si altera o li si riorienta, è la capacità di immaginare della gente che si sta ineluttabilmente modificando. riunione di famiglia 29 novembre 2014 pag. 4 Le Sorelle Marx Nicoletta Mantovani, presentata assessore al Comune di Firenze in quanto vedova Pavarotti e grazie alle mille miglia Alitalia acquisite negli anni, non è scomparsa. Questo intanto ci fa fare un sospiro di sollievo. Dalle elezioni infatti se ne erano perse completamente le tracce, il suo ruolo di ambasciatrice per portare a giro il nome di Firenze doveva averla spinta in ogni angolo del mondo. Ecco quindi che quando l’abbiamo vista spuntare sul palco del candidato del PD alla presidenza dell’Emilia Romagna, Bonaccini, la scorsa settimana che l’ha presentata come ambasciatrice dell’Emilia Romagna nel mondo (si parla anche di un possibile posto in giunta per Lei) ci siamo sentite tradite. Ma non doveva farlo per Firenze? Per cui, quando il sindaco Nardella ha twittato del suo incontro con l’ambasciatore del Kuwait propiziato proprio dalla Mantovani, ci siamo sentite riavere. Ora che il Kuwait conosce Firenze, la città è a posto. Ci rimane solo un dubbio, l’ambasciatrice mica avrà detto al collega che la cultura è il nostro petrolio? I Cugini Engels Cambiare idea Dopo aver cantato l’ira funesta della acidula Acidini contro la riforma del Ministero dei Beni Culturali, che è stata causa delle sue dimissioni dalla direzione del Polo Museale Fiorentino, di tutto ci immaginavamo meno che di dover registrare i peana acidiniani sulla medesima riforma. Ricordate il 23 settembre? Alla domanda sulle motivazioni delle sue dimissioni, con la compostezza di sempre, ma con una certa punta di acidità, l’Acidini rispondeva: “Proprio in previsione degli esiti della riforma, del futuro assetto dei musei, fiorentini e non solo, che la riforma configurerà, e del nuovo impianto dell’organizzazione dirigenziale, all’interno del quale io non credo che una condizione come la mia attuale si possa più identificare”. Ma dopo meno di 2 mesi ecco la signora dei musei che se ne esce con questa frase, nel suo discorso di congedo: “Vedo nella riforma Un’ambasciatrice per due giunte Bobo La Geopolitica di Eugenio che si annuncia un effetto positivo. Accanto a quello, ovvio, di conferire maggiore autonomia e visibilità ai musei individuati, c’è altro – che forse percepisco meglio di chiunque altro – di suddividere questo smisurato carico di responsabilità tra posizioni apicali diverse, rendendolo per ognuno umanamente sostenibile”. Ora, il parla come mangia tradurrebbe così la frase: “Solo io, che sono sovrumana, potevo sostenere tutto quel potere concentrato su di una sola persona; siccome non c’è nessuno come me, sminuzzino pure il potere e se ne vadano al diavolo tutti!”. Ce la immaginiamo l’Acidini, spettinata come Francesca Neri nella pubblicità di Salvini, mentre cerca l’abito adatto da indossare per andare alla sua ultima uscita pubblica da Sovrintentende, che prova davanti allo specchio il discorso, sconvolta, furiosa, con i capelli indomabili nonostante l’estintore di lacca, che come l’attrice esclama: “Odio le donne che piangono. Ma non porto rancore... Niente è per sempre. Odio i trucchi. Non voglio più legami. Odio farmi notare....Ho cambiato idea” 29 novembre 2014 pag. 5 Classico, anticlassico e il senso della geometria di Nardi di John U Stammer no dei capitoli del libro di Bruno Zevi “Il linguaggio moderno dell’architettura” (Einaudi 1973) si intitola “Sintassi della scomposizione quadridimensionale”. Il libro di Zevi era la risposta ad un altro libro, edito nel 1964 da John Summerson, dal titolo “The classical language of Architecture”, dopo che lo stesso Zevi, come racconta nella premessa al suo libro, aveva invano atteso la pubblicazione di un libro di Summerson riguardo all’ “Anti-classical language of Architecture”. Il capitolo è preceduto da altri con titoli ugualmente espliciti come “Asimmetria e dissonanze” e “Tridimensionalità antiprospettica”. Il libro di fatto si configura come un insieme di regole, di idee, di suggerimenti per la costruzione di un’architettura contemporanea., e anti – classica. Regole anti - classiche in contrapposizione alle regole del classicismo invocate da Summerson. Queste riflessioni vengono in mente guardando il nuovo lavoro di Claudio Nardi a Novoli. Nardi ha progettato un edificio, anzi due edifici collegati fra loro da un ponte aereo e una quinta, in due lotti del Piano di Recupero redatto da Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia d’Isola, sulla base del piano guida di Leon Krier. Edifici per residenze che si collocano a fianco, e di lato, a opere di Isola, e a lato dell’edificio che ospita la biblioteca universitaria di Scienze Sociali di Adolfo Natalini. Edifici “classici” tutti questi ultimi, anche se con licenze stilistiche e formali importanti, licenze che si manifestano in particolare nel grande edificio per attività commerciali e sale cinematografiche di Isola. Gli edifici di Nardi parlano un linguaggio architettonico, sia nella sintassi sia nella grammatica, sostanzialmente diverso da quelli contermini. Il progetto è pensato con due diverse tipologie edilizie per i due edifici che sono uniti dalla piazza, caratterizzata dalla ricercata mancanza di omogeneità delle due facciate che si fronteggiano, e dalla quinta che la separa dalla strada di scorrimento esterna al lotto. Un linguaggio moderno che utilizza parole classiche in un contesto contemporaneo. Parole classiche come copertura e parete qui sono rappresentate da un unica struttura, che raccoglie tre dei cinque lati esterni dell’edificio più grande, e forma un grandissimo trilite che, come un grande foglio rigido, sembra appoggiato su di esso. Parole classiche come loggia e finestra qui sono declinate in modi e forme diverse a seconda degli usi e delle esigenze degli spazi interni, e costituiscono un abaco da utilizzare in modi diversi nei due edifici, contribuendo a differenziarli anche ad una vista esteriore, e non solo per le due diverse tipologie utilizzate (edificio in linea quello più piccolo e edificio a corte quello più grande). Il risultato è un unico grande edificio, complesso e articolato, che offre diverse modalità di lettura, che utilizza colori scuri delle terre delle crete e finiture delle facciate dei piani terra che ricordano il grassello. Un edificio costruito secondo le regole del risparmio energetico (l’edificio rispetta i parametri della classe A) attraverso la realizzazione di un rivestimento isolante a “cappotto”, che rimane invisibile all’esterno, e con materiali innovativi,come il “legno tecnico”, per le finiture esterne delle pareti rivolte verso la strada principale. Un edificio che dimostra come le regole del piano di recupero dell’area ex Fiat a Novoli siano capaci di essere lette, interpretate ed agite, sia per la realizzazione di edifici di impianto e caratteristiche “classiche” come quelli adiacenti, sia per edifici di impianto “anti-classico” come quello di Nardi, contribuendo a garantire quella diversità formale e funzionale che è la condizione del buon funzionamento urbano; a maggior ragione in un nuovo pezzo di città come quello in via di realizzazione nell’area di Novoli. L’edificio ospita 51 appartamenti di piccola dimensione, in linea con le esigenze del mercato attuale, e 6 negozi al piano terra, ed è stato realizzato in due anni dalla fine 2012 alla fine del 2014, dopo che sullo stesso lotto lo stesso progettista aveva redatto altri progetti per funzioni universitarie. 29 novembre 2014 pag. 6 Laura Monaldi [email protected] di I l mondo dell’Arte Contemporanea saluta con stima e affetto uno dei creatori della Poesia Sonora e della Poesia Azione: un uomo che ha creato, con la passione per la poesia, l’Arte e la performance, un’energia espressiva, teatrale ed esaustiva in grado di abbracciare suono e visualità in un’estetica del Totale priva di limiti e di limitazioni; un artista che ha lasciato un segno indelebile nello sperimentalismo poetico. Nelle sue opere la scrittura incontra la visualità, ponendosi su un unico piano di azione e comunicazione, connettendosi con i linguaggi interdisciplinari e intermediali propri della sperimentazione neoavanguardista. A partire dagli anni Sessanta e Settanta le forme visive, gestuali e musicali hanno operato all’insegna dell’intersezione, della contaminazione e della percezione multisensoriale, sino a giungere alla dimensione profonda e aperta della performance. Bernard Heidsieck ha agito, in tal senso, nello spazio acustico e figurale dell’Arte Contemporanea, attuando un progetto poetico complesso e articolato, nella consapevolezza che la poesia poteva e doveva uscire dallo spazio privato e passivo della lettura per divenire attiva, aprendosi allo spazio pubblico e coinvolgendo il fruitore nell’Azione poetica, stimolandolo sensorialmente, senza però perdere la poeticità e la letterarietà insita nella parola. La Poesia Sonora dell’artista è un genere al limite tra arte e spettacolo che unisce saperi, tecniche e tecnologie innovatrici, al fine di rivoluzionare l’idea di poesia e far rivivere la scrittura poetica e la visualità del verso. Un neoumanismo inedito, capace di cavalcare le spinte del moderno, compiendo una parabola storica sull’idea di Arte e Scrittura; un modo e un tentativo di interpretare la parola poetica, attraverso l’azione, il gesto artistico e la spinta espressiva che ha distinto l’artista nel vasto panorama della Neoavanguardia, con la sua doppia vita di banchiere di stato e artista: due vite apparentemente inconciliabili, ma che gli hanno permesso un’immersione assoluta e passionale nell’attualità. Quella di Bernard Heidsieck è stata una totalità estetica che ha abbracciato tecniche e discipline tendendo alla presa di coscienza e alla messa in luce che tutto è Arte che la parola ha ancora molto da donare sotto ogni punto di vista. Heidsieck, arte da sentire Dall’alo in senso orario Leonardo a bien dû inventer quelques couleurs … ! Créditons-le, en tous cas, de celles-çi … !, 1997 Scrittura e collage su cartoncino, cm. 32x24, Leonardo a certainement inventé le boogie woogie, 1997, Scrittura e collage su cartoncino, cm. 32x24, Leonardo a certainement inventé le champ de Basf professional, 1997, Scrittura e collage su cartoncino cm. 24x32, Leonardo a certainement inventé le vert espérance, 1997, Scrittura e collage su cartoncino, cm. 24x32, Leonardo a certainement inventé le tissus écossais, 1997, Scrittura e collage su cartoncino, cm. 32x24 Tutte courtesy Collezione Carlo Palli, Prato 29 novembre 2014 pag. 7 Simonetta Zanuncoli [email protected] di A Parigi, nel immenso parco della Villette progettato nel 1983 dall’architetto svizzero Bernard Tschumi sui 35 ettari dell’ex mattatoio della città, è sorta nel corso degli anni una sorta di Babele della musica, una città nella città dalle mille lingue dove però le note sono al posto delle parole. E’ composta da Zenith, una grande arena coperta, che ospita manifestazioni di musica di vario genere con 700.000 spettatori all’anno, e da due bellissimi edifici, la Citè de la Musique, progettata dal architetto Christian de Portzamparc (ideatore anche della Cidade da Musica a Rio de Janeiro), e la Philarmonie de Paris. del più famoso archistar francese, Jean Nouvel. La Citè de la Musique, è un grande museo “sonoro”, inaugurato nel 1995. Fu pensato come un luogo dedicato esclusivamente alla musica, un progetto innovativo, ripreso in seguito in molte altre parti del mondo, con sale di altissima qualità acustica. Nei suoi 2000 mq. espone i 4500 strumenti, alcuni appartenuti a musicisti importanti come il pianoforte di Chopin, collezionati dal Conservatorio Nazionale di Musica fin dal XVIII secolo. Un piacere per gli occhi e una delizia per gli orecchi. La visita a suon di musica con l’audioguida, che via via fa sentire i più bei brani realizzati con lo strumento che si sta guardando, si snoda in due percorsi, uno di musica occidentale dal 1600 ai giorni d’oggi e l’altro etnico con le tradizioni dell’Asia, dell’Africa, dell’Oceania e del mondo arabo. Completano questa immersione totale nel mondo delle note i concerti gratuiti organizzati tutti i giorni nella sala di 1200 posti, la libreria Harmonia Mundi, la medioteca con un vastissimo catalogo sonoro, una biblioteca, un laboratorio di restauro e conservazione degli strumenti e un centro di studio della danza e della musica moderna collegato al Conservatorio Nazionale Superiore che incoraggia giovani artisti con premi e coproduzioni. Nel 2007, vicino alla Citè de la La Babele della musica Musique, come sua integrazione iniziarono i lavori della Philharmonie de Paris progettata da Jean Nouvel, uno dei protagonisti della nuova Parigi (suoi sono l’Istituto del Mondo Arabo, il museo Quai Branly e la Fondation Cartier), premiato con il Pritzker, il nobel dell’architettura. Nouvel ritiene il progetto il suo capolavoro e in effetti è magnifico: i 2400 posti della sala grande, con un acustica tra le migliori del mondo, “avvolgono” letteralmente la scena. Gli spettatori seduti attorno all’orchestra ne hanno un contatto diretto e ravvicinato. Un arco alto 52 metri che sormonta l’intera struttura consentirà di proiettare all’esterno in tempo reale i filmati. Da anni però il progetto e poi la realizzazione della Philharmonie sono soggetti a critiche sempre più feroci da parte dell’opinione pubblica e della stampa. Il suo costo è lievitato dai 177 milioni di euro previsti ai 386 finora spesi. L’architetto più amato dai francesi è ora criticato per la sua ambizione che lo porta a “disprezzare il denaro pubblico per il suo ideale di estetica”. Il governo e la città di Parigi che finanziano in parti uguali vengono accusati di aver voluto un progetto faraonico in un periodo di crisi. Le 2 sale prova per 140 musicisti e 200 spettatori, la biblioteca per gli spartiti, la sala conferenza con 200 posti, le 12 sale studio per gli allievi del conservatorio e il ristorante con vista mozzafiato vengono giudicati come un’inutile ripetizione degli spazi già a disposizione nella Citè de la Musique. Ma Parigi è una metropoli globale e nonostante che i frettolosi turisti si fermino a rimirare la sua immagine più stereotipata, attraverso le opere dei più famosi architetti, alcune delle quali brevemente descritte in questa rubrica, è una città che negli ultimi decenni si sta completamente reinventando. Per rispondere alle critiche al governo Hollande è stato costretto a prendere in prestito lo slogan di Sarkozy quando era alle prese con lo stesso problema: chi può sostenere che in questo momento di crisi non abbiamo bisogno di una nuova musica? La Philharmonie dovrebbe aprire, con 2 anni di ritardo, il prossimo 14 gennaio 2015. 29 novembre 2014 pag. 8 Matteo Rimi [email protected] di ché è il suo animo a imporglielo ma solo per vederla poi ingiallire sull’ennesima mensola. Chi, non sapendo a chi chiedere se è o non è un vero poeta, si ritrova a credere che sarà un libro a incensarlo infine. Chi ti riempie di poesia, di gioia e di speranza in una qualche sala semivuota ed alla fine ti indirizza verso il banchino là in fondo per lasciare qualche obolo. Chi non andrebbe mai a leggere davanti ad un pubblico senza conoscere i numeri del suo H o visto le migliori penne di questa degenerazione distrutte dalla smania, morir di fame impoverite, mute, trascinarsi per i corridoi freddi dei festival cercando una dose affamata di fan ed acquirenti, poeti sconosciuti veder bruciare copie su copie della loro invisibile pubblicazione nell’infinito macero di un’editoria fatta moloch divoratore, digerente libri - evacuante soldi. Sul pubblicar poesie Chi inizia un’alta conversazione con gli ormai pochi interessati alla poesia per poi finire affibbiando ai malcapitati l’ennesima silloge come se essa fosse la massima espressione e conclusione di ogni ragionamento sull’arte. Chi intasa i cataloghi on line di copertine e descrizioni telegrafiche credendo ancora ai prezzolati tentatori che gli promisero massima esposizione nel mondo della cultura. Chi, finiti parenti ed amici ai quali regalare copie per ogni occasione e festività, terminata la lista di critici e poeti dai quali aspettarsi non spontanei commenti, usa gli scatoloni di libri in propria dotazione per contratto per stipare librerie e aggiustare gambe di mobili. Chi sfoggia una bibliografia da Massimo cavezzali [email protected] di Indimenticabile Diurno e notturno. sempre gestirsi. Farsi orologio. e lancettarsi. E disconoscersi. E andare avanti. Non tutto spingersi. Non appassirsi. Si, coltivarsi. Provare estasi. Un po’ esaltarsi. Poi un segnaposto. Dove sedersi. Pellegrinare. Ginnasticarsi. far paura, titoli improponibili o finto-aulici uno dietro l’altro come coppe polverose sugli scaffali, confondendo uscite con passi evolutivi. Chi va in giro dicendo che come il proprio editore non ce n’è e poi finisce ammettendo che è giorni che cerca di parlarci ma il telefono squilla a vuoto. Chi, come ad un appuntamento al buio, si ritrova alla presentazione della propria fatica al fianco di un qualunque critico (o, forse, sempre lo stesso), chiamato dall’editore, il quale trova nei suoi scritti analogie alle quali non aveva mai pensato! (Magari perché non esistono affatto...) Chi neanche ti conosce e prorompe sulla rete con un “Ciao! Vuoi acquistare il mio libro?” e se gli chiedi perché invece non organizza letture in bar o piazze ti risponde perché così fa i soldi, ignorando che l’unico modo per far soldi per noi sconosciuti è lavorare. Chi pubblica per la propria soddisfazione consapevole di non apportare niente di nuovo ma ben deciso a piazzarsi là in mezzo a prendersi gli applausi. Chi scambia raccolte eterogenee di scritti risalenti a periodi anche molto diversi tra loro per un lavoro compiuto fregandosene se il libro che tanto brama poi sembrerà un’accozzaglia senza capo né coda. Chi vince i concorsi per opere edite indetti, nascosti tra gli altri, dai suoi stessi editori non cogliendone affatto il paradosso. Chi non ultima una poesia per- Mettere ordine. Bibliografarsi. Provare il suono. E poi accordarsi. Trovare un bilico Dove appoggiarsi E declinare Un po’ sfogarsi Avere un dubbio Per rinnovarsi E poi ogni tanto sottolinearsi un po’e un pò per romanticarsi Né prima né dopo Per sognarsi Essere paghi Ma non pagarsi Farsi rugiada Un po’ bagnarsi Essere uva avvinazzarsi Nel chiaroscuro Inginocchiarsi Fare l’acrobata Quasi cascarsi Così indimenticabile da non ricordarsi. Scavezzacollo conto in banca. Chi non crede alla diffusione libera, svincolata, della poesia come forma di comunicazione o manifestazione, di comunione tra esseri senzienti e predisposti ma riconduce il tutto a quel prezzo in quarta di copertina. Chi non indietreggerebbe di un sol passo di fronte anche alla critica più accorta ed empatica perché tanto il numero delle copie vendute vale più di qualsiasi spontaneo apprezzamento. Non mi si è visto ancora su pubblicazioni a mio nome, ma aleggiare tra strade e byte in cerca di inchiostro, andando incontro alle persone prima che ai poeti, comunque in attesa, fremente ed ingenua, di finire in una qualsiasi delle categorie summenzionate. 29 novembre 2014 pag. 9 Danilo Cecchi [email protected] di N elle arti figurative lo sguardo assume da sempre una importanza notevole, tale da condizionare la fruizione dell’opera, e questo è tanto più vero in fotografia, dove lo sguardo del fotografo, incarnato nello sguardo registrato e reso indelebile dalla fotocamera, poi replicato nello sguardo dell’osservatore dell’immagine, si incrocia fatalmente con lo sguardo della persona o delle persone raffigurate nell’immagine stessa. Roland Barthes, osservando una fotografia del fratello minore di Napoleone, esclamava con una certa meraviglia “Osservo gli occhi che hanno visto l’Imperatore!”. Sicuramente non avrebbe mai esclamato qualcosa del genere davanti ad un semplice ritratto dipinto, perché lo sguardo fotografato ha una forza ed un impatto che sono impensabili nella pittura. In fotografia lo sguardo, al pari della luce, assume infatti la valenza di un vettore, e si caratterizza per la direzione, l’intensità ed il verso. Lo sguardo dei personaggi raffigurati può essere rivolto verso il fotografo, ovvero verso l’osservatore dell’immagine, ed incrociare così lo sguardo di chi guarda. Mentre lo sguardo del fotografo è di solito caratterizzato da una curiosità più o meno intensa (quando non patologica), quello dell’osservatore dell’immagine oscilla fra i diversi gradini che separano l’interesse dal disinteresse, l’approfondimento dalla superficialità. Lo sguardo del personaggio raffigurato si articola invece in un numero di possibilità molto più esteso, può essere complice o infastidito, interrogativo o irritato, stupito o compiaciuto, umile o altezzoso, secondo una gradazione di emozioni che comprende tutte le sfumature dell’animo umano. Lo stesso sguardo può essere dritto e deciso, oppure può essere lanciato di sghembo, ruotando leggermente la testa, ma non gli occhi, o indirizzato dal basso verso l’alto abbassando la fronte. Talvolta lo sguardo rivolto verso il fotografo sembra attraversarlo senza vederlo, senza percepirne la presenza, concentrato su qualcosa che si trova alle sue spalle, verso qualche punto dell’orizzonte o dell’infinito. Ma lo sguardo del personaggio raffigurato può essere rivolto anche altrove, verso oggetti Fenomenologia dello sguardo o persone posti al di fuori dell’inquadratura, e di cui l’osservatore intuisce la presenza, immaginandola ma senza poterla verificare. Talvolta invece lo sguardo è rivolto verso qualcosa o qualcuno posto all’interno dell’inquadratura, con un effetto di corto circuito visivo, in cui l’osservatore dell’immagine vede il personaggio che guarda qualcosa che anche lui riesce a vedere. Se i personaggi raffigurati sono più di uno, nasce fra di essi un rapporto di sguardi che può essere semplice (nessuno dei personaggi guarda nessun altro personaggio) o variamente complesso. Tutti i personaggi possono guardare nella stessa direzione, diventando una cosa sola in base alle leggi della Gestalt, oppure guardano in direzioni diverse, dividendosi in due o più gruppi di cui uno generalmente prevale numericamente sugli altri, a meno di una perfetta simmetria di sguardi opposti. Se i personaggi incrociano gli sguardi si realizzano situazioni estremamente variabili, uno guarda l’altro essendo riguardato, oppure senza essere riguardato, oppure ambedue guardano uno terzo personaggio che guarda altrove, e lo fanno da punti di vista simili o diametralmente opposti, mentre il personaggio che guarda altrove può rivolgere, direttamente o indirettamente, lo sguardo verso uno solo degli altri, innescando dei rapporti complicati e tessendo una vera e propria rete di sguardi che l’osservatore dell’immagine sarà chiamato a decifrare e ad interpretare. Spesso lo sguardo è accompagnato da un gesto della mano che lo rende ancora più esplicito, ma vi sono anche degli sguardi nascosti. Come quello di chi indossa degli occhiali scuri, che rendono lo sguardo impenetrabile, alimentando così l’ambiguità della visione. 29 novembre 2014 pag. 10 Letizia Magnolfi [email protected] di P arlare delle origini di Prato e della Val di Bisenzio significa anche parlare della famiglia Forti. È stato questo il tema portante dell’incontro – curato dalla Fondazione CDSE – che si è tenuto sabato 15 novembre alla villa del Mulinaccio dal titolo “La storia della famiglia ebrea Forti e il tesoro della Sinagoga”. A parlarne sono stati studiosi e eredi della famiglia, soffermandosi sugli aspetti principali che hanno legato i Forti a questo territorio a Nord di Prato. Silvia Sorri, storica dell’età contemporanea, ha presentato la storia della famiglia a partire dalle origini. Nel 1882 i Forti, di origine ebrea, si trasferirono da Prato nella bassa Val di Bisenzio, e, da commercianti di tessuti, divennero proprietari di un lanificio a ciclo completo. Fu Beniamino Forti in particolare il creatore di uno stabilimento moderno che contava centinaia di operai provenienti da tutta la vallata. Intorno al 1890 nacque quella che si può definire una città-fabbrica: furono costruiti palazzi abitativi per gli operai, un asilo, una scuola, una biblioteca e altre strutture a carattere ricreativo e solidaristico. Promosse inoltre numerose attività formative per i suoi operai. La figura di Beniamino Forti e dei suoi successori si lega anche all’intensa attività politica e culturale della prima parte del ‘900. Nel 1912 infatti il lanificio Forti partecipò alla formazione dell’Unione Industriali; Beniamino Forti inoltre fu assessore alle finanze del Comune di Prato. Ma il ruolo che forse conosciamo meno della famiglia è quello di mecenate, una passione che vide i Forti stringere una profonda amicizia con Giorgio De Chirico. Come ci racconta Attilio Tori, è nella figura di Giorgio Castelfranco, marito di Matilde Forti, storico, critico dell’arte e anch’egli da parte di madre appartenente alla famiglia Forti, a cui si deve la cosiddetta collezione Forti – Castelfranco. Prima degli anni ’30 Castelfranco aveva raccolto più di 30 La famiglia Forti tra mecenatismo e solidarietà opere del padre della metafisica. Come si evince da alcune corrispondenze De Chirico chiamava Castelfranco proprio mecenate. Il pittore era molto affezionato al critico d’arte (dal 1936 direttore di Palazzo Pitti) e non disdegnava di chiedere molto spesso dritte lavorative, quando gli affari andavano male. La presenza in archivio di numerosi dattiloscritti testimonia lo stretto rapporto tra i due e l’interesse che Castelfranco nutriva per la pittura metafisica già dal 1918. È l’opera “Le muse inquietanti”, proprio del ’17-’18, senz’altro il dipinto più importante della collezione. Si tratta di uno spazio aperto sul quale sono situate in primo piano due statue classiche con la testa di un manichino da sartoria e circondate da diversi oggetti. Il critico Eugenio Borgna definisce le figure come intrise di angoscia e disperazione per l’anonimità dei volti, quasi a dare l’impressione di “un silenzio stupefatto e lacerante”. La forte relazione instaurata con i Forti è inoltre testimoniata da un dipinto, “Ritratto di Matilde Forti”. È un quadro del 1921, che dimostra l’interesse che De Chirico nutrì per l’arte Rinasci- mentale. Il volto ovale e l’espressione nostalgica della signora ricordano l’arte di Raffaello, che il pittore metafisico ammirava moltissimo. Il ritratto fu regalato da Matide Forti a Rodolfo Siviero, agente segreto e storico dell’arte, noto per la sua importante attività di recupero delle opere d’arte trafugate dall’Italia nel corso della seconda guerra mondiale. Altro dipinto facente parte della collezione Forti-Castefranco che però il pittore volle disconoscere, è “Autoritratto con colonna”. È con ogni probabilità il ritratto del 1919 che Siviero cita in un dattiloscritto dei primi anni ’40, ma che da De Chirico fu dichiarato come un falso. Siviero rispose prontamente, difendendo l’autenticità dell’opera. Anche questo dipinto fu donato a Siviero da parte di Matilde Forti nel 1943. Studi recenti hanno dimostrato che il dipinto è stato più volte rimaneggiato, con particolare riferimento alla colonna, al volto e alla capigliatura dell’artista. Queste e altre opere d’arte furono, come già detto, tutte vendute dopo il 1939. Castelfranco fu infatti licenziato da Palazzo Pitti per effetto delle leggi razziali e costretto a vendere le opere d’arte che servirono a pagare il viaggio in America dei figli. 29 novembre 2014 pag. 11 Alessandro Michelucci [email protected] di tiva lo affianca da Giovanni De Zorzi, ricercatore di Etnomusicologia all’Università “Ca’ Foscari” della città lagunare. De Zorzi è il più autorevole esperto italiano della materia, alla quale ha dedicato un bel libro intitolato Musiche di Turchia (EDT, Torino 2010). Ciascun seminario viene documentato da un disco. Il primo, Compositori alla corte ottomana L a repubblica turca che Kemal Atatürk fonda nel 1923 nasce con l’intento di cancellare il retaggio multietnico dell’impero ottomano per creare un paese con un solo popolo, una sola lingua, una sola cultura. Naturalmente questa omogeneizzazione spietata colpisce anche la musica. La furia giacobina del nuovo regime non vieta soltanto le espressioni musicali delle minoranze, ma anche le esibizioni pubbliche dei dervisci rotanti, manifestazione plurisecolare del sufismo islamico. Viene bandita dalla radio la musica classica ottomana, che secondo Atatürk “non riflette i veri valori della cultura musicale turca”. Ma una volta che la musica ottomana è stata “depurata” dalle influenze arabe, bizantine e persiane non rimane molto. Per sopravvivere, quindi, questa entità mutilata si ispira alla musica europea: il fondatore della Turchia è convinto che sia possibile costruire un paese moderno soltanto attraverso l’europeizzazione. In realtà si tratta di un etnocidio. Negli ultimi 15-20 anni molti artisti hanno lavorato intensamente per ricomporre questo Fabrizio Pettinelli [email protected] di Fra il 1833 e il 1846 il geografo carrarese Emanuele Repetti pubblicò un’opera di grande interesse, il monumentale “Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana”. In quel testo fondamentale, a proposito del termine “Affrico” scriveva: “Nome comune a molti rivi probabilmente derivato dal loro andamento verso la direzione del vento Affrico. Tali sono i piccoli torrenti (fra i quali) Affrico nel subborgo orientale di Firenze” Ora, con tutto il rispetto dovuto al Repetti, occorre dire che, almeno nel caso dell’Affrico “fiorentino”, ha preso un clamoroso abbaglio: l’origine del nome ce la spiega infatti nel “Ninfale fiesolano”, con dovizia di particolari e quindi senza tema di smentite, Giovanni Boccaccio, che si preoccupa anche, una volta per tutte, di chiarire l’etimologia degli altri principali corsi d’acqua fiorentini (fatta eccezione per l’Arno). (2013), proponeva opere di compositori provenienti dalle numerose comunità linguistiche e religiose dell’impero ottomano: armeni, greci, ebrei, turchi. Il secondo, Compositori armeni nella musica classica ottomana (2014), si concentra sul patrimonio musicale di questa minoranza. Se si eccettuano Erguner e De Zorzi la formazione dell’Ensemble Bîrûn è diversa, ma gli strumenti sono in gran parte gli stessi: def (tamburo a cornice), kanun (cetra su tavola), ney (il flauto suonato da Erguner), percussioni, tanbûr (liuto a manico lungo), ‘ûd (liuto a manico corto) e viella. Buona parte dei ventuno brani è stata scritta da compositori armeni attivi alla corte ottomana. La perizia tecnica e l’attenta scelta del materiale fanno del CD un’opera indispensabile per chiunque voglia conoscere la ricchezza musicale dell’impero ottomano. Le ampie note del libretto, scritte da Erguner, forniscono un complemento indispensabile all’ascolto. Bella e curata come sempre la confezione, che conferma la validità dell’etichetta udinese. Sarebbe bello se tutti facessero i dischi così. Analogamente a quanto fa la valenciana Mara Aranda con la musica sefardita, questi artisti ci danno la possibilità di conoscere un patrimonio musicale che rischiava di andare perduto. Lo stesso che Atatürk voleva cancellare. Col tempo, fortunatamente, l’effetto di questa politica sciagurata è diminuito fino a scomparire: oggi la Turchia risuona di mille musiche diverse, antiche e moderne, accogliendo le influenze straniere ma senza rinnegare il ricco patrimonio dei secoli passati. menti), che evidentemente aveva ereditato i cromosomi del nonno: infatti, non appena raggiunta l’età della ragione, pensò bene di insidiare una bella ninfa fino a farla capitolare con l’aiuto di Venere che, come noto, aveva in uggia Diana e non perdeva occasione per farle qualche sgarbo; dall’amore con la ninfa (il cui nome è a sua volta tutto un programma: Mensola) nasce un figlio che, infrattato fra i cespugli per sfuggire alla vigilanza di Diana, viene chiamato Pruneo (da “prunaio”). La tragedia incombe: credendosi abbandonato dalla ninfa, Africo si taglia le vene lungo un fiume che, arrossato dal suo sangue, prende il suo nome; l’occhiuta Diana non perdona Mensola e la trasforma in un corso d’acqua. Anni dopo, su consiglio di Apollo, capita da quelle parti Atlante che fonda una città che, con grande modestia, chiama “Tu fies sola” e, non si sa bene in forza di quale autorità, dona a Pruneo tutta la fascia di territorio compresa fra la Mensola e il Mugnone, con l’Affrico al centro: così Pruneo diventa signore di una terra delimitata da nonno e madre e attraversata dal padre. Il Comune di Firenze, nel 1956, confermò implicitamente l’etimologia del nome, contrassegnando la confluenza fra l’Affrico e l’Arno con una colonna, la cui iscrizione recita: “Il torrente Affrico, cantato da Giovanni Boccaccio, dalla sorgiva Fiesole qui si getta nell’Arno”. Suoni redenti mosaico infranto. Uno dei più attivi è stato Kudsi Erguner, musicista e musicologo turco. Nato a Diyarbakır nel 1952, Erguner ha studiato la tradizione sufi e si è imposto come uno dei massimi esperti di musica classica ottomana. Nessuno meglio di lui, quindi, potrebbe dirigere i seminari che la Fondazione Giorgio Cini di Venezia sta dedicando a questo patrimonio. In questa importante inizia- Via Lungo l’Affrico Fra la Mensola e il Mugnone Andiamo con ordine: Mugnone, nel poema citato, è un cacciatore che, vagando nei boschi della valle Faentina, “ad una bella fonte trovò una ninfa star tutta soletta”; neanche fosse re Carlo che tornava dalla guerra comincia ad inseguirla, e, quando la agguanta, lei gli cede senza troppo resistenza. Grave errore, perché Diana, signora delle ninfe, “di sul soprastante monte abbracciati li vide fronte a fronte” e, mentre scaglia un’unica freccia che inchioda insieme i due amanti, grida: “i vostri nomi faranno dimora nel fiume dove siete in sempiterno!”. Mugnone aveva un figlio, Girafone, a sua volta padre del pastore Africo (fra l’altro ai fiorentini suonava male la “f” singola, così la raddoppiarono senza tanti compli- 29 novembre 2014 pag. 12 Paolo Marini [email protected] di così-come-è: l’arte deve comunque supplire all’insufficienza della natura, senza l’aiuto dell’arte raramente essa è tollerabile. Così, uno dei più bei capitoli del libro è dedicato alla contrapposizione tra giardino all’italiana – con le aiuole dai contorni lineari, i parterres fioriti, i viali di ghiaia, le piante scolpite dall’arte topiaria e le fontane - e giardino all’inglese - con le libere ondulazioni del terreno, i prati verdi, gli alberi casualmente raggruppati, i liberi corsi d’acqua e i laghetti - nato come reazione, sì, “alle forme geometriche, regolari, architettonicamente pianificate, proprie del giardino all’italiana o alla francese”, ma questo giardino informale non S imulare ciò che non si è, dissimulare ciò che si è: voglio cominciare da qui a parlare di “Ars est celare artem” del filosofo Paolo D’Angelo (Quodlibet, pp. 176, € 13,50), un libro che ho letto tutto d’un fiato, poiché semplice ed elegante nel linguaggio ma prima di tutto accattivante nella ricostruzione storica dello sviluppo dell’argomento: dalla filosofia greca, dall’ars oratoria di Cicerone fino all’orinatoio, ai ready-made di Marcel Duchamp. Se l’argomento è il “nasconder l’arte”, l’Autore rievoca all’uopo il concetto di “sprezzatura”, neologismo coniato da Baldassarre Castiglione nel suo “Il Cortegiano”: “per dir forse una nova parola, usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi”. E’ gustoso, il Castiglione, quando ‘applica’ la sprezzatura, per esempio, all’impiego di cosmetici: “Non vi accorgete voi, quanto più di grazia tegna una donna, la qual, se pur si acconcia, lo fa così parcamente e così poco, che chi la vede sta in dubbio s’ella è concia o no, che un’altra, empiastrata tanto, che paia aversi posto alla faccia una maschera, e non osi ridere per non farsela crepare?” “Pars est eloquentiae eloquentiam abscondere” - diceva Seneca. Anche nell’oratoria forense è essenziale la capacità di nasconder l’arte, di occultare le capacità retoriche, facendo credere di parlare in modo semplice e non studiato. Ha scritto Flavio Filostrato nella “Vita di Apollonio di Tiana”: “nei giudizi l’eccesso di abilità, quando è palese, rischia di riuscire dannoso, quasi che congiurasse ai danni di chi dovrà emettere il verdetto; e solo se si dissimula può ottenere il successo, giacché l’autentica abilità sta nel nascondere ai giudici che si è abili”. Del resto, chi proverebbe mai compassione per le disgrazie di chi, in un momento di pericolo, vedesse enfatico, tronfio e intrigante venditore di eloquenza? Si dice “sprezzatura” ma anche, con qualche variazione semantica, “grazia”, “nonchalance” e quel certo “non-so-che” che include un’aura di mistero, di non spiegabile: il tutto però, si badi bene, non ha nulla a che vedere con la spontaneità, con la natura La più grande perfezione deve sembrare imperfetta Michele Morrocchi twitter @michemorr di Può un libro metterti una gran voglia di finirlo e contemporaneamente metterti una gran fame di ciccia? Può senz’altro se a scriverlo, insieme ad Alessandro Rossi già nostro direttore ai tempi del Nuovo Corriere, è Dario Cecchini, macellaio in Panzano, ristoratore, declamatore di versi, istrione. Il libro di cui parliamo è Aprilante, pensato, scritto e pubblicato dallo stesso Cecchini in quella che promette essere una collana da nome Nero di Ciccia, ça va sans dire. Aprilante è un giallo, un noir, una storia ingarbugliata che ha per protagonisti gli stessi autori, un bel po’ di abitanti di Panzano e dintorni (veri e verosimili) e che ruota su alcune morti misteriose e sulla bottega nasce certo da sé. Non di assenza, dunque, bensì di dissimulazione dell’ornamento, dell’artificio, si tratta. Perché, come dice il Tao: “la più grande perfezione deve sembrare imperfetta, e allora sarà infinita nel suo effetto; la più grande abbondanza deve sembrare vuota, e allora sarà inesauribile nel suo effetto”. Nasconder l’arte, anche nella moda. Di un dandy del Novecento, Drieu La Rochelle, François Mauriac soleva dire: “Era più che ben vestito: era ben malvestito”. La perfezione del vestire – così ha detto Baudelaire del dandy – consiste nella semplicità assoluta, che è poi il modo migliore per distinguersi. Ecco, volendo inverare e non già - come potrebbesi pensare – banalizzare quanto fin qui detto, voglio citare - fuori dal testo – il personaggio del Tenente Colombo; si, proprio lui, quello della felicissima serie televisiva che molti (me incluso) da sempre amano; quel suo mescolare una bonomia reverenziale, talora adulatoria, con una straordinaria trasandatezza, quante volte è servito a rassicurare, quante volte ha spinto il sospetto assassino a sottovalutare chi aveva di fronte ed ha, con ciò, spianato la strada al disvelamento dei fatti realmente accaduti? Quale impressionante capacità di interpretarli è riuscito a nascondere, il ‘povero’ tenente? Non è un fulgido, popolarissimo esempio di nascondere l’arte? I delitti del Chianti metton fame del cecchini, calamita di affamati di ciccia e verità. Così sempre in bilico tra la storia di paese, l’autocelebrazione e l’intreccio misterioso il libro scorre facile e avvincente tra un sushi del chianti, una caccia al cinghiale, un po’ di morti ammazzati e se alla fine rimani con un po’ dubbi e una sensazione di una troppa fretta nel chiudere la vicenda, ti sei intanto appassionato ai personaggi coloriti e colorati e chiudi il libro con la voglia di ritrovarli presto ad indagare. Il libro non è di facile reperibilità, lo trovate natural- mente a bottega dal Cecchini, all’edicola di Panzano, alla via dei Libri in via Martelli a Firenze oppure scrivendo una mail a [email protected] 29 novembre 2014 pag. 13 Valentina Monaco [email protected] di 4 minuti e 45 secondi. È il tempo necessario per leggere questo pezzo. Se non disponi di questo tempo non cominciarlo neanche. Perderesti tempo e il tempo è denaro, il tempo è tiranno, c’è tempo per ogni cosa e chi ha tempo non aspetti tempo. No, non sto collezionando frasi sul tempo per puro esercizio di stile, è solo che oggi come ieri, e come il resto della settimana, mentre scendo da un vagone e vengo spinta a pressione per entrare nel successivo, mi domando dove andiamo tutti così di fretta e perché. Dove, non sono fatti miei, ma il perché è lo stesso per tutti: non abbiamo tempo e quindi corriamo. A Madrid, Bogotà, Londra, Catania, Honk Kong o Teheran non abbiamo tempo e lo ripetiamo in tutte le lingue possibili, continuamente, come fosse un mantra. E allora mentre probabilmente a Nuova Delhi in metro si fa yoga o si levita – il che, a pensarci bene, sarebbe molto utile per ridistribuire in maniera più ottimale ogni metro quadro del vagone – e a Tokyo si sfogliano fumetti – evviva gli stereotipi – a Madrid, per non perdere neanche un minuto di tempo, in metro ci si trucca, si leggono 4 righe tra una fermata e l’altra fin quando qualcuno non ci costringe a mettere il libro elettronico o cartaceo sotto il mento, stile bavaglino, e poi si fa la maglia – eh sì, anche quello, visto che riscoprire gli antichi mestieri è cosi di moda ultimamente – si ripassa la lezione di storia o di musica e poi naturalmente si prendono appuntamenti o si flirta su whatsapp, digitando alla velocità della luce, si aggiorna l’agenda e si mandano milioni di email. Perché la Metro di Madrid non è solo colorata, moderna, veloce, pulita, grande, semplice, ma anche iperconnessa. Su qualche linea, nonostante la lenta discesa agli inferi sulle chilometriche scale mobili ci faccia sentire paurosamente vicini al nucleo della terra e la temperatura sia da foresta equatoriale, si continua a tenere la testa bassa e a digitare quasi ossessivamente PERCHÈ NON C’È TEMPO DA PERDERE! Certo, tutto ciò con il rischio di infilarsi in un vagone che va nella direzione opposta (la sottoscritta ha un master in questo tipo di perdite di tempo) o di saltare la Tempus Fugit propria fermata nonostante la voce metallica de doña MetroMadrid abbia dato l’avviso a tempo debito e ripetutamente. È tutto inutile, il tempo ci insegue e non c’è modo di fermarlo o di sdoppiarsi per fare più cose allo stesso tempo. Il tempo non si può prestare, scambiare né comprare, mmm, forse questo però si può fare... In effetti qualcuno ci ha già pensato e con il business del tempo ha creato un piccolo impero. Il motto dell’azienda madrilena di vendita del tempo è “Déjamelo a mi” che suona come un rassicurante invito ad affidarsi. Mi sembra quasi di vederlo il virile Direttore Marketing che fa l’occhiolino mentre dice “Niña, lascia fare a me, ci penso io”. È proprio questo quello che mi dice quando lo chiamo e inizio a spiegargli svogliatamente gli impegni dei prossimi giorni che prevedo di non riuscire A cura di Cristina Pucci [email protected] Cartello pubblicitario in latta serigrafata risalente alla prima metà del 1900. Vi si legge il nome del sapone ADRIA e della ditta che lo fabbricava, Pollitzer, Trieste. Augusto Pollitzer divenne proprietario dell’omonima fabbrica di sapone nel 1860, essa per molto tempo aveva prodotto solo il classico sapone bianco di olio di oliva, oggi detto di Marsiglia, e Augusto fu il primo ad impiegare la soda al posto della consueta cenere e ad ampliare e variare la produzione. Dopo un inizio difficile la fabbrica si espanse molto arrivando ad esportare i suoi saponi prima in tutto l’Impero Austro Ungarico e poi, con Alfred in tutto il mondo. Nel corso della prima guerra mondiale gli austriaci impiantarono a Lubjana una propria fabbrica di sapone usando materie prime e macchinari trafugati alla fabbrica Pollitzer. Rimessa in piedi alla fine del conflitto, raggiunse velocemente il successo di a portare a termine per ragioni di… guess what? Tempo! E così mi va sciorinando tutti gli obblighi e le commissioni di cui la sua azienda si farà carico al posto mio alleggerendo la mia to do list, nonché la coscienza. Potranno prenotarmi il volo per tornare in Italia a Natale cercando prima la migliore combinazione di prezzi e orari, assoldare una nuova donna delle pulizie che non mi inseguirà perché le ricompri i prodotti per la pulizia finiti da tempo, andranno in Ambasciata per recuperare il passaporto che ho rinnovato e abbandonato lì da settimane, ritireranno il cappotto in tintoria prima che arrivi l’estate e sulla base di precise indicazioni mi riempiranno il frigorifero ogni 3 giorni, cambieranno in profumeria un regalo non proprio gradito ecc. ecc… Mentre lo ascolto fantastico su tutte le cose che potrei fare se lo assumessi per i prossimi mesi: potrei andare a yoga 2 volte a settimana, iscrivermi al corso di photoshop, riprendere le lezioni di chitarra, recuperare la vecchia e sana abitudine dell’aperitivo il giovedì sera, il mercoledì andare al cinema in bianco e nero, andare in piscina in pausa pranzo... Ma con questa nuova agenda quando troverei il tempo di scrivere il pezzo della prossima settimana per CUCO, andare dall’allergologo, provare il menù per la cena di fine anno con i colleghi, fare la lista dei regali di Natale, andare a vedere il Re Leone a teatro e finire gli esercizi di portoghese che il mio prof ancora ottimista si ostina a darmi per casa? Ecco, siamo punto e daccapo. Così facendo non avrei più tempo, dovrei correre da un punto all’altro della città, dalla palestra al teatro, dalla piscina all’ufficio... Ma non sarà che il tempo di cui disponiamo in fondo è troppo e lo riempiamo come una valigia pensando che sia come quella di Mary Poppins? “Senta, mi scusi se la interrompo, la sua idea di comprare il tempo mi piace, è geniale, ma io non ho tempo di starla a sentire, per cortesia mi mandi un email e quando ho un po’ tempo la leggo”. Dalla collezione di Rossano Bizzarria degli oggetti prima. Nel 1938 si costituì come “Antiche Ditte Riunite Industrie Adriatiche”, ADRIA appunto, come si legge nella nostra placca pubblicitaria, che risale quindi a questo periodo. Le guerre, come tutti sanno o dovrebbero sapere, portano distruzione e morte, nel 1943, Direttore e maestranze della ADRIA furono imprigionati e materiali, prodotti e macchinari, di nuovo trafugati e confiscati con il beneplacito di un Commissario nominato dal Comando Tedesco e che, a guerra finita, fuggì impunito e, ritiratosi a Klagenfurt, suo paese natale, visse felice e contento dei suoi illegali proventi. Indennizzi di guerra non ve ne furono mai. Ultimo erede e capo di questa meritoria Ditta fu Andrea, personaggio poliedrico e cosmo- polita, organizzatore di spedizioni nel Caucaso, in Marocco e in Islanda e grande fotografo, fu proprio lui che nel 1962, visto il decadere dell’uso di saponi e il diffondersi delle lavatrici, ne decise con dolore, prima la chiusura e poi l’ abbattimento. Ed è proprio a lui che Trieste ha intitolato una strada e un Concorso Fotografico Internazionale. Tanti auguri il Portolano 29 novembre 2014 pag. 14 Periodico trimestrale di letteratura Fondato da Piergiovanni Permoli, Arnaldo Pini, Francesco Gurrieri Direzione: Francesco Gurrieri (Responsabile), Maria Fancelli, Ernestina Pellegrini Si pubblica a Firenze con l’Editore “Polistampa” “il Portolano” vede la luce a Firenze nel dicembre 1994 / gennaio 1995 . Nacque dalla convergenza di amicizia, amore per la scrittura e la critica letteraria, maturata inizialmente con Alessandro Bonsanti (in anni precedenti) da parte di Arnaldo Pini, Ferruccio Masini, Piergiovanni Permoli, Francesco Gurrieri; quest’ultimo coagulò, con impegno pragmatico, quelle potenzialità, facendovi convergere gran parte della cultura fiorentina, attivando la rivista. Fra i collaboratori vi sono stati o vi sono Sergio Givone, Giuseppe Bevilacqua, Claudio Magris, Ferruccio Masini, Enzo Siciliano, Alessandro Parronchi, Sandro Veronesi, Giorgio Luti, Mario Luzi, Sauro Albisani, Luigi Baldacci, Enrico Ghidetti, Marco Marchi, Maria Fancelli, Ernestina Pellegrini, Giuseppe Nicoletti, Anna Dolfi, Renzo Gherardini, Marco Fagioli, Mario Materassi, Stefano Lanuzza, Giovanna Mochi, Gloria Manghetti ed altri. “il Portolano” ha curato numeri monografici su Gadda, Vittorini, Hemingway, Malaparte, Saba, Pound, Betocchi, Luzi, Quasimodo, Baldacci, Parronchi, Quinto Martini, Bonsanti, 20 anni di lettere e letterati Sartre, Strati, Cases , Magris. Numerose sono le presentazioni e le incursioni critiche sulla letteratura in Europa. Sono stati dedicati interi numeri agli scrittori della “giovane Germania” e a quelli della “Globish Literature” inglese. Due numeri monografici (2008) sono stati dedicati alla poesia in Italia. Nel 2010 si sono raccolti contributi sulla “narrativa sociale” nel secondo Novecento, con particolare attenzione a Pasolini. Vi è particolarmente curata anche la redazione grafica, bandite le fotografie e ammessi solo il disegno e l’incisione , così da farne, a giudizio di molti, “una delle riviste più raffinate degli ultimi decenni”. “il Portolano” si è progressivamente consolidato nel tempo, come periodico di letteratura di area fiorentina, toscana e del centro Italia ed è giunto oggi al suo ventesimo anno di vita, col n. 76-77. Può ormai essere considerata come la rivista erede di quelle novecentesche , quali “La Voce”, “Campo di Marte”, “Il Frontespizio”; pertinace testimonianza letteraria cartacea a fronte dell’irreversibile avanzare informatico della “pagina on line”. Del “Portolano” c’è la consolidata consuetudine della presentazione alla sua uscita, effettuata in luoghi pubblici come i palazzi comunali, il Gabinetto Vieusseux, le grandi librerie. in giro 29 novembre 2014 pag. 15 Catherine de Zagon Immagini del Vietnam, realizzate nel 2007: persone, mercati, cibi, stili di vita di un paese esotico provato negli anni sessanta e settanta da una guerra lunga e devastante. Tutto può essere reso interessante dall’occhio fotografico, il più banale oggetto quotidiano, ogni forma persino inconsistente come quella di un’ombra o di una piega può rivelare aspetti inconsueti e misteriosi ignoti allo sguardo comune. Con un procedimento inverso la fotografia rende familiare l’esotico e nessuno tra i fotografi si sottrae all’attrazione di testimoniare le realtà osservate durante un viaggio. Cartier-Bresson dalla Cina riporta foto di cinesi, un’ovvietà all’apparenza, in realtà l’immagine fotografica constata, ferma cioè il momento che è destinato a essere velocemente sostituito dal Teatro solare Presentazione di Teoria, 1976, Mancamenti, 1978, Timparmonico, 1971: tre opere presentate a Villa Romana - dove Renato Ranaldi nel 1984 ha già esposto una serie di disegni raccolti nel volume Angherie - sono nuclei cellulari di un atteggiamento artistico che si realizza in un ricco dispiegamento di concetti e linguaggi adottati nell’arco di tempo di oltre cinquanta anni. Sabato 29 novembre ore 18.00 Renato Ranaldi The quick brown fox jumps over the lazy dog non è un ambigramma, non è un anagramma, non è un cronogramma,non è un lipogramma, non è un metanagramma, non è un paragramma, non è un tautogramma; non è una mostra in cui i media tracciano forme in grado di dialogare a livello estetico e metaforico; non è una mostra che comprende dodici disegni a carboncino di celebri dipinti dell’espressionismo astratto; non è una mostra su una lettura occulta del post strutturalismo, legata principalmente agli ultimi scritti di Roland Barthes; non è il nostro primo solo show istituzionale in Svizzera; non è una critica rigorosa al capitalismo contemporaneo; non è una mostra che mette in luce le connessioni tra una cosa e un’altra; non è una mostra che rivaluta la figura di un artista non famosissimo; non è una mostra collettiva che dovrebbe invece essere intesa come una “situazione” collettiva; the quick brown fox jumps over the lazy dog non è una nuova retrospettiva sull’arte povera; non ha a che fare con la new media art; non è una mostra di Art Brut; non è una soluzione plausibile tempo che tutto trasforma. Nelle realtà osservate in Vietnam da Catherine de Zagon è escluso ogni elemento turistico o puramente estetico come quello degli antichi edifici. Catherine de Zagon, nata a New York, è cresciuta a Firenze dove ha frequentato l’Istituto d’Arte. Ha vissuto in seguito a Parigi, Los Angeles, New York, Bruxelles. Di formazione internazionale è restata molto legata all’ambiente e alla cultura fiorentina e toscana. Tra i suoi interessi oltre alla fotografia ci sono la cucina e la moda. Attualmente vive in Abruzzo dove lavora nella moda Catherine de Zagon dal Vietnam al Caffè Letterario Gallery Le Murate Firenze 1- 29 dicembre 2014 Foto&Foto a cura di Elda Torres al senso di solitudine cosmica della specie umana; non è una speculazione aprioristica sulle falle e sui favoritismi del sistema arte; non è il final show degli studenti de la Ecole Cantonale d’art de Lausanne; non è il desideratissimo sequel di Final Fantasy VII; non è un nuovo film di Cristopher Nolan; non è un’antologica di pittura, the quick brown fox jumps over the lazy dog non è l’evento collaterale di “Shit and Die”; non include statement di Ludwig Wittgenstein, Gilles Deleuze o Giorgio Agamben; non è un percorso processuale per superare l’ansia da prestazione. Fino al 20 dicembre 2014 Galleria Pananti, viale del Poggio Imperiale 32, Firenze orari apertura: da lunedì al sabato 15.00 - 19.00 e su appuntamento (ones.officeproject@gmail. com) The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog Dopo il successo della prima edizione, il Teatro Solare presenta la seconda edizione de Il Sole d’Inverno, la breve stagione teatrale presso il Teatro di Caldine. In questa occasione verrà presentato Cinquanta! Epopea di un faticoso entusiasmo. Lo spettacolo (come già Farruscad e Cherestanì nel 2013) è stato realizzato in collaborazione con la compagnia fiorentina Teatro dell’Elce e nasce dalla raccolta di interviste a uomini e donne nati tra il ‘30 e il ‘40, che formano la base della drammaturgia. Cinquanta! Epopea di un faticoso entusiasmo* Cinquanta! Epopea di un faticoso entusiasmo è stato realizzato dalla Compagnia Teatro dell’Elce nel 2008 ed è presentato ora con un cast rinnovato di giovani attori. Lo spettacolo, selezionato per il Premio Scenario 2007, è stato distribuito sul territorio nazionale ed ha rappresentato l’Italia al Festival de Teatro por la Paz 2011 a Barrancabermeja (Colombia). Spettacolo non verbale, Cinquanta! narra l’epopea di un vivere quotidiano allo stesso tempo difficile e luminoso, l’avventura di quattro personaggi negli anni in cui la fatica necessaria a guadagnarsi da vivere era accompagnata dall’entusiasmo di un’epoca ricca di speranze. Il lavoro è il risultato di un processo di improvvisazione e scrittura scenica basato su fonti storiche, letterarie e cinematografiche, sulla consultazione degli archivi RAI e su interviste a donne e uomini nati tra gli anni ‘30 e gli anni ‘40. 1-2-3-4-5 dicembre 2014 ore 20:45 Teatro di Caldine horror vacui 29 novembre 2014 pag. 16 Disegni di Pam Testi di Aldo Frangioni Non meravigliatevi, i mostri che vedete, e vedrete nel futuro, sono immagini al microscopio: la realtà è molto, molto più piccola. Eliminate la meraviglia e cominciate ad essere fortemente preoccupati. 29 novembre 2014 pag. 17 Scottex L’ del riciclo arte Dopo la fortunosa serie di ben 100 Finzionari, recensioni di libri inesistenti, che a dire il vero, eran venute a noia anche a chi li faceva, inizia, con Culturacommestibile 101, l’analisi critica delle originali sculture in Scottex di Paolo della Bella noto artista poliedrico, polimorfico e polimaterico. Egli, da un po’ di tempo, si sta cimentando nella “scultura leggera”. L’opera “Raffreddore invernale” composta da centinaia di Kleenex usati è stata battuta alla recente asta d’arte varia di Baku in Azerbaigian per 152 Manat. Le recenti sculture, plasmate in purissimo Scottex, occupano tutta l’ala nord della Cartoteca di Romagnano Sesia. Nel catalogo del museo (che abbiamo curato insieme) spicca un lavoro, che la spirituale manipolazione dell’artista, richiama il linguaggio del primo Michelangiolo, o, se vogliamo, anche grazie ai pochi tratti di spiegazzatura espressionista, riesce a produrre un pathos paragonabile all’Urlo di Edvard Munch. 29 novembre 2014 pag. 18 L’Aquila 5 anni dopo di Davide Virdis per confotografia La città interrotta Frammenti di una ricerca di normalità www.davidevirdis.it www.confotografia.net L immagine ultima 29 novembre 2014 pag. 19 Dall’archivio di Maurizio Berlincioni [email protected] I l massacro di My Lai rimarrà per sempre nella storia dell’umanità come una delle stragi più assurde e orrende della guerra del Vietnam. A fine autunno del 1969, un numero imprecisato di civili vietnamiti disarmati, una cifra compresa fra le 350 e le 500 persone, uomini donne e bambini, furono sterminati a sangue freddo dalla compagnia C del primo Battaglione di Fanteria dell’esercito americano agli ordini del luogotenente William Calley Jr. Condannato in un primo momento all’ergastolo fu rilasciato solo dopo tre anni e mezzo di arresti domiciliari! Questo episodio è rimasto nella memoria collettiva mondiale come un insulto alle persone ragionevoli di ogni paese civile. In questo caso l’accostamento tra La Posada (la fattoria per cui stavano lavorando a cottimo questi raccoglitori, principalmente messicani, ma non solo) e My Lai vuole identificare nel capitalismo violento a stelle e strisce, i nemici giurati della classe operaia in genere e, in questo caso, dei lavoranti agricoli stagionali. Erano quasi tutti poveri migranti messicani, costretti a vivere con le loro famiglie in modo molto precario ai bordi di strade come queste, in attesa di essere chiamati per una giornata di lavoro da qualche altro “caporale” di turno. Gilroy, California, 1972
Scarica