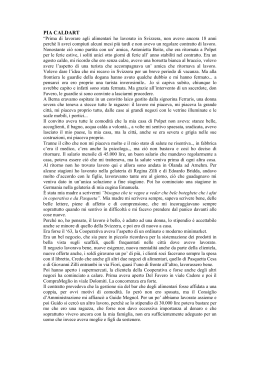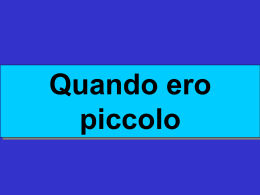Dedico questo libro A mio nipote Nicola. Se un giorno vorrà leggerlo Troverà un poco delle sue radici. B.G. 7 8 9 11 CAPITOLO PRIMO Prime ribellioni Vi presento Bianca Grasso, nata a Vercelli l'11 agosto 1926. Quando nacqui, mia madre, Rita, aveva quarant'anni e mio padre, Oreste, quarantadue. Mi accettarono come una grazia dal cielo, ma con un po' d'imbarazzo per la loro età avanzata (mio fratello Remo aveva sedici anni e mia sorella Egle quindici). Tanto è vero che la mamma, preoccupata e timida, andò a partorire in ospedale. La prima tragedia fu il parto. L'ostetrica mi procurò un trauma alla spalla destra, da cui derivò una paralisi permanente alla quale non fu più possibile trovare un rimedio. Mi volevano dare un nome diverso, ma il regime fascista non lo permetteva, perché era un nome russo. Mio padre, bracciante, aveva partecipato alle lotte sindacali, era un attivo sostenitore del circolo cooperativo del rione Isola. Venne poi assunto in una fabbrica di prodotti chimici. Con la guerra del 1915, a trentun anni, sposato con due figli, fu mandato al fronte, presso Monfalcone, per quattro anni. Mia madre lo sostituì in fabbrica, a fare lavori massacranti, per dodici ore al giorno. Mio padre, al fronte, nelle ore di tregua faceva diversi lavori con i bossoli vuoti delle cartucce e delle bombe, costruiva accendini, tagliacarte, braccialetti, che vendeva ai suoi compagni ricavandone soldi da mandare a casa, alla famiglia. In quel periodo scrisse un diario, che conservo tuttora e che è stato pubblicato e commentato sulla rivista "L'Impegno". Tagliacarte costruito a mano da mio padre, col rottame di un aereo austriaco abbattuto da Francesco Baracca 13 Mia madre aveva sempre lavorato in risaia, sin da quando le mondine erano costrette a prestare la loro opera dall'alba al tramonto, percorrendo a piedi vari chilometri al giorno. Partecipò alle lotte contadine del 1905-1909 per le otto ore, con sua nipote, Margherita Baucero detta Tin. Durante una delle manifestazioni di protesta, le guardie regie a cavallo scatenarono una carica e mia madre fu ferita al petto da una lancia; per evitare un ematoma applicò sulla lesione una fetta di lardo, come si usava a quei tempi. Dovette rimanere nascosta con altre scioperanti per più giorni, per sfuggire alle ricerche della polizia. Dopo qualche giorno, poiché non c'era niente da mangiare e la fame diventava insopportabile, mia madre mangiò la fetta di lardo che aveva usato come medicazione. Per quanto dedicò in difesa della dignità, della famiglia, per le sue lotte, mi sento orgogliosa di lei. Nel 1927, mia sorella Egle, sedicenne, fu arrestata dai fascisti, perché in casa nostra, nel corso di una delle frequenti perquisizioni a cui erano soggette le abitazioni degli antifascisti, avevano trovato tra le sue cose dei volantini di opposizione al regime. Data la sua giovane età, fu condannata a soli tre mesi di carcere, che scontò a Novara (allora nostro capoluogo di provincia). Era iscritta al PCI e aveva contatti con Nino Baltaro, Domenico Facelli (poi mandati al confino), Giuseppe Rimola (Nero) di Novara (poi emigrato in Russia), Maria Seccatore e altri antifascisti. *** A cinque anni fui portata all'asilo Filippi, ma l'ambiente non mi piaceva. Dopo sette giorni di quella brutta esperienza, scappai con un bambino diventato mio amico, pure lui con un'imperfezione fisica. Ci facemmo "scaletta" (una sulle spalle dell'altro), per arrivare a tirare il chiavistello del portone, uscimmo e andammo a giocare nei giardini della vicina piazza del duomo. Ci trovarono seduti tranquillamente tra le ali delle aquile del monumento. Non mi mandarono più all'asilo, rimasi a giocare nella mia "Bella Venezia", il grande caseggiato popolare del rione Isola. In quel periodo fui colpita dal virus della difterite, una malattia infettiva di cui c'era un'epidemia. Mi portarono in ospedale, con mia madre, nel reparto isolamento, dove rimasi per quaranta giorni (la quarantena). Mi riempirono di siero, finché guarii. A sei anni subii un intervento alle tonsille per le adenoidi. 14 Frequentando la prima elementare dovetti constatare che i bambini possono essere crudeli. Mi deridevano per il mio braccio diverso dagli altri, mi chiamavano brass a'stort (braccio storto). *** Il giorno della "Befana fascista" radunarono nella grande palestra tutti i bambini del plesso scolastico (circa quattrocento); ogni scolaro venne chiamato per nome e ricevette il "pacco", che conteneva una palla o un trenino per i bambini, una bambolina per le bimbe e cioccolatini, biscotti, mandarini. Soltanto io venni esclusa, perché i miei genitori si erano rifiutati di iscrivermi all'Opera Balilla e di farmi portare la divisa da piccola italiana (gonna nera e camicetta bianca). Tornai a casa triste, arrabbiata e umiliata; le compagne e le amiche erano tutte felici per i doni ricevuti, ma anch'esse incapaci di capire perché io sola ero stata esclusa. Vedendomi così infelice e piangente, i miei cercavano di consolarmi, ma io non riuscivo a capire. Arrivò mio fratello, che mi spiegò le ragioni per cui, il primo maggio, la polizia aveva preso lui, papà, la Egle e tanti altri lavoratori, trattenendoli in guardina per tutto il giorno. Non si trattava di una gita, ma di una misura di sicurezza per impedire la festa del lavoro, che sarebbe stata una manifestazione contro il fascismo. - Il fascismo - proseguì Remo - è quello che tu hai visto. Ci vorrebbe fatti tutti allo stesso modo e pronti ad applaudire quando gli fa comodo. Il fascismo è il partito dei padroni, quelli che si prendono la maggior parte delle ricchezze guadagnate con il faticoso lavoro delle mondine come la mamma e degli altri operai. I fascisti sono quelli che hanno dato i pacchi della Befana ai bambini, per influenzarli, educarli con le parole d'ordine del duce: credere, obbedire, combattere. Compresi meglio quando mi spiegarono che la Egle era stata imprigionata a Novara per tre mesi perché attivista comunista. Posso dire che il mio antifascismo nacque quel giorno, con la vicenda della Befana. Quell'episodio fu l'inizio della mia ribellione. *** Alle scuole elementari non ero un disastro, però non avevo voglia di fare quello che mi dicevano, un po' per ripicca, un po' perché ero diversa dagli altri; almeno, gli insegnanti e il direttore mi consideravano diversa, a parte la maestra Maria Grosso (pure lei un po' discriminata perché di religione protestante) che all'occasione prendeva le mie difese. Ero sovente in castigo in corridoio e, non sapendo che fare, aiutavo il bidello ad annaffiare i vasi dei fiori. 15 Per andare alle scuole Carducci si doveva percorrere tutta la via Trento, detta anche "strada rossa", poiché ai suoi margini una fabbrica di concimi depositava enormi cumuli di cenere rossa che arrivava fino al Cervetto, un canale che sfocia nella Sesia. D'inverno, quando nevicava, noi ragazzi andavamo su quelle montagnole e, sedendoci sulla cartella, facevamo grandi scivolate. Un gioco pericoloso, perché avremmo potuto sbandare e finire nell'acqua. Sul sentiero che costeggiava il Cervetto crescevano un'infinità di rovi e piante di more, di cui facevamo scorpacciate. Un giorno, la Renata ed io, mentre le coglievamo, ci spaventammo alla vista di una enorme biscia verde con la cresta di colore rossastro. Si immergeva e ricompariva, finché scomparve sotto il ponte. Rimasi talmente traumatizzata da conservare per tutta la vita un terrore invincibile per qualsiasi tipo di serpe. *** Mio padre aveva conseguito la patente di guida e faceva l'autista da quando io nacqui. Era pagato molto bene, per quei tempi, guadagnava 126 lire alla settimana e un "pintone" (bottiglione di circa sette litri) di vino. Facevamo la spesa nel negozio di alimentari del Clemente, vicino a casa nostra, e ogni settimana pagavamo il conto che si teneva su un apposito libretto. Alla domenica mattina avevo il compito di andare a comprare la carne al mercato coperto di San Marco, con uno o due "scudi" d'argento da cinque lire (da un lato c'era raffigurata un'aquila, per cui la moneta veniva chiamata anche "aquilotto"). Mia sorella sposò Bruno Gentile e da essi nacque Nerina, la mia prima nipotina. Era bellissima, ma piccola piccola; mio fratello Remo, con delle perline di legno, le costruì una mini-culla, che fu sistemata accanto alla stufa, da cui la piccina poteva ricevere il calore necessario. Nel 1935 mio fratello sposò Giulia, che abitava a Strona. Il matrimonio si celebrò nel comune di residenza della sposa e per andarci mio padre affittò un'auto, una "Balilla", nella quale riuscimmo ad entrare in otto persone. La povera vettura arrancava nelle salite di montagna, ma fu un viaggio appassionante. Da loro, nel 1937, nacque Mirella, la mia seconda nipotina, bionda e bellissima. Quando terminai le scuole elementari, la dittatura fascista e il clero obbligarono i miei genitori a farmi ricevere i sacramenti (ero stata solamente battezzata). Mi fecero confezionare un vestito bianco con della fodera a buon mercato e mi comprarono un paio di scarpe bianche da tennis. 16 La mia prima comunione, a dieci anni 17 Alla cerimonia, che si svolse nel duomo, oltre che per il vestito scadente spiccavo tra gli altri bambini per la mia statura. L'età media degli altri comunicandi era di sei anni ed io ne avevo dieci. Finita la funzione, saltai a cavallino tutti i paracarri davanti al duomo. Era consuetudine portare i bambini al bar a prendere la cioccolata in tazza con i biscotti. *** Le condizioni economiche piuttosto buone della mia famiglia consentirono a mio padre, nel 1939, di comprare un apparecchio radio, che allora costava parecchio; il nostro, pur essendo di seconda mano, funzionava perfettamente. Eravamo tra i pochi fortunati che disponevano di due camere in affitto; certe famiglie composte da sei-otto persone vivevano in una sola camera. Per ascoltare buona musica, canzonette, opere e commedie, i vicini affollavano il nostro alloggio, si facevano anche turni di otto-dieci persone. Quando eravamo soli, riuscivamo a captare le stazioni estere, in special modo "Radio Londra", rigorosamente vietata, perché si trattava di una trasmissione antifascista in lingua italiana. La radio forniva l'occasione di stare insieme, stringere rapporti cordiali ed amichevoli. *** Dopo le elementari, ci riunivamo in squadre di dieci, quindici ragazzi e ragazze, dedicandoci a tutta una serie di giochi e svaghi. Andavamo spesso alla Sesia (mio padre mi aveva insegnato a nuotare quando ero molto piccola). Si partiva al mattino, accompagnati da qualche adulto, portandoci qualche panino, e si tornava alla sera, trascorrendo le giornate a giocare, nuotare, prendere il sole e a fare tutte le cose che si fanno da giovani per stare allegri. C'erano i cubi di cemento per rafforzare gli argini contro le piene, dai quali ci tuffavamo. Un giorno, Rosanna, della nostra squadra, ammirando le nostre esibizioni, mi domandò : - Pensi che sarei capace di farlo anch'io ? - Certo, non è difficile; hai visto, no ? Tutta entusiasta, si tuffò, ma quando riemerse si mise a gridare : - Non so nuotare, venite a prendermi...! In quel punto l'acqua era molto alta; per fortuna alla domenica la spiaggia era frequentata da intere famiglie. Vicino c'era mio padre, che si tuffò e la trasse in salvo. Rosanna era imprevedibile, ignoravamo che non sapesse nuotare. Ma da quel giorno imparò. Un giorno attraversai il fiume facendo una gara con i ragazzi più grandi - mi accettavano volentieri e ci si sfidava a vicenda.- Salii sulla sponda opposta, passando una specie di guado con pietre molto grosse, per tornare dal lato di partenza che chiamavamo "il boschetto". Quando arrivai a circa dieci metri dalla sponda vidi una grossa biscia che dalla riva veniva verso di me. Svenni per lo spavento e mi dovettero ripescare perché l'acqua mi stava trascinando via. *** Papà e mamma erano angosciati vedendo quanto soffrivo per il mio difetto al braccio. Durante l'infanzia mi avevano portata da diversi 18 specialisti, perfino a Firenze (a quei tempi non era facile spostarsi, sia per la spesa che per la distanza), ma tutti dicevano che ero affetta da paralisi infantile, perciò non emendabile. Tra i cinque e i sei anni venni sottoposta a lunghissimi cicli di applicazioni elettriche, tanto dolorose (ancora oggi, se appoggiassi un dito sull'omero, risentirei il dolore e le vibrazioni elettriche). Tutto era stato inutile. Avevo dodici anni quando arrivò da Torino un rinomato chirurgo, il professor Pecco. Papà mi portò pure da lui, pagando una parcella salatissima. Terminata la visita, il professore dichiarò che avevo una frattura tra la spalla e l'omero, bastava praticare subito un bendaggio e l'articolazione sarebbe andata a posto. - Come chirurgo - disse,- tenterei l'operazione; come padre, la lascerei così; intanto, vede, il braccio lo usa bene. Un intervento adesso, con questa anchilosi, potrebbe paralizzare l'articolazione. Un giorno, forse, sarà possibile... Fu così che la nostra grande speranza tramontò definitivamente. *** A quattordici anni, mio fratello cominciò ad affidarmi alcuni compiti di responsabilità. Con la mia cartella di scuola, non sospettabile come gli adulti, potevo trasportare dei libri messi all'indice dal fascismo, che ci procurava il signor Giovanni Giovannacci, la persona più gentile e affabile che io conobbi, un libraio antifascista che aveva il negozio sotto i portici di piazza Cavour. Portavo i libri a Nino Baltaro, Pino Graziano, Mario Serassi e altri militanti antifascisti. Erano libri proibiti e questa mia attività mi inorgogliva, perché mi attribuiva una eccezionale responsabilità. Mio fratello mi aiutava, era informato di tante cose tramite l'organizzazione clandestina del partito. Era abbonato alla rivista "Relazioni internazionali", obbiettiva e democratica, che dopo qualche anno venne soppressa dal regime fascista. Lessi alcuni dei libri, "Il tallone di ferro" di Jack London e "Il capitale" di Marx, ma ne capivo ben poco. Più tardi, nelle formazioni partigiane, quando si faceva l'ora politica e il commissario leggeva e spiegava brani di questi libri, compresi il significato di quelle pagine che a quattordici anni trovavo incomprensibili. *** Con papà iniziai presto, nelle domeniche d'estate, a fare lunghe gite in bicicletta. Le strade erano di terra battuta e cosparse di ghiaietta, sulla quale 19 Mio padre Oreste a 47 anni, in tenuta da ciclista 20 era facile slittare e sbucciarsi le ginocchia. Per il "giro dei laghi", di 183 chilometri, si partiva al mattino alle cinque; il percorso comprendeva Gattinara, il Lago d'Orta, Omegna, Fondo Toce e Intra. A Pallanza si sostava e si faceva il bagno. Al ritorno passavamo da Stresa, una bella cittadina con molti turisti, quasi tutti svizzeri, perché dalle nostre città erano ben pochi a potersi permettere una gita sul lago. Dopo il pranzo si girellava ammirando il paesaggio; un altro bagno, una merendina e poi in sella: Arona, Novara e Vercelli. Si arrivava a casa verso le otto di sera. Papà, bravissimo nel "fai da te", pensò di costruire un tandem, unendo le varie parti di due biciclette. Ne costruì due perfetti. Con questi facemmo una gita fino ad Oropa, con le mie amiche Silvia e Giovanna. Ci fermammo a dormire all'ospizio del santuario, dove si affittavano camere ai turisti e pellegrini. Per due giorni compimmo scalate e lunghe passeggiate, fino al Mucrone. Al ritorno, scendendo da Oropa, la discesa era talmente ripida che aiutavamo i freni tenendo un bastone schiacciato sul pedale e premuto contro il suolo, come facevano i montanari. Ad un tratto si ruppe la forcella anteriore, che univa il manubrio al telaio del tandem su cui viaggiavamo Giovanna ed io. Facemmo un brutto volo, per fortuna senza farci alcun male. Riuscii a formare un gruppo di cinque ragazze per una gita ai laghi, ma giunte a Gattinara, che distava trentacinque chilometri, le mie amiche si fermarono, dicendomi che erano stanche e sarebbero tornate a casa. A Vercelli, quando avevo quindici anni, portare i calzoncini corti era considerato scandaloso; eravamo solo in due ragazze, in città, a portarli, io e la figlia di un commerciante di motociclette. Quando la gente ci vedeva in tale succinto costume, ci indirizzava qualche parolaccia, ma nel mio rione nessuno si scandalizzava, conoscevano la mia famiglia e ci rispettavano. Le mie coetanee mi invidiavano: - Sei fortunata, ad avere genitori che ti permettono una tenuta così sportiva e comoda. I calzoncini noi li portiamo solamente quando andiamo allo stadio Robbiano a fare ginnastica. I miei famigliari mi permettevano di fare gite anche da sola, talvolta con la bicicletta da corsa di mio fratello. Un giorno decisi di fare il solito giro dei laghi. Avevo un po' di soldi e tante idee, per esempio quella di pranzare a Stresa in qualche bel ristorante. Prima di pranzo, cercai una spiaggia per fare un bagno. Ne vidi una deserta, attraverso un cancelletto aperto sulla strada. Non c'era nessun cartello con divieti, misi dentro la mia bicicletta, discesi alla spiaggia e mi tuffai. Stavo risalendo sulla riva, quando mi sentii apostrofare da un uomo molto irritato: - Voi, che cosa ci fate, qui dentro ? E' proprietà privata - (con il regime autoritario fascista era stato abolito il "lei" e reso obbligatorio l'uso del "voi"). - Ho visto il cancello aperto - risposi, - non c'era nessun divieto. Mi sono meravigliata e non mi pareva di commettere qualche infrazione, perciò sono scesa. Vi chiedo scusa. Quella gente doveva essere ricca per avere anche un motoscafo. Comunque, quel signore fu ragionevole e comprensivo. Infine ci salutammo con una stretta di mano. 21 Tornai al mio programma, avvicinandomi ad un bell'albergo, con un giardino sul davanti. Una larghissima gradinata portava ad uno spiazzo con dei tavolini, alcuni occupati da turisti che stavano pranzando. Non c'era molta gente (le macchine erano rarissime, in maggioranza svizzere). Parcheggiai la bicicletta e mi avviai per pranzare, ma i miei calzoncini corti destavano indignazione. Si avvicinarono due camerieri, mi guardarono dall'alto al basso con evidente disapprovazione e mi domandarono che cosa volevo. Chiesi di pranzare. Alla fine di una piccola discussione, mi fecero accomodare ad un tavolino piuttosto appartato. Là seduta me la ridevo; fu veramente una vittoria contro i pregiudizi di mezzo secolo fa. *** Mia sorella aveva mandato sua figlia Nerina, che aveva otto anni meno di me (io ne avevo sedici) in colonia a Brolo, sul Lago d'Orta. Ero molto affezionata alla mia nipotina, perché dormiva nella mia camera ed era molto timida e delicata. Qualche giorno dopo la sua partenza, pensai di andare a farle visita. Dissi a mia sorella : - Senti, Egle, vorrei andare a trovare la Nerina, che ne dici? - Oh, bene, và pure. E' la prima volta che va lontano da casa ed è sola. Se non le piace, se non vuole più restare, sei capace di riportarla qui ? La rassicurai. Presi la bicicletta da uomo, infilai un cuscino nello zaino e mi misi in viaggio, arrivando a Brolo in mattinata. Alla colonia, gestita dalle suore, mi presentai, declinando le mie generalità e la mia qualità di zia della piccola. Le suore chiamarono la cuoca, la signora Giuseppina (zia di Nerina dalla parte di suo padre), e questa mi accompagnò lungo un viale, finché vidi la piccola, sola, seduta su un cordolo del giardino. Appena mi vide, mi corse incontro, esclamando: - Zia Bianca, sei venuta a prendermi ? - Perché, non ti piace stare qui ? - No. Mi fanno dire le preghiere quattro volte al giorno e non mi danno da mangiare quello che io desidero. Vorrei tornare a casa mia, non mi piace stare qui. Non ci sono le mie amiche, queste non le conosco nemmeno. Che potevo fare ? Ascoltai la bambina per un po', cercando di convincerla. A un certo punto, visto che il posto non piaceva nemmeno a me, mi rivolsi alla direttrice: - Senta, la mamma della bambina mi ha autorizzata a riportarla a casa, 22 se non fossi riuscita a convincerla a rimanere. Torniamo a Vercelli tutte e due. - Ma voi non potete, dove la mettete ? Non andate mica a casa a piedi... - Per quello ci penso io, suora. Accompagnai Nerina a raccogliere le sue cose, tirai fuori il cuscino dallo zaino, lo sistemai sulla canna della bici e vi caricai la bambina. Salutammo tutti e partimmo. Per strada, le domandai: - Non hai mai visto il Lago Maggiore, vero ? Ti piacerebbe vederlo ? - Si, zia, vedo sempre solo questo, che è sempre grigio... Mi avviai verso Fondo Toce e quindi a Pallanza. A Stresa mangiammo i panini che avevo con me e ci riposammo, con i piedi immersi nell'acqua del lago. Nel pomeriggio feci un bagno in previsione di tutti i chilometri che dovevo coprire. Arrivate ad Arona, scoppiò un grande temporale. Ci fermammo in un bar, per ripararci e prendere un bicchiere di latte. Un signore e sua moglie ci guardarono, colpiti dal fatto che eravamo inzuppate d'acqua, e ci domandarono : - Ma da dove venite, bambine ? Raccontai un po' la storia della colonia e del nostro ritorno con visita al Lago Maggiore. - Dovete andare a Vercelli ? Sentite, noi abbiamo un camioncino per trasportare merce e siamo diretti ad Alessandria; per tornare a casa passiamo da Vercelli. Anche rischiando di prendere una multa, possiamo caricare dietro la bicicletta e farvi salire con noi in cabina. Così, un po' pigiati, ma al riparo, ci portarono fino a Vercelli; passato il ponte della Sesia, a Porta Milano, la pioggia era cessata. Ringraziai i signori per la loro gentilezza e tutto finì bene. Facevo grande uso della bicicletta di papà, mi capitava di fare gare di corsa o lunghi giri. Un giorno caddi e sfasciai tutta la ruota davanti. Mio padre mi somministrò un sonoro ceffone. Era la prima volta che mi percuoteva e fu anche l'ultima. In bicicletta mi recavo spesso a Tronzano, dove c'erano i miei zii e mio cugino Walter con i suoi amici. Qualche volta andavamo tutti assieme fino al lago di Viverone, dove si facevamo lunghe nuotate. Nel mio caseggiato, bambini e ragazzi erano tantissimi. Norma aveva otto fratelli, Maria ne aveva sette. Eravamo molto affiatati, quasi tutti figli di 23 operai, braccianti e mondine; di studenti tra noi ce n'erano pochi, perché a quei tempi gli studenti erano figli dei ricchi, i soli con le possibilità di pagare le tasse e le spese scolastiche. Noi li guardavamo con profonda avversione, anche perché quando era scoppiata la guerra di Abissinia quasi tutti gli studenti si erano pronunciati a favore del conflitto, per la "conquista dell'impero", inneggiando alla guerra con sfilate e gagliardetti. 24 Tra i nostri giochi c'era la costruzione di casette sugli ippocastani; imitando Tarzan, ci issavamo sugli alberi con le corde. Si giocava alla "settimana" e a "guardie e ladri"; si andava a pescare le "sgrappe" (cobiti) nei fossi e ci si divertiva in molti altri modi. Ero forse l'unica ragazza del rione che giocava al pallone con i ragazzi. C'era una squadra, con Nino, Ennio, Bruno, Lucio, Tonino, che andava a giocare al campo di Marte, oltre il fiume Sesia, in un grande campo di calcio aperto a tutti i ragazzi di Vercelli, che lo usavano a turno. Un altro tipo di svago era costituito dal cinematografo. Il cinema che, con le mie amiche, frequentavo di più era il Corso, molto popolare; prendevamo i biglietti dei primi posti per non essere esposte a rischi e molestie. Qualche mio dipinto CAPITOLO SECONDO Alba di guerra 25 Mi piaceva dipingere e disegnare. Un giorno portai i miei disegni all'Istituto delle Belle Arti, dal professor Cerallo. Dopo averli esaminati, disse che col tempo e con una buona educazione artistica, un indirizzo diverso, avrei potuto accedere all'Accademia Albertina. Dopo qualche breve e amara riflessione, scartai la pur bella prospettiva. Come avrei potuto accedere all'Accademia, se mi erano vietate le scuole medie, che dovetti frequentare da privatista? Papà tuttavia, volle incoraggiare la mia vocazione e mi mandò a scuola da suor Ester, una sua nipote di secondo grado, delle monache di Maria Ausiliatrice. Era una brava professoressa di pittura, di pianoforte e di francese. Esaminò i miei disegni e fu lieta di avermi come allieva per poter arricchire la mia formazione artistica. Mio padre era soddisfatto, sperava che imparassi qualche cosa. In quindici giorni dipinsi tre quadretti, sempre nature morte in un portafrutta. Erano buoni quadri, suor Ester insegnava bene. La scuola era un istituto di suore per ragazze, a pagamento (si pagava molto caro). Il difficile era l'ambiente; dovevamo vestire un grembiule con le maniche lunghe, calze lunghe, tutto in nero, in piena estate; sia all'entrata che all'uscita dovevamo recitare le preghiere. Dopo due settimane mi ero stancata del grembiule e di tutto il resto; le nature morte mi erano venute tanto in odio che non ne dipinsi più in tutta la mia vita. Così incominciai a marinare metodicamente la scuola. Uscivo al pomeriggio con papà e ci lasciavamo all'angolo di via Trento; anziché recarmi all'istituto, me ne andavo in bicicletta fino a Novara, distante una ventina di chilometri, a prendere il gelato al caffè Coccia, il più grande e rinomato della città. Il tempo dell'andata e del ritorno corrispondeva esattamente alle quattro ore di scuola. Dopo quindici giorni di questi sotterfugi, suor Ester interpellò mio padre, domandandogli se ero malata, poiché non mi vedeva da due settimane. Papà mi chiese spiegazioni. Gli dissi che ero stanca del grembiule, delle calze, delle preghiere e delle nature morte, non ci sarei più andata. Papà capì la situazione e mi concesse pacificamente di concludere questa esperienza. *** Quando, nel 1939, Mussolini venne a Vercelli, ci fu una grande manifestazione, con tutta la città imbandierata. La piazza Mazzini, un grande prato senza alberi sul quale si affacciava il balcone della Prefettura, era affollatissima; la gente si accalcava come le acciughe nel barile. Tutte le donne avevano il cappello di paglia delle mondine, con la scritta "viva il duce". Vercelli era (come oggi) la capitale europea del riso, perciò bisognava essere all'altezza della situazione e presentare le mondine, come simbolo della provincia; gli uomini avevano il fez, Erano ridicoli. Mentre monologavo a voce alta su questi argomenti, si avvicinò un giovane, coi capelli rossi. Mi domandò perché imprecavo e non applaudivo. Risposi che non mi importava nulla di quell'uomo e di tutta quella gente, che ritenevo tutto una farsa. Era un poliziotto in borghese; mi prese per un braccio e mi avviò verso la questura, ma dopo pochi passi mi lasciò andare, dicendomi : - Va’ via. In fondo, anch'io non condivido tutto questo. In quell'occasione, mio fratello Remo era stato tenuto in guardina per tutto il giorno, come tanti altri antifascisti, quale misura precauzionale a scanso di incidenti e attentati. *** L'Italia entrò in guerra e Mussolini dispose la raccolta di oro, argento, rame e ferro. Mamma nascose nel "baraccone" che serviva da ripostiglio tutto il rame che possedevamo, padella, paiolo, mestolo, dichiarando di non avere alcun oggetto da offrire. Quanto all'oro, spiegò che non portava l'anello per via dell'artrite e non poteva consegnare nulla, che non ne possedeva. In realtà aveva anelli, catenella, spilla, orecchini d'oro, che mi regalò poi, per farli fondere e ricavarne le vere per me e mio marito, quando ci sposammo. In periodo di guerra si faceva tanta fame, tutti i generi alimentari erano razionati. Avevamo duecento grammi di pane al giorno (trecento per chi lavorava), cento grammi di riso o pasta e pochissimi altri generi; lasciavo volentieri una parte del mio pane a papà, che lavorava. In quegli anni mangiai grandi quantità di patate, cucinate in diversi modi: bollite, tagliate e 26 condite con conserva di pomodoro e sale, oppure in insalata, con olio e aceto. Il sale era scarso e difficilissimo da reperire; l'olio era di semi di ravizzone, con un orribile e inspiegabile sapore di petrolio. Per integrare gli insufficienti viveri razionati, si doveva ricorrere alla borsa nera spendendo moltissimo. Anche se papà aveva una buona paga, i soldi non bastavano mai. In estate e in autunno, quasi tutti noi del rione andavamo a spigolare il grano, il riso, il mais. Qualche volta non si spigolava soltanto, ma si prelevava dai covoni o si mieteva direttamente. D'altra parte, era tutta roba che gli agricoltori dovevano poi conferire all'ammasso, per il governo fascista. Un giorno, con mia sorella, dopo aver riempito un sacco ciascuna di pannocchie di mais, ci accingevamo a saltare la Sesietta, una roggia larga più di due metri, che si trovava sulla via del nostro ritorno. Ma i sacchi erano pesanti e il balzo non era tanto facile. Mia sorella lanciò il suo sacco sull'altra riva e saltò; quando sentiti i cani del padrone che stavano sopraggiungendo, mi buttai il sacco in spalla, e saltai al volo dall'altra parte, certamente battendo un record. Per il riscaldamento, si andava a tagliare alberi per fare legna da ardere, oppure nelle discariche della stazione a raccogliere il carbone scartato dalle locomotive. Mamma non usciva mai, era sofferente di artrite, e dovevamo mantenere in casa un minimo di tepore. *** Nel rione circolava una serie curiosa e divertente di ambulanti. Veniva il carro che portava la biancheria, lenzuola, coperte, camicie. Di solito erano confezionate in valigie che l'ambulante metteva in vendita, contrattando il prezzo con il suo linguaggio colorito. Passavano l'arrotino con la sua mola a pedale, il vetraio con i vetri in una specie di gerla che teneva sulle spalle, l'ombrellaio che annunciava la sua professione con un allegro motivetto musicale. C'era lo spazzacamino, di solito accompagnato da un bambino che mi faceva tanta tristezza; forse prendeva con sé un bambino perché poteva andare su per il camino con la scopa di ferro. Quando venivano nel rione il teatro dei burattini o i saltimbanchi, per noi ragazzi erano grandi avvenimenti. Erano i nostri svaghi. *** Nel 1942 andai a lavorare per la prima volta, nella fabbrica che allora si chiamava Chatillon. Ero nel turno dalle quattordici alle ventidue, nel reparto 27 rocche (così si chiamavano le grandi macchine che avvolgevano il filato). Dovevo badare a sette macchine. Nel reparto c'era un rumore d'inferno, così assordante da spaccare i timpani. Il capo reparto era un fascista che le donne chiamavano Cordini, ma io ignoravo che fosse un soprannome. Quando ebbi bisogno di lui, già tutta fuori fase per quel rumore inconsueto, andai a cercarlo; lo vidi in fondo al capannone, che stava per uscire. Lo chiamai ad alta voce: - Signor Cordini ! Lui mi si avvicinò e disse: - Che vuoi, figlia di puttana ? Io non mi chiamo Cordini, chi ti ha detto questo nome? - Tutto il reparto vi chiama con questo nome. Ma il 'figlia di puttana' lo tenete per voi, maleducato. Potevo rispondere a quel modo perché non temevo di essere mobilitata. A quei tempi, infatti, i lavoratori potevano essere arruolati a forza nell'organizzazione Todt, soggetta ad una disciplina rigidissima. Ero esente dalla mobilitazione perché munita di una certificazione medica attestante l'inabilità al lavoro a causa del mio braccio. Tornai alle mie macchine e all'ora di cena, preso il mio pacco del cibo, mi rinchiusi nel gabinetto fino alle dieci, senza mangiare, quindi tornai a casa. Trovai tutta la famiglia riunita in attesa, con mia madre agitatissima. Era la prima volta che andavo a lavorare e sapevano che nel reparto delle rocche il lavoro era un inferno. Mio padre mi domandò com'era andata. Ero furibonda e anche un poco intimorita, non sapevo se mi avrebbero fatta ritornare là dentro. Raccontai il fatto accadutomi e che avevo saltato la cena. - Non mi sarebbe andata giù. Mi ha chiamata 'figlia di puttana'. Ero così arrabbiata che avrei voluto ucciderlo, ma non sapevo come fare, non ho potuto. - Non andarci più - sentenziò mio padre. Mi licenziai, presentando la mia certificazione di invalidità. Così si concluse il mio primo giorno di lavoro. *** Ebbi un'altra esperienza. Giovanna ed io avevamo letto l'inserzione di una piccola fabbrica tessile e andammo a vedere. Si diceva che questo signore assumeva molte ragazze, anche sei o sette per volta, ma alla fine della settimana non le pagava, sostenendo che erano state in prova e, non 28 essendo risultate idonee, non avevano diritto alla paga. Insomma, ogni settimana aveva sette-otto ragazze che lavoravano gratuitamente. Ci consultammo: - Beh, adesso vediamo come si comporta. Infatti, fummo assunte e lavorammo per una settimana. Al sabato, il proprietario non c'era e la caporeparto ci comunicò che non eravamo idonee. - Ritorneremo lunedì a prendere il grembiule e a parlare col padrone. Lunedì il proprietario non era presente La capa confermò che, non avendo superato la prova, non ci spettava alcuna paga. - Va beh, andiamo a prendere i nostri grembiuli. Quando fummo nel reparto, dove non c'era nessuno, proposi a Giovanna di sabotare i motori di alcune macchine, infilando robusti uncinetti di metallo nei fori di lubrificazione. Così il cavaliere si trovò costretto a sostituire buona parte del suo macchinario. *** Dopo quell'episodio, andai a lavorare alla riseria Bianchi, nel reparto in cui si produceva il surrogato di caffè, rimanendovi per dieci mesi. Ero addetta alla macinazione della liquirizia, uno degli ingredienti del surrogato. Nel reparto eravamo circa una sessantina di operaie. Ogni tanto, qualche ragazza mi chiedeva un po' di liquirizia ed io, di nascosto, glie ne lanciavo qualche pezzetto. Un giorno sbagliai il lancio e la liquirizia finì sulla scrivania del caporeparto, il signor Emilio, che tra l'altro era cugino del padrone. Questi si infuriò e volle sapere chi era l'autore del lancio. Le operaie non mi denunciarono. Ad un certo punto il capo minacciò di dare a tutte venti soldi di multa se non si rivelava il nome della colpevole. Preferivano subire la punizione piuttosto che denunciarmi. Una sola alzò la mano e disse il mio nome. Si chiamava Giovanna (non la mia amica, un'altra Giovanna). Subito le dissi che era una brutta spia e che l'avrei aspettata fuori. Quando uscimmo a mezzogiorno, non ascoltai le raccomandazioni delle compagne, che mi dicevano di lasciare perdere, non le avrebbero più parlato, era protetta. L'aspettai davanti alla fabbrica fino alla mezza, quando uscì con gli impiegati, in bicicletta. La invitai a fermarsi per parlare con me, ma lei rispose in malo modo. A quel punto l'afferrai per una spalla tirandola giù dalla bicicletta. Naturalmente cadde ed io la presi a pugni, allo stomaco. Nella mia foga - certamente eccessiva, pensandoci adesso - colpii 29 anche un impiegato, intervenuto per dividerci, rompendogli gli occhiali. Mi avviai verso casa, agitata ma soddisfatta. Per qualche giorno Giovanna non venne a lavorare. Fui convocata dalla polizia, dovevo recarmi in Questura alle cinque per un colloquio. Mi presentai puntualmente, mi introdussero nell'ufficio del questore (o capo della "mobile"), dottor Panvini, un uomo grassoccio, dal viso roseo, con radi capelli grigi. Non aveva un'espressione tanto rassicurante. Vicino a lui era seduta una signora bellissima, con folti capelli neri e ricci. Il funzionario cominciò l'interrogatorio, chiedendomi le generalità: - Dove abiti, che lavoro fai, dove lavori ? Risposi a tutte le sue domande. - E vai in giro a picchiare le bambine ? - Ma io amo i bambini, ho una nipotina, ce ne sono nel mio caseggiato, ma non ne ho mai picchiati. La signora intervenne furibonda: - Hai picchiato la mia bambina ! Il dottor Panvini cercò di calmarla, mentre io continuavo a non capire: - Ma quale bambina e quando l'avrei picchiata? Come si chiama ? Infine il funzionario sbottò: - Si chiama Giovanna. - Giovanna una bambina? - Ma Giovanna ha la mia stessa età, siamo coetanee. Se è una bambina lei, allora sono una bambina anch'io. Il dottore si rivolse alla signora incuriosito - Sì - rispose lei. - Ma mia figlia è ancora una bambina. - Se fosse una bambina, perché verrebbe a lavorare? Lavoravamo insieme alla riseria Bianchi. Il dottor Panvini calmò la signora, assicurandole che sarei stata punita. Poi si rivolse a me, dicendomi di non picchiare più nessuno, perché la "bambina" era a casa da cinque giorni con male allo stomaco ed ero anche colpevole di avere rotto gli occhiali ad un impiegato. Spiegai il motivo della colluttazione, avevo agito d'impulso perché la ragazza aveva fatto la spia. Infine venni rilasciata e ripresi il lavoro. Mi cambiarono reparto, nel magazzino della riseria c'erano anche delle pezze di maglia felpata di cotone, che forse usavano per imballare. Una operaia, con tre figli e il marito in guerra, ne aveva sottratto un pezzo, evidentemente per farne delle camiciole per i suoi bambini. L'ammanco venne scoperto e il capo reparto, signor Emilio, essendo io un po' responsabile, pretese che denunciassi la compagna. 30 Sapendo quale punizione avrebbe colpito quella donna tanto bisognosa, non rivelai nulla, anche quando il capo mi disse che se non avessi fatto il nome dell'autrice mi avrebbe licenziata. Così avvenne (Renata e Mariuccia Caccina ricordano questo episodio ancora oggi). *** 31 Fra le tante mie attività, seguii anche un corso di difesa personale. Non si devono confondere le condizioni di vita attuali con quelle di cinquant'anni fa; le sole persone dalle quali ci si doveva difendere erano i fascisti. Mio fratello Remo parlò con un suo amico pugile, Mario Sarasso, e questi mi accolse come allieva, facendomi praticare il pugilato per una settimana nella palestra Mazzini, allora Gil. (Gioventù italiana del littorio). Indossavo una fascia molto spessa, strettamente legata sui seni, ma questi erano abbondanti e certi colpi mi facevano piuttosto male. Non fu un lungo allenamento, ma poteva bastare; anche col mio braccio invalido imparai a difendermi bene. Le domeniche pomeriggio, in inverno, accompagnavo papà al caffè Barolo, sul corso principale. Io andavo al cinema e quando ritornavo passavo a riprenderlo; mi pagava la cioccolata calda e rincasavamo insieme. A mio padre piaceva vestirsi bene, era sempre elegante; aveva un cappotto di panno nero, con il collo di pelliccia marrone, e le ghette grigie (una volta di moda). Anche quando andava al lavoro, portava la camicia bianca e sul lavoro indossava la tuta. Era un poco snob. Non ho mai avuto la gioia di uscire con mamma. Le gambe non la reggevano e il suo cuore era sempre in pericolo. Ma da lei scaturiva un'immensa bontà. Anche da anziana, mamma non si vestiva mai in nero come le donne della sua età, indossava vestiti chiari e portava sempre il grembiule sui fianchi. Sovente, io e mio fratello ci divertivamo a slacciarglielo tirando il capo di una fettuccia; si ribellava minacciandoci con il mestolo. *** Iniziai la scuola serale da privatista, dalla professoressa Wanda, una brava insegnante. Eravamo in dieci tra ragazzi e ragazze, molto affiatati. Avevo deciso di studiare da privatista perché se fossi andata alla scuola pubblica mio padre avrebbe dovuto ancora scontrarsi con i fascisti. Inoltre, non volevo essere chiamata "studente" e confusa con gli altri figli di papà che inneggiavano alla guerra. Papà preferì pagare le lezioni private. Si trattava di un corso di avviamento professionale industriale che in nove mesi avrebbe sostituito i tre anni della scuola pubblica preparandomi per ottenere la licenza. A scuola andavo bene, però commisi un grave errore, imparai a fumare la mia prima sigaretta e continuai per molti anni. Avevo una difficoltà nell'aritmetica scritta. Il mio insegnante di matematica, professor Colombo, non riusciva a spiegarsi perché mi bloccavo quando dovevo mettere per iscritto quanto avevo elaborato in orale, peraltro esattamente e correttamente. Perciò nel mese di giugno fui bocciata in matematica e rimandata per l'esame di riparazione a settembre. *** Eravamo nel 1943. C'era la guerra e grandi masse di operai e braccianti venivano obbligati a lavorare per la Todt. Mio padre, per non essere mobilitato, si fece operare per una punta d'ernia inguinale, così potè evitare di essere mandato in Germania. Infatti, anche se aveva cinquantanove anni, era un autista soggetto al reclutamento. Mio cognato Bruno era stato richiamato e si trovava nella caserma di artiglieria di Asti. Anche mio fratello Remo era stato richiamato ed assegnato alla Venaria di Torino, ma si rese irreperibile nel giugno-luglio, quindi lo ricercavano come disertore. I carabinieri venivano quasi tutti i giorni a cercarlo in casa nostra, ma la mamma e mia cognata dicevano sempre che ignoravano dove fosse. Infatti di nascosto aveva già iniziato la sua lotta antimilitarista e antifascista, con altri compagni comunisti. Si giunse così all'armistizio dell'otto settembre, e molta gente l'accolse come la fine di tanti drammi, ritenendo che la guerra fosse finalmente terminata. La mia famiglia era al corrente di quanto sarebbe potuto succedere, grazie ai contatti che manteneva con il Partito comunista clandestino. 32 CAPITOLO TERZO Lotta clandestina 33 L'otto settembre 1943, quando si diffuse il proclama di armistizio, la gente correva per le strade, cantava e gridava: - Finalmente è finita ! Con mia sorella dalla finestra continuavamo ad avvertire: - Badate che non è finita. Guardate che il pericolo deve ancora venire, sarà una cosa tremenda, noi abbiamo i tedeschi in casa. Ma nessuno ci ascoltava. Era finita la guerra, il sollievo e la gioia erano così grandi che nessuna previsione pessimistica poteva essere ascoltata. Non sapevano ancora del pericolo incombente, o non volevano crederci. Ormai i tedeschi invasori avevano occupato l'Italia, si erano impossessati della nostra terra, che i fascisti avevano venduto. Ci fu qualche comandante molto coscienzioso e intelligente il quale, quando seppe che i tedeschi stavano per giungere, organizzò una difesa più o meno efficace; qualcun altro smobilitò i soldati e li invitò a scappare a casa, a non farsi prendere. Altri, invece, rinchiusero i militari nelle caserme e consegnarono sia i soldati che le armi ai tedeschi. Questa sorte toccò anche a mio cognato Bruno. Quelli che riuscivano a sfuggire ai tedeschi erano accolti dalla popolazione con sollecita solidarietà e vestiti con abiti borghesi per evitare che venissero identificati e catturati. I tedeschi avevano occupato le caserme e fatti prigionieri i soldati italiani che rifiutavano di arruolarsi con le truppe germaniche. Caricavano sui carri bestiame i nostri ragazzi e li portavano nei campi di prigionia in Germania. I soldati erano stipati nei vagoni merci, dove di solito si trasporta bestiame. Al posto di venti cavalli erano ammucchiati settanta-ottanta militari, senza bere, senza mangiare, senza aria, perché i due finestrini non erano sufficienti ad ossigenare l'interno per tante persone. Quando le tradotte entravano nella nostra stazione cercavo di essere sempre presente, insieme a molti altri cittadini che andavano a vedere se c'era qualche loro famigliare, parente o amico, oppure se qualcuno poteva dare qualche notizia. Se non conoscevano nessuno, potevano sempre dare una mano agli altri, porgere un po' d'acqua o un po' di frutta, magari raccogliere qualche biglietto di quei poveri sventurati, anche soltanto un indirizzo, un nome, per mandare qualche notizia ai loro famigliari, sfidando le frequenti raffiche di mitra delle guardie nazi. Una volta raccolsi un biglietto trovato per terra, calpestato, certamente lanciato dal finestrino da uno dei militari deportati con la speranza che qualcuno lo vedesse. C'era un nome, Luisa Vanini, e un indirizzo di Como (che ho dimenticato), e queste brevi parole: "Mi portano in Germania. Aspettami. Ildebrando." Spedii il piccolo messaggio all'interessata, accompagnandolo con un mio breve scritto. Lei mi rispose, ringraziandomi; ci tenemmo in corrispondenza per un paio d'anni. Finita la guerra mi recai a trovarla a Como. Ci conoscemmo e ci abbracciammo. Era più anziana di me, piccolina, un viso dolce, triste e sofferente. Ildebrando le aveva scritto un paio di volte, poi fu silenzio, non fece più ritorno. *** Un mattino piovoso e freddo, in stazione c'era una tradotta proveniente da Torino, carica di prigionieri, ferma per qualche motivo. I prigionieri erano assiepati davanti ai finestrini e ai portelloni. I tedeschi erano scesi dalle loro vetture, ben lontani dai carri, e si sgranchivano le gambe. Mi trovavo con un gruppo di cittadini proprio davanti al cancello che dà sui giardini della stazione, di fronte ai vagoni dai quali si sporgevano centinaia di mani che chiedevano aiuto. Ci guardammo intorno: un tedesco era lontano un centinaio di metri. Ben presto riuscimmo ad aprire il pesante portellone, con una rapida azione che prese alla sprovvista gli aguzzini. Parecchi prigionieri riuscirono a saltare giù, prima che cominciassero ad echeggiare le raffiche di mitra. Fuggimmo tutti, disperdendoci nei dintorni e portandoci dietro i militari liberati. Alla stazione andavo sempre con la bicicletta da uomo di mio padre, perché occasioni come quella, di trasportare qualche fuggitivo, si presentavano non poche volte, perciò la bici era provvidenziale. Caricai uno dei militari sulla canna di questa e filai velocemente in mezzo agli alberi dei giardini, verso il passaggio a livello che imboccava la strada del mio rione, dove saremmo stati al sicuro. Nel bosco del Vola, sulla riva della Sesia, un gruppo di antifascisti ci attendeva per organizzare i 34 fuggitivi nei primi nuclei di partigiani, diretti in montagna, a combattere contro i nazifascisti. *** Con l'armistizio i tedeschi erano subentrati ai soldati italiani nella custodia dei prigionieri alleati angloamericani. In particolare, alla cascina Coltellino, presso l'Isola, era stato istituito un campo di lavoro agricolo per i prigionieri australiani e inglesi. Gli avevano applicato un triangolo rosso sulla camicia per distinguerli dagli altri militari. Uno dei compiti di noi antifascisti nelle città e nei paesi era quello di far fuggire questi militari stranieri. Non era facile, perché nei campi di lavoro ai quali erano assegnati erano rigorosamente sorvegliati dai nazifascisti, ma azioni del genere riuscirono spesso. Qualche volta, gli "evasi" venivano rifugiati provvisoriamente nell'Ospedale Maggiore di Vercelli, dove le infermiere avevano dato vita ad un eccellente lavoro clandestino, che si concludeva, quando il ricovero non era più sicuro, con il trasferimento degli ex prigionieri nel bosco del Vola. A me era stato assegnato il compito di operare questi trasferimenti. Dovevo andare in una certa stanza, conoscerli, farli uscire come se fossero stati cittadini vercellesi qualsiasi, vestiti con abiti borghesi procurati dalla organizzazione clandestina. Dall'ospedale, dovevo portarli al Vola. Un giorno, come facevo da un paio di settimane, entrai nell'accettazione dell'ospedale, accolta dalla Maria Fracassi Pastore, infermiera addetta alle entrate e uscite clandestine, e indossai il camice e la cuffietta da infermiera che mi forniva la sua collega Primina. Andai da Giorgio Caldwel, l'australiano ventenne che visitavo quotidianamente, perché malato grave, di reuma al cuore. Stavamo aspettando che migliorasse un po' per portarlo via, ma si aggravava ogni giorno di più; non era nemmeno sorvegliato, perché i tedeschi sapevano come noi che era pericoloso muoverlo. Come ogni giorno, mi scongiurò di non lasciarlo prendere dai tedeschi, assicurando che non sarebbe stato di peso, che sarebbe guarito. Purtroppo era assolutamente impossibile trasportarlo e dovemmo rinunciare a farlo evadere. Lo calmai con qualche pietosa bugia. Morì pochi giorni dopo. Incontrai due altre nostre infermiere, Irene Cafasso e Zaira, le quali, preoccupate, mi dissero che era urgente portare via altri due australiani, Alan, che nel suo paese era allevatore di bestiame, e Mac. Infatti, il giorno dopo i tedeschi avrebbero operato una perquisizione e nessuno era in grado 35 di dire che fine avrebbero fatto se li avessero trovati. In una minuscola stanzetta incontrai i due, e mi venne un accidenti. I vestiti che indossavano erano assolutamente inadatti per Alan, che era alto circa due metri: pantaloni e camicia gli andavano ridicolmente corti e stretti, si vedeva lontano un miglio che era uno straniero, e io lo dovevo condurre per le vie della città ! Ero perplessa, incerta, ma la paura che all'indomani li potessero requisire mi fece ben presto decidere. Era essenziale assicurarsi che mi seguissero sempre, che non parlassero mai e non compissero alcun gesto che potesse tradire la loro identità. Uscimmo dall'ospedale e percorremmo un pezzo di strada senza fare brutti incontri. Arrivati ai giardini di piazza del duomo, vidi avanzare dalla mia sinistra tre tedeschi. I due australiani si bloccarono di colpo; reagii immediatamente; fingendo di scherzare, presi i due sottobraccio e ripresi a camminare come se niente fosse. I tedeschi erano di fianco e non potevano notare lo strano abbigliamento di uno di noi, nè il nostro pallore. Oltre il passaggio a livello dell'Isola, il mio rione, eravamo salvi. Accompagnai i due nel bosco del Vola, dove iniziò la loro partecipazione alla lotta partigiana con i vercellesi. Tornata in ospedale, mi attendeva Teresa Roncarolo (Gina) con un altro compito da assolvere. Le brave infermiere sapevano organizzare tutto. Dovevo recarmi nella stanzetta dove si trovava un militare italiano, che qualche giorno prima era fuggito da una tradotta mentre transitava sul ponte della Sesia. Passando attraverso un finestrino rotto, era saltato sul ponte e da lì si era buttato nel fiume; purtroppo, i tedeschi lo avevano visto e gli avevano sparato, ferendolo alle gambe. Era stato portato all'ospedale e operato a entrambe le ginocchia; ovviamente, non era in grado di camminare. Lo sorvegliava un militare austriaco che alla mezza andava a mangiare in un'altra stanza coi suoi commilitoni. La guardia aveva quarantacinque anni e si era confidata con la Gina, ricordando suo figlio militare che assomigliava al ragazzo da lui piantonato. Non volli né dovevo sapere altro, poiché era compito della brava infermiera organizzare il resto. Aiutata da Gina, mi caricai il ferito in spalla e mi calai dalla finestra, al piano rialzato del vecchio ospedale (erano quasi tre metri di dislivello). Col mio fardello attraversai in fretta il cortile, entrai nei sotterranei della camera mortuaria, dove mi attendeva un carretto con della biancheria sulla quale adagiai il ferito. Il giovane venne portato a casa di qualcuno che lo curò, con l'aiuto prezioso dei medici nostri collaboratori. Del piantone austriaco non si seppe più nulla, non fu più visto in ospedale. 36 Non seppi più nulla nemmeno del ragazzo che avevo portato in salvo, finché, pochi anni or sono, ne riparlammo con Gina, l'infermiera, durante l'incontro delle donne della Resistenza in occasione del cinquantenario della Liberazione. La trasmissione della rubrica "I fatti vostri", grazie alla quale un signore aveva potuto realizzare il desiderio di ritrovare due suoi compagni di prigionia, mi spinse a tentare di rintracciare quel giovane, conoscere la conclusione della sua storia e magari rivederlo. Scrissi a Frizzi e, con mia somma sorpresa e soddisfazione, ricevetti la risposta, sotto forma di un invito esplicito a partecipare alla trasmissione in diretta del 23 aprile 1993, negli studi della Rai-Tv a Roma. Quando mi sedetti al tavolino e Frizzi cominciò ad interpellarmi, il timore e l'imbarazzo che mi assillavano sparirono, mi concentrai nei ricordi e risposi scioltamente alle domande. Fui applaudita, forse per la singolarità dell'episodio. L'esito della trasmissione non fu quello sperato, forse quel ragazzo non aveva visto il programma, o forse era scomparso, altrimenti avrebbe raccolto il mio appello e si sarebbe fatto sentire. Ma mi sentii onorata e commossa quando due giornali di Vercelli citarono la trasmissione e mi intervistarono, rievocando ed esaltando l'episodio di una donna della Resistenza vercellese. *** Mio fratello Remo, già disertore, dopo l'otto settembre si impegnò nella resistenza attiva contro i nazifascisti. Con lui altri compagni, Pietro Camana, Bruno Bellotti, Nino Baltaro, Enrico e Giulio Casolaro. Furono i primi a formare i nuclei di partigiani, con renitenti alla leva, fuggiaschi delle caserme ed ex prigionieri alleati, che diedero poi vita al Battaglione Vercelli. La mia attività di antifascista a contatto coi comunisti, cominciata con la circolazione dei libri clandestini e con l'organizzazione dei militari fuggiaschi, continuava con altre iniziative. Un giorno tenevo sulla bicicletta da uomo una cassa di fucili che mi aveva consegnato il Giovannacci e stavo attraversando la piazza del duomo per andare verso il Covo, un boschetto dove c'era un ballo estivo, e portarmi sull'argine verso il bosco del Vola, quando vidi avanzare da piazza d'Angennes un gruppo di quattro o cinque fascisti in divisa. Dai loro cenni capii che probabilmemte intendevano rincorrermi per vedere che cosa portavo, perché sospettavano la nostra attività, specialmente quella di mio fratello. Allora mi misi a pedalare quanto potevo per distanziarli. Mi guardai bene attorno e, visto che avevo "seminato" gli inseguitori, proseguii fino a destinazione. 37 38 Una delle prime formazioni partigiane. Qui erano raccolti i militari scappati, e tra essi c'erano due dei prigionieri australiani che avevamo fatto fuggire dalla cascina Coltellino. Uno di loro faceva il cuoco e da borghese faceva anche il pugile; era alto due metri e grosso in proporzione. Quando arrivai, lasciata giù la mia cassa di fucili, mi trattennero per il pranzo (avevo anche una gran fame). I viveri per questi militari che scappavano erano offerti da quasi tutta la popolazione del rione Isola. Il ragionier Ferraris dava la marmellata, la frutta, il miele; altri portavano galline, oche. Da mangiare non ne mancava, perché tutti offrivano qualcosa, in una generosa gara di solidarietà, anche se possedevano pochissimo. Attorno a una tavolata costruita con assi, con alcuni piatti, un pentolone pieno di minestra e un altro grosso recipiente con l'insalata, c'erano ventiquattro o venticinque uomini, diretti da Pietro Camana, il futuro comandante Primula del Battaglione Vercelli. Primula mi disse: - Ora ti fermi a mangiare con noi. Io felicissima, risposi: - Sì, bene, bene. - Però mangi tutto quello che ti danno, sai ? - Si, come no ? - Tutti sorrisero e io non riuscivo a capire. Il prigioniero alleato mi porse un piatto, ci versò un mestolo di minestra e aggiunse l'insalata, nella quale aveva vuotato due vasetti di miele. Mi si rivoltò lo stomaco solo a vedere. Tutto orgoglioso, l'australiano mi disse: - Mangia. Cercai di evitare quella tragedia dicendo che dovevo andare via. Mi mise una mano sulla spalla rimettendomi a sedere e insistendo: - No via, tu giovane, fame, prima devi mangiare. Gli altri ridendo mi dissero: - Sono tre giorni che noi mangiamo così. Adesso mangia tu, almeno una volta. Vuotai il piatto per metà poi lasciai tutto, pensando: "Adesso basta, si arrabbi fin che vuole, io me ne vado." *** Verso la fine di settembre arrivò una segnalazione da parte di un nostro collaboratore che faceva parte della milizia. Mi disse di allontanarmi da casa perché probabilmente sarebbero venuti a prendermi, sospettando la mia attività antifascista, anche per avere informazioni su mio fratello Remo, che risultava disertore. Partii in treno e mi recai presso la famiglia di mia cognata Giulia a Quiesa, nella provincia di Lucca. Ma non sospesi la mia attività. Prendevo il treno al mattino e andavo a Lucca, vicino al distretto militare. Là si aggiravano tanti giovani che non sapevano che fare, cercando di capire dove andare anziché arruolarsi nelle forze armate repubblichine. In genere erano meridionali e non potevano più ritornare a casa. Consigliavo loro come potevano fare. A due ragazzi consegnai il mio anello, che aveva incise le mie iniziali, e fornii l'indirizzo di casa mia; se andavano in Piemonte, dalle mie parti, potevano consegnarlo ai miei famigliari, che li avrebbero aiutati. Persi l'anello; quei ragazzi non sono mai arrivati a casa mia e non so che fine abbiano fatto. La sera ritornavo a Quiesa. Il mangiare era sempre scarso. Subii una indigestione di castagnaccio e melone; ogni pomeriggio spendevo due lire per un chilo e mezzo di castagnaccio e quattro meloni. Avevo una fame del diavolo. Dopo circa una settimana tornai a Vercelli per dare gli esami di avviamento industriale, che erano stati rimandati di qualche giorno per intervento del professor Colombo, il quale conosceva la mia attività e aveva ottenuto il rinvio "per motivi di salute". Passai gli esami a Trino e fui promossa, ottenendo il diploma. 39 La mia lotta clandestina continuò nei gruppi che avevamo a Vercelli, organizzati nel Fronte della Gioventù. Ne facevano parte studenti, operai, artigiani; tra gli altri, c'erano Ugo Donati, Sergio Mauri, Alcide Brusa, Giovanni Acquadro, Giovanna Michelone, Maria Scarparo, Rosanna Mignone, Olga de Bianchi, Rosina Corradino e Francesca Ferraris. Nell'inverno del 43- 44 uscivamo di sera e quando ci andava bene ritornavamo con qualche pistola sotto il cappotto, ottenuta con diversi espedienti. Nascondevamo le armi per mandarle poi in montagna, quando venivano giù le staffette o pattuglie partigiane per prendere viveri, armi e indumenti. Una sera - faceva molto freddo - rientrai a casa dopo le dieci, ora del coprifuoco. Mio padre mi sgridò aspramente. Cercai di giustificarmi: - Ho fatto tardi, lo so. Scusa papà, non lo farò più. In quella aprii il cappotto e mi caddero due pistole. Mio padre le guardò e mi domandò da dove venivano, che cosa avevo fatto. Gli risposi: - Papà, queste sono cose che non ti riguardano, non devi sapere niente, altrimenti diventa pericoloso per te e per la mamma. Mi diede della sciocca, facendomi presente che doveva sapere tutto, per aiutarmi. Se io ero antifascista, dovevo a lui anche questo. Ci spiegammo nei termini più esaurienti e da allora collaborammo, lui fu sempre al corrente della mia attività. Mia madre, col suo intuito materno, talvolta ci diceva: - Non cercate di tacermi tante cose, mi fate più male che dirmele apertamente, perché mi inducete a fare tante congetture, magari peggiori della realtà, e starei ancora più male. Le lotte che ho fatto io prima di voi non erano poi tanto diverse. Aveva ragione. Intanto si aiutava pregando davanti all'effige della sua "Madonnina di Lourdes", nella quale credeva sinceramente. Sopra il letto, i miei genitori tenevano anche uno di quei ritratti di Gesù di Nazareth con la tunica rossa. Ma i fascisti, durante una ennesima visita alla ricerca di mio fratello, ce lo fecero togliere, perché, dicevano, era un... socialista. *** Un altro motivo di apprensione per la nostra famiglia era costituito dalla situazione di Bruno, il marito di Egle. Con l'otto settembre era stato internato in Germania, a Schwering, una città sul mar Baltico. Per sua fortuna gli facevano fare il muratore, che era il suo mestiere. Gli 40 mandavamo ogni mese i pacchi consentiti, con maglie, calze di lana e tabacco, che poteva scambiare presso i suoi compagni con qualcosa da mangiare. Nel pacco inserivamo anche molte gallette, confezionate da noi, con farina comprata alla borsa nera, e cotte nel forno del nostro panettiere Clemente, il quale, col regime fascista, per simili collaborazioni rischiava parecchio. 41 Cartolina spedita da mio cognato Bruno Gentile, dal Lager numero E 823, in Germania. Un giorno, con due compagni, compimmo una delle nostre più importanti azioni di sabotaggio. Si doveva cercare con qualsiasi mezzo di ritardare il transito di un treno di tedeschi che doveva arrivare sulla linea Casale-Vercelli, perché il convoglio avrebbe ostacolato una azione che i partigiani dovevano condurre. Dovevamo ostacolare il treno per almeno tre o quattro ore. Siccome le rotaie della ferrovia erano fissate alle traversine e tra loro con morsetti e grossi bulloni, noi ci eravamo muniti di grosse chiavi adatte alla bisogna, fatte nell'officina di Acquadro, un nostro compagno. Tra Vercelli e Asigliano, togliemmo i bulloni a due rotaie, una da una parte e una dall'altra, lasciandole al loro posto affinché le vedette dal treno non notassero il sabotaggio. La locomotiva, il tender e le due prime carrozze andarono fuori binario e il treno tedesco rimase fermo per diverse ore. Con il ciclostile nascosto nella casa di Ugo Donati, facevamo volantini che, alla sera, andavamo ad affiggere agli alberi e ai muri. Ad esempio, un ragazzo e una ragazza fingevano di fare l'amore appoggiandosi al muro o ad un albero, e l'altro, col pentolino della colla o con le puntine da disegno, affiggeva i manifestini dei partigiani, che richiamavano l'attenzione della popolazione e incitavano alla lotta contro i fascisti e i tedeschi. Nei cinematografi, al Verdi, al Civico e al Viotti, lanciavamo di nascosto piccoli volantini e restavamo a sedere come se niente fosse. Cercavamo collegamenti con altre persone disposte ad aiutare i partigiani e le formazioni dei GAP (Gruppi di azione patriottica) e delle SAP (Squadre d'azione partigiane). Mi incontravo spesso con le ragazze del mio gruppo, sulle panchine di piazza del Tribunale, e portavo volantini con direttive e parole d'ordine da far circolare in fabbrica. Si facevano diverse riunioni clandestine, alle quali partecipavano Guido Sola Titetto (poi sindaco di Vercelli), Angelo Cavalli, Maria Scarparo, Giovanna Michelone e Olga De Bianchi. Alcune di queste riunioni si tenevano nel cimitero di Vercelli, accanto ad una cappella a quattro colonne con una bellissima e alta scalinata, sopra la quale si appostava una vedetta, pronta a dare l'allarme se si fosse avvicinato qualcuno. Era un posto sicuro, molto appropriato per incontrarci, per discutere, per avere informazioni e direttive sulle lotte e le iniziative da sviluppare, per avere notizie dei compagni, dei partigiani e degli amici che combattevano in montagna. 42 CAPITOLO QUARTO Resistenza sulla Serra 43 Una domenica, il 28 maggio 1944, suonò l'allarme e la gente scappò verso la campagna. Si udiva un lontano rombo di aerei che si avvicinava, capivamo che erano bombardieri carichi e molto numerosi, non si trattava del solito Pippo. Pippo era un aereo solitario che quasi tutte le sere veniva a mitragliare o bombardare dove vedeva qualche luce. Gli aerei che sentivamo avvicinarsi facevano un rumore assordante e ben presto furono sopra di noi. Vicino a casa nostra c'erano molti bersagli da bombardare: la centrale elettrica dell'Ovesticino, la stazione ferroviaria, i due ponti sulla Sesia, la Chatillon e le altre grosse fabbriche. Cominciarono a cadere le bombe, a tappeto, ma mancarono gli obiettivi più importanti. Colpirono il campo dove eravamo noi, presso la villa Guarneri, e, di sbieco, il nord di Vercelli, distruggendo la casa di Rosanna Mignone, i magazzini generali dietro la Pettinatura Lane e altri edifici di abitazioni civili, uccidendo molte persone, senza toccare o scalfire le grandi fabbriche. Dopo quel massacrante e indiscriminato bombardamento, la mia famiglia e poche altre furono messe al corrente delle misure precauzionali da prendere. Tramite la nostra organizzazione clandestina e il collegamento con i comandi di zona partigiani, ci comunicarono che se suonava l'allarme durante il giorno, non ci sarebbe stato alcun pericolo, ma se le sirene suonavano dopo le ore diciotto si doveva scappare subito nei rifugi o in campagna, perché sarebbe avvenuta l'incursione. *** Nel settembre 1944, durante l'attività clandestina, Mario, il nostro collaboratore nella Guardia nazionale repubblicana, ci avvisò, tramite sua moglie, che ero stata segnalata come attivista collaboratrice dei partigiani e che sarebbero venuti ad arrestarci, io e mio padre, verso le quattro. Papà era andato a trovare i nostri famigliari, sfollati nella cascina Casone. In casa tenevo dei volantini, già pronti per la distribuzione della sera, nascosti dietro la lamiera del mio letto; li affidai a mia cugina Tin, che abitava accanto me, raccomandandole di consegnarli alla Rosanna e dirle che dovevo andarmene, che continuassero loro il lavoro clandestino. Rosanna avrebbe riferito agli altri compagni, anche per la redistribuzione dei compiti. Non sapendo quando saremmo ritornati, presi da casa quello che ritenevo utile e necessario; le cose più preziose le consegnai alla Tin e ai coniugi Gentile, suoceri di mia sorella. I fascisti arrivarono con un quarto d'ora di anticipo e per poco non mi sorpresero. Uscii di casa scavalcando la ringhiera del ballatoio e calandomi sul tetto del gabinetto al pianterreno. Inforcai la bicicletta che tenevo in cortile e scappai attraverso l'orto del Carlin Rosso (l'ortolano che ci dava il ribes quando ero piccola), raggiungendo le donne alla cascina. Da lì, papà ed io salutammo la mamma, preoccupata per la nostra sorte, prelevammo qualcosa per cambiarci, un vestito per me, un paio di pantaloni e una giacca per papà e partimmo in bicicletta. Percorremmo la strada dal Canadà per Biella. A Busonengo lasciammo la provinciale, seguendo una strada di campagna fino a Casanova Elvo e procedendo per Carisio, fino al bivio che portava a San Damiano. Lì c'era mio fratello, che ricopriva l'incarico di intendente della V divisione Garibaldi; insieme con Giovanni Cavagliano e Rita Rosso operavano in quella zona per procurare viveri ai partigiani garibaldini. Quando giungemmo a San Damiano era già notte. Fummo ospitati nella cascina della marchesa di Masino e dormimmo sui sacchi del riso. Si sentivano piccoli rumori e squittii; qualcosa di morbido mi passò sul viso e, palpando con la mano, sentii che era un topo molto grosso. Non avevo paura dei topi ma lo dissi ugualmente a papà, il quale replicò: - Guarda che i topi non ci fanno tanto male, tutt'al più mordono; i fascisti invece ci ammazzano. E' meglio un topo. Dormi, ché domani dobbiamo pedalare un bel po'. Il giorno dopo riprendemmo la strada, accompagnati da mio fratello Remo, noi in bicicletta e lui con la "doma" (piccolo calesse basso, aperto, trainato da un cavallo). Ci guidò fino al castello di Masino, proprietà dei marchesi di Masino e conti di Valperga, persone gentili e affabili. Ci ospitarono nel cosiddetto palazzo, a fianco del castello, consistente in diverse camere riservate al personale addetto ai servizi e ai cavalli (ne 44 possedevano molti, anche di razza, e un ricco parco di carrozze). Ci abitavano anche Domenico e Domenica, marito e moglie; lui autista e lei guardarobiera del castello. Nel castello erano rifugiate circa una trentina di persone, in genere giovani renitenti alla leva militare ed ebrei, tutti nobili o ricchi. I marchesi avevano un figlio quattordicenne, Luigino, e la governante, Carla Novellis. Per la gente del luogo noi eravamo sfollati da Torino, città soggetta ai bombardamenti. Masino era un piccolissimo comune del Canavese con circa centotrenta abitanti, senza gioventù, soltanto anziani. Il castello era situato su una altura tra Vestignè e Caravino, da cui si snodavano strade verso Borgomasino, Moncrivello, Cigliano e Ivrea; era il punto di partenza per tante destinazioni, quindi logisticamente e strategicamente molto importante per le formazioni partigiane. Noi "ospiti" lo utilizzavamo come punto di riferimento delle pattuglie che scendevano in pianura per missioni di ogni tipo, attacchi a posti di blocco e caserme, azioni di sabotaggio alle linee di comunicazione. Noi assicuravamo ai partigiani rifornimenti e alloggio. Dopo il nostro arrivo al castello, mio fratello ci portò anche mamma, Egle e la nipotina Nerina. Disse che i fascisti avevano incarcerato Giulia, sua moglie, tenendola in ostaggio per costringerla a rivelare dove si trovava il marito e con quali formazioni partigiane operava. Quando la prelevarono dall'abitazione si trovava con la bambina, Mirella di 7 anni; l'avrebbero lasciata sola in casa se non fosse stata accolta da una zia. In carcere con Giulia c'era la madre dei due fratelli partigiani Attilio e Giovanni Tempia (nomi di battaglia Bandiera I e II), poi trucidati dai nazifascisti. Giulia venne poi rilasciata in seguito ad una specie di scambio di prigionieri tra le parti avverse e venne ospitata con la figlia a San Damiano, nel Cascinotto della Grangia. *** Pochi giorni dopo sentimmo in lontananza una furiosa sparatoria, proveniente da sud, oltre Borgomasino. Non sapevamo che cosa succedeva, rimanemmo all'erta. Verso sera arrivarono da noi una quarantina di uomini, tra i quali riconobbi subito il loro comandante Primula con il figlio 45 quattordicenne, Tino, che aveva una guancia tutta gonfia causata da un dente cariato; poi Fulmine, Carnera, Saetta ed altri partigiani di Vercelli. La formazione proveniva da Maglione, che aveva costituito la sua base per una lunga serie di azioni nella zona, comprendente diversi centri come Cigliano, Carisio, Santhià, nonché l'autostrada. I garibaldini avevano attaccato e disarmato presidi fascisti e tedeschi, teso imboscate agli automezzi nemici, prelevato armi, esplosivi e anche catturato qualche tedesco per farne scambio con prigionieri partigiani. I comandi tedeschi non avevano nessuna stima nè considerazione per i loro alleati fascisti, tanto è vero che se trattavano con noi per lo scambio di prigionieri accettavano soltanto tedeschi in cambio di partigiani, i fascisti per loro non avevano alcun valore. Poi Maglione era stata accerchiata dalle forze germaniche, dotate dei micidiali mortai da 81 millimetri. Il distaccamento partigiano aveva contrattaccato con una furiosa sparatoria, riuscendo a sfondare l'accerchiamento ed a portarsi in salvo verso la collina, raggiungendo Masino Castello e noi, felici di poter prestare loro i primi soccorsi. Col distaccamento c'era pure una giovane donna, un'ostetrica chiamata Ferida, che non si sentiva tanto bene e non era in grado di proseguire a piedi con il reparto, fino a Sala. Primula me l'affidò, raccomandandomi di non perderla di vista, poiché era incerto sulla sua affidabilità; quando si fosse ristabilita, avrei dovuto accompagnarla al comando di Sala. Partimmo qualche giorno dopo, dandoci il cambio a pedalare sull'unica bicicletta che avevamo, per tutti i trenta chilometri circa del percorso. Tutto si risolse per il meglio (Ferida diventò in seguito la compagna di un capo pattuglia garibaldino). *** Arrivata a Sala, non ero solamente stanca, ma anche affamata. Mi recai nell'orto della cascinetta di Speranza, nel centro del paese, dove vidi dei pomodorini, molto piccoli, a grappoli, sembravano grappoli d'uva. Li mangiai tutti (e pensare che a casa non mi piacevano, ma in questa situazione contingente tutto mi andava bene). Speranza, recandosi nell'orto e non vedendo più nemmeno un pomodoro, si rivolse a Primula. Nel frattempo, quei pomodori avevano fatto effetto sul mio stomaco, vuoto da tanto tempo, con una dissenteria che non smetteva più. Perciò non avevo potuto udire che il comandante aveva messo tutto il reparto in punizione, tenendolo senza rancio fino alla scoperta di colui che aveva fatto man bassa 46 nell'orto. Quando rientrai nel cortile per cercare Pina e dirle che stavo male, vidi che tutti stavano attorno al calderone del rancio e nessuno mangiava. Ne chiesi il motivo e mi spiegarono quanto era successo, lasciandomi costernata: non credevo di aver commesso uno sbaglio così grande. Subito confessai che ero stata io a mangiare i pomodori e che ero sofferente. Speranza mi rimproverò: se le avessi chiesto un pezzo di pane, come le altre volte, non sarebbe successo niente. Fiamma, tornando da una visita e saputo della mia indisposizione, mi somministrò un farmaco adatto per il mio caso; Primula e Pina furono molto comprensivi, ma dovetti sorbirmi le canzonature dei ragazzi per la mia "indisposizione". Tuttavia, da allora mangio volentieri i tumatic, come si dice da quelle parti. Quella era proprio una giornata no, e anche la notte. Dormivo in una stanzetta sopra la stalla, con Pina e Renata, quando queste si misero ad urlare a squarciagola, i visi terrorizzati volti in alto a guardare verso la parete. Scorsi sopra il filo della luce, fermo, sembrava seduto, un topolino grosso come il pollice, la causa degli urli terrificanti delle mie compagne. Mi fecero alzare e staccare il letto dalla parete, per paura che il topo ci cadesse addosso. Mentre spostavo quel pesante trabiccolo di legno, sulla scala, che dalla stalla sottostante portava alla nostra stanza attraverso una botola, comparve Primula, seguito da qualche altro partigiano, con il mitra spianato. Le urla di Pina e Renata avevano allarmato tutti e d'un balzo erano corsi a vedere di che cosa si trattava. Quando tutto fu chiarito, Primula si irritò seriamente minacciando moglie e figlia perché avevano svegliato gli uomini già stanchi del pesante servizio. *** Tutti i partigiani avevano un nome di battaglia, ovviamente per evitare di essere identificati dal nemico, che avrebbe potuto perseguitare i familiari rimasti a casa. Io assunsi il nome di "Bruna". Le nostre forze garibaldine presidiavano le basi della zona tra Mongrando, Sala e Zubiena. Il battaglione Vercelli, trasformato poi in 182.a brigata, era composto quasi tutto da vercellesi; c'erano anche altre formazioni, i distaccamenti della 75.a e della 76.a, di cui era commissario politico il giovane Saverio Tutino (Nerio), a quei tempi grande ammiratore di Primula, ora noto giornalista e scrittore. Primula era il comandante del battaglione Vercelli, che faceva parte della V divisione, comandante Piero Germano (Gandhi) e commissario 47 Io, in divisa Da partigiana garibaldina. (Fotocronisti Baita) 48 politico Nino Baltaro (Nino). Il comando di zona era composto da Quinto Antonietti (Quinto), Silvio Ortona (Lungo), Amore Bruno Salza (Mastrilli), Anello Poma (Italo), Elvo Tempia (Gim), Walter Carasso (Tito), Ugo Anselmo (Bruno). Inoltre c'erano i medici Francesco Ansaldi (Ceck), Anna Marengo (Fiamma), entrambi dell'ospedale di Vercelli, il dottor Spirito, forse di Biella, e Carlo Savino (Nestore). Nel vicino territorio canavesano operavano altre formazioni partigiane al co mando di "Diavolo Rosso", molto aggressivo. Avevamo alle spalle le Alpi, un posto strategicamente molto valido, perché quando c'erano incursioni e rastrellamenti nazifascisti le montagne ci facevano da scudo contro gli assalitori e facilitavano la difesa. La Serra era piena di boschi, i tedeschi e fascisti non vi si inoltravano tanto volentieri, perché erano posti da lupi, dove era facile tendere imboscate. Il mio compito consisteva nel mantenere contatti con le donne della zona, prestare attività di infermiera, formare i "gruppi di difesa della donna", avvicinare collaboratrici, attiviste, sarte, magliaie e portaordini. Spesso scendevo a Bornasco, nel nostro magazzino, a prelevare scarponi, maglioni e altri indumenti per chi ne aveva bisogno. Dovevo sempre discutere con Tarzan, il magazziniere, che era scrupoloso, tirchio come pochi. Anche di fronte alle richieste firmate dai comandanti, aveva sempre qualcosa da ridire. Quando arrivai a Sala, Primula mi guardò le calzature e si scandalizzò. Avevo scarpe di tela grigia (comunissime in tempo di guerra), con la suola di cartone pressato così consumata che perdeva i pezzi. Mi scrisse la richiesta e andai da Tarzan. Questi si arrabbiò perché avevo il piede piccolo e lui disponeva solo di scarpe grandi. Remo mi consegnò una piccola pistola, calibro 6,35. Le parole che mi disse in quell'occasione - ribadite anche dal comandante Primula - le ricorderò sempre: - Speriamo che tu non la debba mai usare. Se dovesse succedere qualcosa di grave, l'ultima pallottola tienila per te. Non lasciarti prendere viva. Per fortuna non ebbi modo di usare quella pistola. Un giorno chiesi a Primula se potevo formare un gruppo di azione femminile. Primula non respinse l'idea, ma disse che dovevamo procurarci le armi, perché quelle che avevano i partigiani se le erano guadagnate con tanti sacrifici. Inoltre, se durante le azioni qualcuna del nostro gruppo fosse rimasta uccisa avrei dovuto assumerne la responsabilità e subirne le conseguenze. Rinunciai, perché sarebbe stato impossibile garantire il rispetto di siffatte condizioni, anche se avevo l'entusiastico consenso di Alba, Marta, Carla, Stella, Gioia, Mammola, Amata, decise anche loro a formare un gruppo di donne combattenti. Era un compito troppo arduo e non ci sentimmo di esaudire quel desiderio che ci entusiasmava. Eravamo riunite nel salone della scuola di Sala, quando Gandhi venne a dirci che era arrivata la figlia di Mauro Scoccimarro; aspettavamo di conoscerla, sperando che ci portasse nuove esperienze, che stesse con noi e ci aiutasse magari a formare quel benedetto gruppo armato che tanto desideravamo. Sapevamo del padre, comunista, grande combattente antifascista, e speravamo che la figlia fosse della sua stoffa. Quando ce la presentarono restammo un po' deluse: non era ome noi, della montagna, 49 era tutta... stile, una vera cittadina. Non ci furono scambi di esperienze (forse era venuta per portare qualche messaggio al comando), con noi si pose su di un piano così staccato che sembrava quasi volesse darci la caramella (non fu solo la mia impressione, ma di tutto il gruppo). Ci guardammo in viso tutte quante e le domandammo se si sarebbe fermata per molto. Alla sua risposta negativa tirammo un sospiro di sollievo. Partì presto e fu meglio così. *** Un giorno arrivò trafelata la staffetta Lia, della 75.a brigata, dicendo che c'era stato un attacco e i feriti dovevano essere trasportati subito nel nostro piccolo ospedale, che si trovava nella villa Rivetti, tra Zubiena e Sala, in territorio presidiato dalle nostre formazioni. L'ospedaletto, allestito per i casi di emergenza, disponeva di quattro stanzette con due lettini ciascuna e relative attrezzature, nonchè di un locale arredato come una vera e propria sala operatoria, compreso un lampadario; purtroppo, il pavimento era di legno, difficile da disinfettare. Quasi tutto il materiale era stato fornito dai medici dell'ospedale di Vercelli e dalle nostre bravissime infermiere, Teresa Roncarolo, Maria Fracassi, Carmela Pertusi, Maria Bolla, Edmea Bisio, Firmina Casalino, Maria Caldera, suor Teresita, suor Teofila, Rosanna Ansaldi, una Marina del Pronto soccorso, il dottor Gennaro e tanti altri di cui non ricordo il nome. La loro opera fu tanto preziosa, ammirevole e insostituibile, nei drammatici giorni dell'otto settembre e per tutto il periodo della lotta di liberazione, che dovremmo sempre ricordarla. I feriti erano Sicula, Pompeo e Renè. Sicula aveva preso una pallottola nell'inguine, Pompeo era stato colpito alla spalla e Renè ferito da un proiettile che gli aveva trapassato un polmone. Io avevo il compito di aiutare Fiamma e Ceck. I tre feriti vennero operati e curati con esito positivo e rimasero ricoverati il tempo strettamente indispensabile a raggiungere l'autosufficienza: non c'era proprio tempo per la convalescenza. *** Ogni tanto mi torna in mente la curiosa faccenda di Renè (Rinaldo Starda, che abitava nel mio rione). Il ragazzo, che si teneva molto curato, mi chiese di fargli la barba. Avevamo un solo rasoio di sicurezza con una sola lametta molto usata, perfino un po' arrugginita, era praticamente impossibile raderlo senza tagliuzzarlo. Glielo dissi. Ma lui insistette: pur 50 Il partigiano Rinaldo Starda ( Renè), capo pattuglia. 51 essendo immobilizzato a letto voleva essere sbarbato e pettinato. - Non importa - diceva, - tu prova. Non pensarci se mi tagli, io non voglio stare con la barba lunga. Una volta sbarbato, tutto un po' tagliuzzato che mi faceva una gran pena, si guardò allo specchio e disse: - Va benissimo. Poi chiese la brillantina, perché quando era a casa si curava bene la persona proprio come esigeva la moda. Lo informai che di brillantina non ce n'era. Lui disse di provare a prendere un po' di grasso dal mozzo della ruota di un carro. - Ma guarda che puzza, è cattivo. - Non importa, va bene così, vedrai che capelli brillanti mi verranno. Prelevai un po' di grasso da un mozzo, quello meno sporco, ma tuttavia gialliccio e puzzolente, e glie lo spalmai sui capelli. Feci del mio meglio, alla fine aveva i capelli belli lucidi e lisci, sembravano stirati; però puzzavano. Tutti lo deridevano. Fu una delle note allegre di quei giorni. *** Ho ritrovato Renè in questi giorni (dicembre 1995, nel cinquantenario della Liberazione) e insieme abbiamo rievocato questo episodio. Ne ho approfittato per farmi rilasciare una testimonianza più completa sulle sue vicende nel movimento partigiano. Eccola: "Sono della classe 1923 e abitavo nel rione Isola, in via Spagna, nello stesso caseggiato di Nino Zavattaro. Con lui ho cominciato la mia partecipazione alla lotta antifascista. L'8 settembre ero militare all'aeroporto di Cameri e riuscii a tornare a casa. C'era già il coprifuoco e tutte le limitazioni di quel periodo; ci riunivamo all'osteria del Vintebbio, io, il Lodo Novilio e tutti gli amici e si parlava di andare sù coi partigiani. Così stabilimmo rapporti con un gappista, certo Guasco, che operava dalle nostre parti, concordando che lui ci avrebbe fatto strada. Partimmo in diversi, tra cui il Lodo e Gigi Crepaldi. Costeggiando la Sesia, passando dalle parti di Sandigliano, ci portammo verso la Valsesia. Il nostro primo incontro coi partigiani avvenne a Gattinara, dove c'era il comandante Pesgu, che ci destinò ad una formazione dalle parti di Rima. Era l'inizio del l944. Il periodo invernale lo passammo poi nella zona di Sordevolo. Poi avvenne quel famoso rastrellamento, in seguito al quale furono disfatti tutti i distaccamenti. Ci dissero: " - Cercate di nascondervi, ci ritroveremo dopo. "Tornammo giù e rimanemmo a casa per un po' di tempo, finché organizzammo quella famosa azione alla caserma della Guardia di finanza, Nino Zavattaro, il Lodo (Black), Guido De Bianchi ed io. Prelevammo numerosi moschetti, che caricammo su un triciclo e sotterrammo vicino a casa nostra, presso il muro di cinta dell'Ovesticino (l'attuale centrale Enel di via Trento). Con la collaborazione del sappista Guasco, ci segnalarono l'arrivo di una pattuglia della 75.a brigata e allora dissotterrammo le armi e le portammo al Comando della brigata sul Mombarone, risalendo il fiume Sesia e transitando per San Damiano. Quì c'era il comandante Mastrilli e fummo inquadrati nel distaccamento del Tigre. Visto il successo della nostra azione, ci promossero, io comandante di pattuglia e Lodo vice comandante. "Rimanemmo insieme per un certo periodo di tempo, finché arrivò il rastrellamento e il nostro distaccamento venne attaccato a Muzzano. 52 I nostri avevano una bombarda che non funzionò e rimasero bloccati fino al giorno dopo, perché si trovavano proprio di fronte al presidio nazifascista. Noi risalimmo per congiungerci al distaccamento e rimanemmo lì ad aspettare di poter entrare. Il giorno dopo, sabato, 11 ottobre o giù di lì, del 1944, stavano arrivando i tedeschi, un centinaio e più. Il comandante mi mandò giù con la mia pattuglia (Sicula, Pompeo, Lodo e un altro) a vedere se per caso i nazi stavano per venire su. Noi scendemmo; nessuno in paese ci avvisò che stavano arrivando e ci accerchiarono proprio dove c'è il santuario di Graglia; noi chiusi in mezzo e loro che sparavano un'iraddidio. Resistemmo, scaricando le armi finché finimmo le munizioni. Poi intervenne il distaccamento che ci era vicino; si misero a sparare anche loro e poi ci raccolsero e ci portarono a Netro. "Noi tre feriti (io, Sicula e Pompeo) fummo accolti dalle donne del paese, che ci prestarono le prime cure, ci ospitarono e ci nascosero. Al mattino, ci caricarono su un'ambulanza della Croce Rossa - o almeno era un furgone proprio come la Croce Rossa - e ci portarono nell'ospedaletto di Sala, cioè lì nei dintorni. Il giorno dopo arrivarono la dottoressa Marengo (Fiamma), il dottor Ansaldi (Ceck) e le infermiere: già conoscevo te, Bianca, poiché abitavamo vicino, e la figlia del Primula, Renata; c'era anche una 'Ferida', che non so come si chiamasse. Mi visitarono e non si capiva se c'erano due pallottole o una. Ad ogni modo la Marengo disse che era stato leso anche il polmone, infatti avevo avuto uno sbocco di sangue. Mi curarono alla bell'e meglio, come si poteva, e poi Ceck mi disse: "- Quando sarai a Vercelli, se avrai la possibilità di conoscere qualcuno al Distretto che ti faccia un documento fasullo, dovresti andare al Dispensario, dalla Ferrero, e farti fare una radiografia per sapere quali sono realmente le tue condizioni. "Infatti per parecchi giorni ebbi un po' di febbre. Come hai scritto tu, in effetti ho voluto che tu mi sbarbassi eccetera; a queste cose io ci tenevo. "Poi ritornai a Graglia, dove c'erano sempre Tigre, il comandante del distaccamento, e il vice comandante Marino. Mi mandarono presso una famiglia che mi curò e mi assistette come si doveva. Poi, quando stetti meglio, il Comando di distaccamento, preoccupato per la sicurezza mia e dei compagni (forse pensavano che stando al paese potevo essere indotto a fare la spia anche senza volerlo) e anche perché c'era un grande bisogno di uomini, mi mandò a chiamare. Tutta la 75.a brigata e la divisione 53 erano di stanza vicino a Graglia, e quì trovai Ricu Casolaro, che mi disse: "- Perché non vieni alla 182.a brigata ? "Così ne parlò al Comando, che mi autorizzò ad andare con loro. Mi misero nel distaccamento comandato da Prete (Bruno Bellotti). Da lì ci portavamo a Zimone, o a San Sudario e giù in pianura, facendo le cose che si facevano allora, cioè combattere i nazifascisti. "Poi, quando venne la Liberazione, il nostro reparto si fermò di stanza ad Olcenengo, perché c'era quella famosa colonna tedesca che aveva fatto una strage a Santhià. "Ecco, la mia storia sarebbe questa." *** A volte, al mattino, ero assalita da una struggente malinconia. Pensavo ai pericoli e alle preoccupazioni che gravavano sui miei cari lontani, a tutte quelle mamme che avevano i figli chissà dove. Sentivo la nostalgia della mia casa, delle piccole e grandi cose lasciate; nell' insieme mi invadeva la preoccupazione per i compagni che in pianura lottavano affrontando rischi maggiori dei nostri (noi avevamo le montagne per rifugiarci e le armi per difenderci, loro no). Mi domandavo : "Quando finirà ?". Per fortuna, fra tante brutte cose c'era la natura che un poco mitigava la mia tristezza, con i suoi panorami ricchi di paesaggi dolcissimi, il sole che al suo sorgere formava contrasti stupendi di luci, tra le foglie bagnate di rugiada che sembravano pagliuzze d'oro, impreziosite com'erano dall'ingiallire dell'autunno. In una molteplicità di mutazioni, i colori variavano a seconda del tipo di albero, dal verde intenso al giallo pallido all'arancio all'amaranto, enormi mazzi di fiori nella maestosità delle Prealpi. Sembravano dire: "Uomini, guardateci. Come potete pensare a sopprimere, ad uccidere, quando la nostra bellezza inebriante, il frusciare del vento tra le nostre foglie sembrano musica che invita a una danza universale di pace e di amore ? Uomo stolto, non fare piangere la natura !" A volte indugiavo tra simili pensieri quando i miei occhi miravano quelle bellezze e si inumidivano. *** Nel nostro piccolo ospedale avvenne un altro episodio, questa volta finito tragicamente. Eravamo a Sala Biellese, nell'ottobre del 1944. Lia, la brava staffetta partigiana, corse dal comandante Primula: 54 - Hanno portato tre feriti in infermeria - disse.- Non sono della nostra brigata. Due sono feriti agli occhi e uno ai piedi. Si cercarono immediatamente i medici; io corsi subito in infermeria, nella villetta dei Rivetti, curiosa ed ansiosa di rendermi utile. Arrivarono subito i medici partigiani Anna Marengo e Francesco Ansaldi. I partigiani che portarono i feriti ci spiegarono i particolari del disastro occorso ad un loro distaccamento. Erano stati attaccati dalle forze nazifasciste, che avevano fatto saltare un ponte mentre i partigiani vi si trovavano sopra. Il bilancio era di un morto e tre feriti. I dottori dissero che bisognava operare subito il ferito ai piedi, aveva perso molto sangue e minacciava una cancrena; gli altri due, secondo la diagnosi dei medici, avrebbero riacquistato completamente la vista in una decina di giorni. Il ferito al piede era un giovane carabiniere, che era entrato nelle formazioni garibaldine venti giorni prima portando con sè diversi fucili e assumendo il nome di battaglia di "Trimoncino". Il verdetto dei medici fu terribile, dovevano tagliargli un piede e cercare se era possibile salvare l'altro. - Bruna - mi disse Fiamma,- te la senti di aiutarmi ? I ragazzi sono molto coraggiosi, ma assolutamente digiuni in fatto di chirurgia; tu qualcosa ne capisci. Col cuore che mi batteva in gola, accettai, e i preparativi ebbero inizio. In quel momento avevamo poco alcool; data l'urgenza, i dottori furono costretti ad usare la grappa. Con quella si disinfettò tutto il pavimento di legno. L'odore del liquore era opprimente. Trimoncino delirava, aveva la febbre altissima, tuttavia bisognava operare per salvargli la vita. Mancava anche la sega, se ne trovò una dal macellaio di Sala. Infine l'intervento ebbe inizio. Fiamma e Ceck operavano, Ferida, l'ostetrica, porgeva loro i ferri e io fungevo da anestesista. Sotto la guida di Fiamma, gli somministravo l'anestetico spruzzandolo a piccole dosi sul pezzo di garza che gli avevamo applicato sulla bocca e che, gelando, si imbiancava come se fosse brina. Contemporaneamente dovevo badare che al ferito non mancasse l'aria e che non inghiottisse la lingua. Alle voci dei medici che chiedevano i ferri si alternava la voce di Trimoncino. - Mamma - ripeteva, - mamma, non lasciarmi, non lasciarmi, mamma! Sotto l'anestesia, mi aveva scambiata per la sua mamma. 55 La dottoressa ogni tanto mi chiedeva: - Ce la fai, Bruna ? Resisti ancora ? Forse capiva dal mio pallore che ero al limite della resistenza. Mi vergognavo di sentirmi tanto debole, lo sforzo mi spezzava il cuore, ma alle invocazioni del paziente dovevo una risposta e lo assecondai, fingendomi la sua mamma, confortandolo amorevolmente. Le mani dei medici si muovevano leste, precise ed esperte. Un piede venne amputato e l'altro, leso al calcagno, lo salvarono. L'operazione, in quella difficile situazione, ebbe termine. Sperando che non subentrasse un'infezione, Trimoncino era salvo. Uscii per prima dalla saletta e non seppi rispondere alle domande dei garibaldini, che attendevano per conoscere l'esito dell'intervento. Svenni. L'odore della grappa, l'ansia e la paura mi avevano annientata. Alla sera lo stato di allarme si propagò nella zona. I feriti vennero nascosti nel vecchio mulino di Bornasco. Tutte le attrezzature del piccolo ospedale furono riposte in casse foderate di zinco e sotterrate nelle buche da noi già approntate nel giardino della villa, per occultarle ad una eventuale incursione fascista. Tutti i distaccamenti dovettero "sfollare"; ai feriti avrebbero pensato i medici, che si tenevano nascosti nelle vicinanze. *** Il battaglione Vercelli si trasferì da Sala nella valle di San Sudario, ai piedi della Serra. La caccia all'uomo, i rastrellamenti in grande stile, erano cominciati con l'autunno, quando le foglie gialle lasciavano i rami degli alberi amici che ci occultavano quando dovevamo fuggire. L'intera zona era in stato di allarme e gli attacchi si susseguivano. Eravamo rimaste a Sala la Pina, Renata ed io con due garibaldini. Anche noi eravamo pronte per partire, per raggiungere la formazione. D'un tratto, in lontananza scoppiò una furiosa sparatoria. Chi sparava, se i nostri erano già sfollati ? L'automezzo che doveva venirci a prendere era stato avvistato e assalito ? La spiegazione venne mezz'ora dopo da tre uomini del Comando, arrivati trafelati e bagnati come pulcini. Uno di essi reggeva una grande borsa di cuoio, che la pioggia aveva tutta inzuppata. - Brio, che cosa è successo ? Da dove venite ? Che cos'erano quegli spari ? - domandò Pina. - Non c'è tempo per le spiegazioni ! C'è qualche garibaldino, qui ? - No, perché ? Che cosa vi occorre ? Potete dire a noi. Intanto posa 56 questa borsa, che pesa, no ? - Questa borsa vale più di tutti noi messi assieme. Il Comando è stato attaccato e noi siamo fuggiti con tutti i documenti. Nello scompiglio ci siamo dispersi ed ora dobbiamo assolutamente ricongiungerci al resto della formazione e portare in salvo la borsa. La zona è infestata dai briganti neri e noi dobbiamo trovare il passaggio libero per portarci nella valle di San Sudario. Brio e Marinaio si rivolsero a me: - Tu sei Bruna, la sorella di Remo, l'intendente di divisione, vero ? Allora ascolta. Bisogna perlustrare la strada, precederci; insomma, fare l'avanguardia. Te la senti ? - Certo che me la sento - risposi, come se non aspettassi altro.- Era ora che mi prendeste in considerazione. Che cosa c'è da fare ? - Brava. Prendi la tua pistola e va avanti. Noi ti seguiremo a circa quindici minuti di distanza, se tutto andrà bene. Se tu dovessi fare brutti incontri, spara un colpo in aria e scappa. Per qualsiasi ragione, non tornare indietro. Stà attenta, per un pezzo devi fare la strada maestra ed è pericoloso. Vai cauta. Poi sai che dietro la chiesa di Zubiena si taglia nel bosco, sul sentiero che porta nella valle di San Sudario. In bocca al lupo, Bruna. Pina era preoccupata. - Senti - mi disse,- passa a chiedere a Quinto di accompagnarti. Non andare sola, è meglio essere in due. Mi seccava dividere con un altro la mia missione, sinceramente avrei voluto fare da sola. Ma la Pina, per me, era sempre stata tanto saggia e materna che ascoltai il suo consiglio. Quinto Quaglino era un bravo e robusto montanaro del posto. Nella formazione aveva due figli, Alba, che lavorava con me a Sala, e suo fratello, che militava in un distaccamento di Primula. Lo trovai in casa. - Perbacco, Bruna, vengo subito. Ma vedi come piove ? Aspetta, che prendo l'ombrello. Ci incamminammo senza sentire altro che il tamburellare dei goccioloni sul parapioggia. Nella mia qualità di "avanguardia" mi sentivo un po' menomata da quell'aggeggio borghese. Ma come avrei potuto impedire a Quinto di usarlo ? In fondo era un bravo collaboratore, ma... in borghese. Nessuno gli impediva di ripararsi sotto un ombrello. Io pensavo: "Però, questa pioggia dell'accidenti che risuona su 'sta lobbia', non ci lascia sentire niente. Devo dirgli di chiudere l'ombrello. Qui non bastano gli occhi, 57 bisogna tenere le orecchie ritte". I miei pensieri furono interrotti bruscamente dalla vista di una donna che correndo verso di noi urlava sbracciandosi: - I tedeschi, i tedeschi! Dalla curva, a poco più duecento di metri, spuntarono camion e motociclette. Il tamburellare della pioggia sulla tela dell'ombrello ci aveva impedito di sentirli e quelle maledette curve della strada chiudevano la visuale. Come risultato, ecco tutta quella canaglia che stava per piombarci addosso. Senza dire una parola, Quinto mi prese per mano e di corsa attraversammo la strada, infilandoci sotto gli alberi del bosco che fiancheggiava la carrozzabile. La nostra fuga improvvisa era più che sufficiente per denunciarci agli sguardi dei tedeschi. Dai camion, che erano cinque, i soldati spianarono le armi. Esitammo un attimo davanti ad un crepaccio che ci eravamo trovati dinnanzi, dal fondo minacciosamente buio, ma non c'era altro da fare. Ecco la prima fucilata. Saltammo, affidandoci alla nostra stella. Quella era fortuna: nel fondo non c'erano sassi, ma tanto fango che ci sommerse fino alla cintola. Cercammo di uscirne, di allontanarci al più presto dal crepaccio, ma la mota era viscida e pesante. Se qualche pallottola ci avesse raggiunti, non avremmo più avuto bisogno di alcuna sepoltura. I tedeschi spararono un po' di colpi, poi proseguirono. Non eravamo preda per loro. "Benone," pensammo, "con le schioppettate hanno avvisato i partigiani, che certamente si saranno allontanati per un'altra strada". Arrivati a Zubiena, dovevamo passare per forza sul prato sotto il campanile della chiesa, per scendere a valle. Ci guardammo. Quinto, pallido come un morto, mi disse: - Lo sai, vero, che poco tempo fa, proprio qui, dall'alto del campanile i tedeschi hanno ucciso tre partigiani ? - Si, lo so. - risposi. - Bene, ora facciamo finta di niente e attraversiamo questo prato. Se mi dovesse capitare qualcosa, và a casa mia e dì a mia moglie che i nostri soldi sono nascosti dietro i due mattoni nel camino; dopo l'allarme di oggi gli ho cambiato posto, lei non era in casa e non lo sa. - Va bene - risposi.- Però se succede qualcosa a me dì a mio fratello Remo che gli voglio bene... Dopo queste "raccomandazioni" ci avviammo sul prato; io mi chinavo ogni tanto con noncuranza a raccogliere qualcosa di verde, mentre lui mi 58 teneva per mano. Giunti sotto gli alberi, ci stavamo stringendo così forte le mani che la mia era tutta crampi. Non guardammo il campanile, eravamo troppo contenti, il cuore ci batteva da impazzire. Si presentava un altro ostacolo: bisognava attraversare il torrente Viona, che con tutta la pioggia caduta era in piena, ma in quel tratto le due sponde erano abbastanza vicine. Quinto divelse due alberelli e affrontammo il salto con l'asta, come gli sportivi. Prima saltò Quinto, poi saltai a mia volta. Con un po' di fortuna ce l'avevamo fatta; finite le preoccupazioni, subentrava l'entusiasmo. Tirammo un sospiro di sollievo e ci abbracciammo. Arrivammo al comando dopo molte ore, stanchi morti e inzaccherati fino al collo. Primula ci accolse con gioia, ma non nascose la sua ansia. - Perché siete qui soli ? Gli altri dove sono ? Che cosa vi è accaduto ? Gli raccontammo di Brio, della borsa e della colonna nazifascista. Il comandante mandò subito una pattuglia alla ricerca dei due uomini del Comando, della moglie e della figlia. Ero preoccupata e sentivo un certo rimorso. Chissà se la pattuglia aveva sentito i colpi ? Non avevo dato il mio segnale, perché altrimenti quei dannati avrebbero mangiato la foglia e avrebbero setacciato tutta la zona, rischiando di chiudere in trappola i nostri compagni. La cascina Zona in Valle Mulino di San Sudario. 59 Il mio tormento durò per un paio d'ore, finché la sentinella gridò: - Arrivano tutti insieme. C'è Brio con la borsa, Marinaio, Yanez. Ci sono tutti, anche Pina e Renata, con la pattuglia che era andata a cercarli. Corsi loro incontro scusandomi per non averli avvisati. Mi presero quasi in braccio, dicendomi: - Sta’ zitta, che ci hai fatto prendere una paura da matti, quando abbiamo sentito quegli spari. Avevamo tutta l'impressione che vi avessero mandati in Svizzera senza scarpe (in gergo partigiano, voleva dire "ammazzati",fatti fuori). Noi siamo scesi per Torrazzo. E' stata un po' lunga, specialmente per la Pina, ma in compenso niente brutti incontri. Le loro forze erano tutte concentrate sulla strada di Zubiena, quella che avete percorso voi. Ero felice dell'esito della mia missione. Ma c'era un punto nero. "Accidenti a quell'ombrello !" Alla Zona (una cascina presso San Sudario) c'era lo stato di allarme. Ci appostammo nei punti strategici. Qualcuno mi diede in mano una "Machinepistola" e mi disse: - Con la tua pistolina non ti difenderesti abbastanza. Sta attenta che a questa manca la sicura, appena premi il grilletto parte il colpo, quindi datti da fare, occhio. Era un falso allarme. Pietro, il proprietario della Zona, aveva scambiato per fascisti una nostra pattuglia di garibaldini che rientrava, composta da sei uomini, tra i quali Bruno Salvai (Pantera). Tutto finì bene, ma Pietro ebbe da Primula una strigliata coi fiocchi. *** Il rastrellamento tedesco si concluse dopo due giorni, poi la nostra staffetta Lia ci raggiunse dicendoci come avevano ridotto Trimoncino. Fiamma e Ceck l'avevano trovato nel rifugio dove era nascosto, morto, con una baionetta piantata in bocca. Mi sentii morire, lo rivedevo mentre lo operavano e chiamava la sua mamma ed io piangendo fingevo di essere lei. Non seppi più resistere, urlai e maledii chi l'aveva ucciso. Scoprimmo che la spiata era stata fatta da uno sfollato di Torino. Venne arrestato, processato dal comando partigiano e condannato a morte. Ricordando la penosa vicenda dell'intervento a Trimoncino, le sue invocazioni alla mamma, chiesi di essere io ad eseguire la sentenza. 60 61 Veduta aerea della Serra, con il Comune di Magnano. (Foto g.c. dall’architetto Pietro Foddanu) Primula mi guardò accigliato e disse: - Sei giovane, Bruna. Capisco quello che senti dopo quanto hai provato durante l'intervento e quando hai saputo di come l'hanno trucidato. Ma pensa, non scorderesti mai un atto del genere, per tutta la vita, ed io me ne riterrei responsabile. La sentenza venne eseguita nel modo più semplice. La spia fu accompagnata lungo un sentiero da un partigiano che lo affiancava, e due altri che lo seguivano gli spararono un colpo alla nuca. Mi resi conto, assistendo all'esecuzione, che quel tale non si era accorto di nulla. *** Nella Valle di San Sudario, ai piedi della Serra, l'acqua veniva estratta da un pozzo artesiano; purtroppo in quell'epoca, dopo il trasferimento, non piovve per tanto tempo e il pozzo divenne quasi asciutto. Per fare da mangiare al nostro distaccamento, composto da circa quarantacinque uomini, si era costretti a prelevare l'acqua da una cisterna della capacità di una ventina di metri cubi, situata dietro alla cascina, che raccoglieva l'acqua piovana. Anche quella però era scarsa, sul fondo ne restava circa trenta centimetri, grigiastra con tanti insetti. Io, che ero astemia, la bevevo dopo averla filtrata, fatta bollire e poi ancora filtrata, rammentando le raccomandazioni della dottoressa Fiamma. Certo mi faceva un pessimo effetto, ma non c'era altro. Per fortuna, si mise a piovere, prima che quella scorta finisse. *** Venne un po' di calma e vennero le belle giornate, serene e piene di sole, anche se eravamo in ottobre. Il cielo di un blu intenso era una meraviglia. Certi tramonti incantavano. Sembrava che la vita cominciasse quando il sole spariva, con tutte quelle luci, quei riflessi gialli, oro, arancio, indaco; con le nuvole che sembravano balzare e saltellare, mutando di forma e di colore. A volte sembravano soffici palloni bianchi, a volte cavalli che volavano nel cielo come Pegaso. In cielo i più bei colori del mondo. Pensavo: "Perché la guerra ? Perché la vita deve essere così piena di mali, di torture, di morti, di pianti, quando la natura che ci circonda è così bella da far desiderare solo la gioia e la serenità, di stare bene, uniti con tutti ?" Erano i sentimenti che viaggiavano, quelle cose che tu hai dentro, e a volte è meglio ascoltarle, tirarle fuori, parlarne. Talvolta, quando sei sola e vedi queste cose, ti viene un groppo in gola, perché non hai nessuno al quale dire tutto quello che senti. Il castello di Masino, luogo della battaglia del febbraio 1945. 62 CAPITOLO QUINTO Primula 63 Silvio Ortona (Lungo), che faceva parte del Comando Zona, compose una canzone partigiana: Portiamo l'Italia nel cuore, abbiamo il moschetto alla mano. A morte il tedesco invasore e noi vogliamo la libertà. A morte il fascio repubblican, a morte il fascio siam partigian ! Il ritornello di questa canzone era utilizzato da noi come segno di riconoscimento. Uno fischiettava le note di: "A morte il fascio repubblican..." e l'altro rispondeva: "A morte il fascio siam partigian". Me lo aveva insegnato Ken (Carlo Serravalle). L'autunno avanzava rapidamente e i rastrellamenti si susseguivano. Pina, Renata ed io fummo portate al castello di Masino, raggiungendo mamma e papà, Egle e Nerina. Remo ci portò anche Mirella, la sua bambina di 7 anni, perché potesse stare in compagnia e giocare un po' con la cuginetta. Nel cascinotto della Grangia, dove stava nascosta con mia cognata, non potevano avere contatti con nessuno e la bimba era molto sola. Stette con noi alcune settimane. Avevamo della farina per il pane, ce lo confezionava di nascosto un panettiere di Caravino (paese a due chilometri sotto Masino, in pianura). Gran parte dei viveri erano forniti da mio fratello Remo, sia per noi che per i partigiani che transitavano. Un pomeriggio Pina, Egle io, scese a Caravino con le due bambine, scorgemmo un giovane che era stato nella nostra brigata per qualche tempo (il suo nome di battaglia era Vito) e poi era scappato; avevamo saputo che si trattava di una spia della brigata nera, venuto tra noi per carpire dati e notizie sulle nostre postazioni e sulle armi a nostra disposizione; probabilmente conosceva la zona dove eravamo rifugiate, sia la moglie e la figlia di Primula che io e la mia famiglia. Facemmo in tempo a nasconderci prima che ci vedesse e chiedemmo informazioni al nostro fido panettiere. Ci disse che quel tizio da qualche giorno andava e ritornava; era di Borgo d'Ale e stava cercando certe sue amiche. Tornammo a Masino di volata e il mattino dopo, molto presto, partii a piedi con una compagna per portare la notizia a Primula, al comando. Percorrendo la strada di Caravino, Albiano e Bollengo, raggiungemmo la Serra (la lunga collina di natura morenica che divide il Canavese dal Biellese), affrontando una strada in salita piena di tornanti. In pianura non avevamo fatto brutti incontri, ero un po' tranquilla, in giro non c'era tanta gente ed io avevo una carta d'identità falsa, secondo la quale mi chiamavo Gorini Bruna di Giuseppe. Ma dopo qualche tornante ci bloccammo: a circa cento metri c'era un uomo abbigliato come "l'uomo mascherato" (il protagonista di un fumetto del giornalino "L'avventuroso", che faceva furore fino a qualche anno prima), con tanto di mascherina nera. Lo guardai stupita, anche perché faceva tanto freddo e lui era pochissimo vestito. Non passava nessuno per accompagnarci e andare avanti; dovevamo a tutti i costi raggiungere i partigiani, ma con una apparizione del genere non sapevamo che fare. Riflettemmo rapidamente. Se non era un fascista non poteva farci del male; però, se fosse stato un pazzo? Concludemmo che in caso estremo avrei potuto sparare, quindi proseguimmo con molta cautela. Quel giovane (avrà avuto 25-30 anni), vedendoci, scappò tra i cespugli di felci che costeggiavano la strada. Noi camminavamo guardando a destra e a sinistra, per evitare sorprese. Lo rivedemmo al tornante successivo, fermo a guardarci; per un minuto circa restammo ad osservarci a vicenda, poi lui fuggì di corsa tra le felci e non lo rivedemmo più. Non sentivamo più nemmeno la stanchezza, anche se avevamo percorso quasi venti chilometri a piedi oltre la salita della Serra. Arrivate al distaccamento, riferii di Vito, che era di Borgo d'Ale e ci stava cercando a Caravino, mentre a nostra volta cercavamo lui. Poco dopo, raccontai dell'uomo mascherato sulla Serra e i ragazzi ci derisero, dandoci scherzosamente delle visionarie. Protestai, finché due partigiani mi diedero ragione; loro abitavano a Magnano e sapevano che si aggirava sulla Serra 64 un tipo del genere, l'avevano visto altre persone. Era uno squilibrato, insensibile al freddo, ricercato dai carabinieri e mai scovato; viveva rubacchiando qua e là per cibarsi, ma non aveva mai fatto male a qualcuno, era solo ed era piuttosto protetto dalla gente, che gli lasciava di che nutrirsi vicino alle case da lui visitate di nascosto. Qualche tempo dopo la Liberazione, lessi su un giornale che la polizia l'aveva individuato e internato in un ospedale. Alba Quaglino, di Sala, ricorda ancora oggi quel singolare personaggio. Con la notizia che avevo portato, Primula fece partire subito una pattuglia alla ricerca della spia fascista. *** Ci trovavamo in una località ai piedi della Serra (ma non a San Sudario), dove si erano riuniti i comandi di diverse formazioni per incontrarsi con la missione inglese Cherokee, onde discutere e concordare gli eventuali "lanci" con aerei alleati, predisposti con messaggi speciali via radio. Il primo comandante della missione fu il maggiore Mac Donald, poi caduto prigioniero; liberato alla fine della guerra, tornò a trovarci a Borgosesia pochi anni or sono. Il secondo comandante era il maggiore Redhead. Faceva parte della missione anche il tenente Patrik Amoore, poi capitano; era sempre con noi, era il nostro "capitano Pat". Quando morì, nel 1993, volle che si seppellissero le sue ceneri a Sala, dove aveva vissuto una parte tanto importante della sua vita, ma il suo desiderio attende ancora di essere esaudito causa lungaggini burocratiche. Bisognava preparare da mangiare per tutti e i cuochi (Fra Diavolo e Dick) si misero al lavoro. Folgore ed io fummo incaricati di attingere acqua al pozzo, per rifornire la cucina. Ma in quel compito eravamo completamente inesperti. Al capo della corda era fissata una specie di spirale di ferro, nella quale si doveva infilare il manico del secchio; ma non sapevamo che bisognava inserirlo per almeno due giri della spirale e succedeva che il recipiente, urtando contro l'acqua, si sganciava. Così perdemmo tre secchi. Quando arrivò Dick per vedere se avevamo fatto il nostro lavoro, lo informammo che di acqua non ce n'era e che i secchi erano rimasti nel pozzo. Dick andò a prendere un altro secchio, lo tirò sù traboccante e ci minacciò energicamente: avrebbe riferito al comandante che per colpa nostra eravamo in ritardo per il pranzo. Io e Folgore ci nascondemmo dietro una catasta di legna da ardere e ci 65 rimanemmo per oltre un'ora, temendo la punizione di Primula, che era molto severo. Non sapevamo se avrebbe avuto comprensione per la nostra inesperienza. Pina e il comandante ci cercavano: - Dove è finita la Bruna ? Quando Primula fu informato della faccenda dei secchi, ci chiamò a voce alta, chiedendoci di uscire dal nostro nascondiglio e promettendo che non ci avrebbe puniti fino alla prossima volta. Allora ci decidemmo a presentarci, mentre gli altri ridevano divertiti. Non era poi così severo come si credeva. *** Il secondo inverno era alle porte; la neve e il freddo si avvicinavano inesorabilmente e ai garibaldini occorrevano indumenti e soprattutto armi. Gli uomini non avevano niente di pesante da indossare. Molti garibaldini avevano ancora i pantaloni corti e già soffrivano i morsi del freddo. Bisognava avere la possibilità di vestire gli uomini per affrontare l'inverno e anche avere le armi per difenderci, che scarseggiavano seriamente. I partigiani di G.L. (Giustizia e Libertà) avevano vestiti di gabardine e un mitra Sten o Thompson ciascuno, mentre i garibaldini dei nostri distaccamenti erano poco vestiti e avevano poche armi, soltanto tanto coraggio, tanta fede e tanta speranza. Le donne dei paesi avevano fatto camicie con la seta dei paracadute che erano stati lanciati in precedenza alle formazioni GL e che alcuni garibaldini erano riusciti a prelevare, insieme ad alcuni vestiti di gabardine, battendo sul tempo i destinatari giellini. Ma si trattava di ben poca roba. A questo proposito ricordo un gustoso episodio. Durante un incontro con Primula, il capitano Monti, delle GL, aveva espresso le sue vive, ma garbate rimostranze per l'indebita appropriazione. Porgendo la mano, disse: - Piacere, capitano Monti delle GL. - Poi, battendo una mano sulla spalla di Primula:- Questo è il nostro gabardine. Di rimando, Primula rispose: - Piacere mio. Riformato Primula, gabardine garibaldino. In quel tardo autunno del 1944 venne diramato il proclama del generale Alexander, comandante delle forze alleate in Italia, in cui si dichiarava che i partigiani dovevano smobilitare e nascondere le armi, per riprenderle poi in condizioni più favorevoli. Era semplicemente pazzesco. Quel proclama 66 Pietro Camana ( Primula), comandante del Battaglione Vercelli, poi 182^ Brigata Garibaldi. 67 venne discusso nel comando, in tutti i distaccamenti e fu respinto. La missione Cherokee si schierò con noi e intensificò la sua attività per ottenere i lanci di rifornimenti dagli alleati. Il primo dei lanci che ci interessavano fu realizzato a Baltigati il 24 dicembre del '44, gli altri sulla Serra, vicino a Torrazzo. Poi non ci furono più messaggi speciali, la missione Cherokee comunicava direttamente con la base in Puglia, usando un codice cifrato. (Le notizie sulla missione Cherokee sono state precisate sulla scorta di una informazione fornitami recentemente dal comandante Silvio Ortona). *** Quando ci riportarono a Masino, il giorno successivo alla riunione con la missione inglese, io non stavo tanto bene. La dottoressa Marengo disse a Primula e a mio fratello Remo che mi dovevo fermare a Masino con i miei genitori, poiché ci sarebbero stati attacchi e rastrellamenti; le nostre pattuglie, nelle loro soste al castello, avrebbero certamente avuto bisogno di assistenza. Pina e Renata stettero ancora qualche tempo con noi, poi furono portate in altro posto. Eravamo tutte famiglie divise: Giulia, mia cognata, era al cascinotto della Grangia, dove era tornata anche sua figlia Mirella (che un brutto giorno cadde e si fratturò un'anca); mamma, papà, Egle e Nerina erano a Masino con me; Remo nelle formazioni garibaldine; Bruno, il marito di Egle, deportato in Germania. Mia madre Rita, mia sorella Egle e sua figlia Nerina, nel parco del castello di Masino. 68 Noi occupavamo cinque stanze al primo piano del "palazzo", alle quali si accedeva dall'interno, passando dall'una all'altra. Accanto al nostro c'erano l'alloggio di Pitetto, lo stalliere del castello che curava le scuderie e la "citronera", e quello di Domenico, l'autista, con la moglie. Fuori c'era il ballatoio a ringhiera. A Masino, non avendo più compiti importanti come quelli di infermiera e portaordini, nè contatti con i gruppi delle compagne per le attività di volantinaggio e confezione di indumenti per i ragazzi, mi sembrava di impazzire. Nerina aveva dieci anni e in paese non c'era una scuola; io le insegnavo qualche cosa, ma ne mancavano tante altre. Quando sentivamo sparare per gli attacchi dei nazifascisti alle nostre postazioni (lo si capiva malgrado la lontananza), la mamma era tutta in agitazione. - Oh, cara Madonnina - esclamava.- Chissà quei ragazzi, chissà Remo... Con tutta l'ansia per i nostri compagni che combattevano, per mio fratello, avevamo anche tante preoccupazioni per lei. Fino a quando il suo cuore malato avrebbe retto ? Ma la sua fibra era già temprata dalle dure battaglie per le otto ore combattute con papà. Di genitori di questa pasta c'è di che essere orgogliosi. Nel negozietto di Masino avevo comprato dei colori a pastello e un foglio di carta da disegno; per ingannare il tempo, la tristezza e l'ansia, mi rifugiavo nell'incavo di un enorme tronco di castagno quasi morto, disegnando e riflettendo. Era un ottimo posto di osservazione; la distesa del Canavese sembrava ai miei piedi e l'eco di ogni conflitto al di là della Serra (la nostra zona) veniva portato dalle onde sonore fino a noi, poiché eravamo posti in alto. Lasciai un poco della mia vita tra la landa canavesana, la Serra, la neve e le lacrime. Avevo fatto amicizia con "Renè" (Enrico Odisio), uno dei giovani di Masino che si tenevano nascosti per non essere arrestati dai fascisti o internati in Germania (poi si arruolò nella 182.a brigata). Lavorava con Pitetto. Nel dicembre del '44 c'era tanta neve. Dovevo scendere a Caravino a prendere il pane; il sentiero era impraticabile e la strada lunga, a tornanti. Renè mi diede i suoi sci e mi spiegò come usarli. Partii, zaino in spalla, ma alla prima curva tirai diritto e mi impiantai in un mucchio di neve e roccia, sfasciando uno sci. Fu la prima e ultima volta che misi quelle cose. Andai a piedi, più sicura. *** Quando stavo nel mio rifugio, dentro l'incavo dell'albero, facevo qualche riflessione sul passato, sul presente, sul futuro; ricordavo lo stato d'animo, la combattività dei ragazzi che andavano di pari passo con gli eventi e le battaglie che si combattevano in Unione Sovietica e in altre parti del mondo. Quando sentivamo "tum-tum-tum-tum, qui radio Londra" ascoltavamo con ansia vivissima le notizie dell'Armata Rossa che aveva respinto su tutti i fronti le truppe tedesche, delle divisioni naziste che erano in rotta, degli Alleati che sbarcavano in Normandia iniziando la liberazione della Francia. Allora il nostro entusiasmo si risvegliava, si esprimeva con parole e gesti festosi e spingeva a combattere, alle azioni più temerarie. Combattevamo per respingere il tedesco invasore con i suoi scagnozzi fascisti, ma se questi non venivano sconfitti su tutti gli altri fronti, in special modo dove i nazi avevano impegnato il maggior numero di uomini, per noi la lotta sarebbe stata ben più lunga, anche con lo sbarco degli Alleati ad Anzio. La lotta partigiana in Italia aveva la sua grande importanza per determinare la fine dell'invasione germanica ed accelerare la conclusione del conflitto. 69 *** Nevicava da qualche giorno; eravamo pieni di freddo e di ansie, non sapevamo niente dei combattimenti che si udivano in lontananza. C'era tanta neve che attutiva i rumori per la strada e nel cortile. Una sera arrivò Pitetto, trafelato, gridando: - I tedeschi ! Sono nel cortile ! Pitetto, che sapeva tutto di noi, era corso ad avvisarci, pover'uomo, anche col buio. Io avevo la mia pistola e dovevo nasconderla. Corsi nell'ultima stanza, aprii la finestra e lasciai cadere l'arma sul tetto di un ripostiglio coperto di neve. Stavo per chiudere la finestra quando mi arrivò alle spalle un orribile mongolo, in divisa da tedesco. Mi prese per una spalla e mi girò, domandandomi cosa facevo alla finestra. - Ho sentito degli spari e volevo vedere che cosa fossero. La mia scusa non lo convinse, e disse che soltanto loro potevano sparare e non l'avevano fatto, quindi, perché stavo affacciata? Il brutto mongolo, che nel frattempo era stato raggiunto da altri quattro, guardò fuori dalla finestra. Sul davanzale c'era un pacco di burro, che pochi giorni prima ci aveva portato la staffetta con altri alimenti, perché da casa nostra passavano continuamente i partigiani di pattuglia e bisognava rifocillarli. Il mongolo aprì il pacco e sorrise soddisfatto; probabilmente credeva che io volessi nascondergli il burro. Diede il pacco ad un altro mongolo, brutto come lui. Poi mi mise una mano sul seno. Non ci vidi più, non pensai alle conseguenze e istintivamente gli mollai un ceffone. Subito quell'essere mise mano alla pistola; per fortuna lo fermò un ufficiale tedesco che seguiva i mongoli. Gli parlò molto duramente, lo convinse a lasciarmi perdere e ad unirsi agli altri, che stavano perquisendo la casa, buttando all'aria i materassi e gli armadi. Mentre uscivano, passando in cucina dove c'erano papà, mamma, Egle e Nerina, un altro mongolo si fermò ad ammirare la mia nipotina con occhi bramosi, che non ispiravano niente di buono. D'istinto, mia sorella disse che il papà della bimba era in Germania; quel coso non capì che Bruno era un internato, certamente lo credette un nazi; lasciò il braccio di Nerina e le diede un buffetto su una guancia. Se ne andarono portando via solamente il chilo di burro, qualche chilo di riso e un po' di sale. Le provviste importanti erano celate sotto una botola vicino alla stalla, introvabili. Avevamo provato una grande paura, io in special modo. Ringraziai il tenente tedesco, il quale mi disse: 70 - Bona, bona, sinorina. Mamma dovemmo metterla a letto e farle una iniezione per il cuore. Il mattino dopo andai a recuperare la mia pistola e scesi a Masino. Tutti i paesani parlavano dell'accaduto, della razzia dei tedeschi. Dalla sarta, la buona Teresa, le donne avevano fatto crocchio e descrivevano quanto avevano loro sottratto: maiali, oche sotto strutto, lardo, a tutti avevano portato via qualcosa. Per fortuna, erano soltanto razziatori. Cercavano da mangiare requisendo quanto trovavano. Io stavo sempre un po' più male, non mangiavo ed ero stanca (non sapevamo, allora, che avevo una pleurite secca). Passarono gli uomini di Quinto, comandante della I Zona. Dopo uno sganciamento, andavano a Cossano e poi alle Cascine d'Arei. Andai a trovarli, non erano tanto lontani, qualche chilometro, forse sei o sette. Era bello stare un po' con loro. *** Arrivò il due febbraio 1945. Si sentivano i colpi dei mortai, le raffiche delle mitragliatrici, i "tac-pum" dei terribili fucili tedeschi di precisione. Era un susseguirsi di colpi che ci spezzavano il cuore. Si capiva che la battaglia era a Sala, ma ignoravamo quali proporzioni avesse assunto, certo enormi, data la gran quantità di detonazioni che si udivano. Non riuscivamo ad avere notizie, l'attesa era snervante, densa di timori. Il giorno dopo Egle ed io andammo a Caravino per fare provvista di tanto pane, perché pensavamo che senz'altro sarebbero arrivati i nostri ragazzi e bisognava rifocillarli. Risalendo, scorgemmo in cima alla strada un gruppo di uomini, ma tra il bianco accecante della neve, il freddo e la paura, era difficile riconoscerli. Ci fermammo indecise e solo allora sentimmo chiamare: - Bruna, vieni, siamo noi. Sono Fra Diavolo, con Brio, Marinaio, Ricovo, Dick. Era una nostra pattuglia. Ci erano venuti incontro per strada perché i miei genitori avevano loro detto dove eravamo andate. Domandai: - Perché siete qui ? Che cosa è accaduto ieri l'altro a Sala ? Che cosa è successo ? Dove sono gli altri ? Tutti si chiusero in un silenzio opprimente, più doloroso di un grido. - Che cosa c'è? Parlate ! 71 72 La lapide commemorativa di Primula a Sala Biellese, sul luogo dove morì in combattimento. Fra Diavolo disse: - Primula è stato ucciso dai tedeschi e Ricu ferito durante il combattimento a Sala. Noi, con Carnera, Pace e Rapid, eravamo con lui. Siamo riusciti a sganciarci senza altre perdite, aiutati dal buio. Però nell'attesa siamo quasi congelati. Non ricordo il tono della mia voce, ma ero disperata. Continuavo a ripetere: - No, non può essere, lui non può morire. Primula non deve morire, sarebbe tutto finito. Fra Diavolo mi prese tra le braccia e piangemmo insieme; tutti si asciugavano gli occhi, i visi stravolti dal dolore, dalla stanchezza, dalle fatiche. Andammo a casa, si scaldarono un poco e mangiarono qualcosa, poi partirono per raggiungere altri gruppi dislocati un po' ovunque in pianura. In casa eravamo tutti annientati, sembrava che il mondo ci fosse crollato addosso, che tutto finisse con Primula. Mi rifugiai nel mio tronco d'albero; attraverso quel sentiero in mezzo alla neve, non sentii più nemmeno il freddo. Mi aiutai ricordando e ripetendo il famoso canto di Goethe: Pensiero vile Dubbio ed affanno, Timor donnesco, Cruccio e pianto, Non scaccia pena, Nè ti riscatta ! Alla violenza far fronte altiero, Non mai piangere, mostrarsi forte, Cosi s'invoca degli dei l'aiuto ! Pensavo a Pina, Renata, Tino, il ragazzino di quattordici anni, diventato uomo nell'attimo in cui aveva visto il babbo abbattersi straziato ai suoi piedi; a sua richiesta gli era stato affidato il mitra del padre. Dopo qualche giorno Remo venne a trovarci con due uomini, anche per tranquillizzare la mamma. Ci descrisse un poco la battaglia. Quando Primula cadde, i garibaldini lo spogliarono (non potendo portarlo via) perché non fosse riconosciuto come il comandante Primula; lo posero su di un tavolo dell'osteria-bar di Daria, poi si ritirarono a causa delle preponderanti forze naziste. I tedeschi riconobbero ugualmente la salma e la straziarono, infierirono selvaggiamente sul corpo inerme con tante percosse. Ma gli eroi non si distruggono, si valorizzano. Camana era prima di tutto un padre, un amico, un confidente, un combattente di prima qualità e un grande stratega (pur non avendo nemmeno fatto il militare perché riformato). Remo ripartì coi suoi uomini, doveva stare sempre all'opera per rifornire quelle masse di ragazzi in continuo movimento. La popolazione collaborava coi partigiani - guai se non fosse stato cosi ! - ma non poteva certamente dare sostentamento a migliaia di uomini. Ecco perché c'era la sussistenza. *** Passarono i giorni e continuava a nevicare, le strade erano sempre più impraticabili. Un pomeriggio una pattuglia proveniente dalle cascine d'Arei mi portò un messaggio del comandante Quinto, il quale chiedeva la mia opera (finalmente qualche cosa potevo fare, dopo tanti giorni di forzato riposo). Mi dissero che dovevo portare un biglietto al comandante Nerio (Saverio Tutino) della 76.a brigata, che si trovava con la sua formazione nel paese di 73 Io, alla base partigiana di Sala Biellese. 74 Palazzo, ai piedi della Serra, sulla provinciale tra Ivrea e Biella. Non potevano mandare nessun altro, dovendo tenere tutti gli uomini a disposizione in vista di eventuali, probabili attacchi nemici. Partii immediatamente. Scesi fino a Caravino e fin qui andò bene, poi imboccai la strada per Azeglio, ma questa era irriconoscibile, sommersa dalla neve. Per di più mi avevano detto che non dovevo percorrere le strade, ma i sentieri. Non si capiva niente, ero in un deserto bianco. Avevo percorso quella zona solamente due volte, ma allora non c'era la neve, si vedevano anche i sentieri trasversali e le foglie degli alberi, tanto importanti quali punti di riferimento. Persi l'orientamento e non incontrai nessuno per chiedere indicazioni. Infine vidi un casolare e mi avvicinai, domandai ad una donna affacciata alla finestra quale strada dovevo prendere per Palazzo. Mi indicò una direzione e mi avviai verso i ruderi di una vecchia cascina, con intorno qualche albero rinsecchito. Vidi di spalle un uomo appoggiato ad uno di questi tronchi e gli dissi : - Scusate, mi potreste insegnare la strada... Non finii la frase, perché l'uomo si voltò e vidi che era uno della "San Marco" o della "Ruggine", non ricordo di quale banda fascista fosse. Fatto sta che per poco non mi venne un colpo. - Che cosa fai da queste parti con un tempo simile ? - mi apostrofò.Dove vuoi andare ? - Cerco la strada per andare a Ivrea, in farmacia, a comprare medicine per mia madre, che è malata di cuore. - Da questa strada vai, e non da Albiano ? - Non sono di qui, siamo sfollati di Torino e non conosco nessuno, tanto meno la strada, e mia madre ha bisogno delle medicine. - Perché non vai con la corriera ? - Perché non viaggia, con un tempo simile. - Ora stai qui con gli altri, poi ti porteremo a Ivrea e vedremo come te la caverai. Dietro i ruderi di un fienile si tenevano al riparo dal vento altre otto o dieci persone. C'erano pure due camion con cinque o sei fascisti. Poco dopo ne arrivarono altri due su una moto e presero a discutere coi loro compari, mentre da lontano echeggiavano degli spari. Infine si rivolsero a noi con voce minacciosa : - Per ora andate pure, ma non fatevi più sorprendere un'altra volta, perché sarà peggio per voi. Mi parve che avessero una paura del diavolo, che quegli spari li avessero terrorizzati al pensiero dei partigiani che si aggiravano da quelle parti. Intanto tra una cosa e l'altra era arrivato il buio ed io non sapevo dove andare; sospettavo anche che la donna alla quale avevo chiesto la strada mi avesse ingannata, mandandomi a bella posta verso i fascisti. Non avrei più potuto portare il messaggio, perché mentre il fascista mi parlava lo avevo distrutto: infilandolo nel buco della tasca predisposto in precedenza, lo avevo fatto cadere lungo la gamba dei pantaloni e quando era giunto al suolo lo avevo calpestato con gli scarponi nella neve. Decisi di ritornare a Masino, sperando che Nerio avrebbe risolto il problema senza di me. Adesso bisognava ritornare indietro con quella gente, che abitava un po' a Caravino, un po' a Cossano e un po' a Masino, senza farci sorprendere per strada da nessuno. C'erano i fascisti che con la paura potevano scambiarci per partigiani e i partigiani che potevano scambiarci per fascisti. L'unica soluzione che mi venne in mente fu quella di cantare, proprio a squarciagola, canzoni "neutrali". Tutti furono d'accordo, si rivolgevano a me con fiducia, pareva che sapessero chi ero. Per quei sei o sette chilometri cantammo "La montanara". Rientrai a casa alle otto di sera; stavo veramente male e rabbrividivo per il freddo, ma anche per il senso di colpa che mi tormentava per non aver portato a compimento la missione affidatami. *** La sera del 16 febbraio 1945, mentre risalivo la rampa del castello per vedere se si scorgeva qualcosa sulla Serra, vidi attraverso i vetri di una finestra qualche figura che prontamente si ritraeva. Pensai a qualche ospite che si teneva nascosto, ma non notai nessun altro movimento anormale. Il giorno successivo il buon Pitetto ci disse che al castello c'erano i partigiani. Rimasi stupita dal fatto che non si fossero fatti riconoscere, 75 La lapide commemorativa Del Caduto partigiano Dero Azeglio (Turiello), al castello di Masino, sul luogo della battaglia. 76 non fossero venuti da noi. Pitetto disse che erano tanti, tanti. Pensai che fossero della GL. A mezzogiorno del 18 cominciammo a sentire raffiche di mitra da ambo le parti. Il combattimento durò per un po' di ore, finché scese la sera e tornò il silenzio. La marchesa, alle mie domande, rispose preoccupata che non conosceva quei partigiani, sapeva soltanto che erano del Biellese. Ero sempre più stupita. Mentre risalivamo la rampa del castello, Egle ed io trovammo i cadaveri di due fascisti, molto giovani (dalle nostre informatrici sapemmo poi che erano stati reclutati al Ferrante Aporti di Torino, casa di correzione per giovani delinquenti). I fascisti fuggiti avevano dato l'allarme e i tedeschi arrivarono il giorno dopo, con camion e grandi forze. Piazzarono una mitragliatrice pesante sul campanile della chiesetta di San Rocco, all'inizio del paese. La nostra casa si trovava proprio sulla traiettoria della mitragliera, in direzione del castello, e le prime raffiche tedesche colpirono le nostre finestre; i colpi entrarono e si conficcarono nella parete di fronte (per fortuna eravamo nell'altra stanza). I nazisti alzarono il tiro e mirarono al castello, ma non ci furono risposte. I partigiani erano riusciti ad aprirsi un varco dalla parte posteriore del castello e ad allontanarsi verso Vestignè. Ma avevano lasciato un morto, Dero Azeglio (Turiello). Eravamo stupite di non vedere nemmeno uno degli ospiti nascosti nel castello. Prima c'erano il conte Vagnone, il barone Mazzonis, il marchese di Valperga. Si erano dileguati. I lavoranti pensavano ad una galleria del castello che andava chissà dove. Per questa ragione i tedeschi non trovarono nessuno. CAPITOLO SESTO Ritorno a casa Nel castello erano rimasti soltanto la marchesa, il figlio Luigino con la governante Novellis, qualche altro bambino e una anziana contessa. La marchesa si rendeva perfettamente conto che erano possibili altre incursioni di nazifascisti, ma era una donna coraggiosa e intelligente. Stette a vedere che cosa sarebbe successo. Infatti, il mattino successivo arrivarono due camion e diverse auto di tedeschi. Saccheggiarono il castello, colmarono i camion di quadri, argenteria, arazzi, suppellettili di valore e viveri. Li vedemmo partire tutti soddisfatti. Il comandante salutò la marchesa con una impeccabile battuta di tacchi. Lei, che conosceva il tedesco e il francese, rispose con il sorriso sulle labbra: - Adieu, grand cochon (addio, grande porco). Eravamo tutti costernati. Domandai alla marchesa dove erano finiti i suoi ospiti ed ella mi rispose garbatamente che anche lei, come me, aveva i suoi segreti. C'era il problema dei viveri; in castello non era rimasto più niente, nemmeno un grammo di farina. Portammo i bambini, compresi Nerina e Luigino, nell'asilo delle suore del paese, dove si potè allestire una specie di mensa, anche per qualche anziano, la vecchia contessa, la marchesa con il figlio, la governante e la mia famiglia. Per qualche giorno furono utili le nostre provviste, specialmente la farina per il pane, finché la marchesa mandò a fare rifornimento di vettovaglie presso i suoi fattori, a San Damiano e in altre sue cascine. *** Qualche giorno dopo, temendo altre incursioni o rappresaglie dei nazifascisti, feci portare mia madre e Nerina a Borgomasino, nella casa di Domenico, l'autista, con l'auto che la marchesa ci mise a disposizione. Io e 77 Egle le accompagnammo. Ma dopo tre giorni di permanenza nella nuova abitazione la mamma si sentiva male, e noi non sapevamo come fare. Intanto Remo mandò a dire che sarebbe venuto a prenderci appena possibile, poiché sia lui che il comando ritenevano che a Masino, dopo la battaglia, non eravamo più al sicuro. Partii con Domenico e andai a prendere mamma e Nerina. Quando mi videro piansero di gioia, si sentivano sole e abbandonate, in preda alla paura accumulata in quei giorni. Al ritorno, tra Borgomasino e Vestignè, scorgemmo un uomo in bicicletta, il cantoniere, che ci faceva strani cenni additando il cielo con la mano. Guardammo, e capimmo il pericolo: due aeroplani alleati (Pippo?) stavano prendendo quota e miravano alla nostra auto. Domenico fermò immediatamente, scese, prese per mano sua moglie e scappò lontano, saltando al riparo dietro il ciglio della strada. Ero disperata, gridai a Nerina di scappare, ma la piccola, terrorizzata, mi rimase accanto; aveva paura ad allontanarsi da sola. Camminare era difficile, la strada era ghiacciata, si scivolava; la mamma era pesante, non si reggeva in piedi, e il primo aeroplano si stava abbassando per mitragliare. Ci buttammo giù, sulla strada, ma ci trovavamo a pochissima distanza dalla macchina (il cantoniere, dopo l'incursione, misurò lo spazio fra noi tre e l'auto, che risultò di tre metri). Cercai di coprire Nerina buttandomi su di lei, mentre mamma mi stava Il mitragliamento dell’auto che portava mia madre, Nerina ed io al castello, tra Borgomasino e Vestignè, in un mio dipinto ad olio. 78 accanto. Sentimmo la prima raffica dell'aereo e, vedendo che aveva colpito soltanto l'auto e non noi, mi sentii un poco rinfrancata. Pensai: "Se il primo aereo è riuscito a evitarci, speriamo che anche l'altro sia così bravo." Il secondo aereo dovette accorgersi che eravamo soltanto due donne e una bambina, fece due giri a vuoto, dandoci il tempo di allontanarci. Ci buttammo giù dalla scarpata della strada, quasi al riparo. Nerina era terrorizzata, cercava di nascondersi premendo il viso sulla neve ghiacciata, scorticandosi le guance e il naso e gridando: - No, no, basta ! Mamma tremava, non diceva nulla, era ammutolita. In verità anch'io ero costernata; sarebbe stato proprio da sciocchi morire a causa di un insulso mitragliamento. Dopo due sventagliate, entrambi gli aerei se ne andarono. Domenico e sua moglie si avvicinarono, aiutandomi ad alzare la mamma e chiedendomi mille volte scusa per essere scappati senza darmi una mano per aiutarmi. In quelle condizioni, avrei voluto rispondergli male, ma poi capii che la paura era stata più forte dell'altruismo. Portammo mia madre e Nerina in una vicina chiesetta dedicata a un santo (Domenico e sua moglie fecero poi fare un quadro che appesero in quella cappella, per ringraziare qualcuno che li aveva salvati). Mamma era svenuta; andai alla macchina e presi la borsa con i medicinali (l'unica cosa rimasta intatta, poiché l'auto era ridotta come un colabrodo per le raffiche degli aerei). l cantoniere, che nel frattempo si era allontanato, ritornò a vedere che cosa ci era successo e prestò la sua bicicletta a Domenico, che andò al castello in cerca di aiuto per la mamma. Papà, Egle e la marchesa avevano seguito le evoluzioni degli aerei con preoccupazione. Sapevano che a quell'ora solo noi potevamo essere il loro bersaglio, poiché altre auto, a parte quelle dei nazifascisti, non potevano viaggiare senza il permesso speciale che, nei dintorni, aveva soltanto la marchesa. Quando arrivammo al castello, sulla carrozza che ci aveva mandato la marchesa, papà, pover'uomo, ci abbracciò tutte e tre, piangendo. *** Dopo qualche tempo Remo venne a prenderci con due "dome". Mi disse che i due partigiani in borghese che lo accompagnavano mi avrebbero 79 portata in una cascina di Livorno Ferraris, la Spinola, una tenuta modello. Mi raccomandò di stare tranquilla, anche se poco tempo prima, il 1° marzo, in quella cascina avevano catturato numerosi partigiani, uccidendone poi la maggior parte a Salussola. Non erano stati i proprietari a denunciarli, ma una donna della cascina Morone, al di là del canale Cavour. Remo mi raccomandò di tenere sempre la pistola a portata di mano e di stare sempre in compagnia di qualcuno della famiglia. Mamma piangeva spesso, ma si tranquillizzò quando seppe che l'avrebbero portata a Tronzano con papà, Nerina e Egle, dove abitavano due fratelli di mio padre, zio Umberto e zio Luigi, capoguardia del Comune (ma a quell'epoca si trovava in carcere a Vercelli da qualche mese, per attività antifascista e collaborazione con i partigiani). Suo figlio, Valter, era impiegato nel Comune di Biella. La zia Pierina aveva affittato due camere per i miei genitori, in una casa poco distante da lei, dicendo che erano parenti di Torino, sfollati per paura dei bombardamenti. Tante altre famiglie facevano così, quindi nessuno nutrì qualche sospetto sulla loro identità. Io restai per una settimana alla cascina Spinola, proprio una azienda agricola modello, con alloggi e corridoi da fare invidia, quasi roba da film. Mi tenevo sempre la pistola a portata di mano e stavo sempre vicino a Dionisia, una maestra con qualche anno più di me; dormivamo nella stessa camera. Sentivo di peggiorare, il dolore alla schiena diventava più forte. Inoltre ero troppo isolata, malgrado la lettura di buoni libri e le conversazioni. Quella non era la mia vita, mi sentivo come un bruco nel suo bozzolo. Un giorno non ne potei più; salutai tutti, mi feci prestare una bicicletta e partii per Tronzano, distante dieci chilometri circa. Quando arrivai vidi mamma un poco più tranquilla, stava meglio. *** Grazie ai membri della locale SAP (Squadre d'azione partigiane), mi misi in contatto con Ugo, Alcide Brusa e altri militanti del Fronte della Gioventù di Vercelli. Un giorno, con Egle, decidemmo di andare a vedere la nostra casa. Partimmo da Tronzano in bicicletta, passando per San Germano e Olcenengo, quindi dal mulino della Cantarana e dal Canadà; percorrendo la "strada della catena", costeggiammo la cascina Bruciata, l'orto del Volpara e quello del Carlin Rosso, di fronte a casa nostra. 80 Andammo da mia cugina Tin. L'incontro fu commovente, ma la Tin e suo marito Toiu (Vittorio) provarono tanta paura per noi, temendo che qualcuno ci avesse viste e magari fatto una spiata. Noi li rassicurammo, perché avevamo calcolato di arrivare quando ormai faceva buio, così sarebbe stato difficile vederci. I miei cugini avevano in custodia le chiavi di casa mia, ma non servirono, perché i fascisti, quando ci cercarono, l'anno precedente, non trovandoci avevano sfasciato la porta e tutto il mobilio. Rimanevano ancora in piedi mezzo armadio e il letto di ferro dei miei genitori, un po' bruciacchiato. Il piumone del letto grande, qualche lenzuolo, la trapunta, il grammofono con i dischi e la radio erano salvi, la Tin li aveva messi al sicuro, un poco da lei e un poco dai Gentile, i nonni di Nerina. Ci fermammo da loro a dormire e al mattino presto tornammo a Tronzano. *** Finalmente arrivò il 25 aprile. La notizia che i partigiani avanzavano verso i paesi e le città ci inondò di sollievo e di entusiasmo; avremmo potuto ritornare alle nostre case. Lo straniero era sconfitto, il fascismo abbattuto, annientato. La volontà del popolo sano trionfava sulla dittatura, lo schiavismo, il razzismo. La guerra era FINITA. Il 29, Egle ed io tornammo a Vercelli in bicicletta. Indescrivibile l'accoglienza che ci fece la gente del nostro rione. Non so come, la voce del nostro arrivo si era sparsa con estrema rapidità da una casa all'altra. Mentre percorrevamo la via principale che conduceva a casa nostra, molte persone, per la maggior parte donne, correvano ad abbracciarci, piangevano, ci ringraziavano, sapevano più di noi come i fascisti ci avevano ridotta la casa. La mamma di Ermanno Agosti, un partigiano che fu ucciso dai fascisti in montagna, mi venne incontro con le braccia tese, come se invocasse chissà quale grazia, esclamando: - Sei tornata, grazie a Dio, almeno tu sei tornata, Bianca, almeno tu sei qui, hai gli anni del mio Ermanno e mi sembra di averlo qui abbracciando te. Sentii un groppo alla gola, non sapevo che Ermanno era morto. Dopo un istante di imbarazzo, abbracciai quella madre con il viso inondato di lacrime e mi sentii parte di lei. Emanava tanto dolore e tanto amore da farmi sentire 81 quasi colpevole, perché io ero tornata e suo figlio no. Raggiungemmo la nostra casa, finalmente alla luce del sole (beh, il sole era poco, perché piovigginava e faceva freddo, ma era bello ugualmente). Lasciai Egle dalla Tin e dalle sue amiche, che la circondarono subissandola di domande, e tornai in strada. Dai partigiani del rione seppi dove si trovava il comando di piazza e lo raggiunsi. Chiesi di mio fratello Remo e appena lo vidi ci abbracciammo. Per riportare a casa mamma, papà e Nerina, mi fece rilasciare dal comandante di piazza, Spartano, un permesso speciale di transito per superare i posti di blocco che i partigiani avevano istituito sulle strade principali che portavano in città. C'era un grave pericolo, una colonna dell'esercito tedesco ormai sconfitto non si era arresa, voleva consegnarsi solo alle forze alleate, americane o inglesi. I nazi avevano minacciato di fare terra bruciata al loro passaggio, perciò eravamo permanentemente all'erta. Mi misero a disposizione un camioncino e due partigiani di scorta e partimmo per Tronzano, la Egle ed io. Tutto andò liscio fino ad un posto di blocco all'ingresso di San Germano. Ci fermarono chiedendoci il lasciapassare; poi guardarono all'interno del camioncino, coperto da un telone poiché piovigginava, mi videro con Egle ed io li salutai festosamente. Vederli cosi in libertà era veramente bello. Però la mia gioia durò poco: un gappista del gruppo mi guardò ed esclamò: - Guardate chi c'è qui; abbiamo preso una spia, finalmente l'abbiamo beccata. Tutti si sporsero per guardare dietro il telone; io mi voltai per vedere di chi stavano parlando, ma il soggetto, quella che chiamavano la spia, ero io. Il piccolo uomo, con un fucile più alto di lui, ce l'aveva con me. Mi presero per un braccio, mi trascinarono giù in malo modo e mi tolsero la pistola. A nulla valsero le proteste dei due partigiani, nostre guardie del corpo, che esibirono ancora il lasciapassare ripetendo che il documento era firmato da Spartano, comandante della piazza di Vercelli, che ero la sorella di Remo e che garantivano la mia qualifica di partigiana. Furono disarmati anche loro e piantonati. Mi domandarono chi era la donna che stava con me; risposi che non la conoscevo (ignoravo la sorte che mi attendeva e, se la cosa avesse preso una brutta piega, almeno Egle avrebbe potuto andare da mamma e papà a riferire l'accaduto). Ma Egle di rimando disse: - Ma non fare la stupida. Come, non mi conosci? Ehi voi, sono sua sorella. 82 - Allora vieni giù anche tu. Tenendomi in mezzo a loro, mi portarono sù e giù lungo la strada principale del paese, gridando che avevano preso "la spia internazionale". Cose dell'altro mondo! Ci sarebbe stato di che morire dal ridere, ma per me tutto ciò si stava trasformando in un incubo. Mentre passavo le donne mi prendevano a schiaffi e mi sputavano in viso, sia all'andata che al ritorno. Se non mi venne allora un colpo apoplettico, non mi verrà mai più. Dopo quella passeggiata allucinante, malgrado le mie proteste la situazione non migliorò. Ci portarono nella caserma dei carabinieri, presidiata dal GAP e dalla SAP. Il piccolo uomo incitava gli altri affinché fossi fucilata. Era incredibile, non riuscivo a capacitarmi di una simile situazione e di esserne proprio io la protagonista. Qualcuno, più intelligente, propose: - Aspettiamo che arrivi il comandante. Dopo circa un'ora si aprì una porta ed entrarono cinque o sei persone; io pensai: "Ora viene il bello". Ero veramente preoccupata, l'euforia poteva far commettere sbagli irreparabili, in special modo da persone che avevano bevuto un po' troppo. Ma uno dei nuovi arrivati disse: - Ciao, Bruna, come va ? Io non lo ricordavo bene, ma poi mi sovvenni, era il professore che parlava inglese, venuto al comando quando c'era la missione Cherokee per discutere la proposta assurda del generale Alexander; si chiamava Giuseppe Bellaguardia. Soggiunse: - Dov'è la donna, la spia ? Il piccolo uomo mi indicò dicendo che ero io. Giuseppe andò su tutte le furie, specie quando gli raccontai quanto era successo e avevo subìto. Confermò che ero la sorella di Remo (conosciutissimo, perché operava anche da quelle parti) e non sapeva come questi avrebbe reagito appena informato di quel che mi avevano fatto. Ci fecero tante scuse e ci restituirono le nostre armi. In verità la mia pistola l'avrei usata volentieri contro quel piccolo uomo. Risalimmo sul nostro camioncino, dove i due partigiani ci attendevano preoccupatissimi per la mia sorte, e ripartimmo per Tronzano. *** Mamma e papà quando videro la nostra casa piansero, era peggiore di quanto io e Egle gli avevamo detto. Per rimetterla in piedi, qualcuno ci diede un armadio, qualcuno un cassettone, altri un tavolo e tirammo avanti, eravamo a casa nostra. 83 Scarseggiava il cibo, Remo era nella sussistenza, ma non ci portava a casa mai niente. Un giorno venne a fare visita alla mamma Nino Baltaro, il commissario politico della nostra divisione, che era anche un nostro lontano parente; saputo che Remo non portava a casa nulla, ci fece avere un po' di generi alimentari e anche del sale, pressoché introvabile. Pure per il vestire era veramente un problema. Non avevamo più una lira, i vestiti da uomo li avevamo dati ai militari che scappavano l'otto settembre, anche quelli di Bruno, perché allora era più urgente salvare i fuggiaschi dai nazifascisti che pensare di conservarli per noi. Gli indumenti da donna, già scarsi, li avevamo consumati. Qualche giorno dopo la Liberazione vennero scarcerati i detenuti politici, compreso lo zio Luigi che fu condotto a casa sua a Tronzano, dove fu accolto festosamente. *** Quando si divulgò la notizia della tragica uccisione delle sorelle Elsa e Laura Scalfi e della loro nonna, insieme allo zio Luigi Bonzanini, rimasi indignata. Conoscevo le giovani, abitando nello stesso rione, sapevo che il loro padre era un sottufficiale e attivista fascista, ma da quanto mi risultava le figlie erano ragazze a posto come tante altre. Durante il periodo da me trascorso in montagna non avevo mai saputo nulla al loro riguardo. La sentenza emessa dal comando partigiano, che dispose la fucilazione immediata dell'esecutore del massacro, Felice Starda detto "Bugia", fu esemplare. *** Ero a disposizione del comando di piazza; un giorno fui mandata ad un posto di blocco presso la Manifattura Rondo, presidiato dai ragazzi della 182.a brigata. C'erano Carnera, Fulmine, Marinaio, Brio, Ricovo, Pace, Folgore e tanti altri. Vidi una motocicletta e domandai se potevo provarla; mi dissero di sì e mi indicarono le marce, l'acceleratore, i freni e via di seguito; mi dovettero spingere perché la moto partiva solamente con la terza marcia. Sembrava una gara di corsa. Così partii, ma non sapevo fare altro se non andare diritto. Mentre sfrecciavo veloce arrivò mio fratello, mi fece inseguire da Brio e Marinaio con un'altra motocicletta per darmi istruzioni e andò tutto bene. Fu così che mi innamorai delle moto, che per tanti anni furono la mia più grande passione. 84 I giorni passavano, Egle stava con i volontari della Croce Rossa, che andavano con i camion al confine con l'Austria ad attendere il rimpatrio degli internati. Bruno fu scaricato a Pescantina e finalmente portato a casa. Quando arrivò, pesava trentotto chili, ma era salvo. Disse che, nei lager, i nazisti avevano dichiarato che se volevano ritornare in Italia potevano farlo, firmando l'arruolamento nelle forze armate repubblichine. Lui, Carlo Casalino, Dino Fornaro e gli altri di Vercelli non firmarono, preferirono restare là, magari morire, piuttosto che venire a combattere contro di noi. Quella era stata una decisione veramente eroica. Dal comando piazza avevo avuto l'incarico di cercare e scovare le donne (se non erano ancora fuggite con i resti delle truppe fasciste) che avevano collaborato con i nazifascisti in città. Ne conoscevo un paio, e tra queste la Bianca Molinaro; era di una crudeltà indicibile, lavorava al Bel Giardino (un albergo sequestrato dai fascisti, luogo di triste memoria, dove si trovava l'UPI, Ufficio politico investigativo); per le torture utilizzava anche i cani. Proprio la Molinaro possedeva un lupo tedesco al quale si accompagnava quando andava ad arrestare qualche antifascista. Rividi quella ragazza cadavere nella camera mortuaria dell'ospedale di Vercelli. Probabilmente qualcuno l'aveva giustiziata. Per fortuna arrivò anche il caldo, cosi potevo fare asciugare in fretta i vestiti che indossavo e rimetterli, perché non ne avevo di ricambio. Mio padre non aveva un lavoro, nel frattempo era stato licenziato dal suo principale, che aveva giustificato il suo gesto sostenendo che papà si era assentato per troppo tempo e che ormai era in età pensionabile (aveva 61 anni). Il padrone conosceva le vicende della nostra famiglia, anche lui aveva contribuito a nascondere i prigionieri alleati, però aveva sottratto i loro numeri di matricola per poi gloriarsene davanti alle autorità del CLN (Comitato Liberazione Nazionale). La liquidazione che pagò a mio padre fu una somma irrisoria, dopo ventisei anni di attività quale camionista. Papà vendette il grammofono e tanti dischi a Gaspare Montobbio per comperare dei viveri. Un giorno un ragazzo arrivò a casa mia e consegnò a mia madre un pacco con un biglietto, sul quale era scritto: "Scusami se mi permetto di inviarti queste piccole cose, so come ti hanno ridotto la casa e non hai di che cambiarti d'abito. Ti prego di accettare quanto ti dono, è poca cosa in confronto a quello che ha fatto la tua famiglia. Ti abbraccio. Un'amica." Nel pacco c'erano una gonna, una camicetta, una maglietta, un vestito, una 85 giacca, due canottiere, tre paia di mutandine, due paia di calze, due camicie da notte. Cercai di rintracciare la donatrice, tramite la Maria Scarparo, una collaboratrice della Resistenza. Riuscii a risalire fino alla quarta delle persone che si erano tramandato il pacco, poi più nulla. Su un giornale locale feci pubblicare un ringraziamento alla ignota "amica". Ancora oggi le sono grata, non ho mai dimenticato quel gesto di solidarietà. *** Collaborai subito con il Partito comunista della città (ero già iscritta dal 1944). Si costruiva l'organizzazione, si tenevano riunioni e comizi. Chiesi ed ottenni di presenziare ad un comizio di partigiani nel salone delle scuole di San Germano. Dopo quanto mi era successo, volevo, in un certo qual modo... riabilitarmi. Quella sera l'assemblea era veramente imponente, era la prima volta, dopo ventitré anni di dittatura fascista, che si poteva parlare liberamente. Mi presentò Giuseppe Bellaguardia, il comandante del GAP locale che mi aveva salvato la vita poco tempo prima. - Vi presento la compagna partigiana Bianca Grasso - disse, - con il nome di battaglia Bruna. Poche settimane or sono, in questo paese, è stata scambiata per una spia, e di conseguenza maltrattata da voi tutti. Mi sento in dovere di farle le più sentite scuse da parte vostra per l'enorme errore commesso. Vi fu uno scroscio di applausi. Chi mi si avvicinava e mi baciava, chi mi invitava a casa sua. Prima di iniziare il comizio, dissi: - Vorrei parlare con quell'uomo che mi arrestò. Diedi i suoi connotati, ma sembrava che nessuno lo conoscesse; vidi due uomini che erano con lui quel giorno, ma dissero che non ricordavano chi fosse, non sarebbero stati in grado di trovarlo. Ero furiosa. Lo cercai altre volte, ma non lo trovai mai. Ancora oggi ho stampato quel viso nella memoria e se non fosse invecchiato sarei certa che vedendolo lo riconoscerei. In giugno mi sentii improvvisamente prudere tutto il corpo: avevo la scabbia. Incredibile. In montagna non avevo mai sentito niente e mi si era sviluppata a casa, dove mi potevo lavare senza preoccupazioni di economizzare l'acqua come succedeva a volte in montagna. Il medico mi prescrisse la terapia da seguire: fare il bagno tutti i giorni con sapone allo zolfo; impomatarmi tutta con crema allo zolfo; indossare una camicia lunga; cambiare le lenzuola tutti i giorni e farle bollire con la camicia. Per dieci giorni seguii tutta quanta la terapia, ma senza esiti 86 apprezzabili. Mi ricoverai nel reparto infettivi dell'ospedale. Era pieno di partigiani, anche per altre malattie più importanti. Suor Teofila, che conoscevo quale collaboratrice nelle vicende dell'otto settembre, era uno spasso; ci canzonava per come ci si grattava. Passeggiavamo con un camicione lungo fino ai piedi, con maniche lunghissime per coprire le mani; puzzavamo tutti di zolfo (al buio, con un poco di fantasia e con quell'odore, si poteva immaginare che fossimo usciti da un girone dell'inferno). Questo supplizio durò per quindici giorni; poi, ristabilita, tornai alla mia tanto sospirata casa. Il partito mi chiese se volevo andare alla sua scuola, fare un corso di sei mesi. Consultai i miei genitori, furono d`accordo e accettai. Ma le mie condizioni di salute mi impedirono di fare questa esperienza. In luglio il mio dolore alla schiena stava aumentando. Fiamma mi osservò e un giorno disse: - Bruna, stai perdendo troppo peso; fà una cosa buona, và a farti fare una radiografia dei polmoni all'ospedale. Ogni tanto tossivo, avevo una tosse stizzosa e a Fiamma non piaceva, non potevo rifiutarmi. Andai all'ospedale. Il medico radiologo guardò la lastra e diagnosticò: - Cuore di ferro, polmoni d'acciaio. Fiamma si rassicurò un poco, ma nei primi giorni di settembre mi disse, molto garbatamente: - Senti, Bruna, le radiografie che hai fatto in ospedale non mi soddisfano, stai veramente preoccupandomi. Oltretutto devi andare alla scuola di partito e io vorrei che tu partissi sana, "mens sana in corpore sano". Perciò fammi un favore, và al dispensario a farti visitare dal dottor Re. Non avrai mica dei pregiudizi contro il dispensario, vero ? - No, no, Fiamma, è fatto apposta per aiutare, curarci e guarirci; quanto dice la gente non ha importanza. Poiché la maggior parte della gente, se sentiva che qualcuno andava in dispensario, lo bollava subito come tisico e cosi veniva un po' emarginato. Questo accadeva cinquant'anni or sono, quando la penicillina in Italia era ancora pressoché sconosciuta. Il mattino successivo andai al dispensario; il dottore mi visitò, mi chiese quali sintomi avevo e poi disse: - Non si è curata la pleurite ? - Quale pleurite ? - Non ha mai avuto dolori alla schiena, in basso, dalla parte sinistra ? 87 - Si, che li sentivo, eccome; ma non gli davo tanta importanza. - Aveva una pleurite secca, ed ora ha una brutta ricaduta. Lei è sola ? - No, ho i miei genitori, una sorella e un fratello. Ma che cosa vuol dire ? - E` venuta qui sola, oggi ? - Si, ma perché mi dice questo ? Senta, dottore, io so che sono malata, per questo sono qui; dove mi trovavo prima, in montagna con i partigiani, non era possibile curare una pleurite; ci si fermava quando c'erano ferite più gravi. Ora, se sono tbc me lo dica, se sono ancora curabile tanto meglio, ma non si preoccupi d'altro. L'unica mia angoscia è che procuro a mia madre, già tanto provata, un altro dolore. - Capisco. Senta, l'abbiamo presa in tempo, però deve ricoverarsi immediatamente in ospedale, da domani. Forse ce la farà prima che venga intaccato il polmone. Salutai e andai dalla Fiamma, dicendole tutto. Della scuola di partito, neanche parlarne. Al posto mio ci andò la Luigina, che dopo la scuola divenne una buona militante. Il problema era di come spiegarmi con mia madre senza farla tanto soffrire. Come potevo intavolare un discorso per non colpirla troppo ? Quello stesso giorno venne a pranzo da noi zio Luigi, che qualche anno prima era stato ricoverato in sanatorio per circa due anni e poi era guarito. Perciò, durante il pranzo, per avviare il discorso, gli domandai: - Zio, quando ti sei ammalato di pleurite, come ti sentivi? Avevi la febbre ? - Si, avevo sempre un po' di febbre. Mi sentivo sempre un po' stanco, svogliato. - Mangiavi normalmente ? - No, proprio pochino. Perché me lo chiedi ? - Cosi, tanto per curiosità. Non sapevo andare avanti nel discorso. A questo punto mia sorella intervenne, chiedendomi la ragione di tutte quelle domande. - Senti, Bianca, un motivo valido devi averlo, per fare tante indagini sullo zio. Altrimenti non entreresti in argomenti così personali. - E va bene - risposi.- Ecco di che cosa si tratta. Mamma, tu e papà eravate d'accordo che io andassi a scuola di partito e sarei stata lontano da casa per sei mesi. Invece, ora non vado più tanto lontano, starò a Vercelli e voi potrete venire a trovarmi tutti i giorni. Devo ricoverarmi in ospedale da domani, per una ricaduta della pleurite avuta in montagna. Ecco, questo è il motivo, non sapevo come dirvelo. 88 CAPITOLO SETTIMO Nostalgia della montagna 89 Venni ricoverata in ospedale nella corsia di medicina. L'ospedale era vecchio, ma proprio vecchio (del 1200), aveva le corsie disposte a crociera, da un lato la medicina, dall'altro la chirurgia, da un altro l'otorino e infine l'urologia e la cardiologia. I letti erano uno vicino all'altro, ci si poteva vedere da ogni angolo, niente riservatezza, niente intimità, neanche la più elementare; si era praticamente esposti alla curiosità di tutti, dai malati ai visitatori. Al centro della crociera, nel reparto uomini, ben piantato, c'era pure l'altare. Tutti i giorni, al mattino e alla sera, si recitava il rosario; alla domenica, la messa. L'altezza dell'interno era enorme; in alto scorreva tutt'intorno un ballatoio a ringhiera. Le finestre erano così in alto che nessuno andava mai a pulirle o a spolverarle, tanto è vero che le ragnatele cadevano giù. La pulizia dei letti, peraltro, era impeccabile, ma l'igiene generale molto discutibile; l'assistenza era valida, i dottori pure, però le suore imperavano. Il primario e il suo aiuto erano nostri collaboratori; con molti altri medici, avevano rifornito di medicinali le nostre piccole infermerie in montagna. Mi sistemarono in un letto vicino alla saletta delle visite. Era un posto strategico, potevo vedere in tutte le corsie. Almeno quel posto mi piaceva. Stetti ricoverata per tre mesi; il primo mese dovevo persino mangiare stando coricata, senza mai sedermi; dal quindicesimo giorno potevo alzarmi solamente per andare in bagno. Ero veramente messa male. Ogni giorno, anche fuori orario, venivano tante persone a farmi visita; ero ben coccolata, mi portavano zucchero, caramelle, creme, biscotti, giornali, libri. Le infermiere erano meravigliose, mi conoscevano per la loro collaborazione nell'attività clandestina ed erano a conoscenza di tutto quanto avevano fatto i fascisti alla mia abitazione e alla mia famiglia. In breve, mi subissarono di premure (anche perché stavo male). Ricordo Primina, Rosanna, Francesca, Maria, Edmea, quante altre? E poi suor Teresita, suor Guglielmina, piccola, anziana, magra, sembrava una bambolina di biscuit. I medici erano molto premurosi, mi facevano tante di quelle iniezioni che sembravo un colapasta. 90 Un giorno accadde un brutto episodio. Avevo sul comodino un libricino tascabile tratto da un periodico femminile, che descriveva la storia di due giovani; sulla copertina c'era la figura dei due innamorati, con le guance appoggiate l'una all'altra; il titolo era "Un grande amore". Passò una suora e mi disse: - E' il vostro ? Ci davamo del voi come in tempo di fascismo. - No, me lo hanno prestato. - L'avete già letto ? - No, ma se vi interessa lo potete prendere, io lo leggerò dopo. Apriti cielo ! Sembrava una furia; avevo interpretato le sue domande come una sottintesa richiesta, invece lei mi voleva sottrarre il libro e basta. - Come osate farmi una simile proposta ? Questo libro è scandaloso; lo prendo e non lo vedrete più. - Eh, no ! Non potete farlo; primo, perché il libro non è vostro e sarebbe appropriazione indebita; secondo, non è un libro indecente come dite voi, poiché è in vendita liberamente. Guardate che lo devo restituire. - E' finito il tempo in cui potevate fare tutte le sconcezze che volevate, comprese le uccisioni. Non ci vidi più. Replicai: - Sentite, suora, avete tempo per restituirmelo fino a domani sera alle sette, quando lascerete il servizio, dopo di che verrò a prendermelo. Ero fuori di me, indignata. Le degenti nei letti vicino al mio avevano sentito tutto, anch'esse sorprese e amareggiate. Mi calmarono dicendomi che scherzava, che mi avrebbe senz'altro restituito il libretto. Il giorno dopo feci rapporto, denunciando quel fatto al direttore dell'ospedale. Alla sera, la suora passò davanti al mio letto per andarsene, avendo finito il turno. Le chiesi il libro e lei mi rispose: - Ve l'ho detto ieri, non rivedrete più quel libello. - Adesso basta! - Non ero in grado di alzarmi, però vicino a me sostava il carrello dei piatti puliti; ne presi uno e glie lo lanciai, colpendola alla schiena; il piatto cadde e si infranse; la suora se ne andò. L'infermiera di servizio, la Primina, vide e sentì tutto. Il mattino dopo venne a farmi visita il direttore, un nostro compagno, con il libro che la suora mi aveva sottratto. - Ecco - disse,- il libro è qui; però tu non dovevi tirarle il piatto, non è bello ciò che hai fatto; il piatto rotto lo devi pagare, è proprietà dell'ospedale. - Va bene, io pago il piatto, ma se voi tollerate soprusi del genere da parte di chi ha sempre abusato del suo potere, che vuole limitarci e controllare le nostre scelte, allora di libertà ne abbiamo conquistata veramente ben poca. Da quel giorno diventai la beniamina della suora. Mi portava tante leccornie, quelle che davano ai malati paganti: creme, zabaglioni, cervella fritte, budini, a qualsiasi ora del giorno. Questo peraltro faceva parte della terapia, mangiare sovente, molto e bene. Stetti ricoverata dai primi di ottobre fino alla vigilia di Natale. Quando mi dimisero mi raccomandarono di fare una convalescenza di due mesi a mezza montagna, per respirare aria pura. Per un anno non dovevo andare in bicicletta, non sudare, non fare bagni in acqua fredda, non lavorare a maglia con i ferri; era un supplizio. Dopo Natale andai a Pianceri Alto, in Valsessera, ospite dei miei cugini. Anche il loro figlio Franco era stato partigiano, con Gemisto. La solidarietà e l'affetto di quella famiglia mi furono di grande aiuto. Quante passeggiate in mezzo alla neve ! Mio cugino Franco mi accompagnò ad Ailoche per farmi vedere una miniera di ferro. La strada era brutta e il ritorno lo feci in sella a un mulo della miniera, Ritornai a casa a fine febbraio e mi sottoposi al controllo del dispensario ogni tre mesi, per un anno. Tutto procedette bene, ero guarita. *** Ripresi la mia vita normalmente. Lavoravo presso l'UDI (Unione donne italiane), ma lo stipendio era poco ed io dovevo pensare ai miei genitori. Remo aveva fatto l'autista per il partito per un po' di tempo, poi riprese il suo lavoro da carpentiere: anch'egli doveva pensare alla sua famiglia. Il suo aiuto ai genitori non poteva che essere modesto. Venne bandito un concorso per ex partigiani all'INPS di Vercelli. Presentai subito la domanda alla direzione, che aveva sede in via Cagna. 91 92 Vercelli, la manifestazione del 25 aprile 1946. Io apro il corteo. (Fotocronisti Baita, g.c. dal partigiano Giovannimario Vaccino (Olmo), medaglia di bronzo al V.M.) Mi ricevette il direttore, il quale, dopo aver letto i documenti, mi disse: - Una legge vi permette di presentare la domanda di assunzione, ma se credete di poter entrare qui dentro vi sbagliate. Finché ci sarò io nessuna persona che abbia fatto parte di quella banda di assassini avrà accesso in questo istituto. Rimasi esterrefatta. Mi feci ripetere le ultime parole, credevo di aver capito male, ma quando risentii per la seconda volta quel discorso inaudito, risposi: - Io non entrerò qui dentro, come voi dite, ma dovrete lavarvi la bocca e il vestito. Presi il sottomano, sul quale stava appoggiato anche il calamaio (cinquant'anni fa non esistevano ancora le biro) e glie lo rovesciai tutto addosso, sporcandogli il vestito e, sperai, anche i pantaloni. Salutai e me ne andai. Sulla porta dell'ufficio due impiegati si ritrassero; evidentemente non volevano che il direttore li citasse come testimoni. Anche questo era un segno di solidarietà. Non avrei avuto l'impiego, anche se mi spettava per legge, ma non avevo saputo tollerare gli insulti alle forze partigiane. Quei morti lasciati lassù non me lo avrebbero perdonato. *** La mia militanza nel partito fu sempre attiva; avevo un po' il pallino dell'organizzazione e tenevo frequenti contatti con la base. La sera si partiva con la macchina della federazione in quattro o cinque, e per ognuno di noi c'era un paese dove tenere riunioni o assemblee. Fu indetto il referendum del 2 giugno 1946, per la scelta tra monarchia e repubblica, e partecipai con passione alla campagna di propaganda. A volte si veniva anche alle mani, perché gli attacchini dei nostri avversari politici coprivano i nostri manifesti con i loro; noi ne avevamo pochi e non potevamo permettere che ci distruggessero il nostro già misero materiale. Il giorno dell'apertura dei seggi fu una vera lotta. Presidiavamo i locali per timore di sabotaggi da parte dei facinorosi giovani monarchici o fascisti. Io mi trovai "di guardia" per tutta la notte del sabato, con altri compagni, al seggio che eravamo incaricati di presidiare, nei vecchi locali del posto di ristoro mondariso in piazza del Duomo. Avevo un diavolo per capello; ero stata partigiana, avevo contribuito a realizzare quanto si stava per compiere in quei seggi; quel giorno si poteva decidere la sorte degli italiani; ma non mi era concesso il diritto di esprimere la mia volontà, perché ero giovane. Per poter votare bisognava aver compiuto ventun anni, questa era la legge, e io ne avevo soltanto venti. Le elezioni andarono bene, vinse la Repubblica e fu nominata l'Assemblea costituente, con presidente il comunista Umberto Terracini, che era stato incarcerato dai fascisti nel 1928 e liberato nel 1943. Il primo gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione della Repubblica italiana. *** Nel mese di luglio del '46 entrai come operaia nella Manifattura Rondo, un complesso di trecento persone circa. Ero addetta al rammendo di pesantissime pezze di cotone felpato. Venni eletta segretaria delle tre cellule del partito. La collaborazione e l'affiatamento con le compagne di lavoro e anche con la commissione interna erano eccellenti. Il direttore, ingegner Mazzinari, era un'ottima persona, comprensiva, tollerante, amica. Volli recuperare gli anni perduti, un po' per il fascismo e poi per la guerra partigiana. Alla sera, dopo il lavoro, presi a frequentare una scuola privata con una buona insegnante, la professoressa Fassetta Seeman. Per 93 pagarmi la scuola senza pesare sul bilancio familiare, lavoravo dalle sette del mattino alle diciannove di sera, con un intervallo di mezz'ora per il pranzo alla mensa della fabbrica. Alla sera, per cena, mangiavo budini o dolci, per fare in fretta. Andavo a scuola dalle otto e mezza alle undici, tornavo a casa e studiavo fino alle due di notte. Per stare sveglia prendevo la simpamina. Dormivo fino alle sei e mezza, poi via in bicicletta, in fabbrica. Un giorno, dalla professoressa, incontrai il direttore della fabbrica, anche lui doveva studiare francese e nell'ora di lingue ci trovavamo assieme. Da quella sera seppe il motivo per cui avevo chiesto di fare il lavoro straordinario (la mano d'opera scarseggiava): per pagarmi la scuola. Fu molto comprensivo, mi diede un lavoro meno massacrante, quasi da impiegata. Dopo nove mesi di studio (mi stavo preparando per le prime tre classi magistrali), nel mese di maggio 1947, svenni per ben cinque volte in un giorno, ero sfinita. Non volevo ammettere di stare male, avevo lavorato troppo, non potevo lasciare tutto proprio alla fine, ma dovetti arrendermi. Ero diminuita di peso di ben tredici chili in dieci mesi. In sostanza, soffrivo di esaurimento nervoso e deperimento organico. Passai due mesi e mezzo a Bologna, nel convalescenziario per ex partigiani di Villa Altura. Ero proprio depressa, non dormivo mai, chiudevo gli occhi solamente quando svenivo. Le compagnie erano ottime, ma io mi estraniavo completamente. Un giorno arrivò un professore per visitare una degente paralizzata, che aveva una scheggia nel midollo spinale, dovuta allo scoppio di una bomba lanciatale dai fascisti quando era con i partigiani in Romagna. Il professore, che si chiamava Scaglietti, era un luminare dell'ortopedia. Mi vide, mi fece fare una radiografia alla spalla (per via del mio braccio anchilosato) e disse: - Senti, figliola, per ora posso solamente allungarti il braccio, se vuoi, ma per la spalla non ci sono tecniche in grado di aiutarti. Sono sicuro che un giorno si perfezioneranno e guarirai. Gli risposi un po' sgarbatamente: - Se non può fare niente per la spalla, il braccio sta com'è. Così, più corto, mi fa risparmiare la stoffa per la manica. Chissà perché, quell'omone alto e grosso accolse la mia logica così indiscutibile con una fragorosa risata. Dopo più di un mese cominciai ad affiatarmi con l'ambiente, i degenti, i 94 95 Con i miei familiari nel 1965. medici, le inservienti e il direttore, tutti partigiani. Non c'erano suore. Cominciai a pensare, mangiare, imparare a giocare a ping-pong (divenni anche brava, pur giocando da mancina). Ritornai a casa alla fine di agosto. Ripresi il lavoro alla Rondo, ma non andai più a scuola; non rammentai più nulla di quanto avevo imparato studiando con passione e sacrificio. Fu la rinuncia al mio obbiettivo agognato. Avevo chiesto troppo a me stessa, mi ero fidata troppo delle mie risorse naturali. *** Finalmente, alle votazioni del 18 aprile 1948 partecipai anch'io, per la prima volta. Ero emozionata, felice. Purtroppo, l'esito di quelle votazioni truffaldine mi fece subire una grande delusione. Il Partito comunista e i suoi alleati del Fronte democratico popolare subirono una cocente sconfitta. Il progresso del popolo italiano subì un arresto da non potersi dimenticare. Pochi mesi dopo, il 14 luglio, ci fu l'attentato a Togliatti. La protesta si tradusse in una grande mobilitazione popolare, in cui mi sentii coinvolta come se fossi ancora con i partigiani in montagna. Impiegai in quella lotta tutte le mie energie e tanta rabbia. Ma tutto finì nel nulla, mentre ancora oggi penso che l'azione rivoluzionaria in quel momento avrebbe potuto cambiare radicalmente e permanentemente la situazione. *** Venne agosto, il mese delle ferie. La montagna era rimasta la mia passione e chiesi ai miei genitori se non avevano niente in contrario a che mi recassi da sola a ripercorrere i sentieri sui monti che conoscevo, a rivedere le cascine che avevo abitato e la gente che mi voleva bene. Conoscendo le mie stranezze, non mi negarono il loro consenso, pur colmandomi di raccomandazioni. Mi equipaggiai con calzoncini corti, scarponi, zaino, e via ! Con la "littorina" raggiunsi Biella e con il trenino andai a Mongrando. Come prima tappa feci visita a Barbìs, partigiano, comandante di un distaccamento della 182.a brigata. Salutai e ripartii subito a piedi arrivando a Graglia, dove dormii da Giovanna e Gaia, dopo aver trascorso la serata raccontandoci le nostre vicende dei tre ultimi anni. Al mattino salii al Santuario, alla "Bausla" e al monte San Carlo. C'erano pure i lamponi e ne feci una scorpacciata. Il giorno dopo, scesa a Bornasco, passai a visitare il mulino dove era stato scoperto e trucidato dai nazifascisti il povero Trimoncino. Mi recai a Sala da Amata, diventata poi la moglie del comandante partigiano Enzo Pezzati (Ferrero), anche lei non proprio in ottima salute. Non so descrivere il suo stupore e la sua gioia; andò a chiamare anche le altre compagne e amiche e si fece una piccola festa, naturalmente ricordando sempre il passato partigiano. Quindi raggiunsi la Speranza, la proprietaria della cascinetta in pieno paese di Sala, dove pernottavamo quando il distaccamento era in "ferma". La donna mi offrì latte, panna e biscotti fatti in casa, e mi ricordò quel giorno, quando ero arrivata con il distaccamento alla cascinetta e le avevo mangiato tutti i pomodori. Dormii dalla Speranza, sempre squisitamente ospitale; andai anche da Daria e Italo nel loro bar. Ripartii al mattino e andai da Alba, la figlia di Quinto, quel papà che mi aveva accompagnato con l'ombrello quando eravamo andati in avanguardia alla Zona. Si parlò, si rivangarono quei pochi anni passati, si rivissero le stesse scene, quelle belle, quelle tristi e quelle disperate. Ritornai alla cascina tra Graglia e Bornasco. Da Giovanna c'erano altri pastori; era bello vedere le loro facce sane, bruciate dal sole; sono burberi, 96 ma con un cuore immenso. - Ciao, sei arrivata ? Come va ? Vuoi del latte ? Senti, ormai è tardi, ti fermi a dormire ? Vai con Giovanna e Gaia. Dissi che volevo dormire nella stalla ma loro rifiutarono decisamente. Prima di ritirarci chiacchierammo di tante cose; poi mi trattenni un po' fuori all'aperto. C'era una lieve brezza. Contemplavo quelle montagne che si stagliavano contro il cielo arancione del tramonto e mi tornavano in mente i visi tesi, preoccupati o lieti, a volte sognanti, di quei ragazzi partigiani, volontari della libertà. Dopo la colazione con latte, panna e pane di meliga abbrustolito, con una scorta di salame di "bec" (maschio di pecora) che mi vollero dare a tutti i costi, scesi a Sala. Dissero che ben pochi erano tornati a trovarle; erano felici di rivedermi e che mi fossi ricordata di loro, speravano che mi fermassi un poco. Avevo il mio programma, ma promisi che sarei tornata un'altra volta. Sempre con il mio zaino in spalla (era un poco pesantuccio, ma la forza dei miei giovani anni rendeva lieve la fatica), scesi verso Zubiena per vedere la villetta che avevamo trasformata in ospedaletto. Ma c'erano i proprietari e il cancello era chiuso. Mi limitai a guardare il giardino, dove nascondevamo tutta l'attrezzatura e i medicinali quando scattava l'allarme per i probabili rastrellamenti e incursioni nazifasciste. Arrivata a un bivio dalle parti di Vermogno, non ricordavo bene se andare a destra o a sinistra, chiesi informazioni ad un vecchio contadino: - Per favore, quale sentiero devo prendere per andare alla Zona? - Và, và, marunha, che tla sè mei ad mi (và, và, ragazza, che lo sai meglio di me). Così mi salutò e se ne andò, senza dirmi altro. Lo rincorsi, mi disse che il sentiero l'avevo percorso troppe volte e non potevo averlo dimenticato. Aveva capito che ero stata partigiana, ma non voleva capire che non mi ricordavo quel percorso, perché di lì ero passata una sola volta, con Pina, quando ero andata a prenderla alla stazione di Vergnasco, ed era quasi buio. Mi orizzontai con il sole e presi il sentiero a destra, quello giusto. Arrivata a San Sudario, piccolo agglomerato di casette, andai da Maria e Remo, suo marito, che mi riservarono una accoglienza meravigliosa, come soltanto loro sanno fare. Mi fermai per qualche giorno. Aiutavo Maria nell'orto, accudivo alle galline, andavo al negozietto di alimentari e tabaccheria a fare la spesa; girai un poco da tutte le parti che conoscevo. 97 A un certo punto mi trovai al mulino, dove era di stanza il distaccamento di Caruso (Aldo Bosetti). Con mia grande sorpresa lo trovai lì con la famiglia. Ci scambiammo saluti, abbracci, e via. Altri posti. Alla Zona, andai a rivedere la cisterna dell'acqua piovana dietro la cascina (mi era rimasto impresso quanto era stata utile in tempo di siccità). Osservai il buco nella parete di mattoni e pietre della cucina, dove i partigiani nascondevano le macchinette per farsi la barba, perché le lamette scarseggiavano e chi riusciva a prenderne una nuova per primo se la nascondeva. Quelle ferie durarono diciotto giorni. Per tre anni consecutivi le trascorsi in quel modo meraviglioso. Quanti bei ricordi, ripercorrendo quelle mulattiere e sentieri, rivedendo le note cascine ! *** In occasione del Carnevale 1950, durante una gita in moto con Nino Zavattaro, nostro amico di famiglia, rimasi vittima di un grave incidente, riportando una commozione cerebrale i cui postumi perdurarono per lungo tempo. La mia amica Ines, saputo quanto mi era accaduto, mi invitò a passare la convalescenza da lei ad Aosta. Il suo fidanzato ci portò al casinò di San Vincent; rimasi sbalordita vedendo quanta gente sprecava i soldi. Con la mia amica Ines Pavia. 98 Ci condusse in alta montagna, nei cantieri della sua segheria. Un giorno ci portò all'Ospizio del Gran San Bernardo. I famosi cani da neve impressionavano, tanto erano grossi, ma il loro sguardo dolce e mite stimolava il desiderio di accarezzarli. Quella convalescenza mi offrì l'opportunità di tornare sulle montagne che tanto amavo, perché in montagna ho vissuto la parte più importante della mia esistenza, temprato la mia personalità, esaltando in me la forza della solidarietà, indispensabile per il rispetto del prossimo. *** A questo punto concludo il mio racconto, non perché non abbia più niente da dire, ma perché ce ne sarebbe ancora troppo. Desideravo far conoscere la vita di una antifascista, di una partigiana combattente, di una comunista. Come ho scritto nell'apertura, le ansie, le gioie, le disperazioni sono tutte qui dentro. Sono fiera di essere come sono ed orgogliosa di essere una donna vercellese che qualcosa ha dato per la libertà. 99 100 Otto marzo 1993 e 1994. Gli incontri delle donne Della Resistenza di Vercelli Nel Cinquantesimo anniversario della Liberazione. (Foto Renato Greppi) 101 102 103
Scarica