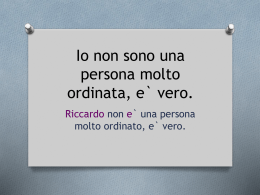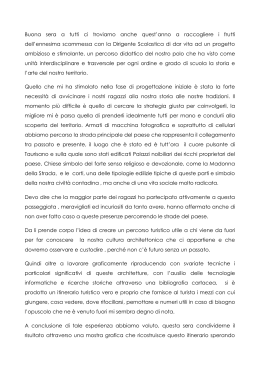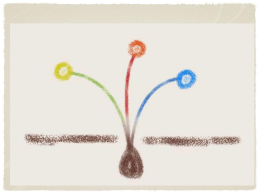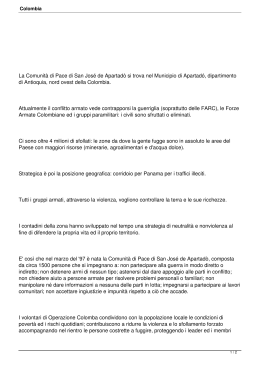http://scrivi.10righedailibri.it/ leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it PRIMO GIORNO Charlotte G., una vocazione stroncata sul nascere Le sei. Mi sveglio preoccupata come tutti i venerdì pari da otto mesi, cioè da quando i ragazzi trascorrono il weekend con il padre. E anche come tutti i martedì, «la sua sera della settimana». Anzi, a pensarci bene, come tutte le mattine da quando io e José ci siamo separati. Il mio ex marito non è mai stato così presente nella mia vita da quando non viviamo più insieme. Non so se essere felice o no del sole che filtra tra le tende; in passato dev’essermi capitato qualcosa di bello, ma quando? Per quanto mi sforzi, non mi viene in mente niente. Non ricordo i miei sogni di stanotte, so soltanto che mi hanno lasciato uno sgradevole presentimento che potrebbe restarmi incollato addosso per tutto il giorno. Meglio non indugiare a letto, non me ne verrebbe niente di buono. Approfitto dell’ora di calma prima che si alzino i bambini e controllo la posta elettronica, con quella speranza insensata, ostinatamente radicata dentro di me, che un giorno troverò il messaggio che cambierà tutto, le parole d’amore dall’ortografia perfetta di un meraviglioso sconosciuto (altrimenti non saprei chi), oppure la notizia che ho vinto un milione di dollari (sempre che non si tratti di spam). Sono così stupida da preferire la prima opzione, anche se al momento la seconda risolverebbe un certo numero di problemi che con la prima aumenterebbero solamente. Ma questa mattina, come tante 9 altre volte, ad aspettarmi c’è un messaggio di José. Ecco che cos’era quel presentimento. «Mi era sembrato di capire che avresti accompagnato tu i ragazzi in stazione per le vacanze di Pasqua, come sempre.» In effetti. José non ha mai viaggiato con i suoi figli in treno, in autobus o in metropolitana, cioè su un qualsiasi mezzo di trasporto, esperienza che si colloca tra l’ottavo e il nono girone dell’Inferno dantesco. José ha altre qualità, tra cui quella di essere molto attraente. E un appassionato di bricolage. Oltre che terribilmente intelligente, quindi perverso. La prova: «Quando dici che hai accettato di partecipare a questo incontro letterario perché eri convinta che i ragazzi sarebbero stati con me, non ti capisco proprio. Visto che era l’unico fine settimana delle vacanze in cui potevi vederli. Detto ciò, non intendo ficcare il naso nelle tue priorità». Sento montare la rabbia. José ha deciso di giocare al padre responsabile, espressione che dovrebbe suonare pleonastica, ma che riferita a lui ha quasi dell’incredibile. Nel tempo sono diventata l’esegeta della lingua estremamente specifica del mio ex marito, e ho capito che ha deciso di cogliermi in fallo. Gli rispondo prontamente: «Infatti, non ficcare il naso nelle mie priorità. Mi sembra di essermi presa cura dei ragazzi giorno e notte per nove anni perché tu avevi bisogno di silenzio per scrivere (che cosa, non lo saprò mai), situazione che pareva giustificare i tuoi va e vieni dal Portogallo, ma noto che la reciprocità non funziona. In fin dei conti, è sempre stato il principio base della nostra ex vita di coppia e, a quanto vedo, anche della nostra vita futura di genitori separati». Messaggio inviato. Se José non risponde entro dieci minuti è un brutto segno. Una doccia e due sigarette più tardi, ancora niente. Sento che questa discussione non è finita… e non lo sarà mai. 10 I ragazzi dormono ancora, ma mi piacerebbe che si svegliassero per non lasciarmi qui da sola a rimuginare. Penso a cosa fare per difendermi dall’ansia, ma purtroppo ho riordinato tutto ieri sera. Non mi rimane che preparare la colazione con particolare zelo: metto a bollire l’acqua e con le ultime due arance mi faccio una spremuta, per berla prima che si alzino i miei figli; e poi, loro preferiscono il succo nel cartone. Prendendo la teiera dall’armadietto sopra il lavello faccio cadere una tazza che non avrebbe dovuto trovarsi lì: il regalo di Adrien per la Festa della Mamma. Raccolgo i cocci in punta di piedi, ma lui si è svegliato: deve aver riconosciuto l’urlo disperato del suo capolavoro andato in frantumi… Vengo colta sul fatto. Ora è qui davanti a me e io sollevo lo sguardo, imbarazzata. Vedo il suo faccino affranto e cerco una bugia che non mi viene. Così decido di confessare: «Mi dispiace, tesoro, ti chiedo scusa. Era stata riposta male e quando ho aperto l’anta è caduta». Gli scende una lacrima. «Proverò a incollarla», propongo in evidente malafede, poiché la tazza è ormai tornata al suo stato originario: argilla friabile, sbriciolata, polvere di sabbia. Lui si rannicchia contro di me in silenzio, il viso gonfio di sonno, poi dice: «Papà non l’avrebbe mai rotta». Gli scompiglio i capelli, dispiaciuta e un po’ irritata al riconoscere nella voce di mio figlio quella di suo padre: sono esattamente le stesse parole che avrebbe detto José. Spingo Adrien verso il salotto per sgombrare il luogo del dramma e gli prometto un regalo, il solito modo per farmi perdonare. Ma lui non si lascia intenerire. O almeno, è quello che penso prima che butti lì, vendicativo: «Voglio un pacchetto di carte dei Pokémon». Mi pento di aver ceduto alla facilità del ricatto ancora prima che l’idea venisse a lui. Presa in trappola, acconsento. Lo sistemo al tavolino e gli metto davanti una cioccolata 11 calda. Suo fratello ci raggiunge, ma non ci lasciamo sfuggire una parola sull’incidente, che lo avrebbe senz’altro fatto felice (quest’anno si è dimenticato della Festa della Mamma… e anche se è più piccolo, si è comunque sentito mortificato). Accendo la radio e tutti e tre, nel tepore della stanza riscaldata come una serra dai raggi di sole che colpiscono le mattonelle, cominciamo a masticare le fette di pane imburrate. A colazione finita, riporto le tazze in cucina, metto via il burro, passo la spugnetta, e premendo il pulsante di accensione della lavastoviglie scrivo la parola fine al rituale del mattino. La lavastoviglie si mette a tossicchiare e si blocca prima ancora di iniziare il ciclo. Riprovo, schiacciando tutti i tasti uno dopo l’altro. Invano. Stupore. Sconforto. Il mese scorso l’ho già fatta riparare due volte. Il tecnico aveva predetto una fine rapida e indolore. E che cosa si fa quando ci viene assicurata la morte di qualcuno? Ovviamente non ci si dà peso. Non si crede alla catastrofe annunciata, si incrociano le dita dietro la schiena per tenerla lontana, fino a dimenticarsi di porgere l’ultimo saluto. Non si rinuncia nemmeno ai rituali magici, pur consapevoli della loro inefficacia. E oggi eccomi qui, davanti alla disfatta della negazione… e dell’elettrodomestico. Dovrò sostituirlo, e non ho più un soldo. La mia prossima busta paga dell’università è già stata fagocitata dalle bollette e dalle spese future… non può piantarmi in asso adesso, senza attendere l’e-mail salvifica lì pronta ad aspettarmi al risveglio. Avrei dovuto augurarmi la vincita di un milione di dollari, non qualche misera parola d’amore, pur senza errori ortografici. Forse mi avrebbe portato fortuna. Come ultima risorsa le sferro un calcio, tenendo a mente i precetti di José: mantenere sempre il controllo e, in caso di fallimento, vendicarsi. A giudicare dal male che sento, 12 devo essermi rotta il mignolo. La lavastoviglie, al contrario, non ha battuto ciglio. E ora eccomi zoppicante tra i resti della tazza di Adrien a inveire contro la Bosch, che porta un nome davvero di cattivo auspicio per la storia del Ventesimo secolo. Sulla soglia della cucina, Adrien e Gabriel mi osservano, sconsolati: sanno quanto sono allergica ai piatti da lavare. «Mamma, e adesso come farai?» «Andate a prepararvi!» ordino, in tono troppo duro, umiliata da questa scena disastrosa. I miei figli sono un po’ sorpresi, ma preferiscono obbedire e filano via. In effetti, come farò? La soluzione più saggia sarebbe pretendere da José il versamento degli ultimi sei mesi di alimenti che si rifiuta di darmi. Ma corro il rischio di sentirmi ripetere ancora una volta che l’ho «sbattuto fuori, buttato per strada, messo sul marciapiede», e che dovrei vergognarmi di chiedergli qualsiasi cosa. Ne ho la forza? Scivolo sul pavimento, la schiena contro il frigorifero (ancora fedele, lui), i capelli (troppo secchi) davanti agli occhi. Poi riprendo il controllo. No. Non sarò come quelle donne che si sentono sconfitte al minimo ostacolo, che hanno bisogno di assistenza non appena le macchine rinunciano alla loro vocazione (che sarebbe quella di funzionare), non mi arrenderò davanti alle insidie della tecnologia, alla rivolta degli oggetti, all’ostinazione delle caldaie a rompersi al preannunciarsi di un inverno gelido, ai water che s’intasano il giorno dell’inizio dei saldi, inghiottendo i nostri ultimi risparmi. Non mi lascerò sopraffare dalla debolezza di credere che il mondo ce l’ha con me; il mondo infatti è saturo di oggetti inanimati che, per definizione, non hanno né volontà né idee per la testa. Purtroppo, la sociologia non è dalla mia parte: sono una donna sola, quindi incapace di far funzionare un qualsiasi apparecchio, in particolare quando il libretto delle istruzioni rende vana 13 ogni speranza di autonomia e indispensabile l’intervento di un tecnico specializzato, non tanto in allacciamenti vari, quanto nell’interpretazione del libretto stesso. I miei figli, però, si aspettano ben altro da me. Devo dimostrare loro che una madre è anche una guerriera, e tanto peggio per il mio conto in banca. Finisco velocemente di spazzare i cocci, poi raggiungo i ragazzi in camera loro. «Non preoccupatevi, bambini, ho trovato la soluzione ai nostri problemi. Internet! Con un clic posso ordinare una lavastoviglie nuova, con consegna a domicilio e un risparmio del 30%!» Ma Gabriel è pronto per uscire e mi fa fretta: «Mamma, non ti vesti?» «Due secondi, tesoro.» Lui si siede sul divano con addosso il cappotto e io faccio lo stesso, appoggiando il portatile sulle ginocchia. «Ecco, scegliamo la lavastoviglie che preferisci e poi andiamo.» Non si dimostra particolarmente ricettivo alla mia proposta, ma mi viene in aiuto suo fratello. Adrien s’interessa a tutto ciò che riguarda l’appartamento, e mi sono già chiesta se non finirà per diventare un architetto d’interni. Spero comunque che, crescendo, i rivestimenti per cucine di Spiderman eserciteranno su di lui una minore attrazione. Clicchiamo sul sito del C-Discount. È indubbiamente il sito meno glamour da quando sono nate le start-up, ma il mio entusiasmo compensa il suo grigiore. Per far piacere ai ragazzi, mi fermo su una lavastoviglie a incasso: «La potremo rivestire a nostro piacimento! Con l’ardesia, per esempio, per scriverci la lista della spesa o un elenco di parole in codice per augurarci buona giornata, per tradurre dei sostantivi in inglese, farci dei disegni o esporre le nostre lamentele…» «Che cosa sono le lamentele?» «Devi sapere che durante la Rivoluzione francese c’erano dei “quaderni delle lamentele” sui quali il popolo poteva scrivere tutto quello che non gli piaceva. Potremmo fare la 14 stessa cosa!» L’idea sembra solleticarlo. Ho appena inventato la lavastoviglie terapeutica. Parecchio orgogliosa della mia scoperta, clicco su «acquista». Pagamento in tre rate senza spese extra, consegna la settimana prossima, con l’assicurazione che mi chiameranno per fissare una data. La giornata pareva essere cominciata male, ed ecco che riparte in quarta. Usciamo, sognando la nostra futura lavastoviglie… o meglio, con i miei figli che sognano le loro lamentele, e io fiera della rapidità con la quale ho condotto l’operazione (cosa che mi aiuta a dimenticarne l’aspetto finanziario). Mentre ci avviamo a scuola, mi squilla il telefono. Numero sconosciuto alle otto e trentacinque del mattino: siamo in ritardo e non rispondo. Ascolto il messaggio solo dopo aver lasciato i bambini, preoccupati di finire nell’ufficio del preside, a cui ho scritto un bigliettino di scuse sufficientemente drammatico perché s’impietosisca. Un certo Émile «Benthaux» (non ho compreso bene il cognome) vuole vedermi. Ci metto qualche istante per capire che non si tratta del direttore generale del C-Discount, ma del nuovo responsabile di collana che sostituirà Marguerite. Il mio nuovo capo, insomma. O forse no. Marguerite mi aveva preannunciato il suo arrivo in casa editrice, e la cosa aveva suscitato in me una legittima inquietudine: il mio futuro letterario sarebbe stato nelle mani di uno sconosciuto, che, date le scarse vendite delle mie ultime pubblicazioni, avrebbe potuto decidere di porre fine alla nostra collaborazione. Avevo optato per una dolce amnesia: finché non chiama, non esiste. Solo che oggi ha chiamato, e l’orario lascia supporre una certa urgenza. Sono mesi che non faccio progressi sull’idea dei coniglietti pestiferi, il testo che avrei dovuto consegnare 15 a Marguerite prima che andasse in pensione per firmare con lei un ultimo contratto, ma la sua partenza ha prosciugato la mia ispirazione. Troppi cambiamenti in troppo poco tempo: prima la separazione dal padre dei miei figli, poi la mia editor, che ricopriva anche il ruolo di madre e psicanalista, mi abbandona, rendendosi conto un po’ troppo tardi che non le piacciono i bambini e che forse ha sbagliato a dedicare tutta la propria vita alla letteratura per ragazzi. Ho tentato di farla ragionare: non c’è bisogno di amare i bambini per scrivere libri per loro. Non è detto che gli autori di letteratura «seria» amino l’umanità, malgrado si sappia che, senza di essa, nessuno leggerebbe le loro opere. Le mie argomentazioni non l’hanno convinta e, a sessantacinque anni suonati, è entrata in piena crisi adolescenziale. Così eccomi costretta a incontrare un uomo che esercita un potere notevole sulla mia scalcinata esistenza e che telefona ai suoi autori alle otto e trentacinque del mattino (chiamava senz’altro dal cellulare). Aspetterò stasera per rispondere. Per questa mattina, dopo aver distrutto la tazza che mio figlio mi ha regalato per la Festa della Mamma ed essere stata piantata in asso dalla lavastoviglie, non credo sia saggio provocare ulteriormente la sorte. Nel mio caso, il principio di concatenazione delle catastrofi ha sempre funzionato. Nell’attesa, non ho altra scelta se non lasciare controvoglia il porto sicuro del mio appartamento, adiacente alla prigione della Santé e all’ospedale Sainte-Anne: almeno sono dalla parte giusta del muro, seppur vittima di una leggera cattiva coscienza e della sensazione di un fato arbitrario, senza contare che non sarò mai al sicuro da un’evasione. È dal giorno del trasloco che mi preparo all’eventualità di dover ospitare, contro la mia volontà, un serial killer; in questa prospettiva, 16 leggo regolarmente testi di psicologia e psichiatria per adottare il comportamento migliore qualora dovesse verificarsi una situazione simile. Non avendo ancora completato lo studio delle psicopatologie che hanno condotto questi individui dietro le sbarre, incrocio le dita perché attendano la fine del mio percorso autodidatta in criminologia per minacciarmi con un coltello alla gola. A quel punto potrei finalmente avere un ruolo da protagonista, di cui si parlerà nelle aule universitarie e nei commissariati: Joséphine Fayolle, la seduttrice dei serial killer. La melodia di un flauto e abbasserebbero le armi, per trasformarsi in appassionati di letteratura per ragazzi. Ma sono in ritardo, e le mie fantasie devono aspettare. La scuola media in cui devo parlare questa mattina è in periferia. L’insegnante di francese ha fatto lavorare la classe per sei mesi sui miei due ultimi libri, I pinguini monchi e Lo scoiattolo cieco e il nano autistico, promettendo un incontro finale con l’autrice per «dare un volto» alla letteratura. Per convincermi a partecipare mi ha detto che i giovani non immaginano che dietro ogni opera c’è una persona in carne e ossa, e l’incontro renderà la lettura qualcosa di vivo, un’opportunità incredibile per loro. Non che facessi la difficile (tanto più che potrebbe essere la mia ultima occasione di questo genere, visto che la mia carriera letteraria dipende dalla decisione arbitraria e ingiusta del nuovo responsabile di collana): incontrare gli studenti è sempre divertente, e che abbiano lavorato sui miei testi mi onora. Inoltre, rappresenta un cambiamento di routine rispetto alle lezioni di filosofia che tengo all’università, e che ho avuto la buona idea di non interrompere per buttarmi anima e corpo in questa attività di cui oggi sono in grado di valutare la precarietà: nel mondo della letteratura per ragazzi gli anticipi sono penosi. Ma Rosny-sous-Bois è lontana. Quarantacinque minuti 17 di metropolitana e RER, poi mezz’ora chiusa in auto con la sconosciuta che è venuta a prendermi e con la quale mi sento obbligata a conversare, decantando la vita meravigliosa della scrittrice e la gioia di essere accolta da questi allievi così ben preparati, quando per la testa mi frulla un unico pensiero: la lavastoviglie. La guerriera sta deponendo le armi. Ed Émile Benthaux si aspetta di sicuro un libro. Che non ho scritto. Tuttavia, gli studenti mi rinvigoriscono. I miei figli tra qualche anno potrebbero essere come loro; tranne per il colore della pelle, perché bisogna ammettere che in periferia il concetto di classi miste non è ancora passato. Sono tutti ragazzini neri e magrebini, ma non corro alcun rischio di imbarcarmi in una polemica identitaria: i miei personaggi sono esclusivamente animali – animali di ogni genere, occidentali, africani, americani e asiatici – a cui poco importa di origini geografiche e convinzioni religiose, per la maggior parte handicappati (ci sono monchi, un emiplegico, un cieco e un sordomuto, per citarne solo alcuni), cosa che fa dire all’insegnante che promuovo il diritto alla differenza e alla normalizzazione dell’handicap. Non avevo mai considerato il mio lavoro sotto questo punto di vista; d’altronde non vedo il mio lavoro sotto nessun punto di vista, e di certo non sotto quello della filosofia, che resta il mio mezzo di sostentamento ma che non intendo contaminare con le mie orge animaliste. Tuttavia, se incoraggio davvero dei valori positivi, ne sono felice. Eppure, non sembra sia questo a interessare i ragazzi, e il discorso universalista della loro insegnante li disorienta. Riprendo le redini della discussione rassicurandoli sul fatto che scrivere significa osare, dire ciò che ci fa arrabbiare, senza preoccuparsi della morale. Mitigo però i miei propositi per 18 non ferire questa pasionaria che mette così tanta energia nell’educare alla civiltà generazioni di giovani più portati per i videogiochi che per la letteratura. Propongo loro un esercizio: raccontare la storia di un topo che s’intrufola in un videogioco e che, per goffaggine, fa morire tutti, sia i buoni sia i cattivi, cercando di trovare comunque un happy end; piccola concessione all’insegnante, un po’ inquieta davanti alla piega presa dagli eventi. Ci si mettono con impegno, a gruppi di cinque. Spiego sottovoce a questa donna di una certa età che si tratta di un esercizio catartico: se riescono a perdere le inibizioni nella scrittura, forse le manterranno nella vita vera: «È ciò che tutti ci aspettiamo dalla gioventù, no?» La mia proposta pedagogica sembra interessarla, ma in ogni caso la scrittrice sono io. Io ho in mano la chiave della creatività, che non s’insegna alle scuole medie; vivo di parole e in compagnia di gente morta, converso con Cartesio, Henri Bergson, Fëdor Dostoevskij, Victor Hugo e tanti altri, e a tutti do del tu (ma questo non lo dico). Possiedo un sapere esoterico di cui costei lambisce il mistero sfiorandomi la manica (macchiata dal caffè di questa mattina) mentre si alza per scrivere alla lavagna. Ama gli scrittori. Commovente. Se solo sapesse… Gli studenti mi consegnano gli elaborati e io prometto di restituire loro, nel giro di una settimana, un resoconto dettagliato. L’insegnante mi travolge di complimenti, regalandomi l’illusione momentanea di essere importante; mi ci abbandono, immaginando di passare in rassegna tutte le scuole medie di Francia per attingere dagli sguardi degli allievi e dai ringraziamenti dei loro professori la forza che mi manca davanti al computer. «È stato incredibile!» sento una volta uscita in corridoio, e arrossisco di piacere. Nel cortile della scuola tiro fuori una sigaretta e faccio per 19 accenderla, ma l’insegnante mi posa una mano sul braccio: dimenticavo, siamo in un luogo pubblico. Un gruppetto di ragazze mi segue all’esterno dell’edificio e me ne chiede una, al riparo dallo sguardo della prof. Forte della mia nuova aura, consegno loro l’intero pacchetto senza esitare, mettendomi un dito davanti alle labbra. Non indietreggio davanti a nulla per farmi delle nuove amiche, nemmeno quando si tratta di ragazze tossicomani di tredici anni (anche se queste vanno per i sedici), che prendono la pillola già da quattro e che avrebbero un gran bisogno di incontrare un adulto responsabile, cioè qualcuno che trarrebbe vantaggio dalla loro ammirazione per lui per porre loro dei limiti. Non io, quindi. Riprendo la RER in senso inverso, dopo una corsa in autobus per evitare un nuovo e inutile tête-à-tête. Di ritorno a casa, mi è impossibile evitare il richiamo al dovere. Kant il pappagallo, appollaiato sulla mia spalla (sì, Immanuel K. mi appare sempre sotto forma di pappagallo), mi si manifesta per ordinarmi di prendere il telefono e chiamare Émile Benthaux senza più indugiare. Cerco di convincere il guardiano della mia coscienza che sarebbe meglio rimandare: stasera sono distrutta, la voce mi tradirebbe, e bisogna essere in forma per mentire. L’argomentazione si rivela improponibile per Immanuel K., che considera la menzogna la trasgressione ultima della legge morale. E allora cosa dovrei fare? Chiamare Émile Benthaux e dirgli che ho urgente bisogno di denaro e di garanzie sul mio futuro? Ma che, al momento, non ho nulla da sottoporgli? Continuo a perorare la mia causa: il venerdì sera è sacro, non ho i ragazzi, è il momento che riservo alla correzione dei compiti. E per chiamare Émile Benthaux dovrei prima rileggere le poche pagine che ho scritto sei mesi fa e rivederle un po’, in modo da riappropriarmene ed essere in grado di 20 parlarne. Sarebbe un’entrata in scena migliore, no? Se mi libero stasera delle correzioni (ho promesso agli studenti di restituire i compiti mercoledì), avrò tutto il fine settimana per concentrarmi. Di fronte a questa retorica inattaccabile Kant si zittisce, mentre in sottofondo risuona «El Camino» dei Black Keys; evito di chiedergli la sua opinione sui miei gusti musicali. Rimane comunque appollaiato sulla mia spalla destra, dove di solito si dedica alle sue attività abituali, aspettando la prossima occasione per tormentarmi. Sono arrivata solo al quinto compito quando sento dei passi sulle scale e le voci acute di Adrien e Gabriel. Il battito del mio cuore accelera, come ogni volta che sto per rivederli, che si tratti dell’uscita da scuola, di quando tornano da casa di José o del risveglio al mattino. Ben presto, tuttavia, fa capolino l’ansia: perché rientrano a quest’ora? Non doveva passare a prenderli il padre? Un danno collaterale della mia e-mail? Un incidente? Mi alzo precipitosamente, immaginando già che a Gabriel è stato fatto lo scalpo e ad Adrien è stata amputata una mano. Ma sul penultimo gradino c’è José, sta riprendendo fiato. «Cos’è successo?» chiedo in preda al panico. Lui se ne accorge e ne gode per mezzo secondo, ma prima ancora che possa pronunciare la frase che senza dubbio stava preparando accuratamente da tre piani, sento gridare: «Mamma!» I ragazzi entrano e mi si buttano tra le braccia. Devo averli tenuti stretti e baciati sui capelli per parecchio tempo, a giudicare dal moto d’impazienza che avverto alle loro spalle. «Ciao», mi dice José con fare sostenuto, sottolineando la mia mancanza di buone maniere. «Non riesci nemmeno a salutare il padre dei tuoi figli, Charlotte?» Ormai mi chiama sempre così, ritorcendomi contro la fiducia che gli avevo accordato ai tempi della nostra intesa, 21 quando gli amanti si raccontano le piccole e grandi umiliazioni che li hanno resi ciò che sono e ancora non immaginano la bomba a orologeria che stanno costruendo in quell’istante di meravigliosa complicità. Charlotte non è altri che Charlotte Gainsbourg, che occupa un posto speciale nella mia esistenza da quando avevo dieci anni e una domenica sera la vidi per la prima volta in televisione nel film Sarà perché ti amo? Io, i miei genitori e mio fratello eravamo comodamente seduti sul divano, io mi succhiavo ancora il pollice (un’abitudine dura a morire), la testa contro la spalla di mio fratello, emozionata, gli occhi umidi, quando mia madre commentò: «Che ragazzina sciocca… e che smorfiosa insopportabile», e poi si rifugiò in cucina per borbottare (ma fu un borbottio che non sfuggì a nessuno): «Che zoccoletta!» A casa non si dicevano parolacce, tranne in cucina e a condizione di essere soli; poco importa che la cucina fosse separata dal salotto da una semplice porta di cartongesso, oltretutto spalancata. L’episodio accadde poco dopo che mio padre, proprio all’inizio del film, aveva commentato: «Buffo quanto vi somigliate». Osservazione che sembrava essere passata sotto silenzio – ma che non era sfuggita a mia madre – e che mi era rimasta dentro come un segno della mia vocazione: essere Charlotte Gainsbourg (mi sono poi ricreduta). Grazie alle parole di mio padre, ero diventata qualcuno. L’istante successivo avevo capito che diventare qualcuno era esattamente ciò che irritava mia madre. È forse questa la ragione inconscia per cui ho postato su Facebook l’unica mia foto in cui si nota la vaga somiglianza tra me e Charlotte Gainsbourg? Ammetto di essermi impegnata, come in una sorta di rivincita: sono di profilo, ho i capelli raccolti, indosso un top rosa, jeans neri e stivaletti con il tacco. Un copia-incolla della locandina di Prestami la tua mano. 22
Scaricare