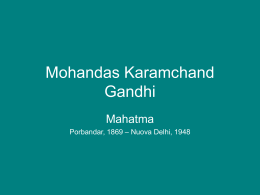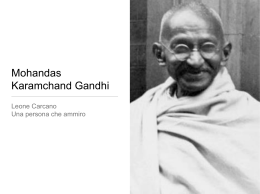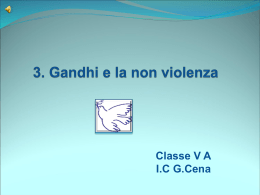leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it Antidoti Eknath Easwaran GANDHI Come un uomo cambiò se stesso per trasformare il mondo CD Traduzione di Catherine McGilvray Titolo originale: Gandhi The Man © 1972, 1978, 2011 The Blue Mountain Center of Meditation Tutti i diritti riservati. Traduzione dall’inglese di Catherine McGilvray I edizione settembre 2011 © 2011 Elliot Edizioni Srl via Isonzo 34, 00198 Roma Tutti i diritti riservati Cover design: IFIX project ISBN 978-88-6192-241-9 [email protected] www.elliotedizioni.com www.myspace.com/elliotedizioni L’Editore ringrazia la Fondazione Centro Studi Aldo Capitini per aver concesso la publicazione dello scritto Introduzione alla pedagogia di Gandhi di Aldo Capitini PREFAZIONE Il mio primo incontro con la figura di Gandhi – o almeno il primo di cui abbia memoria – fu l’articolo che “Life” dedicò alla sua cremazione. Erano trascorsi solo pochi giorni dal mio undicesimo compleanno, ed ero ancora turbato e ferito dai ricordi dell’olocausto. “Life” aveva scelto di sottolineare, nello stile enfatico dell’epoca, le impetuose manifestazioni di dolore da parte della folla sconfinata, lasciandomi con la sensazione di un evento accaduto in uno strano mondo, molto distante dal mio. Quando conobbi l’autore di questo libro, ai tempi in cui venni nominato docente all’Università di Berkeley, California, ero già un obiettore di coscienza. Come tale, in più occasioni ero stato profondamente attratto dall’esempio di Gandhi, ma altrettante volte ne ero stato scoraggiato. Il suo rigore estremo, i suoi digiuni, per non parlare del suo coraggio apparentemente sovrumano, lo facevano sembrare un essere di un altro pianeta, qualcuno le cui conquiste non ero neanche lontanamente in grado di emulare (il che era più o meno l’impressione che ne avevo tratto dalla presentazione di “Life”). Tuttavia, man mano che ascoltavo Easwaran raccontare di lui, un quadro totalmente diverso si dispiegava davanti ai miei occhi. Di sicuro ne emergeva un paradosso: Gandhi era un grand’uomo, ancora più grande di quanto avessi potuto immaginare, eppure – e questo era l’aspetto davvero straordinario – al contrario di quel che avevo credu7 Gandhi davanti al suo studio legale a Johannesburg, Sud Africa, 1905. to, era raggiungibile. Easwaran insisteva nel dire che esistevano discipline attraverso le quali una persona normale come me poteva, col tempo, sviluppare in sé una parte, seppur minima, delle colossali capacità del Mahatma. Gandhi aveva liberato l’India dal più grande impero mai visto al mondo, e nel farlo, come affermò Albert Szent-Györgyi, “dimostrò che il potere della violenza aveva perso il suo fascino”. Nel mio piccolo, anch’io avrei potuto contribuire a ridurre il livello di violenza in un mondo come il nostro, materialista e lacerato dai conflitti. E, come avrei scoperto più avanti, non avrei dovuto farlo da solo. L’inatteso potere scatenato da Gandhi per dissolvere il mito della violenza si era diffuso: in questo preciso momento potrebbe essere all’opera per cambiare le sorti dell’umanità. Easwaran mi disse una volta che Gandhi, “tornato dal Sud Africa, iniziò tranquillamente a risolvere tutti i problemi del mondo moderno”. In principio sembrava incredibile, ma quel che è certo, uno dopo l’altro i principali leader mondiali risultarono debitori nei confronti di Gandhi in questioni riguardanti l’economia, l’educazione, la politica, la filosofia e persino la dieta e la salute. Gli attivisti sociali naturalmente guardavano a lui come al padre della nonviolenza, e il più grande fra loro, Martin Luther King, cambiò la propria vita e la nostra per sempre seguendo senza riserve l’esempio di Gandhi. E.F. Schumacher, l’autore di Small Is Beautiful1, mi avrebbe in seguito confidato che il movimento da lui guidato per l’uso di tecnologie appropriate, antesignano di tanti movimenti ecologisti odierni, era interamente ispirato dall’uso che Gandhi aveva fatto del telaio a mano. Lewis Mumford lo definì “la più importante figura religiosa dei nostri tempi”, e un instancabile pacifista americano, Kirby Page, che aveva incontrato quasi tutte le figure pubbliche di spicco dei suoi tempi, affermò: “Quando annotai per la prima volta le mie impressioni su di lui, il titolo del mio libretto finiva con un punto interrogativo: Il Mahatma Gandhi è forse l’uomo più grande della nostra epoca? È da tempo ormai che ho cancellato dalla mia mente quel punto interrogativo”. Tuttavia, la domanda più importante, ossia come Gandhi abbia potuto raggiungere una tale grandezza, è rimasta senza risposta. Ed è questa la questione sollevata in quest’opera. Perché ogni conquista, in campo politico, economico, pacifista o salutista, esprime solo un aspetto dell’o9 pera di Gandhi, e nessuno di questi aspetti può essere compreso appieno a meno di non capire in prima istanza chi sia stato veramente Gandhi in quanto uomo. Lui stesso diceva: “La mia vita è una totalità indivisibile”. La vera conquista di Gandhi non va cercata in un campo particolare, ma nella sfida più importante con cui ciascuno di noi si deve misurare: cosa fare di noi stessi. Come riuscì, per dirla con le parole di Easwaran, “a fare della sua vita una simile opera d’arte”? Le prime descrizioni che abbiamo di Gandhi ci rivelano un giovane timido e goffo il cui unico tratto distintivo era l’esagerata paura del buio, nonché, come lui stesso amava sottolineare, un paio di orecchie insolitamente grandi. Come poté trasformarsi in un leader tanto carismatico, al punto che neppure i suoi stessi avversari dichiarati seppero resistere al suo magnetismo? Come poté quel giovane, soggetto a improvvisi scatti d’ira, imparare ad affrontare col sorriso sulle labbra ogni sorta di critica ingiuriosa, finendo poi per riconciliare a sé l’avversario, come un amico perduto e ritrovato? Come riuscì, per farla breve, a espandere la personalità limitata dell’uomo Mohandas K. Gandhi fino a diventare il Mahatma, quell’immensa forza propulsiva per l’evoluzione dell’essere umano che, pur descritta da innumerevoli biografi, nessuno ha mai saputo spiegare? Ecco perché abbiamo bisogno di un interprete quale Easwaran. Easwaran è nato nell’India di Gandhi, quando l’India era ancora la gemma della Corona imperiale britannica. Il suo splendido villaggio natale, come tanti altri villaggi dell’India del sud, era tagliato fuori dal corso di quei tumultuosi eventi politici che chiamiamo Storia. Più che Gandhi, col suo impegno a risvegliare l’India, fu la nonna materna a influenzare la sua giovinezza: una donna semplice, totalmente ignorata dalla storia, che non varcò mai i confini del proprio villaggio ancestrale e di certo non prese parte ad alcun movimento sociale o politico. E tuttavia, il seme che piantò nella coscienza di Easwaran aveva una storia molto più antica del movimento indipendentista: l’eredità che gli trasmise fu la ricca tradizione spirituale che aveva nutrito l’India per, probabilmente, cinquemila anni. Crescendo, Easwaran fu portato dalla vita molto lontano dai confini fisici e intellettuali del mondo di sua nonna. Quando si recò in visita a Gandhi, al culmine della lotta per l’indipendenza, era un promettente 10 giovane scrittore e futuro conferenziere, che subiva il fascino dell’Occidente. Ma non furono gli studi all’europea e la formazione intellettuale di prim’ordine che lo aiutarono a comprendere quella forza vivente che si trovò di fronte quel pomeriggio a Sevagram sotto l’albero di neem, bensì la coscienza spirituale che sua nonna gli aveva instillato nel cuore decenni prima. Fu questa che gli permise di vedere, al di là del politico, l’uomo Gandhi. L’India è una terra di grandi contrasti ma di profonda unità. La forza spirituale che Easwaran intravide in Gandhi durante quella visita era già riaffiorata innumerevoli volte nel subcontinente indiano. Sebbene le persone travolte da quella forza l’abbiano espressa in modi molto diversi, la forza in sé è la stessa; la visione ispiratrice che a essa sottende – la visione dell’unità della vita – è assolutamente identica. Lo stesso Easwaran, anche se per lo più inconsapevolmente, lottava per raggiungere quello stato di coscienza. Gandhi lo aiutò a dar voce e a rafforzare quell’anelito. Fu ancora da Gandhi, la cui vita era un libro aperto, che Easwaran imparò a trasporre nelle cose di ogni giorno le capacità sviluppate grazie alla pratica della meditazione. Gandhi era un instancabile sperimentatore: in un paese in cui i vincoli della tradizione erano sempre stati fortissimi, si sforzò, fino all’ultimo istante di vita, di introdurre deliberatamente cambiamenti nel suo modo di vivere, limandone di continuo le imperfezioni. Il manuale da lui usato a tal fine, il suo “prontuario spirituale”, come era solito chiamarlo, fu la Bhagavad Gita. Easwaran fece ricorso a quel classico senza tempo esattamente allo stesso modo. Nonostante da un punto di vista esteriore apparissero molto diversi (Easwaran, ad esempio, non prese mai parte alla vita politica), entrambi usarono la Gita come guida per le loro sperimentazioni. Così, quando Easwaran interpreta l’evoluzione interiore ed esteriore di Gandhi, ha il vantaggio di attingere direttamente alla propria esperienza. Nel mio corso sulla nonviolenza a Berkeley ero solito mostrare un eccellente documentario della BBC dal titolo Gandhi’s India, basato su interviste a persone che ebbero modo di conoscere Gandhi o di collaborare con lui. Tra le persone intervistate c’era una donna di nome Asha Devi, la preferita dai miei studenti. Alla domanda: “Com’era Gandhi? Descriva ciò che più l’ha colpita di lui” lei sintetizza il segreto di Gandhi 11 in quattro parole: “Il suo grande amore”. Più avanti, l’intervistatore dà voce a uno dei dubbi più comuni che aleggiano intorno alla figura di Gandhi: “Non pensa che avesse un atteggiamento un po’ irrealistico, che non tenesse conto di quanto siano limitate le nostre capacità?”. Mi piacerebbe farvi vedere il luccichio di gioia negli occhi della donna mentre risponde: “Non ci sono limiti alle nostre capacità”. Questa è l’autentica voce della Gita. Come esseri umani, osservava Gandhi, la nostra grandezza non risiede tanto nella nostra capacità di dare una nuova forma al mondo che ci sta intorno – come molti sono portati a credere – quanto nell’essere capaci di dare nuova forma a noi stessi sulla base del più alto modello umano di cui siamo consapevoli. Ciascuno nasce per scoprire da sé gli ideali della nonviolenza e della verità, e se solo ci lasciamo infiammare da questi ideali non c’è debolezza “di cui sia erede la carne”2 che possa impedirci di raggiungere la nostra piena grandezza. Questo è quanto Asha Devi imparò da Gandhi, ed è questo il messaggio che Easwaran ha cercato di trasmettere nelle pagine che seguono. William Shirer, autore di un’importante biografia di Gandhi, racconta come un suo amico giornalista, giunto in India subito dopo l’assassinio del Mahatma, si trovò ad assistere all’immensa manifestazione di dolore che rappresentò la mia prima, fuorviante, esperienza di Gandhi. Sgomento, chiese a un amico indiano spiegazioni su quello che stava avvenendo e questi gli rispose: “Sai, questa gente vedeva nel Mahatma lo specchio della parte migliore di sé, e ora teme che lo specchio si sia infranto”. Non è stato così. Spero che questo bel libro possa offrirvi ciò che, insieme al privilegio di una lunga frequentazione del suo autore, ha dato a me: non solo la rivelazione dell’immenso potenziale della natura umana, ma un’idea del modo in cui dispiegarlo nelle nostre vite. Michael N.Nagler Università di Berkeley 12 GANDHI N on sono un visionario. Mi considero un idealista concreto. N on ho il minimo dubbio che ogni uomo e ogni donna possano conseguire i miei stessi risultati, se compiono i miei stessi sforzi e hanno altrettanta fede e speranza. Passeggiata mattutina con Khan Abdul Ghaffar Khan e Manubehn Gandhi nel Bihar durante l’esplosione della violenza collettiva del marzo 1947. GANDHI: ALLORA E ADESSO Crescere nell’India di Gandhi Mi piace affermare che non sono cresciuto nell’India britannica bensì nell’India di Gandhi, poiché è stato lui a dominare il mio mondo come un gigante. Ero solo un ragazzino nel 1915, quando fece ritorno in patria dopo vent’anni trascorsi in Sud Africa, e fu salutato come Mahatma, ‘grande anima’. Ero troppo giovane (e il mio piccolo villaggio era troppo isolato) per avere sufficiente consapevolezza delle tragedie che lo avevano spinto, già in quegli anni, ad assumere il ruolo di guida della nazione. Solo all’età di sedici anni, quando andai al college, scoprii l’esistenza di “Young India”, il suo settimanale d’opinione. Gandhi riversava tutto il cuore in quelle pagine e sono convinto che malgrado il diffuso analfabetismo le sue parole abbiano raggiunto ogni villaggio indiano, poiché il giornale veniva passato di mano in mano e letto pubblicamente. Gli anni che trascorsi al college furono tempi turbolenti per la politica indiana. Frequentavo il terzo anno quando, la notte del 31 dicembre 1929, allo scoccare della mezzanotte, il Congresso dichiarò l’indipendenza, innalzando la bandiera dell’India libera. Il motto, in puro “stile Gandhi”: Satyam eva jayate, ‘la verità vince sempre’, era tratto da una delle nostre scritture sacre più antiche. In seguito Jawaharlal Nehru disse di quella notte: “Fissammo un appuntamento con il destino”. Per un ragazzo che frequentava il college, lontano dal suo villaggio, erano tempi eccitanti in cui vivere. Ma era solo l’inizio di un’epoca. Come gli americani con la loro Dichiarazione d’Indipendenza, avevamo preso appuntamento anche con la guerra. 17 La marcia del sale Gandhi, Jawaharlal Nehru e Maulana Azad controllano l’ora, Wardha, agosto 1935. E tuttavia sarebbe stata una guerra senza armi. Nel marzo del 1930, Gandhi scrisse al Viceré britannico che intendeva intraprendere la resistenza nonviolenta con una marcia di protesta fino al mare, contro il decreto che stabiliva che il sale e la sua manifattura fossero monopolio del governo. Aggiungeva che avrebbe accettato gioiosamente le conseguenze e che invitava il resto dell’India a seguire il suo esempio. La lettera, osservò con soddisfazione il giornalista Louis Fischer: “Era sicuramente la lettera più strana mai ricevuta da un capo di governo”. La marcia del sale fu una sorta di grandioso palcoscenico. Gandhi e il piccolo gruppo di volontari che lo seguivano impiegarono quattordici giorni per raggiungere il mare, fermandosi di villaggio in villaggio lungo la strada. Riempirono le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Quando arrivò all’oceano, la processione contava migliaia di persone. Le immagini di Gandhi che sulla spiaggia raccoglieva una manciata di sale marino e la alzava verso il cielo, inviando un segnale all’India intera, saranno state viste nei cinegiornali di ogni nazione da milioni di uomini e donne. Ma in India nessuno aveva bisogno dei media. La nazione semplicemente si sollevò in un’ondata di disobbedienza – del tutto nonviolenta – alle leggi britanniche. Nessuno poteva prevedere che, di fronte alle cariche della polizia, alle botte, agli arresti e a fatti ancora più gravi, non ci sarebbero stati cedimenti alla linea della nonviolenza. Ciascuno di noi sapeva che, per quanto fossimo provocati, Gandhi avrebbe abbandonato la sua campagna se ci fosse stata qualsiasi violenza da parte nostra. “Mantenemmo la promessa”, giorno dopo giorno, riempiendo le carceri fino a farle letteralmente scoppiare. Molti veterani di quel tempo ricordano il periodo di prigionia come il momento più alto delle loro vite: Gandhi aveva reso un punto d’onore il “soffrire per la verità”. Non trovo le parole per esprimere l’effetto che questa vicenda ebbe su di me e sull’India intera. Certo era tutto molto drammatico, ma la cosa che più mi colpì fu l’alchimia umana. I resistenti erano persone comuni, famigliari, amici, compagni di scuola, conoscenti, uomini e donne che incontravamo abitualmente al mercato o al tempio, al lavoro o a scuola. Persone di tutte le età, di ogni casta, istruite o ignoranti, raffinate o rozze, ric19 che oltre ogni dire o incredibilmente povere. Com’era potuto accadere che, tutt’a un tratto, si fossero trasformate in eroi ed eroine che gioiosamente si facevano avanti per farsi percuotere con manganelli dalla punta d’acciaio, per essere trascinate in prigione, spogliate di ogni mezzo di sussistenza e, a volte, persino uccise? Spronati a essere più che umani, ci guardammo intorno, accorgendoci che era nelle nostre possibilità. Gandhi aveva ragione: il corpo poteva essere fragile ma lo spirito non aveva limiti. Eravamo molto, molto più forti di quello che pensavamo, capaci di grandi imprese, non per nostra bravura, ma perché c’era del divino in tutti noi – anche in coloro che roteavano i bastoni e brandivano le armi. Il quesito che mi bruciava dentro era: qual era il segreto di questa alchimia? Gandhi nel suo ashram I miei studi mi portarono a frequentare un’università dell’India centrale, situata in prossimità dell’ashram di Gandhi, la piccola comunità da lui chiamata Sevagram, ‘villaggio del servizio’. Finalmente avevo l’occasione di avvicinarlo. Un fine settimana decisi quindi di fargli visita, sperando di trovare risposta al mio quesito. Giunto alla stazione, dovetti percorrere le ultime miglia a piedi. Arrivai che il sole era già basso sull’orizzonte. Una folla si era raccolta intorno al piccolo capanno dal tetto di paglia dove Gandhi era rimasto chiuso fin dall’alba, impegnato in trattative urgenti di rilevanza nazionale. Ebbi un tuffo al cuore. Dopo tutto quel da fare, sarebbe stato stanco, teso e irritabile, con poco tempo da dedicare a un ospite. Ma quando si aprì la porta del capanno, saltò fuori un agile ometto sulla settantina con il passo elastico e gli occhi maliziosi di un adolescente, che rideva e scherzava con chi gli era intorno. Avviandosi di buon passo per la sua passeggiata serale ci fece cenno di seguirlo. Dopo un po’ la folla si era diradata. Più che camminare velocemente sembrava volare. Con lo scialle bianco che svolazzava e le goffe gambe nude sembrava una gru in procinto di alzarsi in volo. Mi è sempre piaciuto passeggiare, ma dovevo continuamente allungare il passo per tenergli dietro. Gli interrogativi in me andavano aumentando. Sulle spalle di quest’uomo, che aveva ormai superato i settant’anni – l’età del crepuscolo 20 per gli standard indiani di quei tempi – gravava quotidianamente la responsabilità di quattrocento milioni di individui. Da almeno cinquant’anni viveva sotto l’immensa pressione di questa responsabilità per quindici ore al giorno, ogni giorno. Come aveva fatto a non cedere? Come poteva mantenere una simile freschezza? Qual era la fonte di una simile vitalità e di un buon umore apparentemente sconfinati? Al termine della passeggiata, giunse l’ora di riunirsi in preghiera. Era ormai notte, dappertutto erano state accese le lampade antivento. Gandhi sedeva con la schiena dritta appoggiata a un albero. Ero riuscito a trovare un posto vicino a lui, così da aprirgli tutto il mio cuore. Un monaco giapponese iniziò intonando un’invocazione buddista, poi una signora inglese cantò uno degli inni preferiti da Gandhi: Lead, Kindly Light di John Henry Newman. Gandhi, gli occhi chiusi, era profondamente concentrato, come assorbito dalle parole. Finito il canto, la sua segretaria, Mahadev Desai, intraprese la recitazione della Bhagavad Gita, la più nota delle scritture indiane, le cui vicende si svolgono su un campo di battaglia che secondo l’interpretazione di Gandhi rappresenta il cuore umano. Nei versi che venivano declamati, Arjuna, il principe guerriero che simboleggia ognuno di noi, chiede a Sri Krishna, il Dio interiore, come si possa riconoscere una persona consapevole del Divino in ogni momento della sua vita. Shri Krishna risponde con otto magnifici versi che non hanno pari nelle sacre scritture di tutto il mondo: Vivono nella saggezza coloro che vedono se stessi in ogni cosa e ogni cosa in se stessi, coloro il cui amore per il Signore dell’Amore ha consumato ogni desiderio egoistico e ogni brama dei sensi che turbano il cuore. Né turbati dalle afflizioni, né ansiosi di piacere, essi vivono liberi dalla lussuria, dalla paura e dalla rabbia. Non più incatenati da legami egoistici, non si esaltano per la buona sorte né si deprimono per la cattiva fortuna. Tali sono coloro che vedono Dio. Il sanscrito è una lingua musicale, perfetta per essere recitata. Mentre la domanda iniziale di Arjuna riverberava nell’aria della notte, Gandhi si fece del tutto immobile. Era così profondamente assorto che sembrava respirare appena, come sospeso al di là dello scorrere del tempo. D’improvviso, la questione posta nella Gita: “Dimmi di coloro che vivono radicati nella sag21 gezza”, divenne parte di un dialogo vivente. Non stavo solo ascoltando la risposta, la vedevo, mentre osservavo un uomo che, per quella che era la mia comprensione, incarnava ogni condizione prescritta dal testo. Ho sempre amato la Gita per la sua bellezza letteraria. L’ho letta e l’ho sentita commentare molte volte. Ma l’interpretazione di Gandhi rendeva palese il suo significato nascosto. Non si limitava a “illustrarla”: egli era diventato letteralmente quelle parole, un’incarnazione vivente del loro significato. “Libertà dai desideri egoistici”, non era sinonimo di indifferenza, significava, piuttosto, non cercare di ottenere nulla per se stessi, ma dare il meglio di sé in qualsiasi circostanza, senza dipendere da altro se non dal Divino dentro di noi. Il fine, chiaramente, non era l’estinzione della personalità. Gandhi, in ogni senso, si stagliava per la sua personalità, del tutto originale. Noi, in confronto, sembravamo insipidi, come se vivessimo addormentati. Lui diceva di aver fatto di se stesso uno zero, eppure sembrava essere diventato, invece, una sorta di canale cosmico, un passaggio per qualche immensa forza universale, uno “strumento di pace”. Quei versi della Gita rappresentano la chiave per comprendere la vita di Gandhi. Sono parole che illustrano la più alta espressione dell’essere umano. Non descrivono un leader politico, ma un uomo di Dio. Non ci dicono cosa dobbiamo fare della nostra vita, ma quello che dovremmo essere. Sono parole universali, che dipingono un ritratto comune, nella sua essenza, a tutte le religioni, che si riflette nelle esistenze di tutti coloro che aspirano a una vita spirituale, in ogni parte del mondo. Nonviolenza In profonda meditazione durante un raduno di preghiera, Bombay, settembre 1944. “Solo quando imparai a ridurmi a uno zero”, afferma Gandhi, “divenni capace di sviluppare il potere del satyagraha in Sud Africa”. Satyagraha – letteralmente: ‘attenersi alla verità’ – è il nome che diede al suo metodo di lotta priva di violenza o ritorsione. Gandhi era un genio quando si trattava di rendere concreti degli ideali astratti, ne è prova il modo in cui spiega l’essenza del satyagraha. In sanscrito la parola satya,’verità’, deriva da sat, ‘ciò che è’. La verità è; il suo contrario invece è solo apparenza. Gandhi portò questo concetto fuori dal regno del23 le dotte dissertazioni e lo collocò nel centro della realtà politica. Ne spiegava il significato affermando che il male ha una sua realtà solo nella misura in cui noi lo nutriamo. Attenersi alla verità significa quindi essenzialmente togliere nutrimento a ciò che è sbagliato. Se ciò viene fatto da un numero sufficiente di persone – sosteneva Gandhi – o anche da una sola persona a un livello abbastanza profondo, il male, venendo meno il suo sostentamento, non può che dissolversi. Gandhi non fu mai un teorico. Imparava facendo. Continuò a perfezionare il satyagraha mettendolo in pratica per tutta la vita, andando avanti a sperimentare fino al giorno in cui lo assassinarono. Ma i fondamenti del suo approccio sono presenti fin dall’inizio in Sud Africa. Il primo passo è la sincera convinzione che una situazione ingiusta danneggi entrambe le parti coinvolte: la discriminazione razziale era degradante per gli europei così come per gli indiani. Una soluzione, per essere duratura, avrebbe quindi dovuto sollevare da quel peso gli uni e gli altri. In termini spirituali, questa concezione è la logica conseguenza dell’unità della vita, ossia di ciò che Gandhi intende con la parola verità. Ma tale concezione ha anche dei risvolti eminentemente pratici, poiché solo una soluzione che sia giusta per tutti può di fatto portare alla risoluzione del problema, e far evolvere la situazione. Non si tratta tanto di cercare una soluzione “vincente” per entrambe le parti in conflitto, ma di far sì che ognuna di queste ne esca con maggiore dignità, con una umanità più profonda. Concetto ugualmente essenziale, ma di più difficile comprensione, quello secondo cui l’esercizio della nonviolenza consiste nella sofferenza volontaria. È così che funziona di fatto. In Sud Africa Gandhi si rese conto di come, in ultima analisi, la ragione sia incapace di cambiare il cuore delle persone. La discriminazione razziale era fonte di sofferenza; lo scopo del satyagraha era di rendere visibile tale sofferenza. Dopodiché, prima o poi, l’opposizione avrebbe finito col trasformarsi in solidarietà, poiché nel profondo di ciascuno di noi, per quanto nascosta essa sia, è insita la consapevolezza della nostra comune umanità. Chiaramente, non c’è nulla di passivo in questa forma di resistenza. “La mia concezione di nonviolenza”, affermava Gandhi, “è più attiva e più concretamente combattiva della rappresaglia, la cui vera essenza è l’accrescimento della malvagità”. Ed è questo il punto: la violenza non fa 24 che peggiorare le cose. Non risolve, serve solo a provocare una reazione violenta. Letteralmente, satyagraha non significa ‘nonviolenza’. È uno strumento, un metodo. La parola in sanscrito che traduciamo con l’espressione ‘nonviolenza’, estremamente importante anche nel buddismo, è ahimsa, che significa completa assenza di violenza nelle parole, nelle azioni e perfino nel pensiero. Dà l’idea di una negazione, così come nonviolenza sembrerebbe avere una connotazione passiva. Ma al pari della parola inglese flawless, ahimsa indica la perfezione. Ahimsa è amore incondizionato, satyagraha è amore in azione. Il messaggio di Gandhi La vera missione di Gandhi non era la liberazione dell’India. Quella fu certo una straordinaria conquista, ma l’India divenne una sorta di palcoscenico, uno spettacolo offerto al mondo di ciò che si poteva conseguire tramite la nonviolenza nel mondo imperfetto della vita reale. Non ho ancora nemmeno sfiorato la superficie di tali conseguimenti. La vita di Gandhi è piena di miracoli che bastano a dimostrare come la natura umana sia infinitamente più elevata di quanto crediamo. È ciò che ognuno di noi deve scoprire, e da questa scoperta dipende il nostro futuro. “Non c’è nulla di nuovo nell’ahimsa”, sosteneva Gandhi. “È un concetto vecchio come il mondo”. Nel corso della storia ogni legame di lunga durata, tutte le comunità e le società, fino alla civiltà stessa, si fondano sulla rinuncia alla violenza nell’interesse di un bene superiore. Ogni conflitto, grande o piccolo che sia, rappresenta ogni volta l’opportunità di fare un passo avanti nel processo di evoluzione o viceversa, di regredire. In questo senso, ritengo che la civiltà si trovi oggi a un crocevia. Un pugno di persone arrabbiate, forse anche una sola di esse, può causare distruzione dall’altra parte del globo. La violenza non suscita più stupore, persino nelle nostre case e nelle nostre scuole. Abbiamo edificato una cultura della violenza e, a meno di non cambiare rotta, questa violenza distruggerà buona parte dei progressi faticosamente conquistati in secoli di evoluzione dell’essere umano. Usando un linguaggio attuale, si può dire che Gandhi ci abbia fornito le basi per una tecnologia della pace. Ci ha offerto gli strumenti per risol25 S ono nato a Portbandar, altrimenti nota come Sudamapuri, il 2 ottobre 1869. Lì ho trascorso la mia infanzia. Mi ricordo di quando mi fecero frequentare la scuola. Faticai a padroneggiare le tabelle pitagoriche. Il fatto che di quei giorni mi ricordi solo di aver appreso, insieme ad altri ragazzi, a chiamare il nostro insegnante con una gran quantità di epiteti, indica quanto pigra fosse la mia intelligenza e poco affinata la mia capacità mnemonica. Portbandar. vere qualsiasi tipo di conflitto, strumenti che tutti possiamo imparare a usare. La cosa più urgente è comprendere il suo messaggio: la nonviolenza è un modo di pensare, uno stile di vita, non una tattica, ma un modo di adoperare l’amore per risolvere i problemi, per risanare i rapporti, e in generale per innalzare la qualità della nostra vita. Non c’è bisogno di una scena grandiosa come quella in cui lui ha recitato la sua parte per iniziare. D’altronde, nemmeno lui iniziò così. Per prima cosa si occupò delle proprie relazioni interpersonali, consapevole di non poter spegnere le fiamme della rabbia e dell’odio altrove, fino a che quelle stesse fiamme covavano nella sua casa e nel suo cuore. La sua nonviolenza non è un’arma politica o una tecnica per la trasformazione sociale, quanto un’arte necessaria – forse l’arte fondamentale – per l’evoluzione della civiltà. In altre parole, la nonviolenza è una capacità che si acquisisce, come la lettura. L’amore è una capacità. Il perdono è una capacità. La trasformazione della rabbia è una capacità. Sono tutte capacità che si possono imparare. Non possiamo affermare di non essere capaci di praticare la nonviolenza. Possiamo solo dire che non siamo disposti a fare quanto è necessario per apprenderla. Infine, a beneficio di tutti coloro che aspirano alla spiritualità, quale che sia la loro fede, Gandhi ha dimostrato che per condurre una vita spirituale non è necessario ritirarsi in convento o in una spelonca. La si può perseguire in famiglia, nella propria comunità, nella propria carriera, con spirito altruistico e di servizio. Finanche tralasciando la dimensione spirituale, se consideriamo che lo scopo principale della vita sia dare un contributo durevole alla famiglia e alla società, Gandhi ha saputo darci un’immagine più nobile di noi stessi, una glorificazione della bontà innata nell’essere umano, la cui gioia deriva dal vivere per il benessere di tutti. Questo è il messaggio fondamentale che Gandhi ci ha trasmesso. In questo senso, la sua frase più significativa – ed è bene ricordare che quest’uomo non pronunciava mai neanche una parola della cui verità non fosse certo, per la propria personale esperienza – è la seguente: “Non ho il minimo dubbio che ogni uomo e ogni donna possano conseguire i miei stessi risultati, se compiono i miei stessi sforzi e hanno altrettanta fede e speranza”. 28 LA TRASFORMAZIONE Gli anni giovanili in India, a Londra e in Sud Africa NON VI ERA NULLA DI ECCEZIONALE nel giovane Mohandas Karamchand Gandhi, tranne forse la sua estrema timidezza. Non possedeva alcun talento particolare ed era uno studente mediocre. Impacciato, serio, profondamente legato ai genitori, era quasi del tutto ignaro di quel che accadeva fuori della tranquilla cittadina di mare dove era nato. Il XIX secolo volgeva al termine e all’epoca l’Impero britannico, al culmine della sua ricchezza e potere, si estendeva per buona parte del mondo. Per l’India era il secondo secolo di dominazione britannica. La famiglia lo fece sposare a soli tredici anni, quando ancora frequentava il liceo. Come egli stesso ebbe a scrivere in seguito, quelle nozze erano avvenute a un’età “irragionevolmente precoce”. Ma Kasturbai era una bella ragazza e Gandhi si calò presto nel ruolo del marito innamorato, geloso ed esigente. I due giovani avevano ognuno il proprio carattere e una forte personalità, per cui il matrimonio ebbe i suoi risvolti tempestosi fin dal principio. Il giovane Gandhi si considerava il pigmalione di sua moglie. Più tardi si sarebbe reso conto che era stata lei invece a insegnargli la tolleranza attraverso il proprio esempio. La pazienza, la forza, la capacità di sopportare e perdonare di Kasturbai deve aver 29
Scarica