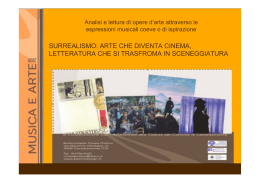C R I T I C A • C U L T U R A • C I N E M A Conoscerete la verità E la verità vi farà liberi Giovanni 8,32 Questa pubblicazione è stata curata dal Cinecircolo Romano Roma – Via Nomentana 333/c – tel 068547151 – fax 068553108 Sito internet: www.cinecircoloromano.it E-mail: [email protected] Assistente editoriale Alessandra Imbastaro Assistente amministrativo Giuliana De Angelis Collaborazione edizione “Dossier” Catello Masullo con Paola Dell’Uomo, Alessandro Jannetti, Maria Teresa Raffaele Coordinamento schede filmografiche Alessandro Jannetti con Giuseppe Rizzo e Vincenzo Carbotta Coordinamento realizzazione “Progetto Educazione al Cinema d’Autore” Luciana Burlin con Rosa Aronica, Fiorenza Irace ed Eugenia Porta Collaborazione operativa Lamberto Caiani, Francesco Fazioli, Maria Teresa Raffaele Direzione e coordinamento generale Pietro Murchio Le fotografie all’interno sono state gentilmente messa a disposizione da: Centro Studi Cinematografici / Archivio del Cinecircolo Romano / Mauro Crinella / Catello Masullo / Giuseppe Rizzo Valutazione: del Cinecircolo e della Commissione Nazionale per la valutazione dei film della C.E.I. Recensioni cinematografiche: da “Rassegna Stampa Cinematografica” Editore S.A.S. Bergamo, data base del Cinecircolo, siti Internet. Per la stagione 2010/2011 sono operanti due Comitati Consultivi Selezione Cinematografica Vincenzo Carbotta, Mauro Crinella, Paola Dell’Uomo, Francesco Fazioli, Alessandro Jannetti, Maurizio Lacorte, Catello Masullo, Giuseppe Rizzo Promozione e Cultura: Rosa Aronica, Luciana Burlin, Lamberto Caiani, Anna Maria Curini, Fiorenza Irace, Laura Palmas, Paola Pironti, Maria Teresa Raffaele IN COPERTINA: - foto CSC e sito internet del Festival Internazionale del Cinema di Roma - in senso orario: CHRIS KRAUS - Premio Speciale della giuria - Roma Film Fest 2010 per il film “Poll”, ABBIE CORNISH (Bright Star di J. Campion), VIRGINE EFIRA (Kill me please di H. Yomebayashi), CATHERINE DENEUVE tra JUDITH GODRÈCHE e KARIN VIARD (Potiche di F. Ozon), RUSSEL CROWE (Robin Hood di R. Scott), ZAZIE DE PARIS tra OLIAS BARCO e VIGILIE BRAMLY (Kill me please), MICAELA RAMAZZOTTI (La prima cosa bella di P. Virzì) CINECIRCOLO ROMANO STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2010/2011 DOSSIER ASSOCIAZIONE • • • Le emozioni del cinema: questo è un valore che continuiamo a sostenere... nonostante le difficoltà • • La Mostra d’Arte 2010 CineCortoRomano 2010 SCHEDE FILMOGRAFICHE con le biografie dei registi Rubrica Festivaliera del Cinecircolo Il Premio Cinema Giovane ✓ la VI Edizione ✓ la VII Edizione: dal 28 marzo al 2 aprile 2011 Appuntamenti di programma e calendario Il cast del film “Una vita tranquilla” di Claudio Cupellini 1 LE EMOZIONI DEL CINEMA: QUESTO È UN VALORE CHE CONTINUIAMO A SOSTENERE... nonostante le difficoltà del Presidente Pietro Murchio L’atmosfera di insicurezza, di provvisorietà dello scenario futuro ha pervaso anche molte delle espressioni culturali e di intrattenimento che caratterizzano questi nostri tempi. Sembra apparentemente che il contesto non sia mutato più di quanto la naturale evoluzione non comporti, ma analizzando meglio i fenomeni ci rendiamo conto che purtroppo non è così. La crisi economica e finanziaria a livello globale ha ridotto gli spazi di manovra alle politiche sociali e nel caso dell’Italia emerge, a seconda dello stile di governo, la diversa priorità che viene data alle espressioni della vita civile, e quindi nel nostro caso la cultura soffre di più. Non ci deve trarre in inganno il risultato del box office dei primi dieci mesi del 2010 che da una crescita degli spettatori e degli incassi delle sale, dovuta al richiamo dei film in 3D, infatti nei primi venti titoli in classifica solo 6 sono di film italiani (con “Benvenuti al Sud” in testa!) il che non sarebbe uno scandalo se non si riscontrassero nel top 20 ben dieci titoli di film stranieri, in cui domina l’aspetto spettacolare e tecnologico che spesso serve a coprire la scarsa qualità narrativa. la fine dei lavori della metro e l’apertura della relativa stazione Annibaliano e nella acquisizione di introiti dalla sottoscrizione, da parte dei soci, del 5%° dell’irpef. Per la stagione appena iniziata abbiamo rinnovato le convenzioni promozionali con Upter, Festival di Roma e Bibliocard, nonché le agevolazioni per i soci con alcuni teatri. Il successo crescente del Premio Cinema giovane ci ha indotto ha programmarne la VII^ edizione per marzo 2011, con la proiezione dei dieci migliori film del Cinema Giovane Italiano, dibattiti ed interviste agli artisti, contornati dall’usuale interessante Forum e dalla Mostra d’arte. Quella del 2010 ha avuto una eccezionale partecipazione (104 artisti) e pensiamo per il 2011 di poter migliorare la qualità media anche chiedendo alle Associazioni invitate di fare un pre-filtraggio delle opere amatoriali. Confidiamo infine nel supporto alla manifestazione da parte della Regione Lazio nonché nella sponsorizzazione di un noto istituto bancario. Il programma cinematografico stagionale, pubblicato a fine ottobre, rimane di consistenza invariata con una locandina ricca di commedie di qualità (più della metà), con film il più recenti possibile, compatibilmente con la distribuzione e con il vincolo della programmazione annuale anticipata, includendo film non ancora usciti in sala. Abbiamo altresì inserito alcuni titoli relativi a film di cassetta e di qualità come, Avatar e Innocenti bugie, per dare testimonianza dei mutamenti in atto nel modo di fare cinema. Infine pensiamo di presentare in sala, come evento speciale, un piccolo giro nel mondo dei documentari. “Le emozioni del cinema: questo è un valore che continuiamo a sostenere... nonostante le difficoltà”: è un motto che abbiamo parafrasato dai titoli di testa della clip del Festival di Roma e che vorremmo fosse vero non solo per noi ma anche per tutti i soci che continuano a sostenere la nostra Associazione. Per parlare delle faccende di “casa”, registriamo ancora una volta una diminuzione del tesseramento, le cui cause sono sia strutturali che contingenti, come ad esempio la mancanza di posti di parcheggio limitrofi all’Auditorio generata dagli eterni lavori della metro B1. Per far fronte alle ovvie conseguenze di natura economica abbiamo ottenuto dall’assemblea di dicembre 2010 l’approvazione ad adeguare le quote associative ed ad anticipare la campagna associativa. Ciò assieme all’introduzione di novità operative come: la distribuzione dei bollettini di c.c.p. premarcati tramite Bancoposta e l’adozione di una nuova tecnica per il controllo degli accessi in sala tramite lettore ottico delle tessere, ci ha consentito di ottenere significativi risparmi di costo per personale e spedizioni postali. La nostra speranza di recupero della tranquillità economica sta nel ritorno di adesioni nel 2011 con 2 PASSEGGIANDO TRA I FESTIVAL Rubrica Festivaliera del Cinecircolo a cura di Pietro Murchio Cannes mantiene il primato come kermesse e base industriale del cinema, Venezia quello storico di primogenitura e di vetrina del pensiero originale, Roma, pur nelle difficoltà e nella sua incompiuta identità, cresce nel percorso per diventare grande nel panorama mondiale. Tutte e tre hanno confermato, nelle scelte delle giurie, un certo distacco dal gusto del pubblico anche di quello più professionale. In particolare i maggiori premi delle tre mostre sono andati a film che avranno poco successo nelle sale: ma cosi è e forse così ha da essere! Al cinema italiano è andata male solo a Venezia, dove è rimasta a secco di premi significativi mentre negli altri due si è aggiudicata i trofei per il miglior attore con Elio Germano e Toni Servillo. presidente; • le Locations di entrambi i festival sono straordinarie: Venezia per il fascino lagunare e Roma per la impagabile struttura dell’auditorio ospitante, che non ha eguali in tutto il mondo per armonia ed adeguatezza allo scopo. In merito alle modifiche, ventilate dal Comune di Roma, per razionalizzare l’organizzazione degli eventi del mondo audiovisivo internazionale a Roma, riteniamo che spostare il Festival del Cinema dall’Auditorium sarebbe un suicidio. Mentre potrebbe essere condiviso l’obiettivo di perseguire delle economie di scala di tipo organizzativo - amministrativo con il “Fiction Festival” a patto che non vengano in nessun modo intaccate le autonomie delle rispettive direzioni artistiche. Ancora qualche notazione sul Festival di Roma di cui abbiamo apprezzato sia la qualità media dei film in concorso, sia la sobrietà nella ospitalità del mondo delle star: limitarne i costi non è poi cosi male. Segnaliamo inoltre una recentissima novità: il MARC’AURELIO Esordienti, cioé il premio al miglior film, presentato al festival da regista esordiente, assegnato dal Ministro della Gioventù: al proposito ci piacerebbe esaminare qualche forma di collaborazione con il nostro Premio Cinema Giovane! Infine riscontriamo nella nostra locandina stagionale la presenza di più di un terzo di film provenienti dai tre festival oggetto della rubrica. Nella “querelle” sulla incompatibilità tra Venezia e Roma a nostro avviso va chiarito quanto segue: • i periodi di svolgimento sono ora lontani di quasi due mesi e quindi i fenomeni di cannibalismo reciproco sono ridotti solo ai prodotti nazionali, come è capitato quest’anno a Roma soccombente; • il festival di Roma ha delle interessanti sezioni (Alice ed Extra) che lo distinguono dagli altri due in questione; • Roma dovrebbe forse accentuare la missione di “festival per il pubblico” anche per le sezione in concorso calibrando di più le scelte sia dei film che dei componenti della giuria, infatti Venezia ha pagato al proposito la scelta di Tarantino come Festival Internazionale del Cinema di Roma Festival di Cannes 3 Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia PASSEGGIANDO TRA I FESTIVALS 63° FESTIVAL DI CANNES di Paola Dell’Uomo Il Festival di Cannes gode di una lunga e solida vita e questo è stato confermato anche nella 63° edizione. Indiscussa la qualità dei film in concorso, ma anche piena la Croisette di personalità: da Tim Burton, presidente di giuria, a Woody Allen e Ken Loach, ma anche attori come Russell Crowe, Cate Blanchett, Michael Douglas, solo per citarne alcuni. Grandi i nomi anche delle defezioni dell’ultimo momento; come Ridley Scott, Sean Pen e Jean-Luc Godard. La Palma d’Oro per il miglior film è andata al tailandese «Uncle Boonmee, Who Can Recall His Past Lives» di Apichatpong Weerasethakul, mentre quella alla regia è rimasta in casa con Mathieu Amalric per “Tournée”. Sempre in casa è rimasto il Gran Prix della giuria per “Des hommes et des dieux” di Xavier Beauvois, mentre il premio speciale è andato a Mahamat-Saleh Haroun per “A screaming man”. Al di la dei vincitori è vinti, delle polemiche inevitabili seguite ai giudizi di una giuria di tutto rispetto, la riflessione su cui mi vorrei fermare è la nuova svolta che il cinema Italiano ha avuto in questa manifestazione. Primo fra tutti il premio come migliore attore dato ad Elio Germano, che, anche se ex.equo con l’ottimo Javier Barden, ha confermato il successo con cui è stato accolto il film Daniele Lucchetti “La Nostra Vita”. Il cinema Italiano torna a trovarsi sotto le luci della manifestazione più importante d’Europa e tra le più importanti del mondo. E sotto i riflettori sono finite anche le polemiche che hanno accompagnato la scelta di mostrare il film di Sabina Guzzanti, “Draquila” che, come le parole con cui Germano ha ringraziato per il premio e la manifestazione di tutti i lavoratori nel cinema che abbiamo visto sul tappeto rosso del Festival del cinema di Roma, porta alla ribalta il disagio che il cinema Italiano sta vivendo nel suo rapporto con le Istituzioni. Giusto o sbagliato sarà il pubblico a giudicare. Nonostante nubi vulcaniche e varie calamità naturali il Festival non è stato disertato. Cannes è una kermesse spettacolare. Totalmente diversa dalla sobria eleganza di Roma, con il suo lungo tappeto rosso che va a morire nella cavea dell’auditorium di Renzo Piano. Qui il tappeto rosso è un piccolo spazio, non accessibile praticamente al pubblico, dove salgono le scale le Stars come i miti di tutti i tempi. Totalmente diverse dalla fascinosa spiaggia del lido di Venezia, con la sua aria un po’ retrò di una dolce vita morente. Cannes è la caotica vita sulla Croisette, con divi che ti sfiorano, folle che si spostano in massa, stand impegnatissimi dove soprattutto si fanno affari. Perché Cannes è anche il più grande mercato del cinema d’Europa e se ne hai la possibilità qui si possono vedere proiezioni da tutto il mondo, in vetrina per essere acquistate dai distributori europei. A Cannes si muove un’industria immensa che si presenta sulla Croisette per mostrare film che magari, solo fortunosamente riusciremo a vedere molti mesi dopo nelle sale. Nel contempo abbiamo selezionato per la locandina stagionale tre film che hanno ben figurato al Festival, due dei quali non ancora usciti in sala. Cannes riempie il piccolo spazio del salone del cinema di un folla stipata nelle numerosissime sale. E la sera è un via vai di signore in abiti da sera e uomini in Smoking che si fermano nei piccoli ristoranti, seduti vicino a ragazzi in jeans che parlano delle proiezioni della giornata. Il Festival di Cannes è tutto questo; il Festival di Cannes è il cinema. Eva Longoria e Aishwarya Rai sul red carpet Il cast del film di Ridley Scott “Robin Hood” 4 PASSEGGIANDO TRA I FESTIVALS 67° FESTIVAL DI VENEZIA - Il Leone più Tarantiniano di Catello Masullo La crisi mondiale non ha risparmiato il settore dell’industria cinematografica. Si investe meno. Meno produzioni, meno idee, meno film di qualità. La 67-esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia non poteva non accorgersene. Una sala di proiezioni in meno. Una qualità generale un po’ inferiore alle passate edizioni. Ma quella del 2010 passerà alla storia come la più “tarantiniana”. Quentin Tarantino (nella foto) è stato infatti il travolgente presidente della Giuria. Che appare essersi imposto nei verdetti con la sua forte personalità. Che hanno lasciato molto discutere. Come sempre, ma forse un po’ più di sempre. Pensare male si fa peccato, ma non sempre ci si sbaglia. La Mostra è stata vinta dalla ex di Tarantino, il secondo premio al film più tarantiniano del concorso, premio speciale al mentore e maestro di Tarantino, Monte Hellman. Il Leone d’Oro per il miglior film è stato infatti attribuito a “Somewhere” di Sofia Coppola (Usa). Un film un po’ al di sotto delle sue precedenti performances. Un buon film, ma non il suo migliore, né il migliore della Mostra. Il Leone d’Argento per la migliore regia ad Álex de la Iglesia per il film “Balada triste de trompeta” (Spagna, Francia), durante la proiezione del quale Tarantino ha fatto i numeri: applaudiva a scena aperta, si alzava, inneggiava fragorosamente. Ed al quale ha pure tributato il premio per la migliore sceneggiatura. Hanno fatto discutere anche gli ambiti premi per i migliori attori: Vincent Gallo nel film “Essential Killing” di Jerzy Skolimowski , e Ariane Labed nel film “Attenberg” di Athina Rachel Tsangari (Grecia). Le valutazioni, si sa, sono totalmente personali. Io avrei dato il leone d’oro a “La Versione di Barney”. Uno strepitoso film di Richard J. Lewis con Dustin Hoffman, Rachelle Lefevre, Paul Giamatti. E proprio a Paul Giamatti avrei dato il premio per miglior attore. Mentre la migliore attrice per me è stata, di gran lunga, Alba Rohrwacher, per “La Solitudine dei Numeri Primi” di Saverio Costanzo. Ove recitasse in un film americano, sarebbe senza dubbio da Oscar. Una grandissima prova attoriale. Di assoluta dedizione alla missione assegnata. Un incredibile lavoro sul corpo. Ha perso 10 kg, che sono tantissimi partendo da una magrezza ossuta come la sua. Non sono mancati film di qualità. Come “Il Fosso”, del cinese Wang Bing , presentato come film a sorpresa del programma. Un film durissimo, rigoroso, di grande potenza espressiva, sulle terribili e disumane “rieducazioni” maoiste inferte agli intellettuali. “Columbia Cirkus”, del premio Oscar Danis Tanovic, acutissimo affresco, tra l’ironico ed il crepuscolare, dell’era dell’oro della ex Jugoslavia, alla vigilia dello scoppio delle assurde atrocità. Il poetico “Silent Souls” di Aleksei Fedorchenko, Osella per la miglior fotografia. Agguerritissima la presenza del cinema italiano. Con Rai Cinema a fare la parte del “leone” (è il caso di dirlo…), con ben 18 opere presentate. Oltre al già citato “La Solitudine dei Numeri Primi” di Saverio Costanzo, che si conferma un autore maturo, con piena padronanza del mezzo espressivo e che ha saputo cogliere l’essenza del libro scritto da Paolo Giordano, molte le opere a distinguersi. La scorrevolissima commedia di Carlo Mazzacurati “La passione”. La gustosa commedia “Into Paradiso”, abbastanza riuscita opera prima di Paola Randi. Il convincente “L’Amore Buio” di Antonio Capuano. Il corposo e coinvolgente “Noi Credevamo” di Mario Martone. L’elegante “Notizie degli Scavi” di Emidio Greco. Il vincitore della rassegna Controcampo Italiano è “20 sigarette” di Aureliano Amadei, film non riuscitissimo, ma un efficace grido alto e forte contro ogni forma di guerra. Bellissimi e fulminanti alcuni corti : “Come un Soffio” di Michela Cescon , “Niente Orchidee” di Simone e Leonardo Godano, “Achille” di Giorgia Farina, “Sposerò Nichi Vendola” di Andrea Costantino. Una menzione del tutto speciale va infine fatta sul genere documentario. Che ha visto nel programma veneziano opere di grande fattura. Come “Dante Ferretti: Production Designer” di Gianfranco Giagni, “Se hai una montagna di neve lasciala all’ombra” di Elisabetta Sgarbi, “Niente paura” e le canzoni di Luciano Ligabue, di Piergiorgio Gay. Anche quest’anno il programma del Cinecircolo non si fa mancare una selezione accurata di film del festival di Venezia. Vedremo: “La Passione” di Carlo Mazzacurati con Silvio Orlando, la divertente commedia francese “Potiche-la bella statuina”, di François Ozon, con la deliziosa Catherine Deneuve (nella foto). 5 PASSEGGIANDO TRA I FESTIVALS V° FESTIVAL DI ROMA: la Lupa si mangia il Leone di Catello Masullo e cappelli d’epoca, per ammissione dello stesso regista ad una mia domanda specifica. Di grande impatto emotivo il ritorno in patria di Susanne Bier, dopo la felice parentesi americana, con “In a better world”, che, per la prima volta, mette d’accordo pubblico e critica, aggiudicandosi sia il premio assegnato dagli spettatori che il gran premio della giuria. Molto forte e toccante il film irakeno “I fiori di Kirkuk” di Fariborz Kamkari, con la creativa collaborazione della italiana orchestra di Piazza Vittorio per le musiche. Interessante “Kill Me Please” di Olias Barco, una sorta di “Helzapoppin” macabro e grottesco, di un umorismo noir ed irresistibile, che si è aggiudicato il Marco Aurelio d’Oro, il massimo premio del Festival. La presenza del cinema italiano non è stata invece forte come a Venezia, la cui Mostra è più brava a fare incetta in questo specifico mercato. Non sono però mancate le opere degne di nota. Come il film sorprendente di Claudio Cupellini, “Una vita tranquilla”. Un film di genere, un noir classico, che non ti aspetti dall’autore del delizioso e leggero “Lezioni di cioccolato”. Con una incredibile verosimiglianza ed un meccanismo molto intrigante di alternanza delle tre lingue: napoletano, italiano e tedesco, che vengono usate come tane in cui nascondersi dal protagonista, un monumentale Toni Servillo, che con questa interpretazione vince finalmente il premio per miglior attore ad un festival internazionale. Interessanti le sezioni collaterali come quelle tenute presso la Casa del Cinema, ove segnaliamo il medio metraggio “L’elefante occupa spazio” di Francesco Bernabei. Anche quest’anno i “movie hunters” del Cinecircolo hanno approfittato a piene mani del Festival di Roma, che offre maggiori possibilità di pescare film più adatti alla nostra programmazione. Infatti la locandina prevede ben cinque titoli, di cui tre dalla passata edizione, che sono usciti nelle sale solo questo anno, molto di recente: “Hachiko” di Lasse Hallstrom, “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti, e “The Last Station”, di Michael Hoffman. I due film selezionati dal programma di questo anno del Festival di Roma sono: “We want Sex” e “Una vita tranquilla”, già qui commentati. Il Festival Internazionale del Film di Roma è arrivato alla sua quinta edizione. Ad onta di chi ne preconizzava una precoce dipartita, pensando ad una rapida liquidazione, una volta esaurita la esperienza veltroniana, che l’aveva tenuta a battesimo, è più in salute che mai. Risente meno della crisi internazionale rispetto alla mostra di Venezia, confermando, a sua differenza, tutte le sale disponibili. Conferma la sua vocazione di maggiore attenzione alle preferenze del grande pubblico. Privilegiando, pur sempre nella attenta ricerca della qualità, le produzioni spettacolari e tradizionali, rispetto a quelle di ricerca sperimentale. Continua a mantenere i suoi cavalli di battaglia, che ne fanno un festival unico: la splendida sezione Alice nelle città, dei film per l’infanzia e per l’adolescenza, e gli incontri dei protagonisti del grande cinema con il pubblico. Pur con il rammarico del ridimensionamento parziale della sezione Extra, quella curata da Mario Sesti, che spesso ha fornito le opere più interessanti ed intriganti, la qualità media dei film proposti si mantiene elevata. Nella ideale competizione a distanza con la ben più blasonata kermesse veneziana, Roma, ancora una volta la spunta. Prevale, di poco, ma prevale. La Lupa Capitolina si mangia il Leone di San Marco. Le punte di diamante dalla scuola di cinema inglese, che, negli ultimi anni, sta producendo le cose più belle nel settore. La strepitosa commedia “We want sex”, di Nigel Cole, che fa ridere e fa pensare e fa entusiasmare, sulla vera storia di 187 operaie della Ford inglese che, negli anni ’60, misero in scacco la multinazionale dell’auto, chiedendo parità di trattamento retributivo rispetto ai maschi: una vera rivoluzione per l’epoca. Lo struggente, bellissimo “Oranges and sunshine” di Jim Loach, figlio del mitico Ken, che alla sua opera prima fa subito centro, con la storia di 130.000 bambini di famiglie disagiate che furono brutalmente deportati dalla Gran Bretagna all’Australia nel dopo guerra. L’ironico, sulfureo, impagabile “Burke & Hare” del grande John Landis, che, per fare i film che vuole fare, deve lasciare Hollywood e rivolgersi alla industria europea, supportata dagli artigiani italiani, i migliori del mondo per calzature Julianne Moore, Marc’Aurelio alla carriera 6 PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME Il Cinecircolo Romano ha programmato, a partire dalla stagione 2004/2005, di organizzare una manifestazione celebrante il cinema giovane italiano, istituendo un Premio nell’ambito di un festival. Il Premio Cinema Giovane è dedicato agli autori di opere prime ed ai giovani interpreti (attori ed attrici) del cinema italiano della più recente stagione, ed è caratterizzato dal giudizio espresso dal pubblico cinefilo. Lo scopo quindi è quello di dare annualmente un riconoscimento a personaggi emergenti del panorama del giovane cinema italiano, dando visibilità al giudizio del pubblico ospite e dei Soci dell’Associazione. ESITI DELLA VI EDIZIONE: MARZO 2010 a cura di Alessandro Jannetti È stata presentata una selezione di film italiani opere prime, ovvero pellicole interpretate da giovani attori italiani, prendendo in esame tutti quelli distribuiti nel corso del 2009 (ben 30 opere) e nominando i tre film in concorso. Durante la rassegna sono stati proiettati anche altre 7 pellicole del cinema giovane italiano, di cui 4 opere prime selezionate. Complessivamente alle 19 proiezioni si sono riscontrate complessivamente circa 9.000 presenze a inviti gratuiti. Anche questa edizione ha mantenuto la tradizione dei numerosi incontri del pubblico con gli autori, attori e produttori dei film in concorso e selezionati. Una consuetudine che è uno dei fiori all’occhiello della manifestazione. Ed un importante motivo di interesse e di attrazione, che garantisce un consistente numero di presenze alla kermesse. Le interviste/dibattito sono state condotte ancora una volta dal critico cinematografico del Cinecircolo Romano, Catello Masullo. Sono stati proiettati all’Auditorio San Leone Magno, nella VI edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, i tre film opere prime in concorso - Cosmonauta di Susanna Nicchiarelli, La doppia ora di Giuseppe Capotondi, Dieci inverni di Valerio Mieli - e sette film selezionati: Piede di dio di Luigi Sardiello, Mar Nero di Federico Bondi, La siciliana ribelle di Marco Amenta, Diverso da chi? di Umberto Carteni, nonché, per la presenza degli interpreti candidati, Ex di Fausto Brizzi, Fortapàsc di Marco Risi, Il grande sogno di Michele Placido. La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 26 marzo 2010 e per il secondo anno consecutivo, è stata condotta dal giornalista e critico cinematografico Maurizio Di Rienzo. Hanno consegnato i Premi: l’Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport Giulia Rodano e la responsabile dell’area Cinema, Audiovisivi e Programmi Europei Cristina Crisari della Regione Lazio, il Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Bruno Torri, il regista Marco Risi ed il Presidente del Cinecircolo Pietro Murchio. Sono state consegnate, davanti ad un grande pubblico, targhe d’argento a tutti i candidati ed a Fabio Troiano per l’interpretazione nel film blockbuster Cado dalle nubi, come corollario dell’assegnazione dei seguenti “Premi Cinema Giovane”: – il Premio Opera Prima al film La doppia ora, al produttore Francesca Cima, per Giuseppe Capotondi; – il Premio Miglior Attore a Libero De Rienzo per Fortapàsc di Marco Risi; – il Premio Miglior Attrice a Jasmine Trinca, per Il grande sogno di Michele Placido; – il Premio Migliore Attrice Esordiente a Miriana Raschillà per il film Cosmonauta. Durante la manifestazione si è svolto un interessante Forum sul tema “Il cinema giovane italiano: come aiutarlo?”, al quale hanno partecipato: Pietro Murchio-moderatore, Carlo Brancaleoni, Daniele Cini, Bruno Torri, Enzo Ciarravano, Ugo Baistrocchi, Luigi Sardiello, Franco Rina, Enzo Natta e Catello Masullo. A corollario dell’evento, nel foyer dell’Auditorio del San Leone Magno, si è svolta una mostra-concorso di arti figurative competitiva e non commerciale, alla quale hanno partecipato più di 100 artisti con oltre 200 opere. Marco Risi e Valerio Mieli Miriana Raschillà 7 Jasmine Trinca e Libero De Rienzo PREMIO CINEMA GIOVANE VII EDIZIONE: MARZO-APRILE 2011 a cura di Pietro Murchio La manifestazione è pur sempre caratterizzata dal giudizio espresso dal pubblico di soci ed ospiti, con il coinvolgimento di numerosi giovani, dei “cineasti” protagonisti nonché delle risorse culturali del territorio. La manifestazione si svolgerà dal 28 marzo al 2 aprile 2011 presso l’ Auditorio San Leone Magno di Via Bolzano 38 la cui sala ospiterà le proiezioni cinematografiche, il Forum su “Il Cinema Giovane Italiano: quale futuro?” e la Premiazione; contemporaneamente nell’elegante foyer si svolgerà una mostra concorso di opere di arte figurativa, competitiva non commerciale. Una Commissione di esperti, appositamente nominata composta da membri altamente qualificati del mondo della cultura e stampa cinematografica, sta effettuando una selezione di film italiani opere prime, di genere fiction, distribuiti nel corso del 2010: ad oggi ben 25 opere sono state censite. La rassegna finale del Festival si terrà presso l’Auditorio San Leone Magno in occasione della annuale settimana culturale. I tre film nominati verranno proiettati tre volte, in tre orari diversi (16.00, 18.30, 21,15) nei giorni 28, 29 e 30 marzo, raccogliendo su apposita scheda i giudizi del pubblico spettatore, inoltre negli stessi giorni in orario mattutino si terranno le proiezioni per i giovani studenti delle medie superiori del Comune di Roma. Durante la settimana culturale verranno proiettati anche altri 7 film selezionati dal Cinema Giovane Italiano, di cui 3 selezionati per la presenza di interpreti candidati (ad es.: Io loro e Lara, I figli delle stelle…). Complessivamente, nella settimana, sono previste 19 (di cui 3 mattutine per giovani studenti ) proiezioni ad inviti gratuiti per i soci e per il pubblico ospite, come avvenuto nelle sei precedenti edizioni. Interviste agli artisti e con il pubblico sono previste per ciascun film della rassegna. La sera del primo aprile 2011 verrà effettuata la premiazione. I “ Premi Cinema Giovane”, assegnati all’autore della migliore opera prima ed ai migliori giovani interpreti, consisteranno in un oggetto di fattura originale appositamente inciso e personalizzato. Agli autori degli altri due film in concorso verrà consegnata una speciale targa in argento. Agli autori di tutti gli altri film selezionati per la rassegna verrà consegnata, al momento del loro intervista in sala, una targa personalizzata di partecipazione. Inoltre i film selezionati ed in concorso verranno invitati, come special guests, a presentare la loro opera durante lo svolgimento del Festival itinerante CinemaDamare che si terrà nelle regioni del centro sud da luglio a metà agosto 2011. Per l’occasione la prestigiosa rivista del Cinecircolo “ Qui Cinema” dedicherà un numero speciale alla manifestazione. Il Cinecircolo provvederà a divulgare la rassegna oltre che con locandine, depliants di programma ed inviti personalizzati, con comunicati alla stampa quotidiana, periodica, e ai media radio-televisivi, nonché alle Istituzioni Pubbliche e agli Enti Patrocinanti. La manifestazione usufruisce, tra gli altri prestigiosi, del Patrocinio con collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e sarà preannunciata da una apposita Conferenza Stampa che sarà tenuta 6 o 7 giorni prima dell’inizio, presso la Casa del Cinema. Questa edizione del Festival si prevede che beneficerà anche della sponsorizzazione della Banca Mediolanum. Le notizie della manifestazione verranno divulgate tramite Radio Cinema (ente collaborante) anche in appositi spazi radiofonici su rete nazionale, nonché sulla stampa quotidiana e periodica. Interviste al direttore artistico verranno trasmesse anche da reti radio nazionali e reti TV regionali. Infine, le notizie sul programma della manifestazione saranno altresì pubblicate nel sito internet del Cinecircolo (www.cinecircoloromano.it), nonché in altri siti convenzionati come: www.upter.it; www.radiocinema.it, www.Cinemonitor.it, e sul sito del Festival del Cinema di Roma,etc. Fabio Troiano, Libero De Rienzo e Cristina Crisari Miriana Raschillà, Jasmine Trinca e Giulia Rodano 8 Ludovica Rampoldi e Francesca Cima CINECORTOROMANO 2010 - VI EDIZIONE a cura di Maria Teresa Raffaele Il Concorso per Corti cinematografici, promosso dal Cinecircolo Romano nell’ambito delle iniziative collaterali alla programmazione ufficiale, è giunto quest’anno alla sua sesta edizione ed ha offerto ancora una volta agli operatori appassionati di questo genere la possibilità di portare in visione le loro opere ad una grande platea come quella dei nostri soci. Il corto è un genere cinematografico che si sta sempre più affermando tra gli appassionati di Cinema, non solo perché necessita ovviamente di un budget minore, ma anche perché sostanzialmente in sintonia con la velocità espressiva della contemporaneità. Generalmente un corto nasce da un’idea forte, deve avvalersi di una struttura narrativa compatta e veloce, tutto deve essere insostituibile ed efficace al completamento di un’azione che generalmente sfocia in un colpo di scena finale. Anche i corti premiati nell’edizione di quest’anno hanno rispettato queste regole presentando situazioni coinvolgenti ed originali, la loro visione ha sicuramente arricchito la proposta culturale del Cinecircolo Romano: OPERA VINCITRICE: “IN AMORE” di ANDREA MENGHINI Attraverso uno sguardo ironico ma mai cinico, un montaggio veloce e ritmato, è raccontata la storia di un uomo e di una donna e del loro amore tormentato, con un finale a … sorpresa. OPERA SEGNALATA: “SU DUE PIEDI” di MARIA CHIARA PIAZZA OPERA SEGNALATA: “SOSPIRI E SOSPETTI” di FABIO CLEMENTELLI Nella serata della premiazione, fuori concorso, è stato presentato anche il corto “Questi avvocati” realizzato dagli allievi del Corso Upter di Cinematografia dal titolo“Dall’idea allo schermo: come si gira un film” diretto dal nostro socio Lamberto Caiani che ha tenuto le lezioni del corso presso la nostra sede. MOSTRA CONCORSO DI ARTI FIGURATIVE 2010 a cura di Maria Teresa Raffaele Uno degli appuntamenti più seguiti nell’ambito della settimana culturale del Cinecircolo è la MOSTRA CONCORSO DI ARTI FIGURATIVE che anche quest’anno ha visto grande affluenza di pubblico e di partecipanti non solo tra i soci, ma anche tra artisti ospiti provenienti dall’Associazione Pittori di via Margutta e INARTE e da allievi e docenti dell’UPTER, Università Popolare di Roma. Tra professionisti ed amatori, il numero degli artisti partecipanti è stato di ben 104 e questo ha creato uno stimolante clima di competitività ed ha testimoniato, ancora una volta, come il nostro pubblico sia interessato non solo al Cinema ma anche ai vari linguaggi dell’arte ed alle molteplici sinergie che possono intercorrere tra le arti visive ed anche con la poesia. Il Premio Acquisto di quest’anno, infatti, era riservato ad un’opera ispirata ad una frase del poeta greco Nikos Kazantzakis: “Avete il pennello, avete i colori, dipingete voi il paradiso e poi entrateci” invito che non ha mancato di sollecitare la sensibilità e la creatività di molti artisti con opere valide e suggestive. Qui sotto sono riportati la formazione della Giuria e l’elenco dei vincitori per ogni sezione di concorso. Giuria: Ugo Bevilacqua - docente arti figurative Carlo Fabbrini - antiquario Claudio Guidi - architetto Elio Morbiducci - architetto Ferruccio Fantone - giornalista PITTURA sezione professionale Primo premio Riflessi di Largo Torre Argentina di Germana Ponti - nella foto Secondo premio: Fiori e farfalle di Mario Santini Terzo premio: A Perth tra luna e stelle di Anna D’Arienzo PITTURA sezione amatoriale Primo premio: Campo de’ Fiori di Lorenzo Longhi Secondo premio: Pensieri di Angela Laudato Terzo premio: Tetti d’Abruzzo di Tilli Scarpis CERAMICA Primo premio: Vaso con calle di Maria Claudia Telese Secondo premio: Amami di Antonello Massariello SCULTURA Primo premio: Andata e ritorno di Irene Coscarella Secondo premio: E fu la vita di Gennaro Curzio PREMIO ACQUISTO: Il mio Paradiso di Gianluigi Poli (nella foto con la sua opera) 9 SCHEDE FILMOGRAFICHE 1 HACHIKO - Il tuo migliore amico di Lasse Hallström 28-29 ottobre 2010 Lasse Hallström, Lars Sven Hallström - Stoccolma, 2 giugno 1946 - dopo aver lavorato nella televisione svedese, conquista la popolarità e l’attenzione della produzione americana con il film “La mia vita a quattro zampe”, del 1985. Tratto dal romanzo autobiografico di Reider Jonsson, il film, drammatico e surreale, fa ottenere a Lasse Hallström la nomination all’Oscar per la migliore regia e sceneggiatura non originale. Vincitore di numerosi premi della critica cinematografica di New York, dirige nel 1991 “Ancora una volta” e nel 1993 il film di successo “Buon compleanno Mr. Grape”, con Johnny Depp, Juliet Lewis e Leonardo Di Caprio. Due anni dopo realizza “Qualcosa di cui sparlare”, con Julia Roberts e Dennis Quaid, e firma alcuni programmi di successo per la televisione svedese. Nel 1997 dirige i videoclip musicali degli ABBA e cura la regia di alcuni film svedesi, come “A Lover and his Lass”. Con “Le regole della casa del sidro” è stato candidato all’Oscar 2000 per la miglior regia. Interpreti: Richard Gere (Prof. Parker Wilson), Joan Allen (Cate Wilson), Jason Alexander (Carl), Sarah Roemer (Andy), Cary-Hiroyuki (Tagawa Ken), Erick Avari (Jasjeet), Davenia McFadden (Mary Anne), Kevin DeCoste (Ronnie), Robbie Sublett (Michael), Denece Ryland (Sig.na Latham), Tora Hallstrom (Heather), Donna Sorbello (Myra), Rob Degnan (Teddy Barnes), Frank S. Aronson (Milton) Genere: Drammatico Origine: Stati Uniti d’America Anno: 2009 Soggetto: Kaneto Shindo Sceneggiatura: Stephen P. Lindsey Fotografia: Ron Fortunato Musica: Jan A.P. Kaczmarek Montaggio: Kristina Boden Durata: 93’ Produzione: Richard Gere, Bill Johnson, Vicki Shigekuni Wong e Dean Schnider per Grand Army Entertainment, Inferno Distribution, Shochiku Kinema Kenkyû-Jo Distribuzione: Lucky Red SOGGETTO: In una cittadina americana, il professor Parker, tornando una sera a casa dalla scuola dove insegna musica, trova un cucciolo abbandonato. Lo prende con se e, vincendo le resistenze della moglie Cate, lo tiene e lo cresce. Il rapporto tra il cane di razza Akita e l’uomo diventa sempre più stretto. Quando Parker muore per un improvviso ictus, il cane torna regolarmente ogni giorno alle cinque alla stazione ferroviaria ad aspettarlo, come aveva cominciato a fare in precedenza. Così avviene per i successivi dieci anni…. VALUTAZIONE: I titoli di coda ricordano che all’origine c’è una storia vera, accaduta in Giappone tra gli anni Venti e Trenta del ‘900. Il cane è diventato un eroe popolare. Trasferita in America, la vicenda é diventata una favola, tuttavia ben inquadrata in contesti realistici. Un storia di fedeltà, che vede da una parte i due maturi sposi, dall’altra l’affetto tra l’uomo e l’animale. Quest’ultimo, grazie all’uso sapiente delle inquadrature, suscita simpatia e in molti momenti forte commozione. Perciò il racconto resta interessante e coinvolgente, non indulgendo a facili scorciatoie emotive, legato ad un modo di esprimersi sobrio, dove il tema dominante appare quello della fedeltà come valore principale cui ispirare la propria vita e il rapporto con gli altri. La fotografia conferisce bel risalto allo scorrere delle stagioni, e la natura, con il suo cangiante cromatismo, diventa una sorta di coprotagonista attento e silenzioso. 10 SCHEDE FILMOGRAFICHE 2 LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì 4-5 novembre 2010 (marzo 1964) Abbandonati gli studi di Lettere e Filosofia all’Università di Pisa, Paolo Virzì frequenta a Roma il corso di sceneggiatura di Furio Scarpelli presso il Centro Sperimentale di Cinematografia . Terminati gli studi collabora a numerosi script lavorando con Gabriele Salvatores, Giuliano Montaldo, Farina e Giannarelli. Il primo esordio dietro la macchina da presa è del 1994 con “La bella vita”, film premiato con il Ciak d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia, il Nastro d’Argento ed il David di Donatello come miglior regista emergente. Anche la successiva pellicola “Ferie d’Agosto” procura a Virzì un secondo David, questa volta come miglior film in concorso. “Ovosodo” (1997), scritto con la collaborazione di Francesco Bruni e del suo maestro Scarpelli, vince il Gran premio speciale della giuria al Festival di Cannes e il Ciak d’Oro per la migliore sceneggiatura. Al quarto lavoro del regista toscano (“Baci e abbracci” del 1999) seguirà due anni dopo l’applauditissimo “My name is Tanino”. Nel 2002 viene assegnato a Virzì il Premio Vittorio de Sica per il cinema italiano. Nel 2003 esce nelle sale il suo sesto cortometraggio “Caterina va in città”, con Sergio Castellitto. Produce nel 2005 il film “4-4-2 il gioco più bello del mondo”, firmandone anche la sceneggiatura. In seguito “N - Io e Napoleone” viene tributato con un’anteprima al secondo giorno del RomaFilmFestival 2006 .Segue “Tutta la vita davanti” (2008 )che ha ricevuto il premio Ciak d’oro quale miglior film dell’anno. E per il quale lo stesso Virzì è stato votato come il miglior regista. Il suo ultimo film “ La prima cosa bella “ è stato scelto dalla commissione dell’ANICA come candidato italiano all’Oscar 2011 per il miglior film straniero. Interpreti: Valerio Mastandrea (Bruno Michelucci nel 2009), Micaela Ramazzotti (Anna Nigiotti in Michelucci 1970-1980), Stefania Sandrelli (Anna Nigiotti in Michelucci nel 2009), Claudia Pandolfi (Valeria Michelucci nel 2009), Marco Messeri (il Nesi), Aurora Frasca (Valeria Michelucci nel 1970), Giacomo Bibbiani (Bruno Michelucci nel 1970), Giulia Burgalassi (Valeria Michelucci nel 1980), Francesco Rapalino (Bruno Michelucci nel 1980), Isabella Cecchi (Zia Leda Nigiotti), Sergio Albelli (Mario Michelucci), Fabrizia Sacchi (Sandra), Dario Ballantini (Avvocato Cenerini dal 1970 al 1980) Genere: Commedia Origine: Italia Soggetto: Francesco Bruni, Francesco Piccolo, Paolo Virzì Sceneggiatura: Francesco Bruni, Francesco Piccolo, Paolo Virzì Fotografia: Nicola Pecorini Musica: Carlo Virzì Montaggio: Simone Manetti Durata: 116’ Produzione: Fabrizio Donvito, Marco Cohen, Benedetto Habib, Paolo Virzì, Carlo Virzì per Indiana Production Company/Medusa Film/Motorino Amaranto Distribuzione: Medusa SOGGETTO: Nell’estate del 1971 Anna Nigiotti viene eletta Miss Pancaldi, lo stabilimento balneare più popolare di Livorno. Questo evento scongolge la sua vita e quella delle sua famiglia. Attratta dal cinema, Anna litiga con il marito Mario, e va via di casa con i due figli piccoli Valeria e Bruno. Per i tre comincia una peregrinazione in vari appartamenti, tra tentativi di riappacificazione e nuovi scontri. Tanti anni dopo, Anna é malata gravemente, e in ospedale arrivano Valeria e Bruno, tornato controvoglia da Milano dove abita e insegna. I ricordi del passato si mescolano con il presente e, quando la mamma sta per spegnersi con l’arrivo di un terzo figlio finora sconosciuto, e con il matrimonio contratto con il Nesi, un amico fedele degli ultimi anni. VALUTAZIONE: Il regista racconta di persone e situazioni che ben conosce senza farne oggetto di semplice nostalgia. La memoria, ricostruita in forme sovrapposte e per successive aggregazioni, diventa filtro per rivedere modi di fare e di rapportarsi, per fare il conto delle ferite dell’infanzia, e delle delusioni della maturità, per capire il valore degli affetti e dei punti di riferimento familiari. Nel lasciarsi come nel ritrovarsi c’è un fremito, un timore, un momento di esitazione sulla cosa da fare: il dubbio sulle decisioni, la timidezza nel manifestare i sentimenti. Così il racconto lascia sul terreno narrativo tante cose belle: allo spettatore il compito di decidere quale sia la prima. 11 SCHEDE FILMOGRAFICHE 3 GLI ABBRACCI SPEZZATI di Pedro Almodovar 11-12 novembre 2010 Pedro Almodóvar Caballero (Castiglia La Mancia, Spagna – settembre 1951) A sedici anni interrompe gli studi, inizia a lavorare presso una compagnia telefonica per mantenersi (ci passerà ben dodici anni della sua vita), ma nel frattempo inizia a dedicarsi alle riprese di documentari, filmati amatoriali e cortometraggi .Il suo primo cortometraggio risale al 1974, cui ne seguiranno una decina prima del suo esordio nel lungometraggio, che arriva nel 1980. È l’inizio della sua folgorante carriera. Proprio in quegli anni gira i primi film realmente distribuiti in grande stile: “Pepi, Luci Bom e le altre ragazze del mucchio” e “Labirinto di passioni”. Seguono i film “L’indiscreto fascino del peccato”, “Che ho fatto io per meritare questo?!”, “Matador” e “La legge del desiderio”. Con “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” giunge la consacrazione a livello internazionale, coronata con una nomination all’Oscar . I film seguenti sono successi in tutto il mondo: “Lègami!”, “Tacchi a spillo”, “Kika”, “Il fiore del mio segreto” e “Carne Tremula”. Nel 2000, dopo la Palma D’Oro nel 1999 a Cannes come miglior regista per “Tutto su mia madre”, riceve l’Oscar per lo stesso film, a coronamento di un successo planetario sia di critica che di pubblico. I più recenti “Parla con lei”, “La mala educación”, “Volver”, “Gli abbracci spezzati”, completano la sua filmografia. Interpreti: Penélope Cruz (Lena), Lluís Homar (Mateo Blanco/Harry Caine), Blanca Portillo (Judit García), José Luis Gómez (Ernesto Martel), Rubén Ochandiano (Ray X), Tamar Novas (Diego), Ángela Molina (Madre di Lena), Chus Lampreave (Portiera), Kiti Manver (Madame Mylene), Lola Dueñas (Lettrice di labbra), Mariola Fuentes (Edurne), Carmen Machi (Chon), Kira Miró (Modella) Genere: Drammatico Origine: Spagna Soggetto: Pedro Almodóvar Sceneggiatura: Pedro Almodóvar Fotografia: Rodrigo Prieto Musica: Alberto Iglesias Montaggio: José Salcedo Durata: 129’ Produzione: El Deseo S.A., Universal International Pictures Distribuzione: Warner Bros. Italia SOGGETTO: Divenuto cieco in seguito ad un incidente d’auto di quattordici anni prima, lo sceneggiatore Harry Cain decide di raccontare a Diego, figlio della sua direttrice di produzione Judit, la storia della sua vera identità. Lui in realtà si chiama Mateo Blanco, e tutto è cominciato quando ha conosciuto Lena, che volle fare lavorare nei suoi film, a dispetto del produttore e amante di lei, Ernesto Martel. VALUTAZIONE: I temi ci sono: la casualità; il paradosso dell’essere ‘ciechi’ per chi si serve dello ‘sguardo’; il cinema come luogo dello sdoppiamento dell’identità personale; la passione e la gelosia. Anche stavolta la sensazione di un amore folle per la vita, per le persone, per il ‘fare cinema’ attraversa il racconto e lo segna con toni marcati. Ma l’ispirazione appare un po’ appannata, c’è meno vigore da parte di Almodovar nell’aggredire le immagini e i sentimenti. Oscillando tra momenti di pausa, qualche ripetizione e spunti di riflessione. 12 SCHEDE FILMOGRAFICHE La Stampa - Lietta Tornabuoni Grande melodramma. Una ragazza bellissima molto povera va a vivere con un uomo d’affari anziano molto ricco che l’ama follemente, ma non rinuncia al proprio sogno di essere attrice di cinema. Per accontentarla e per non perderla, l’uomo d’affari diventa finanziatore e produttore della commedia brillante “Chicas y muletas”, ragazze e valigie, in cui lei ha la sua prima parte importante. La ragazza e il regista s’innamorano. Geloso e sospettoso, l’uomo d’affari li spia, incarica il figlio di girare in video ciò che i due fanno, assume una lettrice di parole sulle labbra per farsi riferire quanto dicono. Appena finito il film, ragazza e regista fuggono a Lanzarote, rifugiandosi soli in un bungalow sull’incantevole spiaggia di Famara. In un incidente d’auto (voluto? casuale?) la bellissima muore, il regista (come in Woody Allen) diventa cieco. Intanto l’uomo d’affari, pazzo di dolore, ha fatto completare il film nel modo peggiore, scegliendo le scene mal riuscite, la recitazione sciagurata e l’ha messo nei cinema allo scopo di svergognare il regista. Come lieto fine il regista, che ha scoperto di avere un figlio, decide di mettere a posto il film: il cinema è troppo importante, si deve fare anche senza poterlo vedere.La storia appassionata e fiammeggiante s’intreccia in filigrana con l’altra grande storia di Almodóvar, la propria vita di cinema. Il cinema è sempre presente: nei personaggi, nella lavorazione del film, nelle riprese di vita quotidiana, nella lettrice di parole sulle labbra (il doppiaggio), nelle immagini di Ingrid Bergman e George Sanders in “Viaggio in Italia” di Rossellini, nelle inquadrature di strumenti obsoleti per la lavorazione cinematografica. Specialmente nello stile de “Gli abbracci spezzati”, che ne fa un perfetto thriller hollywoodiano degli Anni 40-50, sul genere di “Gilda” o simili, molto ben fatto e bello. Almodóvar sembra aver perduto con il tempo il suo speciale sarcasmo e persino il grottesco. Questo film non somiglia affatto ai primi film farseschi che lo hanno reso tanto amato e popolare in Europa. È invece tenero, dolce: l’ironia si esercita sul genere, non sulle emozioni dei personaggi, e il cambiamento non rende il film meno amorevole. molto alla foresta del cinema sul cinema, ma conferma in tutta la sua forza l’arte di Almodóvar. Nessuno sa cogliere come lui l’urgenza del desiderio (vedi la bella scena iniziale in cui il maturo Mateo Blanco/Harry Caine, diventato cieco, seduce la bella sconosciuta che lo ha accompagnato a casa). E nessuno, se non Almodóvar, potrebbe ribaltare la trovata del tradimento scoperto grazie al labiale in una scena in cui la Cruz, smascherata, ‘doppia’ se stessa in diretta infliggendo un’umiliazione definitiva al suo attempato amante. Il problema, perché c’è un problema, è che tutto questo stenta a trasformarsi in personaggi solidi e coinvolgenti. Ma proprio l’invadenza di una trama così minuziosa e estenuante genera momenti di cinema che irritano e insieme incantano per inventiva e leggerezza. Non perdoneremo a Almodóvar le troppe citazioni o la disinvoltura con cui butta via in due battute un soggetto come quello del figlio Down di Arthur Miller. Ma non dimenticheremo facilmente le mille parrucche della Cruz, la scena in cui amoreggia sotto le lenzuola con un partner invisibile, la sconosciuta che rivestendosi dopo aver fatto l’amore pesta sbadatamente il piede del cieco con lo stivaletto. Come un mago in crisi, Almodòvar passa in rassegna trucchi e feticci. A un regista come lui lo si può concedere. Il Corriere della Sera - Paolo Mereghetti Costruito come un gioco di scatole cinesi dove il doppio binario temporale - una storia che si svolge oggi e una 14 anni fa - si riverbera e si scompone in personaggi che hanno una vita e due nomi (come il protagonista, che si chiama Mateo Blanco quando fa il regista e poi diventa Harry Caine quando la cecità lo costringe a trasformarsi in sceneggiatore), oppure lo stesso nome ma due vite diverse (come il dispotico padre Ernesto che cerca di plagiare il complessato e remissivo figlio Ernesto), o ancora una vita prima e una dopo l’evento che ne cambierà il destino (come per la bellissima Lena, interpretata da Penélope Cruz, prima segretaria e poi aspirante attrice, prima mantenuta e poi amante), il film di Almodóvar “Los abrazos rotos” (letteralmente, “Gli abbracci spezzati”) è una disperata riflessione sul cinema, sulle responsabilità di chi lo fa e, per estensione, su quello che l’occhio umano può e vuole vedere. Disperata perché, nonostante il piacere che spesso le storie possono offrire, e che l’ultimo film (nel film) diretto da Mateo Blanco cercava di trasmettere al pubblico (ne vediamo alcune scene, che non a caso ‘citano’ “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”), proprio quel piacere può essere causa di dolore. Oppure, può costare molto dolore a un regista per portarlo a termine. Da un po’ di tempo a questa parte Almodóvar sembra aver messo da parte il piacere di raccontare storie immaginifiche e colorate per addentrarsi in una riflessione sul proprio mestiere (“Il fior del mio segreto”, “La mala educación”) oppure sul materiale dei suoi sogni, a cominciare dal melò hollywoodiano (“Tutto su mia madre”, “Volver”) che con “Los abrazos rotos” tocca il suo culmine, per interrogarsi su cosa davvero possono dire le immagini. Come quelle girate da Mateo Blanco che possono essere manipolate da un produttore ostile o quelle senza sonoro che il giovane Ernesto gira sul set per spiare i comportamenti dell’ amante del padre e che hanno bisogno di qualcuno che sappia leggere sulle labbra per poter diventare davvero ‘parlanti’. Anche se è curioso, che in questo film generoso e complesso, il regista spagnolo abbia così tanto bisogno di rivolgersi alla parola (è forse uno dei suoi film più dialogati) per spiegare allo spettatore il senso delle immagini. Il Messaggero - Fabio Ferzetti Un film fatto di tanti altri film in cui tutto è doppio, replicato, spezzato, moltiplicato. Un regista, Pedro Almodóvar, che racconta la storia tragica e barocca di un altro regista, Mateo Blanco, alias Harry Caine (l’attore Lluis Homar), prestandogli diversi tratti del vero Almodóvar (e un’intera sequenza di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”), ma senza per questo confondersi con lui. E poi ancora: una storia che viaggia su diversi piani, passato e presente, realtà e finzione, visibile e invisibile, con un virtuosismo e un piacere del cinema così evidenti che tutto il resto, l’amore, la famiglia, la paternità, il tradimento, la colpa, in fondo conta poco. Perché malgrado tutti i colpi di scena e le piroette, Gli abbracci spezzati ruota solo e instancabilmente attorno al cinema e ai suoi poteri.È il cinema che fa e disfa la realtà, non viceversa. È l’ossessione per la settima arte che unisce due uomini, ignari di essere padre e figlio, al lavoro insieme su una sceneggiatura. Ed è sempre il cinema che trasforma il movimento avvolgente di una bobina di pellicola in una scala a spirale. O consente al vecchio produttore di scoprire che la sua amante (Penelope Cruz) lo tradisce, facendo leggere da una specialista le labbra della ragazza nelle scene ‘rubate’ sul set... dal figlio del produttore, che sta girando un making off del film medesimo! E via di questo passo in un gioco di specchi vertiginoso e molto almodovariano che non aggiunge 13 SCHEDE FILMOGRAFICHE 4 L’UOMO NERO di Sergio Rubini 18-19 novembre 2010 Nato a Grumo Appula, in provincia di Bari, nel ‘59, Sergio Rubini lasciò il Sud per trasferirsi a Roma e frequentare l’Accademia d’Arte Drammatica a diciotto anni. Dopo due anni però, gli si presentò l’occasione di dirigere spettacoli propri, scritti dall’amico e collaboratore Umberto Marino. Dal teatro approdò alla radio e quindi al cinema in film come “Desiderando Giulia”, “Il caso Moro”, “Figlio mio infinitamente caro” fino alla grande occasione di interpretare un giovane Federico Fellini ne “L’intervista”: un incontro, quello con il regista riminese, che si rivelerà decisivo per la sua carriera. Nel ‘90 Rubini firmerà il suo primo film da regista, “La stazione”. Il considerevole successo di critica e pubblico del film lo spinse a rimettersi in gioco con un nuovo progetto da regista, “La bionda”. Il film però si rivela un insuccesso, e spinge Rubini a realizzare un film successivo senza grandi pretese, e più adatto al grande pubblico. In seguito Rubini lavora con Tornatore in “Una pura formalità”. Al film di Tornatore seguiranno “Nirvana” di Salvatores, per il quale lavorerà anche in “Amnèsia” e “Denti”. Tra gli altri suoi film più importanti, si ricordano “Chiedi la luna”, “Il viaggio della sposa” - da lui diretto - “Del perduto amore”, “Il talento di Mr. Ripley” e “Manuale d’amore”. Interpreti: Sergio Rubini (Ernesto Rossetti, padre di Gabriele), Valeria Golino (Franca Rossetti, madre di Gabriele), Riccardo Scamarcio (Pinuccio, zio di Gabriele), Fabrizio Gifuni (Gabriele Rossetti), Guido Giaquinto (Gabriele bambino), Anna Falchi (Donna Valeria Giordano), Margherita Buy (Anna adulta), Vito Signorile (Venusio), Maurizio Micheli (Avvocato Pezzetti), Vittorio Ciorcalo (Tonino Zucca), Mario Maranzana (Direttore Dalò), Mariolina De Fano (Signorina Lo Turco), Adelaide Di Bitonto (Zia Graziella), Pierluigi Corallo (Nonno di Gabriele), Nicoletta Carbonara (Dora Spadella), Isabella Ragno (Melina Spadella) Genere: Commedia Origine: Italia Soggetto: Domenico Starnone, Carla Cavalluzzi, Sergio Rubini Sceneggiatura: Domenico Starnone, Carla Cavalluzzi, Sergio Rubini Fotografia: Fabio Cianchetti Musica: Nicola Piovani Montaggio: Esmeralda Calabria Durata: 117’ Produzione: Donatella Botti per Bianca Film in collaborazione con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: Tornato in Puglia per dare l’ultimo saluto al vecchio padre Ernesto, Gabriele Rossetti rievoca la propria infanzia, segnata duramente dal dissidio del genitore tra l’anonimo mestiere di capostazione e l’ambizione di diventare un grande pittore. Un dilemma che ha condizionato non poco la crescita di Gabriele. VALUTAZIONE: Sergio Rubini torna nelle proprie terre e vi colloca una vicenda che, rivista oggi attraverso un lungo flashback, diventa occasione per rimettere insieme frammenti di ricordi e notazioni di diario. Nello snodarsi del racconto, la cronaca diventa via via meno asciutta e rigorosa, per cedere il passo alla memoria: dando così ampio spazio ai sogni, alle delusioni, alla rabbia del piccolo Gabriele e disegnando i controcanti di un dissidio padre/figlio tanto più profondo quanto più volto verso il rispetto reciproco. Cercare i tratti comuni tra la finzione di Gabriele e la realtà di Sergio Rubini è gioco che il copione autorizza a fare, essendo la narrazione molto legata alla concretezza della terra, dei lugohi, delle tradizioni locali. Lo sguardo dell’attore-regista diventa voglia di capire e capirsi, di fermare sull’immagine momenti belli e bruttima sempre importantissimi, nel succedersi di storie, epoche, generazioni. 14 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Tempo - Gian Luigi Rondi Sergio Rubini, con il suo cinema, ritorna volentieri in Puglia, dov’è nato. L’hanno dimostrato certi suoi film di successo quali “Tutto l’amore che c’è”, “L’anima gemella” e, soprattutto “La terra”. Lo dimostra anche il film di oggi, più scopertamente autobiografico dei precedenti, visto con gli occhi di un ragazzetto di una cittadina di provincia accudito da una mamma tenera ma spesso coinvolto nelle ire un po’ nevrotiche di un papà che, pur facendo di mestiere il capostazione, ai treni preferisce la pittura. A tal segno da volere un giorno organizzare con i suoi dipinti una mostra dedicata un po’ temerariamente a Cezanne di cui ha copiato l’autoritratto conservato nel museo di Bari. Naturalmente non ha successo, i due critici d’arte locali lo stroncano e continueranno così anche quando lui organizzerà alle loro spalle una beffa che dovrebbe farli ricredere. I punti di forza del film sono proprio, nel disegno vivace di quella passione per la pittura da cui il padre è affetto. Si tiene in equilibrio sagace fra la commedia ed il dramma, evocandovi attorno una famiglia e un coro di gente paesana affidati in più momenti a colori vividi, qua con accenti caricaturali, là con puntate nell’onirico, dato che il ragazzetto che guarda e ricordando ci racconta ha spesso, anche di giorno, incubi e visioni; a cominciare dall’”Uomo Nero” del titolo. In altri momenti il testo, che Rubini ancora una volta si è scritto con i suoi fedeli Domenico Starnone e Carla Cavalluzzi, insiste un po’ in episodi marginali, proponendo figure di contorno che non favoriscono la linearità della storia di quel padre pittore dilettante. Nel suo insieme, comunque, il film può convincere perché ha tensioni, ritmi e atmosfere che, specie quando nelle sue cornici provinciali predomina il realismo, pretendono una plausibile attenzione. La facilitano gli interpreti. Non solo lo stesso Rubini che incide a tutto tondo quel suo personaggio passionale e fanatico, ma Valeria Golino, una moglie trepida dagli accenti misurati, e Riccardo Scamarcio un cognato nei panni abilmente ricostruiti di un pittoresco seduttore di paese, destinato però al grigiore. gine di sé radicalmente opposta a quella del genitore. Allora è facile vedere nella figura elegante e dinoccolata di Fabrizio Gifuni, sullo schermo Gabriele, ragazzino pestifero e poi fisico geniale, un po’ dello stesso Rubini che a suo tempo ha abbandonato il paese in provincia di Bari diventando ‘famoso’. Mentre il padre capostazione di una fermata invisibile è il suo, con la ferrovia de “La stazione”, l’esordio da regista, e la memoria della terra d’origine che è in tutti i suoi film. E quell’addio quasi pacificato al padre morto, visto dal giovane come era negli anni Sessanta della sua infanzia, commuove e sembra essere quasi il punto di arrivo di un cammino personale e d’artista. Però forse perché a interpretare il padre è lo stesso Rubini è impossibile non vederci anche un po’ del regista/figlio (autore della storia insieme a Domenico Starnone e Carla Cavalluzzi), mentre è più difficile scorgerlo nell’altra figura maschile, Pinuccio, lo zio amatissimo dal ragazzino, fratello di sua mamma, che invece il padre guarda di traverso perché si è piazzato a casa loro e non accenna a andarsene. Scapolo con vanto è il modello di Gabriele deluso fino alle lacrime come le tante innamorate quando il bel Pinuccio (Riccardo Scamarcio) sarà costretto alle nozze riparatrici con una bruttina che l’ha ‘inguaiato’ come il più fesso degli uomini. Appartiene a Rubini quel sentirsi incompreso dalla critica del capostazione con amore per Cezanne, ‘il maestro’ che vuole imitare fino a divenire quasi pazzo? Certo capita a qualsiasi artista di odiare il critico ma sarebbe strano adesso perché coi suoi film Rubini ha successo e non è certo un marginale. Infatti qui ha la grazia dell’ironia che mancava in “L’amore ritorna”, quando l’ansia di prendersi la rivincita su produttori, registi, la fidanzata ex aveva involgarito il film. Il ritratto del critico trombone di paese (soltanto?) è magistrale come la capacità di mettere in scena i riti della provincia del sud, le sue gerarchie di compiacimento, ossequi, malignità. Dove solo i ragazzini, specie se poveri e scalzi, portano la freschezza dello scompiglio mentre gli altri sono già ingessati tali e quali ai genitori. E il povero capostazione oltre a pagare il prezzo di voler essere ‘artista’, subisce pure le invidie oblique contro la moglie, bella, elegante, abbastanza folle da sopportarlo, professoressa d’arte. Dire però che “L’uomo nero” è il “Baaria” di Rubini è davvero sbagliato. Lui a differenza di Tornatore non ha la prosopopea di volerci parlare della Storia con la esse maiuscola di cui le vicende familiari sono specchio. No, la storia di Rubini è tutta personale, non si scomodano per opportunismo le grandi trami e l’immaginario, cosa che gli permette la libertà della commedia, i primi amori, la farsa con sorpresa finale quasi gogoliana. Il gioco del cinema sono i sogni visionari del ragazzino Gabriele/Rubini, gli arlecchini nascosti negli armadi, i fantasmi dei nonni vestiti da sposi, l’uomo nero che è il carbonaio del treno e con la mano sporca getta caramelle scintillati ai bimbi dell’orfanotrofio, omaggio affettuosamente esplicito e personalissimo a Federico Fellini. Ci piace pensare allora che quel padre di Rubini sia anche lui, l’altro padre che lo ha reso famoso con “L’Intervista” (le musiche sono di Piovani), che nell’ultimo periodo della sua vita venne non trattato male dalla critica ma messo fuori dal cinema e attaccato da Berlusconi quando si schierò contro la pubblicità nei film in tv. Un padre grande e difficile di cui non si rivendica l’eredità ma il ricordo col sapore dolce di un sentimento quasi infantile. Il Manifesto - Cristina Piccino Un figlio torna a casa per raccogliere l’ultimo soffio del padre che muore dopo averlo abbracciato. Inizio classico da cui si apre nel sentimento doloroso del lutto il flashback che narra la relazione tra i due, il figlio fuggito dal paesino pugliese soffocante di provincia vive in Svizzera, famiglia bilingue, carriera di successo e, esclamano con soggezione davanti alla bara del padre in chiesa i paesani: ‘Ti abbiamo visto in tv’. Il padre invece è stato costretto dalla vita a un destino insopportabile, passione per la pittura e forse anche talento che non ha potuto coltivare visto che suo padre non gli ha fatto frequentare il liceo artistico costringendolo a lavorare come capostazione. Frustrato l’uomo cerca ossessivamente un riconoscimento alla sua arte, ai suoi quadri, e quando pare riuscirvi sarà l’ennesimo fallimento. Il ragazzino oggi uomo davanti alle grida paterne si ripete sotto al tavolo di una tristissima festa di compleanno che lui no, non vuole essere come suo padre, mai. A questo punto accettando l’evidenza dichiarata anche dal regista, “L’uomo nero” è un racconto di formazione, amore e distacco che è pure sofferenza del figlio dal padre per diventare adulto, a sua volta padre, coltivando una personalità e un’imma- 15 SCHEDE FILMOGRAFICHE 5 SHERLOCK HOLMES di Guy Ritchie 25-26 novembre 2010 Nato a Hatfield, Hertfordshire (England) 10/09/1968, ma cresciuto a Londra, nel 1993 Guy Ritchie inizia a lavorare nel campo cinematografico come tuttofare. Nel 1995 inizia a dirigere video musicali e spot pubblicitari. Con i soldi guadagnati realizza un corto della durata di venti minuti intitolato “The Hard Case”, di cui cura anche la sceneggiatura. In seguito scrive e dirige “Lock & Stock” (1998), il suo primo lungometraggio. Nel 2000 è sceneggiatore e regista di “Snatch” con Brad Pitt. Nel 2001 firma la sceneggiatura del film “The Mole”. Interpreti: Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes), Rachel McAdams (Irene Adler), Jude Law (Dottor John Watson), Mark Strong (Lord Blackwood), Eddie Marsan (Ispettore Lestrade), James Fox (Sir Thomas), Hans Matheson (Lord Coward), Robert Stone (Prizefighter), Robert Maillet (Dredger), William Hope (John Standish), William Houston (Constable Clark), David Garrick (McMurdo) Genere: Giallo Origine: Gran Bretagna Soggetto: tratto dal libro a fumetti di Lionel Wigram ispirato ai personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle Sceneggiatura: Mike Johnson, Anthony Peckham, Simon Kinberg, Guy Ritchie Fotografia: Philippe Rousselot Musica: Hans Zimmer Montaggio: James Herbert Durata: 130’ Produzione: Lin Pictures/Silver Pictures/Wigram Productions Distribuzione: Warner Bros. Italia SOGGETTO: Londra, fine ‘800. Un complotto ordito da una setta potente (di cui fa parte anche il ministro dell’Interno) minaccia la distruzione dell’Inghilterra. Ad indagare vengono chiamati Sherlock Holmes e il suo fedele collaboratore dott. Watson. I due devono confrontarsi con il malvagio Lord Blackwood, che è stato impiccato ma è riapparso a commettere nuovi delitti. VALUTAZIONE: Va detto che all’origine non c’è una delle molte produzioni letterarie (romanzi, racconti...) di Sir Arthur Conan Doyle (creatore, come si sa, del personaggio Holmes) ma un successivo libro a fumetti di Lionel Wigram. Questo può spiegare l’approccio scelto dal regista Guy Ritchie: uno stile frenetico, un vorticoso accavallarsi di immagini in pieno stile videoclip, che arriva addirittura al ‘ralenti’ che abbiamo visto in certi titoli cinesi recenti. Fatto l’occhio ad atmosfere tutt’altro che compassate, bisogna aggiungere che scenografie, ambientazione, costumi sono di eccellente livello e l’azione ha pochi momenti di pausa. Il ‘personaggio’ Holmes é affidato a momenti differenti, muovendosi tra freddezza, disincanto, e un umorismo “all’inglese”. Un ‘giallo’ ma soprattutto una storia d’azione calata in costumi d’epoca. 16 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Messaggero - Fabio Ferzetti Sherlock Holmes ha il cazzotto che uccide. Il fido Watson non è da meno, in più vorrebbe sposarsi. Entrambi però sanno benissimo che non accadrà mai. Come tutte le vecchie coppie, in fondo, hanno finito per assomigliarsi. E poi non è il momento di rinunciare al loro tempestoso ménage: bisogna salvare Londra da un complotto esoterico-criminale che “Angeli e Demoni” in confronto è Paperinik. Messe nere, impiccati che resuscitano, gentiluomini uccisi nella vasca da bagno. E interi cantieri navali distrutti nel corso di risse epico-comiche a cavallo fra Jackie Chan e gli altri film di Guy Ritchie, da “Snatch” a “Rocknrolla”...Benvenuti nella versione più libera, pompata e irriverente che si potesse concepire del classico di Conan Doyle. Spariti berretto e mantellina, messo in un angolo il violino, la logica deduttiva è diventata un’arma in più per abbattere l’avversario con colpi micidiali a pugni nudi. E il gusto per la scienza serve a sperimentare potenti anestetici sul povero bulldog di casa, o a stendere avversari colossali con repentine scariche elettriche. Holmes e Watson, insomma si divertono un mondo, anche se le rispettive spasimanti (la delinquente d’alto bordo Rachel McAdams per il detective, la vaporosa Kelly Reilly per il dottore) se li rigirano come vogliono. Ci divertiamo anche noi? Qui la faccenda è più complicata. E non per lesa maestà ma perché a forza di aggiungere, dilatare, contaminare, sovrapponendo strati su strati di cultura pop e hip ai pochi elementi residui dell’originale, si rischia di uscire esausti e un po’ nauseati come dopo una cena tex-mex innaffiata da birre irlandesi e magari conclusa con qualche bicchierino di vodka. Anche perché Guy Ritchie ha tutte le qualità salvo la misura. Ma se si sta al gioco (prolungato oltre il dovuto, che un film d’intrattenimento debba durare 130 minuti resta una contraddizione in termini) ci si può divertire eccome. Non tanto seguendo la storia, quanto ammirando questa Londra vittoriana ridisegnata a tavolino come un incubo di archeologia industriale. E il gioco sopraffino dei due primattori, Robert Downey Jr e Jude Law, che dominano lo schermo dalla prima all’ultima inquadratura. Iniettando in questo susseguirsi di colpi bassi un sottotesto di tic, ammicchi, finezze, private jokes, così nutrito da farne quasi un film a parte. Un pizzico più di attenzione alle due co-protagoniste e il divertimento sarebbe stato anche maggiore. Invece Ritchie si attarda dietro alle gesta dell’infame Mark Strong, stregone e massone, con lo zelo di chi deve vincere la prima mano a tutti i costi. È presto per dire se ci sarà una seconda puntata. Ma non ci sorprenderebbe se fosse migliore. tasmagoria degli effetti sia ‘al servizio di’ e parte sostanziale di un’operazione ammirevolmente creativa. Senza sbracciarci per gridare al miracolo, qui votiamo la seconda. Decisivo è il carisma, via via nel tempo acquisito e qui esaltato, dell’attore Robert Downey jr. È lui che fa rivivere il fascino stravagante ed eccentrico del genio deduttivo concepito da Arthur Conan Doyle, dell’investigatore capriccioso e infallibile e incredibilmente erudito di Baker Street. Ma l’avventura inventata per il film aggiunge molto di suo. Armonizza l’impiego di uno stile velocissimo e sorprendente - che tiene insieme la classica ambientazione cupamente londinese fine Ottocento, con le arti apprese dal regista nella sua frequentazione dei linguaggi pubblicitari - con l’attualizzazione di un Holmes che fa valere la sua schiacciante superiorità non solo dell’ingegno e dell’intelligenza prodigiosi ma anche dei muscoli, dell’abilità e velocità nel colpire: quasi da cinema delle arti marziali. Gli è accanto il consueto dottor Watson (Jude Law), vittima un po’ riluttante della sua brillantissima e irresistibile arroganza, soggiogato e trascinato per bassifondi malgrado il proposito di rifarsi una vita con una deliziosa fidanzata che il misogino e geloso Holmes fa di tutto per mettere in cattiva luce. Si tratta di tenere testa allo smarrimento incompetente di Scotland Yard, alla corruzione massonica penetrata nelle più alte sfere, e al terrore che dilaga per Londra. Si tratta di smascherare un ciarlatano che ha plagiato tutti i suoi adepti persuadendoli di possedere doti soprannaturali e contatti diretti con il Maligno. Naturalmente per imporre il suo tirannico e avido potere sul mondo intero. Per fortuna del film, e nostra, regista e attori non fanno mancare il fondamentale supporto umoristico e dell’ autoironia. Che dire? È uno di quei film - e, dato il genere, la faccenda non è proprio indifferente - di fronte ai quali alla fine hai l’impressione e anzi ti accorgi decisamente che non tutto l’intreccio scorre fluido e plausibile. Ma onore alla capacità di suggestione che ti fa dimenticare le incongruenze e ti avvolge nell’atmosfera. La Stampa - Alessandra Levantesi Se Amleto può venir rappresentato in abiti antichi o moderni, fingersi pazzo o esserlo, apparire malinconico o isterizzato e restare, ‘purché tutto si tenga’, Amleto; perché non concedere pari opportunità a Sherlock Holmes, il mitico detective di Baker Street 221B, che nel film di Guy Ritchie diventa un supereroe d’azione alla James Bond? Visti gli incassi del weekend natalizio, la domanda è retorica. In Usa Sherlock, che è costato un terzo di “Avatar”, lo tallona al secondo posto con 62 milioni di dollari; da noi gli stanno davanti “Beverly Hills” e Pieraccioni, però 4 milioni e mezzo di euro sono una gran bella partenza. Padrone del mestiere, Ritchie è abile a imbastire, fra riprese dal vero ed effetti speciali, uno spettacolo avvincente nella suggestiva cornice di una livida Londra vittoriana. La musica di Hans Zimmer è raffinata, la misterica storia e i dialoghi brillanti divertirebbero anche Conan Doyle e la coppia di interpreti è assai intrigante: Robert Downey Jr, il più fascinoso e sfaccettato degli Holmes, e Jude Law, un Watson che non è mai una noiosa spalla. La Repubblica - Paolo D’Agostini Sicuramente ci sarà un partito di scontenti e di detrattori di questa stupefacente nuova tappa nella discontinua carriera dell’ex ‘signor Madonna’. Il punto è qui quello di stabilire se la sua rilettura del personaggio di Sherlock Holmes, con la sua vistosissima e provocatoria regia, sia affidata esclusivamente al gusto di stupire e al piacere di abbagliare, senza sostanza sotto. Oppure se (prendiamo ad esempio l’ultimo Terry Gilliam di “Parnassus”, anche se il confronto tra le due personalità e i rispettivi curricula è generoso verso Ritchie) la fan- 17 SCHEDE FILMOGRAFICHE 6 L’UOMO CHE VERRÀ di Giorgio Diritti 2-3 dicembre 2010 Giorgio Diritti (Bologna - dicembre 1959) Si forma al fianco di vari autori italiani (Lizzani, Wetmüller, Vancini), ed in particolare Pupi Avati. Realizza vari casting per film in Emilia Romagna, tra cui “La Voce della Luna”(1990) di Federico Fellini. Partecipa all’attività di Ipotesi Cinema, Istituto per la formazione di giovani autori, fondato e diretto da Ermanno Olmi. Come autore e regista dirige documentari, cortometraggi e programmi televisivi. In ambito cinematografico il suo primo cortometraggio, “Cappello da Marinaio” (1990) è stato selezionato in concorso a numerosi festival internazionali, tra cui quello di Clermont-Ferrand. Nel 1993 ha realizzato “Quasi un Anno”, film per la TV .Il suo film d’esordio, “Il Vento fa il suo Giro” (2005), partecipa ad oltre 60 festival nazionali ed internazionali, vincendo oltre 36 premi. Riceve 5 candidature ai David di Donatello 2008 (fra cui Miglior Film, Miglior Regista Esordiente, Miglior Produttore e Migliore Sceneggiatura) e 4 candidature ai Nastri D’argento 2008. Il film inoltre diventa un “caso nazionale”, restando in programmazione al Cinema Mexico di Milano per più di un anno e mezzo. Interpreti: Alba Rohrwacher (Beniamina), Maya Sansa (Lena), Claudio Casadio (Armando), Greta Zuccheri Montanari (Martina), Vito/Stefano Bicocchi (Signor Bugamelli), Eleonora Mazzoni (Signora Bugamelli), Orfeo Orlando (il mercante), Diego Pagotto (Pepe), Bernardo Bolognesi (il partigiano Gianni), Stefano Croci (Dino), Zoello Gilli (Dante) Genere: Drammatico Origine: Italia Soggetto: Giorgio Diritti Sceneggiatura: Giorgio Diritti, Giovanni Galavotti, Tania Pedroni Fotografia: Roberto Cimatti Musica: Marco Biscarini, Daniele Furlati Montaggio: Giorgio Diritti, Paolo Marzoni Durata: 117’ Produzione: Simone Bachini e Giorgio Diritti per Arancia Film/RAI Cinema Distribuzione: Mikado SOGGETTO: Inverno 1943. Alle pendici del monte Sole, non lontano da Bologna, Martina, 8 anni, vive con la propria famiglia di contadini e ha smesso di parlare da quando tempo prima ha perso un fratellino di pochi giorni. Nel dicembre la mamma rimane nuovamente incinta. Nei mesi successivi la gravidanza va avanti bene, mentre la vita per la comunità diventa sempre più difficile. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944, il piccolo viene alla luce. Quasi nello stesso momento le SS scatenano nella zona un rastrellamento di inaudita violenza. Martina riesce a prendere il neonato e a portarlo via, facendolo scampare alla terribile strage di Marzabotto. VALUTAZIONE: Sulla ferocia delle SS, sul sacrificio di tanti civili inermi, sulle vittime della seconda guerra mondiale, il cinema italiano ha già scritto pagine importanti e giuste. Il merito quindi di questo secondo film di Diritti é quello di riuscire a raccontare un episodio conosciuto come se fosse la prima volta. L’operazione é perciò opportuna e necessaria. Soprattutto per i più giovani, a rischio di “non conoscenza” dei fatti e quindi condotti a partecipare quasi in prima persona. La sensibilità storica del regista si fonde con quella antropologica e umana. Di quella civiltà contadina, dedita a seguire i ritmi della terra, si sentono i sapori e gli odori (secondo la lezione di Olmi); di quella vita modesta e intensa si avverte il forte orgoglio; di quell’andare incontro alla morte si percepisce l’affranto fremito di innocenza. Senza gridare né fare proclami, lo sguardo di Diritti si posa con tono visionario sul calvario dei protagonisti e ci chiede di essere con loro anche nella preghiera e nel riscatto. E nella speranza offerta dalla vita che nasce dopo l’orribile strage. 18 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Corriere della Sera - Maurizio Porro Sulla scorta della poetica del maestro Olmi, Giorgio Diritti racconta le opere e i giorni, i sentimenti, le paure, le giovinezze e maturità dei contadini prima di Marzabotto, la strage nazi fascista del 29.9.44. Un film bello, originale, commosso in cui si assiste alla vita quotidiana dei tempi di guerra e della brigata partigiana, finché l’eccidio non si compie. Un film meravigliosamente poetico e civile, da memorizzare e diffondere, da mostrare a scuola prima che sdoganino anche questo: così il cinema ha ancora un senso. ta che dà peso e rilievo a ogni parola (l’italiano lo parlano solo i tedeschi, il padrone o un funzionario comunale in città). Così fra il dicembre ‘43 e il settembre ‘44 prende vita un microcosmo pulsante di affetti, dubbi, speranze, paure, che prima di esser spazzati via dall’eccidio, messo in scena con aspro pudore e dettagli rivelatori (quel prete che si unisce ai balletti nazisti per evitare che la festa degeneri in orgia, e finisce ucciso), acquistano un’innocenza, una densità, una verità, scomparse nel cinema d’oggi. Un capolavoro, limpido e accessibile, di cui essere orgogliosi. Chiedendosi anche perché ci siano voluti tanti anni per avere un film così libero e rigoroso sul tema. Il Messaggero - Fabio Ferzetti Succede ancora. Ogni tanto un regista allergico alle convenzioni soffia via la polvere da pagine che credevamo di sapere a memoria. Quanti film abbiamo visto sugli orrori nazisti? Quante stragi, quanti rastrellamenti, quanti tedeschi urlanti in armi? “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti è il contrario di tutto questo. Non la ricostruzione di una pagina di Storia, con tutte le maiuscole e il kitsch del caso, ma il prodursi di un evento che sembra accadere sotto i nostri occhi per la prima volta. È ciò che il cinema cerca di fare quasi sempre, non riuscendoci quasi mai. Eppure non c’è trucco. Basta spogliarsi di tutto ciò che sappiamo - oggi - su quell’evento. Per viverlo con gli occhi di chi lo visse, allora, come un fatto enorme e incomprensibile perché del tutto estraneo al proprio sapere e alla propria scala di valori. Facile a dirsi, meno a farsi. Diritti, già regista di “Il vento fa il suo giro”, ci riesce sposando dall’inizio alla fine lo sguardo dei contadini di Monte Sole, secondo logiche e ritmi che non appartengono alla Storia e alle sue guerre ma alla cultura contadina, al rapporto con la natura, a quella concezione arcaica e sacrale della vita già cara, con accenti diversi, a Olmi e Pasolini. In mani meno abili poteva diventare retorico. In quelle di Diritti e dei suoi eccellenti interpreti, scelti mescolando non professionisti ad attori veri come Alba Rohrwacher, Maya Sansa o Claudio Casadio, interprete di teatro per ragazzi qui al suo primo film, diventa un esercizio di straniamento poetico che ripaga lo spettatore con un’emozione e una comprensione delle cose straordinarie. Una madre incinta (Sansa); una zia che torna dalla città, l’unica che sa leggere e scrivere (Rohrwacher); una bambina che non parla più per un trauma (la commovente Greta Zuccheri Montanari) ma vede e capisce tutto di tedeschi, ribelli e alleati, tanto da scrivere un tema così compromettente che la maestra glielo brucia. Poi i racconti la sera, tutti insieme, adulti e bambini, si parli di emigrazione o del partigiano che ha ucciso un fascista. In dialetto naturalmente, una lingua sonora e pietrosa oggi quasi estin- L’Espresso - Lietta Tornabuoni Nel settembre 1944, durante la Seconda guerra mondiale e la prima offensiva degli Alleati contro la linea Gotica, le formazioni partigiane dell’Appennino tosco-emiliano intensificarono le azioni per impedire ai tedeschi di arretrarsi nella zona. Si scatenò un violento contrattacco nazista. Reparti della l6a divisione delle SS Adolf Hitler respinsero i partigiani del gruppo Stella Rossa operanti sui monti intorno a Marzabotto. Due reggimenti comandati dal maggiore Walter Reder perpetrarono uno dei massacri più feroci. Dal 29 settembre al 18 ottobre sterminarono 1.830 persone, o secondo altri 770 persone, perlopiù donne, piccoli, preti, vecchi, nella cosiddetta strage di Marzabotto. I bambini uccisi furono 200. Giorgio Diritti, gia autore de “Il vento fa il suo giro”, evoca il fatto ne “L’ uomo che verrà” e fa un film molto bello. Gli avvenimenti visti con lo sguardo di una bambina di otto anni procedono parallelamente alla gravidanza della madre, il parto coincide con la strage: il neonato è “L’uomo che verrà” del titolo, il portatore di futuro che sarà giovane nel boom economico, vecchio nella crisi globale. Nell’originale i personaggi parlano nel loro dialetto emiliano, sottotitolato in italiano. Il film comincia prima del massacro e consente di conoscere il modo di vita faticoso della campagna, lo sfruttamento, la volontà rurale di non abbandonare case né animali, la paura, la bellezza insopportabile della Natura. Non ci si trova di fronte a un avventuroso “Bastardi senza gloria” né a un epico-politico “Achtung banditi!” né a un documentano storico. “L’uomo che verrà” è la narrazione alta, nobile e semplice d’una grandezza umana e morale calpestata a morte. I protagonisti sono quelle che nella pittura figurativa vengono dette ‘figure iconiche’: ossia immagini realistiche e insieme icone eloquenti, ricche di significati, capaci di condensare la Storia. Eppure sono la sobrietà rispettosa dell’autore e la bravura degli interpreti a rendere il film ammirevole come nessun’altra opera italiana del presente. 19 SCHEDE FILMOGRAFICHE 7 AN EDUCATION di Lone Scherfig 9-10 dicembre 2010 Lone Scherfig (Copenaghen - 1959) La regista ha studiato cinematografia all’Università di Copenaghen e alla National Film School of Denmark. Ha debuttato alla regia con The Brithday Trip, selezionato nella sezione Panorama alla Berlinale e per la sezione Nuovi Registi al Museum of Modern Art di New York, in seguito realizza cortometraggi, programmi radiofonici, lavori teatrali e dirige episodi di serie televisive. Nel 2000 conosce il successo internazionale grazie alla commedia “Italiano per principianti”, realizzata avvalendosi dei dettami del Dogma 95, che vince diversi premi tra cui l’Orso d’Argento, il Premio della Giuria e il premio FIPRESCI al Festival di Berlino. Nel 2002 dirige il suo primo film in lingua inglese, “Wilbur Wants to Kill Himself”, e nel 2009 segue “An Education” su una sceneggiatura dello scrittore Nick Hornby. “An Education” vince il Premio del Pubblico al Sundance Film Festival e viene in seguito presentato con successo in diversi festival cinematografici internazionali. Interpreti: Carey Mulligan (Jenny), Peter Sarsgaard (David), Alfred Molina (Jack), Cara Seymour (Marjorie), Matthew Beard (Graham), Dominic Cooper (Danny), Rosamund Pike (Helen), Emma Thompson (Preside), Olivia Williams (Sig.na Stubbs), Amanda Fairbank-Hynes (Hattie), Ellie Kendrick (Tina), Sally Hawkins (Sarah) Genere: Drammatico Origine: Gran Bretagna Soggetto: tratto dalle memorie di Lynn Barber Sceneggiatura: Nick Hornby Fotografia: John de Borman Musica: Paul Englishby Montaggio: Barney Pilling Durata: 100’ Produzione: BBC Films/Endgame Entertainment/Finola Dwyer Productions/Wildgaze Films Distribuzione: Sony Picture Releasing Italia SOGGETTO: Twickenham, quartiere di Londra, anno 1961. La sedicenne Jenny, ragazza modello, conosce David, 35 anni, che fa breccia nel suo cuore e ottiene la fiducia della severa famiglia di lei. David conquista Jenny, facendola divertire in locali notturni e coinvolgendola in azioni imprevedibili, fino a portarla in gita nella Parigi da lei tanto amata. Un giorno David chiede a Jenny di sposarla e anche il padre sembra d’accordo. Jenny lascia la scuola e si prepara al matrimonio, quando scopre che David é gia sposato, ha dei figli e abitualmente, oltre a fare il truffatore, passa il tempo a raggirare minorenni. Così tutto crolla, e la ragazza torna a scuola, e alla vita di tutti i giorni. VALUTAZIONE: Cornici reali, avvenimenti credibili e tono simbolico si incontrano e bene si fondono in questo copione tratto da un libro di memorie e girato con aderenza ai moduli del cinema inglese anni Sessanta. Si tratta con evidenza di un racconto di formazione: la crescita di una adolescente passa attraverso esperienze suadenti e accattivanti prima di rivelare il vuoto che le accompagna e offrire a Jenny le giuste indicazioni per il futuro. Supportato da ambientazione e costumi che ricreano con esattezza la Londra del periodo, il film disegna un percorso di iniziazione alla vita coerente e coinvolgente. 20 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Corriere della Sera - Maurizio Porro Nella Londra del ‘61, una liceale vicina a Oxford incontra un 30enne, entra in zona vip e sembra che i soldi siano tutto. E la scuola, l’educazione bigotta? si fa uno sconto. Quando affiora la verità, bisogna redimersi, ricominciare. Educazione social sentimentale vista da Nick Hornby che sceneggia benissimo i ricordi di Lynn Barber con fantastica attenzione al dettaglio. Cast super con Carey Mulligan, l’Audrey Hepburn di riserva e Sarsgaard, diretti dalla Scherfig. Valore aggiunto la Francia, Camus e Grèco. Sarsgaard, capace di farci capire la sua tragedia personale (guardate il lampo d’invidia quando lei nomina Oxford...) senza mai metterci contro di lui. Passando per Alfred Molina, semplicemente strepitoso nei panni del padre così interessato all’ascesa sociale della figlia da rendersi complice di vere nefandezze. La seconda parte è più illustrativa, meno sorprendente. Ma poche volte un film ha raccontato meglio il viluppo di aspettative, proiezioni, sentimenti e risentimenti, che unisce genitori e figli, ricchi e poveri, colti e meno colti, in un unico infernale girotondo. Il Messaggero - Fabio Ferzetti Si può resistere a un giovane dal sorriso gentile che dopo aver ceduto il passo, colmo della cortesia automobilistica, a una mamma col bimbo in carrozzina, vi salva da un tremendo acquazzone offrendovi un passaggio sulla sua Bristol fiammante? Si può resistere se quel giovane spiritoso, che avrà più di 30 anni, vi sconsiglia di salire sull’auto di uno sconosciuto ma si offre galantemente di riparare dal diluvio almeno il vostro violoncello? No naturalmente, e così quando il giovanotto dichiara con dolcezza disarmante le sue ‘debolezze’ non ha fatto l’università ed è ebreo, in anni di aperto e diffuso antisemitismo - è fatta. La deliziosa Jenny, brillante studentessa 16enne dei sobborghi londinesi che nel 1962 sogna Parigi (la swinging London non è ancora esplosa) e prepara l’esame per Oxford, sale sulla Bristol amaranto, stringe la mano del suadente David, che le parla di Elgar e di pittura preraffaellita. Ed entra in un mondo ignoto e sfavillante fatto di concerti, ristoranti, sigarette russe, aste da Christie’s. Anche se come scoprirà presto il dandysmo di David, che le fa una corte tenace ma discreta, con frequenti visite a casa per sedurre prima di Jenny i suoi genitori filistei, nasconde vari lati oscuri. Ma che importa l’onestà? A 16 anni si ha voglia di vivere, Jenny ha una passione sincera e divorante per il bello, e una naturale diffidenza per i rigidi principi che le inculcano a scuola. Inoltre perfino i genitori sono sedotti da quel soave imbroglione che spaccia finte dediche di famosi scrittori e si paga la bella vita con mezzi non proprio leciti... Tratto da un amaro e pungente racconto autobiografico della famosa giornalista inglese Lynn Barber, sceneggiato con libertà e finezza da Nick Hornby (che evoca le metamorfosi dello script in un appassionato libretto edito da Guanda), “An Education” è un incantevole film in costume con molti ‘genitori’. Alla Barber e a Hornby vanno aggiunti infatti la regista danese Lone Scherfig (“Italiano per principianti”), che ci mette un tocco delicato e un’attenzione mai esteriore per l’epoca e i suoi segni. Ma soprattutto un cast oltre ogni elogio. Dalla scintillante, irresistibile Carey Mulligan (candidata all’Oscar), che dà a Jenny la curiosità, i fremiti, le ritrosie, l’impertinenza di una ragazza cresciuta in un paese ancora segnato dalla guerra, al molle, doppio, spregevole ma umanissimo Peter Famiglia Cristiana - Enzo Natta “Prima di incontrarti tutto era noioso”. Basta una battuta per condensare il vissuto di Jenny, 16 anni, fino al casuale incontro con David, 35, dandy dal fascino irresistibile, che riesce ad ammaliare anche i genitori della fanciulla e che con il loro consenso la introduce in un mondo dorato, fino a quel momento ritenuto inaccessibile da una famiglia della piccola borghesia londinese. Seguirà il brusco risveglio dalla magia di un sogno, l’amaro senso della sconfitta. la volontà di trarsene fuori. Tutte queste fasi descritte dalla giornalista inglese Lynn Barber nella sua autobiografia sono state riversate nel romanzo An Education di Nick Hornby e dallo stesso adattate per l’omonima trasposizione filmica diretta dalla danese Lone Scherflg (scuola di Lars von Trier, autrice di Italiano per principianti). Siamo nel 1962 ed è facile perdere l’innocenza in un’Inghilterra che da li a poco avrebbe ceduto alla rivoluzione dei Beatles, della minigonna, del femminismo, della Swinging London. Jenny è carina, brillante, fantasiosa, adora la Francia, i libri di Albert Camus, le canzoni di Juliette Greco, studia con impegno per poter essere ammessa a Oxford. Ma quando incontra David è convinta di aver trovato la scorciatoia per il futuro. Senza passare da Oxford. Sembra una moderna favola di Cenerentola, ma Jenny non è la Sabrina di Billy Wilder, anche se le assomiglia. Film indipendente, realizzato con il contributo della Bbc che ha fiutato l’originalità e la freschezza deI progetto, scoperto e lanciato da queI cercatore d’oro che è Robert Redford con il Sundance film festival, An Education è al contempo la storia di un’educazione sentimentale e un romanzo di formazione. Elegante e raffinato affresco dell’Inghilterra di cinquant’anni fa, ritratta in un unico abbraccio che cinge una rigida scala gerarchica fatta di genitori e figli, allievi e insegnanti, dove i rapporti si consumano fra scontri e conflitti, ma anche fra sotterranee complicità, il film della Scherfig registra gli ultimi momenti di un’impalcatura sociale apparentemente solida che sta per accartocciarsi su sé stessa e finire nelle soffitte della Storia. In corsa per tre Oscar (film, sceneggiatura, protagonista femminile). E l’ultima nomination, quella di Carey Mulligan, è la più convincente. 21 SCHEDE FILMOGRAFICHE 8 INVICTUS - L’invincibile di Clint Eastwood 16-17 dicembre 2010 Mito del cinema western e uno dei più prolifici registi americani di fine secolo, Clint Eastwood nasce a San Francisco nel 1930. Nella metà degli anni ‘60 ha inizio il sodalizio con Sergio Leone ,che durerà per anni e che frutterà a entrambi la fama internazionale. Alla fine degli anni ‘60 fonda una sua casa di produzione, la Malpaso Company, abbandona il personaggio del pistolero solitario per vestire quelli dell’ ispettore Callaghan. La sua prima regia risale al 1971, con “Brivido nella notte”, ne seguiranno altre, non tutte importanti. Nel 1988 dirige “Bird”.Negli anni ‘90 centra un successo dopo l’altro: nel 1992 dirige “Gli spietati “. Vince anche (finalmente) l’ambita statuetta per il Miglior film, dopo essere anche stato nominato per quella di Miglior attore. Nel 1993 dirige “Un mondo perfetto. Con questo film Clint Eastwood si erge come uno dei registi più sensibili ed etici nel panorama americano. Continua a dirigere grandi film, come “I ponti di Madison County” (1995) “Potere assoluto” (1996 ), “Mezzanotte nel giardino del bene e del male” (1997) “Fino a prova contraria” (1999) “Space Cowboys” (2000) e “Debito di sangue” (2002). Nel 2003 arriva un nuovo capolavoro, “Mystic River”. Con il suo lavoro “Million Dollar Baby”, Clint Eastwood vince l’ Oscar 2005 come migliore regista e di miglior film. Tra i suoi ultimi lavori: “Flags of our Fathers” (2006), “Lettere da Iwo Jima” (2007), “ Gran Torino ( 2009). Pare che Sergio Leone dicesse di lui: “Ha soltanto due espressioni, con il sigaro e senza”. Interpreti: Morgan Freeman (Nelson Mandela), Matt Damon (Francois Pienaar), Tony Kgoroge (Jason Tshabalala), Patrick Mofokeng (Linga Moonsamy), Matt Stern (Hendrick Booyens), Julian Lewis Jones (Etienne Feyder), Adjoa Andoh (Brenda Mazibuko), Marguerite Wheatley (Nerine), Leleti Khumalo (Mary), Patrick Lyster (Sig. Pienaar), Penny Downie (Sig.ra Pinnear), Sibongile Nojila (Eunice), Bonnie Henna (Zindzi), Robin Smith (Johan De Villiers), Danny Keogh (Presidente Rugby) Genere: Biografico/Drammatico Origine: Stati Uniti d’America Soggetto: tratto dal libro ‘Ama il tuo nemico’ di John Carlin (ed. Sperling & Kupfer) Sceneggiatura: Anthony Peckham Fotografia: Tom Stern Musica: Kyle Eastwood, Michael Stevens II Montaggio: Joel Cox, Gary Roach Durata: 133’ Produzione: Clint Eastwood, Robert Lorenz, Lori McCreary, Mace Neufeld e Kel Symons per Malpaso Productions/Revelations Entertainment/Spyglass Entertainment/Mace Neufeld Productions Distribuzione: Warner Bros Pictures Italia SOGGETTO : Nelson Mandela, Presidente dopo le prime libere elezioni, intuisce che lo svolgimento dei campionati mondiali di rugby, assegnato per il 1995 proprio al Sudafrica, può rappresentare una grande occasione per completare quel processo di pacificazione tra negri e bianchi, da lui avviato dopo i bui anni dell’apartheid. Si impegna allora in prima persona a sostenere gli Springboks, la squadra nazionale, partecipando alle gare con entusiasmo sempre maggiore. Il successo che alla fine arride ai padroni di casa nella finale contro la Nuova Zelanda, corona un momento di felice attaccamento di tutti alla maglia e alla bandiera. VALUTAZIONE : Stavolta Clint Eastwood, solo regista, si lancia nella Storia e nella cronaca. Quelle vere, perché Mandela è ancora felicemente vivo a testimoniare gli eventi, e resoconti e telecronache sono lì a dirci che fu una partita combattuta finita con un punteggio di misura. Se dai fatti autentici il copione non poteva quindi prescindere, Eastwood di suo (prendendo le mosse da un romanzo) ci ha messo il ritmo da ballata popolare, una realtà che diventa quasi favola ma al vero ritorna in alcuni momenti toccanti e coinvolgenti (la visita della squadra alla cella del leader). Così un tema molto caro al regista, quello del perdono, torna in primo piano e si pone come vero punto di riferimento del racconto. Serve il perdono per riconciliare un popolo e fargli riacquistare una identità comune smarrita. Serve lo sport come terreno di una competizione giusta che esalta e entusiasma, meglio se infine vincente. Esemplare in questo sguardo compassionevole, la regia risulta meno attenta laddove costruisce un Mandela troppo bravo, saggio e perfetto, quasi una figura già collocata nell’agiografia. 22 SCHEDE FILMOGRAFICHE L’Unità - Alberto Crespi Per apprezzare “Invictus” amare il rugby non è indispensabile, ma aiuta. Aiuterebbe anche non avere una visione talebana del cinema e non essere obnubilati dalla vecchia ‘politica degli Autori’ (ancora!?) inventata dalla Nouvelle Vague negli anni ‘50: lo diciamo perché, alle proiezioni-stampa, c’era puzza... di puzza sotto il naso, di riflessioni del tipo ‘non sembra un film di Clint Eastwood’, è diverso da “Gran Torino” e da “Mystic River”... Se è per questo, “Gran Torino” è molto diverso dai film dell’ispettore Callaghan, dei quali però costituisce una rilettura a distanza di decenni; e l’unico modo di indurre il vecchio Clint ad estrarre ancora la 44 Magnum sarebbe definirlo, appunto, un ‘Autore’. “Invictus” è un film ‘di’ Morgan Freeman. È l’attore che ha conosciuto di persona Nelson Mandela, che ha sognato per una vita di interpretarlo, che ha cullato per anni questo progetto e che aveva, in quanto afroamericano, ottimi motivi per farlo. Poi, al momento di scegliere un regista, Freeman ha contattato il migliore, con il quale aveva due magnifici precedenti (“Gli spietati” e “Million Dollar Baby”). Il migliore, cioè Clint, ha detto di sì. Detto questo, Eastwood si è impossessato della materia allestendola in modo magistrale. Osservate con attenzione il film, la sua complessità logistica, le decine di ambienti, gli esterni disagevoli in Sudafrica: e poi valutate se sembra diretto da un uomo di 80 anni. Il tema la redenzione e il riscatto attraverso lo sport - gli era ben noto. Stavolta, a differenza che in “Million Dollar Baby”, non si trattava del riscatto di due individui, ma di un’intera nazione. Il film non è una biografia di Mandela, ma un capitolo della biografia del Sudafrica: come una giovanissima democrazia, costruita su basi fragilissime, usi un evento sportivo - i Mondiali di rugby del 1995 -come strumento di unificazione nazionale. Il rugby era lo sport dei bianchi razzisti: Mandela seppe trasformarlo nello sport della “nazione arcobaleno” alleandosi con François Pienaar, il capitano degli Springboks (nel film è Matt Damon). Il Sudafrica era sfavorito nella finalissima contro gli All Blacks neozelandesi di Jonah Lomu, ma vinse attuando un gigantesco ‘catenaccio’ che portò al punteggio finale di 15-12 (nemmeno una meta in tutto il match). Il film racconta nel dettaglio la partita, ricostruendola in modo accettabile. Ma per valutare l’apporto di Eastwood al film osservate come racconta la nascita di un’altra ‘squadra’, quella delle guardie del corpo di Mandela, dove debbono coesistere i suoi vecchi amici neri dei tempi della clandestinità con i ‘gorilla’ bianchi che proteggevano Frederik de Klerk. All’inizio si guardano in cagnesco, durante il match - con i neri che non capiscono nulla di rugby, ma finiscono per fare anch’essi il tifo - diventano quasi amici. Ci sono molti momenti del film in cui si piange, ma lo scambio di battute tra la guardia nera e quella bianca (‘È un pareggio’ ‘E ora che succede?’ ‘Tempi supplementari’ ‘Non credo di farcela’) è degno di John Ford. vicini coreani, per ritrovarci a soli due anni di distanza davanti a quell’immenso evento che fu la fine dell’apartheid (almeno legalmente) in Sudafrica e l’avvento del presidente Mandela. Una storia gigantesca da raccontare, ma grazie al cielo Eastwood si è ritrovato per le mani una sceneggiatura (tratta dal libro ‘Playing the Enemy’ di John Carlin) perfetta allo scopo. Perché concentrata sul primissimo periodo presidenziale di Mandela e sulle prime, fondamentali, scelte politiche finalizzate ad integrare come possibile afrikaners di origini olandesi e inglesi alla maggioranza della popolazione nera e ad evitare una guerra civile. Stretto su un breve periodo storico (il 1995), Eastwood sceglie due eventi attraverso cui forzare il senso dell’operazione: l’inserimento nel suo servizio d’ordine formato da uomini dell’Anc di vecchi agenti fedeli alla presidenza de Klerk (lo Special Branch, che non poche volte aveva torturato e incarcerato i primi) e la scelta di contrastare la volontà del popolo nero di abbattere tutti i simboli del vecchio governo, in primis l’inno nazionale e l’amatissima - dagli afrikaners - squadra di rugby degli Springboks, la più forte nel mondo assieme ai neozelandesi All Blacks. Alleandosi con il capitano della squadra François Pienaar (interpretato da un grande Matt Damon), e affascinandolo con i versi di William E. Henley che furono il suo mantra nei 27 anni di prigionia (‘Non importa quanto sia stretta la porta, quanto piena di castighi la pergamena, Io sono il padrone del mio destino: Io sono il capitano della mia anima’), Mandela gioca da fine politico e stratega, inimicandosi inizialmente anche i suoi più stretti collaboratori. Ma l’intuizione è giusta: niente unisce la gente più del tifo sportivo, niente può fare miracoli quanto una bella vittoria su un campo da gioco. Il resto è storia, anche se un po’ sviolinata. Nel 1995 i frastornati Springboks (che Eastwood rende un po’ più ex-perdenti di quanto siano stati in realtà) prevalgono sugli invincibili All Blacks, e alla loro Haka (la danza maori) contrappongono il doppio inno della nuova Africa: il ‘Die Stem’ di origine olandese e il nuovo ‘Nkosi Sikelei i Afrika’ in lingua xhosa. Nonostante qualche forzatura narrativa (oltre alla già citata, la rappresentazione di una squadra di afrikaner - un solo nero, il grande Chester Williams - molto più tollerante di quanto fosse in realtà), e nonostante la scelta di Eastwood di rispettare in modo canonico le regole del film storico-politico intrecciato a quello sportivo, il tocco del maestro si sente comunque. Soprattutto nelle magnifiche scene in campo, nelle mischie strette tra le due squadre, nell’intreccio dei corpi maschili, nei suoni gutturali (bellissima, come sempre, la colonna sonora curata da Eastwood figlio, Kyle), nei ralenti che vedono trasformare la guerra di posizione in magiche corse verso la mèta. Due le nomination agli Oscar, per Morgan Freeman e Matt Damon. La Repubblica - Roberto Nepoti Nel 1995, la volontà di Nelson Mandela porta la squadra di rugby sudafricana alla Coppa del Mondo, per ricostruire l’unità nazionale. Attivo quanto Allen, però mai sottoforma, Clint realizza un film dopo l’altro: con risultati più e meno alti, ma con l’identico umanesimo rivestito di forme classiche. Questa volta affronta un soggetto epico, che in mani altrui poteva scivolare nella retorica. Non in quelle di Eastwood, il quale mira all’essenziale senza cadere nella semplificazione. E dirige magnifiche partite, mostrando di sapere riprendere i corpi bene quanto le anime. Liberazione - Roberta Ronconi Difficile ormai giudicare l’opera di un artista in costante crescita come Clint Eastwood, 80 anni il prossimo maggio e un curriculum cinematografico (come attore, regista, produttore, musicista) impressionante. Usciamo estasiati dall’ultimo capolavoro di “Gran Torino”, storia di un veterano incazzato della guerra di Corea che impara - nel giro delle due ore del film - a convivere con i suoi 23 SCHEDE FILMOGRAFICHE 9 HAPPY FAMILY di Gabriele Salvatores mercoledì 22 - giovedì 23 dicembre 2010 Gabriele Salvatores (Napoli - luglio 1950) Trasferitosi a Milano, il suo primo approccio al mondo dello spettacolo non avvenne attraverso il cinema: iniziò infatti la sua attività fondando nel 1972 a Milano (assieme a Ferdinando Bruni) il Teatro dell’Elfo, per cui diresse molti spettacoli d’avanguardia, fino al 1989, anno in cui passò definitivamente al mondo della celluloide. Del 1989 è il film “Marrakech Express”, cui seguì nel 1990 “Turné”. Nel 1991 giunse la consacrazione internazionale con “Mediterraneo”, Premio Oscar come miglior film straniero (la pellicola si aggiudicherà anche tre premi David di Donatello per il miglior film, il montaggio ed il suono e, nel 1992 un Nastro d’Argento per la regia). Nel 1990 è anche regista dell’unico videoclip girato dal cantautore Fabrizio De André, per la canzone la domenica delle salme. La sua cosiddetta “trilogia della fuga”, composta dai tre film sopra citati, è idealmente proseguita nel 1992 da “Puerto Escondido”. L’anno seguente dirige “Sud” (1993). Nel 1997 “Nirvana” segna l’inizio di un periodo di sperimentazione narrativa durante il quale firmò “Denti” (2000) e “Amnèsia” (2002). Nel 2003 ha diretto “Io non ho paura” tratto dall’omonimo romanzo di Ammaniti. La pellicola gli vale una nuova nomination all’Oscar e il “Gattopardo d’oro” - Premio Luchino Viscont. Del 2005 è “Quo vadis, baby?”, tratto dall’omonimo romanzo di Grazia Verasani. Nel 2008 torna a dirigere un film tratto da un romanzo di Ammaniti, “Come Dio comanda”. Interpreti: Fabio De Luigi (Ezio), Diego Abatantuono (Papà), Fabrizio Bentivoglio (Vincenzo), Margherita Buy (Anna), Carla Signoris (Mamma), Valeria Bilello (Caterina), Corinna Augustoni (Nonna Anna), Gianmaria Biancuzzi (Filippo), Alice Croci (Marta), Sandra Milo Genere: Commedia Origine: Italia Soggetto: tratto dall’omonima commedia di Alessandro Genovesi prodotta dal Teatro dell’Elfo di Milano Sceneggiatura: Alessandro Genovesi e Gabriele Salvatores Fotografia: Italo Petriccione Musica: Louis Siciliano Montaggio: Massimo Fiocchi Durata: 90’ Produzione: Maurizio Totti per Colorado Film/RAI Cinema Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: All’inizio il protagonista Enzo, 38 anni, si rivolge direttamente alla m.d.p., dichiarando il proposito di scrivere una storia da cui fare un film. A poco a poco emerge un gruppo di personaggi, che si trovano ad interagire tra loro ma che, rischiano seriamente di restare senza autore. Ecco due famiglie: entrano in contatto perché i rispettivi figli sedicenni vogliono sposarsi. Ma nella cena che organizzano per conoscersi meglio, é invitato anche Enzo. Indecisione e paura si insinuano tra i sentimenti. Quando sembra che tutto si fermi, il racconto riprende. Quei personaggi vogliono vivere, e magari anche morire, ma provare emozioni. Lo scrittore prova ad accontentarli e a soddisfare anche se stesso. VALUTAZIONE: Dal profondo Nord Est del precedente “Come Dio comanda”, Salvatores ci invita a spostarci a Milano, città viva e vibrante, piena di attività e di molte culture. “Happy family” é una storia soprattutto spiazzante. Rifacendosi ad un testo teatrale, il regista scrive il puzzle narrativo come fosse il diario della precarietà contemporanea, tra il bel vivere e le belle case della buona borghesia e una irrefrenabile voglia di fuga. Nello schizofrenico diagramma delle paure quotidiane si insinua la malattia, che può essere vera (il tumore maligno) o simbolica (l’uso di ‘canne’). Passati i cinquanta, la famiglia si propone a Salvatores come il luogo di una comunità magari disordinata ma alla quale volere bene e nella quale recuperare quell’armonia che sembra sempre sfuggire di mano. Il gioco del cinema é ancora in grado di offrire quella duttilità espressiva che fa confondere vero e falso quasi senza farsene accorgere. 24 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Corriere della Sera - Paolo Mereghetti Scriveva Pirandello, commemorando Verga al teatro Bellini di Catania nel 1920, che ‘la vita, o la si vive o la si scrive’. Chi sembra non volergli dare ascolto è Ezio (Fabio De Luigi) uno scrittore senza apparenti problemi economici (il padre, inventore della pallina per il detersivo usata nelle lavatrici, è morto lasciandolo unico erede e togliendogli ogni problema di sopravvivenza) il quale non solo ha deciso di mettersi in scena nel romanzo che sta scrivendo, ma ha scelto anche di interagire con i vari personaggi, confondendo i ruoli di burattinaio e di burattino: la vita riscritta per riviverla, si potrebbe dire parafrasando Pirandello. È questo lo spunto di partenza di “Happy Family” di Alessandro Genovesi, una commedia prodotta con buon successo dal Teatro dell’ Elfo di Milano nel 2007 e diventata - con molta fedeltà - la sceneggiatura dell’ultimo film di Gabriele Salvatores. Non è certo la prima volta che il regista porta in scena una pièce né che intreccia la realtà con l’immaginazione (in “Nirvana” si interagiva addirittura con un videogioco) ma quello che in altri film era la base per una ‘riscrittura’ cinematografica qui rischia di rivelarsi il punto di approdo per una (troppo) semplicistica illustrazione dei possibili scambi tra invenzione e narrazione. Perché Ezio si mette sullo stesso piano dei suoi personaggi, diventando uno di loro? Si potrebbe rispondere (alla fine del film) perché ha paura di innamorarsi nella vita reale e allora vuole esercitarsi prima nella finzione. Ma anche in questo caso il meccanismo narrativo rischia di sembrare troppo artificioso e insieme troppo superficiale e quello che all’inizio poteva sembrare una traccia per capire il senso del film alla fine rischia di apparire solo un giochetto piuttosto scontato per impressionare lo spettatore con le trovate più risapute della mise-en-abîme e dello scambio di prospettiva tra oggettività e soggettività. Un po’ come sembra suggerire la presentazione ‘in soggettiva’ dei vari personaggi, con tutto quello che questa scelta dovrebbe comportare a livello di linguaggio (rottura della linearità narrativa, coinvolgimento diretto dello spettatore, messa in discussione del ‘patto di credibilità’ con lo spettatore) e che invece poi il film finisce per lasciar cadere. L’espediente, comunque, permette allo spettatore di fare conoscenza con la famiglia di Vincenzo e Anna (Fabrizio Bentivoglio e Margherita Buy) e i figli Filippo (Gianmaria Biancuzzi) e Caterina (Valeria Bilello) - quest’ultima figlia solo di Vincenzo e di un suo precedente matrimonio - e con la famiglia di Marta (Alice Croci) e dei suoi due improbabili genitori (Carla Signoris e Diego Abatantuono). Il sedicenne Filippo ha deciso di sposare la sua compagna Marta e la proposta di nozze diventa occasione per una cena che vede tutti riuniti e a cui parteciperà, per ‘merito’ di un incidente stradale con Anna, anche Ezio. Giocando con la doppia ‘coscienza’ di Ezio (come scrittore della pièce e come scrittore invitato alla cena) e regalandosi qualche divagazione di troppo (la pretestuosissima dedica iniziale a chi ha paura, l’avventura con la massaggiatrice-prostituta cinese che dovrebbe, forse, far ridere), il film dà l’impressione di voler ironizzare sullo scollamento dalla realtà dei giovani e degli adulti, dei borghesi e dei fricchettoni, delle femmine e dei maschi, mescolando la morte e la vita, il caso e la necessità, il gioco e la realtà. Ma lascian- do invece l’impressione di una superficialità gratuita e un po’ furbesca (ha funzionato a teatro, funzionerà anche al cinema), che usa i toni della commedia per affrontare temi più seri e complessi ma che finisce per rendere tutto banale. Certo, Salvatores è un ottimo direttore di attori e il cast regala momenti di divertimento e di ilarità (con Abatantuono e la Signoris su tutti), il direttore della fotografia Italo Petriccione riesce a far sembrare inedite certe atmosfere milanesi ma alla fine il sentimento dominante è quello che ti prende davanti all’arredamento troppo alla moda del loft dove vive Ezio: sembra di essere capitato all’interno di un servizio per riviste di arredamento, dove c’è tutto ce qu’il faut ma manca una cosa fondamentale: la vita! Il Manifesto - Silvana Silvestri Gabriele Salvatores riunisce la sua famiglia cinematografica con cui dimostra affiatamento ormai più che ventennale e, a parte le maestranze, rimette insieme due attori del suo gruppo di amici, Fabrizio Bentivoglio e Diego Abatantuono che non si incontravano sul set dai tempi di “Marrakech Express”, viaggiatori sans frontières ed ora padri di famiglia ugualmente disponibili alle avventure che la vita offre. Due estrazioni diverse, della Milano bene l’uno e tardo hippy l’altro: l’occasione è far incontrare le famiglie dei rispettivi figli sedicenni che hanno deciso di sposarsi. Il testo di partenza è la commedia finalista del premio Solinas di Alessandro Genovesi già andata in scena al Teatro dell’Elfo (che Salvatores fondò nel ‘70 e dove iniziò la sua attività di regista), un intreccio pirandelliano dove uno scrittore decide di scrivere una sceneggiatura d’autore ‘ma di successo’. I personaggi evocati prendono vita e interagiscono tra di loro e con il pubblico attraverso un espediente super vietato al cinema, il look in camera, cioè lo sguardo verso il pubblico ad ammiccare o a chiedere consenso, concesso solo a Oliver Hardy. In questo caso si può anche fare un’eccezione, poiché oggi tutta la comunicazione passa anche attraverso il vis à vis tipico della tv di cui il protagonista scrittore, Fabio De Luigi, è una star. Ben inseriti nel quadretto di famiglia tutti gli attori da Margherita Buy a Carla Signoris (le mamme), Corinna Augustoni (la nonna, attrice dell’Elfo), Valeria Bilello (la ragazza dai capelli rossi), Alice Croci e Gianmaria Biancuzzi (i figli) e Sandra Milo che aggiunge un tocco di follia in più oltre a quello sparso a piene mani da Abatantuono e Bentivoglio. Commedia sulla famiglia italiana con un titolo da merendina, lascia ampio spazio alle battute, alla recitazione anche un po’ sopra le righe e si trasforma ben presto in una trappola sapiente dove scontrarsi con alcuni punti dolenti del mondo contemporaneo o meglio del penoso microcosmo italiano fatto per lo più di volgarità, razzismo, spaesamento e paura. Interessante il suo modo di provocare la risata che dal fondo di un pozzo oscuro fa emergere quello che sarebbe meglio restasse sommerso: non siamo poi troppo lontani dal mondo di “Io non ho paura”, dove si distillavano sotto forma di personaggi circoscritti caratteristiche ben più vaste di un intero paese. Apparentemente Salvatores si dedica alla commedia, in realtà non tralascia il metro del discorso morale dei suoi ultimi film. 25 SCHEDE FILMOGRAFICHE 10 INNOCENTI BUGIE di James Mangold 13-14 gennaio 2011 (1963 - New York) Molti non hanno la minima idea di chi sia James Mangold, ma chi ha visto uno dei suoi film migliori, il thriller che si ispira al romanzo di Agatha Christie Dieci piccoli indiani, dal titolo “Identità” (2003), sa che è un regista che può offrire pellicole costruite con intelligenza con l’approfondimento psicologico dei suoi personaggi e la descrizione del contesto sociale. Dopo aver frequentato la Washingtonville High School, viene accettato alla California Institute of the Arts, dove studia cinema e recitazione. Quindi consegue un master e comincia a firmare i suoi primi cortometraggi. Poi, nel 1985, viene assunto come regista e sceneggiatore dalla Disney, per i quali collaborerà nella stesura di alcuni film tv e qualche film animato. Per vedere la sua opera prima, si deve aspettare il 1995, con “Dolly’s Restaurant” (Premio Speciale della Regia e il Gran Premio della Giuria come miglior opera drammatica al Sundance Film Festival). Un esordio che lo spinge a Hollywood a dirigere, attori del calibro di Robert De Niro e Sylvester Stallone in “Cop Land” (1997). L’anno seguente, dirige Vanessa Redgrave in “Ragazze interrotte” (1999). Seguiranno “Kate & Leopold” (2001) e il quasi invisibile thriller “Identità” (2003). Senza alcun dubbio, il film più noto di questo regista è “Quando l’amore brucia l’anima” (2005). Nel 2007 firma la regia di “Quel treno per Yuma”, remake dell’omonimo western del 1957. Interpreti: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Maggie Grace, Paul Dano, Marc Blucas, Viola Davis, Jordi Mollà, Liam Ferguson, Stream, Nicole Signore Genere: Azione, Commedia Origine: USA Sceneggiatura: Patrick O’Neill Fotografia: Phedon Papamichael Musica: John Powell Montaggio: Michael McCusker Durata: 109’ Produzione: New Regency Pictures, Tree Line Films, Twentieth Century-Fox Film Corporation Distribuzione: 20th Century Fox SOGGETTO: Un incontro casuale nei corridoi dell’aeroporto, catapulterà un’innocente ragazza in partenza per fare da damigella ad un matrimonio, nell’avventuroso e pericoloso mondo di un agente segreto. L’unica cosa che può fare per stare al sicuro, é stargli attaccata il più possibile... VALUTAZIONE: Gli ingredienti, in “Innocenti bugie”, ci sono tutti, riverniciati a fresco e studiati su misura per le due star, Tom Cruise e Cameron Diaz in gran forma, che non temono di giocare con gli stereotipi legati ai personaggi che li hanno resi famosi, l’eroe action e acrobata lui, tutto sorrisi e occhiali da sole, dal fascino inossidabile, la svampita e ingenua lei, che trova in sé doti e potenzialità che non credeva di possedere. “Ethan Hunt” incontra “Tutti pazzi per Mary” e l’alchimia è perfetta: lui si scopre vulnerabile, lei volitiva; lui inizia a credere nel destino, lei a lasciarsi alle spalle una vita scolorita, che si intuisce fatta di delusioni. Soprattutto entrambi iniziano a fidarsi l’uno dell’altra, poco per volta, in un divertente e mai banale “scongelamento” di sentimenti. Un film da non perdere, che intrattiene con intelligenza, non disdegna azioni spericolate (mai fini a se stesse), fa ridere e ci fa sperare di vedere più spesso al cinema film così ben congegnati, dagli ingredienti dosati a puntino. Una nota positiva tutta italiana per il doppiaggio, soprattutto per quello di Tom Cruise, reso come sempre al massimo dal grande Roberto Chevalier. 26 SCHEDE FILMOGRAFICHE Coming Soon.it - Adriano Ercolani A nove anni dal sottovalutato “Vanilla Sky” di Cameron Crowe si riforma la coppia Tom Cruise/Cameron Diaz, questa volta impegnata in una commedia d’azione che appare appositamente ideata a strutturata per rilanciare la carriera delle due star, ultimamente un po’ in ribasso al botteghino. Entrambi infatti ritrovano in questo film i “tipi fissi” che meglio hanno saputo esplorare nei loro lavori precedenti, e che li hanno portati ad ottenere i maggiori successi di pubblico. La Diaz veste nuovamente i panni della ragazza carina ma un po’ impacciata, insicura nella vita e soprattutto nelle questioni sentimentali. Cruise invece ripropone in versione più simpatica e divertita il suo cavallo di battaglia, la spia dal volto umano che diventa invincibile quando si tratta di passare all’azione. Fin dalle prime scene “Innocenti bugie” riesce a conquistare l’attenzione e solleticarne il divertimento grazie all’evidente dose di autoironia che i due attori mettono nell’interpretare i propri ruoli: in un momento in cui il cinema mainstream americano sembra prendersi molto sul serio – salvo non riuscire poi a supportare questa seriosità con la necessaria funzionalità narrativa – vedere due star come Cruise e la Diaz che scherzano sulle proprie icone in alcuni momenti è piuttosto intrigante. In particolare l’attore regala alla figura di Roy Miller una lucida follia che lo rende immediatamente simpatico, insistendo in maniera sicuramente furba ma funzionale sulla presunta “eccentricità” della spia reietta: nel caratterizzarlo in questo modo Cruise sembra strizzare l’occhio divertito alle sue recenti vicende personali, che a detta di molti hanno influito sul calo di popolarità che ha subito negli ultimissimi anni. Nei momenti in cui l’ironia e la leggerezza con cui Innocenti bugie è stato improntato viene meno, soprattutto nella parte finale, ecco che il film perde di presa sul pubblico. Ciò è imputabile anche alla regia di James Mangold, cineasta che da sempre dimostra una certa solidità nel costruire storie e personaggi ma anche alcuni limiti quando si tratta di impostare scene movimentate. Non fosse stato per un chiusura abbastanza farraginosa nello sviluppo ed esteticamente meno coinvolgente, “Innocenti bugie” sarebbe diventato un prodotto pienamente riuscito: la confezione è senza dubbio meritevole, sviluppata secondo un gusto cinematografico che strizza l’occhio al cinema del passato e ne ripropone con scioltezza alcuni stilemi. Un altro punto a favore nella messa in scena di Mangold sta nell’utilizzo elegante delle ambientazioni europee, in particolar modo le scene girate in Austria. Ed almeno una sequenza, più precisamente quella iniziale dentro l’aereo, è assolutamente spassosa. ammiccanti. Ma bastano poche sequenze per rendersi conto che il loro flirt non sfocerà soltanto in una semplice commedia romantica, quanto in una girandola di eventi frenetici e mozzafiato, che porterà la ragazza ad essere trascinata, suo malgrado, nel complotto che circonda Miller, sballottata da una città all’altra, vivendo un pericolo dopo l’altro senza soluzione di continuità.Nonostante l’ambiguità nelle intenzioni di Miller e l’insicurezza che provoca in June, Mangold sceglie di non sfruttare questi aspetti per costruire sequenze cariche di tensione, ma decide di mettere insieme una commedia d’azione dai toni leggeri e dal ritmo frenetico, senza tempi morti o possibilità di approfondimento, costruendo una giostra ad uso e consumo dei due protagonisti e dell’alchimia che sanno costruire. Gli stessi comprimari di un cast ricco al di là di Cruise e della Diaz hanno ben poco spazio per mettersi in mostra: Maggie Grace e Marc Blucas devono sfruttare i pochi minuti a propria disposizione per tratteggiare i loro personaggi, mentre i più fortunati Paul Dano, Peter Sarsgaard e Viola Davis hanno un proprio ruolo nell’ambito dell’intreccio che riguarda Miller/Cruise e la fantascientifica invenzione in suo possesso, e riescono a guadagnare del tempo extra su schermo da sfruttare per farsi notare, ma non sufficiente a caratterizzare dei ruoli a tutto tondo.Innocenti bugie è un vero e proprio pop corn movie, divertente e scanzonato, a tratti anche riuscito ed effettivamente divertente, soprattutto nella parte iniziale e nei dialoghi frizzanti. Il tono è infatti quello da commedia brillante e qualcosa si perde quando la sua componente più propriamente d’azione prende il sopravvento, facendo salire lo spettatore su delle montagne russe che non gli lasciano nemmeno il tempo di godersi le ambientazioni suggestive (si passa da Boston alle Maldive, passando per Salisburgo, le Alpi e Valencia) o le soluzioni visive messa in scena. L’azione che vede protagonisti i due attori è eccessiva e sopra le righe, ben costruita ma poco realistica, tradendo un intento parodistico verso il genere - e lo stesso Cruise di “Mission Impossible” - apprezzabile, ma purtroppo poco incisivo, travolto com’è dalla frenesia d’insieme che ne fa perdere lo spirito e da un intreccio che rivela i suoi limiti in termini di originalità.Il risultato non è comunque da buttare e il film risulta in definitiva godibile per una serata senza pensieri, purchè non ci si aspetti il miglior 007 o un Cary Grant d’annata. CritamorCinema - Franco Pecori Una batteria che non si scarica mai. Un’invenzione così, pur se ancora da perfezionare, attrae di certo interessi mondiali. Per impossessarsene qualcuno, “cattivo”, è disposto a tutto. Ignara, Junes (Diaz), se ne sta andando tranquilla al matrimonio della sorella. All’aeroporto fa uno strano incontro, casuale. Non ci fa caso. Ma durante il volo avrà modo di notare la stranezza del tipo. Roy (Cruise), il tipo, è affaccendato parecchio in una strana e movimentata attività, anche molto violenta, tanto che ad un certo punto tutti i passeggeri muoiono ammazzati e l’aereo resta senza piloti. Ma Roy s’improvvisa pilota e, bene o male, riesce ad atterrare in un prato. Ma che sta succedendo? La disinvoltura è tale che viene quasi da ridere. Proprio qui è il punto. L’intreccio, il solito affarismo e spionaggio internazionale, è complicato e andrà complicandosi sempre di più, eppure restiamo sereni e divertiti perché la materia è trattata con umorismo e tutto ciò che sembra impossibile (non mancano scene davvero “fantastiche”) rientra in un gioco spettacolare, trattato con ironia esplicita. Non cercate ragioni profonde nel comportamento dei protagonisti. La leggerezza vi sovrasterà. In giro per il mondo, da Boston a Siviglia passando per l’Austria, l’azione si veste da commedia e viceversa, aprendo l’avventura a prospettive rosa che, dato il fascino dei divi, è più che lecito attendere. Potere del cinema: Cameron Diaz si trasforma in un batter d’occhio da donna qualunque in prestante ragazza pronta a tutto. E Tom Cruise mostra perfino di avere un cuore che s’innamora. Buon divertimento. Movieplayer.it - Antonio Cuomo Non si può dire che le ultime apparizioni cinematografiche di Tom Cruise abbiano lasciato un segno profondo nella mente e nei cuori degli spettatori. Ciononostante, complice il cospicuo credito accumulato nei suoi anni d’oro e l’immenso ritorno agli MTV Movie Awards nei panni di Les Grossman, l’appeal dell’attore sembra restare quasi immutato e basta citarne il nome perchè si percepisca un’aura di successo attorno ad ogni progetto. È a questo alone da star che sembra attingere James Mangold in Innocenti bugie, affidandosi proprio al carisma dei protagonisti, Cruise e Cameron Diaz, per costruire un film di puro intrattenimento, che, con ritmo travolgente e situazioni folli, strapazza il duo e lo spettatore trascinandolo in giro per il mondo. Le due star vestono i panni di Roy Miller e June Havens, formando un’improbabile ma efficace coppia d’azione: lui in versione agente segreto, dotato di abilità che lo rendono letale nel corpo a corpo ed animato da intenzioni ambigue; lei decisamente più normale e goffa, diretta a Boston per partecipare al matrimonio della sorella. Incontriamo i due in aeroporto nel Kansas, in procinto d’imbarcarsi, e ne vediamo l’incontro apparentemente fortuito, giocato tra scambi di battute vivaci ed 27 SCHEDE FILMOGRAFICHE 11 CRAZY HEART di Scott Cooper 20-21 gennaio 2011 (1971 – Abingdon, Virginia) Dopo aver studiato recitazione al celebre Lee Strasberg Institute di New York, Scott Cooper incontra quello che sarà il suo mentore, Robert Duvall, con il quale collabora in quattro pellicole, tra cui anche in “Crazy Heart”. Nel 1999, compare in un cameo nel comico Austin Power - La spia che ci provava. Una decade più tardi, compare nell’horror “For Sale by Owner” e in “Get Low”. Archiviate ,per un attimo,le velleità di attore, Cooper si è scoperto dietro la macchina da presa, dirigendo “Crazy Heart”, tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Cobb. La pluripremiata pellicola, della quale ne è anche produttore e sceneggiatore, segna un esordio registico invidiabile che vanta ben due Golden Globes e tre candidature agli Academy Awards. Interpreti: Colin Farrell (Tommy Sweet), Jeff Bridges (Bad Blake), Maggie Gyllenhaal (Jean Craddock), Robert Duvall (Wayne Kramer), Sarah Jane Morris (Marissa Reynolds), Beth Grant (JoAnne), Tom Bower (Bill Wilson), Rick Dial (Wesley Barnes), William Sterchi (Pat), Brian Gleason (Steven Reynolds) Genere: Musical Origine: Stati Uniti d’America Soggetto: tratto dal romanzo di Thomas Cobb Sceneggiatura: Scott Cooper Fotografia: Barry Markowitz Musica: T-Bone Burnett Montaggio: John Axelrad Durata: 112’ Produzione: Robert Duvall, Robert Carliner, Judy Cairo, Scott Cooper e T-Bone Burnett per CMT Films/Informant Media/Butchers Run Films Distribuzione: 20th Century Fox Italia SOGGETTO: Bad Blake è un cantante di musica country a pezzi, che ha vissuto troppi matrimoni, troppi anni on the road e troppi drink. Tuttavia, Bad prova a cercare la salvezza con l’aiuto di Jean, una giornalista che scopre l’uomo vero dietro al musicista. Mentre lui lotta nella strada verso la redenzione, impara nel modo più duro come una vita difficile possa dipendere dal cuore folle di un uomo. VALUTAZIONE: Il film scorre seguendo le tappe convenzionali del dramma personale, tra entusiastici nuovi inizi e tristi ricadute. L’abilità del regista esordiente Scott Cooper è soprattutto nel suo sapere dirigere (o semplicemente, nell’aver scelto) Jeff Bridges. L’attore californiano riesce a dare corpo e voce (sia lui che Colin Farrell cantano in presa diretta) ad un personaggio che fin dalle sue rughe e barba grigia racconta un passato che a parole viene solo accennato. Bridges ha inciso un disco di musica country nel 2000, oltre ad aver interpretato in passato altri ruoli da cantante (vi ricordate del suo jazz in “I favolosi Baker”?): “Crazy Heart” sembra scritto su misura per lui.Peccato che la versione doppiata tolga molto al film: l’accento texano di quasi tutti i personaggi maschili, quel suono roco e scavato tipico di chi sembra sempre che ne abbia viste di tutti i colori, è un elemento cardine per essere trasportati dopo pochi attimi dall’altra parte dell’oceano, nel sud degli Stati Uniti. La musica country, seppur così lontana dalle nostre radio, ha la capacità di essere orecchiabile e coinvolgente fin dal primo ascolto.”Crazy Heart” ne diventa un piccolo manifesto visto dalla parte dei suoi protagonisti, uomini erranti frutto più che mai dell’America più tradizionale. È stato girato in soli ventiquattro giorni con sette milioni di dollari (cifra piccolissima per una produzione americana).Un buon film classico che dimostra come, a volte, non sono necessarie idee originalissime per essere visti e apprezzati, ma basta fare le cose per bene, partire da un personaggio ben scritto e poi dare la giusta attenzione ad ogni aspetto narrativo e tecnico della realizzazione. 28 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Corriere della Sera - Maurizio Porro Scommettiamo che stavolta ce la farà? Jeff Bridges, figlio e fratello d’arte rispettivamente di Lloyd e Beau, alla sua quarta nomination potrebbe vincere l’Oscar col personaggio non certo inedito di un perdente alcolizzato, una specie di “Wrestler” con la chitarra. Il primo film di Scott Cooper, ex attore molto raccomandato da Robert Duvall, che qui recita e produce ricordando “Tender mercies”, attacca lo spinotto country del cinema anni 70 in profumo di Ashby, Rafelson e Altman (magari!), road movies con scontento esistenziale incorporato. Questa figura di ex star country che si vede superare dal suo pupillo (appare e scompare senza nome in ditta il gentile Colin Farrell) e tenta di rifarsi una vita accogliendo tra le sue nostalgie bagnate di whisky un’assai improbabile giovane mamma giornalista di Santa Fè, fa parte del panorama del cinema dei ‘loser’, quelli che ogni giorno barattano la vita bevendo e fumando. L’autore, formato alla scuola di Strasberg, rispetta ogni regola del gioco: molta musica in concert e il viso incolto, gli occhi ispidi di un Bridges ispirato da un allegro cinismo, tentato di rifarsi famiglia in un’offerta speciale con l’intervista. E dietro scorre la solita America alla Hopper di motel e stazioni di servizio, bar con musica alla sera (i saloon di oggi, dove comanda un affettuoso Duvall) e i non luoghi omologati dove un piccino si può perdere. Sogno posticipato: a 57 anni è a rischio. Il film, giocato come un pezzo country, di ambientazione provinciale proprio come il debutto di Bridges “L’ultimo spettacolo” di Bogdanovich, è banalmente scorrevole, non si nega il sentimentalismo e il moralismo nella finale difesa dei valori costituiti con melassa, si prolunga oltre la misura del racconto ispirato dal libro di Thomas Cobb, ennesima elegia di un uomo rude e solo, cow boy andato fuori strada e fuori tempo. Virtuosa almeno quanto era spudorata in “Secretary”, Maggie Gyllenhaal sfodera un’ antica dolcezza di torte di mele che forse farà vincere pure a lei la statuetta. Ma chi comanda incroci e svincoli emotivi, gettandoci in faccia birra e scotch come fosse in 3D, è lui, Jeff, ex “grande Lebowski”, il Bad texano che ha l’aria stropicciata di chi è andato a letto tardi in questi anni. Pescando dalla sua generosa offerta espressiva si legge nel volto peloso e arruffato di Bridges (simile a quello di Kris Kristofferson, impossibile non notarlo) la lista delle illusioni americane e la diagnosi di un cuore matto, matto da legare ma che non ha nulla a che vedere col colesterolo. whisky alle labbra, alcolizzato cronico che sopravvive alla solitudine esibendosi in provinciali locali di quart’ordine. È un uomo a perdere sino a quando incontra Jean, giovane giornalista bella e rampante e il suo bambino Buddy, e sente risvegliarsi perduti sentimenti d’amore, frustrati sensi di paternità, spiragli redentivi di effimero sollievo, meteorici. Il film allinea ripetitività di situazioni e concerti, climaterica serialità di momenti country, secondo maniera nel quadro d’una cartolinesca America di frontiera, e al di là di scoramenti e malinconie con un’apertura a sani valori d’amore e amicizia. E tanta bella musica. Ma soprattutto, interprete da meritatissimo Oscar, Jeff Bridges, con allegro cinismo e sussiego stropicciato clone del fu ‘drugo’ Lebowsky. Porta alla perfezione un ritratto di perdente accidioso, trasandato e - sporco, in vano sussulto di rasserenata vita coniugalfamliare accanto a Maggie Gyllenhaal morbida e dolce. Film TV - Mariuccia Ciotta Jeff Bridges è “Crazy Heart”, corpo e melodia malinconica, genere country-western, laggiù nelle pianure deserte del New Mexico, in mezzo al ‘nulla’. Candidato all’Oscar, lo vincerà. Non è facile infatti sfuggire allo stereotipo del cantante alcolizzato, ex leggenda folk, passato nomade, vita sentimentale bruciata, figlio e moglie lasciati marcire da qualche parte, e in più fumatore estremo, il che sugli schermi americani è più spregevole di un tossico. Bridges nelle vesti spiegazzate del texano Bad Blake evita la tentazione dell’artista maledetto, modula tristezza e tenerezza, e dà voce alle canzoni con lo stesso tono disorientato. Stella cadente davanti alle platee di una generazione che non lo ricorda più e ha eletto a nuovo divo il giovane Tommy Sweet (Colin Farrell), il suo ex allievo. La jam session per soli uomini si completa con la presenza di Robert Duvall (anche produttore) nella parte del vecchio amico dei tempi gloriosi, dispensatore di saggi consigli per conquistare la felicità, affogata in troppi bicchieri di whisky. Il regista esordiente (e sceneggiatore) Scott Cooper, attore, creatura di Duvall, che lo ha voluto accanto a sé in quattro film, non poteva volere di più. Forte della formazione al Lee Strasberg Institute, ha diretto l’orchestra di tre grandi interpreti e grazie a loro parteciperà alla Notte delle Stelle con un film che ha già vinto due Golden Globe, uno per il miglior attore e l’altro per la canzone originale, ‘The Weary Kind’ (di T-Bone Burnett e Ryan Bingham). I problemi arrivano con il soggetto, tratto dal romanzo omonimo di Thomas Cobb, ammuffito refrain sul campione suonato e in crisi di età (ma Bad Blake ha solo 57 anni!) nella scia di “The Wrestler” e di “Tender Mercies” (Oscar per Robert Duvall). Uomo disilluso trova la redenzione nell’amore per la ragazza tutta acqua e virtù, in questo caso una giornalista improbabile (Maggie Gyllenhall, “The Secretary”), mammina amorosa di un pargoletto, al quale manca un ‘padre affidabile’ proprio come capita nei film del filone mucciniano. E “Crazy Heart” affonda nel più convenzionale dei mondi possibili, con la donna repressiva sentinella dell’ordine morale e alcolico e con tutto ciò che prevedibilmente accade. Il Giornale di Brescia - Alberto Pesce È un’America country Anni ‘70 quella di “Crazy Heart”, da un libro di Thomas Scott con atmosfere alla Rafelson di “Cinque pezzi facili” e alla Hopper di “Easy Rider”. Ma il film le rivisita con bisturi leggero, quasi soave, e con vago sentore tra buonismo e malinconia le incasella in una stereotipia di personaggi e situazioni. Tutto gira attorno alla figura di Bad Blake, ex-star del country, ora surclassato dal pupillo Tommy Sweet, anche se ancora idolatrato da tifoserie di periferia texana; con 4-5 matrimoni alle spalle, un figlio lasciato perdere, sigaretta accesa e bicchiere di 29 SCHEDE FILMOGRAFICHE 12 L’AMANTE INGLESE di Catherine Corsini 27-28 gennaio 2011 (maggio 1959 - Dreux - Francia) Passata dalla recitazione direttamente dietro la macchina da presa, nei suoi film mette in scena la complessità dell’universo femminile e la fragilità delle relazioni. Catherine Corsini passa la sua infanzia nella cittadina di Seineet-Marne; la sua passione per il cinema nasce in lei da adolescente, quando degli amici le consigliano di vedere alcuni film della Nouvelle Vague. Godard resta sempre un suo punto di riferimento; inizialmente però il suo sogno è quello di diventare un’attrice. Per realizzarlo, a 18 anni si trasferisce a Parigi dove frequenta corsi di recitazione e laboratori; studiando cinema, però, si appassiona sempre di più alla scrittura e alla messa in scena, e comincia a lavorare come sceneggiatrice, realizzando alcuni cortometraggi e lavorando per il teatro. Esordisce nel lungometraggio nel 1988 con “Poker”, di cui firma anche la sceneggiatura, come succederà per tutti i suoi lavori successivi; in seguito si fa notare come regista televisiva realizzando il film “Interdit d’amour”. La sua opera seconda, “Les Amoureux” viene presentato al festival di Cannes nel 1994, permettendole di farsi conoscere dalla critica. Nel 1999 firma un film dai toni più leggeri, “La Nouvelle Eve” - Una relazione al femminile che si rivela in Francia un successo a sorpresa. Nel 2001 è nuovamente a Cannes con “La Répétition”. In seguito ritorna alla commedia, nel 2003, con “Mariées mais pas trop”; nel 2006 scrive e dirige un film tratto dalla sua autobiografia “Les Ambitieux”. “L’amante inglese”, del 2009, rappresenta un altro tassello del suo mosaico al femminile. Interpreti: Kristin Scott Thomas (Suzanne), Sergi López (Ivan), Yvan Attal (Samuel), Bernard Blancan (Rémi), Aladin Reibel (Dubreuil), Alexandre Vidal (David), Daisy Broom (Marion), Berta Esquirol (Berta), Gerard Lartigau (Lagache), Geneviève Casile (Madre di Samuel), Philippe Laudenbach (Padre di Samuel), Michèle Ernou (Sig.ra Aubouy), Jonathan Cohen (Banchiere), Hélène Babu (Dorothée), Mama Prassinos (Sig.ra Dubreuil) Genere: Drammatico/Romantico Origine: Francia Sceneggiatura: Catherine Corsini, Gaelle Macé Fotografia: Agnes Godard Musica: Georges Delerue, Antoine Duhamel Montaggio: Simon Jacquet Durata: 85’ Produzione: Pyramide Productions/Camera One/VMP/Solaire Production/Canal +/Ciné Cinéma Distribuzione: Teodora Film SOGGETTO: L’inglese Suzanne vive in una cittadina di provincia nel sud della Francia con Samuel il marito medico e due figli adolescenti. Quando conosce Ivan, operaio spagnolo incaricato di ristrutturale lo studio, in Suzanne scatta una scintilla incontrollabile. Tra i due comincia una storia che diventa ben presto passione travolgente. Da allora le cose precipitano. Suzanne va via di casa, ma non ha più niente, il lavoro di Ivan è precario, e i soldi non ci sono. Decisa a seguire la propria storia d’amore, Suzanne comincia una dura lotta col marito per avere quello che le spetta. In occasione di una sua assenza, entra in casa e ruba dipinti e gioielli. Ivan viene incolpato e arrestato. Samuel dice a Suzanne che se torna a casa, lo farà liberare…. VALUTAZIONE: “Avevo voglia -dice Catherine Corsini- di raccontare una vicenda classica, che mi permettesse un ritratto femminile simile a quello delle eroine di cui ho sempre sognato, donne come Anna Karenina e Madame Bovary (...) Ho provato a mostrare la forza del desiderio, la sua inevitabilità e la sua irruzione in un’esistenza normale e ordinata”. Sotto questo profilo, la vicenda é ben motivata, e, si potrebbe dire, anche semplice. Il diagramma dell’ amour fou, del sentimento folle che si fa irrazionale, conduce a gesti estremi, dei quali chi li commette non avverte la gravità. Che però resta, e sebbene il copione non si risolva in una esaltazione dei fatti narrati, ci sarebbe ancora una volta da chiedersi perché l’esistenza “normale e ordinata” sia accostata quasi ad un non esistenza. Nell’ambito dunque del melò a tinte forti, il racconto procede con logica e rigore. 30 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Mattino - Valerio Caprara In un periodo che al cinema suggerisce solo riprese e riferimenti, non sorprende il teorema truffautiano svolto dalla francese Corsini. Peccato che estirpi dal modello “La signora della porta accanto” qualsiasi palpito di calore e ne inverta l’oltranzistico, folle romanticismo in una cerebrale e cruda resa dei conti neo-femministica. La brava ma algida Kristin Scott Thomas e il tarchiato e macho Sergi Lòpez vi attualizzano il tema lawrenciano della donna di classe e di censo soggiogata sul piano del sesso da un proletario reietto, percorrendo un calvario determinato dalle leggi economiche e societarie di cui, invece, è adepto lo spregevole marito tradito. I temi dell’amore-passione e del prezzo della libertà individuale risultano insomma forzati per amore di tesi, finendo con lo svuotare lo slancio di un film corretto e lineare sul piano professionale. simili ‘normalità’ che adora infilarsi l’amo di Eros: nella fattispecie, lo spagnolo Ivan, operaio in nero, ex carcerato per una sciocchezza. Un uomo buono, che la vita ha segnato quel che basta per desiderare di lanciarsi in una dimensione nuova. È passione, è amore, è vita. Nelle storie dell’amata Nouvelle Vague era raro che il tutto finisse in un happy end. Sono passati gli anni, il cinema è sempre il cinema, e il mondo, là fuori, esige che si paghi il tributo. La Repubblica - Roberto Nepoti Inizia con un colpo di fucile poi ci racconta una storia di moglie-marito-amante che può sembrare pericolosamente vecchiotta. In una località del Sud della Francia vive Suzanne, quarantenne di origine inglese, col consorte di successo e due figli. Quando la donna incontra Ivan, operaio catalano ed excarcerato, è l’’amour fou’: prima incontri clandestini, poi Suzanne decide di abbandonare la famiglia per vivere la sua passione. Malgrado il soggetto iper-frequentato, è un mélo che non dà una versione ovvia della psicologia dei personaggi. Soltanto il seduttore (involontario), alla fine, sa farsi carico della sofferenza altrui. Attenzione al mix musicale, tratto da tre film di Truffaut. La Stampa - Lietta Tornabuoni La passione per un operaio spagnolo sconvolge la vita ordinata d’una donna inglese, madre di due figli grandi, moglie di un imprenditore del Sud della Francia. Non ci sarebbe nulla di inconsueto, se non fossero fuori del comune i due protagonisti, moglie e marito, Kristin Scott Thomas e Yvan Attal. Lei è una persona senza compromessi: incontrata la passione, la vive completamente, non intende rinunciarvi, lascia il marito benestante. Il marito è una persona ripugnante, vendicativa, meschina, preoccupata della propria reputazione: la picchia, le urla “non ti lascerò andare”, fa perdere il lavoro al rivale, denuncia tutti e due, allontana lei dai figli, la perseguita. Comportamenti odiosi e inutili, forse testimonianza d’amore o forse prova di suscettibilità ferita. I due interpreti (Sergi Lòpez, l’amante spagnolo operaio, non ha molta parte) sono bravissimi. In particolare, Kristin Scott Thomas affronta molto bene le scene erotiche e nude che si trova a interpretare per la prima volta nella sua carriera, nei film in cui i registi l’hanno vista piuttosto come emblema di riservatezza e d’eleganza. Con un minimo scarto, la regista Casini arriva a trasformare un adulterio come tanti in uno specchio sociale, nell’immagine di una schiettezza inglese, d’un meschino senso di proprietà francese, nella previsione di non facile felicità per gli amanti. Il Manifesto - Silvana Silvestri Un adulterio è argomento prezioso per il cinema: qui la storia è complicata dalle differenze di classe e dai diversi paesi di origine. Nulla fa cambiare idea a Suzanne (Scott Thomas) quando si innamora di Ivan, l’operaio dall’oscuro passato che sta ristrutturando il suo studio, né la vita agiata che conduce con il marito, né i due figli adolescenti. Confessa il tradimento e lascia la casa. Due cuori e una capanna spesso non sono l’equazione giusta e poiché il marito le ha tolto carte di credito, chiuso il conto e fatto il vuoto attorno, non riesce a sopravvivere. Ora, poiché si tratta di una donna inglese possiamo anche capire che contravvenga alla regola aurea del ‘negare sempre’ e abbia la smania della confessione a tutti i costi, più difficile è credere che non sappia come gestire gli affari e non corra subito dal suo avvocato prima ancora che dal prestante amante catalano (Sergi Lòpez, è la seconda volta dopo “Ricky” che lo vediamo come operaio d’oltre confine). Da questi indizi si capisce che si tratta di un raffinato gioco di ruolo, dove tre personaggi portano alle estreme conseguenze i risvolti della loro personalità: il marito francese (Yvan Attal, costruito sulla falsariga del ministro François Fillon, diceva la regista) non può sopportare che la sua immagine venga intaccata pubblicamente, soprattutto ora che ha deciso di entrare in politica, Suzanne vuole vivere fino in fondo quell’attrazione mai provata prima, Ivan si dimostra accogliente e paziente a dispetto di ogni cliché di machismo. Ma se la moglie fosse stata francese, il marito inglese e l’amante italiano? Lei avrebbe ancora il suo conto, lui non si accorgerebbe di niente, l’altro se ne andrebbe a seguire la squadra in trasferta. Il Sole 24Ore - Luigi Paini Improvviso arrivò l’amore. L’amour fou, che tanto piaceva a François Truffaut e a tutti i suoi compagni della Nouvelle vague : l’amore che ti getta al tappeto, che ti fa sragionare. “L’amante inglese”, di Catherine Corsini,s’incammina su questa via fin dalle prime battute. Nel Sud della Francia, sferzato dal vento e baciato dalla luce, Suzanne è all’apparenza la donna più felice del mondo. Non manca nulla per poterla definire una tranquilla, perfetta borghese, bella casa, marito di successo, due figli, la voglia (e pure la possibilità) di ricominciare a lavorare. Non per bisogno, giusto per realizzarsi. È in 31 SCHEDE FILMOGRAFICHE 13 MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek 3-4 febbraio 2011 Ferzan Özpetek (Istanbul -1959) si trasferisce in Italia nel 1976 per studiare Storia del cinema a La Sapienza di Roma, Dopo aver avuto alcune esperienze in teatro, riesce ad avvicinarsi al mondo del cinema iniziando a collaborare come assistente ed aiuto regista con Troisi, Ponzi, Ricky Tognazzi, Francesco Nuti. Il suo primo lavoro come aiuto regia è in “Scusate il ritardo” di Troisi, seguito da “Son contento” di Ponzi. Il suo debutto cinematografico come regista avviene nel 1997 con il film “Il bagno turco (Hamam)”. Il film, ottiene grande successo di critica e pubblico, ottenendo svariati premi e venendo presentato alla 50ª edizione del Festival di Cannes. Nel 1999 realizza “Harem Suare”. Nel 2001 dirige “Le fate ignoranti”. Nel 2003 è la volta de “La finestra di fronte”. Nel 2005 realizza “Cuore sacro” (12 candidature ai David di Donatello, e premio per la miglior attrice protagonista, Barbora Bobulova, e miglior scenografia). Nel 2007 è in sala “Saturno contro” (4 Ciak d’oro, 5 Globi d’oro, 4 Nastri d’Argento e un David di Donatello come miglior attrice non protagonista, assegnato ad Ambra Angiolini). Il 2008 è un anno importante per Özpetek: per la prima svolta lavora su un film non basato su una sua sceneggiatura ma adattando il romanzo corale di Melania Mazzucco “Un giorno perfetto”. Nel dicembre 2008 il MoMa di New York ha dedicato una retrospettiva al regista:è uno dei pochi registi italiani ad aver avuto questo onore. Nel 2009 ha diretto il cortometraggio “Nonostante tutto è Pasqua”, segmento del progetto L’Aquila 2009 - Cinque registi tra le macerie, in cui diversi cineasti raccontano il terremoto dell’Aquila. Nel 2009 intraprende un nuovo progetto cinematografico: dopo aver scritto una sceneggiatura a quattro mani con Ivan Cotroneo, dirige il film “Mine vaganti”. Per la prima volta il regista dirige un film fuori da Roma, città a cui è molto legato e nella quale ha ambientato molti dei suoi lavori. Interpreti: Riccardo Scamarcio (Tommaso), Nicole Grimaudo (Alba), Alessandro Preziosi (Antonio), Lunetta Savino (Stefania), Ennio Fantastichini (Vincenzo), Elena Sofia Ricci (Zia Luciana), Ilaria Occhini (Nonna di Tommaso), Bianca Nappi (Elena), Massimiliano Gallo (Salvatore), Paola Minaccioni (Teresa), Emanuela Gabrieli (Giovanna), Carolina Crescentini (La nonna da giovane), Giorgio Marchese (Nicola), Matteo Taranto (Domenico), Carmine Recano (Marco) Genere: Commedia/Drammatico Origine: Italia Sceneggiatura: Ferzan Ozpetek, Ivan Cotroneo Fotografia: Maurizio Calvesi Musica: Andrea Guerra Montaggio: Patrizio Marone Durata: 116’ Produzione: Domenico Procacci per Fandango in collaborazione con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: Da Roma Tommaso torna a Lecce, dove la famiglia gestisce da tempo un avviato pastificio. Tommaso dovrebbe dire ai genitori che nella capitale non ha studiato economia ma lettere, che vuole fare lo scrittore e, soprattutto, che é omosessuale. Un giorno, a tavola, il fratello Antonio spiazza tutti e rivela di essere gay. Il padre Vincenzo lo caccia di casa e lo esclude dalla gestione dell’azienda. Così Tommaso è costretto ad interessarsene e a tenersi il proprio segreto dentro. Deve passare un po’ di tempo prima che, grazie anche alla visita inattesa di alcuni suoi amici e alla morte della saggia nonna, anche Antonio torni in famiglia e si possano creare le condizioni per una migliore convivenza. VALUTAZIONE: Un nucleo familiare ampio e armonico, un’azienda di famiglia ben condotta, una solidità borghese che sembra non scalfibile. “Dopo tanti film -dice Ozpetek- in cui ho raccontato le famiglie degli affetti, ho voluto, complice forse l’età, concentrarmi sulla famiglia di sangue, quella ‘classica’, anche perché, dopo la scomparsa di mio padre, ho cominciato a riconsiderare il rapporto genitori-figli con un nuovo sguardo.(...)”. Una situazione paradossale costruita per creare sconcerto e raddoppiare la possibilità di equivoci e fraintendimenti. Nella rete della commedia di costume, la regia si muove bene per la prima parte, poi perde il controllo, si adagia sul già detto. Ozpetek prova a rifare Germi, ma l’accento posto sull’ipocrisia di provincia é spuntato e poco velenoso. 32 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Messaggero - Fabio Ferzetti Segreti di famiglia. Tutti ne hanno, nessuno li vuole. Ma il bello dei segreti è che sono contagiosi. Ogni segreto ne genera un altro, poi un altro e un altro ancora. Che alla lunga, naturalmente, sono sempre meno segreti e sempre più comici (o tragici, ma più di rado). Mine vaganti applica questo principio al clan patriarcale di un industriale della pasta leccese e ci porta di sorpresa in sorpresa con una leggerezza e una verve che il regista de “Le fate ignoranti” aveva un po’ perso per strada dopo tanti film seri o seriosi se non cupi ma poco convincenti. Il segreto più esplosivo è quello di Riccardo Scamarcio, figlio del patriarca Ennio Fantastichini, che torna da Roma con un piano. Il padre vuole affidargli l’azienda di famiglia. Lui invece dirà a tutti che ha altri progetti, vuole scrivere, ha un romanzo nel cassetto e soprattutto è gay, è sempre stato gay e sempre lo sarà. Così, pensa, verrà cacciato di casa e sarà finalmente libero. Un piano perfetto se qualcosa, non diremo cosa, non andasse storto. Perché a casa Cantone ognuno ha il suo scheletro nell’armadio. Papà Fantastichini annega i dispiaceri nel seno accogliente della sua antica amante. Mamma Lunetta Savino sopporta quelle corna istituzionali in cambio di un potere assoluto. La sorella zitella (ma assai piacente), una spiritosa Elena Sofia Ricci, riceve ogni notte l’amante urlando ‘al ladro, al ladro!’ per giustificare la finestra aperta. Quanto al fratello di Scamarcio, Alessandro Preziosi, anche lui non dice tutto... Mentre la collerica bellezza bruna che sfreccia per Lecce su una spider rossa (Nicole Grimaudo: perché lavora così di rado?) è il mistero in persona. E finirà per intrecciare un’intensa amicizia, anzi un quasi-amore proprio con Scamarcio, che dopo aver rimandato il suo coming out vive come sospeso fra due vite, due età, due città. In una lunga parentesi coincidente con l’intero film, incorniciato da un drammatico antefatto sepolto nel passato di nonna Ilaria Occhini (un altro segreto...) che regge il peso ‘morale’ della vicenda ma è saggiamente concentrato nel prologo e nell’epilogo. Lasciando a Ozpetek l’estro, il piacere, la libertà di giocare con quel mondo in cui ognuno recita una parte premendo come mai prima sul pedale del comico. Come nella lunga e irresistibile visita degli amici gay venuti da Roma a trovare Scamarcio. Un gruppo di ‘pazze’ caricaturali (ma palestrate...) che solo Fantastichini, nel suo perbenismo all’antica può scambiare per virili rubacuori. Con conseguenze assolutamente esilaranti (anche perché la servitù non la beve). A conferma che per dare il meglio prima o poi bisogna buttare a mare convenzioni e preoccupazioni inutili. Anche dietro alla macchina da presa. tutto - come ha sottolineato Maurizio Cabona - ‘infilava il dubbio malignetto che nessuna eterosessualità è al di sopra di ogni sospetto’). Qui lo è meno. Anche se il problema del rivelare la propria omosessualità sta al centro del film. O forse no. E infatti il film sembra partire da lì per poi allargare invece il suo raggio di azione e di indagine a tutti i membri della famiglia Cantone e ai rapporti che all’interno di questa nel corso degli anni si sono instaurati tra di loro. Il padre autoritario, la madre ossessiva, la zia ‘disturbata’, la cameriera ‘suonata’ e un po’ tarda. Per non parlare di Alba, l’amica di Tommaso, veramente sciroccata. L’unica che sembra mantenere qualche briciolo di lucidità è proprio quella che avrebbe il diritto (per età, esperienza, per la malattia che la affligge) di non averne: la nonna. Sarà lei, oltretutto - e non potrebbe essere altrimenti - a ricucire i rapporti all’interno della famiglia, a rimettere insieme i cocci di un nucleo familiare che si stava disgregando sotto il peso dei pregiudizi, del perbenismo piccolo borghese, della paura di ‘cosa dirà la gente’. L’altro pregio del film, come accennavamo, è la fluidità del racconto a cui si accompagnano un paio di bei momenti di cinema che mescolano la realtà e il suo fantasma. Non mancano, naturalmente, le famose sequenze conviviali intorno a una bella tavola imbandita che hanno reso celebre il cinema di Ozpetek. Insomma: un film che riesce a restare in equilibro tra il cedimento alla farsa le il prendersi troppo sul serio. Il Tempo - Gian Luigi Rondi Ancora famiglie per Ferzan Ozpetek. Come ne “Le fate ignoranti”. In Puglia, questa volta, a Lecce, dove i Cantone padre e figlio gestiscono un pastificio. L’altro figlio, Tommaso, è andato a studiare a Roma, non economia e commercio come i suoi credono pensando all’azienda, ma lettere, per diventare scrittore. Torna per dire la verità anche sulle sue inclinazioni omosessuali di cui in casa non sanno nulla, ma lo precede Antonio, l’altro fratello, rivelando inclinazioni analoghe in occasione di un pranzo in famiglia. Il padre prima rischia un infarto, poi lo caccia, Tommaso allora decide di tacere. Attorno la madre, un’altra sorella, ma soprattutto la nonna che si era sposata quasi a forza pur innamorata del futuro cognato cui si era comunque sentita legata fino a quando era morto, ricordandolo ancora con tenerezza struggente. È questa nonna il centro più autentico di una vicenda scritta da Ozpetek con Ivan Cotroneo e poi rappresentata con modi sempre intensi, tra un via vai di situazioni, spesso attorno a tavole da pranzo, in cui ogni psicologia è sottilmente cesellata alternando i climi ansiosi ad altri ora polemici ora ironici. In una cornice in cui la solarità mediterranea di Lecce e nella Puglia è messa in sapiente contrasto con il buio che pesa su tutti quegli animi feriti da duri contrasti. Con un felice equilibrio sia drammatico sia emotivo tra le cui pieghe stona solo una sequenza che indugia sull’intrusione di una banda di amici omosessuali di Tommaso piovuti giù da Roma con atteggiamenti a dir poco macchiettistici. Ma la si dimentica quasi subito per apprezzare la salda bravura della maggior parte degli interpreti: Riccardo Scamarcio (Tommaso), con una mimica eloquente sempre sospesa tra reticenza e dolore; Alessandro Preziosi (Antonio), con dignità e misura quasi severe; Ennio Fantastichini (il padre), perfetto prima nello sbalordimento furioso poi nel terrore provinciale di possibili scandali; Ilaria Occhini (la nonna), il personaggio più bello e sofferto, espresso con accenti finissimi; da grandissima attrice. L’Eco di Bergamo - Andrea Frambrosi ‘Tu vuò fa l’americano’,cantava Renato Carosone. Più che in altre occasioni, in questo “Mine vaganti”, ci è sembrato che Ferzan Ozpeteck si sia divertito a ‘fare’ l’Almodóvar. Questa iniezione di almodovarismo ha permesso però ad Ozpeteck di realizzare un film piuttosto vivace, coloratissimo, narrativamente fluido come non gli capitava da un po’. Detto questo, però, il film non ci ha convinti pienamente. A fronte della scorrevolezza di cui dicevamo, “Mine vaganti” non ci è sembrato andare tanto al di là di una rivisitazione, se pure più vivace, come dicevamo, dei consueti temi affrontati dal regista turco-italiano nelle sue precedenti opere. In particolare, naturalmente quello sull’essere (o non essere) gay. Un tema che, francamente, sembrava diventato ossessivo nel cinema dell’autore de “Le fate ignoranti” (film nel quale oltre- 33 SCHEDE FILMOGRAFICHE 14 L’UOMO NELL’OMBRA di Roman Polanski 10-11 febbraio 2011 Il suo vero nome è Roman Lieblin (Parigi agosto1933) e nasce da emigranti polacchi che si trasferisce di nuovo a Cracovia due anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto i suoi genitori vengono imprigionati in un campo di concentramento e lui è costretto a cercare accoglienza per sottrarsi dal ghetto dove è rinchiuso. Si ritrova con il padre soltanto alla fine della guerra . Nel 1962 realizza in Polonia il suo primo lungometraggio, “Il coltello nell’acqua”, che ottiene una nomination all’Oscar tra i migliori film stranieri e conquista il Premio della Critica al Festival di Venezia. Nel 1965 realizza “Repulsion” e l’anno dopo lavora a “Cul de sac”. “Per favore non mordermi sul collo”, del 1967, è di nuovo un grosso successo. La fama di Polanski arriva fino a Hollywood, dove il regista si trasferisce per realizzare “Rosemary’s baby” che gli vale il Golden Globe. Nel 1971 gira un nuovo film, “Macbeth”, trascrizione del dramma shakespeariano. Dopo il grottesco “Che’”, nel 1974, Polanski torna a Hollywood per dirigere “Chinatown”. Nel 1979 realizza “Tess”, nuovo capolavoro che ottiene il César per il miglior film e per il miglior regista, più tre Oscar (fotografia, scenografia e costumi). Nel 1984 scrive la sua autobiografia, che diventa subito un best seller, ma dal punto di vista creativo gli anni Ottanta sono piuttosto deludenti per lui. Nel 1988 ottiene un nuovo successo grazie a “Frantic”, con Emmanuele Seigner. L’attrice, divenuta sua moglie, da questo momento è la protagonista di quasi tutti i suoi film, facendosi notare soprattutto in “Luna di fiele” (1992). Nel 1993 riceve a Venezia il Leone d’Oro alla carriera. Dopo “La morte e la fanciulla” (1995) e “La nona porta” (1999), nel 2002 realizza “Il pianista”, che vince la Palma d’oro al Festival di Cannes e l’Oscar come miglior film straniero. Nel 2004 ha girato a Praga il film “Oliver Twist”, tratto dall’omonimo romanzo di Charles Dickens. Nel 2007 ha preso parte in qualità d’attore al film italiano “Caos calmo” di Antonello Grimaldi. Interpreti: Ewan McGregor (Ghost Writer), Pierce Brosnan (Adam Lang), Kim Cattrall (Amelia Bly), Olivia Williams (Ruth Lang), James Belushi (John Maddox), Timothy Hutton (Sidney Kroll), Eli Wallach (Anziano della vigna Genere: Thriller Origine: Francia Soggetto: Robert Harris (romanzo) Sceneggiatura: Robert Harris (adattamento), Roman Polanski Fotografia: Pawel Edelman Musica: Alexandre Desplat Montaggio: Hervé de Luze Durata: 131’ Produzione: Roman Polanski, Robert Benmussa e Alain Sarde per R.P. Films, France 2 Cinema, Elfte Babelsburg Film, Ruteam Iii Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: Uno scrittore britannico accetta di completare, in qualità di ghostwriter, il libro di memorie dell’ex Primo Ministro inglese Adam Lang: una sostituzione resasi necessaria dopoché il predecessore, storico assistente di Lang, é morto in un incidente. Per raggiungere Lang, lo scrittore vola al suo quartier generale, un’isola sulla costa orientale degli Stati Uniti: proprio quando un ex ministro lo accusa di aver autorizzato la cattura illegale di sospetti terroristi e di averli consegnati alla tortura della CIA. In caso di conferma, si configurerebbe l’accusa di crimine di guerra. Da quel momento per lo scrittore il compito cambia: non più solo la scrittura del libro ma la voglia di capirne di più nei rapporti tra Lang e la CIA. Tra scoperte e mezze verità, il ghostwriter comincia seriamente a rischiare la vita… VALUTAZIONE: Si tratta del film presentato al festival di Berlino 2010 e girato da Polanski mentre su di lui incombeva la riapertura del processo per l’accusa di stupro di minorenne negli Stati Uniti. All’origine c’è il romanzo omonimo di Robert Harris, narratore e giornalista inglese, autore di libri best seller in molti Paesi. Siamo nell’ambito di una quanto mai ‘classica’ storia di spionaggio, un intrigo politico economico tra le due sponde dell’oceano, con in più la presenza dello scrittore che non c’è (o non ci dovrebbe essere). Questo è il tocco in più che fa lievitare la vicenda, innestando nel copione robuste dosi di suspence. Niente di veramente nuovo, a dire il vero. Ma il regista é bravo a tenere ben stretto il ritmo del thriller, e a nascondere la verità fino alla conclusione. 34 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Fatto Quotidiano - Anna Maria Pasetti Il coltello nell’ombra è affilato. Tanto che ne mostra una densità orrorifica, dal grigio più dark che mai si fa nero, perché nel buio totale si è ciechi. E invece Roman Polanski vuole che il nostro sguardo si accompagni al suo, un radar nei labirinti dell’invisibile. Con “L’uomo nell’ombra”, il suo lavoro più recente premiato a Berlino per la regia, lo spettatore diventa Polanski e il cinema fa il suo miracolo. Insufficienti gli aggettivi per un’Opera dalle sospensioni perfette, dalle incursioni shakespeariane nelle tre ‘p’ della Tragedia: potere, passione, paura. Il miglior Polanski mentre rievoca “Chinatown”, ritmi ‘frantic’ e dark lady da Macbeth, si mescola ‘per natura’ thriller-visiva a Hitchcock, ma anche a Huston. “L’uomo nell’ombra” è il ghostwriter (Ewan McGregor) dell’ex premier britannico Adam Lang - leggi Tony Blair (Pierce Brosnan) - in momentaneo ritiro su un’isola americana a completare l’autobiografia. Scoprirà il buio oltre una siepe intrecciata di trame politiche, accuse di crimini di guerra (l’Iraq...). manovre di una Cia molto ‘embedded’, il tutto troppo off the records. Ma soprattutto un’inquietudine che dal 2003 tortura la British intellighenzia ex blairiana: il Regno Unito è ormai il 51° degli Usa. Questo è alla base del bestseller ‘The Ghost’ (‘Il Ghost Writer’, 2007 Mondadori) di Robert Harris, scrittore ed editor politico tra i più feroci accusatori di Blair, da cui il film di Polanski è tratto. Il regista l’ha voluto con sé a sceneggiare con un risultato che, rivela Harris ‘è migliore del romanzo’. McAra ha nascosto sotto un cassetto? Presi dalla vicenda personale del ghost writer, immaginiamo che Polanski abbia girato un thriller, o almeno un poliziesco. Ci aspettiamo che la capacità di scrittura del protagonista riesca a mettere ordine e senso nei fatti complessi e oscuri che, via via, la sceneggiatura accumula. Uno più di altri attende una spiegazione: Lang è un criminale di guerra? Di questo l’accusa in televisione Robert Rycart (Robert Pugh), che è stato suo ministro degli esteri: d’aver consegnato alcuni prigionieri agli Usa, per essere torturati.Prima nell’universo chiuso dell’isola, poi sulla terraferma, lo scrittore raccoglie indizi e testimonianze. Intanto, legge e inizia a riscrivere le pagine lasciate da McAra. E si stupisce della loro scarsa qualità narrativa. Era o non era un professionista, il suo predecessore? In fondo, che cosa ci vuole a migliorare un’autobiografia? Basta metterci quello che i lettori vogliono trovarci. O meglio basterebbe, se alle preoccupazioni del mestiere non s’aggiungessero quelle d’arrivare alla verità. E la verità a un certo punto sembra a portata di mano. È sufficiente collegare quelle tali vecchie foto al professor Paul Emmett (Tom Wilkinson), e poi cercare conferme in internet. A un certo punto, (anche Rycart), entra direttamente nella storia. Tutto ormai sembra chiaro: da almeno trent’anni Lang è legato alla Cia. Ora non resta che affrontarlo, in un faccia a faccia che sembra uscito da un film di Hitchcock, appunto. Ma poi qualcuno gli spara…..Siamo così all’ultima sequenza, anch’essa, anzi soprattutto essa hitchcockiana. A Londra, mentre l’ex primo ministro viene rievocato e celebrato (anche da Rycart), lo scrittore capisce. La verità è sempre stata vicinissima, nelle carte di McAra. Ma proprio adesso Polanski abbandona alla sua irrilevanza il MacGuffin. Lo fa con un’immagine geniale. “The Ghost” lascia la sala della cerimonia, portando con sé la prova della soluzione finalmente trovata. Così immagina (e noi con lui) allontanandosi a piedi. Ma all’improvviso si sente un colpo. La macchina da presa tuttavia non si gira in controcampo a mostrarne gli effetti. Con un’inquadratura fissa sulla strada, l’occhio del cinema non ci lascia vedere che i fogli di McAra dispersi dal vento: come del primo, anche del secondo ghost writer non resta che l’assenza. Qualunque sia la verità scoperta dai due, d’ora in poi conterà quella che il potere ha deciso che conti. Così sempre avviene, per quanto ci si illuda. E resto è fantasma. Il Sole 24Ore - Roberto Escobar ‘I’m the ghost’: cosi, in originale, si presenta il protagonista di “L’uomo nell’ombra” (“The Ghost Writer”. E subito qualcuno precisa che ‘he’s the ghost writer’. Insomma, lo scrittore di cui narrano Roman Polanski e il suo cosceneggiatore Robert Harris non è solo un ‘negro’ - come in un italiano molto rude, ma efficace, si può tradurre ghost writer -, ma è anche proprio un ghost, un fantasma. D’altra parte, nel film non ha un nome. Per l’ex primo ministro britannico Adam. Lang (Pierce Brosnan), per sua moglie Ruth (Olivia Williams) e per i molti coinvolti nella vicenda è solo “The Ghost” (Ewan McGregor).Un nome - ossia, McAra - ha invece il ‘negro” che lo ha preceduto nel compito di scrivere l’autobiografia di Lang, e che è stato trovato annegato sulla spiaggia di un’isola al largo della costa orientale degli Usa (lì, protetto da occhiute guardie del corpo, vive da qualche mese l’ex primo ministro). McAra, tuttavia, non compare mai, nemmeno in flashback. Di lui si vede solo l’auto, che nella prima sequenza un carro attrezzi rimuove dal ponte di un traghetto. Pur in modi diversi, i due scrittori sono fantasmi: l’uno privato dell’identità di un nome, l’altro rievocato solo ‘in assenza’. Già questo suggerisce che Polanski sta attirandoci in un gioco narrativo raffinato e ingannevole. Nonostante la sua centralità, il protagonista - ecco l’inganno - non ha un ruolo sostanziale nella storia. Non lo ha al pari di quello che Alfred Hitchcock chiamava MacGuffin: un oggetto attorno a cui si sviluppa una trama, ma che alla fine viene abbandonato. Un MacGuffin spiegava con ironia, è ‘un marchingegno per catturare leoni sulle montagne della Scozia’. E se di leoni in Scozia non se ne vedono, poco male: quel che conta è catturare uomini e donne in una sala cinematografica. Certo il fantasma di “L’uomo nell’ombra” ne cattura, di leoni-spettatori. Di lui,condividiamo l’impegno a scrivere centinaia di pagine in un mese. E con lui trepidiamo. Come ha potuto il corpo di McAra arrivare sulla spiaggia, vincendo le correnti? Che cosa c’è nelle vecchie foto di Lang che Io Donna - Paolo Mereghetti Un ghost writer (McGregor è chiamato a scrivere le memorie dell’ex ministro inglese Adam Lang (Brosnan) proprio quando si scopre che il politico aveva aiutato la Cia nelle peggiori pratiche antiterroristiche. È per questo che il ghost writer precedente è morto? È per questo che c’è sempre qualcuno che spia? Quasi tutto ambientato - secondo la più classica tradizione gotica - nella casafortezza che Lang ha su un’isola, capace di ‘respingere’ la realtà che sembra volerla assediare (troupe televisive, dimostranti pacifisti, curiosi); costruito sfruttando al meglio l’ostilità della Natura (vento, pioggia, mare burrascoso); giocato con sapienza tra inquietanti personaggi ‘secondari’ e reticenti comprimari (la moglie Ruth, la segretaria Amelia, un misterioso professore), il film sa trasmettere un senso di angoscia insinuante e sotterraneo che trasporta lo spettatore in un mondo senza più certezze, dove le macchinazioni politiche diventano l’altra faccia dell’insicurezza quotidiana. Perché Lang fa subito pensare a Tony Blair e il thriller si intreccia alla fantapolitica in maniera inestricabile. Come solo Polanski sa fare. 35 SCHEDE FILMOGRAFICHE 15 ROBIN HOOD di Ridley Scott 17-18 febbraio 2011 Ridley Scott (novembre 1937, Northumberland -Inghilterra) Dopo aver studiato al West Hartpool College of Art e al London’s Royal College of Art, all’inizio degli anni ‘60 comincia a lavorare come scenografo . In seguito, dirige alcuni show dell’emittente inglese. Realizza centinaia di spot pubblicitari e la mano è già quella di un maestro. Molte di quelle sue iniziali produzioni conquistano infatti premi e riconoscimenti. Nel 1977 debutta come regista con “I duellanti” (migliore opera prima al Festival di Cannes). Il film successivo, è ancora più ambizioso: “Alien” (1979), rivoluzionario esempio di cinema di fantascienza. Tre anni dopo con “Blade runner”, liberamente tratto dal romanzo di Philip K. Dick, il regista propone una tenebrosa visione del futuro; il film contribuisce a rendere mitico il suo interprete Harrison Ford. Gli altri film realizzati negli anni ‘80, “Legend” (1985), “Chi protegge il testimone” (1987) e “Black Rain - Pioggia sporca” (1989), sono certamente meno originali dei primi, ma nel 1991 “Thelma & Louise” è uno straordinario successo commerciale: ottiene sei nomination dell’Academy Award. Dopo il flop di “1492 - La scoperta del paradiso” (1992), Scott realizza opere che non raccolgono più i consensi di un tempo: “Albatros - Oltre la tempesta” (1996) e “Soldato Jane” (1997). Ma nel 2000, torna al successo con “Il Gladiatore” (vincitore di cinque Oscar, tra cui quello per il miglior film). Subito dopo realizza “Hannibal”, il seguito de “Il silenzio degli innocenti”.A questo è seguito il meno fortunato “Black hawk down”. Tra le ultime fatiche vi sono il divertente “Il genio della truffa”, “Le Crociate”(2005) e “American Gangster” (2007). Interpreti: Russell Crowe (Robin Longstride), Cate Blanchett (Marion), William Hurt (Guglielmo il Maresciallo), Mark Strong (Sir Godfrey), Mark Addy (Fra’ Tuck), Oscar Isaac (Principe Giovanni), Danny Huston (Re Riccardo), Eileen Atkins (Eleonora d’Aquitaine), Kevin Durand (Little John), Scott Grimes (Will Scarlet), Alan Doyle (Alan A’Dale), Max von Sydow (Sir Walter Loxley), Matthew Macfadyen (Sceriffo di Nottingham) Genere: Azione/Drammatico Origine: Stati Uniti d’America/Gran Bretagna Soggetto: Brian Helgeland Sceneggiatura: Brian Helgeland, Ethan Reiff, Cyrus Voris Fotografia: John Mathieson Musica: Marc Streitenfeld Montaggio: Pietro Scalia Durata: 131 Produzione: Ridley Scott, Russell Crowe e Brian Gazer per Imagine Entertainment/Scott Free Productions/Universal Pictures Distribuzione: Universal Pictures International Italy SOGGETTO: Inghilterra, tredicesimo secolo. Alla morte di Re Riccardo I, gli succede il figlio principe Giovanni. Ma il regno ormai é fin troppo indebolito e non si accorge che un traditore sta agevolando lo sbarco dei francesi in terra inglese. Solo Robin Hood, prode arciere di Nottingham, tiene la testa a posto, conquista il cuore della vedova Marion e organizza la difesa che risulta vittoriosa. Il nemico é messo in fuga. VALUTAZIONE: A ognuno il Robin Hood che si merita. Errol Flynn, Kevin Costner, ora Russell Crowe, già gladiatore sempre per Rydley Scott. Tra la storia e la leggenda, stampa sempre la seconda, diceva il tipografo di “L’uomo che uccise Liberty Valance” di John Ford, e sulla falsa notizia di avere ucciso quel pericoloso bandito, James Stewart costruisce una carriera da venerato senatore. Ecco quindi Robin Hood che, nel ricordo del padre ucciso brutalmente, supera divisioni e rivalità e scende in campo a difesa dei cittadini e per migliorare la vita civile. Ricostruzione ambientale impeccabile (costumi, luoghi, situazioni), grande e spettacolare incalzare dell’azione. Ma Crowe, alla c.s. al festival di Cannes, dice: “Se rinascesse oggi, Robin Hood farebbe politica o starebbe a Wall Street a combattere contro gli speculatori e chi si arricchisce illegalmente oppure farebbe la guerra a chi controlla e monopolizza i media”. Il riferimento plateale all’oggi sa di didascalico e stempera molto la vivacità del prodotto. 36 SCHEDE FILMOGRAFICHE Film TV - Mario Sesti Bell’omaggio francofilo che Ridley Scott sta portando a Cannes: nel suo nuovo “Robin Hood”, i cattivi tradizionali come lo sceriffo di Nottingham e il Re infido e prepotente, impallidiscono nei confronti dei francesi che ammassano i contadini dentro ricoveri di legno per poi dargli fuoco come facevano i nazisti con i villaggi dell’Ucraina e della Bielorussia, nel tentativo di preparare lo sbarco del loro monarca sul suolo inglese. I francesi di oggi la prenderanno, sicuramente, con la loro tradizionale mancanza di suscettibilità (tra Francia e Inghilterra c’è, da sempre, lo stesso elegante fairplay che c’è tra tifosi romanisti e laziali). In ogni caso, il film avanza con passo robusto e pesante fino a una sanguinosa battaglia sulle spiagge di Dover, tra i due eserciti, che rende il cinema di cui è fatto più vicino all’epica guerresca del “Signore degli Anelli” che alle acrobazie spaccone di Errol Flynn. È anche il momento in cui scintilla quel mix di montaggio ormonale e sguardo stroboscopico che ha reso celebre in tutto il mondo lo stile de “Il Gladiatore” (copiato da tutti: in primis dal suo regista). Ma prima di arrivare Iì, c’è il lungo antefatto del ritorno delle Crociate e della morte di Riccardo Cuor di Leone, un laborioso plotting della situazione internazionale e un inevitabile resoconto delle povertà e delle ingiustizie di Nottingham. Insomma, per aspettare che Robin Hood faccia qualcosa da Robin Hood (predare nella foresta in nome della giustizia e della società) bisogna aspettare quasi 90 minuti (giuro). È vero che Scott ha detto che voleva raccontare la nascita del mito più che il mito stesso, ma nella classifica dei film sul tema, questo rischia proprio di trovarsi quasi al fondo - né rimarrà alla Storia la solenne ricostruzione, libertaria, della lotta dell’aristocrazia alla corona. Cosa lo salva dalla retrocessione? Non il copione colto ma velleitario, né le inquadrature paesaggistiche da art design, né Russell Crowe (il suo Robin Hood non ha né il carisma di quello di Sean Connery, né la purezza naif di Kevin Costner), ma una Lady Marian di lineamenti e bagliori preraffaelliti: anche perché non c’è bisogno di un grande filmaker per far risaltare su tutto Cate Blanchett. lo a tratti greve e didattico come un film di propaganda camuffato da cinema d’azione. Ci vuole più di mezz’ora difatti perché Riccardo Cuor di Leone (il sempre bravissimo Danny Huston) muoia quasi per caso durante uno dei tanti assedi innescando il macchinoso scambio di identità che farà scoprire al rude Robin Longstride chi è veramente. Non senza prima calarsi nei panni - e nel talamo coniugale - di un altro crociato defunto nel frattempo. È così che il futuro Robin Hood approda nell’impoverita Nottingham depredata dal famigerato sceriffo. È sempre così che si trova ‘sposato’ d’ufficio a una bella vedova perseguitata (intrepida Cate Blanchett) grazie al padre dell’uomo di cui ha assunto l’identità, un maestoso vegliardo cieco e irredento (un gigionissimo Max Von Sydow). Chi cerca riferimenti alla geopolitica odierna, e magari ai neonazionalismi antieuropei, si accomodi. Chi voleva più equilibrio fra spettacolo e divertimento storico, dovrà armarsi di pazienza. Le due ore e mezzo di film, malgrado l’azione incessante, si sentono tutte. Vivilcinema - Marco Spagnoli A differenza, fortunatamente, di quello che era possibile attendersi sulla carta, “Robin Hood” non è il remake ideale de “Il gladiatore”, quanto piuttosto un film diverso che sembra partecipare dello stesso spirito e delle medesime suggestioni visive che avevano animato “Le crociate”. Il ricongiungimento della coppia Ridley Scott-Russell Crowe in un contesto epico dà comunque vita ad un film d’azione spettacolare e ricco di humour, qualità ampiamente consentite dal personaggio dell’eroe incappucciato. “Robin Hood”, presentato in pompa magna quale film d’apertura di Cannes 2010, rappresenta una variazione interessante e originale sul tema delle gesta del ribelle che ruba ai ricchi per donare ai poveri: un prequel alla sua intera storia, rivisitata però sempre in chiave leggendaria, lasciando solo uno spazio minimo alla storicità e, ovviamente, al realismo. Una pellicola dalla vocazione molto classica che percorre, a suo modo, il solco della lunga tradizione cinematografica dell’eroe portato diverse volte sullo schermo, da Errol Flynn passando per Sean Connery fino ad arrivare a Kevin Costner. Robin Longstride è un arciere al seguito di Riccardo Cuor di Leone, che prima di tornare a casa a Londra dalla Terza Crociata, sta riconquistando alcuni castelli che gli erano stati sottratti dal Re di Francia. Robin, dopo una zuffa, sollecitato dal sovrano inglese gli comunica pubblicamente il proprio disagio per alcune gesta poco onorevoli cui era stato costretto l’esercito in Terrasanta. Messo alla gogna insieme a dei commilitoni, l’uomo di umile estrazione approfitta della morte di Riccardo per fuggire. Intercettata una pattuglia di spie francesi che hanno teso una trappola fatale al corteo che sta riportando la corona in Inghilterra, Robin è costretto a fingersi un nobile e a mantenere una promessa fatta ad un cavaliere in punto di morte. in quel momento che il soldato inizierà, suo malgrado, ad incamminarsi verso quel destino che lo porterà a diventare Robin Hood. Impreziosito dalla presenza di Cate Blanchett e da un cast di grandi talenti eterogenei, che vanno da William Hurt a Max Von Sydow, “Robin Hood” è un film gradevole ed intelligente, animato da quella cura dei dettaglio, quell’elegante gusto per il virtuosismo e il senso dello humour caratteristiche del cinema di Ridley Scott. Pienamente apprezzabile per la sua qualità e il suo stile, “Robin Hood” lascia un unico rammarico nella possibile aspettativa nei confronti di una trama di maggiore sostanza e introspezione, radicalmente differente da quanto visto e raccontato fino ad oggi. Il Messaggero - Fabio Ferzetti Chi l’avrebbe mai detto? Nel film scelto per inaugurare con fragore il 63mo festival di Cannes i francesi sono invasori odiosi e intriganti, i loro soldati usano metodi degni delle SS, i buoni sono gli inglesi di ceppo sassone opposti a quelli di discendenza normanna, cioè francese, che depredano e taglieggiano gli onesti britanni all’alba del XIII secolo. Cioè dieci anni dopo la fine della terza Crociata. Se non riconoscete in questa tumultuosa tela di fondo l’epoca che vide nascere il mito di Robin Hood, non c’è niente di strano: il film di Ridley Scott (fuori concorso) è un prequel, vuole raccontare l’uomo prima della leggenda, il guerriero prima dell’arciere, il combattente prima del ribelle. Naturalmente ogni epoca ha il Robin Hood che si merita, o che le conviene, e quello dell’ex militare Ridley Scott è un nipote nemmeno troppo lontano dei soldati tutti d’un pezzo delle Crociate e del Gladiatore. È lontano il ricordo degli arcieri romantico-acrobatici resi leggendari negli anni ‘20-30 da Fairbanks e Flynn, lontani anche i due ufficiali napoleonici legati da un odio quasi metafisico che resero celebre Scott con “I duellanti”, Palma come miglior opera prima qui a Cannes nel 1977. Il Robin Hood di Scott è piantato anima, corpo e frecce nell’Inghilterra infuocata del primo Duecento, fra contese dinastiche e tensioni da guerra civile aggravate dalla costante minaccia francese. È il lato più ambizioso di questo kolossal cupo e muscolare. Ma è anche quello che gli impiomba le ali rendendo- 37 SCHEDE FILMOGRAFICHE 16 THE LAST STATION di Michael Hoffman 24-25 febbraio 2011 Nato alle Hawaii nel 1956 e cresciuto nell’Idaho, Hoffman è stato cofondatore dell’Idaho Shakespeare Festival nel 1980. Studente di arte drammatica, scrive e dirige come saggio finale un film con Hugh Grant, Privileged. Amico di John Schlesinger, che collabora alla produzione delle sue opere, Hoffman realizza in seguito Restless Natives. Nel 1987 firma regia e sceneggiatura di “Terra promessa”; l’anno successivo dirige “Some Girls”. Autore eclettico, nel 1991 Hoffman è dietro la macchina da presa per la divertente satira sul mondo delle soap opera “Bolle di sapone”; nel 1995 dirige “Restoration – Il peccato e il castigo” e nel 1996 firma la commedia romantica “Un giorno, per caso”. Seguono nel 1999 “Sogno di una notte di mezza estate” e “Il club degli imperatori” (2002). Nel 2009 è nuovamente regista e sceneggiatore del film “The Last Station”, basato sugli ultimi giorni di vita del grande scrittore Lev Tolstoj. Interpreti: Helen Mirren (Sofya Tolstoj), Christopher Plummer (Leo Tolstoj), James McAvoy (Valentin Bulgakov), Paul Giamatti (Vladimir Chertkov), Anne-Marie Duff (Sasha Tolstoj), Kerry Condon (Masha), Patrick Kennedy (Sergeyenko), John Sessions (Dushan), David Masterson (Reporter), Tomas Spencer (Andrej Tolstoj), Maximilian Gärtner (Kind), Nenad Lucic (Vanja) Genere: Drammatico Origine: Germania/Russia Soggetto: tratto dal romanzo ‘L’ultima stazione’ di Jay Parini (ed. Bompiani) Sceneggiatura: Michael Hoffman Fotografia: Sebastian Edschmid Musica: Serghei Yevtushenko Montaggio: Patricia Rommel Durata: 112’ Produzione: Zephyr Films/Egoli Tossell Film/Samfilm Produktion/Andrei Konchalovsky Production Center Distribuzione: Sony Pictures Releasing Italia SOGGETTO: Unione Sovietica, 1910. Lev Tolstoj, scrittore celebrato, ha ormai deciso di rinunciare al titolo nobiliare e ai diritti sulle proprie opere. Intende così dare concretezza a quelle rinnovate idee politico-sociali, che lo hanno indotto a creare uno sorta di scuola aperta a giovani che lo adorano e lo seguono con venerazione. In questo modo però il contrasto con la contessa Sophie, da quasi cinquanta anni amata moglie, si fa sempre più aspro. Partito senza di lei per il sud del Paese, Tolstoj accusa un malore. Ricoverato in una stazioncina, muore, confortato dalla presenza di Sophie, che in un primo momento la figlia aveva tenuto fuori della porta. VALUTAZIONE: Tratta da un libro, la ricostruzione dell’ultimo anno di vita di Lev Tolstoj é affidata ad una scelta espressiva di tono memorialistico e illustrativo più che sinceramente approfondito. La regia di Michael Hoffman é più preoccupata della cornice che non del contenuto. Ne esce una illustrazione d’epoca sapiente, non confortata da una adeguata riflessione su argomenti, scelte politiche e filosofiche. Una bella messa in scena dunque, edulcorata e sentimentale. 38 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Giornale - Cinzia Romani Nel 1910 l’82enne Tolstoj (Christopher Plummer) abbandona moglie (Helen Mirren) e figli, mettendosi in viaggio su un vagone ferroviario di seconda classe: cerca la rivoluzione personale. Ma dopo mezzo secolo di matrimonio, sarà difficile che la frivola contessa Sofja, sposa devota e ignara dei moti sociali russi, possa seguire l’evoluzione del grande scrittore, smanioso di liberarsi anche del suo titolo nobiliare. L’intenso biopic in costume descrive bene gli ultimi anni di Tolstoj, rimanendo in equilibrio tra la difficoltà di vivere l’amore coniugale e l’impossibilità di vivere senza di esso. Station”, cui giovano, però, una bene strutturata solidità di sceneggiatura, in apertura e in epilogo suggestive soluzioni visive d’antan, accorte scelte musicali, soprattutto una calzante resa recitativa dei personaggi: anche Christopher Plummer Tolstoj acciaccato ma vitalistico, Paul Giamatti egoistico e perfido Chertkov, James McAvoy Valentin con la sua aria fanciullesca e sprovveduta; soprattutto Helen Mirren, non a caso premiata migliore attrice alla Festa di Roma dello scorso anno, Sofia di straordinaria immedesimazione psicofisionomica. La Stampa - Lietta Tornabuoni Leone Tolstoj, il grande scrittore di ‘Guerra e pace’, fuggì di casa a 82 anni, per evitare una crisi coniugale, nella notte del 27-28 ottobre 1910; malato, si fermò alla stazione ferroviaria di Astàpovo, ospitato dal capostazione; lì morì al mattino del 7 novembre. Da 48 anni era sposato con Sofia, il loro matrimonio era sempre stato tempestoso (lui aveva raccontato in ‘Sonata a Kreutzer’ l’odio-amore di quel rapporto). L’ultima volta però la frattura era particolarmente grave: Tolstoj intendeva lasciare in testamento tutti i propri beni (terreni, case, la villa di Jasnaja Poljana dove era nato, cresciuto, invecchiato) e i propri diritti d’autore ‘al popolo’, ossia ai seguaci della sua filosofia, i tolstoiani; la moglie esigeva che quel patrimonio restasse alla famiglia. Sono adesso nelle librerie italiane almeno tre opere che raccontano la fine di Tolstoj, episodio affannoso e struggente nella vita del narratore. Una è ‘La fuga di Tolstoi’ di Alberto Cavallari ripubblicata da Skira, breve libro molto bello concentrato sul tema della fuga: la fuga dalla morte, la fuga come rivolta o come ricerca di libertà. Un’altra è ‘Tolstoj è morto’ di Vladimir Pozner, edita da Adelphi, che ricostruisce i fatti sulla base d’un numero sterminato di documenti inediti e dei sei giorni d’agonia d’una morte in diretta con la polizia, la Chiesa ortodossa, giornalisti, fotografi, cineoperatori, familiari dello scrittore (anche la moglie, il cui arrivo venne taciuto al malato che non le fu consentito di vedere). Un’altra ancora è il romanzo di Jay Parini da cui è stato tratto “The Last Station”. Il film è centrato sul personaggio di Sofia Tolstoj, oltre che sull’episodio della fuga e morte di suo marito, così enigmatici che ancora nessuno è riuscito a comprenderne le motivazioni complesse (oppure troppo semplici). La moglie lotta ferocemente per quello che ritiene le appartenga, contro la comunità tolstoiana libertaria, povera, vegetariana, utopista e anarco-cristiana, contro le volontà del suo marito. È una nuova magnifica interpretazione di Helen Mirren, persino più straordinaria della lodata e premiata personificazione della regina Elisabetta II; anche Christopher Plummer è molto bravo nella parte di Tolstoj, mentre le scenografie perfette sono di Patrizia von Brandenstein. I pregi risultano questi e non includono il film di andamento e qualità davvero televisivi. Il Giornale di Brescia - Alberto Pesce ‘Tutto ciò che so l’ho imparato dall’amore’. Lo ha scritto Lev Tolstoj in ‘Guerra e pace’. Grafia bianca su schermo nero, lo ripete Michael Hoffman prima ancora che scorrano le immagini di “The Last Station”, preciso suggerimento allo spettatore di una chiave di lettura per il film.Sulle tracce di un libro di Jay Parini, Hoffman rievoca le ultime stagioni di vita del famoso romanziere russo nella sua tenuta di Jasnaja Poliana. Qui, ormai ottantenne, Tolstoj, tutto preso da una dottrina di austerità, solidarietà sociale, pacifismo ad oltranza, vive povero, mangia vegetariano, veste ‘come un guardiano di pecore’, con la moglie contessa Sofia - che ama anche dopo cinquant’anni di matrimonio - si fa celibe e scostante, sfoga pensieri in diari segreti, rimugina privazioni e rinunce, anche al proprio titolo nobiliare, anche a ciò che possiede.Sofia gli è sempre devota, ma sospetta che a raggirare il marito, indurlo alle rinunce, cercare di fargli firmare un nuovo testamento, sia il suo discepolo più fervido e rampante, Vladimir Chertkov, appena può con scaltro assillo in prima persona, in ogni caso attraverso il giovane e ingenuo Valentin Bulgakov che Chertkov ha mandato a Jasnaja Poljana con il compito di relazionargli ogni dettaglio e comportamento di Tolstoj. Per questo, Sofia odia e disprezza Chertkov e, irritata, appassionata, gelosa, sta addosso al marito, al punto che lui, assieme a Chertkov e Bulgakov e alla figlia Sasha, il 28 ottobre 1910 decide di fuggire via. Febbricitante, Tolstoj è costretto a fermarsi alla stazioncina di Astopovo, dove muore il 7 novembre. Ma, al di là dell’episodica di calco storico, è l’amore la falsariga su cui si struttura il film. Non solo quello di Sofia, vanitosa ma appassionata, tra vezzi e chiassosità attaccata al benessere proprio ma anche a quello del marito, gelosamente curiosa tra le carte di lui, ferocemente nemica di Chertkov, la cui immagine a suo dispetto domina persino nella loro camera coniugale. C’è anche l’amore tracimante di Valentin, nella sua ingenuità sentimentalmente travolto dalla giovane Masha, discepola tolstoiana anticonformistica e sensuale. Sono due ben diversi percorsi d’amore, cui Hoffman di continuo ama guardare in parallelo, a montaggio alternato, complementari nella loro sfaccettata diversità. Per questo, più che un fedele biopic, è un melò dì distaccata compostezza “The Last 39 SCHEDE FILMOGRAFICHE 17 LA NOSTRA VITA di Daniele Luchetti 3-4 marzo 2011 Daniele Luchetti ( Roma , 1960) ha studiato Lettere e Storia dell’Arte, frequentando la scuola di cinema Gaumont, dove ha partecipato alla realizzazione del film collettivo Juke Box nel 1985 Molto amico di Nanni Moretti, è stato prima suo attore in Bianca (1983) e poi è diventato il suo aiuto regista in “La messa è finita” (1985), passando alla regia di spot pubblicitari (Suzuki, Fiat e Galbani) ed esordendo come sceneggiatore e regista in “Domani accadrà” (1988). La pellicola gli permette di vincere il David di Donatello come miglior regista esordiente. Seguiranno, “La settimana della sfinge” (1990), dove il regista strizza l’occhio al suo autore francese preferito (Truffaut) e “Arriva la bufera” (1993). Tornerà attore, sempre per Nanni Moretti, in “Palombella rossa” (1989), mentre due anni più tardi firmerà il suo più grande successo: “Il portaborse”. La pellicola viene accolta bene in Italia (dove Luchetti vince il David per la migliore sceneggiatura) e viene addirittura osannata in Francia.Sarà poi la volta del buon risultato de “La scuola” (1995) e, dopo una piccola parentesi come attore in “Il cielo è sempre più blu” (1995) di Antonio Luigi Grimaldi, eccolo dirigere Stefano Accorsi ne “I piccoli maestri” (1998). Collaborerà con altri autori nel film collettivo “Un altro mondo è possibile” (2001), seguito dalla commedia leggera e dalla sceneggiatura brillantissima “Dillo con parole mie” (2003). Segue “Mio fratello è figlio unico” (2007) con Elio Germano e Riccardo Scamarcio. Non è da dimenticare “12 pomeriggi” (1999), memorabile cortometraggio sull’arte accompagnato da delle splendide musiche. Nel 2008 fa parte del progetto All Human Rights for All con il corto “Articolo 15 – La lettera”, realizzato in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani. Torna dietro la macchina da presa nel 2010 con “La nostra vita”, unico italiano in concorso a Cannes. Interpreti: Elio Germano (Claudio), Raoul Bova (Piero), Isabella Ragonese (Elena), Luca Zingaretti (Ari), Stefania Montorsi (Liliana), Giorgio Colangeli (Porcari), Alina Madalina Berzunteanu (Gabriela), Marius Ignat (Andrei), Awa Ly (Celeste), Emiliano Campagnola (Vittorio) Genere: Commedia Origine: Italia Soggetto: Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Daniele Luchetti Sceneggiatura: Sandro Petraglia, Stefano Rulli, Daniele Luchetti Fotografia: Claudio Collepiccolo Musica: Franco Piersanti Montaggio: Mirco Garrone Durata: 100’ Produzione: Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz per Cattleya/Babe Films/in collaborazione con Rai Cinema Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: Claudio, operaio edile sui trenta anni, affronta un evento impossibile da immaginare: l’amata moglie Elena muore di parto nel dare alla luce il terzo figlio. Di fronte ad un lutto impossibile da elaborare, con un neonato e altri due ragazzini da accudire, Claudio reagisce con la decisione di dedicarsi ad avere il meglio, per se e per la propria famiglia. Ci vogliono molti soldi, e per questo si caccia in affari edilizi che ben presto si rivelano troppo rischiosi per lui. Seguono debiti, ricatti, illegalità. Quando, toccato il fondo, riesce a risalire, Claudio capisce che nel momento del bisogno gli unici a stargli vicino sono stati il fratello e la sorella, e che ora la vicinanza dei figli piccoli é la cosa più importante per poter affrontare il futuro. VALUTAZIONE: Siamo nella Roma contemporanea, meglio nella periferia, che Luchetti disegna come un luogo a parte, lontano dalla città tradizionale. Per Claudio, Elena rappresentava l’unico punto valoriale possibile. Dopo la caduta nella trappola dell’ “avere”, l’uomo si risolleva e si lascia andare nel finale al recupero della famiglia come orizzonte di equilibrio. Va detto che il regista privilegia più il taglio antropologico che quello etico. Nel protagonista infatti, dice di aver rappresentato: “Un italiano come tanti, che fa cose disoneste, imbroglia e sfrutta gli altri”. E Germano: “Uno spacciatore truce, ma solo nell’aspetto, di un’Italia non immorale ma amorale”. 40 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Mattino - Valerio Caprara Elio Germano, diventato celebre presso le persone che del cinema di solito se ne sbattono, ha dichiarato a Cannes di dedicare il premio di migliore attore ex aequo agli italiani che sono molto migliori della loro classe dirigente (ma quale, quella di sempre o quella degli ultimi 5, 10, 15 anni? E solo di quella nazionale o anche di quella regionale o municipale, metti della Campania come della Puglia, del Piemonte come della Toscana?). Intanto in “La nostra vita” interpreta con partecipata veemenza il ruolo di un italiano non proprio esemplare, portatore di comportamenti equivoci e pronto a tuffarsi in un mondo di compromessi e d’illegalità; un protagonista sin troppo carico sul piano simbolico, visto che deve incarnare l’inestricabile mix d’ingenuità e determinazione, onestà e furfanteria che caratterizzerebbe il ceto ex proletario in bilico tra lavoro nero e imprenditoria fai-da-te. Si può dire subito che il film di Daniele Luchetti non passa inosservato, ha una bella grinta e, soprattutto nella prima parte, dispone bene i suoi personaggi sullo sfondo di una Roma nient’affatto glamour ma neanche miserabile, un’enorme distesa di dignitosi conglomerati dove la nuova periferia senza identità cerca di mascherarsi da appagato quartiere residenziale. Claudio (Germano), marito e padre felice, è il perno dello spaccato drammaturgico perché proprio a lui capita la disgrazia che fa crollare il castello di carte sociale scatenandolo in un’ansia di riscatto basata sui soldi e i beni da mettere a tutti i costi disposizione dei figlioletti. Più che di neo-neorealismo, si tratta di un taglio teso, sincopato, attento, incollato ai volti e ai gesti come per catturarne il senso profondo, per cogliere nella loro apparente casualità il leitmotiv di paura e solitudine urbane, un po’ sulla linea del cinema indipendente newyorkese a cavallo del 1970 che ha il suo nume tutelare in John Cassavetes. A poco a poco, però, il film inizia a spegnersi, a ripetersi, a ritrovarsi addosso l’ingombro di una sgradevolezza che doveva restare a carico di Claudio, della sorella in cassa integrazione (Montorsi), del fratello scapolo (Raoul Bova) e dell’inquietante vicino di casa Ari (Zingaretti). La sceneggiatura del duo storico Rulli-Petraglia esagera nel suggerire una serie di sottolineature inutili, pedanti e a tratti persino grottesche (il ragazzo rumeno che fa la lezioncina all’italiano cinico) che non servono a causa della loro sbrigatività didascalica: in Italia impera il consumismo, il culto dell’apparenza dilaga, la classe operaia non è più quella di un tempo e, anziché leggere i giornali o impegnarsi in politica, preferisce i raid di fine settimana nei centri commerciali. Il finale consolatorio rischia di lasciare tutti gli spettatori scontenti: i furiosi perché non picchia duro come “Draquila”, i normali perché la troppa carne a cuocere sembra ancora cruda e anche un po’ bruciacchiata. porata in una storia di sapore realistico scritta da Luchetti con la collaborazione di Petraglia e Rulli, benissimo interpretata da attori adatti alla loro parte. Insomma l’attento studio di un contesto operaio che il cinema italiano si meritava con ‘clandestini’ anche arrabbiati, intrighi per mettere insieme i soldi che paiono la misura di tutte le cose come suggerisce la ragazza extracomunitaria che poi consolerà il fratello del protagonista, il bello e credibile ritratto di un ‘eroe del nostro tempo’ (non un cinico alla Sordi ma un uomo provato), un gran rispetto della forza della famiglia e della necessità dell’amicizia, i debiti ai parenti alla fine pagati e, a risarcimento, la piena riconciliazione del protagonista con i figli. Claudio dunque che non rifiuta sé stesso, è pronto a riprendersi la vita che pareva essergli sfuggita. Non rinuncia, come tanti, alla fiducia nel futuro. Il Tempo - Gian Luigi Rondi Ancora famiglie per Daniele Luchetti. Secondo una voga, del resto, ormai abbastanza diffusa nel cinema italiano. Questa volta, però, a differenza di “Mio fratello è figlio unico” che si riferiva al passato, o comunque agli anni roventi del dopo ‘68, con uno sguardo decisamente rivolto al presente, anzi all’attualità di questi nostri anni così contraddittori e turbati. Eppure si comincia con un idillio; Claudio ed Elena, giovani sposi con due figli piccoli, che si amano teneramente. Con un solo problema, la scarsità di denaro perché lui lavora in un’impresa edile dove, nonostante un gestore corrotto, non cede un solo momento alle lusinghe di comportamenti disonesti e redditizi. Ma ecco che tutto si rovescia. La moglie muore di parto lasciandogli tra le braccia un terzo bambino e Claudio, per rifarsi e vincere il suo lutto, decide di far molti soldi ricorrendo addirittura a un ricatto per costringere il gestore dell’impresa a concedergli in subappalto certi lavori nel cantiere. Contrae molti, debiti, sfrutta cinicamente con compensi in nero degli indifesi operai quasi tutti extracomunitari, ma, pur agli inizi vincendo, tira troppo la corda e rischierebbe il tracollo se non intervenissero parenti ed amici a metterlo in condizione di riprendersi. Sempre, però, passando sopra a qualsiasi principio di onestà. Lo lasciamo così, senza che intenzionalmente ci si dica se, mentre torna a godersi l’affetto dei figli, una presa di coscienza possa metterlo in futuro su strade più giuste. Luchetti il testo se l’è scritto con Rulli e Petraglia e, pur dando spazi, con tutta l’attenzione possibile, a quel radicale mutamento di intenzioni e di gesti del protagonista, gli ha costruito attorno, con accenti colorati e felici, una galleria di personaggi solo in apparenza secondari, ma capace ciascuno di dare il suo contributo al procedere dell’azione. Con pagine in cui poi la regia, quasi sempre guidata dalla macchina a mano, ha mostrato di saper alternare i ritmi più affannati e spesso anche angoscianti a pause di intensa emozione. Come la scena muta e distante in cui Claudio apprende la morte della moglie o quella, concisa ma intensa, che lo induce a svelare a un giovane sempre pronto a fidarsi di lui il suo colpevole silenzio su un incidente nel cantiere che aveva provocato la morte di suo padre. Qualche scompenso narrativo e una certa insistenza in situazioni solo marginali sono comunque riscattati da una interpretazione sempre salda e felice a cominciare da quella di Elio Germano, un protagonista di una gestualità e di una mimica mobilissime e prodighe di espressioni anche forti. Fra gli altri, Isabella Ragonese, la moglie, Raoul Bova, un fratello, Giorgio Colangeli, il gestore, Luca Zingaretti, Stefania Montorsi. Tuffi guidati con meditata sapienza. Vita Pastorale - Francesco Bolzoni Diretto da un altro regista ‘in crescita’, Daniele Luchetti, “La nostra vita” descrive un credibile mondo operaio: un uomo è morto nel cantiere di un piccolo imprenditore cadendo nel vuoto di un ascensore. Una disgrazia che può rovinare una vita, in apparenza felice, con due figli simpatici, la moglie incinta, i parenti affettuosi. E, ad avvicinare Claudio (il bravo Elio Germano) al grado zero, ci si mette la morte per parto della donna. Il neoimprenditore vi reagisce in modo insolito: al funerale canta una canzone che condivideva con la compagna. Una soluzione surreale che, assieme ad altre annotazioni dello stesso timbro stilistico, sfida il tono narrativo impresso a una molto attendibile cronaca dei nostri giorni. Un colpo d’ala. Parecchio commovente, bene incor- 41 SCHEDE FILMOGRAFICHE 18 IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI di Juan José Campanella 10-11 marzo 2011 (1959 Buenos Aires - Argentina). Regista televisivo (Dr. House, la più popolare serie del mondo, e Law & Order, un cult del poliziesco contemporaneo), italiano da parte di padre. Nel 2001 il suo “Il figlio della sposa” è stato candidato all’Oscar; quest’anno “Il segreto dei suoi occhi” lo ha vinto. Miglior film straniero. E secondo incasso di sempre del cinema argentino. Così in una intervitsa: «Sono cresciuto con il mito del cinema americano anni Settanta, le storie di denuncia, profonde, rotonde. Ho capito che volevo fare il regista dopo aver visto “Quel pomeriggio di un giorno da cani”. Ho studiato regia e mi sono trasferito a Los Angeles. Ma quel cinema, per Hollywood, è storia. Non interessa più nessuno. I miei progetti di film sono rimasti tutti stipati in cantina. E allora, quando ho capito che avrei potuto spendere la mia esperienza televisiva e il mio nome, ho deciso di tornare a casa per fare film veri». Interpreti: Ricardo Darín (Benjamín Espósito), Soledad Villamil (Irene Menéndez Hastings), Pablo Rago (Ricardo Morales), Javier Godino (Isidoro Gómez), Guillermo Francella (Pablo Sandoval), José Luis Gioia (Ispettor Báez), Carla Quevedo (Liliana Coloto), Rudy Romano (Ordóñez), Mario Alarcón (Juez Fortuna Lacalle), Alejandro Abelenda (Mariano), Sebastián Blanco (Tino), Mariano Argento (Romano) Genere: Thriller Origine: Argentina Soggetto: Eduardo Sacheri Sceneggiatura: Eduardo Sacheri Fotografia: Félix Monti Musica: Juan Federico Jusid Montaggio: Juan José Campanella Durata: 129’ Produzione: Juan José Campanella, Gerardo Herrero, Mariela Besuievsky per Tornasol Films, Haddock Films, 100 Bares, Telefe, Tve, Canal+ Distribuzione: Lucky Red SOGGETTO: Un tempo impiegato al palazzo di giustizia di Buenos Aires, Benjamin, oggi pensionato, si sente preso dalla voglia di scrivere e, a tal fine, recupera uana vicenda relativa ad un caso di omicidio accaduto venticinque anni prima. L’aveva vissuto in prima persona e, accanto a lui, c’erano la sua superiore Irene e il suo collega/amico Sandoval. Le indagini sull’assassinio di una bellissima giovane da poco sposata erano state dichiarate chiuse dopo l’arresto di un uomo, poi liberato: una soluzione non del tutto convincente. In flashback, Benjamin ricostruisce i fatti, e incontra di nuovo Irene, di cui da sempre é innamorato senza aver mai trovato il coraggio di rivelarsi. La scoperta di nuovi elementi da ragione a Benjamin… VALUTAZIONE: Alla base c’è un romanzo di Eduardo Sacheri, che ha anche partecipato alla sceneggiatura. Dice Campanella: “Non lo considero un film ‘noir’. Il piatto forte é un amore non dichiarato durato anni, la frustrazione e il vuoto percepito dai personaggi principali. Il genere ‘noir’ é solo il vassoio sul quale la pietanza principale veniva servita. La memoria mi affascina...”. Il menù che ne viene fuori é, va detto, intrigante ed emozionante. Con grande misura il regista tiene alto il tono di una vicenda che ha appunto la cornice del thriller, ma si insinua con decisione nei territori del romanticismo, offre spazio ad una pungente ironia e con pochi, azzeccati cenni parla del doloroso periodo dell’arrivo dei generali al potere in Argentina. Non trascurando una inedita passione per il calcio che aiuta a scoprire il colpevole. Un film tanto facile nella lettura quanto denso nei contenuti, premiato con l’Oscar 2010 per il miglior prodotto in lingua non inglese. 42 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Manifesto - Silvana Silvestri In un film di Campanella ci saranno sempre particolari che a una prima visione sfuggiranno, altri momenti che ci piacerà vedere più di una volta: hanno un fascino popolare i suoi film perché (come ci racconta il regista premio Oscar nell’intervista su Alias di sabato prossimo), si ispira al cinema italiano e al cinema americano degli anni ‘70. Forse è proprio questo elemento che lo rende diverso dagli altri registi della sua generazione, quelli del nuovo cinema argentino - Burman, Trapero, Martel per citare quelli che utilizzano come lui, un tipo di produzione industriale. Come nel cinema italiano dei tempi di Gassman e Manfredi, anche a lui piace lavorare con i grandi attori. In particolare ne ha scelto uno, Ricardo Darín, come protagonista ideale di tutti i suoi film (‘El hijo de la novia’, ‘La luna de Avellaneda’), uomo dal presente affaticato, talvolta disperato, che mette in moto un meccanismo di risalita per non affondare grazie alle sue doti di umanità e alla luce che balena nei suoi occhi. Anche se il titolo di questo film non allude precisamente a Darín, questo attore possiede un carisma in cui il pubblico argentino si identifica, così come poteva farlo in Hector Alterio. Il pubblico può trovare in lui parecchi motivi di identificazione. Si entra nella carne viva della società con temi come la corruzione, il sentimento di vendetta e del potere, storia d’amore a parte. “El secreto de sus ojos” è ambientato per lo più in tribunale, che in qualche modo scandisce i tempi burocratici dell’azione. Fin dal 1974 Benjamín Espósito, funzionario del ministero della giustizia segue un caso di omicidio rimasto insoluto. Ha perfino scritto un romanzo, visto che, andato in pensione, il suo legame con il caso non è solo di carattere professionale, ma anche sentimentale, intrecciato a una storia d’amore rimasta in sospeso, nei confronti dell’irraggiungibile Irene, magistrato a capo dell’ufficio, donna di illustre famiglia come si intuisce dal cognome (Menéndez Hastings), che ha studiato negli Stati uniti e sposerà un uomo alla sua altezza (mentre lui è discendente da semplici immigrati italiani). I binari del romanzo, della vicenda dell’inchiesta, della storia d’amore, del trentennio trascorso, si incrociano su vari piani di lettura, pure se l’indagine sembra prendere il sopravvento. Se questo abbia a che fare con l’elaborazione della memoria che ha coinvolto tutto il continente latinoamericano e l’Argentina in modo eclatante per i processi ai responsabili di genocidio a noi sembra evidente, ma per il regista è un tema da cui non è partito intenzionalmente nello scrivere la sceneggiatura tratta dal libro di Eduardo Sacheri, suo abituale cosceneggiatore. Né si potrà svelare qui la trama, ma certo ha a che fare con tutto il complesso meccanismo di cancellazione del passato avvenuto nel paese e con la vigile persecuzione dei responsabili e non di un solo omicidio. Ha a che fare con il rigore morale di un paese che attraverso il suo protagonista sentiamo non aver perso dignità ed ha cercato di rialzarsi dopo la dittatura e dopo il crollo dell’economia. Per continuare a vivere infatti è più facile evitare di pensare al passato. Ci sembra un valore in più del film che procede ora romantico, ora in piena suspence, sempre con interpreti in grado di riempire lo schermo con la loro presenza. Oltre a Ricardo Darín, Soledad Villamil (Irene), interprete di “Un oso rojo” di Adrian Caetano e di “El sueño de los heroes” di Sergio Renan, principe della malinconia, regista sentito distante dalla nuova generazione, con l’eccezione di Campanella, di cui ritroviamo qui qualche atmosfera e perfino di “Un muro de silencio”, film militante di Lita Stantic, regista e produttrice. E Javier Godino e Guillermo Francella, l’amico fedele che nei film di Campanella non manca mai. valanga di informazioni che a volte confonde e rimescola tutto in un eterno presente. Su questo terreno il cinema ha ancora molte carte da giocare, specie in paesi che con la memoria hanno un conto aperto come l’Argentina. “Il segreto dei suoi occhi”, Oscar come miglior film straniero in barba a due capolavori come “Il nastro bianco” e “Un prophète”, è un perfetto esempio di questo lavoro che usa con abilità i generi (poliziesco, mélo) per scavare nella memoria.Protagonista è il maturo Esposito (un magnifico Ricardo Darìn), funzionario in pensione del tribunale di Buenos Aires che vuole scrivere un romanzo su un delitto di 25 anni prima da cui è ancora ossessionato (occhio alle date: il delitto è della primavera 1974, l’azione dunque si divide fra quel periodo e il 1999). Cosa c’era dietro lo stupro e l’omicidio di una giovane bellissima e senza storia? Perché né Esposito né l’affascinante magistrato per cui lavorava e che amava in silenzio, l’altera Irene (la toccante Soledad Villamil), riuscirono a sbattere in galera il colpevole? E dove sarà il marito della vittima, che continuò a cercare da solo l’assassino? Trattandosi di anni 70 e Argentina, scatta l’associazione più ovvia: giunta militare, desaparecidos, voli della morte. Sbagliato! Perché Peron muore nel luglio ‘74, il golpe è del marzo’76, dunque la parte principale del film si svolge nel periodo d’incubazione della dittatura. Un periodo semicancellato dalla valanga di orrori successiva, tanto che oggi gli stessi argentini, specie i più giovani, ne hanno scarsa cognizione. Campanella rievoca quegli anni oscuri proiettando l’inchiesta di Esposito, del suo aiutante ubriacone e della loro bella capoufficio, contro lo sfondo agghiacciante di un paese che stava sprofondando nell’orrore ma non osava dirselo. Sono gli anni in cui il Potere reclutava malviventi comuni e la famigerata AAA (Alleanza Anticomunista Argentina) rapiva e trucidava impunemente ‘sovversivi’. Si dice persino che Peron sia morto per mano di uno di questi delinquenti, guardia del corpo e amante di sua moglie Isabelita (a questo allude una scena del film, da non svelare). Campanella è bravissimo a evocare tutto questo giocando sulle atmosfere, gli uffici divorati dalle scartoffie, il collega improvvisamente e apertamente minaccioso, le scene madri centellinate con maestria (c’è perfino un imprevedibile momento ‘hard’). Qualcuno non gli perdonerà l’epilogo a sorpresa o l’addio alla “Dottor Zivago”. Ma basterebbe la scena dell’ascensore a riconciliarci con un cinema insieme tradizionale e potente. Dopo tanti ‘cattivi’ da 007, avevamo dimenticato cos’è la paura al cinema. Campanella ce lo ricorda con schietta brutalità. È una lezione anche questa. Panorama - Piera Detassis L’ombra del passato, il disagio del tempo perduto, il peso inevaso della colpa. Come in un classico noir, tutto questo è raccontato benissimo nel film argentino di Juan José Campanella, che a sorpresa ha strappato l’oscar al favorito “Il nastro bianco” di Michael Haneke. Benjamin (Ricardo Darin), ex investigatore della squadra criminale, e il giudice Irene (Soledad Villamil) si rincontrano 25 anni dopo avere indagato insieme, nel 1974, su un brutale caso di omicidio e violenza carnale a Buenos Aires. L’uomo non è mai stato convinto della colpevolezza dei due arrestati, l’indagine ricomincia e il feeling taciuto ma palpabile tra i due bravissimi protagonisti riemerge in misteriosi, intensi sguardi. Si intuisce che la dittatura militare dell’epoca non è estranea al crimine, ma nel mirino del regista c’è soprattutto il magma complesso dei sentimenti e il film ondeggia fra passato e presente con eleganza fluida e ombrosa. Una regia da 10 e lode che si esprime a pieno nel labirintico inseguimento dentro lo stadio affollato, specchio feroce del tumulto del tempo che non fa sconti e girato con virtuosismo all’ultimo respiro. Il Messaggero - Fabio Ferzetti Una volta il peggior nemico della memoria era il tempo. Oggi è la 43 SCHEDE FILMOGRAFICHE 19 AFFETTI & DISPETTI - La nana di Sebastián Silva 17-18 marzo 2011 Nato a Santiago del Cile nel 1979, dopo aver frequentato una prestigiosa scuola cattolica, Silva studia per un anno alla Scuola del Cinema del Cile. Di conseguenza, dopo aver lasciato la scuola di cinema, va a Montreal a studiare animazione, finendo però a lavorare in un negozio di scarpe. Nel frattempo, durante un suo spettacolo di illustrazione, un amico lo convince a cercare Spielberg in persona per presentargli un progetto. Così decide di andare a Hollywood, ma la missione si rivela un autentico fallimento. Inizia così due ulteriori progetti musicali, Yaia e Los Mono che in un secondo momento sarebbero stati acquistati per la distribuzione dalla Sonic360 e pubblicati in America e Inghilterra. A New York scrive la sceneggiatura del suo primo film “La Vida me Mata”. Al suo ritorno in Cile, registra il suo album e produce il film “La Vida me Mata”. Scrive, inoltre, una sceneggiatura sul suo viaggio a Hollywood e successivamente “Affetti e dispetti”, che viene prodotto quasi immediatamente al termine della scrittura, nel febbraio del 2008. Interpreti: Catalina Saavedra (Raquel), Claudia Celedón (Pilar), Mariana Loyola (Lucy), Alejandro Goic (Mundo), Anita Reeves (Sonia), Delfina Guzmán (Nonna), Andrea García-Huidobro (Camila), Mercedes Villanueva (Mercedes), Agustín Silva (Lucas), Darok Orellana (Tomás), Sebastián La Rivera (Gabriel), Luis Dubó (Eric) Genere: Drammatico Origine: Cile Soggetto: Sebastián Silva Sceneggiatura: Sebastián Silva, Pedro Peirano Fotografia: Sergio Armstrong Musica: Pedro Soubercaseaux Montaggio: Danielle Fillios Durata: 94’ Produzione: Gregorio González Distribuzione: Bolero Film SOGGETTO: Santiago del Cile, oggi, una tranquilla famiglia borghese, padre, madre, quattro figli di varia età. Da oltre venti anni Raquel è la fidata cameriera di casa. Quando comincia ad accusare forti attacchi di emicrania, la signora decide di cercare un’altra donna per aiutarla. Raquel è contraria e riesce a far scappare le prime che si presentano. Più paziente e disponibile, Lucy riesce invece a reagire con ironia ai comportamenti ostili di Raquel. Così le due diventano amiche, e Lucy la invita per il Natale a casa della sua famiglia. Al ritorno, Lucy comunica l’intenzione di lasciare la casa per tornare a vivere con i parenti. VALUTAZIONE: Si tratta di uno spaccato in interni, con un andamento calmo, disturbato da alcuni avvenimenti che però non portano mai a conseguenze forti o traumatiche. Il dramma c’è ma non emerge. Il fatto è che il copione, ben messo in scena da una regia sciolta e scorrevole, é sempre sul punto di accostare qualche passaggio importante ma all’ultimo curiosamente se ne ritrae, come se non volesse confrontarsi con temi importanti. Il chiuso della bella casa con piscina, e l’assenza totale di riferimenti esterni a lungo andare diventano un limite per una vicenda sincera ma limitata e quasi impalpabile. L’autore sceglie un tono da dramma intimista e vi resta coerente fino alla fine. L’approccio alla realtà borghese cilena resta comunque interessante, il ventaglio di sentimenti, per quanto appena abbozzato, é vivo e condotto con attenzione. 44 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Manifesto - Mariuccia Ciotta La nana del sottotitolo non è una donna bassa, ma una “tata”, una domestica babysitter, ed è anche il titolo originale del film cileno, che in italiano diventa “Affetti&Dispetti”. Un percorso a ostacoli per arrivare a un’operetta originale, proveniente dal Sundance, dove ha vinto come miglior film straniero, e poi di passaggio in concorso al festival di Torino, che ha premiato l’attrice protagonista, Catalina Saavedra, Raquel, la tata. Una quarantenne arcigna, infaticabile e restia a farsi coinvolgere dalla famiglia dove lavora da più di vent’anni. Tanto grandi e piccini la adulano, la circondano di attenzioni, la chiamano a tavola, la festeggiano con una torta di compleanno, tanto lei è sfuggente e sospettosa. In fondo, direbbe Mike Bongiorno, è solo una ‘serva’, altro che ‘collaboratrice domestica’ e tutto questo miele le suona fasullo. Tanto più che deve star dietro a una nidiata di bambini e adolescenti, e non tutti le garbano. Il film accumula tensione, la tata fa sparire qualche oggetto, distrugge un modellino di nave, hobby del ‘padrone’, si rifugia nella sua stanza off limits, perseguita la ragazzina più grande. E poi i movimenti furtivi nella grande villa, la solitudine della donna, le telefonate alla madre lontana, che non vede mai... Il messicano Arturo Ripstein farebbe scorrere il sangue in questa storia di vita borghese osservata dal punto di vista sghembo della cameriera Raquel. Ma il trentenne cileno Sebastian Silva, al secondo lungometraggio (“La vida me mata”, 2007, l’esordio) sceglie la commedia sentimentale, la compassione per il suo personaggio avvolto nell’ipocrisia, diseguale in un mondo che finge di ignorare le barriere sociali. Tutti amano Raquel, ma lei sembra pronta a eliminarne qualcuno, cova qualche segreto, moltiplica feroci dispetti, e chiude fuori di casa a ripetizione le nuove cameriere, assunte per darle aiuto. Insomma, una potenziale devota assassina che fa lievitare la suspense in un gioco a rimpiattino tra le mura domestiche, tanto che ci si aspetta una imminente vendetta metaforica a danni dell’opulenta borghesia cilena. Il detour narrativo si chiama Lucia, l’ennesima cameriera chiamata per affiancare l’esaurita Rachel, sempre più affetta da atroci mal di testa, e ridotta al collasso per stress domestico. Lucia è radiosa, amabile e soprattutto condivide con la tata lo stesso status. La fa sentire amata non più per convenienza, la strappa alla sua ossessione maniacale per il lavoro. Quella casa non è il suo regno ma la sua prigione. Nominato ai Golden Globe, il film, essenziale, minimalista nello scavare variazioni psicologiche della quarantenne senza fascino, devia e volge verso un finale confortante, l’amore scalderà il cuore duro della Nana. a scambiare, come la Raquel di “Affetti & Dispetti” (il titolo italiano più brutto e traditore dell’anno, ma anche il manifesto non scherza), la familiarità concessa dai suoi padroni con una famiglia vera. È una dinamica ambigua che in Italia conosciamo bene perché tipica dei paesi cattolici. Finché funziona fa da ammortizzatore sociale. Se degenera produce, oltre che ingiustizia, nevrosi e infelicità a catena (come dire, dalla lotta di classe al conflitto interiore). Premiato in mezzo mondo, dal Sundance a Torino, il bel film del cileno Sebastian Silva scava in una di questa nevrosi con finezza e ironia sorrette da una qualità invidiabile di scrittura e interpretazione, ovvero da personaggi così ben disegnati che ci sembra di conoscerli da sempre e insieme di non averli mai visti (e capiti) meglio. A servizio da più di vent’anni dai benestanti Valdés, l’ombrosa Raquel è meno di una parente e più di una governante, ma soprattutto è una persona sola e spaventata. Dunque disposta a tutto per mantenere il potere. Potere sui ragazzi, che sente un po’ suoi (tranne la detestata primogenita, troppo grande e forse troppo carina). Potere sugli orari, le consuetudini, le mansioni. Potere su quella bella villa con piscina, di cui conosce ogni minimo anfratto (dettaglio decisivo: è la casa in cui è cresciuto il regista, che dedica il film a due sue “nane”). A farne le spese sono soprattutto le aiutanti che la padrona di casa si ostina ad assumere per darle una mano. Senza immaginare che è lei, Raquel, a far loro la guerra. Salvo poi crollare svenuta per lo stress e la fatica. Fino a quando una di queste aiutanti più fantasiosa (e risoluta) delle altre, adotta una strategia nuova. Come un esperto di judo, non reagisce alle provocazioni di Raquel ma le schiva, facendo in modo che sia lei a sbatterci contro. Come uno psicoterapeuta, intuisce il suo disagio e anziché combatterla la accoglie, le offre comprensione, calore e un modello di vita alternativo. Impossibile dire di più senza rovinare il piacere della visione, ma “La nana” ha almeno un’altra qualità rara, specie oggi. Un ottimismo che non suona mai ingenuo o semplificatorio, ma è un esercizio di intelligenza e amore per i personaggi che scalda il cuore. La Stampa - Alessandra Levantesi Ha tenuto in ordine, pulito, strofinato la villa che é grande, ha visto nascere i bambini che sono quattro, li ha accuditi, vestiti, nutriti: da ventitré anni a servizio presso la stessa famiglia, ora Rachele ne compie quarantuno e una famiglia sua non ce l’ha. Quei borghesi agiati e civili ai quali ha dedicato le sue cure, e che la ricambiano con affetto, restano in definitiva degli estranei. Del dramma di solitudine e di identità che la macera dentro, la donna non è consapevole: però ha frequenti mal di testa, capogiri, si dimostra patologicamente ostile verso la primogenita che sta sbocciando alla vita; e fa guerra senza esclusione di colpi alle domestiche che la padrona di casa si azzarda ad assumere per aiutarla. Molto riuscito questo ritratto di cameriera prigioniera del suo ruolo sociale che il regista cileno Sebastian Silva ben coadiuvato dallo sceneggiatore Pedro Peirano, ha imbastito sul filo dell’allarme temperando le note cupe con l’arma di una sottile ironia. Senza cadere nel patetico o scivolare nella violenza, anche grazie alla recitazione asciutta ed essenziale di Catalina Saavedra: straordinaria attrice che di Rachele riesce a fare personaggio emblematico e al contempo autentico essere umano. Il Messaggero - Fabio Ferzetti Una volta si chiamava “la serva”. Poi la parola diventò troppo cruda e si passò a governante, cameriera, domestica, donna di servizio, fino al burocratico colf (anche se ormai a Roma tutti dicono con larvato razzismo ‘la filippina’). Ma il termine migliore per indicare la protagonista di questo impeccabile “La nana” (che in Cile sta per “tata”) è proprio domestica: formale, rispettoso, corretto, eppure distante.Una specie di membro esterno della famiglia che per farne parte svolge i lavori più umili. Una figura domestica, appunto, cioè appartenente alla casa, che baratta tempo e forza lavoro con una parvenza di calore famigliare. Fino 45 SCHEDE FILMOGRAFICHE 20 CITY ISLAND di Raymond De Felitta 24-25 marzo 2011 Sceneggiatore e regista di professione, musicista jazz per amore. Conosciuto ai più come autore di commedie brillanti, Raymond De Felitta nasce nel 1964 a New York. Dopo il diploma in regia, riceve il prestigioso premio Academy Award for Live Action Short Film per il cortometraggio “Bronx Cheers”. Nel 1995 scrive e dirige “Cafe Society”: il film si fa notare dalla critica ma non ottiene il successo sperato tra il pubblico. Continua a perfezionarsi nella scrittura, collaborando con Myra Byanka per la realizzazione “L’ombra del dubbio” (1998) ,ma non trascura la regia, nella quale si cimenta ancora una volta con “Two Family House” (2000). Il film vince l’Audience Award al Sundancce Film Festival. Gira poi “The Thing About My Folks” (2005). In seguitosi dedica alla musica jazz. Dopo alcuni anni di ricerca monta il documentario “This Autumn” (2006), riflessione sugli aspetti privati della carriera artistica di Jackie Paris. Nel 2009 ritorna alla ‘fiction’ e scrive e dirige “City Island”: segreti, bugie e tradimenti che preludono al film successivo, “Married and Cheating” (2011), dove l’infedeltà è il filo conduttore dell’intreccio che vede tre coppie in crisi amorosa. Interpreti: Andy Garcia (Vince Rizzo), Alan Arkin (Michael Malakov), Julianna Margulies (Joyce Rizzo), Emily Mortimer (Molly Charlesworth), Steven Strait (Tony Nardella), Ezra Miller (Vince Jr.), Dominik García-Lorido (Vivian Rizzo), Sharon Angela (Tanya) Genere: Commedia/Drammatico Origine: Stati Uniti d’America Sceneggiatura: Raymond De Felitta Fotografia: Vanja Cernjul Musica: Jan A.P. Kaczmarek Montaggio: David Leonard Durata: 100’ Produzione: Raymond De Felitta, Andy Garcia, Zachary Matz Lauren Versel per Cineson Productions/Medici Entertainment in associazione con Lucky Monkey Pictures/Gremi Film Production/Filmsmith Productions Distribuzione: Mikado SOGGETTO: A City Island, una fetta del Bronx nella baia di New York, Vince Rizzo fa la guardia carceraria e non ha avuto il coraggio di dire alla moglie Joyce che nel tempo libero segue un corso di recitazione. In casa ci sono anche la figlia maggiore Vivian e il figlio adolescente Vinnie. Un giorno, esaminando da vicino il detenuto Toni Nardella, Vince capisce che si tratta di suo figlio, avuto venti anni prima da una donna più grande dalla quale era scappato. Vince ne prende la custodia e, senza dire niente, lo porta a casa. Da quel momento equivoci, sotterfugi, colpi di scena scandiscono la vita del gruppo. Alla scuola Vince conosce Molly; a casa Joyce resta sola con Tony; cacciata da scuola, Vivian per rifarsi i soldi della borsa di studio fa la spogliarellista; Vinnie ha una simpatia per le donne grasse. Tutto va avanti all’insaputa degli altri, fino a quando i nodi vengono al pettine…… VALUTAZIONE: Con fin troppa evidenza, il tema centrale é quello della famiglia: nella quale spesso é difficile parlarsi, facile dire parole a sproposito, complicato trovare il momento giusto per essere capiti. Tuttavia gli ostacoli, anche i più spigolosi, si possono appianare, purché resti vivo quel sentimento di fondo fatto di umiltà, rispetto, amore reciproco. Va detto che il copione è scritto bene, con attenzione e scorrevolezza, riuscendo a toccare molte sfumature (il quartiere come una piccola città; la recitazione come rottura della barriera tra vero e falso; i rischi dell’uso del computer per gli adolescenti...), sempre tenendo in primo piano l’irrisolto rapporto padrefiglio (tema di punta nel cinema americano attuale). La bravura degli attori e la spigliatezza della regia rendono il racconto denso di notazioni e insieme vivace. 46 SCHEDE FILMOGRAFICHE L’Eco di Bergamo - Achille Frezzato A City Island, una delle isole del la baia di New York, un tempo sede cantieri navali e poi di industrie le fate alla pesca, vivono Vince Rizzo (Andy Garcia), una guardia carceraria che sogna di diventare attore, ed i suoi familiari: la moglie Joyce (Juliann Margulies), che, costantemente aggressiva, si sente trascurata e sospetta del marito per le sue uscite serali (frequenta un corso di recitazione), ed i figli, Vivian (Dominik Garcia Lorido), spogliarellista in un locale notturno da quando, all’insaputa dei suoi, è stata allontanata dal college, e Vinnie (Ezra Miller), adolescente insopportabile con l’ossessione per le donne obese. in questa famiglia, dove tutti fumano di nascosto e si raccontano bugie, entra a far parte il ventenne Tony Nardella (Steven Strait), il frutto di una lontana relazione di Vince, da lui scoperto fra i detenuti e messo in libertà sotto sua tutela. È, per gran parte, quanto racconta il cineasta indipendente Raymond De Felitta (New York, 1964) in “City Island” (ne è coproduttore, sceneggiatore e regista), un melodramma sui rapporti all’interno di un nucleo familiare, complicati da segreti, speranze, litigi, illusioni, contrarietà e frustrazioni. Una commedia dolceamara, comunque gradevole grazie all’ambientazione, nel corso della quale l’intreccio di equivoci, menzogne e silenzi prepara il finale rivelatore.Un film sincero dai dialoghi quasi sempre efficaci ed incalzanti, in cui a scene divertenti succedono momenti tesi e pagine commoventi e alla completa riuscita nuoce il tratteggio segnato ‘da sottolineature facili e ridondanti’ della personalità dei figli del protagonista. Un film dal tocco brioso che fa riflettere sul necessario distacco dalle proprie ambizioni nell’accettazione della realtà non sempre entusiasmante, concedendosi a compromessi sempre onorevoli, se decisi nel rispetto degli altri, dei loro sentimenti, delle loro aspirazioni. rispetto.Come avviene in casa Rizzo, dove tutti, sereni in apparenza, hanno qualche segreto a parte. Papà Vince (Andy Garcia), guardia carceraria, in un giovane carcerato Tony (Steven Strait) ha riconosciuto un suo figlio e con la scusa di una educativa tutela di lavoro, se l’è portato in famiglia. Inoltre, ha una inconfessata passione per il teatro, in casa appena può si legge biografie di Marlon Brando, con la scusa di una partitina a poker va a scuola di recitazione, frequenta provini, ama confidarsi con una comprensiva collega di corso Molly (Emily Mortimer), che a sua volta ha un burrascoso passato da nascondere. E mamma Joyce (Julianna Margulies) nella sua inquietudine casalinga finisce per turbarsi per Tony.Segreti nascondono anche i figli: l’adolescente Vince jr. (Ezra Miller) è tutto un afrore per donne obese, gonfie alla Botero, e Vivian (Dominik Garcia-Lorido) con tanta voglia di riprendere gli studi mette insieme un po’ di soldi lavorando come lapdancer in un pub. Senza volerlo, sarà Molly, ma in parte anche Tony, a scoprire gli altarini in casa Rizzo, riportandovi confronto e chiarezza.In “City IsIand”, l’anno scorso premiato al Tribeca Film Festival, non c’è irrisione, tanto meno sarcasmo, sui personaggi, ma un’intonazione agrodolce che fa dei loro segreti, momenti funzionali di reciproca pace e serenità. Così, nessuna pretesa di polemica sociale su dritto e rovescio dell’istituzione famigliare oggi, ma con leggerezza, e appena un tocco di sorridente malinconia, un gioco sul rapporti di gruppo in un interno.Il tutto, tra comprensiva indulgenza e divertito humour, tenuto ben fermo nella caratterizzazione dei personaggi (anche quelli di quinta, come l’insegnante di recitazione, un Alan Arkin, che deliziosamente sberteggia pausative cadenze attoriali alla Marlon Brando), ben ritmato nell’incrocio dei dialoghi, ben recitato, non solo dallo scafatissimo Garcia, anche dai comprimari, tra cui la Mortimer con piacevolissimo show di grazia e bravura. Il Corriere della Sera - Maurizio Porro L’ idea è buona, da Actor’ s Studio: una guardia carceraria fan di Brando, frustrata dalla vita a City Island (New York), studia di nascosto recitazione e invita a casa un figlio segreto. Troppo per un film solo e di Raymond De Felitta: infatti sbanda e si perde nel gioco degli equivoci, nelle pause (!) sentimentali, soprattutto per carenza di humour e cinismo nei dialoghi, per la paccata buonista sulle spalle, per la prova del simpatico Andy Garcia che purtroppo non è Woody Allen. Il Sole 24Ore - Luigi Paini - 04/07/2010 Recito, ergo sum. “City Island”, di Raymond De Felitta, si apre con la ‘confessione’ del protagonista, un secondino, pardòn guardia carceraria, con la fissa del palcoscenico. Teatro o cinema, per lui pari sono: l’importante è emulare il suo idolo, Marlon Brando, e conquistare le folle immedesimandosi in un altro personaggio. Attenzione, però, la recita inizia subito, perché nessuno, in famiglia, è al corrente della sua segreta passione: né la moglie, che fiuta qualcosa ma s’immagina il classico tradimento; né i due figli, maschio e femmina, che quanto a segreti, beh, meglio lasciar perdere. Situazione piena di equivoci dunque, perfetto terreno per una commedia con il sorriso sulle labbra ma sempre lì lì per sfiorare il dramma. Soprattutto quando all’orizzonte si materializza un altro figlio del nostro aspirante Brando: un ‘peccato di gioventù’ taciuto per tutta la vita. Segreti e bugie in un angolo del Bronx tutt’altro che male, un tranquillo ex borgo di pescatori che osserva i grattacieli di Manhattan da lontano. Con il sorriso sulle labbra, sperando che il dramma non scoppi mai. Il Giornale di Brescia - Alberto Pesce Con quella italoamericana dei Rizzo nel newyorkese “City Island”, borgo marinaro dentro il Bronx, ancora una famiglia. Scritto e diretto da Raymond De Felitta, ancora un luogo dove tutto accade, risacca di flutti dell’esistenza quotidiana, microcosmo in tranquilla convivenza, dove le tensioni si sfioccano solo a saper evitare scontri aperti, tutti assieme cianciando a tavola, tenendo ben chiusi segretamente nell’armadio della propria anima ‘scheletri’ allotri, frustrati desideri e sogni di rischio conflittuale, almeno sino a che le circostanze possano intervenire a metterli a nudo senza stridori, in reciproco 47 SCHEDE FILMOGRAFICHE 21 BRIGHT STAR di Jane Campion 7-8 aprile 2011 Nata in Nuova Zelanda, nel 1954, Jane Campion si è laureata in antropologia alla Victoria University di Wellington nel 1975 e quattro anni dopo si è diplomata in pittura al College of the Arts di Sydney . Nel 1982 ha realizzato il suo primo cortometraggio, “Peel‘ An Exercise in Discipline”, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes del 1986. Dopo realizza altri tre cortometraggi: “Passionless Moments” (1983), “After Hours” (1984) e “A Girl’s Own Story” (1984). Nel 1989, la regista neozelandese dirige il suo primo film per il grande schermo, Sweetie, vincitore di molti premi internazionali; l’anno dopo realizza “Un angelo alla mia tavola” (1990), che conquista il Leone d’argento a Venezia. Il grande successo arriva tre anni dopo, con “Lezioni di piano” (1993). A Cannes, il film vince la Palma d’oro e il premio per la migliore attrice, mentre l’Academy Award consegna un Oscar alla protagonista Holly Hunter, uno alla giovane Anna Paquin e un altro a Jane Campion per la sceneggiatura originale. Dopo “Lezioni di piano”, Jane ha diretto “Ritratto di signora” (1996) e “Holy Smoke” (1999), scritto insieme alla sorella Anna. Nel 2003 dirige “In the Cut”. Nel 2006 scrive e dirige il cortometraggio “The Water Diary”, realizzato in collaborazione con l’ONU per promuovere la campagna lanciata da Kofi Annan nel 2000. Interpreti: Abbie Cornish (Frances ‘Fanny’ Brawne), Ben Whishaw (John Keats), Kerry Fox (Sig.ra Brawne), Paul Schneider (Charles Armitage Brown), Edie Martin (Margaret ‘Toots’ Brawne), Thomas Sangster (Samuel Brawne), Claudie Blakley (Maria Dilke), Gerard Monaco (Charles Dilke), Antonia Campbell-Hughes (Abigail ‘Abby’ O’Donaghue), Samuel Roukin (John Reynolds), Samuel Barnett (Joseph Severn), Jonathan Aris (Leigh Hunt), Olly Alexander (Tom Keats) Genere: Drammatico Origine: Australia/Gran Bretagna/Francia/Stati Uniti d’America Sceneggiatura: Jane Campion Fotografia: Greig Fraser Musica: Mark Bradshaw Montaggio: Alexandre de Franceschi Durata: 119’ Produzione: Jane Campion, Jan Chapman, Caroline Hewitt per Hopscotch Entertainment, Bbc Films, Pathé Renn Productions, Uk Film Council Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: Londra 1818. Tra il poeta John Keats, 23enne, e la giovanissima Fanny Browne, studentessa di moda, nasce una storia d’amore che col tempo diventa sempre più forte e intensa. Keats però é malato. Tre anni dopo si reca a Roma nella speranza di migliorare a contatto con un clima più mite. VALUTAZIONE: Non é un film su John Keats ma semmai su di lei, sulla giovane Fanny, destinata a soffrire per amore. Scegliendo questa storia, peraltro vera e documentata, la Campion evita la trappola del taglio romantico fine a se stesso a favore di un approccio più sfaccettato. Fanny conduce il gioco doloroso dei sentimenti, ora con discrezione ora con una insistente presenza al limiti del fastidioso. All’epilogo racchiuso nei palpiti della malattia inguaribile, Fanny arriva attraverso una scansione puntigliosa della passione d’amore, consumata negli angoli di una infelicità gridata ma non urlata. Il merito maggiore della Campion è il disegno di un pentagramma psicologico del tutto moderno, lontano da orpelli ottocenteschi eppure ben calato nei colori e nelle luci di quel secolo. Un romanticismo perenne e non storico. 48 SCHEDE FILMOGRAFICHE La Repubblica - Natalia Aspesi In tempi d’intrattenimento volgare, può sembrare un atto di coraggio sconsiderato fare un film che ha al centro la grandezza della poesia; ma chissà che non ne nasca una virtuosa tendenza. Si riscopre il poeta romantico inglese John Keats, in Italia nel bel libro ‘Vite congetturali’ di Fleur Jaeggy, qui a Cannes nel film della neozelandese Jane Campion, “Bright star”, che con esaltante dolcezza e incanto davvero poetico, evitando le noie delle biografie, racconta gli ultimi due anni di vita del giovane Keats, vissuti nella passione contraccambiata per la coetanea Fanny Browne. Jane Campion è la sola donna regista ad aver vinto una Palma d’oro, nel 1992, con “Lezioni di piano”, e in ogni suo film c’è sempre al centro un’eroina in lotta con le convenzioni sociali e ansiosa d’amore. Qui, tra immagini meravigliose di interni di belle case Regency e immensi campi fioriti alla periferia di Londra, all’inizio pare che stia per svolgersi una battaglia femminista tra poesia e ricamo, essendo la poesia un’arte maschile e il ricamo, allora, il solo modo di esprimersi del talento femminile. Per fortuna non è così. Siamo nel 1818, Keats (Ben Wishaw) ha 23 anni, è orfano e senza un penny, sua madre è morta di tisi, di tisi sta morendo il fratello Tom, e anche lui sputa sangue; le sue poesie, così immaginifiche e malinconiche esasperano i critici ma commuovono la vicina Fanny (Abbie Cornish) molto carina anche se deturpata dalla moda d’epoca, bruttissima, con cuffiette in casa e cappelloni a megafono fuori, vita alta e gonne sopra le caviglie. L’amore è infuocato perché casto, e tra i tanti film dove in totale nudità si geme e ci si divora e ci si penetra dappertutto e fin troppo, questa passione tra corpi completamente abbigliati e distanti, quegli sguardi di luce che fanno arrossire, quello sfiorarsi le guance con un’intimorita carezza, quelle attese di cui pare di sentire i battiti del cuore, quei baci sulla bocca come tra due bambini, risultano essere per ora, il solo momento veramente erotico del Festival. Senza televisione, si capisce che allora sì ci si divertiva davvero in compagnia: pranzi e danze, concerti e cantate in casa, lettura di poesie, corteggiamenti muti. O fruttuosi, mettendo incinta la cameriera, come fa l’amico e protettore di Keats, Charles Brown, (Paul Schneider) che forse ama in silenzio Fanny e forse la detesta perché distrae il poeta dalla sua arte; anche se invece i suoi versi più belli, come ‘Ode to a nightingale’ sono ispirati da lei. Allora era ovvio che una ragazza di buona famiglia non sposasse uno senza soldi, né cedesse al desiderio: quando lui, a spese degli amici tra cui Shelley, parte per l’Italia per curare la tisi, lei non lo può seguire. Le lettere di lei sono andate perdute, quelle di lui sono tra le più belle missive d’amore mai scritte da un uomo. ‘Qui giace uno il cui nome fu scritto sull’acqua’ è l’epigrafe sulla tomba romana del poeta morto a 25 anni, nel febbraio del 1821. Fanny si cuce un vestito tutto nero, da vedova, ma poi, e questo il film non lo dice, pochi anni dopo si sposerà, avrà tre figli, e morirà a 65 anni. della metà degli esseri umani, e li diamo alla luce tutti quanti!’. Tutto ineccepibile, e coerente con il film che Jane presentava in concorso sulla Croisette nel maggio del 2009: “Bright Star”, dedicato alla storia d’amore fra il poeta John Keats e la giovane Fanny Brawne. Una storia sulla quale abbiamo libri e testimonianze, ma solo una “voce”: la voce di Keats, uomo che con le parole ci sapeva fare e che scrisse a Fanny lettere bellissime che lei, dopo la sua morte, conservò a lungo. Paradossalmente Jane Campion, scrivendo il film, ha dovuto rovesciare il punto di vista e inventare una seconda ‘voce’ che, almeno per iscritto, non ci è giunta: quella di Fanny. Il film, infatti, non è la storia di John Keats: è la storia di come Fanny Brawne si innamora di John Keats e della sua poesia. Ma non crediate che si tratti della solita storiella romantica sulla fanciulla sognatrice infatuata del poeta: “Bright Star” è anche il confronto fra due creatività, perché Fanny Brawne è una stilista del suo tempo - Inghilterra, primo Ottocento - e adora inventare cappelli e vestiti. Non a caso il film si apre con un’immagine che forse solo l’occhio di una donna regista poteva concepire, il primissimo piano di un ago che penetra una stoffa bianca, e finisce con un’immagine speculare, un altro ago che cuce una stoffa nera. Fra i due aghi, passano anni e irrompe la morte, perché John Keats muore a Roma, a soli 26 anni, il 23 febbraio del 1821. Fanny gli sopravvive portando per tre anni il lutto, pur non essendo i due sposati: ‘All’epoca - è sempre Jane Campion a parlare - le donne cucivano e aspettavano, aspettavano e cucivano. Eppure il cucito, nel film, è la parte creativa di Fanny, e diventa lo strumento per raccontare Keats attraverso lei’. La Stampa - Lietta Tornabuoni Un film d’amore perfetto, bello come una poesia e commovente come una canzone, è la nuova opera della geniale Jane Campion. “Bright Star” (il titolo è l’inizio di un poema amoroso, ‘Stella lucente’) è la storia della passione casta e sensuale, romantica e intensa, del giovane inglese John Keats e della sua vicina di casa Fanny Browne. Era il 1818, a Londra e nelle campagne circostanti. Lui aveva ventitre anni, lei diciannove. Lui era poeta, lei una borghese che imparava le tecniche del cucito e lo stile della moda. Lui, senza un soldo, fratello d’un ragazzo malatissimo, mantenuto da un amico che lo ammirava, non avrebbe mai potuto sposarla: nella società dell’epoca, il loro amore appassionato era impossibile. Arrivati all’ossessione romantica, dovettero separarsi: lui, malato di tubercolosi, andò a passare l’inverno 1820 nel clima mite di Roma (‘Dubito che ci rivedremo su questa terra’), dove morì nel febbraio del 1821 a ventisei anni. Lei come una vedova portò il lutto per tre anni, passando ore nella propria stanza a rileggere le lettere d’amore di lui; più tardi, nel 1833, si sposò, ebbe due figli. Non tolse mai l’anello che Keats le aveva dato. La storia di dolore, di bellezza e di innocenza, raccontata in maniera meravigliosa, aiuta a ricordare cosa davvero possa essere l’amore, così diverso dal sentimento egocentrico e narcisista a cui siamo ora spesso abituati. Sono bellissimi la delicatezza, l’intensità d’amore, i piccoli baci e le carezze leggere che gli innamorati si scambiano, le loro infinite invenzioni per vedersi e sentirsi vicini. La musica come la Natura sembrano volersi armonizzare alla coppia. Lo stile asciutto, rapido come in un film del Duemila, corrisponde magnificamente alla giovinezza ricca di slanci dei due protagonisti; le inquadrature sono affascinanti come bei quadri e come l’estetica romantica della vicenda; i due giovani attori inglesi, schietti ed entusiasti, sono bravissimi. Jane Campion ha un’invenzione narrativa molto raffinata: l’intera storia appare vissuta dal personaggio meno celebre, la ragazza, ostinata e forte come tante personalità femminili dei suoi film. “Bright Star”, tragico e tenero, è una completa riuscita. L’Unità - Alberto Crespi Jane Campion è nata a Wellington, Nuova Zelanda, il 30 aprile del 1954: e non si dovrebbe mai dimenticare che la Nuova Zelanda è il primo paese al mondo nel quale le donne hanno ottenuto il diritto di voto. Jane Campion non è necessariamente una femminista, ma poco più di un anno fa, al festival di Cannes (che rimane l’unica donna ad aver vinto, con “Lezioni di piano”), rispondeva così alla domanda sul tema: ‘Penso non si possa essere donne senza essere un po’ femministe, ma penso anche che siamo tutti umani, che gli uomini hanno lati femminili - e meno male! - e noi donne abbiamo lati maschili. Io, ad esempio, ho dovuto costruirmi una corazza da maschio a inizio carriera, per sopportare certe critiche feroci ai miei primi film. Le donne hanno fatto grandi progressi nel cinema, ma vorrei vedere più registe donne. In fondo siamo più 49 SCHEDE FILMOGRAFICHE 22 INCONTRERAI UNO SCONOSCIUTO ALTO E BRUNO di Woody Allen 14-15 aprile 2011 (Il film uscirà nelle sale italiane il 3 dicembre 2010) Woody Allen, al secolo Allan Stewart Königsberg (New York, 1º dicembre 1935).Appartiene ad una famiglia medio borghese ebrea, di origini ungheresi. Suona il clarinetto dall’età di dodici anni e gli piace scrivere battute umoristiche che invia regolarmente ai giornali di New York.L’esordio dietro la macchina da presa avviene con “Prendi i soldi e scappa”, ironica parodia della piccola delinquenza, dando il via ad un cammino artistico lunghissimo e pieno di riconoscimenti e successi.Nel 1978 Woody Allen ottiene il primo riconoscimento ufficiale per la sua carriera di regista: “Io e Annie”, girato con Diane Keaton, raccoglie ben 4 Oscar: miglior fotografia, miglior sceneggiatura, miglior regia e migliore attrice protagonista.Wody Allen realizza numerosi film e 18 candidature all’Oscar, prima con lavori spiccatamente umoristi, un miscuglio di commedia farsesca dei fratelli Marx e i drammi filosofici bergmaniani, poi con film di satira corrosiva alla società di massa, alla psicanalisi e il sesso legandosi a temi più personali che si intrecciano spesso con la sua burrascosa vita privata.Periodicamente matrimoni, divorzi, relazioni amorose e tradimenti hanno movimentato la vita di Woody Allen, sia sul set che nella vita privata. Interpreti: Anthony Hopkins, Josh Brolin, Naomi Watts, Antonio Banderas, Anna Friel, Freida Pinto, Ewen Bremner, Lucy Punch, Gemma Jones, Anupam Kher, Jim Piddock, Pauline Collins, Roger Ashton-Griffiths, Jonathan Ryland, Eleanor Gecks, Pearce Quigley Genere: sentimentale Origine: USA,Spagna Sceneggiatura: Woody Allen Fotografia: Vilmos Zsigmond Montaggio: Alisa Lepselter Durata: 108’ Produzione: Gravier Productions, Mediapro Distribuzione: Medusa SOGGETTO: Le vicende di due coppie sposate - nella fattispecie quella formata da Alfie (Anthony Hopkins) e Helena (Gemma Jones), e quella della figlia Sally (Naomi Watts) e di suo marito Roy (Josh Brolin), mentre passioni, ambizioni e ansie causano un crescendo di guai e follie. Dopo essere stata lasciata da Alfie – che se ne è andato per inseguire la perduta giovinezza e una ragazza di nome Charmaine (Lucy Punch) - Helena mette da parte la razionalità e si affida ciecamente ai bislacchi consigli di una cartomante ciarlatana. Dal canto suo Sally, intrappolata in un matrimonio infelice, si prende una cotta per l’affascinate proprietario della galleria d’arte - nonché suo capo - Greg (Antonio Banderas), mentre suo marito Roy, uno scrittore che attende con ansia una risposta dalla sua casa editrice, resta folgorato da Dia (Freida Pinto), una donna misteriosa che cattura il suo sguardo da una finestra vicina. VALUTAZIONE: Allen , si sa, è sempre stato un autore profondamente cinico, un pessimista cosmico che usa l’umorismo come una sorta di medicina per sopportare quella malattia incurabile che si chiama vivere. Nei suoi lavori migliori era sempre questo il tema portante dei suoi film e non sembrava esserci nemmeno un filo di speranza. A settantacinque anni suonati e con questo nuovo film sembra aver maturato una convinzione leggermente diversa ma di certo non più rassicurante: la vita fa sì schifo, ma la colpa non è solo della vita stessa ma della nostra intelligenza; solo chi è pazzo o sciocco infatti, solo chi riesce a non razionalizzare ogni cosa, solo chi è in grado di farsi cieco e rifiutare la realtà di tutti i giorni e a vivere attraverso l’illusione, può veramente dirsi felice e godersi appieno la vita. La nostra esistenza si riduce quindi a questo e poco più: se una veggente ti dice che incontrerai uno sconosciuto alto e scuro, puoi sperare che questo si avveri realmente e cominciare a cercare, oppure rifiutarti anche solo di accettare che questa remota possibilità esista e magari, da vero cinico, pensare che lo sconosciuto a cui si riferisca non sia altro che la Morte. 50 SCHEDE FILMOGRAFICHE Filmup - Andrea D’Addio Woody Allen potrebbe anche raccontarci per novanta minuti una fila al supermercato e comunque troveremmo la sua narrazione gradevole. Il suo modo di approcciarsi alla vita, la sua descrizione sempre leggera anche quando va in profondità, il suo modo spesso distante, forse cinico, con cui vede quelle che in molti considerano le grandi scelte che uno si trova a dover affrontare, matrimonio, tradimento, licenziamento, figli (forse si salva solo l’omicidio, ma dipende dai casi), è sinonimo di scorrevolezza. Tutto accade velocemente, non si rimarca, si lascia sempre e solo l’essenziale. E il tempo scorre, l’orologio non si guarda. Parliamo di un uomo che ha il tocco magico, anche il suo peggiore film è meglio di buona parte della concorrenza. Perché questa premessa? La ragione è che “You will meet a Dark Tall Stranger” è probabilmente il suo lavoro meno riuscito da “Melinda e Melinda”. Si guarda, ma tutto sembra già visto e sentito altrove, oltretutto in maniera migliore.Londra, persone normali, legami familiari che rendono ogni personaggio dipendente, in qualche modo, all’altro. Al centro c’è una coppia di quarantenni in crisi (ad ognuno di loro piace un’altra persona) con tanto di genitori di lei appena divorziati e già con un nuovo amore. È su questo impianto che giocano i visi di Naomi Watts, Josh Brolin, Anthony Hopkins e Gemma Jones da una parte, e i loro possibili-reali amanti, Antonio Banderas, Freida Pinto, Lucy Punch e Roger Ashton-Griffith. L’amore passa, non è eterno e non è una colpa rendersene conto. Lo avevamo già sentito nel divertente “Basta che funzioni”, lo risentiamo ora qui in maniera più seria, ma comunque non drammatica, quasi con distacco, come se neanche valesse la pena dirlo ancora. La stessa voce narrante fuori campo ci anticipa fin dall’inizio che assisteremo ad una storia senza troppo significato, fatta di rumore e poco altro, di cui “non rimane nulla” si dice citando Shakespeare. Ecco allora che per dare almeno un minimo d’interesse alla vicenda, un poco di collante che renda le storie unite, ritroviamo il misticismo de “Lo scorpione di Giada”, la crisi creativa dell’artista di “Hollywood Ending” (seppur qui parliamo di uno scrittore), l’amore tra due persone totalmente distanti per età (come “Basta che funzioni”) e questo solo per citare solo gli ultimi lavori e i richiami più espliciti. Insomma, Woody non entusiasma come al solito, nonostante tutti i suoi attori siano a loro modo amabili e alcune scene valgano da sole la visione del film. Dai due dialoghi tra Banderas e Naomi Watts (in macchina e poi sul divano, con lui che prende tempo sviando le risposte) al Josh Brolin che cambia “la finestra di fronte” avendo un lampo di rimorso di straordinaria intensità, passando per l’idea di non far vedere lo splendido viso di Freida Pinto, la ragazza che suona la chitarra, ma di tenerla sfocata fino a che non esce di casa. È per certi versi anche apprezzabile la scelta di Allen di non chiudere nessuna delle trame lasciate aperte, proprio come accade in “A serious Man” dei fratelli Coen, ma il modo con cui lo fa, senza accumulo di tensione, ma quasi volendo tagliare corto, come fosse finito lo spazio sulla pellicola, rende il tutto un po’ antipatico. Per fortuna Allen fa un film l’anno e avremo presto modo di cele- brare il suo ritorno. Due film sbagliati consecutivamente sarebbe davvero un record per lui. My Movies - Giancarlo Zappoli Alfie ha lasciato la moglie Helena perchè, colto da improvvisa paura della propria senilità, ha deciso di cambiare vita. Ha iniziato così una relazione (divenuta matrimonio) con una call girl piuttosto vistosa, Charmaine. Helena ha cercato di porre rimedio alla propria improvvisa disperata solitudine cercando prima consiglio da uno psicologo e poi affidandosi completamente alle ‘cure’ di una sedicente maga capace di predire il futuro. La loro figlia Sally intanto deve affrontare un matrimonio che non funziona più visto che il marito Roy, dopo aver scritto un romanzo di successo, non è più riuscito ad ottenere un esito che lo soddisfi. Sally ora lavora a stretto contatto con un gallerista, Greg, che comincia a piacerle non solo sul piano professionale… Woody ha preso nuovamente l’aereo ed è tornato in Gran Bretagna dopo che era tornato a respirare aria di Manhattan con Basta che funzioni. Nonostante l’aspetto sempre più fragile, Allen ha ormai le spalle più che larghe per sopportare l’ennesima, ripetitiva reprimenda critica: “Racconta sempre le stesse cose”. È vero: Woody non si inventa novità senili per stupire il pubblico. Anzi qui, fingendo di appellarsi allo Shakespeare del “Macbeth” in realtà si riallaccia al finale di uno dei suoi film più ispirati, Ombre e nebbia, che si chiudeva con la frase: “L’uomo ha bisogno di illusioni come dell’aria che respira”. Sono trascorsi quasi vent’anni da allora e, in materia, Allen sembra essersi ormai arreso all’evidenza: è proprio (e sempre di più) così. Come in Tutti dicono I Love You (ma con l’esclusione dell’adolescenza) le diverse età si confrontano con un bisogno di qualcosa che esemplificano con la parola ‘amore’ ma di cui, se richiesti, non saprebbero dire il significato. Non potendo sfuggire a questa esigenza ognuno cerca di trovare delle soluzioni che finiscono con il rivelarsi aleatorie e provvisorie anche se ognuno, in cuor suo, vorrebbe che fossero ‘per sempre’. Ma il ‘per sempre’ non esiste nell’universo alleniano. Ognuno cerca di porre rimedio alla propria solitudine come può e come sa e non ha neppure bisogno di essere perdonato per questo. L’umanità non può comportarsi altrimenti. Ciò che invece va duramente punito è il furto intellettuale, l’appropriarsi di idee altrui spacciandole per proprie, perseguire il successo a spese degli altri. In questo caso Woody diventa un giudice implacabile. Sarà anche vero che ritorna su propri temi. Ma sono ‘suoi’ per stile, qualità, leggerezza e profondità. Il Messaggero - Fabio Ferzetti “Woody Allen è stato più ispirato in altre occasioni, ma l’età lo rende pungente, specie con i suoi coetanei. Non a caso ha smesso di apparire nei suoi film, e tocca a Hopkins chiedere ancora tre minuti all’amante dopo aver preso il Viagra. Anche così si riesce a fare un film l’anno, senza sentirsi obbligati ogni volta al successo planetario. Ma è triste che spesso nel cinema libertà faccia rima con età. 51 SCHEDE FILMOGRAFICHE 23 TAMARA DREWE - Tradimenti all’inglese di Stephen Frears 28-29 aprile 2011 (Il film uscirà nelle sale italiane il 5 gennaio 2011) (1941 Leicester - Gran Bretagna) Dopo il diploma al Gresham’s School, Frears si iscrive a giurisprudenza ma abbandona presto gli studi per dedicarsi al teatro. Dopo numerose esperienze sul palcoscenico in veste di regista, passa alla direzione di alcuni lavori per la televisione. Il debutto nel lungometraggio avviene nel 1972 con “Gumshoe”, seguita poi da una ricca galleria di lavori per la tv. Con Vendetta (1984) ritorna al cinema. L’anno dopo gira “My Beautiful Laundrette” (1985) e raggiunge la notorietà. Dopo firma “Prick Up – L’importanza di essere Joe” (1987), e “Sammy e Rosie vanno a letto” (1987). Anche Hollywood lo nota e lo chiama per dirigere la trasposizione cinematografica del romanzo “Le relazioni pericolose” di Choderlos de Laclos. Il cast eccezionale e l’eleganza dello stile registico ne fanno un piccolo gioiello della storia del cinema mondiale. Rimane negli Stati Uniti a girare “Rischiose abitudini” (1990), uno dei suoi lavori migliori. Per il film riceve la candidatura all’Oscar come migliore regista e poco dopo ottiene un successo incredibile di pubblico con “Eroe per caso” (1992), seguito dal minore “The Snapper” (1993) e il più interessante “Mary Reilly” (1996). Ha meno fortuna con “The Hi-Lo Country” (1998) e “Due sulla strada” (1996). Ma riprende subito dopo la vecchia vena creativa con “Alta fedeltà” (2000) e “Liam” (2000). Nello stesso anno realizza “A prova di errore” e poi dirige il delizioso noir “Piccoli affari sporchi” (2002), Lady Henderson presenta (2005) e il dissacrante “The Queen” (2006 - Helen Mirren, che interpreta la regina, viene premiata con la coppa Volpi e l’Oscar come migliore attrice) Nel 2009, dopo il film tv “Skip Tracer”, si dedica al progetto e alla realizzazione di “Chéri”, dramma in costume, ambientato nella Parigi cortigiana di inizio Novecento. Interpreti: Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp, Tamsin Greig, Dominic Cooper, Luke Evans, Roger Allam, Tamsin Greig, Jessica Barden, Charlotte Christie Genere: Commedia Origine: Regno Unito Soggetto: Posy Simmonds Sceneggiatura: Moira Buffini Fotografia: Ben Davis Musica: Alexandre Desplat Montaggio: Mick Audsley Durata: 109’ Produzione: Ruby Films, BBC Films, WestEnd Films Distribuzione: BIM Distribuzione SOGGETTO: Dopo la morte della madre, una giovane giornalista fa ritorno nel suo paese di origine, nel bel mezzo della campagna inglese, per scoprire che la casa dove é cresciuta da bambina, é stata messa in vendita. Profondamente cambiata, la ragazza suscita l’interesse di tutti nel paese, non senza lasciare inevitabili conseguenze... VALUTAZIONE: Succede di tutto e si ride dal primo all’ultimo minuto. Gli eventi sono scatenati . I dialoghi sono spassosi, le situazioni geniali. Anche se alcune battute sono prevedibili, bisogna riconoscere la carica di questo film. Ma se sono così prevedibili le battute, perchè è così difficile far ridere? Tutto è più chiaro, quando si scopre che il testo del film non viene da un libro ma, bensì, da una graphic novel, disegnata e scritta da quell’altra mente geniale britannica che è Posy Simmons, amica di Frears. Il regista (autore, tra i più recenti anche di Cheri con Michelle Pfeiffer) ha spiegato che non aveva mai pensato che da quei disegni potesse uscire una sceneggiatura, “fino a quando non me la sono trovata tra le mani”. Non stupisce poi quando confessa che si è divertito da morire e che ha amato questo film, “amo quando non devo fare cose noiose”, ha detto. 52 SCHEDE FILMOGRAFICHE Coming Soon.it - Federico Gironi Da qualche anno a questa parte Stephen Frears è andato affinando un tocco per la commedia che se di nuovo o di originale non ha effettivamente nulla, fa del ritmo, di una leggerezza di toni e di uno humour squisitamente britannico delle caratteristiche chiaramente riconoscibili. E il suo ultimo lavoro, Tamara Drewe, conferma esplicitamente questa tendenza. Tratto dalle omonime strisce a fumetti di Posy Simmonds pubblicate sul Guardian e poi raccolte in una graphic novel (a loro volta basate sul romanzo di Thomas Hardy “Via dalla pazza folla”), il film è ambientato in una piccola cittadina di campagna inglese, dove fa ritorno una bella ragazza un tempo brutto anatroccolo locale. Con sé porterà lo scompiglio, coinvolgendo un vecchio amore, la celebrità locale (uno scrittore proprietario di una sorta di pensione per scrittori), il batterista di una band indie rock e altri personaggi; e a contribuire allo scompiglio, due adolescenti annoiate e innamorate del batterista che ne combineranno di tutti i colori. Commedia romantica, degli equivoci, farsesca, a tratti quasi nera: tutte definizioni che ben si adattano a Tamara Drewe ma che da sole non esauriscono un film che da un lato omaggia il wit tutto inglese del romanzo di Hardy e dall’altro ben rispecchia lo stile e lo spirito della forma fumetto. Nonché la sua iconografia, come si può constatare da un casting effettuato ricalcando la fisicità dei personaggi disegnati. Ed ecco che allora il film di Frears non è certo destinato a lasciare segni profondi nello spettatore, ma gli è totalmente asservito nel tentativo (riuscito) di regalargli un paio d’ore di divertimento garbato ma mai del tutto superficiale, dove il gioco degli intrecci e delle passioni è sempre ben gestito e mai ostentato, dove la semplicità e la schiettezza sostanziali di un testo senza tanti sottoappaiono sincere e rinfrescanti come l’aria di quelle rusticamente eleganti campagne al mattino. A molti, a Cannes, potrà sembrare un’eresia: ma le ambizioni modeste, la lieve eleganza e l’umorismo disarmante di Tamara Drewe restituiscono allo spettatore tutto quello che Woody Allen ha e si è sottratto con You Will Meet a Tall Dark Stranger. diventare una presenza quasi fissa all’interno del villaggio per la gioia di due teenager che lo idolatrano e che faranno di tutto per conquistare la sua attenzione.Il film di Frears fa sorridere con intelligenza grazie ad una sceneggiatura estremamente fluida che lascia trasparire un’estrema fedeltà verso il fumetto da cui proviene ma che al tempo stesso riesce a tratteggiare dei personaggi tridimensionali ed affascinanti senza limitarsi alla sola Tamara, che comunque nella bella Gemma Arterton trova la sua perfetta incarnazione. Ma non bisogna farsi trarre in inganno dai dialoghi brillanti e lo humour tipico inglese, Tamara Drewe è sì una commedia ma al tempo stesso è un’opera che dimostra un grande amore per la letteratura come dimostrano i continui rimandi alle opere di Thomas Hardy, una caratteristica già del lavoro di Simmonds amplificata qui dalla buona messa in scena di Frears e dalle musiche di Alexandre Desplat che in alcuni momenti conferiscono al film un’atmosfera davvero senza tempo. Primissima.it - Nicoletta Gemmi Leggera e divertente la nuova pellicola del cineasta inglese Stephen Frears, Tamara Drewe, è stato inserito dal Festival Fuori Concorso. Il film è tratto dalla graphic novel di Posy Simmonds, ispirata al romanzo di Thomas Hardy ‘Via dalla pazz folla’. Gemma Arterton (nella foto a sinistra), protagonista di Prince of Persia, che ha debuttato come Bond Girl in Quantum of Solace è una delle interpreti principali insieme a Dominic Cooper (Mamma Mia!). Con il suo naso rifatto, le sue lunghe interminabili gambe, il suo lavoro nella stampa e la sua aspirazione alla celebrità e il suo talento per i cuori infranti: Tamara Drewe è l’Amazzone londinese del XXI° secolo. Il suo ritorno al villaggio di origine, dove ha vissuto con la madre, è un vero e proprio choc per la comunità che ci prospera e ci vive in santa pace. In quel luogo sorge nel bel mezzo della campagna, una pensione per scrittori realizzata con tutti i comfort per ispirare i futuri autori nella preparazione dei loro prossimi libri. Proprietari sono l’autore di gialli popolari Nicholas (Roger Allam) e sua moglie Beth (Tamsin Greig), tra gli avventori Tamara e Ben (Cooper - foto a sinistra). Da quel momento uomini e donne, bohemienne, contadini, autori di bestsellers, universitari frustrati, rock star con al seguito i loro fan, sono tutti attirati da quella factory e, soprattutto, dalla bellezza di Tamara la cui bellezza incendiaria e le divagazioni sull’amore provocano passioni e circostanze assurde. Una commedia divertente che ha conquistato critica e pubblico. Stephen Frears ha amato immediatamente lo charme particolare e le possibilità offerte dal romanzo e dalla graphic novel di Posy Simmonds: “Ho adorato – ha affermato il regista – la sua reale originalità. Christine Langan (direttore creativo presso la BBC Films) mi ha inviato il libro dicendomi: “Ho una cosa per te”. Mi è arrivata una busta e durante un viaggio per New York quando mi sono deciso ad aprirlo. Dentro c’erano romanzo e fumetto e ho immediatamente amato quello che stavo vedendo e che poi ho letto con calma. Mi sono reso conto che tutto ciò stava avvenendo esattamente allo stesso modo di quando ho realizzato The Snapper. Da quel momento, ho avuto l’impressione di sognare. È stato davvero un magnifico regalo avere la possibilità di realizzare questo film”. Movieplayer.it - Luca Liguori Dopo le ultime opere passate tra merletti e nobilità, il regista Stephen Frears torna alla commedia con Tamara Drewe, fedele trasposizione dell’omonimo graphic novel di Posy Simmonds, che racconta di un piccolo paesino della campagna inglese in cui un romanziere specializzato in polizieschi, insieme a sua moglie, gestisce un tranquillo e pacifico bed and breakfast per scrittori. Tra mucche, prati e torte sfornate fresche ogni giorno, la vita scorre tranquilla e la serenità di questo piccolo paradiso non viene turbata neanche dai continui tradimenti del padrone di casa, le scenate della moglie o l’impossibilità per alcuni degli aspiranti scrittori a trovare la giusta ispirazione. Le cose cambiano nel momento in cui nella villa accanto fa ritorno dopo tanti anni la Tamara del titolo, una giovane giornalista che in passato era stata un brutto anatroccolo e ora si è trasformata in uno splendido cigno, soprattutto grazie al chirurgo che le ha regalato un nuovo naso. Tra le tante vittime del suo fascino, lo scrittore fredifrago, un ex innamorato ora contadino tuttofare e soprattutto una rockstar di passaggio che finirà così con il 53 SCHEDE FILMOGRAFICHE 24 UNA SCONFINATA GIOVINEZZA di Pupi Avati 5-6 maggio 2011 Bolognese, nato il 3 novembre 1938, Giuseppe Avati, detto Pupi, si laurea in Scienze Politiche, ma insegue fin da ragazzo il sogno del cinema, frequentando corsi di regia e cimentandosi con la macchina da presa. Nel 1968 debutta nel lungometraggio con “Balsamus, l’uomo di Satana”, a cui fanno seguito qualche anno più tardi “La mazurka del barone della santa e del fico fiorone” (1975), con Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio, “La casa dalle finestre che ridono” (1976), e il musical “Bordella” (1976). Con “Una gita scolastica” (1983), Pupi Avati mette definitivamente a punto il suo stile personale, minimalista e intimo, che diventerà una costante nella sua produzione successiva. Nascono così “Festa di laurea” (1984), “Noi tre” (1984), premio speciale per i valori tecnici alla Mostra di Venezia, “Regalo di Natale” (1986), e “Storia di ragazzi e di ragazze” (1989), David di Donatello per la migliore sceneggiatura. Nel 1991 Avati gira in “America Bix”, biografia di Leon Beiderbecke, uno dei pochi jazzman bianchi, e l’anno successivo dirige “Fratelli e sorelle”. Nel 1993 presenta a Cannes il suo film più ambizioso, “Magnificat”, poi porta sul grande schermo “L’amico d’infanzia” (1994), “L’arcano incantatore” (1996) e “Festival” (1996). Dopo “Il testimone dello sposo” (1997), Avati dirige “La via degli angeli” (1999), ambientato nei primi del Novecento nella campagna emiliana, “I cavalieri che fecero l’impresa” (2000), tratto da un suo romanzo, e “Il cuore altrove” (2002). Nel 2004 è la volta invece di “La rivincita di Natale”, sequel a quasi vent’anni di distanza del film sui giocatori di poker. Avati continua negli anni a regalarci il suo universo cinematografico fatto di storie minimaliste con personaggi spesso proiettati nostalgicamente verso il passato, come in “Quando arrivano le ragazze?” (2004) o “La seconda notte di nozze” (2005). Nel 2008 torna al cinema (e al festival di Venezia) con il film “Il papà di Giovanna”. Ambientazione ed epoca sono quelli preferiti del regista: la sua Bologna, e l’Emilia, negli anni trenta. Seguono “Gli amici del Bar Margherita” (2009) e “Il figlio più piccolo” ( 2010). Interpreti: Fabrizio Bentivoglio (Lino), Francesca Neri (Chicca), Lino Capolicchio (Emilio), Manuela Morabito (Teta), Serena Grandi (zia Amabile), Gianni Cavina (Preda), Erika Blanc (la vedova), Osvaldo Ruggieri (neurologo), Vincenzo Crocitti (Don Nico), Lucia Gruppioni (Leda), Marcello Caroli (Leo), Riccardo Lucchese (Nerio), Antonella Ponziani, Chiara Sani, Sandro Dori. Genere: Drammatico Origine: Italia Soggetto e sceneggiatura: Pupi Avati Fotografia: Pasquale Rachii Musica: Riz Ortolani Montaggio: Amedeo Salfa Durata: 98’ Produzione: Antonio Avati per DUEA Film in collaborazione con RAI Cinema Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: Sposati da venticinque anni e senza figli, Lino e Chicca conducono una esistenza serena, quando lui all’improvviso comincia ad accusare dei vuoti di memoria. Sono le prime avvisaglie della patologia dell’Alzheimer. Col tempo la malattia degenera, Chicca decide si restargli accanto ma Lino, rincorrendo i propri fantasmi, un giorno riesce ad allontanarsi ……. VALUTAZIONE: “Inquadro il mio rapporto col tempo- dice Avati- sono nella seconda parte del secondo tempo della mia vita, nella zona del rientro a casa. Ho dunque dismesso la nostalgia per la giovinezza, e fatto un passo avanti, anzi, indietro: la regressione riporta all’infanzia. Il titolo, appunto, avrebbe dovuto essere ‘Una sconfinata infanzia’”. Se scavalcata é la giovinezza, non lo è dunque la nostalgia, che si conferma uno dei motori trainanti da sempre dell’ispirazione avatiana. A questo e ad altri punti fermi, il regista non sa e non vuole rinunciare. Ecco allora l’Emilia, l’inverno, la neve, lo spiare un po’ clandestino le coetanee vicine: elementi ispiratori, un pentagramma sul quale Avati scrive le note di una melodia dolce e tenerissima. Non ci sono consulti, ricette, ospedali: per il marito Chicca fa ricorso alla medicina più importante, quella dell’amore. 54 SCHEDE FILMOGRAFICHE Filmup.com - Francesco Lomuscio Scorrendo la lunga filmografia di Pupi Avati, tra una “Storia di ragazzi e di ragazze” (1989) e “Gli amici del Bar Margherita” (2009), non si può fare a meno d’intuire una certa, fondamentale importanza che i ricordi hanno per il prolifico cineasta bolognese classe 1938.Quindi, c’era da immaginarsi che, prima o poi, dall’autore de “Il regalo di Natale” (1986) sarebbe arrivata la vicenda del giornalista sportivo Lino Settembre alias Fabrizio Bentivoglio, il quale, sposato da venticinque anni con la docente di Filologia Medievale Chicca, interpretata da Francesca Neri, comincia ad accusare problemi di memoria, fino a compromettere in modo sempre più evidente il quotidiano svolgersi delle sue attività professionali e familiari e ad allontanarsi dal presente.Una vicenda che, inizialmente, non sembra altro che la versione ribaltata del riuscito “Away from her-Lontano da lei” (2006) di Sarah Polley, nel quale era Julie Christie ad essere affetta dal morbo di Alzheimer, mentre il marito Gordon Pinsent provvedeva ad accudirla.Ma Avati, che costruisce i circa 98 minuti di visione alternando il presente e un passato che, come un po’ in tutti i suoi film, viene raccontato facendo ricorso ad una fotografia dai toni seppia, prende tutta un’altra strada, mostrandoci una sorprendente Neri costretta a trasformare il proprio amore coniugale in un amore materno nei confronti del sempre più infantile (mentalmente parlando) compagno.Un Bentivoglio alle prese con una delle sue migliori interpretazioni, quest’ultimo, contornato da un cast decisamente in forma comprendente una riscoperta Serena Grandi, il compianto Vincenzo Crocitti, deceduto proprio a pochi giorni dall’uscita del film in sala, e gli immancabili Lino Capolicchio e Gianni Cavina, quasi ospiti fissi dei set avatiani.E, se nel corso della prima parte, durante la quale si tende a sguazzare tra risate amare e una certa nostalgia (basterebbe citare la pista per giocare con i tappi di latta alla gara ciclistica), non si fatica ad avvertire una narrazione piuttosto fiacca, la bellissima seconda spinge non poco verso la commozione lo spettatore, talmente coinvolto nel sempre più accentuato dramma di Lino da provare quasi l’impressione di rivivere le forti sensazioni degli horror d’ambientazione rurale sfornati dal regista, qui responsabile di quello che possiamo tranquillamente definire “un bel film”. e scova quei volti antichi, rustici che ancora ha nel cuore, come non se ne vedono più in questa Italia. Il Mattino - Valerio Caprara Si può girare una storia tristissima senza deprimere lo spettatore? Evidentemente sì, se il fine è stato quello di raggiungere uno specifico equilibrio tra il tono stilistico e la sostanza drammaturgica. Pupi Avati, del resto, va considerato un regista giovane perché più della sua carta d’identità fa fede la filmografia che ha appena superato la quarantina (di titoli): in «Una sconfinata giovinezza» lo spettatore potrà ritrovare gli appigli consueti, andare sul sicuro, insomma, immergendosi nel microcosmo emiliano dell’eterno ritorno memoriale; ma, nello stesso tempo, ritrovarsi faccia a faccia con i motivi più aspri, le riflessioni più sconsolate, le ipotesi meno gratificanti di cui lo stesso itinerario audiovisivo si è nutrito più o meno in sottotraccia. Rivelando che il vissuto avatiano s’intreccia questa volta con la spaventosa patologia dell’Alzheimer, anticipiamo, infatti, solo una parte dell’impianto che fa muovere gli eventi e i personaggi e via via li dirama in altre direzioni e predispone a letture differenti. Lo testimonia bene il fatto che il finale coincida in modo circolare con l’inizio: conoscendo già “tutto”, si tratterà di farsi largo tra quelle evocative nebbie appenniniche e iniziare a separare nel flusso narrativo le offese portate dal tempo da quelle inferte a corpo e mente. Il giornalista sportivo Lino Settembre e la moglie docente universitaria Chicca godono da venticinque anni di un’intesa perfetta, per nulla incrinata e anzi rinsaldata dalla mancanza di figli. Quando i sinistri segnali della demenza degenerativa s’insinuano nella bella casa romana, s’incrementa il reticolo dei flashback che allontanano lo sfortunato Lino da una realtà e lo ricollocano in un’altra: la regressione nell’infanzia e nell’adolescenza del malato porta con sé, peraltro, non solo la cancellazione del presente nel passato con il relativo e impietoso raffronto tra lo stupore, la suspense, il fanatismo dell’età dell’emozione e il disincanto, la costrizione e l’opportunismo dell’età della rimozione, ma anche la volontaria e temeraria trasformazione dell’amore di Chicca da coniugale a materno. La sfida di Avati sta in questo gioco che rasenta l’enfasi per dimostrasi infine asciutto e struggente di flash involontari eppure inevitabili- accentuazione tragica e pessimista delle intermittenze proustiane- ovviamente in gran parte affidato alle prove davvero ardue dei protagonisti. Fabrizio Bentivoglio è un Settembre (che, guarda caso, è il titolo di uno dei più bergmaniani film di Woody Allen) in grado di superare di slancio la facile immedesimazione da documentario medico e Francesca Neri incanta per come dà spessore alle sfumature più oscure e destabilizzanti del copione; ma spiccano nell’armonia d’insieme anche gli assoli di rodati interpreti dell’Avati-touch come Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Erica Blanc e Serena Grandi. La Repubblica - Roberto Nepoti Pupi Avati affronta una storia che parla di un evento sconvolgente come l’ Alzheimer, malattia crudele che separa, cancella, imprigiona e rende estranei. Lei, Francesca, docente universitaria, lui, Lino, grande firma del giornalismo sportivo, sposati da decenni, uniti dalla privazione di non avere figli: lui è Fabrizio Bentivoglio, lei Francesca Neri. Prime crepe, vuoti di memoria, poi la diagnosi infausta del neurologo. Bisognerà prepararsi al peggio, agli articoli impubblicabili, all’ estraniarsi durante le riprese televisive, alla violenza. Pupi Avati evoca con grazia e tenerezza i tempi della sua infanzia, 55 SCHEDE FILMOGRAFICHE 25 LA PASSIONE di Carlo Mazzacurati 12-13 maggio 2011 Nato a Padova nel marzo del 1956, Carlo Mazzacurati s’appassiona al cinema sin dal liceo e tenta d’iscriversi al Centro Sperimentale di Cinematografia per ben tre volte, sempre senza successo. Si trasferisce successivamente a Bologna, dove frequenta senza grandi risultati il DAMS; ricevuta una piccola eredità, decide d’investirla in un cortometraggio, “Vagabondi” (1979), che segna il suo esordio nel cinema. In seguito si dedica alla sceneggiatura: collabora allo script che verrà adoperato da Gabriele Salvatores per “Marrakech express” (1989).Debutta nel lungometraggio con “Notte italiana” (1987) , che vince il Nastro d’argento. Seguono “Il prete bello” (1989) e “Un’altra vita” (1992) .Ne “Il toro” (1994). Mazzacurati appunta ancora la propria attenzione su personaggi di perdenti in cerca d’un impossibile riscatto, come pure la protagonista di “Vesna va veloce” (1996) ; mentre ne “L’estate di Davide” (1998) mette in scena con grande sensibilità l’educazione sentimentale d’un ragazzo in vacanza nel Polesine. Nel 2000 il regista firma “La Lingua del santo”, presentato in concorso alla 57ª Mostra del cinema di Venezia. Nel 2002 il regista gira “A cavallo della tigre” , rifacimento di una commedia girata da Luigi Comencini nel ‘61. Dirige nel 2004 Stefano Accorsi e Maya Sansa nel film “L’amore ritrovato”, - liberamente ispirato al romanzo di Carlo Cassola presentato fuori concorso alla 61ª mostra del cinema di Venezia. Il film è una sorta di esplorazione sulle dinamiche dei rapporti, nello stile tipico del regista. “La giusta distanza” concorre alla II edizione della Festa del Cinema di Roma. Interpreti: Silvio Orlando (Gianni Dubois), Giuseppe Battiston (Ramiro), Corrado Guzzanti (Abbruscati), Cristiana Capotondi (Flaminia Sbarbato), Stefania Sandrelli (Sindachessa), Kasia Smutniak (Caterina), Maria Paiato (Helga), Marco Messeri (Del Ghianda), Giovanni Mascherini (Jonathan), Fausto Russo Alesi (Pippo) Genere: Commedia Origine: Italia Soggetto: Umberto Contarello, Doriana Leondeff, Marco Pettenello, Carlo Mazzacurati Sceneggiatura: Umberto Contarello, Doriana Leondeff, Marco Pettenello, Carlo Mazzacurati Fotografia: Luca Bigazzi Musica: Carlo Crivelli Montaggio: Paolo Cottignola, Clelio Benevento Durata: 105’ Produzione: Domenico Procacci per Fandango in collaborazione con RAI Cinema Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: Da alcuni anni Gianni Dubois, regista di cinema, é in crisi di ispirazione. All’improvviso deve correre in Toscana dove una perdita nel suo appartamento rischia di rovinare un affresco del Cinquecento nella chiesetta adiacente. Per evitare una denuncia e una pessima figura, Gianni accetta la proposta del sindaco del paese di dirigere la sacra rappresentazione della Settimana Santa. In realtà non sa da dove cominciare, e solo l’incontro con Ramiro, un ladruncolo ricercato dalla polizia, sembra poter risolvere la situazione. Tra equivoci e incomprensioni, la Passione va in scena e forse Gianni trova anche la sua nuova storia. VALUTAZIONE: Dice Carlo Mazzacurati: “A dire il vero all’inizio questa storia non era nata per essere un film. Era semplicemente un racconto orale che ogni tanto mi capitava di fare. (...)Ci sono personaggi che sento molto vicini. Sono esseri che per sensibilità o inadeguatezza sono esposti più di altri alle difficoltà della vita. A volte fanno sorridere, a me per lo più commuovono”. Stavolta Mazzacurati entra a pieno titolo nella commedia, dove si ride amaramente sui problemi quotidiani e la ricerca di un equilibrio diventa così difficile da suscitare immediata complicità. C’è umorismo in molti passaggi del copione, c’è l’occhio puntato su vizi atavici (trascuratezza, pressappochismo...), c’é la sensazione che l’arte e la tradizione ‘alta’ possano rappresentare un’ancora di salvezza per la collettività. Poi c’è l’aspetto del cinema nel cinema, il film da fare, il richiamo felliniano che forse diventa il punto debole della storia. Bella invece la rappresentazione della Passione, la ‘messa in scena’: momento che fa appello alla nostra umanità fuori dal tempo e dalla storia, alla capacità di convivenza civile, di essere sempre rispettosi gli uni degli altri. 56 SCHEDE FILMOGRAFICHE Il Tempo - Gian Luigi Rondi Carlo Mazzacurati dolceamaro. Incline all’ironia, ma pronto a suggerire anche l’emozione, specie quando, tra le pieghe della beffa, si fanno avanti temi seri, come la Passione sul Golgota che dà il titolo al film.Si comincia sul versante del buffo perché il protagonista, che è un regista di cinema da cinque anni senza più idee né film al suo attivo, proprio mentre un produttore gli chiede finalmente un progetto per una diva acclamata, viene convocato d’urgenza nel paesino toscano dove ha una casa perché, non avendo provveduto a fare certe riparazioni, una copiosa perdita d’acqua sta danneggiando un affresco del Cinquecento in casa di un suo vicino. Il sindaco - anzi, la sindachessa -non esita a ricattarlo: o lo denuncia alle Belle Arti o lui si assume il compito dì curare, di lì a cinque giorni, per il Venerdì Santo, una rappresentazione della Passione che in quel paese aveva una lunga tradizione interrotta solo dalla morte del suo ideatore.Da qui un susseguirsi di eventi che mettono a dura prova il regista: per un verso costretto a tener a bada il produttore che da Roma chiede con insistenza notizie e, a un certo momento, anche la stessa diva venuta fin lì per rendersi conto delle sue idee sul film, per un altro, intento a metter su alla meglio quella Sacra Rappresentazione che, ad ogni tappa, accumula contrattempi o disastri, nonostante, ad una svolta, un ex galeotto pentito si impegni a risolvere anche le situazioni più ardue, tra cui il fallimento di uno pseudo attore ingaggiato per interpretare Gesù. Tre croci su un monte e una notte di tempesta susciteranno alla fine un’atmosfera tutta diversa: coinvolgendo e commuovendo. Mentre il regista, forse, troverà la sua strada.Un equilibrio attento di tutti gli elementi: all’inizio le disavventure del protagonista, ora espresse con partecipazione ora con umorismo. In seguito la caricatura colorita, però sempre con misura, di quella cornice quasi rurale in cui tutti i difetti vengono a galla, suscitando il riso, spesso con commiserazione. Per concludere, appunto, con quel Golgota paesano che sa vestirsi di sacro nonostante le cifre quasi opposte di prima e senza uno strappo. Lo stile di Mazzacurati.Nei panni del regista, Silvio Orlando. Sulla sua faccia tutti gli echi, i climi, i colori del film. Una interpretazione esemplare. Cito anche Giuseppe Battiston. Come ex galeotto poi crocifisso svela più di sempre un’umanità sincera e profonda. Che conquista. sospeso fra tradizione e imbarbarimento (anche la Toscana non è più quella di una volta). Una sindachessa ipocrita e feroce (Sandrelli) ma non più della media nazionale. E uno spettacolino da allestire per ricatto, nello sperduto borgo toscano, che parte come una trappola ma poi diventa una grande occasione di riscatto artistico ed esistenziale. Di più: la prova che anche un regista di sicuro insuccesso, alle prese con le proprie e le altrui miserie, può ritrovare l’orgoglio per dire malgrado tutto, ‘Noi qui ci mettiamo l’anima!’. Gli americani hanno il musical, noi la sacra rappresentazione, ma le cose non cambiano. Se c’è da mettere in scena a tutti i costi uno spettacolo, la metafora è dietro l’angolo. ‘The show must go on’, e “La Passione” di Mazzacurati riformula il vecchio mito della provincia foriera di rinascite e riconciliazioni. Stravolto dalla disoccupazione (e dalle proposte dementi che intasano la segreteria telefonica), il regista in crisi rompe l’isolamento scaricando l’isterica divetta tv (Capotondi) e ribaltando i ruoli. Volete lo spettacolo (la Passione di Cristo, allestita ogni anno nel paesino)? Benissimo, ma non basta fare gli spettatori. Dovete anche recitarci, per quanto impreparati e svogliati possiate essere... Così quel paesino diviso fra autoderisione, rassegnazione e voglia di farcela, diventa l’emblema di tutto il Bel (?) paese. Peccato che, se la morale è chiara, la fiaba è un poco fiacca, le gag spesso stiracchiate, i momenti felici (i bambini delle scuole messi a copiare a mano il testo, perché le fotocopiatrici del paesino sono tutte inservibili) si alternano ad altri di grana grossa. Forse fa parte della metafora. Rinascere si può e si deve. Ma la strada è ancora lunga. Il Giornale - Maurizio Cabona Dopo il passaggio a Venezia, una commedia semplice, dove si ride e si sorride. A patto, però, di non detestare in modo viscerale il mondo dello spettacolo e le sue atmosfere. Perché qui di questo si tratta, d’una riflessione scanzonata sul mestiere del regista, che se non è arrivato, è nessuno e quindi patisce le pene dell’inferno, aspettando un ingaggio qualsiasi e rodendosi il fegato. Gianni Dubois, infatti, interpretato da un Silvio Orlando contenuto e ironico, da cinque anni non batte chiodo: il telefono tace e di dirigere un film non se ne parla. Ma la Provvidenza gli aprirà una porta: ecco una fiction in tivù, con la stella del momento (Cristiana Capotondi). Idee per il copione, però, zero. In più, lo sfigato protagonista provoca un incidente domestico, mandando in rovina un prezioso affresco del Cinquecento, sulla parete d’una chiesetta adiacente alla sua casa toscana. Il risarcimento? Allestire lo spettacolo d’una Passione, con processione e tutto, in cinque giorni appena, manda a dire il sindaco del paesino (Stefania Sandrelli)... È chiaro il procedimento metaforico di Carlo Mazzacurati, regista già apprezzato ne “La giusta distanza”. La Passione di Cristo rappresenta la crisi creativa del cineasta (il povero cristo, appunto), mentre la Resurrezione coincide con l’agognato provino. Magari, qua e là, si sopravvaluta la possessione artistica, che colpisce Gianni, però le battute spiritose non mancano (‘Gli dai un dito e si prende pure la coscia’) e riesce efficace quel gigione di Corrado Guzzanti, pettinato come Renato Zero, mentre - da metereologo-attore, nella parte di Gesù - legge un copione manoscritto dai bambini d’una scuola, visto che pure la fotocopiatrice ha dato il due di picche... Ben assortito il cast: dalle graziose Kasia Smutniak, in veste di barista e Cristiana Capotondi, brava come stellina rompiscatole, al bonario ex-galeotto pazzo per il teatro (Giuseppe Battiston), l’oliato meccanismo gira, infine, intorno a un perno ben noto: la ‘passione’ di chiunque abbia a soffrire a causa del lavoro, quello assente e quello presente. Tema attuale, quindi, svolto però con freschezza. La Stampa - Lietta Tornabuoni Una commedia amara intelligente e divertente. Silvio Orlando è un regista di grande insuccesso: da anni non dirige un film, viene dimenticato persino negli elenchi di cineasti, una divetta televisiva può trattarlo malissimo. Nel paese toscano dove ha una casa, per incidente si trova costretto a dirigere una sacra rappresentazione, Ultima Cena, Calvario, Crocefissione di Gesù. Non se ne cura quasi affatto, a tutto provvede l’aiuto Battiston. L’attoreGesù, Corrado Guzzanti, è insopportabile; la sindaco Stefania Sandrelli è implacabile; arrivano i guai, uno dopo l’altro. Ma alla fine lo spettacolo conquista il pubblico con la forza della propria evocazione, con la suggestione dell’antica azione, con il fascino della parola dei Vangeli (l’errore più buffo, ‘Prima che il gatto canti’ anziché il gallo, è stato corretto durante le prove). La commedia ben fatta, impasto di risate e tristezza, popolata di persone di buona volontà, è recitata magnificamente: Silvio Orlando raggiunge una brusca malinconia sfiduciata, Giuseppe Battiston si mostra arrivato a una bravura matura e insieme leggera, Corrado Guzzanti è insuperabile. Il Messaggero - Fabio Ferzetti Un regista sull’orlo di una crisi di nervi (Orlando). Un paesino 57 SCHEDE FILMOGRAFICHE 26 POTICHE - La bella statuina di François Ozon 19-20 maggio 2011 (1967 Parigi ). Ozon da giovane inizia a lavorare come modello, ma ben presto si appassiona alla settima arte, si laurea in storia del cinema nel 1993 alla scuola di cinema La Fémis, in quegli anni inizia a realizzare un elevato numero di cortometraggi, fino al 1998, quando debutta con il suo primo lungometraggio. “Sitcom - La famiglia è simpatica”, che lo pone all’attenzione come uno dei più interessanti tra i nuovi autori del cinema francese. La sua fama si consolida grazie a pellicole come “Amanti criminali” e “Gocce d’acqua su pietre roventi”, quest’ultima basata su un’opera scritta R.W.Fassbinder. Nel 2000 dirige “Sotto la sabbia”, primo film della cosiddetta trilogia del lutto, che si chiude nel 2005 con la pellicola “Il tempo che resta”. Ma il successo internazionale arriva nel 2002 con “8 donne e un mistero”, dove raduna diverse generazioni di attrici francesi e confeziona uno dei suoi film più noti al grande pubblico. Nel 2007 dirige “Angel - La vita, il romanzo”, prima produzione girata in lingua inglese. Nel 2009, invece, dirige la fiaba “Ricky - Una storia d’amore e libertà”, presentato alla 59ª edizione del Festival di Berlino. Interpreti: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Judith Godrèche, Jérémie Rénier, Karin Viard, Fabrice Luchini, Évelyne Dandry, Sinead Shannon Roche Genere: commedia Origine: Francia Soggetto: Ispirato all’omonimo romanzo di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy Sceneggiatura: François Ozon Fotografia: Yorick Le Saux Montaggio: Laure Gardette Durata: 103’ Produzione: Mandarin Cinéma, Eric Altmayer, Nicoals Altmayer Distribuzione: BIM SOGGETTO: 1977, Sainte-Gudule, Francia settentrionale. Robert Pujol, ricco industriale, dirige con pugno di ferro la sua fabbrica di ombrelli, mostrandosi dispotico anche con i figli e con Suzanne, la “moglie-trofeo”, sottomessa e costretta alla vita domestica. Quando gli operai entrano in sciopero e sequestrano Robert, Suzanne lo sostituisce alla guida della fabbrica. A sorpresa, la donna rivela una gran competenza e capacità d’azione. Ma Robert torna dal suo viaggio di riposo in forma smagliante e tutto si complica... VALUTAZIONE: Potiche, ovvero una lezione di recitazione. E così potremmo continuare a lungo. Il film in questione, ennesima interessante opera del cineasta francese François Ozon.In ogni caso, Ozon ha realizzato una commedia, vagamente surreale, di raro equilibrio formale, nonostante la pericolosa (a livello estetico) ambientazione anni settanta e la volontaria tendenza a un’impostazione visuale kitsch. Pur ammiccando in modo velato alla saga Peppone-Don Camillo, l’incontro scontro tra la padrona/industriale Suzanne (Catherine Deneuve) e il sindaco comunista/rivoluzionario Babin (Gérard Depardieu) è in realtà la metafora (ma neanche tanto) di quell’accordo politico avvenuto nei decenni successivi (ottanta/novanta) tra certa sinistra riformista e alcuni potentati economici.Ma è la forza dei personaggi femminili a farla da padrone in questo lungometraggio, tutti ben delineati, divertenti e ironici. 58 SCHEDE FILMOGRAFICHE Nonsolocinema - Ilaria Falcone Potiche è il nuovo film del creativo e brillante regista francese Francois Ozon, in concorso alla 67. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Per la terza volta, nella sua prolifica filmografia, Ozon adatta per il grande schermo una piece teatrale (dopo “Gocce d’acqua su pietre roventi” e “8 donne e un mistero”). Il termine “potiche”, equivalente italiano della “bella statuina”, designa una specie di grosso vaso o altro oggetto decorativo privo di grande valore, che si mette su un mobile o una mensola del camino allo scopo di arredare un locale, senza che abbia una vera utilità. Ed è così che viene considerata Suzanne (Catherine Deneuve), una moglie tutta casa e famiglia, consorte dipendente dal marito Robert Pujol (Fabrice Luchini), che dirige una fabbrica di ombrelli. La figlia stessa crede che la madre si diletti a fare la bella statuina. L’uomo ha un atteggiamento freddo e sprezzante, dispotico, nei confronti della famiglia e dei suoi dipendenti. A seguito di uno sciopero e del sequestro del marito, Suzanne si ritrova a prendere in mano le redini della situazione: interagisce con i sindacati, pianificando la nuova gestione della fabbrica. Con grande sorpresa di tutti, figli compresi, si rivela una donna intelligente, con coraggio e determinazione da vendere.Una bella statuina, ma non certo di porcellana. La situazione si complica quando Robert ritorna in piena forma, pronto a riprendere sotto la sua guida tutto e tutti. Anche perché nella vita di Suzanne si è riaffacciato un antico amore, Babin (Gerard Depardieu). Potiche è una storia crudele, arguta, divertente, che arriva dopo Il rifugio, storia di, e su, drammi, sfumate rinascite, paure incallite e nuove speranze. Ozon ha diretto un film sul ruolo della donna nella società, sulla sua emancipazione; tratto dall’opera teatrale di Barillet e Grédy, è ambientato nel 1977, ma la voglia narrativa di affrontare questo tema è venuta al regista perché “ volevo evidenziare il maschilismo che ho visto durante la campagna elettorale che ha contrapposto Sarkozy a Segolene Royale.” Da questo spunto ha realizzato un adattamento disinvolto, partendo dalla situazione della donna negli anni Settanta e sulla divisione di classe: borghesia e operai. Potiche è un allegro melodramma, che evoca il tono e la verve di certe screwball comedies, con quel tocco musicale delicato e improvviso che alletta gli occhi e allieva l’animo. A coronare un film, semplicemente squisito e spietato, una coppia stupenda, la Denueve e Depardieu, che duettano con una maestria esilarante. L’immedesimazione o l’empatia che si prova nei confronti di Suzanne è immediata, il suo personaggio regala risvolti “sovversivi” leggeri e smaglianti. Diretta già da Ozon in 8 donne e un mistero, qui aggiunge anche quel tocco di ironia superba, che si plasma su un personaggio magnifico.Potiche dimostra l’estrosa e sensibile arte di un regista, che sa passare da un genere all’altro, con amore e passione, dal dramma alla commedia, con eleganza, curiosità e scioltezza. La delicata e trascinante forza di Potiche appassiona, dai colori ai dialoghi spiazzanti, dalla forza che ogni gesto e ogni sguardo comunica, senza retorica, riuscendo sempre ad alleggerire armoniosamente la vita. Filmup.com - Monica Cabras Potiche, dal francese, è un vaso, un oggetto decorativo di poco valore, che non ha alcuna pretesa di essere utile, ma esiste solo per arredare e ornare un mobile, una mensola, o il camino.È questo è il ruolo che Francois Ozon ha scelto per Catherine Deneuve, in un film intitolato, appunto, “Potiche”, tratto dalla pièce teatrale di Barillet e Grédy, prolifici autori teatrali del genere francese definito “boulevard”. La celebre attrice francese, infatti, in questo film interpreta Suzanne, figlia di un industriale, la cui fabbrica è stata rilevata dal marito despota e tirannico, e il cui unico scopo è quello di essere una buona moglie, una buona mamma, senza mai contraddire nessuno, ma anzi, cercare sempre la mediazione e il rappacificamento: insomma, una bella statuina, come la definisce la figlia. I problemi sorgono quando il marito si deve allontanare dalla fabbrica per motivi di salute, e in un periodo tumultuoso in cui gli operai chiedono un contratto più adeguato. La brava Suzanne, supportata dal sindacalista Babin, (Gerard Depardieu), decide di sedere nel posto che era stato prima del padre e poi del marito e con il suo spirito accomodante e arguto riesce a risollevare le sorti della fabbrica, rendendo felici gli operai e aumentando produzione e profitti.Sembrerebbe la classica fine da “...e vissero tutti felici e contenti” se non fosse per il marito, che al rientro dal suo ritiro sanitario, rivendica la sua poltrona...Ambientato negli anni ’70, il film descrive bene un’epoca di tumulti individuali e collettivi, dove la lotta di classe definisce profonde barriere interpersonali. La regia e la fotografia, così colorate e frizzanti, si sposano bene con il fermento di quegli anni. I costumi e le scenografie sono perfetti e così accurati nei dettagli che ci si chiede come sia possibile che “Potiche” sia un film girato nel 2010.Ed è appunto questo il problema, il film risponde talmente bene ai clichè della commedia francese anni ’70, negli argomenti, nei dialoghi, nelle situazioni comiche, che finisce per diventare anacronistico. E ad aumentare questa sensazione, c’è la presenza di due attori come la Deneuve e Depardieu, che in quel periodo hanno visto l’acme della propria carriera. Vederli ora così... bisogna dirlo... invecchiati, che si lanciano sguardi languidi e sorrisi maliziosi, in memoria di un fugace momento di rovente passione di gioventù, conferisce al film quell’aria malinconica e nostalgica che mal si sposa con l’intento di creare una commedia divertente e pungente. Senza nulla togliere agli amori senili, e alla dolcezza, tenerezza e passione che si possono sentire e riscoprire anche in tarda età, ciò che intendo è che in questo film, la situazione che si crea è quella in cui gli attori, e la loro fama passata, soggiogano l’attenzione del pubblico, modificando l’intento dei realizzatori del film, facendo passare in secondo piano la storia, la sua realizzazione, la caratterizzazione dei personaggi di contorno, se pur così attenta e ironicamente preziosa.In conclusione, “Potiche”, è una commedia semplice, che diverte senza alcuna pretesa, adatta a chi vuol fare un tuffo nella memoria... una sorta di vaso antico che un po’ stona con l’arredamento moderno, ma che per motivi affettivi non possiamo buttare via. 59 SCHEDE FILMOGRAFICHE 27 WE WANT SEX di Nigel Cole 26-27 maggio 2011 (Il film uscirà nelle sale italiane il 3 dicembre 2010) Nigel Cole (Regno Unito, 1959) ha esordito alla regia con il lungometraggio “Saving Grace” (L’erba di Grace, 2000), che ha vinto un British Independent Film Award per il Miglior regista e il Premio del pubblico al Sundance Film Festival. Nel 2003 ha realizzato “Calendar Girls”, che ha ottenuto un enorme riscontro di pubblico e critica. Sono seguiti “A Lot Like Love” (Sballati d’amore, 2005) e “$5 a Day” (2008). Nigel ha diretto la serie di documentari sulla natura “In the Wild” (1993), che ha incluso gli episodi: Galapagos with Richard Dreyfuss (1996) e Orangutans with Julia Roberts (1998), che ha vinto un Genesis Award per PBS Documentario dell’anno. Per la televisione ha diretto la serie “Cold Feet” (1997) e il medical drama “Peak Practice” (1993). Interpreti: Sally Hawkins, Bob Hoskins, Miranda Richardson, Rosamund Pike, Andrea Riseborough, Daniel Mays, Jaime Winstone, Kenneth Cranham, Rupert Graves, John Sessions, Richard Schiff, Geraldine James, Roger Lloyd Pack Genere: Drammatico Origine: Gran Bretagna Sceneggiatura: William Ivory Fotografia: John de Borman Musica: David Arnold Montaggio: Michael Parker Durata: 113’ Produzione: Stephen Wooley Elizabeth Karlsen - Number 9 Films Distribuzione: Lucky Red SOGGETTO: Rita O’Grady guidò nel 1968 a Ford Dagenham lo sciopero di 187 operaie alle macchine da cucire che pose le basi per la Legge sulla Parità di Retribuzione. Lavorando in condizioni insostenibili e per lunghe ore rubate all’equilibrio della vita domestica, le donne della fabbrica della Ford di Dagenham perdono la pazienza quando vengono riclassificate professionalmente come “operaie non qualificate”. Con ironia, buon senso e coraggio riescono a farsi ascoltare dai sindacati, dalla comunità locale ed infine dal governo. Rita, la loquace e battagliera leader del gruppo, risulterà un ostacolo non facile per gli oppositori maschi e troverà nella battaglia della deputata Barbara Castle la sua eco per affrontare il Parlamento, maschilista. VALUTAZIONE: Una storia che è “Storia”, con la S maiuscola, per un film ben fatto, con un cast all’altezza, una fotografia sbiadita e vintage, una ricostruzione dell’epoca accettabile ed uno script chiaro nel raccontare i fatti, così come avvennero, ma senza mai entusiasmare. Nigel Cole da’ la sensazione di non lasciarsi mai andare, di tenere il freno a mano tirato, con la sua proverbiale ironia troppo spesso trattenuta, facendo così scorrere il film in maniera fluida, senza però coinvolgere eccessivamente lo spettatore. Autentico titolo femminista, con il ‘girl power’ vero protagonista, il film ha il merito di portare sul grande schermo una pagina fondamentale nella storia delle battaglie per i diritti, mostrando una donna finalmente consapevole della propria forza e pronta a scendere in strada per chiedere rispetto ed uguaglianza, troppo spesso, ancora oggi, dimenticati. 60 SCHEDE FILMOGRAFICHE Eco del Cinema - Domenica Quartuccio Quello che le donne della fabbrica Ford di Dagenham vogliono non è il sesso, ma la parità dei sessi nella paga. Siamo nei sobborghi di Londra, nel 1968, e Rita (Sally Hawkins) è una brava lavoratrice e anche una brava mamma e moglie. La situazione lavorativa sua e delle altre 186 donne della fabbrica (a fronte di una presenza di 500 mila uomini) non è certo delle migliori: condizioni lavorative insostenibili e paga al di sotto di quella maschile, nonostante il loro lavoro sia qualificato quanto quello degli uomini. Queste le premesse che daranno il via ad una delle lotte sindacali più importanti della storia inglese e che porteranno, nel 1970, alla legge che parificherà il trattamento economico tra uomini e donne e faranno della Ford una delle fabbriche più all’avanguardia in questo settore. Nigel Cole, già piacevolmente conosciuto grazie a pellicole quali “L’erba di Grace” del 2000 e “Calendar Girls” del 2003, sceglie di portare alla luce una storia sorprendente che è rimasta sconosciuta per quasi 42 anni con l’intento proprio di farla conoscere al grande pubblico. Presentato al Festival del Film di Roma 2010, nella sezione Fuori Concorso, “We Want Sex” è una commedia dai toni leggeri ma nello stesso tempo forti. Quello che queste donne sono riuscite a fare in un’epoca fortemente maschilista, come quella della fine degli anni 60, è ammirevole. Il cast è davvero notevole, le protagoniste, Sally Hawkins e la grande Miranda Richardson, sono convincenti, interpretano con entusiasmo i loro ruoli e riescono a trasmettere lo spirito combattivo di cui erano provviste le vere lottatrici dell’epoca. La pellicola è essenzialmente basata sul concetto di uguaglianza, quella tra uomini e donne, ma anche quella tra persone di ceti sociali diversi. È questo che colpisce della storia, la naturalezza con cui Rita acquisisce pian piano la consapevolezza di essere come gli altri e, di conseguenza, di dover pretendere uguaglianza di trattamento. Nel cast anche un grande Bob Hoskins. narratore di vicende al femminile in Calendar Girls e L’erba di Grace, dà vita ai ricordi delle scioperanti di Dagenham, ispiratrici e anima autentica della pellicola. Più che lo spirito degli Swinging Sixties, il cui glamour ha catturato tanti cineasti, a Cole e allo sceneggiatore William Ivory interessa ricreare lo spirito di queste donne, naturalmente unite, capaci di fare per tanti anni buon viso a cattivo gioco lavorando in condizioni proibitive nello stabilimento della Ford, e dotate di un distintivo working class humour. L’entusiasmo e la forza d’animo delle protagoniste è effettivamente contagioso, e assieme alla bravura degli interpreti - accanto alla Hawkins, anche un simpatico Bob Hoskins, uno spigoloso Richard Schiff e una solare Miranda Richardson (che interpreta il ministro laburista Barbara Castle) - contribuisce ad abbassare le difese dello spettatore, a fronte di una sceneggiatura forse un po’ prevedibile e semplicistica nello sviluppo, e a intrattenere con efficacia, seppure in maniera epidermica. La leggerezza con cui si affrontano argomenti importanti e si sfiorano problematiche drammatiche è comprensibile se si inquadra il film per quello che è, una commedia indirizzata a un pubblico vasto e poco selettivo. Peccato che, pur appassionando alle gesta delle protagoniste e celebrando l’impresa riuscita 42 anni fa a un gruppo di tenaci donne inglesi, il film faccia poco per risollevare il dibattito su questioni ancora estremamente attuali. 35mm.it - Silvia Marinucci Sono forti e determinate le donne di Nigel Cole. La pellicola, tratta da una storia vera mai raccontata, porta alla luce il primo sciopero femminile avvenuto nel 1968: un gruppo di operaie inglesi della Ford chiede ai propri dirigenti la parità salariale. È ‘colorato’, ironico e avvincente il ritratto di Nigel, la sua macchina da presa segue passo dopo passo la ‘lotta’ senza sosta di questo gruppo di ‘ribelli’. Cole dimostra una sensibilità e un’attenzione particolare al tema della parità sessuale. Senza mai essere scontato o banale riesce a centrare l’obiettivo. Non dà giudizi e non ne ha bisogno. Lascia che a parlare siano i fatti, le immagini, le incredibili interpretazioni delle protagoniste. Non si tratta di femminismo, ma di ‘lotta sociale’: il regista inglese regala una ‘lezione di storia’, raccontando avvenimenti che hanno letteralmente cambiato il futuro della classe lavoratrice femminile. Non a caso, accanto alle operaie, c’è una donna (moglie di un manager) - colta - laureata in storia in una delle migliori università - alla quale non è permesso esprimere le proprie ambizioni a causa di suo marito. Ma non solo. La stessa sorte spetta anche a Barbara Castle, deputata in Parlamento. Ognuna di loro ha ‘combattuto’ in prima linea per cambiare le cose, con semplicità, senza far ricorso a partiti o uomini di potere. Impossibile non sorridere, non partecipare e non emozionarsi. L’ambientazione è perfetta, la sceneggiatura priva di sbavature. Lontano dai toni grigi e cupi dei cosiddetti ‘film sociali’, Cole ha il merito di trovare la giusta chiave di lettura. L’ironia è la sua carta vincente. A coadiuvarlo nell’impresa un nutrito cast di attrici, tra le quali emorgono Sally Hawkins (alias Rita O’Grady, a capo della protesta) e una incisiva e ‘infuocata’ Miranda Richardson. Il gioco è fatto. La meta raggiunta. Movieplayer.it - Alessia Starace 1869. Sulle rive del Tamigi sorge lo stabilimento industriale più grande d’Europa, quello della Ford di Dagenham, che impiega 55.000 operai uomini, e 187 donne, impiegate nell’assemblamento dei rivestimenti dei sedili delle vetture, e recenti vittime di un ingiusto declassamento che le pone a un livello subordinato rispetto a colleghi uomini che hanno mansioni molto meno specializzate. Questa è la scintilla che innesca un a situazione potenzialmente esplosiva: spronate dalla timida ma risoluta Rita O’Grady, le operaie avviano un’azione senza precedenti, uno sciopero a oltranza che, grazie all’incoraggiamento di un coraggioso sindacalista, si trasforma in una pionieristica protesta per ottenere la parità La battagliera Rita - interpretata dall’adorabile e bravissima Sally Hawkins - guida le fila di un’azione che, generata dalla volontà unanime delle ragazze di Dagenham, le portetà inaspettatamente lontano: una storia vera, quella narrata nel film di Nigel Cole, che paradossalmente in Inghilterra nessuno conosce. Ma a rendere la terra d’Albione uno dei paesi democraticamente avanzati sono state persone come queste, animate da un principio e sostenute dalla solidarietà reciproca. È con levità e brio che Nigel Cole, già delicato 61 SCHEDE FILMOGRAFICHE 28 UNA VITA TRANQUILLA di Claudio Cupellini 9-10 giugno 2011 venerdì 10 giugno 2011 - ore 19,00 Manifestazione di fine stagione e proiezione con premiazione del concorso CineCortoRomano Il primo spettacolo di venerdì avrà inizio alle ore 15,00 Claudio Cupellini (Padova 1973) è stato allievo di Paolo Virzì e Daniele Lucchetti al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dal 1999 al 2005 realizza diversi cortometraggi fra cui: “Le diable au vélo”, esordio alla regia, “Chi ci ferma più” (2004) e “La talpa” (2005). Nel 2006 dirige “La donna del Mister” episodio del film “4-4-2 Il gioco più bello del mondo”. Debutta nel lungometraggio con la commedia “Lezioni di Cioccolato”, che ottiene la nomination al David di Donatello (2008). “Una vita tranquilla”, da un soggetto vincitore del Premio Solinas (2001), scritto in collaborazione con Filippo Gravino e Guido Iuculano, è il suo secondo lungometraggio. Interpreti: Toni Servillo (Rosario Russo), Marco D’Amore (Diego), Francesco Di Leva (Edoardo), Giovanni Ludeno (Enzino), Maurizio Donadoni (Claudio), Juliane Kohler (Renate), Leonardo Sprengler (Mathias), Alice Dwyer (Doris) Genere: drammatico/noir Origine: Italia/Francia/Germania Soggetto: Il film è tratto dal soggetto “Il Nemico dell’Acqua” di Filippo Gravino vincitore del Premio Solinas 2003 Sceneggiatura: Claudio Cupellini, Filippo Gravino, Guido Iuculano Fotografia: Gergely Poharnok Musica: Teho Teardo Montaggio: Giuseppe Trepiccione Durata: 105’ Produzione: Fabrizio Mosca - Acaba Produzioni, Babe Films, Eos Entertainment; in collaborazione con Rai Cinema, Canal +, Cinecinema Distribuzione: 01 Distribution SOGGETTO: Rosario Russo ha poco più di cinquanta anni. Da dodici vive in Germania dove gestisce, insieme alla moglie Renate, un albergo ristorante. La sua vita scorre serena: ha un bambino (Mathias), un aiuto cuoco (Claudio) che è anche un amico, e molti progetti per il futuro.Un giorno di febbraio, però, tutto cambia. Nel ristorante di Rosario arrivano due ragazzi italiani. Il primo si chiama Edoardo ed è il figlio di Mario Fiore, capo di una delle più potenti famiglie di camorra. L’altro si chiama Diego, e Rosario lo riconosce subito perché Diego è suo figlio. Non si vedono da quindici anni, da quando Rosario si chiamava Antonio De Martino ed era uno dei più feroci e potenti camorristi del casertano.Allora si era fatto credere morto e si era ricostruito una seconda vita in Germania... Diego all’epoca aveva dieci anni, ora è cresciuto… VALUTAZIONE: Claudio Cupellini, che si era già fatto apprezzare con la commedia brillante “Lezioni di cioccolato”, cambia completamente genere e firma insieme ai bravi Guido Iuculiano e Filippo Gravino, premio Solinas nel 2003, uno straordinario thriller dalle atmosfere lunari e gelide, con una sceneggiatura strepitosa in cui primeggiano i dialoghi, in italiano, in dialetto napoletano e in tedesco. Nei ruoli dei protagonisti un impeccabile Toni Servillo, Marco D’Amore, giovane promessa del cinema italiano, nella parte di Diego, dallo sguardo feroce e malinconico e servo della camorra insieme all’amico d’infanzia Eduardo, interpretato dall’intenso Francesco Di Leva. 62 SCHEDE FILMOGRAFICHE Cinematografo.it - Valerio Sammarco Domani mattina parti per Amburgo. Ti tagli la barba, ti fai crescere i capelli, impari il tedesco e lavori tutto il giorno. La sera vai a letto presto, devi diventare un fantasma. E tra un anno cambi lavoro. Se tutto va bene avrai una vita tranquilla”. Rosario lo sa, per sopravvivere e tutelare quel figlio ora cresciuto, d’altronde, quindici anni prima aveva lasciato la Campania, la moglie e il bambino, per nascondersi in Germania, rifarsi un nome (il primo, quello vero, era Antonio De Martino), una famiglia, una vita. Ma nell’albergo-ristorante tra i boschi che ora conduce, l’arrivo a sorpresa di Diego, suo figlio, e del “collega” Edoardo, rimette seriamente in discussione quel lungo periodo di copertura: quel passato che sperava si fosse scordato di lui è tornato a riprenderselo.Ha più di qualche merito l’opera seconda di Claudio Cupellini, Una vita tranquilla: primo tra questi, il sapersi rivolgere allo spettatore senza costringerlo ai soliti, didascalici prologhi o eventuali pregressi dei personaggi principali. Del resto, insieme a Toni Servillo - bravo davvero ad incarnare il conflitto interiore di un uomo con un passato da nascondere e un presente da difendere, a mischiare con naturalezza parlata napoletana e lingua tedesca - e ai due esplosivi giovani camorristi (Marco D’Amore e Francesco Di Leva, rabbia e rancore trattenuti uno, istintivo e folle l’altro, entrambi da continuare a tenere d’occhio), il protagonista vero del film è proprio quell’ombra, strisciante e pesantissima, di un’epoca invisibile ma impossibile da dimenticare, comunque onnipresente e viva, ben resa dall’impianto di una sceneggiatura (Gravino, Iuculano, Cupellini) che dà il meglio di sé nella prima parte del racconto. I problemi, paradossalmente, si presentano dopo, proprio insieme al definitivo arrivo sulla scena di quel passato fino ad allora solamente sussurrato: la camorra torna a prendersi Rosario, e con lui il film, dando il via ad un’escalation di avvenimenti inverosimili (possibile nessuno si accorga dell’improvvisa sparizione di Edoardo? Possibile davvero che i sicari, in macchina, non riescano ad arrivare all’autogrill di Teano dove è rimasto Mathias, il figlioletto di secondo letto di Rosario, prima del loro bersaglio, appiedato e ferito?...). Interrogativi che rimangono senza risposta, come il nuovo “futuro” del protagonista, nascosto dietro il finestrino di un pullman. Confidiamo invece in un’avvenire luminoso per Cupellini, che dopo il leggero, seppur gradevole Lezioni di cioccolato, si confronta con il dramma di genere a testa alta, con buone idee di messa in scena e qualche dolly di troppo. Non ne risentono comunque le atmosfere del film, terzo tra i titoli italiani in Concorso al Festival . ma ammazza gli alberi con i chiodi perché vuole ampliare il suo hotel. Quello che si sforza di uccidere è anche il suo passato di pluriomicida che un giorno gli fa visita sottoforma di Edoardo e Diego, due giovani di malavita, minacce per la sua “vita tranquilla”. Complice la solita monumentale prova di Toni Servillo Una Vita Tranquilla di Claudio Cupellini soffre troppo di una somiglianza registica e di sceneggiatura con il Sorrentino di Le conseguenze dell’amore. Servillo è un Titta Di Girolamo più espansivo ma egualmente torbido che solo con i muscoli del viso apre al noir di buona fattura. Oltre questo sensibile ma circoscritto problema cinematografico, Cupellini passa bene dalla commedia di “dolci” sentimenti e product placement di Lezioni di Cioccolato al dramma di genere con profondità emotiva e accennato sfondo di cronaca: il caso rifiuti in Campania. Pellicola col taglio europeo dal collaudato tema del passato incancellabile, Una Vita Tranquilla instilla tensione fotogramma per fotogramma al ritmo delle ombre dei cattivi ricordi che coprono il plumbeo cielo tedesco e la coscienza pseudosmacchiata di Rosario. Le colpe dei padri ricadranno sui figli come pioggia di pallottole nella nera notte di qualche nonluogo e la salvezza è un’autostrada che non sappiamo dove finirà. L’unica certezza è il dubbio: si può vivere una vita tranquilla fuggendo nella nebbia ma non da se stessi? Eco del Cinema - Domenica Quartuccio Rosario (Toni Servillo) conduce una vita tranquilla: va a caccia di cinghiali che poi cucina nel suo ristorante, è innamorato della sua bella moglie Renate (Juliane Köhler) e si dedica al figlio Mathias (Leonardo Sprengler). Un giorno tutto questo cambia. Dal suo passato ritorna un fantasma, Diego (un sorprendente volto nuovo, Marco D’Amore), e la vita che credeva di aver seppellito ritorna in superficie prepotentemente costringendolo a farci i conti. In concorso al quinto Festival del Film di Roma, “Una vita tranquilla” di Claudio Cupellini (“Lezioni di cioccolato” del 2007 e “4-4-2” del 2006) è davvero un’ottima pellicola che ha tutte le carte per vincere, soprattutto per via dell’encomiabile Toni Servillo. Che dire di lui che non sia già stato detto o scritto? La sua bravura è ormai innegabile, la sua capacità di diventare davvero Rosario, un napoletano emigrato in Germania, lascia a bocca aperta. A tutto questo si unisce la capacità di recitare anche in tedesco. Una continua conferma. È davvero un momento d’oro per l’attore, molti degli ultimi film di cui è protagonista sembrano scritti appositamente per lui. Al suo fianco scopriamo Marco D’Amore, un giovane attore con anni di teatro alle spalle. Sono una coppia perfetta. Il centro della storia di “Una vita tranquilla” è la duplicità dell’essere umano. Davvero ci si può liberare del proprio passato? Davvero si possono cancellare con un colpo di spugna errori e fallimenti? Davvero si può diventare un altro? Forse sì, per vigliaccheria o per coraggio, chissà. Decidetelo voi. Mymovies.it - Luca Marra Al centro della Germania vive Rosario, italiano cinquantenne che mischia il cinghiale con il granchio nella cucina del suo albergo. Con un bella moglie e un figlio gentile, vive felice 63 Appuntamenti in Programma I DIBATTITI A FINE CICLO: sono previsti sette dibattiti, che si terranno alle ore 18.00 del martedì successivo alla fine di ciascun ciclo di film , nella saletta conferenze di Via Nomentana 333/c. IL CALENDARIO: 16 novembre 2010 – “Dimmi la verità. La gente non cade per le scale, succede solo nei film!” (Lluís Homar a Penélope Cruz in GLI ABBRACCI SPEZZATI) 21 dicembre 2010 – “Cezanne era un primitivo, ma era un primitivo geniale. Se manca il genio, uno rimane solo un primitivo!”. (il critico d’arte Vito Signorile a Sergio Rubini in L’UOMO NERO) 25 gennaio 2011 – “Il mio analista dice che non si può fare il regista nella vita: la vita non ha regia. Al massimo puoi fare l’attore!”. (Fabio De Luigi e Valeria Bilello in HAPPY FAMILY) 22 febbraio 2011 – “Gli amori impossibili sono quelli che non finiscono mai, che durano per sempre!” (Ilaria Occhini a Nicole Grimaudo in MINE VAGANTI) 22 marzo 2011 – “Sai, i tacchi so’ come i parenti: so’ scomodi, però aiutano!”. (la sorella Stefania Montorsi al fratello Elio Germano in LA NOSTRA VITA) 3 maggio 2011 – “Per 5.000 anni di storia del teatro non sono esistite le pause. Gli attori parlavano o ascoltavano. Recitavano, non facevano mai pause!”(L’insegnante di recitazione in CITY ISLAND) 8 giugno 2011 – “Un diario non serve quando sei felice!”(Francesca Neri in UNA SCONFINATA GIOVINEZZA) L’Assemblea annuale dei soci: 14 dicembre 2010 presso la sede di Via Nomentana 333/c Settimana Culturale: dal 28 marzo al 2 aprile 2011 - ad inviti - “Premio Cinema Giovane & Festival delle opere prime” VII edizione; Forum e Mostra Concorso di arti figurative Corsi culturali, organizzati dal’UPTER, presso saletta conferenze del Cinecircolo, calendario a parte LA MANIFESTAZIONE DI FINE STAGIONE E PREMIAZIONE CINECORTOROMANO: venerdì 10 giugno 2011, ore 19.00 Eventi speciali ed altre manifestazioni, in data da definire È in vigore una convenzione tra l’UPTER - Università Popolare di Roma e il Cinecircolo Romano. Entrambe le organizzazioni hanno interesse a promuovere la cultura cinematografica presso i propri iscritti e più in generale presso la cittadinanza di Roma e condividono l’impegno a sostenere la promozione reciproca e a sviluppare attività culturali comuni con specifiche forme di collaborazione. Le associazioni hanno convenuto di porre in essere una collaborazione che riguarderà in particolare: scambio materiali promozionali, eventi, corsi Upter e agevolazioni per le iscrizioni. 64 PROGRAMMA 46° ANNO 7/8 ottobre – rinnovi Avatar di James Cameron 28/29 ottobre – inaugurazione Hachiko – il tuo migliore amico di Lasse Hallström 4/5 novembre – La prima cosa bella di Paolo Virzì 11/12 novembre – Gli abbracci spezzati di Pedro Almodóvar 18/19 novembre – L’uomo nero di Sergio Rubini 25/26 novembre – Sherlock Holmes di Guy Ritchie 2/3 dicembre – L’uomo che verrà di Giorgio Diritti 9/10 dicembre – An Education di Lone Scherfig 16/17 dicembre – Invictus di Clint Eastwood mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre – Happy Family di Gabriele Salvatores 13/14 gennaio – Innocenti bugie di James Mangold 20/21 gennaio – Crazy Heart di Scott Cooper 27/28 gennaio – L’amante inglese di Catherine Corsini 3/4 febbraio – Mine vaganti di Ferzan Ozpetek 10/11 febbraio – L’uomo nell’ombra di Roman Polanski 17/18 febbraio – Robin Hood di Ridley Scott 24/25 febbraio – The Last Station di Michael Hoffman 3/4 marzo – La nostra vita di Daniele Luchetti 10/11 marzo – Il segreto dei suoi occhi di Juan José Campanella 17/18 marzo – Affetti & dispetti – la nana di Sebastián Silva 24/25 marzo – City Island di Raymond de Felitta da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile 2011 Settimana culturale – Premio Cinema Giovane – 10 film ad inviti 7/8 aprile – Bright Star di Jane Campion 14/15 aprile – Incontrerai uno sconosciuto alto e bruno di Woody Allen 28/29 aprile – Tamara Drewe – tradimenti all’inglese - di Stephen Frears 5/6 maggio – Una sconfinata giovinezza di Pupi Avati 12/13 maggio – La Passione di Carlo Mazzacurati 19/20 maggio – Potiche – la bella statuina di François Ozon 26/27 maggio – We Want Sex di Nigel Cole 9/10* giugno – Una vita tranquilla di Claudio Cupellini * il primo spettacolo di venerdì 10 giugno avrà inizio alle ore 15.00 Venerdì 10 giugno – ore 19.00 - Manifestazione di chiusura con proiezione e premiazione concorso CineCortoRomano per info: Via Nomentana 333/c - 068547151 - www.cinecircoloromano.it La segreteria dell’Associazione presso l’Auditorio San Leone Magno è attiva nei giorni di spettacolo dalle ore 17.00 sino alle ore 21.30, salvo diversamente indicato (06 8543216) 00198 Roma - V.le Regina Margherita, 176 - Tel. 06/855.39.82 Finito di stampare nel mese di Novembre 2010
Scarica