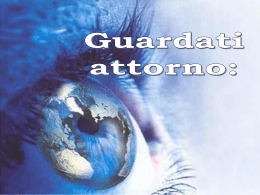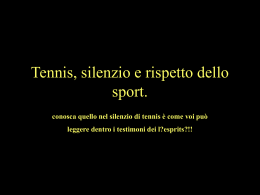DIRITTI D'AUTORE Per volontà dell'autrice questo libro è gratuito e non ha alcuno scopo di lucro. I testi sono protetti da licenza Creative Commons, pertanto qualunque utilizzo deve essere sottoposto alla volontà dell'autrice ed è necessario citare la fonte. INDIRIZZI DI CONTATTO mail: [email protected] profilo facebook: Alessia D'Errigo https://www.facebook.com/alessia.derrigo.7 BREVE BIOGRAFIA Alessia D'Errigo, ricercatrice in campo teatrale e cinematografico, scrittrice, interprete e regista di varie opere teatrali. Dopo un percorso classico come attrice inizia una ricerca personale sull’atto scenico e sulla reale necessità del suo manifestarsi. Nel 2004 apre, insieme al suo compagno, l’artista e regista Antonio Bilo Canella, il “CineTeatro di Roma” (www.cineteatro.org) centro di ricerca formazione e produzione in campo teatrale e cinematografico. Proprio al CineTeatro inizia un lungo percorso sull’improvvisazione totale: la Performazione (www.performazione.com) e porta avanti una ricerca personale sull’Improvvisazione Poetica. Da questa ricerca sull'improvvisazione poetica – nel 2011 – Alessia D’Errigo apre il progetto IMPROMPTU THEATRE (http://impromptutheatre.jimdo.com/ ), l’intento è quello di voler fondere varie arti (musica, poesia, danza, pittura e teatro) in uno scenario d’improvvisazione totale. Progetto sancito dall’omonimo spettacolo “Impromptu” con il pittoreperformer Orodè Deoro, e da altre due performance “Variazioni Belliche (LamentAzione)” e “Per i tuoi occhi bianchissimi”. VEDI VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=h9WManvZMwA Nel Dicembre 2013 una ventina di testi della raccolta 'Pasto Vergine' vengono pubblicati nella rivista POESIA di Crocetti Editore (n°288) nella sezione 'Cantiere Poesia' dedicata agli inediti e diretta da Maria Grazia Calandrone. Nel 2011 pubblica la sua prima silloge poetica ‘Carne d’aquiloni’ con l’editrice Zona nella collana 'Contemporanea'. I suoi testi sono presenti in numerosi blog, riviste (web e cartacee) e in alcune antologie. Ha curato la rubrica di poesia al femminile ‘Rediviva Donna (classica e contemporanea)’ sulla webfanzine Versante Ripido. Se mai più parlerò sopravvissuta al caso con la pelle rosa in quarantena Alessia D'Errigo PASTO VERGINE E cosa ti racconto ora, se le creature vengono a me se le sento strillare e raggrumarsi nel sotto sterno in preda ad un richiamo naturale, quello per cui combatto e difendo Dio, e cosa ti racconto ora che la luna è diventata acqua per abbeverare i morti, i passi grevi della terra ed i passi miei. Potrei mentirti, calare i veli, tirare giù le coltri, imbrogliarti ma qualcuno strilla, uno dei tanti, l'altro parla, uno dei muti ed io rido parlo e sto muta. Forse sono pazza. Bisognerà pur farlo uscire questo dolore, l'urlo del parto, del cuore, l'efferatezza blasfema della ghiandola animale. Bisognerà pur sfaldarsi e ricomporsi, come i castelli di sabbia nelle mani dei bambini, del mare, castelli ad illuderci, bambini, nel mare. Bisognerà calare sì, nelle coltri, il vestito bianco, affogarlo nella sozzura, nel limbo delle ceneri purché ne venga una grande luce fuori, ad accecarci, lasciandoci informi e plasmabili, sciolti verso l'avvenire, purché venga a noi questo avvenire, come la piuma di un angelo ad accarezzarci nella bolla del ventre. Io voglio sì, una carezza, nella bolla del ventre. Remunerami il pianto, biglia del basso ventre che caracolla al sole, remunerami le prestazioni a cui affido l'addio e il ritorno una dispersione afona d'intenti (comprese queste parole). Remunerami l'afflato del vento, che mi schiaffeggia giorno e notte circondandomi d'amore e morte. Per queste strade che non vedo, per i prati che si aprono cingiti lieve, dimenticami in un bacio, nelle fluorescenze dei corpi purché si sfaldi la parte di me che teme l'orrore, il disperato eco di ritorno della vita, per la vita, del suo sale, fuliggine dei morti su tombe di cemento. Io piango, tu piangi, la terra trema, Dio trema. Potremmo perdonarci domani, affiancarci spalle a spalle per questa grande notte nera, sognare lo stesso sogno, un luogo nuovo che s'apre, lasciar salire lo stesso canto. Anche io sono avversa alla mia forma, alla tua forma, alla mia. Io sono avversa sì, a questa morte, al lutto dei giorni senza fiori e rammendo nel cuore un biancospino per ricordarmi del nome e rammento il tuo nome ch'è il biancospino ricamato nel petto. Il profumo dei fiori, l'inevitabile profumo dei fiori. Perché è notte? Cos'ho oscurato senza ricordare? C'era un davanzale una stanza e poi la coltre scura di qualche oblio, in sordina, una memoria vicina alla pelle, l'ortica dei tuoi occhi. Viene l'acqua breve, dai flutti carnefici a spezzare il grembo. Viene l'acqua breve a scavare le rive. Che tu sia libero o legato alla sua foce, passa ed abbevera, lasciando lo scolo alle mandrie dal pascolo brado: Il clone mio Dio, intro la pelle, la stessa pelle, la parte di cuore che non crede più, la parte di cuore che s'annida alle spalle dell'inverno seno tuo Gesù. Bastino le pietre a salvarci, gli stagni bastino purché si taccia questo pensiero eretto e doppio; l'eredità dell'uomo verso l'uomo, la guerra e l'eucaristia. I corpi mangiano e bevono dalla foce dei Tuoi occhi sghembi prostrati a nocciola lungo la terra, il sacrificio dei tuoi sensi è un tutt'uno con la croce. Ti guardi e guardi, uno morrà. Ti guardi e guardi, uno morrà. Viene l'acqua breve, dai flutti carnefici a spezzare il grembo. Viene l'acqua breve a scavare le rive. Il giglio aperto si schiude, addio. Il giglio aperto ha vesti esangui, il nudo grembo madre di ricordo, madre di pancia, addio. Madonna madre chiedi alla figlia, Madonna madre che nel silenzio bianco, chiedi. Non ti somiglio per forma e grazia, non ti somiglio. Pulsione di carne senza lacrime sante, di me dentro te, un giorno fu. Madre Madonna figlia, non ti somiglio per grazia e pallore, ho cosce sode, sguardo al mondo, l'uovo pronto a sacrificare dalla tua testa. L'indice e il medio tra gli occhi ho spostato, per accecare il tuo martirio di donna, il fuoco del tuo cuore è una prigione di preghiere. Madre sposa del nulla, il tuo vacuo sguardo porgi sulla terra, l'imene del seme tuo Gesù. Donna avvinta all'amore, alla carne senza peccato, all'amore, alla carne senza peccato. Figlia madre Madonna sposa, porgi l'imene del seme tuo Gesù. Noi, animali da terra in avanscoperta dalle coronarie inesplose come fossimo parto maturo in perenne ventre, una lotta di placenta appesa tra il calvario di questo e l'altro mondo, il nostro pianto T'arrivi greve a spostarti gli occhi, un'emergenza d'angeli a prenderci in caduta, nel giorno del sangue ove la grande fessura s'aprirà, pronta, a far uscire i nostri corpi. Eludere tutto il mondo, un cimitero per i vivi. Eludere la croce madre degli scacchi, l' indolente forma di pianto e ruoli gomena senza appiglio: riportare a terra gli occhi riportare a terra gli occhi riportare a terra gli occhi E tu ringrazia me, ringrazia l'altro che tutti si ringraziano nella gogna dei loro giochi, la fatica è la forma del male più noto un'incisione sulla schiena a suonare preghiere e organi, a mangiarci l'ossa, inginocchiati sui ceci della speranza. E tu ringrazia me, ringrazia l'altro che tutti si ringraziano a passarsi i fili tra i polsi nel teatro dei ciechi come scudieri delle paure duellanti con lance di frassino. Chi cadrà? E' l'editto dei morti che monta a cavallo col suo esercito sbieco a scrosciare sul mondo liquidi santi: la castità per una croce! La castità per una croce! (è tutto un urlo di guerra). E che parlo se tu non ascolti oltre le prostrazioni del corpo, se parlo senz'ugola di pietate per questo crocicchio nudo e informe: ancora è l'inferno senza pensiero, ancora è l'inferno senza l'azione del pensiero. La bocca di storto a colorare il mondo, a semplificarlo nel suo secchiello d'oro. Come piccoli pesciolini ammaestrati si facevano gl'uomini, gli uni davanti agli altri, con le teste calve al loro calvario, bacio inesistente fatto di sproloqui e mai di corpo. E perdio! Lo rivendico 'sto corpo. Io non so se il cielo possa fabbricare le tue mani di carta, la nuvola sclerotica del petto e la pioggia che viene, sempre. Io mi ci fabbricherei un pozzo per vedere il mondo nel suo ombelico, cadervici dentro sarebbe mandare in pezzi la sala delle bambole. Fabbricando fabbricando ho sognato un filo d'oro che dal pertugio del ventre saliva pendulo al seno, era il latte del tempo trascorso che più non torna. Tu invece fabbricasti, mentre io dormivo, un sogno che viene dal mare, un sale porporino aperto agli occhi, pianto distillato a cadere, e cadesti. Pregando, in sordina, fabbricai l'antenna sensibile all'urto e allo schianto, m'arrampicai nel pozzo, accecai le mie bambole, misi il sogno in una scatola, col pozzo costruii un binocolo, l'ombelico divenne un bottone e tra i seni s'addormentò un bambino. Talune volte vorrei anch'io, donna Madonna, lanciarmi dall'arco dello sterno priva di cuore, a sasso, correre verso le alture, ostia bianca d'un medesimo schianto svuotata e randagia come l'icona del viso Tuo; le mani caste, le vesti caste e gli angeli al seguito. Occhi senza occhi, labbra senza fiore, vene di latte e candore Lasciarmi scorrere dal tempo, marmo freddo marmo, stendere il corpo, statua di Dio, scolpita, finalmente, a Sua immagine e somiglianza. Oh, occhi senza occhi, labbra senza fiore, vene di latte e candore Gli angeli volano a croce nel mondo scudi di riparo al male, nell'informità riposta a rondine ove danza, nel cielo, una danza. Oh, canto nella parola e piuma ch'è latte segreto immune involuta di nubi da cui i corpi si estraggono, come a forgiarsi, armi in caduta sul piano immenso ch'è il fondale di Dio. Sono confusa dal torrido che sempre arriva e s'acqueta adagio adagio nella pancia perché non è tempesta, ma silenzio del vento che tende a bonaccia il cuore e sprofonda a mani nude questo sasso. Al cospetto di tanto amore, di così incommensurabile bellezza al cospetto degli angeli che planano lieti, d'un filo d'erba bruna: una cicala, stridente, che punge nel cuore la sua pena, la pena di una piccola cicala che stridente mi cerca forse invano - forse sposa antica delle albe - forse semplice canto al mondo: Di quel ramo spezzato che solca il terreno e separa le dighe - cosa rimane? di quel prato fiorito che impermea il mattino - cosa rimane? e di me, di me, nell'antico parto della mia mente nell'antico parto che perde il suo domani, il suo ieri e resta - cosa rimane? Sopravvivono gli uomini, gli uni con gli altri gli uni contro gli altri uno per sé, l'altro per loro e l'uno e l'altro da soli e l'uno e l'altro che piangevano - soli che urlavano canti d'alture che amavano al di sopra dei canti d'alture cosa rimane? Io sottendo in me un piccolo limbo io sottendo in me questa ribellione un luogo d'ascolto segreto dove proseguir quel canto dove proseguir quell'amore ma in nome di chi, di che? Per quale strada ch'io non posso vedere oggi per quale domani se il tempo è una meteora caduta a picco sulla terra per quale agone sacro io conduco questo gioco - questo giogo bendata come la dea fortuna al cospetto della mente florida, quella che anche se non vede non può tacere Quanto pianto ancora nasce dai nostri lembi vuoti: come una Madonna sulla sedia a rotelle m'accingo al Miracolo Umano procrastinando solo il tempo d'un addio (sferzata lucida) procrastinando l'ultimo male colto (petalo che si schiude e muore) imberbe nascita da cui esigo il ritorno: purché la vita aspetti - purché la vita ci salvi per atto nostro (amen) ho ucciso l'ultimo deus-ex-machina mentre la luna spiumava la sua forma più vergine imbellettandosi appena le guance imbellettava a sua volta le mie coloriva naturalmente il suo essere assieme al mio uccidendo quest'ergastolo divino spogliandomi nuda e liliale calpestandomi di luce, di latte, d'amore oh, quanto pianto mio (d)Io nasce ancora dai nostri lembi vuoti: Sono la sovversiva che rende il pianto al mondo la contingenza estrema d'ogni male come se fosse una culla d'abbracciare una madre sempre in procinto di partorire. Cantando: Strimpella il suono della neve che sembra un fiume di beltade oh neve di nome di nome mi chiedi ch'io sia di gelo o di virtude sia fatto l'amore tra i seni a bere sia fatto l'amore tra i seni a dire Madonna di grembo e di beltade Quantunque sia celata oh Vergine, la tua bellezza affiora di ricamo bianco il tuo orlo perfetto, l'occhio chiaro a vedere, foss'anche un falco solitario a prenderti, Bellezza, signora mia dimora, di grazia infinita, la tua indole d'abbandono, il capo reclino, il tuo piccolo bambino, la mano, un fiume di pietate. Un dono mi cinge il fianco, l'orzo acceso del tuo cuore a profondere tristezza e gioia, l'avvenire, un'isola di ciliegie mature. Un solo grappolo potesse prendere questa mano profana, mia dimora e regina in questo canto di mare si bagna la veste, annega, in questo canto di marefollie un naufrago attende, la tua mano bagnata, la tua grazia infinita. Madre Madre Madre profondi questo canto chiaro al miracolo infinito di te, per me, per te, ch'io vedo, nella trasparenza come miraggio come il miraggio che s'avvede al tuo richiamo muto, mie orecchie di conchiglia ed eco il ritorno, la grotta di questo cuore. Cantando: Strimpella il suono della neve che sembra un fiume di beltade oh neve di nome di nome mi chiedi ch'io sia di gelo o di virtude sia fatto l'amore tra i seni a bere sia fatto l'amore tra i seni a dire Madonna di grembo e di beltade Muta notte fredda, vischio di sottobosco ad aspettare un bacio. I cardini salgono sulle labbra a suggellarle nel momento della schiusa, a premere i loro lucchetti come la gabbia d'un giallo canarino. Foss'anche senz'ali volerebbe? Preme forte la notte, come un'incudine di raziocinio, preme i tasti del suo peccato, la puttana notte, consapevole del suo raziocinio. Il canarino è sfrondato, implume e nudo, il giallo canarino, così delicato, chi lo carezzerebbe così sfrondato? Oh, vigliacca selva del sottobosco che attutisci nel silenzio l'urlo delle gabbie, le bestie da mondare hanno altri nomi, altre imperfezioni. Io ti rivedo con il corpo ridotto uno scheletro e il plesso in fuori a correre l'amore come un gioco a scacchi d'alfieri e dame che danzano la premura del volo vergine, un volo rivolto e asciutto, prostrato in catene d'angeli. Oh, la trama mortale delle trecce, l'affezione a cui è rivolto l'innocente mio dono mio, un canto rivolto, foss'anche una bugia fatta di labbra, foss'anche una sola, pura, bugia. A chi mi rivolgerò se non a questo immacolato scolo a questo penetrante e lieve spasmo, nudo e bambino e nudo, una carezza rivolgerò a quest'infante audacia che porta il nome impronunciato di Dio. Aspettami. Quel pianto tanto atteso di battesimi santi e d'uccelli arresi ai rami, te lo regalo, foss'anche per liberarlo al volo, te lo regalo, per suggellarlo sulla spalla bianca dei ricordi e perderlo stretto stretto tra le labbra. M'avvedo candida e chiusa, come il primo bocciolo d'inverno. Perché vai di traverso ai miei baci? Quali uccelli hai da liberare ch'io non lasci già liberi al volo? L'uccello e il cuore hanno la stessa durata, lo stesso tragitto, emigrano, ma tu hai la forza del viandante, in te tutto è partenza e ritorno. Tu sei l'inesistente. Io le ali. Forse dovrei camminare in attesa di piedi e d'occhi nuovi, di cuore, forse. Il silenzio è un grande collo di diamanti crocifigge i suoi aghi, uno ad uno, il suo filo una ghigliottina. Poterlo sentire tacere. Ma cosa ascolterai in quella tomba? Il grembo nero della luna? I suoi occhi ignoti e sghembi? Non è salvezza alcun buco nero che s'apre in petto. Ti squarcerai poco oltre i tuoi passi, ne morrai avvizzita dai tuoi stessi spasmi muti. Ti privi della gioia che si ripiega, fatta per nutrire e colmare le ossa e il ventre. C'è una struttura cosmica che non va toccata che non va vista né udita. Mi sembra che il sogno abbia suoni simili, basterebbe forse non svegliarsi più. E poi, rimanere incolumi da cosa? Questa pelle trasuda aria tumida d'altre pelli. Mi manca l'ossigeno eppure vivo Vuoi allontanare ciò che Iddio ha unito Voglio avvicinare ciò che Io ho cercato La morte? La vita Quale vita è mai un rigurgito d'altro? Un parto felice e sano, pieno di dolore Hai un sangue nero che quasi sembri sparire con la notte Non chiedo altro Ritornerai? Assecondare le battute di caccia della luna: è donna. Con il fucile alla tempia strafotti i tuoi stessi seni. Vederti è l'ingiuria della carne, il mostrarsi dalle tempie al cuore. Vederti è l'opaco riflesso di secoli e secoli. Sarebbe sconosciuto questo rendersi informi se l'informe non prendesse forma della tua stessa immagine. Specchi visivi e cloni e sillabe di preghiere si sono spostate sul tuo corpo e le urla ancora cavalcano giovani cavalli da guerra, per le tue labbra, il confondersi, arreso, dei lunghi peni in fila. Regina sei, non lo scordare. Potessi domare tutte voi, donne mie venute, gioconde, ad infestarmi. Chi sono tra voi? La sposa sterile o la domatrice? A rendermi grazia un gufo, che nella notte canta la mia dismessa fronte d'abbandono. L'aria ha trasformato il suo pulviscolo trasparente in rete, prigioniera m'ha fatta, alla sua mercé, il giogo sospeso della sua vulva d'oro m'ha incantata, incantatrice del demonio stesso. Un campanello rosso ora ha suonato, la resa dei miei capezzoli, all'alba. Ecco le ore che vengono sfitte, piene di rovi, ove a cantare è l'usignolo della pietà quello che sui rami trafigge il silenzio e il volo in un unico chiodo, fisima del suo canto: l'amore. Piume d'oro ha intrecciato, catenelle della coscienza in un battito delicato d'ali, lieve, così lieve da svanire col primo vento, nella coltre del meriggio assolato. L'albero è spoglio ora, pallido e nudo, quasi a tendere le braccia e le mani nella traiettoria aerea dettata dal piccolo cuore, si propende sradicando le radici e sospeso, attende. Non m'importa di pronunciare silenzi e parole l'apparenza ha la sua meta oscura come il ramo del fitto bosco ondulato e spiovente di lacrime e crisantemi. Baciami in silenzio nelle notti oscure dove il prato lascia cadere i suoi fiori morti. Li coglierai per me? Foss'anche l'ultimo dono del mio petto, batte di sangue vergine. Cantami, cantami con quattro ugole d'oro, lasciamoci nell'apnea, nella sospensione della carne. Amen. Quali amici mi renderanno il plauso dei miei segreti, spilli e fermagli ornamentali sul petto vestirò i poveri e Dio di un unico pianto, renderò il pane ai denti dei morti come se fosse una caccia aperta, un' infiorescenza di strade e porti. Il mare mi seguirà zitto, unico erede della benevolenza, tappeto d'alghe su capelli d'oro. E' tutto sbagliato questo ricadere sullo stesso sasso sullo stesso ginocchio, la stessa cicatrice che quasi non fa più male. Fare perno sull'escoriazione e voltare, e perdere un ginocchio, e distruggere gli appoggi e saltare, mutilati, in un altro universo con le stampelle nel cuore, la fatica, estrema, estrema, estrema della consapevolezza. Dio, per piangere un po' quanto male, solo per piangere un po' e gettare disinfettante sulle percosse e confidare che il dolore non distrugga l'unica dolcezza concessa, che non asporti altro cuore, e lottare, come un bimbo con la pistola finta contro i demoni, per gioco, e morire, per gioco, e amare, per gioco, e la vita, un gioco. Come sono empie queste parole in questo groviglio di rovi e mammelle. Madre sposa donna santa puttana cialtrona. Che fatica, che fatica, fare quel salto. Tacete stolti, vi renderò la carne, tacete vivi vi caglierò il corpo per donarlo a festa. Ho un banchetto per ogni mano un sogno per ogni pene. Non guardatemi come se fossi l'ultimo canto di un balbuziente guardatemi come per tacere, come per tremare nella paura stessa del render grazie. Io vedevo chiaro, sacro e sacrilego tra il dono dell'esistenza. Io impicciavo nell'aria i nodi dei miei capelli per tenerli uniti ai tuoi, mentre un'alba un'alba troppo grande m'agitava tra i seni. Io capivo nella pallida giovinezza il ballo e sceglievo nel cielo un paio di stelle solo per te le appuntavo sospese nella meraviglia dell'inconsistente e t'amavo nel troppo sole della mattina nel troppo risveglio della città. Com'ero presuntuosa nel mio sentire com'era placida la mia penna nel sussurrarti. Ero una lingua morbida al cospetto di dio ero la mungitura fresca del creato un uovo sospeso al mondo una distorsione asincrona della realtà. E credimi credimi se ti dico che tra me e te nel tempo subacqueo trascorso tra il corallo rosso e tagliente il dono più grande che l'amore m'ha dato è poterti guardare come ti guardo adesso calla et amore semper scollo del tuo toro pietra seminale et geranio et geranio et preghiera amen scollo del tuo pene archivio et amore semper Io sono tutto ciò che muore (edera del mio male) uno spettro che s'avvale del suo trapasso come un fiume fuori dall'argine: libero al suo richiamo. Di questa scorza trattengo l'onda d'urto di uno schianto un contatto che tracima sul mondo nel suo rettale sforzo obliquo la lingua all'infinito cade tremebonda verso l'orlo sfatto del mio pube: nuda al mondo senza assoluti schianto l'osso verso un sé immaginario a cui regalare le mie uova rotte piccole frittate donate agli uccelli per solcare il cielo e mi accingo al pretesto di un Dio per cogliermi persa nel mio io scarabocchiando qualche verso secolare che mi renda meno apparente e poco parente all'uomo meschino un'ubriacatura - direi ma la taccio per il quieto vivere di non so chi sia La stesura del corpo, il suo adagio bianco le balze del mandorlo tra le cosce. La stesura del corpo, il suo adagio pesato lieve incanto del dormiente, il ritorno nel ventre, il nudo ritorno, fresco, di traverso, sponda su sponda, morbido, aleatorio, tra le balze del mandorlo indorato dallo strappo della luna, la palpebra chiusa sogno nel sogno presente alla realtà. S'è avviluppato come una trama indicibile, l'ago del cuore s'era teso, irriverente a tutte le mie forme e tu m'avevi presa tra le cosce e scossa perché così dev'essere l'amore una terra che s'appropria del silenzio rendendolo suono e goduria alla faccia del male. Stando stava e tornava, partoriva partorendo e stando infilando pece nelle nari, vita stante, natural durante ch'era vera, giovane e vera, e il bosco e le betulle col suo tulle danzavano danzando e imitando il passato, e scrostava scrostando e amando la storia e la dimora degli accaduti accadimenti, nel suo libretto riposto, ripostiglio e bisbiglio di soli pensieri allacciati a fiocco insieme alle scarpe ai piedi. Ed era vera, sola e vera. E camminando camminando, camminava, e saliva sulla cima del crocifisso a guardare il mondo e scorgeva, scorgendo, un platano aperto a fiore; il suo cuore, che poi fa rima con timore oppure con ardore ma ch'era vero, giovane e vero. E il silenzio arrivò a pioggia, arrivò il silenzio improvviso stendendo il corpo e gli occhi, stendendo il suo amore per Iddio, che poi fa rima con Io, ed era vero, umile e vero. Andare di terra, con la terra, all'alba tornare di pietra, per la pietra, del cuore. Una giovenca magra ha partorito sette speranze l'aratro ha sepolto sette fanciulle andare di terra di marzo tornare di pietra a giugno fiore nella bocca della speranza canto di pigne dagli alberi andare come tornare e nutrire (i seni delle spose) l'acqua di colonia sulle lenzuola il pizzo tra le cosce rese andare senza tornare e morire era di marzo, era di giugno. Espropriatemi come per ricavare dal corpo solo altre parole espropriatemi da questo silenzio e pallore tiratemi i capelli tiratemi i capelli purché possa innalzarmi dal pentimento dall'eterna agonia dal nero della pece dal nido del cervello. L'asse è la schiena con cui m'erigo lo sforzo concessomi da d(io) per l'affronto del deforme una spada creata nel futuro per uccidere il passato: ed ecco che sono. Sono la pietra, il sasso che si reclina sul capo l'adunco svolgimento della vita che al cadere, cade e cado, e non per dire, ma per fare, sia anche nel silenzio di questo fitto bosco con questo cuore argonauta pieno di ricerche e velli d'oro mi ci costruirò una nave per solcare il pianto il labirinto inconsistente fatto di mura per aprirmi, foss'anche spaccandomi la testa a questo orizzonte nuovo: Da ieri ho i capelli più corti, un effluvio di piccoli serpenti scombinati che inneggiano ad un'idea fissa e combattono l'appalto tra l'aria e Dio. Quel che sapeva era abbandono di forze oscure, filtri scoppiati negli occhi perché non poteva ella reggere la forza del sole pieno al centro della sua fronte, era miraggio che emanava scie di vita come un faro solitario, piena e immensa di barche derelitte, le mani d'acqua immerse nel candore dei resti, degli esuli, degli avvinti, della buona ventura, poiché il mare l'aveva chiamata come un urlo di foga, di rese e d'imbarazzo a chiederle il ventre. Non so se il mio è un suffragio di resti sparsi ovunque; nei tuoi occhi, nei suoi, nei miei. Non so raccapezzare più la strada; scivola il giorno, la notte, le ore. Si scostano pezzi di cuore all'interno; per amore, per dolore, per troppo dolore. S'arresta qualcosa oltre il tempo; un soffio, una ruota, un congegno. L'architettura del corpo permea inesorabilmente; che sia io, che sia tu, è una lunga corsa. Un sudore spossante solca crepe e canali; d'un verde e bianco fiore si discostano le ore. La parte lesa e inoffensiva ha un grande cuore; piange, scalpita, freme. La parte lesa sono io nei tuoi occhi, tu nei miei; lo stesso Dio, la stessa partitura, il suono fosco del mattino. La bocca, il viso, rientra qualcosa in silenzio la lunga fenice apre l'ala grande pronuncia il suo suono, il suo indovinello pagano. Sono io, sei tu che piangi; le lunghe occasioni della notte. Un gatto addormentato nella beatitudine; sono io, sei tu, non ricordo. Io m'era scordata forse che il petto era ramo asciutto tra le costole mentre ballava io la solitudine rimossa dei rami e di dio e un canto salutò l'ultimo uomo prima ch'egli entrasse nella sua piccola dimora mia dimora casa che alla svista potrebbe sembrare un'uccelliera e riposava sulle piume il candore della pelle resa ma se più non rende a chi io renderò il mio amore? e l'alba era limpida agli occhi e l'ombra era limpida agli occhi e dio era limpido agli uomini e in quel silenzio sconosciuto prima delle luci flebili del mattino non avrebbe dovuto cantare il gallo la cresta della ragione non avrebbe dovuto impiegare il suo becco all'apertura estrema del suono e scomporre il silenzio in polvere di morti no no no avrebbe dovuto tacere ancora per non privarci dell'ultimo vuoto concesso dell'ultima immersione aspra del sonno dei sogni e lasciarci in quella speranza ancora riposta nei cassetti dei pigiami avrebbe dovuto tacere ancora sì ma confiscò il suo pugno alla sveglia e irradiò l'occhio alla svista reale e fu giorno improvviso a denudare il mondo. E allora non c'è nell'avvedersi la sua cima e chiglia il suo perdono lieve e l'ultimo pasto delle bocche. E allora non c'era stato un avvento improvviso dei nostri corpi a renderci i salici e i pianti delle mani. E ancora non c'era stato quello scolo santo d'erba e unguenti nelle nostre intime bocche. Tutto aveva preso la deriva. E il ciondolo che mi regalasti Dio mio la mia fede eretta sui tuoi piedistalli dov'era allora mentre piangeva mentre s'addolorava al cospetto del tuo marmo. E allora piansi ancora e allora gridai e allora sentisti perché non v'era rimembranza sterile ma ugola di veritate e allora la sentisti romperti il cranio la mia ugola di veritate esplosa sul tuo piedistallo ed eri caduto anche tu eri caduto sgretolato dal peso della terra dalla colla dei corpi sulla terra dall'unione del tuo prato e il mio verde eri verde ero prato fu unione e spartiacque almanacco di pietate l'unghia tua e la mia a graffiare il mondo. Madre Maria dalla calla confiscata e i seni bianchi chiede il frutto, il sangue del suo Cristo viva immagine delle sue braccia aperte ove piomba il corpo esanime e crudo e marmo: Figlio, t'invoco, pendulo al braccio mia catena di terra esposta al tuo osso tomba lacera di piccoli stracci. Quanto peccato ha raccolto il nostro torchio confiscandoti a me, alla materica carne che soffre e pena e ingoia e urla e piange quanto quanto quanto mio tenero, mio piccolo e innominabile Figlio, io ti tenni, tra i miei seni di calla combattendo sotto la tua croce e non so, fatta più donna ancora, fatta più donna, di carne e terra, se mai potrò perdonare se mai, ci potrò, perdonare. C'è stato un giorno in cui ho ceduto il mio ultimo rosario all'amore lasciandolo sgranato tra le cosce livide ed il pianto c'è stato quel giorno in cui ho smesso di pregare ed ho iniziato a vivere. Quei giorni d'estate con cui colmasti il tuo profilo d'ombre e intagliasti le unghie di rosso e il grande orologio era il big bang dei grilli e sfioristi mentre intorno si rilasciava il profumo verde e l'oro spigato dei prati, mio piccolo papavero dei giorni a venire, come ti conciò il sole? La tua ciocca appariva millantata di porpora e bronzo e gli occhi esagitati di commistione e d'angeli precipitavano lungo le gote a raccogliere i cristalli maturi del mezzogiorno mentre le labbra erano un canto immacolato da Dio ove addormentare il verbo. E non riesco mai a pronunciare 'grembo' davanti ai tuoi fianchi per il candore delle tue colline frammiste allo sfoco dell'aria rovente, direi 'mondo' per renderti grazia e giustizia. E mille notti di sudore e lenzuola bianche, bagnate, come lo scolo di un'acquasantiera imbevesti, per i tuoi sogni naufraghi di preghiere nella foce del pianto. Ti rivedo mia dolce, nel candore delle mani, fatte tutt'uno con il tatto come a voler risanare le forme d'ogni oggetto, a renderli carne nella tua immensa solitudine senza peso, ove la casa intera detiene parole e chiodi per raccontarmi dei tuoi capelli sciolti, scivolati lungo le spalle dall'aria aperta della finestra. Incontrarti sarebbe come suggellare le mie promesse alla vita, detergere il cuore dall'ipocrisia umana, perché tu lo sai che l'escoriazione del corpo, il suo frutto esacerbato dagli anni è un'entità astratta a cui commissionare il tempo degli specchi, ma non l'anima. Mi hai perso consolandomi, valle prostrata al seno della Terra tua una collina d'amore a rendere pace e occhi sfumature di principio avallate sulla tua schiena croce tanto da piangere croce tanto da abbattere croce tanto da dire e silenzio Serbami l'inesistente acqua dei corpi la discesa a cui è vicino il mio addio erba e corolle d'abbandono ove la lingua antica geme ed ingoia i dolori del mondo purché i dardi mi colpiscano il cuore come un canto m'aprirò crocifissa per prendere prendere prendere ovunque e chiunque: il mio viso Era il mese del mai e del poi quando nacque flebile era il mese che mai e che fu, ma nessuno disse era il mese permesso al gelo, paltò e radici era che mai e poi sì, quando il no sfoglia i fiori era acqua e grano quando son fermi era per miraggio e visione ma nessuno disse e nessuno andò nessuno tornò e partì era ago d'abete pronto all'uso era ghirlanda perché ghianda del cuore esposta al ramo fu era per amore e gioia era per dire e non ridire il giorno era chiave riposta nel lampo luce e carne e pascoli e se ne andò era giglio, perché no. Elisandra avea due belle ciglia e fragole in bocca avea fascino e dote. Elisandra avea per amica una rondine e spine nel ventre, ed era bella acqua tra i seni e candore dolore rosa e raso nel cuore e poi non era, non chiedeva non predicava, non sbagliava per pecca d'umore, ma per leggerezza di rondine che plana sul nido Oh, Elisandra, Elisandra mia. La pienezza a quale fonte scabra s'abbevera? Ch'io non posso torcermi per svincolare al giogo quando passa il dolore e il recesso dei mondi ammutolisce nella bolla iridescente d'un bambino. Passa e cammina con la toga impettita la notte nera, infilandosi a lama nella carne mentre tu dormi nel mio duodeno. C' è l'immoto marmo A cui il plesso piega E canfora d'una narice esposta Al suo giaciglio Ombre e calore Spiumano L'inumano Da lontano Il ritornello d'una giostra antica La benda Che si fa cuore e curva D'un cielo aspro Benda Che il sole genuflette Nel mio taschino malato A volerne riesumare Il cammino E pecca Che ancora non è abbastanza Pecca l'involuta del candido fiore Ai vostri presunti occhi Veggenti Di questo nulla. Cade il fiore dalla bocca, quello che ho colto con la lingua avantieri, quello che nel sonno si faceva vena, e la carne, fabbisogno, fabbisogno di vischio, per le tue mani, per il silenzio aspro del tuo pene, ci costruirei una babele, mentre aspiro forte il sudore del letto, e i fantasmi si sgretolano in pulviscoli d'aria, e battono le cosce, e la bocca, una nave, un solco d'acqua liscio a premere il cuore. Allora ho detto no, come se si consolidasse nell'aria il mio sterno pronunciandolo, un'eco plastica a modellare il cranio rimanendo tutta sparsa e sdraiata sulla soglia del desiderio, una finestra avvinta al mondo, nonché aperta perché potesse boccheggiare il pescecuore a questo oceano. No. No. No. Era stata tre volte la trinità a parlare, il dolore prostrato e dissolto, evaporato improvviso di una inconsistente verità perché è resoconto sventrato quello che si pronuncia a bocca deragliata, contro l'esubero di vita che cozza insistentemente, sui conti da fare e quelli da rifare e da prevedere. Ci voleva struttura per sostenere il peso il sasso da tirare in quell'immane pozza d'uomini, ed io, traslucida, ricalcavo la luna con gli occhi per non alienare il confine dei mondi. no. perché non ero, ma sono. Di te impallidisco, luna mia quiescente, tomba mia possa il pianto innevarti d'alture infinite per le tue mani bianchissime, per la tua pelle pallidissima ti vedo farti sposa desolata delle valli, dei lugubri campi sterminati che setacciano ogni dolore, in canto. Tutta occhi di radici nel grembo, tutta occhi e radici alate a premere il nervo di Dio, la solitudine immonda e irreale, il pozzo interminabile di cadute, di detriti e d'uomini e d'embrioni, mia bella d'embrioni fatta, vagito schiuso al mondo, accarezzarti potessi una volta sola, abbracciarti e dirti anch'io di quando si cade, ch'è caduta, di quando si ama, ch'è amore, di quando si muore ch'è infinito cieco. T'ho cercata spoglia, tanto da tremare di nudità esposta, così vera da impallidire, mi credi ch'è così puro l'oblio, se si sente, intreccio di mani mie, se si sente, insieme, io piango. E' scabro il mio petto, come gli angeli aguzzi che spronano al perdono mai avrà corpo la roccia che s'espande tra le gambe mai avrà corpo la croce natami in viso per il perdono tuo, ch'è mio, per i tuoi occhi per tutto quello ch'è caduto, lecito e illecito ai miei piedi ci costruirò trecce di cordoglio per ovviare al martirio per ovviare la stirpe d'abbandono dei nostri corpi la nostra indissolubile stoltezza di carne lasciata a macerare, nel nostro cielo di terra. Figlio mio che t'è preso quale fantasma ha catturato i tuoi occhi, fatti di pietra così duri al mondo. Io volea abbracciarti mentre piangea sassi. Creatura, fermiamoci sulla roccia a piangere assieme, non v'è differenza tra noi la divisione è un'invenzione macabra per sopravvivere al mondo ma c'è verità se guardiamo con gli stessi occhi, c'è verità se la paura non ci ottenebra chiudendoci il cielo, disperdendoci. Io t'amo. Le mani sono così vicine al cuore è solo la stonatura a cantare, avvinta, alle radici passate, ai morti che tremano ancora nelle vene. Ma tu non piangere ch'io ti bacio e assieme il mondo diviene un prato. Il fiore raccolto nel tuo occhiello, sei così bello, ed io m'annebbio tra gli alberi come diventassi uccello. Il mio cuore d'alce esposto al tuo mirino, ferita e fraintendimento accavallano la verità. E tu esigua, affrancata al tuo debole filo punti il dito tra gli occhi, a voler rivendicare il torto, la tegola che ha portato via l'aria. Non t'è bastato conoscermi per annusarmi intera, pezzo di coccio frantumato d'orgasmi e soglie infinite m'hai persa per non vedere negli occhi miei l'altra te, la piccola creatura che l'occhio dondolava, tua altalena d'amore. Dove fuggisti? Ho un nodo che il vento trascorre scorsoio lungo la pena una lametta a fraintendere vacuità e azione. Nostra Signora, il perdono è caritate se la mano v'attinge, non il caso. Le scope avevano manici mai visti, impreviste polveri nell'ano. Mi chiamarono i borghesi per la forca della fica ed io gli risposi picche (il sole cuoceva rondini d'agosto) le smancerie degli uomini si riducevano a sudari per le vergine tutti chiamavano con voce di fuoco il mio nome ma io ero sparsa tra le more ad inforcare aghi per il cuore. Tutti chiamavano le more ed io mi tramutai in rondini d'agosto. C'è nella notte il rincarare delle dosi come se esportassero macerie nere dal cranio allo specchio. La malattia ha origine dal sé che il poi ha reciso, rosa che cede la sua nudità dal viso alle mani, petalo divaricato tra gambe e silenzio e fiori caduti, di tutti i colori, per questo scolora a buio e si rialza pallida. Perché fantasma fui in virtù di coloro che fecero abbaglio che gli occhi non videro forieri d'altro che la bocca tacque allora spinsi l'ultima follia tu la trattenesti le redini sfilavano sotto il petto circumnavigavano specchi occhio nell'occhio ventre su ventre il letto un mare bianco trasparii, trascolorai era cielo di miraggio (vacuo il ritorno del sole) la costola una penitenza sul tuo braccio un dormire di clorofilla a rinverdire la stanza la luce si ruppe sui muri non v'ero io che albeggiavo (la stesura s'era fatta panno) v'era alone di cose imminenti (la stesura s'era fatta corpo) v'era silenzio sfumato negli angoli (la stesura s'era fatta dio). Io solo appartengo al silenzio, golosa, come le bacche di gelso spinta al richiamo del mio utero, della mia barba femmina che annusa a gambe incrociate l'inesistente. solo io appartengo alla fagocitazione di me e dei miei pensieri, quelli assurdi e quelli più assurdi ancora, eretti, eretti, quelli che s'intromettono con l'aria, a pari merito coi sogni, un materializzarsi inesorabile di luoghi d'appartenenza e d'estromissione, appartenenza ed estromissione, appartenenza ed estromissione, ove solo a me, avviene, una sorta di assoluta verità. Vorrei tacere se il vostro livore si fa cemento ma l'angelo sprona la mia bocca e tutti parlano e se così è, donatemi per un secondo un pensiero bianco non per me, ma per i tanti morti che porto (molti camminano ancora) ed io li sorreggo, sento le loro voci, l'incontinenza emotiva che mi piscia in petto. E' sempre così umido l'urlo della verità, la ricerca che rumina con i denti di gesso, la sua chiostra spaventosa capace di mordere il cielo. Mangiare l'azzurro vi chiedo, mangiare l'azzurro. Mi partorirà il glicine quando il folto delle membra prenderà il viola e l'esporrà al solco profondo del cuore ma non so se me ne andrò senza scarpe a battere le strade e i cammini porosi che gravitano d'assuefazione. Le strade avranno altri nomi quando rinascerò nella fortezza santa priva d'orpelli, creatura d'osso e viandante per i mari profondi denudati. Viola ho detto, della misticanza ingenua ed armigera che spetta alla donna, quella che alza la sua sfida bianca e inveisce contro il cielo, che si scrolla con i capelli il ventre in un solo istante, come il momento esistito ed ora nascosto, vacuo entroterra di miniere rosa e riflessi. Il fiore perso l'avea, confiscato dall'esubero d'ogni avvenenza, prostrato, imberbe occhio che per le sue calle espugnato era, avvinto alla giacenza del perdono ove riede al mattino la pelle il suo circondario di rose genuflesse al gambo, per amore illecito di un sole morto che s'avventa sulla terra a nero, perché di seme possa colmare - avorio suo peccato – il suo strale lanciato ad urlo, estorto al suo dio, muto, greve, illacrimato concezione degli astri e concessione sua, per ricerca vera e compianto, tanto tanto tanto compianto, per questo esile era al suo stelo, poi vento, staccata ed espropriata, no, no, no, non si può continuare a crescere spine se il ventre sanguina. Domani, il giorno del poi e del mai, comprerò violette come dono agli dei, per sacrificargli il mio elefante cuore. Domani verrà privo di striature, bianco e folto da risiedere intero nel mio seno, senza curve, solo riposo. Domani saprà di foglie cadute e d'escoriazione di pelle e tronchi, freddo marmo che avvolgerà il mio nefasto in primavera. Domani partorirà la sua foga di vita, la sua trota esposta al banco, la riverenziale forma che m'espropria illusoria, di me, di te. Domani ha sette mani una per ogni giorno moltiplicate all'infinito, io resterò infinito, senza più parole, solo trasparenze. Domani mi creerò un'appendice d'uomini fatti per la vita ma non so se lo dirò a nessuno. Chiamami ch'è lungo il mio disincanto, le braccia tese e in caduta reverenza delle mie danze che salpano nel cielo, così vergine da imbiancare ogni stanza, la mia autosufficienza, ora, implora la pecca del tuo palato, non un abbandono di foglie, non un ceppo di fuoco, ma schiena piegata, schiena dipinta a uovo, mio avvenire privato di cui sfondi la porta, mia chiave, vieni a me, in serratura e silenzio, vieni, senza riserve, addormentato sul mio utero. Rinascere uomo e figlio, madre e madonna, nudi, trasalire di nuovo, al mondo. Il mio è uno schiaffo incontrovertibile, se tace la bocca e mi credi nel silenzio v'è l'ammonizione che ammanca. Il sacro è indissolubile s'è l'occhio a mangiarne e il resto a chiederne, ma non guardarmi come per commiserare il passaggio di una rondine, non guardarmi per solcarmi il cielo. Ci sono cadute arrendevoli che esplodono in verbo, di rugiada esposta a circondare corolle e salmi, un'invocazione al macello, al raglio dei morti, alla gogna della gola. Potessi mutarmi a tal fine almeno di un'ala, spogliarmi di piume, implume rendermi oltre la parola, trasformarmi in sasso, in cagione durevole che s'erode al vento, essere lanciata in cerchio inesauribile di vita. Tutto cade ingoiando radici, alluvionando le nostre rivolte i fastidi eterni del dopo pranzo, le farfalle non catturate che volano ancora iniettandosi di sole altrui, di concezioni al plurale. Un nefasto pomeriggio d'oggi per giunta assolato di nervi e pensieri, di libagioni avventate lungo le strade; un grande affare di clacson e ustioni incartate che per le labbra e per Dio bruciano, isolando la pelle, il suo trasudo spontaneo. L'erba continua a crescere, a dissiparsi lungo i muri lievemente, un lungo ragno di cemento a lagnarci i piedi, i passi, la costipazione dei giorni, il nuvolario del tempo e l'impertinenza mia e tua che osa amare. Questo è un dono - ci hanno gridato - e poi c'impiccano all'ultimo albero, colpevoli d'unione illegittima al mondo, narcotraffico di bramosia. Un affare sporco la purezza, da incartare col giornale e le uova. Donami il collo, la tua estensione a dio perch'io possa morderne tutti i desideri gli assaggi del cuore, il suo afrodisiaco disincanto. Porgimi il collo, rabbrividisci alla vita, chiuditi analizzando l'incontrovertibile piacere a cui espugni il dono della pelle avvinta alla bocca. Chiuditi ancora, rasenta il suolo, seppellisci il tuo muro, la tomba a cui hai donato lacrime e umori, scavati piegato alla forza mirabile del pelo, liscio corpo liscio, trasmutato in acqua, in sperma, in superficie viva ove seminare la tua catarsi, l' atto d'assenzio, di morte e attrazione. Calati i pantaloni, restami nudo accanto, ch'io non veda altro oltre la tua faccia d'amore: Ho un Uomo, si chiama Amore, mi ha donato sette morti e un aborto mi ha donato sette vite e un figlio. Ho una Casa, si chiama Speranza, mi ha donato tre croci e un avemaria. Ho un Dio, si chiama Uomo, ma non so cosa m'abbia donato. Tu mi chiedi di affrancare quello che provo ma non v'è nulla di franco a cui posso chiedere il dono, la vita. Siamo soli. Questa è l'unica certezza, al di là di tutto. No, ce n'è un'altra a cui sovvengo: l'andare retrocedendo, l'immobilità ove si sospendono i fili ove camminano gli angeli in processione. Loro, cantano. Li odi tu, quelli che dal crepuscolo di Dio scendono sino a noi camminandoci di speranze e lene? Li odi? Io sono in prognosi riservata per aspirazione verso la Bellezza, irrinunciabile abito d'oscurità, luce e infiniti colori ma, vi crollo priva d'appigli, vi crollo, da ricostruire notte tempo, il tempo. Mi piangerete domani? Sapendo dell'inesistente dono a cui m'affido? Sapendo che m'aggrappo ad una menzogna? Mi perdonerete sapendo che mi mento espropriandomi di ruoli e forme? Sapendo che non sono altro che il vostro occhio unito al mio? Allora scriverò, no, non scriverò più, intaglierò parole nel bosco estrarrò radici di baci e lingua, tutto il mio sentire reso disponibile a Dio, per la gloria del suo indice volatomi in seno, io tacerò il silenzio che avviene nell'incavo e sulle alture dei cipressi ove cantano i morti e i flauti del mare; la mia vagina è spuma. Ecco che viene, a raccogliermi, come fossi divenuta alga, pesce muto di speranza, spiaggia del mio pianto al mondo, viene, l'amore ad espropriarmi delle omissioni, degli ammanchi, del mio uccello pigro che il nido fabbricò su di un' isola. Perdono. Avvengo al mio assolo come sasso in un prato, esfoliato dalla ruvidezza, poro di pelle aperto e nudo, per perdono e dolore rimastomi in petto, per perdono e dolore che ho taciuto. Sasso. E non so spiegarmi più, se ora taccio e mi schianto, non so spiegarmi poggiata sulla fronte del mio nascituro, io madre a farmi statua e corpo tra le braccia; tu, marmo e il seno alla bocca tua, no, perdono per le mie altezze rosa io non posso più fabbricare morte se ho te, cuore, se ho te. La resa, la resa, l'oblio, la resa, lo schianto, lo scolo, il mio apparato, il mio parato volo, io, figlio non posso ancora mollarmi se tu mi tieni a palloncino e volo, tenuta dal piccolo filo, in trasparenza e riposo, tra la nuvola e Dio. E passano calpestandomi, e mi rialzo che ancora non sono in piedi, mi rialzo, che piango. Tu ridi. Lasciami il filo. Io non parlo più se non con le parole grevi della terra, io non sento più se non con i sensi le urla dei morti che salgono, il loro schianto d'anima. Io non piango più se non con centomilainfiniti occhi, rivendico Dio in terra, m'estrometto da me, incorro verso l'ignoto, pavoneggio il mio stemma umano agli dei, incarto regali inesistenti, aspetto un cenno, non lo aspetto più, sola a chiamare gli angeli di ognuno al mio braccio. Io ho paura di morire, ho paura della morte altrui, ho paura di non vivere abbastanza, inneggio il mio canto, lo odio, lo cerco, mi ripugna, lo abbraccio. Io crollo, salgo le colline vergini, piango senza remore il sale d'appartenenza. Io vorrei amputarmi come un albero per rinascere più forte, io m'amputo e non rinasco, ho avuto quello che meritavo, non l'ho avuto, l'ho cercato, non l'ho mai cercato. Io ti chiamo inesistente per le vie del cielo, ora non ti chiamo più c'è solo un cadere di stelle, di escrescenze sottili al mio interno. Io ho partorito, io non sono stata all'altezza del parto, ho cercato il mistero, il deforme m'ha cercata, io sento con i rami delle mani ma non so se toccherò mai Dio, io sento che dovrei allontanarmi ma non so perché sono qua. Io vi vorrei tutti vicini. Io vorrei piangerci insieme. Vieni a me fiocco, epistola della mia fronte, frangimi che il dunque arriva di traverso a bere, ubriaco dei suoi canti. Spargiamo il terrore della libertà, lanciamo lacrime di grifone come stendardi di questa vita ce n'è per due o tre o per tutti una qualunque cosa chiamata Dio, un'apertura avveduta al suo giogo che si lascia andare, naturalizzandosi, demineralizzata alla sua fonte, una luce libera di smarrimento che assale. Io non so niente, ma la lascio brillare, allagandola delle mie impossibilità e lei mi copre sussurrandomi le sue possibilità. Una bilancia equa ora s'è sviluppata; la resa del destino di ogni uomo, il suo ascolto portato all'apice di ogni scelta. Non v'è luogo in cui si riposi il capo. Il barbiturico eccesso del sentire ha scodellato il vento aprendo ogni finestra. E' incestuoso sentirlo penetrare tra le cosce, privarmi del buonsenso e di altri gingilletti che ho nascosto avidamente per paura di liberare l'evidente pettirosso, l'esposizione della mia isola nascosta di Creato ove cantano antiche muse ove l'acqua di abitanti alieni ha scorso il visibilio di ogni amputazione; la predilezione della chiusa persistente in cui culliamo la paura. Ripeto: la predilezione della chiusa persistente in cui culliamo la paura. Mi rifaccio coda di lucertola, per alterarmi prolungata nei recessi più profondi della ri-creazione degli intenti, nella ri-generazione pura scalciata nella pancia, dagli albori ad oggi, nascita e parto, dolore e mistero, a profondere. Perché Egli non mi salva se non sono io a chiederlo. Egli dorme nei suoi sotterfugi, sdraiato nella croce. Veritiero è chi della verità ne rasenta la forma, la sua cuspide immortale. Ora taglio le assi, le assemblo per costruirne il cielo, un bocciolo, la cappella del Creato. Veritiero è chi della verità ne rasenta la forma, la sua cuspide immortale. Prendine la fune, la sua enorme mole, scortica la foce, il resoconto di qualche ragione. Ma Egli, Egli no, dorme, saluta coll'indice e il medio, tergiversa l'aria piegandone la fuga, il ritmo naturale, piega la luce attorno, chiama gli angeli. Veritiero è chi della verità ne rasenta la forma, la sua cuspide immortale. Io scortico la corteccia e poi la lascio morire tra il libeccio, lascio imperlarmi per una volta, una sola. Domani passerò sotto un arco di luppoli, andrò scalza dissennata come al solito, raccolta nelle mie stravaganze e dissensi, bacerò il greve passo della terra, l'interiora et parsimonia sua aspra astuta veritate. Il mio tunnel di ritorno – che domani sarà ancora domani - e ci ripasserà la storia e gli avi, in processione di lucciole, sotto il mio arco di luppolo fiore, ci passeranno in tre: patris et fili et spiritus sancti, a forgiarci bene nei corpi, saldi e stretti, in reliquia e riposo. Amen. Epistola d'Amore Allora forse verrebbe il domani, amore mio, verrebbe ad assolarci la fronte, circumnavigata di ricordi improbabili, alcuni da implorare la cancellazione, il definitivo disincanto, la maldicenza anche, ma non preoccuparti, una cosa vale l'altra se si vive quest'oggi privo del suo ieri, e verrebbe a cullarci come brina fresca il domani, spaziandoci delle malefatte persecuzioni rivolte a noi stessi, spaziandoci dai nostri segreti pronti a diventare acqua, pronti a ritornare nell'utero primordiale per far navigare barchette di cuori e coriandoli. Io ci credo che il tempo passa e ritorna costantemente, ci credo che abbia un senso tutto questo sentire, questo dolore, questa enorme mole perché, se non ne avesse, un fiore, a quale luce estenderebbe il suo stelo, per quale motivo il rinverdire dell'albero? Ma noi moriamo lentamente, questo è il punto, ci vediamo morire e gli occhi lo sanno, la pelle, che vi trasuda dentro, acquatile forma disgregata da rincollare e lasciare al suo declivio. Sorpassarla dovremmo, renderci immortali oltre il corpo, plasmarci al cielo, ritrovare Dio, lasciarci accecare senza paure a luce piena, in piena faccia, amare, ancora. Ora lasciami piangere un poco, implorare questa resa dei sensi perché possano innevarsi del loro pensiero e sbiancare sino a svanire. Mi piacerebbe portarti con me, amore, tra le mani accarezzarti le guance, il collo, inginocchiarmi sul tuo altare, sacrificarti qualsiasi cosa, espropriarmi, estromettermi da me, svuotarmi intera al tuo atto magnifico, cedere la Creazione e poi, superarti, per non cadere in nessun compromesso, per immolarmi verso il vuoto eterno e da lì, guardarti, tra gli angeli, proteggerti sussurrarti il verbo, la deriva dei mondi, il palinsesto di questa vita; un'astrazione. E scusami se rimango solo con un piccolo vischio tra le mani, in ricordo immemore, di te. Mi vivi, questo è quanto! E se non lo sapessi con l'assoluta certezza di un'anima randagia capace di trasformare i suoi sassi in alabastri e rose, non ti regalerei questo mazzo d'amore fasciato di tutto il sangue che posseggo, in nome tuo, per te, pieno d' illusioni, dei suoi sogni e solo dopo di realtà, solo dopo. Ora mi apro calda, viva di mare, capace di sfogliarmi e prendere questa solitudine, se la penso in virtù di te, esistente o inesistente che sia, la tua compagnia mi avvicina a Dio, mi rende l'odore della terra, l'aspro da cui veniamo. La nostra è una condanna che porta croce e ali, per questo mi sento rondine, il mio è un rimprovero di sospensione, un pretesto per parlati di questo nulla da cui proveniamo, per sentire ancora e scuotermi. Di notte penso agli occhi che non ho ancora guardato, che non m'hanno riempita della mia nudità esposta, estremamente di tutti, per appartenenza inevitabile alla specie. Ma solo ora capisco che la ricerca non risiede nei luoghi, nelle case della memoria, nei sotterfugi d'arte, parole, dispense, carta, derive, no, no, è tutto più semplice se si vede con occhi fanciulli; è risposta, la ricerca è risposta, non di domande ma d'intenti, di unisono simultanei, è gioco, gioco sacro in cui l'amore intercede a renderne il reale, l' impulso necessario, lo slancio. E che il dolore arretri davanti a tanta bellezza, che s'argini, nel suo stesso fiume.
Scaricare