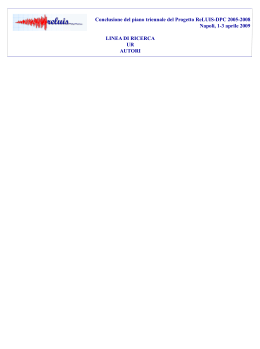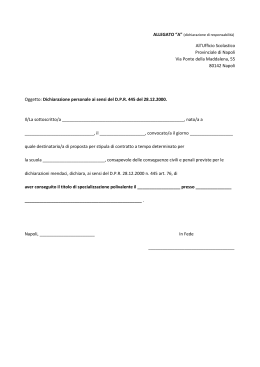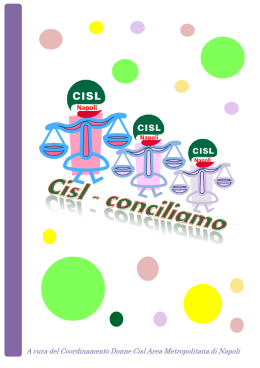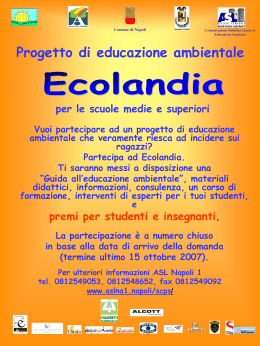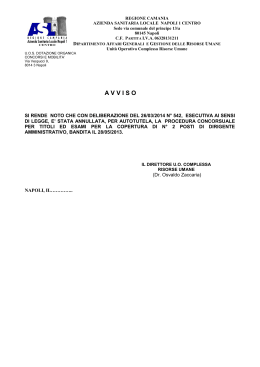Associazione Culturale Voci e Scrittura QUADERNO PELIGNO N. 13 Rivista fondata da Vittorio Monaco L’ABRUZZO E L’UNITÀ a cura di Marco Del Prete Concettina Falcone I componenti dell’Associazione Culturale Voci e Scrittura: De Matteis Maria Luisa - Presidente Cianchetta Diana Colangelo Anna Di Iorio Gemma D’Orazio Di Tunno Nicolina Falcone Concettina Fasoli Mafalda Gay Evandro Giammarco Rosa Leombruno Silvana Maria Mampieri Licia Mosca Gabriele Natale Filomena Nolfi Nicolina Palesse Maria Pia Paolantonio Marcello Pasquali Rita Ricci Evandro Ricottilli Beatrice Russo Raffaele Santilli Bianca Tuteri Rosanna Zurlo Noemi VOCI E SCRITTURA Direttore responsabile: Marcello Paolantonio Aut. Trib. Sulmona n. 127 del 15/01/2004 In copertina: BIANCA SANTILLI, La nostra Unità. www.vociescrittura.it [email protected] PRESENTAZIONE L’Associazione Culturale Voci e Scrittura partecipa alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con la pubblicazione del 13º Quaderno Peligno “L’Abruzzo e l’Unità”. Gli anni passati consentono una visione più distaccata dell’evento, senza dubbio positivo per aver riunito un popolo riscattandolo dalla sottomissione allo straniero, che nel suo compiersi ha dato luogo a sacrifici, eroismi e vittorie ma anche a ritardi colpevoli, attese deluse sfociate in vere e proprie tragedie di cui la storia poco si è occupata, ma che oggi vengono dibattuti anche in questo quaderno nella assoluta libertà di pensiero e opinione di chi scrive. Naturalmente l’obiettività dell’analisi storica non intacca in alcun modo la volontà e l’orgoglio dell’appartenenza, così faticosamente guadagnata, all’Italia. Le tendenze separatiste non possono che amareggiarci e ci auguriamo che le celebrazioni dell’Unità costituiscano non una circostanza retorica, ma l’occasione per un ripensamento sereno della nostra vicenda nazionale, così da ritrovare in essa una memoria condivisa; ricorrenza che vede la Chiesa unita al Paese nel festeggiare l’evento, tanto è lontana ormai la “breccia di Porta Pia”. La copertina del Quaderno è una produzione artistica della socia pittrice Bianca Santilli alla quale va il nostro affettuoso ringraziamento. Voci e Scrittura inoltre ha il piacere di ristampare, quale tangibile ricordo del 150° anniversario dell’Unità, il volume Italia, Italia, Italia – Il Risorgimento nel canto dei poeti, a cura di R. Micacchi e F. Rubbiani, pubblicato la prima volta dalla casa editrice L’«Agave» alla fine della prima guerra mondiale, “nel dì della vittoria, novembre 1918”. Il libro “che non vuole essere antologia, né florilegio letterario” contiene “tutte” le poesie del Risorgimento, da quelle dei grandi quali Leopardi, Manzoni, Pascoli, D’Annunzio, (sono compresi nel volume irredentismo, guerra d’Africa e prima guerra mondiale) a quelle dei minori, per una precisa scelta dei curatori, che raccolsero “per i giovani d’Italia quei canti, che meglio rispecchiano i fremiti, le speranze, i dolori delle generazioni da cui uscirono gli assertori e i vindici della 5 unità nazionale, le aspirazioni di coloro che vollero la risorta Italia grande e rispettata e degna di esercitare nel mondo la missione di civiltà, che le è segnata da tutta la sua storia”. Ai ragazzi di oggi risulterà obsoleto il linguaggio ed eccessiva l’enfasi di molte strofe, che però saranno illuminanti per comprendere lo spirito che animava i loro coetanei di quasi due secoli fa, quelli che resero possibili il Risorgimento e l’Unità d’Italia. L’Associazione Voci e Scrittura ringrazia sentitamente la Fondazione Carispaq, le Istituzioni, gli Istituti Bancari Bls e Carispaq e l’Itaeli, che con il loro contributo rendono possibile la pubblicazione dei Quaderni; l’Agenzia Regionale Promozione Culturale di Sulmona per il sostegno alle iniziative e per l’ospitalità concessa settimanalmente; il prof. Antonio Di Fonso per la cortese disponibilità. Maria Luisa De Matteis 6 SAGGI 7 8 LA LETTERATURA ABRUZZESE E L’UNITÀ D’ITALIA di Marco Del Prete Dopo i fermenti culturali che avevano caratterizzato l’Abruzzo tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta dell’Ottocento1, la repressione borbonica mette un deciso freno al lavoro dell’intellettualità, e anche la letteratura vive una sorta di sospensione. La letteratura “risorgimentale” abruzzese trova infatti voce fuori dall’Abruzzo, ed è comunque priva di ogni caratterizzazione regionale: i Carmi di Clemente De Caesaris, l’opera di Gabriele Rossetti e la produzione paraletteraria di Giannina Milli sono evidentemente scollegati dal luogo di origine degli autori. CLEMENTE DE CAESARIS (Penne 1810-1877), di famiglia liberale, fu a capo della rivoluzione mazziniana di Penne, e nel 1848 combattè a Napoli. Arrestato, fu rinchiuso nel Bagno Borbonico di Pescara. Dopo l’Unità, venne nominato Pro-dittatore dei Tre Abruzzi e Governatore di Teramo, Chieti e L’Aquila. Nel 1840 pubblicò a Napoli la raccolta Pochi versi, e nel 1856 compose I Carmi, scritti sui fogli dei registri carcerari. «De Caesaris ricusa i toni retorici e tribunizi ed esprime il proprio dolore con animo sdegnato ma sereno. Naturalmente la prigione è per lui il punto di vista da cui guardare il mondo, gli affetti familiari, il luogo da cui meditare sulla morte e sulle sventure umane: il dato contingente così si allarga ad una visione universale.»2. GABRIELE ROSSETTI (Vasto 1783 - Londra 1854), di umili origini, assiduo frequentatore dell’erudito vastese Benedetto Maria Betti e arca1 Si ricordino le due riviste ‘Gran Sasso d’Italia. Periodico di scienze mediche ed economiche’ (1838-1848), nata a L’Aquila per iniziativa dell’agronomo Ignazio Rossi e di Luigi Dragonetti, e ‘Filologia abruzzese’, diventata poi ‘Giornale Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti’ (1836-1844), fondata e diretta a Chieti da Pasquale De Virgiliis. A fronte degli interessi quasi esclusivamente tecnici della prima, la rivista del De Virgiliis si occupò largamente di letteratura: cfr. C. De Matteis, Civiltà letteraria abruzzese, Textus, L’Aquila, 2001, p. 260. 2 G. Oliva, Profilo storico-critico, in G. Oliva - C. De Matteis, Letteratura delle regioni d’Italia. Storia e testi. Abruzzo, Editrice La Scuola, Brescia, 1986, p. 47. 9 de con il nome di Filidauro Labidiense, fu personaggio dai diversi interessi culturali. Trasferitosi a Napoli per occuparsi di pittura, fu autore di versi di vario genere (tra i quali spicca quello lirico-patriottico) e critico letterario (molto noti i suoi commenti alla Divina Commedia3). Dopo i moti del 1820-21 fu in esilio a Malta e poi, definitivamente, a Londra. Un discorso a parte va fatto per GIANNINA MILLI (Teramo 1825 Firenze 1888), improvvisatrice di versi fin da bambina, che ad un certo punto abbracciò quella causa risorgimentale che ebbe larga parte nelle sue performances in cui declamava versi estemporanei su argomenti dettati dal pubblico. Parlare di “letteratura” per la Milli -e più in generale per la categoria degli improvvisatori4- risulterebbe piuttosto audace. La natura sarebbe stata con lei eccessivamente benevola se oltre a dotarla di un’eccezionale memoria e della fluidità nel verseggiare le avesse fatto dono anche di un particolare afflato poetico. La Milli si ricorda dunque non tanto per i suoi versi, sicuramente non memorabili, ma per l’aver messo il suo talento di improvvisatrice, da un certo punto in poi, al servizio della causa unitaria: e lo stato unitario non mancò di dimostrarle riconoscenza, con l’affidamento di incarichi ministeriali. Di questa produzione “risorgimentale” -rigorosamente in lingua, per motivi facilmente intuibili- si legga qualche strofa da Unità e libertà di Rossetti, in cui si noterà il ritmo anapestico del decasillabo che richiama immediatamente alla memoria -per fare gli esempi più famosi- il coro del Conte di Carmagnola e Marzo 1821 di Manzoni: (…) Questo fuoco che all’alme s’apprende 3 Si ricordino soprattutto: G. Rossetti, La Divina Commedia con comento analitico di Gabriele Rossetti, John Murray, Londra, 1826-1827, II voll.; G. Rossetti, La Beatrice di Dante, Londra, 1842; G. Rossetti, Comento analitico al «Purgatorio» di Dante Alighieri, op. inedita a cura di P. Giannantonio, Olschki, Firenze, 1967. 4 «[La Milli] ebbe, com’è noto, tra i detrattori Benedetto Croce che, pur non discutendo le buone intenzioni, ne rimproverava l’appartenenza alla genìa degli improvvisatori. E a dare addosso alla categoria si era già prestato Pietro Giordani quando, coinvolto nel pieno della temperie dialettica con la De Staël, venne guadagnato da Giuseppe Acerbi, direttore della “Biblioteca Italiana”, alla causa di arginare il crescente entusiasmo per le esibizioni degli estemporanei», considerate «raptus poetici forieri di pessimi versi.» (L. Pasquini, Lionardo Vigo e Giannina Milli. Due identità culturali a confronto., in L. Giancristofaro, a cura di, L’identità abruzzese tra tradizione e mutamento, Regione Abruzzo, 2004, p. 88). 10 E le invade le scuote le accende, Questo fuoco, fratelli, vi sveli Che terrestre di tempra non è: Ah, discese dall’ara de’ cieli La scintilla che incendio si fé! Da quell’altar discese Che infiamma a sante imprese, E i cuori infervorando Tutti sclamar ci fa - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà! – (…) Ci divise perfidia e sciagura, Ma congiunti ci volle natura. Alma diva, cui l’Alpe corona Fra gli amplessi di duplice mar, Se una lingua sul labbro ti suona, Un sol culto ti sacri l’altar! Chi in sette ti partio Tradì l’idea di Dio E il mostro abbominado Il fio ne pagherà: Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà! – (…)5. È abbondantemente dopo l’Unità che la letteratura abruzzese recupera la memoria e procede ad una riflessione su quegli anni e -soprattutto- sugli anni che tennero dietro all’unificazione. Per quel che riguarda lo specifico della poesia dialettale, come ricorda Haller -sulla scorta di Spagnoletti e Vivaldi6- «nonostante le 05 G. Rossetti, Poesie ordinate da Giosuè Carducci, a cura di Mario Cimini, Carabba, Lanciano, 2004 (1ª edizione Barbera, Palermo, 1861), p. 227-228. 06 «Anche per l’Abruzzo si dovrebbe dire quel che vale per un’altra regione, la Puglia: i poeti dialettali di entrambe le regioni, infatti, non manifestarono affatto quegli spiriti di protesta postunitaria, che, assieme alla denunzia di penose condizioni sociali, caratterizzarono la poesia calabrese.» (G. Spagnoletti - C. Vivaldi, Poesia dialettale dal Rinascimento ad oggi, II voll., Garzanti, Milano, 1991, pp. 783-784). 11 dure condizioni della classe popolare non si alzano voci di protesta sociale paragonabili per forza d’impegno, per non fare che un esempio, a quelle calabresi»7. Certo, c’è in alcuni poeti abruzzesi «la consapevolezza della scelta dialettale come mezzo alternativo al processo di dissoluzione messo in atto contro i dialetti dalla politica post-unitaria»8, ma è in forme piuttosto mediate che emergono posizioni di qualche interesse per il nostro discorso. In Fujj’ammësche9 di LUIGI ANELLI (Vasto 1860-1944) c’è una coppia di sonetti, datati 1891, in cui sono chiamati ad esprimersi e a rendere conto delle proprie idee un ‘borbonico’ e un ‘liberale’. Il primo, nella classica laudatio temporis acti, lamenta il passaggio dall’antica abbondanza ad un presente di povertà: Nin zi pó cambà’ cchiî, è ‘n’arruvëine! mar’a nnî, chi cci seme capitate! e ppinzà’ ca ci štäive li quatrëine, e che ‘m mezz’ala grassce seme nate!10 Segue nella seconda quartina una sorta di tabella del potere d’acquisto preunitario, con precisi riferimenti alle vecchie monete, il cui valore viene spiegato in nota dallo stesso Anelli: A ddu’ turnëisce si vinnè lu vëine: cinghe rane di pane ‘na palate: mê’ nghi nu coppe vi’ chi cci cumbëine, si t’avašte pi’ ffarte ‘na magnate!...11 07 H.W. Haller, La festa delle lingue. La letteratura dialettale in Italia., Carocci, Roma, 2002, p. 230. 08 G. Oliva, Profilo storico-critico, in G. Oliva - C. De Matteis, Letteratura delle regioni d’Italia. Storia e testi. Abruzzo., op. cit., p. 51. 09 L. Anelli, Fujj’ammësche, C.Ed. Arte della Stampa, Vasto, (1892) 19402. 10 Tr.: ‘-Non si può campare più, è una rovina! / poveri noi, che ci siamo capitati!... / e pensare che ci stavano i quattrini, / e che in mezzo all’abbondanza siamo nati.’ (traduz. dell’autore, come tutte le traduzioni a seguire). 11 Tr.: ‘A due tornesi si vendeva il vino; / cinque grana di pane una palata: / ora con un coppe vedi che ci combini, / se ti basta per farti una mangiata!’. 12 Il ‘tornese’ -scrive Anelli- era «una moneta di rame in corso prima del 1860, del valore di circa centesimi due», il ‘coppo’ un «rotolo di monete di rame del valore di L.5.00», un grano equivaleva a due tornesi»: dove si noterà la resa poetica dell’accostamento della moneta, il ‘grano’, al ‘pane’. Il ‘borbonico’ lamenta poi la scarsità di beni sul mercato: Prëime, ala piazze, quälle chi vvulëive; mê’ si l’ome strascëine vita ‘terne a ccapammânde… chi cci vu’ truvà’?12 Infine, nella terzina conclusiva, l’attacco diretto al ‘governo’: Li pisîure ti sîuche vive vëive, cullî ch’arraffe tîtte è lu huverne: chi bbella chéuse ch’è ‘ssa libbirtà!13 C’è in explicit l’antifrasi sulla ‘libertà’, e viene individuata la causa prima dell’impoverimento diffuso, che per il ‘borbonico’ è l’oppressione fiscale dello stato unitario, con le ‘gabelle’ (li pisîure, ‘i pesi’) che ‘ti succhiano vivo’ ed il governo rapace che ‘arraffa tutto’. Che quello della tassazione fosse un problema effettivo, che gravò su una popolazione meridionale abituata ad oneri molto minori sotto il dominio borbonico, è fuor di dubbio. Basti pensare, a titolo di esempio, alle reazioni della popolazione che seguirono all’introduzione della tassa sul macinato14. Immediatamente dopo questo sonetto ce n’è un altro che sembra a tutta prima fargli da contrappeso. Chi parla, in questo caso, è un Libbirale (‘liberale’): Ti dëiche jë, prëime chiù mmäjje jeve! chi bbilli timbe chi mmi štè a vvandà’: 12 Tr.: ‘Prima, alla piazza, quello che volevi; / ora si trascinano vita eterna / fuori… che ci vuoi trovare?’. 13 Tr.: ‘I pesi ti succhiano vivo vivo, / colui che arraffa tutto è il governo: / che bella cosa che è cotesta libertà!’. 14 Il notaio Pietro De Stephanis, che non era propriamente un rivoluzionario, in un articolo inviato a ‘La Riforma’ di Firenze in cui parlava dei tumulti avvenuti a Pettorano 13 sole si ppoche pêuch’ arifiateve jeve ‘n galere senza mal’ a ffa’!15 E continua con la denuncia del prepotere clericale (‘dentro alla casa tua ci comandava / il prete […]’), con il clima di sospetto e con la repressione: (...) e si ddu’ pëile ‘m bacce ti lasseve, Lemme ti li purtav’ a fa’ tajjà’!16 ‘Lemme’ era il gendarme borbonico, come specifica lo stesso Anelli in nota, aggiungendo che «nel 1854 un’ordinanza della sospettosa polizia borbonica proibiva di portare la barba, ritenuta come un segno settario»17. Al ‘liberale’ non preme cioè confutare la teoria del ‘borbonico’ secondo la quale nel vecchio Regno si stava economicamente meglio, ma mettere sull’altro piatto della bilancia la mancanza di libertà. Si’ dëtte ca nijende jave care; ma ‘n d’aricurde ca štavame nî trumundate ‘gne ll’acche dilu mare?18 15 16 17 18 14 sul Gizio, paese della Valle Peligna, nel luglio del 1871, così scriveva: «(...) non si vuol tacere l’opportuna considerazione, che l’odiosa tassa sul macinato, con l’appendice dei sciagurati contatori, e delle vessazioni dei mugnai, onde è tolto di bocca il bisognevole ai poverelli, sia un potente ausiliario alle mene dei tristi (...). Speriamo perciò (...) che sia al più presto abolita la mal consigliata tassa, e convertita in altra imposta meno ingiusta e vessatoria; o altrimenti e con più equo temperamento ordinata.» (P. De Stephanis, in ‘La Riforma’, Firenze, 6 agosto 1871, n. 216). La lettera è riportata integralmente nel sito dell’Associazione Culturale Pietro De Stephanis (www.pettorano.com). Tr.: ‘- Ti dico io che prima meglio era! / che bei tempi mi stai a vantare: / solo se poco poco rifiatavi / andavi in galera senza mal fare!’. Tr.: ‘(...) / e se due peli in faccia ti lasciavi, / Lemme ti portava a farli tagliare!’. Si legga a questo proposito un passo di Colledara di Fedele Romani: «Singolare era l’odio che i briganti avevano per i baffi: i baffi erano segno evidente di liberalismo. (…) Guai a coloro che, all’arrivo dei briganti, non avevano avuto tempo di levarsi i baffi: c’erano di quelli che portavano a questo scopo sempre un bel paio di forbici in tasca: solo così si sottraevano allo strazio di sentirseli svellere, tra feroci sghignazzate, pelo per pelo.» (F. Romani, Colledara, Bemporad, Firenze, 1907; edizione da cui si cita: F. Romani, Colledara, a cura di C. De Matteis, Textus, L’Aquila, 1996, p. 25). Tr.: ‘Hai detto che nulla andava caro: / ma non ti ricordi come stavamo noi / tormentati come l’acqua del mare?’. Ma l’ultima terzina chiarisce la posizione di Anelli e lo colloca in qualche misura, insieme ad altri autori dialettali meridionali, nel filone della protesta antiunitaria: Mê’, alumene, a la länghe ‘n gi fa’ tarle: parlesse spare pure di Ggisî, chi ti dëice cacchéuse?!... Pache… e parle!19 Con l’aprosdoketon finale (paga quello che devi pagare, e poi parla pure quanto vuoi…) Anelli, per bocca del ‘liberale’, avalla in qualche modo le lamentazioni del nostalgico del vecchio regime. Non solo. È evidente che la libertà di espressione è agli occhi del poeta vastese un lusso di nessuna fruibilità per le classi subalterne: che subalterne erano sotto i Borboni e subalterne restano nella nuova Italia. È una posizione, quella di Anelli, che trova esplicita conferma in un altro sonetto, Alu ddazie, che riporta di nuovo il discorso sul terreno delle condizioni economiche disastrose in cui versano larghi strati della popolazione. Un contadino che trasporta un sacco di farina su un mulo viene fermato da un gabelliere che gli intima senza troppe cerimonie il pagamento del dazio: ‘quarantacinque soldi devi sborsare’. La reazione verbale del contadino è una violenta invettiva contro i gabellieri: - Ma quässe mê’ ‘n è ‘na vrivugnarë?!... m’avete date forze pi’ ssumende ca ‘ssi quatrëine v’ájja dà’ ccuscë?!... ‘M mezz’ alu passe ma ppiccä ‘n gi jate?!... ch’almen’ aèlle, pi’ spujjé’ li ggende, vi po’ l’ome chiavà’ ‘na šcupputtate!20 19 Tr.: ‘Ora, almeno, alla lingua non ci fanno tarli: / parlassi male pure di Gesù, / chi ti dice qualcosa?!... Paga... e parla!’. 20 Tr.: ‘- Ma cotesto ora non è una vergogna?!... / m’avete dato forse per sementa / perché cotesti quattrini vi debba dare così?!... // In mezzo al passo perché non ci andate?! / chè almeno colà, per spogliare la gente, / vi possono tirare una schioppettata!’. 15 I gabellieri e lo stato commettono vigliaccamente un ladrocinio legalizzato. Se proprio volete derubare la gente -dice il contadino di Anelli-, abbiate il coraggio di andare al ‘passo’, cioè di appostarvi dove di solito vengono svaligiati i viandanti, mettendo almeno in conto -come tutti i malviventi- il rischio di beccarvi una schioppettata. Va notato, peraltro, come la geremiade del nostalgico di Anelli sull’esosità dello stato unitario sia dello stesso tenore di quella messa in versi alcuni decenni prima nel suo Dies illa21 dal poeta popolare Antonio Rossetti22, che era diretta però contro il governo borbonico: Noi paghiam gabelle tre, Né saper possiam perché. Il Registro, la Fondiaria, L’Ipoteca ...ed anche l’aria. Se vogliamo respirare, Noi dobbiamo pur pagare. E pagar si deve e zitto: Se si grida è un gran delitto: Dies illa, dies irae, Quando, o Dio, vorrà finire?23. Ad inizio Novecento, è ALFREDO LUCIANI (Pescosansonesco 1887 - Pescara 1969) a rievocare nei suoi versi gli anni post-unitari. Lu ragiunamende de ‘nu cafone, in Stelle lucende24, vede squadernate le stesse lagnanze del nostalgico anelliano: 21 La ripresa più o meno parodica dei testi sacri a fini politici non era una novità: si ricordi, a cavallo tra Sette e Ottocento, Il «Te Deum» de’ Calabresi del 1787, composto in due riprese e attribuito a Gianlorenzo Cardone, che è uno dei rari casi in cui il dialetto viene utilizzato in funzione antiborbonica (Cfr. D. Scafoglio, Il Te Deum de’ Calabresi, attribuito a Cardone. Studio e testo, Athena, Napoli, 1985). 22 Antonio Rossetti (1769-1853), di mestiere barbiere, privo di istruzione, era uno dei fratelli del più famoso Gabriele. Un altro, Domenico, che ebbe una formazione giuridica, fu anche verseggiatore estemporaneo. 23 Il testo è riportato in G. Oliva - C. De Matteis, Letteratura delle regioni d’Italia. Storia e testi. Abruzzo., op. cit., pp. 48-49. 24 A. Luciani, Stelle lucende. Canzoniere abruzzese, con lettera di Gabriele D’Annunzio., Bonanni, Ortona, 1913; poi in A. Luciani, L’opera in dialetto, a cura di Ottaviano Giannangeli, Edizioni Textus, L’Aquila, 1996 (edizione da cui si cita). 16 Sott’a Ffrangische, se puteu’ scialá’: lu tabbacche le déune a ttummulate! Mo, nghe ddu’ solde, che tte ‘n’ome dá? Vattel’a vvite’: mezza pezzecate!25 Per buona misura, viene messa in discussione anche la contropartita della “libertà”: E cche tte crite ca tu pu’ parlá ? Pover’a ttì : ci-abbusche ‘na zambate ; pecché mo che cce sta la lebbertà, se po’ fá’ tutte, pure a ddá’ mazzate.26 Una libertà, quella recentemente acquisita, che non serve a migliorare le condizioni di vita del ‘cafone’: ai ‘signori’ l’imposta indiretta sul macinato -scrive Luciani- ne’ jé fa niende! (‘non gli fa nulla’), perché gire ca tte ggire, / magnene sembre (‘gira che ti gira, mangiano sempre’), mentre il cafone si riduce a mmagnarse l’ardiche! (‘a mangiare l’ortica’). Perciò (…) ched’è ‘sta lebbertà, famme capì’?! ‘Nu zappavame prime, e mmo… zappéme; pizze prime, e mmo… pizze: pu’ cambà’? Ma nu’ ‘sta lebbertà ne’ lla vulème!27 Sia pure con tutte le prudenze del caso, e con la registrazione di una sorta di distanziamento praticato dagli autori attraverso l’impiego 25 Tr.: ‘Sotto a (re) Francesco, si poteva scialare: / il tabacco lo davano a tomoli (a iosa)! / Ora, con due soldi, che ti si dà? / Vattelo a vedere: mezza pizzicata!’ (traduz. di O. Giannangeli, come oltre). 26 Tr.: ‘E cosa credi, che tu puoi parlare? / Povero te: ci buschi un calcio; / perché ora che c’è la libertà, / si può far di tutto, anche dar mazzate.’ 27 Tr.: ‘cosa è questa libertà, fammi capire?! // Noi zappavamo prima, e ora… zappiamo; / focaccia gialla prima, ed ora… focaccia gialla: puoi vivere? / Ma noi questa libertà non la vogliamo!’. 17 mimetico del dialetto, siamo dunque, anche in Abruzzo, in linea con lo schema generale delineato da Franco Brevini: «(…) la più tipica letteratura romantico-risorgimentale è di solito in lingua. (…) Dei grandi sommovimenti che investirono il nostro paese tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento i testi dialettali offrono di solito una testimonianza diversa. I risultati più interessanti si registrano fra le pagine ispirate a posizioni reazionarie. In esse, non solo si affermano le ragioni della parte sconfitta, ma, sia pure mediata, si fa sentire la voce delle masse popolari, che, escluse da ogni partecipazione politica, furono nella maggioranza dei casi antigiacobine e conservatrici.»28. Tranne qualche eccezione29, dunque, letteratura risorgimentale in lingua, testimonianze più o meno anti-unitarie in dialetto: emblematico in questo senso -e ci spostiamo per un momento nella capitale del regnoil poemetto in ottava rima ‘O luciano d’ ‘o Rre30 di Ferdinando Russo, pubblicato tra l’altro dal noto editore abruzzese Carabba. ‘A libbertà! Chesta Mmalora nera ca nce ha arredutte senza pelle ‘ncuolle!... ‘A libbertà!... Sta fàuza puntunera ca te fa tanta cìcere e nnammuolle!... Po’ quanno t’ha spugliato, bonasera! (…) ‘A libbertà. Mannaggia chi v’è nato! ‘A chiammàsteve tanto, ca venette! (…) Ah! Ah! Me vene a ridere, me vene! Ogneruno sperava ‘avé na Zecca, tanta renare quanto so’ ll’arene, ‘a gallenella janca, ‘a Lecca e ‘a Mecca! 28 F. Brevini (a cura di), La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento., III voll., Mondadori, Milano, 1999, p. 2617. 29 Lo stesso Brevini cita ed antologizza, tra i dialettali «giacobini», Edoardo Calvo, Gianlorenzo Cardone e Francesco Ignazio Mannu. 30 F. Russo, ‘O luciano d’ ‘o Rre, Carabba, Lanciano, 1910. Si legga anche, dello stesso F. Russo, ‘O surdato ‘e Gaeta, Giannini, Napoli, 1919. 18 Faciteme ‘e beré, sti ppanze chiene! Seh, seh! Quanno se ngrassa ‘a ficusecca! Comme scialammo bello, dint’a st’oro! Sciù pe’ la faccia vosta! A vuie e a lloro! Ccà stammo tuttuquante int’ ‘o spitale! Tenimmo tutte ‘a stessa malatia! Simmo rummase tutte mmiezo ‘e scale, fora ‘a lucanna d’ ‘a Pezzentaria! Che me vuò di’? Ca simmo libberale? E addò l’appuoie, sta sbafantaria? Quanne figlieto chiagne e vo’ magnà, cerca int’ ‘a sacca… e dalle ‘a libbertà!31 Non sfuggirà la sostanziale sovrapponibilità di questi versi con quelli abruzzesi riportati in precedenza. Ma torniamo ad Alfredo Luciani, che non manca di rievocare in una coppia di sonetti la figura del brigante, che tanta parte ebbe nell’immaginario collettivo abruzzese negli anni a cavallo dell’Unità. Qui Luciani pare limitarsi alla descrizione dei fatti, senza addentrarsi in problematiche politico-sociali. Nel primo sonetto vengono infatti richiamati semplicemente la determinazione e la spietatezza dei briganti, che entravano in casa di notte forzando serrature e non davano il tempo di difendersi: E cche vvulive fá’, nghe llu fucile? Lu piomme ti’ lu rabbattéune ‘m mane; ma tu vedive luccecà’ li stile, 31 Tr.: ‘La libertà! Questa Malora nera / che ci ha ridotti senza pelle addosso!... / La libertà!... Questa falsa prostituta / che ci fa tanti ceci in ammollo!... / Poi quando ti ha spogliato, buonasera! / (…) / La libertà. Mannaggia chi vi è nato! / La invocaste così tanto, che venne! / (…) / Ah ah, mi vien da ridere, mi viene! / Ognuno sperava di avere una Zecca, / tanti denari quanti i granelli di sabbia, / la gallinella bianca, Lecca e Mecca! / Fatemele vedere, queste pance piene! / Sì sì! Quando si ingrassa il fico secco! / Come scialiamo bene, in questo oro! / Sciù, alla faccia vostra! A voi e a loro! / Qua stiamo tutti dentro un ospedale! / 19 che tte facéune raggrezzà’ la pelle. E, cacce piastre! sennò, la dumane, ‘n derre le retruvéune le cervelle!32 Nel secondo sonetto si parla della cattura di una banda di briganti, rappresentazione icastica dell’epilogo del brigantaggio: ‘era gente che sta muori e non muori, / e non vuole rassegnarsi ai funerali’. Ma alla fine, non prima di uno scontro cruento, Alli brejande casche l’arme ‘m mane, e sse mìttene tutte ‘ngenucchiune!33 Una descrizione quasi asettica, dunque, quella di Luciani, che non gli impedisce però di tirare un sospiro di sollievo per la ritrovata pace: (…) La pacia me’, tu ne’ lla tié’ l’uhuale: e ppropie ‘n ze vedeve menì’ l’ore de repusá’ e ‘n ze sendì’ cchiù mmale.34 Siamo alla prosa. Oltre ad un paio di novelle di DOMENICO CIAM(Atessa 1852 - Roma 1929) che hanno ad oggetto il brigantaggio (Primi versi e La casa bruciata35), pagine di qualche interesse sulla situazione politica negli anni che seguirono l’unità si rinvengono in un romanzo di GIUSEPPE MEZZANOTTE (Chieti, 1855-1935), La tragedia di Senarica, che ha come scenario la città natale, Chieti, e da cui emerge POLI 32 33 34 35 20 Abbiamo tutti la stessa malattia! / Siamo rimasti tutti in mezzo alle scale, / fuori alla locanda della Pezzenteria! / Che vuoi dirmi? Che siamo liberali? / Dove l’appoggi, questa spacconeria? / quando tuo figlio piange e vuol mangiare, / cerca in tasca… e dagli la libertà!’ (traduz. nostra). Tr.: ‘E che volevi fare, col fucile? / Il piombo “lo raccoglievano (illesi) nelle mani” [Luciani]; / ma tu vedevi lampeggiare gli stiletti, // che ti facevano raggrinzare la pelle. / E, cava piastre! altrimenti, l’indomani, / per terra le ritrovavano le cervella!’. Tr.: ‘Ai briganti cade l’arma in mano, / e si pongono tutti ginocchioni!’. Tr.: ‘O pace mia, tu non hai l’uguale: / e proprio non si vedeva venir l’ora / di riposare e non sentirsi più male’. D. Ciampoli, Fiori di monte, Carluccio, Napoli, 1878. il quadro tutt’altro che limpido degli assetti politici che in periferia seguirono all’unificazione. Esempio emblematico, i membri della potente famiglia Pinti, che erano sempre stati di fede borbonica, e che dopo il 1861 «scavalcano a “sinistra” i vecchi liberali di destra»36. I tre fratelli Pinti erano liberali di sinistra (...). I fratelli Pinti avevano ereditato da don Clementino Pinti l’influenza pubblica insieme alla clientela politica, che essi facevano ogni arte per mantenere ed accrescere. Don Clementino Pinti era in sua vita borbonico e clericale; e gran merito suo era stato non far mistero ad alcuno dei suoi principii, quando ognuno si celava sotto una veste liberale. Dopo le novità del sessanta, allorché, svaniti gli entusiasmi e le turbolenze, gli fu dato riprendere il sopravvento su ogni classe della cittadinanza senza pericolo e senza timore di offendere lo spirito pubblico, egli fu sollecito a mettersi tra gli eccessivi nel gruppo di sinistra, perché i liberali e i novatori erano nella più gran parte schierati sotto la bandiera di destra. Tale condotta era ispirata da uno spirito di opposizione (...): epperò, fu visto il nuovo fenomeno di un’opposizione di sinistra più conservatrice di una maggioranza moderata, avendo don Clementino Pinti raccolto intorno a sé un buon nucleo di possidenti, stretti a lui per sentimenti e per timore di novità, e da lui ispirati; i quali vedevano nel nuovo regime un attentato perenne alla loro proprietà (...). Questo, dunque, era un coro che pigliava intonazione da don Clementino Pinti, il quale si opponeva fieramente a qualunque novità gli altri pensassero e proponessero, nell’intento di fare che Senarica rimanesse quale era prima del 1860: e allorché spiegava la sua opposizione, egli era tale testa ed era talmente temuto, che riusciva a far cadere le proposte, o, approvate, a non renderle esecutive.37 Insomma, uno spaccato socio-politico di trasformismo, di opportunismo e di corruzione che non può non richiamare alla memoria il più celebre e più recente Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. 36 C. De Matteis, Civiltà letteraria abruzzese, Textus, L’Aquila, 2001, p. 281. 37 G. Mezzanotte, La tragedia di Senarica, Pierro, Napoli, 1887. 21 Sempre a proposito di prosa, ma di altro genere, va ricordato FEDELE ROMANI (Colledara 1855 - Firenze 1910) per il suo libro di memorie, Colledara. Romani dedica molte pagine al brigantaggio38, e come Luciani non indulge in rappresentazioni oleografiche e mitizzanti, e non manca di mettere in rilievo la ferocia dei briganti. (…) Essi per lo più agivano per mezzo di ricatti. Sorprendevano e portavano con sé il capo di casa: poi mandavano a chiedere alla famiglia una data somma, proporzionata alla riputazione di ricchezza che essa godeva. (…) Non sempre però i briganti si servivano di questi mezzi, atroci sì, ma incruenti. A volte, fatti più arditi dalla paura altrui e dalla buona fortuna, assalivano le case, le saccheggiavano, le incendiavano. E oltraggiavano, ferivano, torturavano, uccidevano le persone che cercavano di opporsi ai loro atti nefandi, che non volevano dar denaro, o non volevano rivelare dov’esso fosse nascosto, o che, semplicemente, si rifiutavano di gridare: - Viva Francesco II!- perché quei manigoldi, nonostante che non fossero se non veri e proprii ladroni e assassini, volevano innalzare e in certo modo nobilitare il loro carattere, facendo le viste di combattere per un principio politico.».39 E qui Romani opera una distinzione tra briganti, distinguendo tra i «brigantucoli» che «infestavano» le sue «contrade» ed i «briganti di alta reputazione», che avevano contatti con il Re di Napoli ed erano foraggiati dai Borboni. Per descrivere chi si piccava di combattere i briganti, Romani utilizza non di rado il registro ironico, ad attestarne la scarsa propensione al coraggio. 38 Si ricordino, sul tema del brigantaggio, anche le pagine di A. MacDonell, In the Abruzzi. With twelve illustrations after water-colour drawingsby Amy Atkinson., Chatto & Windus, Londra, 1908, tradotto da Gilda Taurisani e pubblicato nel 1991 a Sulmona dal Centro Studi “Panfilo Serafini”, con il titolo Negli Abruzzi e con nota introduttiva di Franco Cercone. 39 F. Romani, Colledara, op. cit., pp. 23-24. 22 La notte, fiere pattuglie composte di borghesi sul labbro dei quali nereggiavano i nuovi baffi rivoluzionari, uscivano in ronda, armate fino ai denti, per dar la caccia ai briganti che s’aggirassero nei dintorni. L’impresa pareva piena di pericoli; e le mogli, come Creusa, la notte dell’incendio di Troia, piangendo e mostrando i figli pargoletti scongiuravano, ma inutilmente, gli ostinati mariti a non uscire. Essi avevano cura di prendere sempre la direzione opposta a quella dove si diceva che fossero i briganti, perché questi la sanno lunga e accennano a voler ferire a destra per poi ferire improvvisamente a sinistra. Ma, con tutto ciò, i fieri drappelli non riuscivano mai ad abbattersi coi briganti; e, benché spesso la campagna risonasse di schioppettate che potevano far credere ad uno scontro, esse erano sempre tirate contro alberi e cespugli (…)40. Erano più “fortunati” -racconta Romani- i bambini, che per emulare le grandi gesta paterne si riunivano in «piccoli eserciti», e non di rado si imbattevano -loro sì- in «schiere di briganti, piccoli come loro», dando luogo a «scaramucce e battaglie, non sempre, a dir vero, incruente»41. Non molto più tenero è Romani con le truppe dei regolari della Guardia Nazionale, di cui sottolinea la mancanza di esperienza e -si direbbe oggi- di professionalità, non solo nei semplici soldati, ma sovente anche in chi era chiamato ad impartire ordini. Né manca di sottolineare, il nostro autore, come molti “garibaldini” delle sue parti non fossero propriamente degli stinchi di santo e degli idealisti: Ma chi erano quelli che partivano? Se non conoscessi, per aver letto il loro nome nella storia, o per aver studiato i loro scritti, quali anime grandi, piene dei più nobili sentimenti e dei più alti ideali, si raccoglievano intorno all’Eroe, dovrei credere, giudicando da alcuni che partivano dal mio paese, che le schiere garibaldine fossero composte di gente non meno forse brigan- 40 F. Romani, Colledara, op. cit., pp. 18-19. 41 F. Romani, Colledara, op. cit., p. 19. 23 tesca dei veri e proprii briganti. Essi partivano, non già per impulso disinteressato d’amor di patria, ma per la speranza di trovare il modo, nella confusione degli avvenimenti, di potersi impadronire di ricco bottino o di essere in altra maniera lanciati in alto dalla fortuna.42 Romani rievoca dunque gli eventi che portarono all’Unità d’Italia in modo lucido, mettendo ordinatamente sul tavolo -al di là di ogni enfasi patriottica, e al di là di ogni atteggiamento nostalgico- una serie di problemi connessi al processo di unificazione e agli anni immediatamente postunitari. E parla, esplicitamente, di una “rivoluzione elitaria”, (...) eminentemente letteraria, ispirata dai libri, fatta con la spada in una mano e con Dante e Virgilio nell’altra. Essa usciva dalla scuola, e il popolo, e specialmente quello di certe provincie, non la capiva, né la desiderava (...). Questa è la verità, e non bisogna aver paura di dirla.43 Riguardo agli anni che seguirono all’unificazione, Romani -come i poeti precedentemente citati- riporta il punto di vista di un “popolo” per nulla entusiasta dei nuovi assetti economico-sociali: Il popolo (....) aborriva quelle novità, che riteneva fossero tutte a vantaggio della classe odiata nel fondo del suo cuore, i signori (...). Le tasse cresciute improvvisamente, in modo insopportabile e non proporzionato ai guadagni ed alle rendite, gli facevano ritenere che il nuovo governo fosse composto tutto di ladri. Il capo dei ladri, secondo lui, era lo stesso Vittorio Emanuele, e per sfogare in qualche modo il suo rancore, lo chiamava lu cecäte (il cieco).44 42 F. Romani, Colledara, op. cit., p. 22. 43 F. Romani, Colledara, op. cit., p. 20. 44 F. Romani, Colledara, op. cit., p. 21. Romani scrive di non sapere da che cosa derivasse il nomignolo dato al re. Nei dialetti abruzzesi, è un dispregiativo piuttosto diffuso e generico. Nel caso specifico, fa pensare ad una mancata visione/considerazione dei problemi del popolo. 24 Insomma, Romani dà la netta impressione di considerare l’Italia dei suoi tempi un’Italia di transizione. Tanti e tali sono gli elementi di provvisorietà, i malcontenti, i sommovimenti sociali, da far preconizzare allo scrittore colledarese una futura «nuova Italia» che abbia come protagonista «quella massa grigia, che non significava nulla, ed era come un fondo nebuloso ed uniforme del gran quadro», e che invece ora «comincia ad avere una coscienza»45: [Quella massa grigia] comincia qua e là ad agitarsi, come le onde che si addestrano agl’impeti ed alle furie della vicina tempesta: essa alza il capo e si guarda intorno e non sa perché sia accaduto quello che è accaduto, come chi si risveglia da un lungo sonno. Essa guarda verso di noi, che leggiamo Dante e Machiavelli, e pensa: - Voi vi siete fatta la vostra Italia: ora tocca a me farmi la mia. – E un giorno, anch’essa se la farà; non c’è da dubitarne. E noi, piuttosto che pensare con dolore e spavento a questa nuova Italia, piuttosto che combatterla ed avversarla prima che essa nasca, salutiamola fin da ora nella sua nuova grandezza e nella sua nuova gloria.46 Quale sia la reale posizione di Romani riguardo a questa nuova Italia da venire, in realtà, è difficile dire. Osta ad un’interpretazione pacifica di questo passo la pluralità dei registri che percorrono la pagina del colledarese. La frase che chiude il passo sopra riportato, ad esempio, non sembra del tutto esente da un’ironia piuttosto amara sulle resistenze al cambiamento da una parte, e sugli entusiasmi facili e le propensioni trasformistiche dall’altra. 45 F. Romani, Colledara, op. cit., pp. 20-21. 46 F. Romani, Colledara, op. cit., p. 21. 25 26 DA OTTAVIANO GIANNANGELI Ho pensato di inviare per questo 13° Quaderno “L’Abruzzo e l’Unità” che esce in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia una stornellata parodistica della cantata che soleva eseguirsi in quasi tutti i paesi del nostro Abruzzo il giorno di Sant’Antonio Abate, 17 gennaio. L’aveva raccolta il dott. Franco Farias della sede Rai di Pescara da un vecchio di Farindola (TE) e l’aveva offerta ai Vecchi Cantori di Raiano che la eseguirono, diretti da me, nella Quinta Serata Canora il 18 Agosto 1979. Il canto sembra nato proprio nel SessantaSessantuno (naturalmente Ottocento), nella presenza degli eventi. Può darsi che qualche strofa fosse aggiunta dopo, essendo ad esempio attribuito un difetto fisico (sembra) del padre Vittorio Emanuele II al figlio Umberto I. Il canto è stato da me passato alla “Rivista Abruzzese” che l’ha pubblicato sul n. 2, 2011 senza la musica trascritta dal M° Vincenzo Polce, che qui compare per la prima volta. 27 HA MINUTE LU SESSANDE Ha minute lu Sessande, aveme armaste a tande a tande. Ha minute lu Sessandune, aveme armaste senza patrune. Come li pecure spatriate, viva Sant’Antonie Abbate! Ca s’ha ndese la voce pe l’arie ca ha arsate la fundiarie, e Umberte nghe l’uocchie cecate ha fatte arsaje la carte bullate. E tutte li tasse ha umentate: Viva Sant’Antonie Abbate! Mo che ngi sta chiù li rane Nin si magne chiù lu pane, mo che nin gi sta li carrine nin si veve chiù lu vine. E ci amanghe li ducate: Viva Sant’Antonie Abbate! Lu cuverne di Borbone ca ha scritte a Pio None ca l’avesse aiutate na sta guerra dichiarate. Ma lu pape nzi n’ha frecate: Viva Sant’Antonie Abbate. Che je pijje n’accidente a Garibalde e Don Clemente; dapù che Napule l’ha pijjate a Vittorie l’ha cunzignate. Alli puvere ngi ha pinzate: Viva Sant’Antonie Abbate. 28 Mo che nin sone lu trabbande s’ha furmate li brihande, mo chi sone lu trumbittire ha finite li cannunire. E Francische ha scappate: Viva Sant’Antonie Abbate Li brihande nin cerche la grazie, Valendine, Saccocce e Ttanazie, ……………………………….. ……………………………….. Li quatrine li tè arcazate: Viva Sant’Antonie Abbate! Oh…ché scite accise li guardie mobbile e li Piemundise, dapù che tutte s’ha finite allu Piemonde si n’ha rijite. Mmezz’alli uaie ci ha lassate: Viva Sant’Antonie Abbate! È VENUTO IL SESSANTA. È venuto il Sessanta, / siamo rimasti come stavamo. / È venuto il Sessantuno, / siamo rimasti senza padroni / Come le pecore spatriate / Viva Sant’Antonio Abate! // S’è sentita una voce per l’aria / ch’è risalita la fondiaria, / e Umberto con l’occhio cieco / ha fatto risalir la carta bollata. / E tutte le tasse sono aumentate; / Viva Sant’ Antonio Abate! // Or che non vi sono più le grana / non si mangia più il pane, / or che non vi sono i carlini / non si beve più il vino. / E ci mancano i ducati: / Viva Sant’Antonio Abate! // Il governo di Borbone / (dicon) che ha scritto a Pio Nono / che l’avesse aiutato / in questa guerra dichiarata. / Ma il papa non se n’è importato: / Viva Sant’Antonio Abate! // Che gli pigli un accidente / a Garibaldi e Don Clemente, / dopo che Napoli l’ha pigliata / a Vittorio l’ha consegnata. / Ai poveri non ha pensato: / Viva sant’Antonio Abate ! // Or che non suona il soldato di guardia / si son formati i briganti, / or che suona il trombettiere / son finiti i cannonieri. / E Francesco è scappato: Viva Sant’Antonio Abate ! // I briganti non chiedono la grazia, / Valentino, Saccoccia e Attanasio, /……… / I quattrini li tengono sotterrati: / Viva Sant’Antonio Abate! // Oh che siate uccisi / le guardie mobili e i Piemontesi, / dopo che tutto si è finito / al Piemonte se ne son tornati. / In mezzo ai guai ci hanno lasciati: / Viva Sant’ Antonio Abate! 29 30 … MA L’IDEAL NON MUORE di Concettina Falcone Nel film Allonsanfan (1974) dei Fratelli Taviani un nobile lombardo, Fulvio Imbriani, incarcerato dopo la restaurazione del 1816 per la sua appartenenza alla setta dei Fratelli Sublimi, dopo il rilascio torna a casa e si abbandona alle piccole gioie della vita domestica. Quando è costretto a rientrare nella carboneria, si impossessa del danaro affidatogli per la causa e tradisce i compagni. Sbarcati tutti in una spiaggia del sud sperando nella sollevazione degli abitanti, vengono massacrati da soldati e contadini – evidenti i riferimenti ai fratelli Bandiera e a Pisacane –. Il traditore, che ha barattato la propria incolumità con la delazione, incontra l’unico sopravvissuto, “Allonsanfan”, ferito alla testa, che nel delirio gli racconta come i rivoluzionari siano stati accolti trionfalmente dalla gente del luogo. Fulvio reindossa la camicia rossa su quella bianca, che deve distinguerlo dai patrioti e salvarlo, e viene ucciso a sua volta. In Senso (1954), film di Luchino Visconti da una novella di Arrigo Boito, siamo a Venezia nel 1866 alla vigilia della battaglia di Custoza. Livia Serpieri, avvenente nobildonna non più giovanissima vicina agli irredentisti, si innamora perdutamente di un giovane tenente austriaco, Franz Malher, al quale consegna i soldi destinati ai patrioti. Livia dimentica ideali, onore, dignità pur di raggiungere l’ufficiale, scoprendo che i denari non gli sono serviti per corrompere i medici e ottenere l’esonero dal servizio militare, ma per vivere nel lusso e tradirla con più giovani donne. Lo denuncia al comando austriaco condannandolo alla fucilazione per diserzione e perde la ragione. Nell’uno e nell’altro film l’utopia si dissolve, nel primo per il desiderio di una serena normalità e nel secondo per un inopinato innamoramento che travolge ogni ideale. Nonostante la riprovazione per il comportamento dei due protagonisti, a noi cittadini edonisti di opulente repubbliche occidentali, privi delle spinte ideali che hanno contraddistinto periodi storici precedenti, sembra più “umano” il cedimento a fatti e sentimenti 31 contingenti che una vita trascorsa in esilio o in galera per un’idea che difficilmente si realizzerà compiutamente. Ma “Una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale l’Umanità approda di continuo. E quando vi getta l’ancora, la vedetta scorge un Paese migliore e l’Umanità fa di nuovo vela”1 dice Oscar Wilde. Paul Claudel è meno ottimista: “Chi cerca di realizzare il paradiso in terra, sta in effetti preparando per gli altri un molto rispettabile inferno”. Ce lo confermano i postumi delle grandi rivoluzioni, dalla “terreur” e dalle guerre napoleoniche al comunismo reale. Ma è anche vero che dopo le rivoluzioni il mondo avanza, a piccoli travagliati passi. Scrive Eduardo Galeano: “Lei è all’orizzonte. [...] Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a questo: a camminare”2. La dedizione all’utopia è assoluta quando il sogno dell’avvento di nuove età di maggiore giustizia sociale assume i contorni certi di una religione, giacché l’utopia “rende concreto e plastico l’anelito antichissimo e diffuso a una vita migliore” (A. Savinio). Non ci spiegheremmo altrimenti il fervore patriottico che infiammò i ragazzi del Risorgimento con il relativo stravolgimento di abitudini e aspirazioni, perdita della libertà, esilio e a volte la morte. L’intellettuale sulmonese Panfilo Serafini (1817-1864) per un volantino e un sonetto contro il regime – secondo Croce scritto in effetti da Leopoldo Dorrucci – fu condannato dalla borbonica Gran Corte Speciale di Aquila a venti anni di carcere. Ne scontò cinque, fino all’arrivo di Garibaldi, in condizioni disumane – prigione scavata nella roccia e catena alla caviglia a Montefusco e nelle altrettanto brutali carceri di Montesarchio e Procida – che minarono irrimediabilmente la sua salute. Ebbe come compagni di pena Carlo Poerio e Sigismondo Castromediano. 41 O. Wilde, L’anima dell’uomo sotto il socialismo, Feltrinelli, 2005 42 E. Galeano, Finestra sull’utopia, da Parole in cammino, Sperling & Kupfer, Milano 2006, pag. 255. 32 Alcuni decenni dopo l’unità Il Martello, periodico newyorkese dell’anarchico di origini sulmonesi Carlo Tresca, pubblica in prima pagina l’articolo Commemorando il nostro poeta Pietro Gori nell’anniversario della morte3 della poetessa Virgilia D’Andrea, anch’essa sulmonese e anarchica, esule negli Stati Uniti dopo esserlo già stata in Francia, la quale descrive con cognizione di causa la vita difficile dell’idealista militante: […] O voi tutti, discacciati dalla terra dove forte e rigogliosa fiorì la giovinezza vostra; O voi tutti, che ve ne andate per le strade del mondo perché non avete un rifugio sicuro nel paese che rendeste grande e nobile con il vostro lavoro, che rendeste glorioso e ammirevole con le vostre lotte; O voi, che sentite il martirio dell’incerto ed oscuro domani ed il singhiozzo e la ruina del passato travolto; O voi, che vi lasciate colpire per difendere la vostra bandiera; [...] O voi che conoscete i deprimenti opifici delle immense città straniere e superbe e che sapete l’agonia delle giornate senza lavoro e senza pane e la freddezza della stanza vuota dove né bimbo vi sorride e né donna vostra vi bacia; O voi, che siete odiati perché avete molto amato, che siete stati feriti perché avete fasciato le ferite dei fratelli, che siete stati insultati e sputacchiati perché vi siete genuflessi davanti allo strazio del calvario, che siete stati ripudiati perché avete raccolto sulle braccia il carico delle umane miserie, che siete stati crocifissi perché avete ostinatamente creduto, che siete stati discacciati oltre i confini perché avete sognato una più vasta e più libera patria, bussate, oggi, alla tomba del vostro cantore e riposate accanto al biancore del marmo la fronte che brucia e le mani che tremano. Perché la primavera rifiorisca attorno al germoglio della vita travolta. Perché l’azzurro ritorni nel fosco grigiore dei pensieri accorati. Perché rinascano le rose là dove magnifici sogni furono recisi. E sieno rosse, rosse e vive come il sangue che cola dal ramo martoriato. 43 V. D’Andrea, Ricordando il nostro poeta Pietro Gori…, Il Martello, New York, 26 gennaio 1924, vol. X, n. 4, pag. 1. 33 E conclude con i versi di Gori: Passan le glorie, muoion gli Dei, l’odio, l’amore, Su per l’orbe vetusto: ma l’ideal non muore. Lo stesso Tresca nell’ultimo primo maggio della sua vita, anno 1942, scrive: Verrà. Verrà il Primo Maggio di fiamme, di sole, di canti e di battaglie feconde. Bisogna avere fede. Bisogna mantenere dritta la schiena, tesa la mente, ferma la coscienza. Nel Risorgimento l’esempio più illustre di anima inquieta è Giuseppe Mazzini, che Edmondo De Amicis in Cuore (1886) così descrive: “ … Tutti pigliammo la penna. Il maestro dettò: «Giuseppe Mazzini, nato a Genova nel 1805, morto a Pisa nel 1872, grande anima di patriotta, grande ingegno di scrittore, ispiratore ed apostolo primo della rivoluzione italiana; il quale per amore della patria visse quarant’anni povero, esule, perseguitato, ramingo, eroicamente immobile nei suoi principii e nei suoi propositi”. Unica consolazione nella vita dell’“apostolo” il telegramma del 9 febbraio 1849 con l’invocazione di Goffredo Mameli: Roma repubblicana, venite! Consolazione che dura qualche mese, dopodiché Mazzini si dimette con gli altri triunviri dichiarando di essere stato eletto “a difendere non a sotterrare la repubblica”. Esule antico, al ciel mite e severo Leva ora il volto che giammai non rise, «Tu sol – pensando – o idëal, sei vero».4 44 G. Carducci, Giuseppe Mazzini, Giambi ed Epodi. 34 Muore sotto falso nome ospite della famiglia Nathan-Rosselli, che a sua volta ci evoca vite sacrificate, stavolta nell’Italia unitaria ma sotto la dittatura fascista. Carlo e Nello Rosselli, colti rampolli dell’agiata famiglia pisana, discepoli prediletti di Gaetano Salvemini, anziché godersi ricchezza e posizione sociale si battono contro la dittatura subendo persecuzione ed esilio, fino ad essere trucidati in Francia dagli estremisti di destra della “Cagoule” su mandato di Galeazzo Ciano nel 1937. Nessuno dei due aveva ancora quarant’anni. Chi sono i campioni dell’utopia risorgimentale? Mazzini lamenta “la presenza perlopiù di aristocratici, intellettuali, ricchi borghesi o ufficiali dell’esercito decisi a costruire, anche dopo la vittoria, una classe privilegiata cui avrebbe dovuto essere affidata la direzione dello Stato”, mentre “tutti gli uomini di una nazione sono chiamati, per la legge di Dio e dell’umanità, ad essere uguali e fratelli” e “l’istituzione repubblicana è la sola che assicuri questo avvenire”. Dunque aristocratici, intellettuali, ricchi borghesi o ufficiali dell’esercito. Anche per immaginare l’“isola che non c’è” occorre istruzione, benessere e fantasia. Il popolo delle città partecipa ad alcuni moti – emblematiche le 5 giornate di Milano –; quello contadino invece non è partecipe dell’utopia: è analfabeta, miserabile, risente di un’arretratezza secolare, ha ben altri problemi che sognare l’unità d’Italia e si limita a sporadiche ribellioni spinto dall’istinto di sopravvivenza. Solo quando Garibaldi, uno dei pochi “uomini del popolo” del Risorgimento, sbarca a Marsala e risale dalla Sicilia verso Napoli con le sue truppe, la gente del sud si illude, si concede la rivolta e l’occupazione delle terre e in qualche caso la vendetta, come a Bronte, dai cui tragici fatti Verga trae la novella Libertà. – A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! –. Innanzi a tutti gli altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. – A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l’anima! – A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! – A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! – A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno! 35 E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! – Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! Proprio un generale in camicia rossa viene a fare giustizia. Alcuni sono fucilati subito, altri sono processati e condannati. Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: – Dove mi conducete? – In galera? – O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la libertà!... Il problema dunque è che esistono due Libertà: quella dei patrioti che si battono per un’Italia unita, sottratta agli stranieri e a sovrani ormai anacronistici, e quella dei poveri per i quali libertà è possedere un pezzo di terra per riscattarsi da fame e servitù. L’errore di molti fu illudersi che l’una avrebbe incluso necessariamente l’altra. Giuseppe Tomasi di Lampedusa cinicamente ipotizza che a muovere alcuni nobili, ricchi borghesi, ufficiali dell’esercito sia l’opportunismo mascherato da utopia. Quando ne Il Gattopardo Tancredi annuncia allo zio che va a combattere contro “Franceschiello Dio Guardi”, il Principe oppone un «Sei pazzo, figlio mio! Andare a metterti con quella gente! Sono tutti mafiosi e imbroglioni. Un Falconeri dev’essere con noi, per il Re». «Per il Re, certo, ma per quale Re?… Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Nel romanzo l’inviato piemontese Chevalley, brav’uomo che in perfetta buona fede crede che «questo stato di cose non durerà; la nostra amministrazione, nuova, agile, moderna cambierà tutto», è sceso da Torino a Donnafugata per invitare un aristocratico di antico casato come il Principe di Salina a entrare in politica, ottenendo peraltro un rifiuto. «Principe, ma è proprio sul serio che lei si rifiuta di fare il possibile per alleviare, per tentare di rimediare allo stato di povertà materiale, di cieca miseria morale nelle quali giace questo che è il suo stesso popolo?» 36 […] Il Principe era depresso: «Tutto questo» pensava «non dovrebbe poter durare; pure durerà, sempre; il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli…; e dopo sarà diverso, ma peggiore. Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra». Se un Tancredi in camicia rossa fa sorridere amaro, stupiscono le vicende dei Panfilo Serafini di tutta Italia, da Silvio Pellico in poi, fino ad arrivare a chi andava a morire sul campo di battaglia come i volontari che combatterono con Garibaldi contro i borbonici nella battaglia del Volturno5. Battaglia in cui “erano state decisive la sorte amica (sic) e le capacità tattiche e strategiche di Garibaldi, sempre presente nei momenti cruciali dei combattimenti, trascinatore ed animatore dei suoi uomini anche nei momenti più critici” – a detta di un’insospettabile Associazione Culturale Neoborbonica on line – e, io aggiungerei, la superiore motivazione dei garibaldini, l’ideale che li teneva insieme, loro, che venivano da tutte le regioni. La nostra storia unitaria è nota. La discrepanza tra utopia e realtà è subito evidente. “Aristocratici, intellettuali, ricchi borghesi e ufficiali dell’esercito” costituiscono il nuovo governo, che inizia i lavori nella maniera più efferata: soldati dell’esercito nazionale annientano, in un crescendo di violenza fratricida, la guerriglia di borbonici irriducibili, ex militari sbandati, contadini delusi e affamati, briganti, che ha il suo culmine nell’applicazione della famigerata legge che porta il nome dell’aquilano Giuseppe Pica votata da tutta la destra storica nel 1863. “Lo stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono d’infamare col marchio di briganti”6. 45 Tra gli altri il sulmonese Giuseppe De Blasiis, comandante della legione del Matese con cui riuscì a entrare a Benevento. 46 Antonio Gramsci, Ordine Nuovo, 1920. 37 Gaetano Salvemini nel saggio Le origini della reazione, pubblicato nel 1898 dopo la strage ordinata da Bava Beccaris stavolta al nord, a danno del popolo milanese in rivolta per il caropane, “mette in evidenza come le forze reazionarie, legate alla monarchia piemontese, abbiano prevalso sulle forze democratiche e popolari – rappresentate da personalità quali Mazzini, Garibaldi, Ferrari e Cattaneo – che lottavano per costruire un assetto politico realmente nuovo. Secondo Salvemini «reazione e rivoluzione, incontratesi nel lavoro dell’unità» hanno lottato fra loro per cinquant’anni allo scopo di «assicurarsi il dominio dello Stato». L’esito ultimo di questa lotta – iniziata quando Carlo Alberto «sentì il bisogno (…) di spargere un po’ d’olio… liberale sulle onde rivoluzionarie» – è stata la sanguinosa reazione del 1898, che Salvemini ha sotto i propri occhi mentre scrive”7. In un dibattito sul Risorgimento apertosi nel 1935 in seno alla rivista Giustizia e Libertà proprio partendo dal tema del saggio di Salvemini, Nicola Chiaromonte afferma: «Gridando “Italia, Italia” si dimentica di abolire il latifondo, di occuparsi della questione sociale, di badare alle garanzie legali di una vera libertà (tribunali indipendenti, poteri di polizia, autonomie provinciali, ecc.) e si finisce col costringere le masse depauperate del popolo italiano a fuggire come “emigrati” dall’“Italia libera”»8. Del resto aveva già scritto Mazzini alla vigilia delle prime elezioni: «Il paese è malcontento, perché ha coscienza d’essere chiamato a vivere d’una nuova vita, chiamato a compire una grande rivoluzione, rivoluzione nazionale e politica, d’unità e di libertà, e si trova diretto da un ministero e da una setta politica che tramano della rivoluzione, che non hanno coscienza né iniziativa 47 Caffi, Calosso, Chiaromonte, Gobetti, Gramsci, Rosselli, Salvemini, Venturi, L’Unità d’Italia – Pro e contro il Risorgimento -, ed. e/o, Alberto Castelli, introduzione, pag. 13. 48 Ibidem, Nicola Chiaromonte, pag. 40. 38 d’unità, che circondano d’ostacoli e di diffidenze la libertà, che intendono a reggere la nuova, ampia, splendida vita della nazione colla formola e colle istituzioni della meschina, angusta, timida vita d’una frazione di quella». E di Cavour: «Cavour, nel fatto, nega l’Italia; egli non conosce che un Piemonte ingrandito, ciò che costituisce nazione, l’anima, la vita vera d’Italia, l’insieme delle tendenze, delle sue aspirazioni, la somma e la verità de’ suoi bisogni, l’istinto della sua missione in Europa, il pensiero collettivo che rende sacro ogni pollice del terreno posto fra l’Alpi e il mare, è arcano a Cavour. Materialista nell’intelletto come nell’intento, ei non varca la questione del territorio. La patria italiana si riduce per lui a un certo numero di leghe quadrate aggiunte alla terra che lo fece ministro.»9 Dunque gli antichi privilegi restano e le terre espropriate tornano a latifondisti e ricchi borghesi con un espediente truffaldino; tra l’altro la necessità di rafforzare l’esercito, diminuire l’analfabetismo (al 75% con punte del 90), costruire strade, omologare lo “scartamento” ferroviario tra i territori dei precedenti stati, ecc., induce il governo a introdurre tasse pesanti e impopolari come quella sul macinato, la cosiddetta tassa progressiva sulla miseria; coi nuovi mezzi di trasporto arrivano granaglie a poco prezzo dalle Americhe, Australia, Russia generando la crisi economica europea degli anni ’70, colpendo in particolare l’Italia che trae sostentamento quasi esclusivamente dalle campagne; i poveri sono più poveri e comincia il grande esodo verso i paesi al di là dell’oceano; la Chiesa avversa l’unità dai pulpiti – ancora nel 1927, due anni prima del Concordato, l’articolista di un giornale clericale si indigna perché … il governo [fascista] della nazione, ormai più che sicuro nelle sue solidissime basi cementate anche dalla divina provvi- 49 G. Mazzini, I doveri degli elettori, Il popolo d’Italia, 29 dicembre 1860. 39 denza, non ha ancora deciso di distruggere tutto ciò che possa ricordare alla mente del popolo buono e calmo per natura il passato caotico e ribelle. Per esempio: che ci fanno in Italia i monumenti di Bruno, Pisacane, Garibaldi, Mazzini, e di tanti altri rivoluzionari scomunicati e ribelli? Perché nelle scuole dello Stato si insegna l’eroismo indiavolato con l’esempio e la venerazione di questi indemoniati?… Le effigi dei cospiratori e dei lottatori rivoluzionari sono stati fin troppo tempo rispettati ingiustamente; è l’ora di distruggerle, e con esse il ricordo funesto che porta alla perdizione dell’anima e del corpo del popolo italiano.10 L’Italia comunque è fatta. L’amor patrio col tempo e l’aiuto di una insistente agiografia si diffonde anche tra i ceti bassi e giunge alla sua massima espressione nella prima guerra mondiale con la mobilitazione effettiva e ideale della nazione contro il nemico. Poi, l’utopia socialista e anarchica della classe operaia nel “biennio rosso” (1919-20), scongiurata da “aristocratici, prelati, ricchi borghesi e ufficiali dell’esercito” con vent’anni di dittatura che termina grazie a un sussulto di dignità da parte degli Italiani: la resistenza. Nella scuola pubblica il popolo dai mille dialetti impara il linguaggio comune. Poi, negli anni sessanta, il decollo, e l’Italia una, democratica e repubblicana siede tra i paesi più ricchi e industrializzati del mondo. Ciononostante oggi, a centocinquanta anni di distanza, abbiamo dimenticato a prezzo di quanti sacrifici sia stata fatta l’unità prima e la democrazia dopo: la questione meridionale non è risolta; il nord considera il sud un freno al suo sviluppo e se ne risente come se all’epoca i meridionali avessero marciato su Torino; i meridionali si riscoprono un mai sopito rancore verso i “conquistatori” settentrionali e sono assai indulgenti verso il “fatiscente” (A. Omodeo) regno borbonico; la malavita cambia pelle e dilaga grazie a connivenze nelle istituzioni e ci chiediamo in nome di quale utopia si siano immolati Falcone e Borsellino; la politica ha un che di mendace e gretto, da pubblicità televisiva; l’inno di Mameli è messo in discussione; i festeggiamenti dell’anniversario, boicottati, sono stati in forse “per 10 Il Martello, La bestia nera si desta, 1927. 40 non perdere una giornata di lavoro” e salvati in extremis dal Presidente della Repubblica. Ci viene il sospetto che una società fondata sul capitale abbia esigenze ristrette, elementari e immediate. Duemila anni di cristianesimo, che comunque la pensiamo ci hanno plasmato alla convinzione del primato della carità, della solidarietà, dell’attenzione all’altro – persona, comunità, popolo – sembrano avere esaurito il loro effetto contro il muro di gomma dell’individualismo più spietato, come del resto aveva preconizzato Pasolini. Processo involutivo a cui non sfugge la Chiesa stessa, afflitta da un’avidità che scarsamente si confà al ruolo. I nuovi “vincenti” per dirla con Fromm non sono, hanno. E chi “non è” non necessita di etica, cultura, utopia. È tempo del vitello d’oro e degli ideali meschini. Il patriota e poeta Alessandro Poerio (1802-1848), napoletano morto a Venezia per le ferite riportate in combattimento nella difesa della città, così scriveva: A che le leggi provvide e ’l frequente senato, e di suffragi gravide l’urne, e ’l pensiero armato, e la parola libera, e la comun Città, se desiderio ed ultimo fine agl’ingegni è l’oro, se qui l’un l’altro compera, se non è più tesoro Coscienza, se mancano Virtudi a Libertà? 11 11 A. Poerio, da All’amico Gabriele Stefani. 41 E. Matania, Giuseppe Mazzini sulla via dell’esilio. 42 G. Induno, Giuseppe Garibaldi a Capua (1861), Milano, Museo del Risorgimento. 43 Senso di Luchino Visconti (1954). Dal loggione del teatro “La Fenice” di Venezia piovono volantini tricolori sugli austriaci in platea durante la rappresentazione del Trovatore. 44 “ARPA D’ OR DEI FATIDICI VATI”: SULLE NOTE DEL RISORGIMENTO. di Sabrina Cardone Il grande movimento ideale dell’Ottocento italiano, che va sotto il nome di Risorgimento, fu seguito, accolto e, qualche volta, preceduto dalla “vetrina sociale” più rappresentativa e popolare dell’epoca: il melodramma. Italianità e melodramma si identificarono in un connubio noto in tutto il mondo; il fenomeno operistico che esaltava la innata musicalità della lingua italiana e con essa era identificato, assunse un ruolo maggiore che in passato grazie al legame allacciato con elementi di cultura nazional – popolare. Già Mazzini, in un saggio del 1836 aveva auspicato il sorgere di una nuova musica, non più salottiera ed aristocratica, ma popolare e che esprimesse con linguaggio immediato e fresco i più nobili sentimenti della nazione e dell’amor patrio; individuando nel coro lo strumento più efficace per attingere ad una fusione ideale degli animi di migliaia di persone e spronarle ad un agire comune. Più di ogni altra forma letteraria o drammatica (poesia, romanzo, teatro) il melodramma, durante il Risorgimento, acquisiva efficacia politica per la sua immediatezza sentimentale, in cui si mescolavano amore e patria, famiglia ed esilio, ribellione e guerra: il motto Viva V.E.R.D.I. (cioè Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia) è sintomatico dell’enorme influenza e funzione propagandistica del genere nei momenti cruciali del Risorgimento italiano. Accantonati argomenti mitologici, arcadici e classici, i libretti d’opera proponevano trame intessute di elementi storici e politici, in cui le immagini di popoli oppressi e riscosse nazionali velavano (ma non troppo) il riferimento alla condizione italiana, coinvolgendo con acceso pathos il pubblico. Il magico potere della musica, capace di commuovere ed incitare all’azione le masse popolari, era però ben noto anche ai regimi conservatori che per questo la temevano. 45 Se i teatri lirici erano lo specchio della società ottocentesca, dalla nobiltà alla borghesia grande e media, al basso ceto (che riempiva i teatri di provincia o quelli ove si rappresentavano opere buffe e farse), si può ben capire quale enorme valore riponessero nella censura coloro che erano preposti alla sorveglianza nel tentativo di tenere a freno le manifestazioni che, in ogni momento del processo risorgimentale, spontaneamente si verificavano durante le rappresentazioni operistiche. Manifestazioni che non furono soltanto appannaggio delle opere di Verdi (apostolo musicale del Risorgimento), ma che interessarono anche opere degli autori maggiori e minori dell’Ottocento italiano. I primi impigli politici in cui incorre il melodramma forse sono contenuti nell’innocua Italiana in Algeri di Rossini (1813), laddove l’aria di Isabella («Pensa alla patria, e intrepido | il tuo dover adempi: | vedi per tutta Italia | rinascere gli esempi | d’ardir e di valor») era fin troppo esplicita per la censura napoletana che sovrintendeva alle rappresentazioni del Teatro de’ Fiorentini dove fu portata in scena nel 1815. Cinque anni dopo fu il giovane Bellini ad essere coinvolto in un episodio “patriottico”, avendo aderito, nel 1820, alla Carboneria. L’entusiasmo durò pochi mesi: quando il 15 maggio 1821 re Ferdinando rioccupò il trono, il furore patriottico svanì nel nulla. L’episodio è raccontato da Francesco Florimo, amico di Bellini e custode della sua memoria: «Ed in quel tempo [1820], spinti un po’ dagli amici e un po’ per seguire la corrente, ci siamo iscritti alla setta così detta dei Carbonari. Ma l’entusiasmo del momento doveva terminare coll’entrata delle truppe tedesche nel marzo del 1821. Si ritornò all’antico ordine di cose, ed addio libertà, addio costituzione: la reazione si mostrò da per tutto e per tutto». La platea del teatro alla Scala di Milano fu divisa in due parti: nelle prime file prendeva posto la milizia austriaca, ai normali spettatori era riservato il fondo sala; nonostante ciò non mancavano tafferugli. Quando nel 1859 fu cantato il coro “Guerra guerra” dalla “Norma” di Bellini il pubblico italiano si alzò in piedi applaudendo freneticamente mentre i soldati austriaci urlavano contro gli italiani, tanto che nelle successive rappresentazioni il coro venne proibito. Uguale entusiasmo suscitava il coro che conclude il secondo atto dei Puritani, altra opera del Bellini, “Suoni la tromba e intrepido io pugnerò da forte”, risve- 46 gliando fino al parossismo il generale furore patriottico nazionale. Cristina di Belgioioso, coi suoi deliri rivoluzionari d’élite, pensò di invitare i musicisti che frequentavano il suo salotto a comporre alcune variazioni sul tema: aderirono di buon grado Liszt, Thalberg, Herz, Czerny, Chopin, che misero insieme una composizione dal titolo Hexaméron. In alcuni casi i musicisti avevano vita difficile, come Piero Maroncelli, musicista di talento e di sicuro avvenire, se non fosse stato per quel suo “vezzo” d’essere un carbonaro, la cui carriera fu stroncata dal carcere duro, dal conseguente esilio in America e da un’esistenza di stenti come maestro di canto e d’italiano. Il Maroncelli ci riferisce di sue conversazioni, in casa degli Antonii, con il più celebre musicista ed operista Gaetano Donizetti (insieme con Rossini, Bellini e Verdi, emblemi del melodramma risorgimentale). Non è chiaro se le conversazioni riguardassero tematiche musicali o politiche, di certo Donizetti rimase fondamentalmente indifferente alle istanze risorgimentali, nonostante che in Italia esista una tradizione orale secondo cui il compositore bergamasco avrebbe partecipato ad attività politiche. Da Roma, quando Gregorio XVI fece reprimere a fucilate i moti degli affiliati alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini, scriveva al padre: «Io sono uomo che di poche cose s’inquieta, anzi di una sola, cioè se l’opera mia va male. Del resto non mi curo». Ma al di là degli interessi diretti o della intenzionalità dei messaggi politici o di incitazione alla ribellione contro lo straniero, era il pubblico ad assumere frasi ed immagini del melodramma come una espressione di indipendenza dalla cultura degli Stati dominatori, appropriandosene come di un simbolico patrimonio comune del popolo italiano. Un esempio: nel 1831, a Modena, la congiura scoperta in casa di Ciro Menotti, la sera del 3 febbraio, fa sospendere le rappresentazioni degli Esiliati in Siberia di Donizetti: una marcia dell’opera è diventata l’inno dei rivoltosi. Nonostante l’apparente carenza di sensibilità politica del musicista bergamasco, una personalità impegnata come quella di Mazzini avrebbe di lì a qualche anno tentato di piegare a fini politici la musica donizettiana. In uno scritto del 1836 (Filosofia della musi- 47 ca) Mazzini scrive: «Forse v’è più che presentimento e speranza lontana, forse, – se a ricostituire la musica non si richiedesse che genio, e non costanza sovrumana ed energia per combattere disperatamente contro i pregiudizi, e la tirannide de’ direttori venali, e la turba de’ maestri, e il gelo de’ tempi – anche tra’ viventi avremmo chi potrebbe, volendo, levarsi all’officio di fondatore della scuola musicale Italoeuropea, e porsi a rigeneratore, dov’oggi non è che primo tra quanti militano sotto le bandiere della scuola Rossiniana Italiana. Parlo di Donizetti, l’unico il cui ingegno altamente progressivo riveli tendenze rigeneratrici, l’unico ch’io mi sappia, sul quale possa in oggi riposare con un po’ di fiducia l’animo stanco e nauseato del volgo d’imitatori servili che brulicano in questa nostra Italia». Nella febbrile atmosfera dei giorni che precedettero le insurrezioni del 1848, durante una rappresentazione della Gemma di Vergy a Palermo, mentre il tenore che impersonava Tamas cantava «Mi togliesti e core e mente, | Patria, Numi e libertà», questa fatidica parola scatenò i sentimenti risorgimentali del pubblico, che eruppe in grida patriottiche, costringendo la primadonna della serata, Teresa Parodi, ad apparire in scena col tricolore. Nonostante l’indifferenza di Donizetti verso le istanze risorgimentali, c’è da sottolineare il fatto che a Parigi il compositore ebbe contatti con Giovanni Ruffini, mazziniano, esule genovese, il quale scrisse il libretto per il Don Pasquale (1843) e alcuni rimaneggiamenti e la traduzione in italiano del libretto per il Dom Sébastien (1843). A Parigi Donizetti aveva quale agente e amico Michele Accursi, spia dello Stato Pontificio sotto le mentite spoglie dell’esule mazziniano. Mazzini, a sua volta, seppe utilizzare la popolarità e la fama di “conformista” acquisita dal bergamasco (soprattutto dopo che il compositore divenne “maestro di cappella dell’imperatore d’Austria”) quando adottò il suo recapito postale parigino come indirizzo delle missive segrete della Giovine Italia. Approfittando della familiarità tra Donizetti, i fratelli Ruffini e Michele Accursi, i cospiratori mazziniani potevano inoltrare i loro messaggi a Parigi, inviandoli all’indirizzo del celeberrimo compositore. Diversa la storia dell’inno nazionale italiano e del compositore della musica. 48 Michele Novaro (1822-1885), genovese, ebbe breve carriera di cantante, ma fu didatta e compositore di melodrammi. In gioventù cantò in due opere di Donizetti: nella Linda di Chamounix (1842) e nella Maria di Rohan (1843); in seguito condusse una apprezzabile carriera di secondo tenore al regio di Torino. Ai giorni nostri è famoso per aver composto la musica dell’inno patriottico Canto degli italiani (1847), con i versi di Goffredo Mameli, meglio conosciuto come Fratelli d’Italia. Inno nazionale “provvisorio” (dal 1946 al 2006) della Repubblica italiana (spesso fu proposto di sostituirlo con il Va pensiero verdiano), ora riconosciuto per decreto definitivamente come nostro inno. Secondo la leggenda, una sera di settembre del 1847, durante una riunione tra patrioti e appassionati di musica a Torino, il pittore genovese Ulisse Borzino portò a Novaro la bozza del Canto degli Italiani che gli mandava Mameli. Il musicista improvvisò subito una marcia; durante la notte perfezionò l’unica sua opera che lo renderà famoso ai posteri. In quello stesso periodo Mameli fu il destinatario d’un breve carteggio con Mazzini, il quale chiedeva al poeta, in una lettera del 6 giugno 1848 (allegando una nota di Verdi), un inno patriottico che poi il maestro avrebbe musicato. Il testo fu scritto e l’inno musicato: ebbe il nome di Suona la tromba. Verdi lo mandò al grande patriota italiano accompagnandolo con queste parole: «Ho cercato d’essere più popolare e facile che mi sia stato possibile. Fatene quell’uso che credete: abbruciatelo anche se lo credete degno […] Possa quest’inno, fra la musica del cannone, essere presto cantato nelle pianure lombarde. Ricevete un cordiale saluto di chi ha per voi tutta la venerazione». In quello stesso periodo Verdi, da Parigi, prendeva i primi contatti con il librettista Salvatore Cammarano, da sempre sostenitore di aspirazioni patriottiche, a Napoli, per un’opera che rispecchiasse l’«epoca più gloriosa della storia italiana, quella della Lega Lombarda». Dopo vari tentativi con la censura napoletana, i due convennero per un lavoro passato alla storia come La battaglia di Legnano, opera, 49 dal contenuto sovversivo, rappresentata durante la Repubblica romana, la sera del 27 gennaio 1849, qualche giorno avanti la proclamazione dell’effimera repubblica. Verdi, che curò personalmente l’allestimento della prima, ebbe un successo travolgente, tanto che il compositore fu investito di una onorificenza repubblicana. Questo fatto, però, nocque alla fama dell’opera che fu sottoposta al cambiamento del titolo, dell’ambientazione e dei personaggi. Ma Verdi era uomo di musica e non d’armi; stando a Parigi si era illuso di poter comporre e portare avanti opere sovversive. La sua opera continuava, dal Nabucco (con il celebre coro Va pensiero) all’ Ernani, alla Battaglia di Legnano, ai Lombardi alla prima crociata (coro Viva l’Italia! Un sacro patto e O Signor che dal tetto natio) ai Vespri siciliani, al Macbeth (con il coro, forse non da tutti conosciuto, Patria oppressa) a raccogliere consensi e a coinvolgere i patrioti che trovavano nella sua cifra melodica e nella sua robusta orchestrazione ispirazione e monito per le loro lotte. Durante le cinque giornate di Milano, un osservatore straniero, J. Alexander von Hübner, così scriveva: «In mezzo a questo caos di barricate si pigiava una folla variopinta. Preti molti col cappello a larghe tese, fregiato di coccarda tricolore, signori in giustacuore di velluto… borghesi portanti il cappello alla Calabrese o in onore di Verdi il cappello all’Ernani». Nel frattempo Verdi scriveva al librettista Piave, arruolato a Venezia nella Guardia Nazionale, una lettera dalle eccitate ed esplicite affermazioni: «… Sì, sì, ancora pochi anni forse pochi mesi e l’Italia sarà libera, una, repubblicana. Cosa dovrebbe essere? Tu mi parli di musica!! Cosa ti passa in corpo?... Tu credi che io voglia ora occuparmi di note, di suoni?... Non c’è né ci deve essere che una musica grata alle orecchie delli Italiani nel 1848. La musica del cannone!...». Il film Senso, per la regia di Luchino Visconti (1954), nel quale si narra una storia d’amore ambientata nell’Ottocento risorgimentale, si 50 apre in un teatro d’opera ove è rappresentato Il trovatore di Verdi (1853) con una coinvolgente dimostrazione patriottica proprio durante la famosa cabaletta Di quella pira. Ma già da tempo le tematiche storiche erano state abbandonate dallo stesso Verdi e con l’unità d’Italia ben altri saranno i risultati dei proponimenti dei tanti che credettero nel Risorgimento. Sconfitti i sostenitori della causa rivoluzionaria, Verdi fu tra i sostenitori della causa monarchica: «L’onore che i miei concittadini vollero conferirmi nominandomi loro rappresentante all’Assemblea delle Provincie parmensi mi lusinga, e mi rende gratissimo. Se i miei scarsi talenti, i miei studi, l’arte che professo mi rendono poco atto a questa sorta d’uffizi, valga almeno il grande amore che ho portato e porto a questa nobile ed infelice Italia. Inutile il dire che io proclamerò in nome dei miei concittadini e mio: la caduta della Dinastia Borbonica; l’annessione al Piemonte; la Dittatura dell’illustre italiano Luigi Carlo Farini. Nell’annessione al Piemonte sta la futura grandezza e rigenerazione della patria comune. Chi sente scorrere nelle proprie vene sangue italiano deve volerla fortemente, costantemente; così sorgerà anche per noi il giorno in cui potrem dire di appartenere ad una grande e nobile nazione» (lettera dell’8 settembre 1859 indirizzata dal musicista al podestà di Busseto). Una curiosità: Verdi celebrò i tre colori della bandiera italiana con uno stornello, Il Brigidino, su parole di Francesco Dall’Ongaro. 51 LE PAROLE IN MUSICA DEL RISORGIMENTO MUSICALE Di seguito un breve assaggio dei testi patriottici di alcuni cori tratti dai melodrammi citati. Va pensiero (Giuseppe Verdi, Nabucco) Va pensiero sull’ali dorate, va, ti posa sui clivi, sui colli, ove olezzano tiepide e molli, l’aure dolci del suolo natal. Del Giordano le rive saluta, di Sionne le torri atterrate. Oh, mia patria, sì bella e perduta, oh membranza sì cara e fatal! Arpa d’or dei fatidici vati, perchè muta dal salice pendi? Le memorie nel petto riaccendi ci favella del tempo che fu! O simile di Solima ai fati, traggi un suono di crudo lamento: oh t’ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù. 52 Patria oppressa (Giuseppe Verdi, Macbeth) Patria oppressa! Patria oppressa! Il dolce nome no, di madre aver non puoi, or che tutta à figli tuoi sei conversa in un avel! D’orfanelli e di piangenti chi lo sposo e chi la prole al venir del nuovo sole s’alza un grido e fere il ciel. A quel grido il ciel risponde quasi voglia impietosito propagar per l’infinito, Patria oppressa, il tuo dolor! Suona a morto ognor la squilla, ma nessuno audace è tanto che pur doni un vano pianto a chi soffre ed a chi muor! Nessun dona un vano pianto a chi soffre ed a chi muor! Partia oppressa! Patria mia! Oh Patria! 53 Dal tuo stellato soglio (Gioacchino Rossini, Mosè in Egitto) Dal tuo stellato soglio, Signor, ti volgi a noi; pietà de’ figli tuoi, del popol tuo pietà. Pietà de’ figli tuoi, del popol tuo pietà, Se pronti al tuo potere son elementi e sfere, tu amico scampo addita al dubbio errante piè. Pietoso Dio, ne aita: noi non viviam che in te In questo cor dolente deh! scendi, oh Dio clemente: e farmaco soave gli sia di pace almen. Il nostro cor che pena, Deh! tu conforta almen. Ma se pigra l’Italia dormisse, se ponesse nell’opra ritardo… Qui la voce dell’esule bardo nel sospiro gemendo spirò 54 CANZONI DEL RISORGIMENTO. L’ISPIRAZIONE POPOLARE. Addio mia bella addio (Carlo Bosi, 1848) Musica di autore ignoto, versi di C. A. Bosi, la canzone si diffuse durante il Risorgimento e divenne molto popolare nel 1848. La patria viene a identificarsi con la moglie/fidanzata ed è l’amor di patria a fornire la motivazione principale. In seguito divenne uno dei canti più diffusi in tutte le guerre. La canzone è anche conosciuta come “Addio del volontario toscano“ o “La partenza del soldato”. Probabilmente fu la canzone più cantata nel corso delle guerre risorgimentali tra il 1848 e il 1870. Addio, mia bella, addio: l’armata se ne va; se non partissi anch’io sarebbe una viltà! Non pianger, mio tesoro: forse ritornerò; ma se in battaglia io moro in ciel ti rivedrò. La spada, le pistole, lo schioppo li ho con me: all’apparir del sole mi partirò da te! Il sacco preparato sull’òmero mi sta; son uomo e son soldato: viva la libertà! Non è fraterna guerra la guerra ch’io farò; dall’italiana terra lo straniero caccerò. 55 L’antica tirannia grava l’Italia ancor: io vado in Lombardia incontro all’oppressor. Saran tremende l’ire, grande il morir sarà! Si muora: è un bel morire morir per la libertà. Tra quanti moriranno forse ancor io morrò: non ti pigliare affanno, da vile non cadrò. Se più del tuo diletto tu non udrai parlar, perito di moschetto per lui non sospirar. Io non ti lascio sola, ti resta un figlio ancor: nel figlio ti consola, nel figlio dell’amor!’ Squilla la tromba...Addio... L’armata se ne va... Un bacio al figlio mio! Viva la libertà! 56 57 LA BELLA GIGOGIN (1858) Fu suonata per la prima volta il 31 dicembre del 1858, al teatro Carcano di Milano, alla vigilia della seconda guerra di indipendenza del 1859 che segnerà la riunificazione dell’Italia. Non vi sono dati certi riguardo a questo canto che risulta composto dalla mescolanza di strofe derivanti da vari canti popolari e tradotta in musica, una polka, dal maestro Paolo Giorza nel 1858. La tradizione orale tramanda che la canzone venne suonata per la prima volta la sera di San Silvestro, il 31 dicembre del 1858, al teatro Carcano di Milano alla vigilia della II guerra di indipendenza. Quando la Banda Civica, diretta dal maestro Gustavo Rossari, cominciò a suonare la bella Gigogin, il pubblico reagì con entusiasmo al punto che la banda dovette riperterla per 8 volte. Vi sarebbe infatti un significato allegorico che non sarebbe sfuggito ai milanesi. La bella è malata (l’Italia? La Lombardia?), bisogna aspettare ancora e lasciare che si mariti, cioè che avvenga l’alleanza tra Vittorio Emanuele II e Napoleone III, per poter marciare contro gli austriaci (daghela avanti un passo). Si narra che la notte di quel capodanno venne cantata, suonata e applaudita continuamente, anche davanti al palazzo del vicerè austriaco, come una sfida. La Ricordi pubblicò la canzone ma il governo austriaco ne sequestrò le copie. Secondo altre testimonianze la stessa canzone venne cantata alla battaglia di Magenta (04/06/1859) in cui le truppe francesi sconfissero quelle austriache guidate da Giulaj. La Gigogin divenne in breve il canto patriottico più popolare e cantato in ogni occasione, dalle spedizioni di Garibaldi ai moti del 1859 in centro Italia. La leggenda intessuta attorno a questo canto ne racconta l’origine a partire dal 1848, durante le 5 giornate di Milano, e narra di una mitica figura di ragazzina. Era il 22 marzo del ‘48 e a Milano, da sotto le barricate a Porta Tosa, esce una bellissima ragazzina tremante per il freddo. E’ vestita con giubbotto, stivaloni e una larga gonna. A chi le chiede il nome risponde Gigogin (diminutivo piemontese di Teresina, Gigogin fra i cospiratori voleva dire anche ITALIA). Fuggita dal collegio e salita sulle barricate, 59 riesce ad arruolarsi fra i volontari lombardi. Un giorno Manara le affida un messaggio urgente per La Marmora, il colonnello dei Bersaglieri. La sua felicità poi aumenta quando riesce ad ottenere un incarico ufficiale, vivandiera o cantiniera (addetta allo spaccio). Conosce Mameli e fra i due scoppia un amore intenso, epico. Va in prima linea, a Goito soccorre e rifocilla le truppe. La sua fama esce dal battaglione dei lombardi di Manara e raggiunge i paesini più piccoli della pianura. Il suo coraggio la spinge dopo la prima sconfitta a percorrere le terre rioccupate, a cantare un ritornello “Daghela avanti un passo” (fate un passo a est verso l’oppressore). Il suo amore per Mameli non è solo sentimento: lo salva dalla polizia austriaca che lo pedina, inscenando in strada un happening di improperi rivolti all’imperatore Ferdinando II (Francesco Giuseppe era solo erede, la sua corona arriverà a fine anno). Il ritorno in collegio è inevitabile. Fugge di nuovo, ma tutti gli uomini del ‘48 sono a Roma con Garibaldi e stanno morendo sugli spalti della Repubblica. Il suo triste domani di fanciulla non le appartiene più. E la bella Gigogin col tremille-lerillellera La va a spass col so spingin Col tremille-relillellà. Di quindici anni facevo all’amore Daghela avanti un passo Delizia del mio cuore. A sedici anni ho preso marito Daghela avanti un passo Delizia del mio cuore. A diciassette mi sono spartita Daghela avanti un passo Delizia del mio cuor. 60 La ven, la ven, la ven a la finestra L’è tutta, l’è tutta, l’è tutta insipriada La dis, la dis, la dis che l’è malada Per non, per non, per non mangiar polenta Bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza Lassala, lassala, lassala maridà. Le baciai, le baciai il bel visetto Cium, cium, cium La mi disse, la mi disse oh che diletto ! Cium, cium, cium La più in basso, la più in basso c’è un boschetto Cium, cium, cium La ci andremo, la ci andremo a riposar. Ta-ra-ta-ta-ta-tam. Sabrina Cardone 61 T. Patini, Autoritratto in divisa di sergente della Guardia Nazionale Mobile, Castel di Sangro, collezione privata. “L’ITALIA CHIAMÒ”. PITTORI GARIBALDINI. di Cosimo Savastano “A vent’anni tutto si amava e soprattutto la patria, l’Italia. Inconsapevoli, si era cospiratori”, scrisse, nel suo diario, Giovanni Fattori (Livorno, 1825-1908), che dedicò parecchie fra le sue più significative pagine pittoriche alla partecipazione di soldati e volontari alle guerre d’Indipendenza, forse più che all’epopea garibaldina, rievocando ove qualche fase dei combattimenti e ove le attività dei cavalleggeri in marcia, in avanscoperta, in perlustrazione o in sosta, nella distensione del breve riposo o nella tensione delle attese, e ove richiamando la quotidiana realtà degli accampamenti, che aveva avuto modo di osservare nei suoi luoghi o nei territori da lui frequentati. “Un solo pensiero, un solo desiderio ci univa” nel dipanarsi di quegli anni fervidi di idealità, contrassegnati dalle convinte adesioni e dalla partecipazione attiva, generosa soprattutto da parte dei giovani, fra i quali non furono pochi i pittori o aspiranti pittori in qualche caso dotati di un patrimonio intellettuale tanto poco frequente fra gli artisti quanto idoneo a caratterizzarne e differenziarne la personalità rispetto ai loro colleghi. Erano quasi sempre del tutto ignari dell’arte della guerra, ma non per questo inclini a esitazioni e timori. A renderli impavidi, fino a distinguersi e a eccellere fra i più decisi e i più animosi, era quella forza interiore, che scaturiva dall’ardore delle convinzioni fondate sulle ineludibili certezze e sulla urgente necessità, avvertita come precipuo e prioritario dovere, di contribuire alla unificazione dell’Italia e al riscatto dalle umiliazioni che le erano state inferte dalle prepotenze straniere. Alcuni fra loro rappresentarono in schizzi, disegni e dipinti fasi dei combattimenti, il rude affanno delle marce, la sofferenza dei feriti, la faticosa durezza dei giorni antecedenti o successivi agli scontri con il nemico, reporters ante litteram nei campi di battaglia o negli attendamenti, dei quali, mostrandone gli aspetti umani e militari insieme, non raramente seppero cogliere il senso più autentico. 63 “L’arte è sempre […] amica di libertà”. Con l’arte “anzi si prepara la libertà, come si conquista con la rivoluzione”1, dichiarava Teofilo Patini (Castel di Sangro, 1840 - Napoli, 1906) ancora negli anni più tardi; e l’espressione si rivela particolarmente idonea non solo a favorire la comprensione delle finalità che si propose come pittore, attraverso la progressiva maturazione e formulazione della sua peculiare poetica sempre decisamente impegnata e propensa a misurarsi con la realtà più viva e palpitante del suo tempo, quanto pure, e forse soprattutto idonea a dar conto dei suoi convincimenti di pensatore colto, approfonditi e modellati nel tempo partendo dall’esempio vivo del padre, antiborbonico e intrepido propugnatore delle idealità risorgimentali, e dietro l’influenza degli insegnamenti ricevuti da Leopoldo Dorrucci, sacerdote e raffinato latinista, e da Panfilo Serafini, studioso e saggista perseguitato ed infine incarcerato a vita per le idee antiteocratiche e libertarie professate apertamente negli “scritti sediziosi”. Sicché, la guida e le indicazioni amorevoli dei maestri sulmonesi, ai quali il genitore tenne ad affidarlo, equivalsero alle tenaci radici da cui partì per indirizzare il suo pensiero verso l’approdo delle speculazioni artistico – filosofiche che scandagliò e in cui si addentrò pure attraverso gli illustri confronti con Bertrando Spaventa e Salvatore Tommasi. Siffatte ascendenze valsero a indirizzarne le propensioni patriottiche, umanitarie e sociali fin dalle iniziali scelte d’arte e di vita, tant’è che a vent’anni, subito dopo avere affrontato le prime opere nel precipuo intento «di mettere in rilievo e brutalmente la giustizia sommaria, il macello che un popolo oppresso fa del suo oppressore», Patini fu fra quei giovani che ritennero indispensabile abbandonare colori e pennelli per imbracciare il fucile e indossare la camicia rossa di Garibaldi. Per la sua militanza scelse di arruolarsi fra i Cacciatori del Gran Sasso, il corpo di volontari voluto e affidato dal mitico Generale al comando del suo amico teramano Antonio Tripoti con la precisa consegna di espugnare la fortezza di Civitella del Tronto, posta a baluardo dei 01 È una delle espressioni raccolte dalla viva voce del Maestro che vennero riportate nel profilo dedicato a Teofilo Patini, in «L’esposizione di Aquila», N° 14-15, Aquila, 20 settembre 1888. Elaborato nell’ambito del gruppo di intellettuali aquilani in cui Patini era ben noto e familiare, l’articolo, che non porta indicazione dell’autore, è quasi certamente costruito su notizie fornite direttamente dal pittore. 64 confini settentrionali del Reame, e quindi lo strategico Forte di Pescara per poi avanzare, fiaccando progressivamente le strategiche posizioni nemiche e soffocando le numerose sacche di resistenza filoborbonica particolarmente agguerrite soprattutto in Abruzzo e di qui muovere, continuando a battersi, verso il Meridione della Penisola mentre egli la risaliva alla testa dei Cacciatori delle Alpi, noti come i Mille, in modo da attuare una gigantesca manovra a tenaglia. E fu nel corso di tale avanzata che il giovane Patini, inviato in avanscoperta verso Castel di Sangro nel cuor della notte del 2 ottobre 1860, toccò con mano la violenza e la furia sanguinaria della folla esaltata, giacché, inseguito dagli “imbaldanziti villani” incitati e eccitati dagli emissari borbonici, sarebbe stato sicuramente trucidato se Margiosso, il marito della sua nutrice, benché di fede borbonica, non lo avesse fatto sdraiare sul basto del mulo e sulle bigonce, che era andato a riempire di letame nella stalla in cui lo sapeva nascosto, e di qui, ricopertolo di sacchi e stracci, non lo avesse portato fino all’aperta campagna. Fu un debito di riconoscenza che Patini saldò tre anni dopo, quando, nuovamente volontario con il grado di sergente fra le fila della Guardia Nazionale Mobile, appena costituita da Giovanni Pica per la repressione del brigantaggio, riuscì a sottrarre quell’uomo e altri contadini di fede borbonica dalla ingiusta accusa di brigantaggio, in quegli anni duramente punita con la pena capitale, avvalendosi anche della considerazione guadagnata per l’intrepido impegno dimostrato, fino a essere gravemente ferito ad una mano, nel corso delle insidiose e spesso sanguinose operazioni di quella campagna. Era stato grazie a Margiosso, del resto, se al sorgere dell’alba di quel 3 ottobre aveva potuto ricongiungersi ai Cacciatori del Gran Sasso, i quali, sulla base del suo rapporto, riuscirono a sedare entro le successive 24 ore i tumulti di quelle torme scalmanate in Castel di Sangro, donde il mattino seguente furono pronti a dirigersi verso la Marsica per spegnervi gli agguerriti focolai di reazione. A dar loro man forte, sopraggiungeva intanto, ma ormai tardivamente, il nutrito drappello dei volontari molisani guidato dal campobassano don Nicola De Luca, che, perciò, ritornò sui suoi passi onde ricongiungersi al più presto con gli altri conterranei impegnati ad affrontare la difficile situazione creata dalle masse filoborboniche nel circondario di Isernia, in scontri che si protrassero anche dopo l’arrivo dei garibaldini entrati a Napoli il 7 settembre 1860. I realisti, alla cui testa si 65 G. Toma, Luisa Sanfelice in carcere, 1874, Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte. 66 erano posti il contadino Domenico Di Ciurcio e il calzolaio Senape, tennero lungamente in scacco le forze liberali ricorrendo spesso alle insidie di imprevedibili e feroci agguati che, il 17 di quello stesso mese, determinarono una delle stragi più crudeli a Pettoranello d’Isernia2. Fra i pochi che riuscirono miracolosamente a sfuggire alla furia omicida di quella giornata fu Gioacchino Toma (Galatina, Lecce, 1836 – Napoli 1891), l’altro giovane pittore di formazione napoletana di quattro anni maggiore dell’amico Teofilo Patini, divenuto ufficiale nell’esercito garibaldino. Inseguito e braccato, però, la sua breve e affannosa fuga si concluse a Isernia, dove, fino a quando i liberali riuscirono ad aver ragione delle schiere nemiche, rimase a languire, dimenticato dai suoi carcerieri nei bui recessi del vetusto sotterraneo, adibito a prigione, in cui lo avevano rinchiuso e incatenato accanto all’agonizzante bersagliere dal cranio spaccato, più tardi rammentato in un suo quadro. Era uno dei tanti vani che si aprivano nel labirinto formato dalle spesse muraglie profondamente interrate, che costituivano le solide fondamenta di un seicentesco palazzo nobiliare, i cui ruderi restano ancora ad affiorare appena discosti da Santa Maria delle Monache, l’antico convento di clausura femminile oggi trasformato nell’importante museo archeologico di cui la Città va giustamente orgogliosa. Anche perché di umili natali, orfano e solo fin dai sei anni, cresciuto nel Convento dei Cappuccini del suo paese e quindi nell’Ospizio dei Poveri della vicina Giovinazzo, le inclinazioni patriottiche del Toma non affondavano le radici in esempi di qualche pregio che non poté ricevere né in famiglia né da particolari maestri. Gli accadde, invece, che nel 1857, due anni dopo essere giunto a Napoli dove visse collaborando con il pittore ornamentalista Antonio Fergola, venne “erroneamente coinvolto in una retata” e, ritenuto cospiratore, fu arrestato e condannato ad oltre un anno di confino a Piedimonte d’Alife. Qui, alcuni esponenti dell’aristocrazia, divenuti suoi amici e committenti, lo influenzarono a tal punto con le loro idee liberali che il giovane pittore anche dopo essere ritornato nella Capitale del Reame, dove cominciò a frequentare l’Accademia di Belle Arti grazie al generoso soste- 02 Cfr. per tutti C. Savastano, Patini, momenti d’arte e di vita, Teramo 1991, pp. 13 – 14. 67 gno del duca Laurenzana, finì con il sentire sempre più vive le inclinazioni patriottiche e con il maturare le precipue convinzioni da cui fu indotto a prendere parte attiva al movimento ed alle operazioni garibaldine del 18603. La schiera abbastanza nutrita dei pittori di formazione napoletana che aderirono entusiasticamente ai moti ed alle lotte per l’unità d’Italia comprende nomi di indiscutibile rilievo, a principiare da Filippo Palizzi (Vasto, 1818 – Napoli, 1899), il cui apporto fu di natura esclusivamente pittorica. Sotto la spinta delle sue “profonde convinzioni morali e civili”, evocò i principali eventi napoletani del ‘48 in “due quadri di piccole dimensioni, […] che costituiscono una testimonianza poetica e morale tra le più alte e commosse di tutta la pittura «impegnata» dell’ottocento”. Nel primo, denominato, con annotazione di suo pugno, La sera del dì 11 febbraio 1848 – Napoli, rappresentò “l’imbocco dell’antica strada di Toledo col popolo che festeggia la Costituzione concessa da Ferdinando II” in tutta “la gioia incontenibile che dà la libertà conquistata” da lui “espressa con diretta emozione” attraverso “una pittura indimenticabile per la bellezza della colorazione” e “che davvero ricorda certi impressionisti (Renoir, ad esempio) e anche il celebre «14 luglio» che sessantanni dopo avrebbe dipinto Marquet. L’altro quadro, intitolato «15 maggio a Napoli» rappresenta invece un momento della lotta del popolo in difesa della Costituzione, tradita dal Borbone e dal Parlamento. La scena è ambientata nello stesso luogo, quasi a sottolineare il netto contrasto fra gli opposti momenti dello stesso evento storico”4. 03 Cfr.. G.Toma, Ricordi di un orfano, a cura di Aldo Vallone, M. Congedo Ed., Galatina 1973, pp. 76-88. 04 Oltre a questi due soggetti, che furono “dipinti con un amore e una commozione che traboccano da ogni pennellata, da ogni particolare del racconto fedele e modesto di quelle memorabili giornate”, oltre ad almeno uno studio sulla condanna a morte di un brigante e a qualche rara pagina dedicata ai garibaldini entrati a Napoli, il Palizzi affrontò solamente altri tre quadri di soggetto storico evocanti episodi delle guerre d’Indipendenza, Il Principe Amedeo alla carica della Cavalchina, Il Principe Amedeo ferito e La carica dei cavalleggeri Alessandria, che rappresentarono per lui “un modo di smontare sia la retorica che la genericità celebrativa, contribuendo così alla conoscenza del complesso dei fatti umani, culturali e di costume che gli eventi storici contengono”. Vd. P. Ricci, I fratelli Palizzi, Bramante Ed., Milano 1960, pp. 41 – 42 e 58. 68 Attiva fu, invece, la partecipazione di Domenico Morelli (Napoli, 1826 – 1901), che, per motivi di studio, nel 1848 si trovava a Roma, ove prese parte ai moti rivoluzionari, nel corso dei quali venne catturato e imprigionato per un breve periodo. Benché non visse altre esperienze di questo genere, di rilievo fu il suo impegno politico specie a seguito della nomina a Senatore del Regno d’Italia conferitagli nel 1886, durante la XVI Legislatura, da re Umberto I. Pure Gonsalvo Carelli (Napoli, 1830 – Londra, 1900) era lontano dall’amata città natale durante gli eventi descritti dal Palizzi. Esponente di spicco della famiglia di apprezzati pittori a cui apparteneva, aveva appena compiuto i 18 anni, quando, nel 1848, scoppiarono gli animosi combattimenti contro le truppe austriache delle gloriose cinque giornate di Milano, alle quali non esitò a prendere parte distinguendosi fra le barricate. Fu durante quel soggiorno lombardo che conobbe Massimo D’Azeglio. Con la progressiva maturazione ed evoluzione della esperienza pittorica crebbero e si rafforzarono anche i suoi entusiasmi patriottici. Per cui fu quasi naturale per lui indossare di nuovo la camicia rossa con la quale, nel 1860, partecipò alla battaglia del Volturno. Trovandosi, invece, a Napoli durante quel 1848, Francesco Saverio Altamura (Foggia, 1822 – Napoli, 1897) prese parte ai moti antiborbonici con tale entusiasmo e tanto attivamente da venire imprigionato nelle carceri di S. Maria Apparente, dove ebbe occasione di conoscere uomini illustri come il Poerio, il D’Ayala, il Settembrini e l’Imbriani. “Le sue disavventure politiche, iniziate con il quadro La morte di un crociato (Foggia, Museo civico) lo costrinsero alla fuga, prima all’Aquila, poi – tramite un salvacondotto del conte D’Ayala – a Firenze, dove giunse nel 1850”. Il suo ardore per le idealità libertarie e l’adesione alle attività finalizzate al processo unitario trovarono una ulteriore conferma nella decisione di rientrare nuovamente a Napoli nel 1861 allo scopo di “assumervi la carica di Consigliere Comunale durante il Governo di Garibaldi”. Fu solo sei anni dopo però, nel 1867, che tornò a stabilirsi definitivamente nella sua città natale. Frattanto, era stato proprio nel suo studio fiorentino che nel 1861, mentre era in corso la prima grande Mostra di carattere nazionale con cui in quella Città si celebrava l’appena conseguita unità dell’Italia alla 69 F. Palizzi, La sera del 18 febbraio 1848 a Napoli, Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte. 70 F. Palizzi, Le barricate del 15 maggio 1848 a Napoli, Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte. 71 F. Palizzi, Gruppo di garibaldini, Roma, Galleria Nazione d’Arte Moderna. F. Palizzi, Il Principe Amedeo ferito con Ufficiali e attendenti dopo la battaglia della Cavalchina, Roma, Galleria Nazione d’Arte Moderna. 72 quale aveva deliberatamente scelto di non partecipare, Filippo Palizzi acconsentì ad esporre i 16 suoi dipinti dai quali i giovani artisti toscani vennero fortemente colpiti e attratti per la innovativa interpretazione del “vero” e della luce, al punto da prenderne a modello le magistrali soluzioni e da derivarne i preziosi suggerimenti che si rivelarono di fondamentale importanza per approfondire e sviluppare la visione e le idealità pittoriche confluite infine nella pittura della macchia. Fervido sostenitore dell’unità d’Italia e animato da profonde convinzioni democratiche, Giuseppe Abati (Napoli, 1836 – Firenze, 1868), volle partecipare a Capua, nel 1860, alla spedizione dei Mille rimanendo gravemente ferito a un occhio dal quale, secondo alcuni storici, avrebbe completamente perso la vista. Sotto molti aspetti decisivo, per la sua esperienza pittorica, si rivelò l’incontro con Telemaco Signorini che ebbe luogo a Venezia nel 1856. Dopo di che si trasferì pressoché definitivamente a Firenze, dove la sua pittura conobbe una fase evolutiva che lo avvicinò molto ai macchiaioli nel cui ambito finì con il distinguersi. Nel 1866 si arruolò fra i bersaglieri che si batterono nella Terza Guerra d’Indipendenza e prese parte, con il grado di sergente, alla campagna del Veneto, nel corso della quale venne fatto prigioniero e rinchiuso per vari mesi nel forte di Osijek, posto ai confini della Croazia. Quando, nel 1868, prematuramente si spense a Firenze, l’amata città in cui da poco era definitivamente rientrato, venne tumulato nel Cimitero di San Miniato avvolto nella tunica rossa dei garibaldini con le decorazioni al valore che aveva guadagnato. Nel 1860 anche Michele Cammarano (Napoli, 1835 – 1920) seguì Garibaldi, arruolandosi nella Guardia Nazionale non senza che l’esperienza influenzasse le scelte tematiche dei dipinti poco dopo prodotti fra cui i Due martiri della Patria, che presentò all’Esposizione nazionale di Firenze del 1861. Quasi dieci anni dopo, a seguito di un proficuo soggiorno parigino, rientrò a Roma, dove si era trasferito, in tempo per assistere al trionfale ingresso nella Città di Re Vittorio Emanuele II, accolto e festeggiato dal popolo lungo il percorso arricchito da grandi dipinti a tempera evocanti episodi e gesta dell’ormai avvenuta unificazione dell’Italia, appositamente elaborati da vari pittori, fra cui il giovane Patini con il quale Cammarano visse una importante stagione di lavo- 73 G. Fattori, Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta (1859), Firenze, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. G. Fattori, Garibaldi a Palermo (1860), collezione privata. 74 ro e di studio. Quindi immortalò la famosa breccia di Porta Pia nella celebre Carica dei bersaglieri alle mura di Roma (Napoli, Museo di Capodimonte), licenziato nel 1871 ed esposto con successo nel 1872 a Milano, nel 1873 a Vienna e nel 1888 a Londra. Destinato ad affermarsi fino ad essere tuttora considerato il maggiore e più richiesto pittore palermitano, anche Francesco Lojacono (Palermo, 1838 – 1915) volle seguire i garibaldini, fra le cui fila militò e combatté nel 1860. Quando, nel 1862, l’amato Generale decise di procedere alla conquista di Roma, tornò a unirsi a quei suoi fedelissimi che ne condivisero le avversità e le amarezze determinate dalle ormai mutate condizioni politiche che indussero a schierare l’esercito della nuova Italia in assetto di guerra con il precipuo ordine di fermarne ad ogni costo l’avanzata sull’Aspromonte. Nel corso della famosa battaglia che ne seguì, Garibaldi fu colpito ad un piede e i suoi volontari, fra i quali si contarono alcune perdite e non pochi feriti, furono in gran parte imprigionati. E fu insieme a Menotti che in quella circostanza anche Lojacono venne arrestato. Ma non certo per riconoscenza ai pittori che lo avevano seguito, bensì per quei convincimenti democratici da cui si sentiva spinto a migliorare le condizioni delle classi subalterne offrendo ai loro figli una possibilità di riscatto attraverso l’istruzione e l’apprendimento di un mestiere, che Garibaldi fondò la Società Centrale Operaia Napoletana, con sede all’Egiziaca a Pizzofalcone. Si trattava di una scuola serale di artigianato per i figli del popolo, specializzata nell’insegnamento dell’intaglio e dell’intarsio in cui, appassionandosi inizialmente agli impegnativi e creativi virtuosismi indispensabili alla elaborazione del cammeo, si avviò allo studio dell’arte anche Vincenzo Migliaro (Napoli, 1858 – 1939), il quale, per essere il terzogenito della numerosissima famiglia di un povero vinaio, non avrebbe potuto mai intraprendere gli studi d’arte e affermarsi nell’espressione pittorica fino a imporsi, nel ricco panorama napoletano, fra i maestri di primo piano. Garibaldini furono pure altri giovani originari delle province più meridionali della Penisola, donde si erano trasferiti a Napoli per frequentarvi il Reale Istituto d’Arte e per intraprendervi, benché nella maggior parte dei casi solo in una fase iniziale, l’attività pittorica, nella 75 G. Della Monica, Garibaldini in battaglia contro la cavalleria borbonica, Teramo, collezione privata. G. Della Monica, L'incontro di Teano, 1861, Teramo, collezione privata. 76 quale, pur senza conseguire i risultati attinti dai maggiori esponenti di quella Scuola, seppero comunque distinguersi. Un posto di rilievo, in questo novero, spetta senz’altro ad Andrea Cefaly (Cortale, Catanzaro, 1827 – 1907), che, dopo aver militato fra i volontari in camicia rossa, predilesse e affrontò spesso, nelle sue opere, temi desunti da quelle eroiche imprese delle quali fu fra i protagonisti più appassionati e fra i testimoni più attendibili e autorevoli. Se va senz’altro ricordata La battaglia del Volturno, commissionatagli da Vittorio Emanuele II, è sicuramente Bivacco di garibaldini il più celebre dei suoi numerosi quadri ispirati alle vicende di quanti si batterono al seguito del Generale, al quale, per altro, tenne a conferire la carica di Presidente onorario della Scuola d’arte che, nel 1862, tentò di far sorgere in Calabria, l’amata regione natia, di cui mise in luce i disagi e rappresentò le esigenze in numerose opere, stroncate, però, dalla critica ufficiale. Per la soluzione dei gravissimi problemi da cui erano afflitte la sua terra e la sua gente offrì il suo contributo anche in veste di deputato al Parlamento nazionale, carica in cui venne confermato fino al 1880. Si mantenne, in tal modo consequenziale e fedele alle ragioni che lo avevano spinto sui campi di battaglia e alle idee dibattute in giovinezza a Napoli, quando nel suo studio, ubicato al vicolo San Mattia, si riunivano abitualmente pittori suoi coetanei che ne “condividevano atteggiamenti liberali e patriottici, scelte ed orientamenti pittorici, ed erano profondamente legati fra di loro non solamente dalle comuni idealità, quanto pure, e forse soprattutto, dall’attenzione rivolta al repertorio dei motivi garibaldini, dai più intimi significati che caratterizzarono numerose prove licenziate e proposte nelle varie esposizioni all’indomani dell’unità d’Italia dai diversi pittori ex combattenti”, a principiare dalla prima grande mostra a carattere nazionale che venne predisposta a Firenze nel 1861. A far parte di tale sodalizio fu Antonio Migliaccio (Girifalco, Catanzaro, 1830 – Catanzaro, 1902), presente all’esposizione fiorentina con due quadri: Garibaldini all’osteria e Un garibaldino ferito, che equivale quasi certamente ad una pagina autobiografica, come aiuta a ritenere la presenza, esplicitamente allusiva nella scena evocata, di un cavalletto e di una tela. Allo stesso gruppo era legato anche il corregionale Achille Martelli (Catanzaro, 1829 – Avellino 1903), che con dipinti di affine soggetto, come L’alloggio garibaldino e Il racconto 77 dell’ospite garibaldino del 1861, fu fra quanti incrementarono il cosiddetto “filone filo garibaldino, che prediligeva un tono più dimesso rispetto a quello celebrativo dei dipinti di rappresentanza”. Si trattò di propensioni che si diffusero sia fra maestri di prima grandezza sia fra pittori al loro tempo affermati e ingiustamente oggi quasi dimenticati, come i due amici corregionali del Patini, Gennaro Della Monica (Teramo, 1837 – 1917) e Oreste Recchione (Sant’Angelo dei Lombardi, 1841 – Napoli, 1904), sia fra artisti meno noti che avevano dimostrato e continuarono a mostrare inclinazioni più legate alle tematiche tradizionali, come si evince, per esempio, da alcune prove di Giovanni Ponticelli, documentato a Napoli dal 1855 al 1882 quale autore di soggetti di storia e di genere. Anche per lui, difatti, “l’aggiornamento sui temi patriottici” si configura “sentito con l’urgenza di un nascente sentimento nazionale”, come “significativamente si riscontra alla prima Esposizione di Firenze del 1861, dove presenta Un garibaldino ferito racconta le sue gesta a due giovinette”. Appartenente al gruppo di pittori ex combattenti che si incontravano nello studio napoletano di Andrea Cefaly e amico soprattutto di Achille Martelli, Michele Tedesco (Moltierno, Potenza, 1834 – Napoli, 1918), fin “dal 1860 si trasferì in Toscana al seguito di Giuseppe Garibaldi, come membro volontario della Guardia Nazionale, ma nei primi anni mantenne stretti rapporti con Napoli: nel ’61 è tra i fondatori della Società Promotrice di Belle Arti di Napoli, assieme a Palizzi, Smargiassi” e altri già autorevoli Maestri o ancora giovani pittori esordienti come Patini. Occorre tuttavia rilevare che la sua “forte passione ideologica e l’attaccamento ai valori risorgimentali”, non diventano solamente “forme pittoriche in Prigionieri borbonici sulla linea del Volturno (Roma, Museo Centrale del Risorgimento)”, ma, avendolo indotto al trasferimento in Toscana, finirono con il determinare la sua stretta frequentazione con i Macchiaioli e la sua determinante svolta pittorica che si rivelò tutt’altro che priva di influenze, dimostrandosi anzi rilevante al punto da venire ritenuta addirittura “fondamentale”, nell’evoluzione della pittura partenopea. “Nonostante il poco interesse che la critica” gli ha riservato, questo autore “fu, infatti, uno dei tramiti della cultura pittorica napoletana con lo sperimentalismo pittorico fiorentino”. 78 Ulteriore dimostrazione di come, a causa o a seguito dell’avventura garibaldina, alcuni pittori abbiano avuto modo di stabilire nuovi contatti e di vivere nuove esperienze rilevanti non solo per la formazione e maturazione del loro linguaggio e della loro personalità artistica quanto pure, a volte, per le influenze esercitate su altri loro colleghi, lo ribadisce anche il caso di Eugenio Tano (Marzi – Cosenza 1840 – Firenze 1914), il quale, oltretutto, “compì gli studi in maniera discontinua” proprio per l’intensa attività in cui si impegnò per seguire la sua vocazione di patriota e di combattente. “Seguì Garibaldi a Soveria, dove ebbe un ruolo preminente nel disarmo dell’esercito borbonico comandato dal generale Ghio”. Dopo il trasferimento a Firenze abbandonò la tematica storica “per la pittura di paesaggio, nella quale sperimentò le teorie dei macchiaioli” con i quali era entrato in contatto, non senza distinguersi anche come “attento e sensibile ritrattista”, apprezzato al punto che “fu richiesto più volte soprattutto dalla Casa Reale”5 e pronto a manifestare anche per questa via la sua ammirazione per le figure risorgimentali più emblematiche, quali, ad esempio, Attilio Bandiera, raffigurato nel 1864, e Giuseppe Garibaldi, a cui dedicò due apprezzate tele, l’una nel 1865 e l’altra nel 1886. Ad incrementare contatti fra le idee macchiaiole e le propensioni naturalistiche della Scuola napoletana, contribuirono gli apporti di Adriano Cecioni (Fontebuona, 1836 – Firenze, 1886), il quale, fra il 1863 e il 1867, soggiornò e operò a Portici a contatto con De Gregorio, Rossano e De Nittis che diedero vita alla “Scuola di Resina”. Di formazione fiorentina, Cecioni era convinto propugnatore degli orientamenti dibattuti al Caffè Michelangelo dai pittori della macchia, che cominciò a frequentare non appena fu rientrato a Firenze dal fronte della Seconda Guerra d’Indipendenza del 1859, alla quale aveva preso parte come volontario nell’Artiglieria Toscana e nel corso della quale aveva conosciuto il coetaneo Telemaco Signorini (Firenze, 1835 1901), pure lui volontario nelle fila garibaldine. 05 F. C. Greco, M. Picone Petrusa, I. Valente, La pittura napoletana dell’800, op. cit., cfr. ad vocem; e per le citazioni vd. pp. 96, 145, 142, 152, 164. 79 G. Induno, La partenza del garibaldino, (1860), collezione privata. 80 G. Induno, La discesa d’Aspromonte, part., (1863), collezione privata. 81 Fervente ammiratore di Garibaldi e di Mazzini, animato da quello stesso spirito e sentimento patriottico vivamente avvertito da quei suoi colleghi ed amici fiorentini fra i quali finì con l’emergere e l’imporsi anche come teorico pronto a diffonderne, attraverso i suoi scritti, le aspirazioni e finalità artistiche, Signorini produsse, subito dopo le imprese a cui aveva preso parte, diversi dipinti di soggetto militare, ai quali, non appena vennero poi esposti presso l’Accademia fiorentina di Belle Arti, arrise largo consenso di pubblico oltreché di esperti. Ad essi si preparò tornando, nel 1860, sui luoghi dei combattimenti dopo un breve soggiorno di studio affrontato in Liguria con Cristiano Banti e Vincenzo Cabianca ( Verona, 1827 – Roma, 1902) che era di quasi dieci anni più anziano e aveva anche lui preso parte alla Seconda Guerra d’Indipendenza, in tal modo confermando e suggellando quell’attivo impegno politico e patriottico dimostrato fin dal 1848, quando, per sfuggire alla coscrizione austriaca, da Venezia, dove aveva intrapreso gli studi d’arte, si era trasferito a Bologna, dove si schierò in difesa della Città finendo con l’essere arrestato e incarcerato durante le manifestazioni di protesta di Castelfranco dell’Emilia. Per cui, solo nell’agosto dell’anno successivo poté tornare nella natia Verona, donde nel 1853 si trasferì a Firenze e qui si unì strettamente al gruppo dei macchiaioli. Fra gli altri pittori legati alla stessa cerchia ed agli stessi ideali artistici che parteciparono alla Seconda Guerra d’Indipendenza va ricordato ancora l’illustre nome di Odoardo Borrani (Pisa 1833 – 1908), il quale militò fra i volontari dell’Artiglieria Toscana, lo stesso corpo del Cecioni, dopo essere partito in compagnia di Telemaco Signorini, da lui conosciuto e frequentato al Caffè fiorentino dell’Onore. Pure Ferdinando Buonamici (Firenze, 1820 – 1892) partì insieme a Cecioni, Martelli e Signorini, il quale lo apprezzò e tenne a rimarcarne l’insofferenza per la dominazione straniera in Italia. Non altrettanto famoso, benché tutt’altro che trascurabile pittore, anche Vincenzo Lami (Empoli, 1807 – Fitenze, 1892) al quale nel 1886 venne conferito il titolo di Cavaliere della Corona per meriti militari, aveva preso parte alla Seconda Guerra d’Indipendenza per il Governo Provvisorio Toscano, nonostante che l’età relativamente avanzata lo avvicinasse agli artisti che erano partiti per la Prima Guerra 82 d’Indipendenza contro l’Austria, al termine della quale entrarono a far parte del gruppo di quanti si riunivano al Caffè Michelangelo. Fra di essi un posto di primo piano spetta senz’altro a Vito D’Ancona (Pesaro, 1825 – Firenze, 1884), che più tardi abbandonò Firenze per trasferirsi a Parigi, dove, oltre al gruppo degli artisti italiani, ebbe modo di conoscere e frequentare Courbet e Corot con non poco vantaggio per l’evoluzione e la maturazione della sua espressione pittorica. Anche Serafino De Tivoli (Livorno, 1826 – Firenze, 1892) si batté, nel 1848, fra i volontari toscani nella battaglia di Curtatone e Montanara per prendere parte, l’anno successivo, alla difesa della Repubblica Romana. Dopo una non lunga prigionia, De Tivoli, rientrato a Firenze dove espose alle Promotrici, si avvicinò al gruppo del Caffè Michelangelo dimostrando una partecipazione straordinariamente attiva al movimento, al punto che viene tuttora additato quale il “papà della macchia”. Dopo aver partecipato anche lui alla battaglia di Curtatone e Montanara, Stefano Ussi (Firenze 1822 -1901) scontò, invece, una più prolungata e sofferta detenzione nel tetro carcere di Theresienstadt in cui ritrasse i suoi compagni di sventura. Per difendere la Repubblica Romana, Gerolamo Induno (Milano, 1825 – 1890) si unì ai volontari che nel 1849 partirono da Firenze, dove aveva scelto di sistemarsi al suo rientro in Italia dalla Svizzera, in cui si era trasferito dopo aver combattuto nella Prima Guerra d’Indipendenza. La passione con cui guardò alle imprese politiche e militari di quegli anni lo indusse a partecipare alla Guerra di Crimea, ancora una volta nelle vesti di pittore soldato, fra il 1864 e il 1865. Figura di primo piano nel panorama della pittura italiana dell’Ottocento, fu molto influenzato, nella scelta dei temi e nello stile con cui ne affrontò le frequenti rievocazioni, dalle esperienze vissute e dalle vicende del Risorgimento. Di oltre sedici anni più giovane, pure Francesco Zandomenighi (Venezia, 1841 – Parigi, 1917), dopo aver seguito Garibaldi in Sicilia nel 1860, durante la spedizione dei Mille, si arruolò nuovamente al suo fianco nel 1866 per battersi contro gli austriaci nella Terza Guerra d’Indipendenza. A rinunziare al linguaggio e ai modi squisitamente macchiaioli che ne avevano contrassegnato l’apprezzata produzione fino agli avanzati anni Sessanta fu un viaggio a Parigi, nel corso del 83 O. Borrani, Le cucitrici di camicie rosse (1863), Torino, Palazzo Bricherasio. 84 O. Recchione, La preparazione del tricolore, acquerello, Milano, collezione privata. 85 quale scoprì le potenti suggestioni della nascente espressione pittorica degli Impressionisti e pienamente ne intese il senso delle nuove prospettive e intuì le possibilità verso cui apriva rimanendone affascinato al punto da mutare completamente il suo stile per avvicinarsi sempre più a quei Maestri, insieme ai quali espose per la prima volta nel 1879 quei suoi dipinti nei quali aveva rapidamente conseguito risultati di indiscutibile efficacia e radicalmente diversi rispetto ai suoi pur fortunati esordi fiorentini. Parimenti impegnato nelle lotte per il conseguimento dell’unità nazionale fu Luigi Bechi (Firenze, 1830 – 1919), che, dopo aver partecipato in camicia rossa, nel 1859, alla Seconda Guerra d’Indipendenza, volle prendere parte, nel 1866, anche alla Terza, tornando a seguire Garibaldi fino in Alto Adige, dove, durante la battaglia della Bezzecca venne fatto prigioniero. Gli impegni di combattente, però, non gli impedirono di attendere al suo lavoro di pittore, tanto è vero che la svolta più importante e per certi versi decisiva per la sua espressione artistica ebbe luogo proprio a cavallo fra le due guerre, a seguito del viaggio che nel 1861 lo portò a Parigi insieme al Cabianca, al Banti, al Signorini e a diversi frequentatori del Caffè Michelangelo. Fra le altre personalità di spicco operanti a Firenze che nel 1848 presero parte alla Prima Guerra d’Indipendenza va segnalato con particolare risalto Luigi Mussini (Berlino, 1813 – Siena, 1888) non fosse altro perché la sua decisione valse da stimolo a seguirne l’esempio per parecchi dei numerosi giovani che andavano approfondendo la formazione nella scuola da lui fondata nel 1844 in quella città insieme all’allievo di Ingres Franz Adolph Von Sturtler. Unitamente al Mussini, a suo fratello Carlo e al collega e compagno di studi Gordigiani, partì anche Silvestro Lega (Modigliana, 1826 – Firenze, 1895), destinato ad imporsi fra quanti aderirono al gruppo del Caffè Michelangelo e si espressero secondo i nuovi criteri della “macchia”, dando luogo a pagine di indiscussa quanto soggettiva valenza pittorica. Benché non assunsero mai un ruolo centrale nella sua produzione, in cui prevalgono temi di ambientazione borghese proposti con sensibile delicatezza di osservazione e magistrale quanto innovativo piglio di esecuzione, le esperienze vissute in qualità di combattente volontario, valsero ad ispirargli le scene e i soggetti di ambiente mili- 86 tare di alcuni dipinti da lui realizzati dopo il 1865, anno in cui divenne socio dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana. Assume significato indubbiamente emblematico e acquista valore di esempio il criterio con cui affrontò, e non fu il solo, il complesso e talora sofferto percorso attraverso il quale pervenne alla conquista e alla maturazione del precipuo linguaggio dalle forme e dai modi apparentemente piani e quasi naturalmente attinti da cui prende corpo e sostegno la sua evocazione di momenti della quotidianità resi con la scorrevolezza di una narrazione. Fu, difatti, un cammino che non si compì, per lui e per qualche altro, attraverso una ricerca appartata, affrontata in solitudine o nell’isolamento dello studio, bensì attraverso il severo impegno di un assiduo lavoro condotto spesso a stretto contatto con alcuni colleghi ed amici, secondo quella sorta di costume progressivamente diffuso per cui di frequente i macchiaioli operavano quasi in comunità di lavoro e di intenti. Contribuiscono a ribadirlo i criteri e i modi da cui prese vita e consistenza quella sorta di “Scuola”, detta della Piagentina dalla località prossima a Firenze in cui si incontrarono e spesso dipinsero gomito a gomito, che Silvestro Lega costituì nel 1862 insieme a Giuseppe Abbati, Odoardo Borrani, Telemaco Signorini e il più giovane Raffaello Sernesi (Firenze, 1838 - Bolzano 1866), che, al pari degli altri amici del gruppo, fu ardente patriota e, come loro, intrepido combattente volontario per l’unità d’Italia. Lo slancio generoso che lo indusse a entrare nelle file garibaldine per battersi contro gli austriaci nella terza Guerra d’Indipendenza del 1866 doveva, però, richiedergli un prezzo altissimo e disperato. La ferita che riportò in battaglia, difatti, produsse la gravissima infezione che rapidamente, e senza risparmiargli la piena consapevolezza di come la sua sorte fosse ormai definitivamente segnata, ne stroncò troppo precocemente l’esistenza a meno di trent’anni. Pure, nonostante la brevità della vita, aveva saputo superare assai presto tutti i limiti e le pastoie della formazione accademica inizialmente ricevuta fino a conseguire, specialmente negli scorci paesaggistici dei luoghi a lui cari dipinti en plein air assai spesso insieme a Lega, Cabianca e Borrani, tutto lo slancio, tutta la disinvolta franchezza e la sorprendente carica innovativa da cui fu elevato al rango di pittore fra i più fini e significativi di quegli anni. 87 M. Cammarano, La breccia di Porta Pia, noto anche sotto la denominazione Carica dei bersaglieri alle mura di Roma, 1871, Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte. 88 Gli sforzi, l’impegno, la dedizione assoluta di tutti quei giovani e di quanti altri avevano creduto e operato per il Risorgimento nazionale non furono, però, ripagati con pari generosità al conseguimento dell’unità d’Italia, né le speranze che li avevano sorretti e meno che mai le loro attese di una maggiore giustizia sociale trovarono una soddisfacente o sia pur parziale attuazione. Apparvero subito evidenti e gravi le inadeguatezze del Parlamento postunitario, in seno al quale albergò, esercitando una eccessiva quanto perniciosa ingerenza, quel “parlamentarismo” definito spregevole e interessato da scrittori come Matilde Serao e dagli autori di certa acuta satira nostrana ospitata nelle coeve riviste francesi. Il diffondersi della corruzione, le sempre più marcate dimostrazioni di incapacità e supina inefficienza, donde la inconsueta rapidità con cui furono varate leggi in netto contrasto con le reali esigenze del Paese in generale e delle classi subalterne in particolare, quale fu per esempio l’improvvida decisione di sottrarre il Tavoliere di Puglia alla transumanza stagionale dei greggi con cui venne segnato l’irreversibile tracollo della industria armentizia tuttora vitale e determinante risorsa per l’economia delle popolazioni appenniniche centro – meridionali, parevano rinnegare le linee programmatiche e le aspirazioni alle garanzie democratiche, che erano state alla base dell’impegno profuso per il conseguimento dell’unità. Per cui, soprattutto fra gli intellettuali, si diffusero presto la delusione e l’amarezza che indussero a parlare di Risorgimento tradito. Le carenze e le inettitudini, del resto, assunsero subito dimensioni decisamente più ampie e complessive di quanto non emerga dalla assoluta irriconoscenza riservata a quanti si erano duramente sacrificati per l’attuazione degli ideali risorgimentali, come Patini pose in evidenza nel Nudo patriottismo, la tela riferibile alla fine degli anni Settanta, in cui, alludendo anche alla sorte toccata al suo antico maestro Panfilo Serafini, mise in evidenza come al patriota, ormai completamente abbandonato al suo destino, non venisse risparmiato neppure il Sequestro, donde il titolo alternativo, degli ultimi beni, talora eseguito persino mentre si congedava dalla vita. Vero è che erano stati varati provvedimenti volti a risarcire soprattutto i feriti e gli invalidi, ma quanti ne avanzarono richiesta vennero confusi con i profittatori e definiti dal Cavour gli “accorsi al bottino”. 89 T. Patini, La catena, ubicazione sconosciuta. 90 T. Patini, Il sequestro o Nudo patriottismo, Bari, Pinacoteca Provinciale. 91 ciali e dei soldati dell’antico esercito rimasti fedeli al sovrano detronizzato, umiliati, privati di ogni bene e di ogni avere, di ogni prospettiva e perciò decisi ad opporre una impari quanto legittima resistenza ad oltranza, la quale venne soffocata nel sangue dai ben 211.500 soldati piemontesi guidati dai migliori ufficiali sabaudi appositamente dislocati nel Meridione. Rese esponenzialmente più tragiche dalle incomprensioni gravissime che ebbero la loro radice primaria nelle profonde diversità dei costumi, ma soprattutto nella radicale difformità dei linguaggi usati, che erano i dialetti tanto da parte dei militari considerati “invasori” quanto da parte delle popolazioni che non conoscevano forme espressive diverse da quelle praticate nelle piccole e spesso isolate comunità a cui appartenevano, tali operazioni provocarono un milione di morti e la distruzione di 54 paesi, alcuni dei quali vennero cancellati per sempre, come si verificò, ad esempio, per Pontelandolfo e Casalduni, nel Beneventano, che, dopo essere stati sottoposti a saccheggi e violenze di ogni genere seguiti dalla più brutale delle stragi perpetrata per le intere popolazioni, vennero dati alle fiamme e rasi al suolo dal 18° battaglione dei bersaglieri. Non a torto perciò, nella nuova pagina della storia d’Italia che si va riscrivendo sulla base dei documenti progressivamente scovati negli archivi, i risultati di siffatti interventi vengono oggi paragonati ai genocidi compiuti contro gli indiani d’America. Se gli ex militari borbonici non ebbero scampo, perché rinchiusi in campi di concentramento fra cui resta famoso quello di Finestrelle, posto a 2000 mt. sulle montagne piemontesi e dal quale non si usciva mai più, visto che i cadaveri venivano immersi e consunti nella calce viva, molti civili fuggirono all’estero, dando origine alla straordinaria emorragia dell’emigrazione di cui si può commisurare l’entità tenendo conto che i 220 mila italiani residenti all’estero nel 1861 divennero 6 milioni nel 1914. In questo variegato e complesso alveo di crudeltà perpetrate senza alcun rimorso, di incapacità di dialogo, di aridità delle coscienze, di divergenze insanabili, affonda le radici e prende corpo il dibattito sulla “Questione meridionale”, la quale, introdotta e alimentata da intellettuali e artisti, si venne proponendo in tutta la sua complessità e con incidenza sempre maggiore, come evidenziò Giustino Fortunato, spe- 92 Commentando alcuni scritti pubblicati dallo zio materno Francesco Sipari, Benedetto Croce poneva in evidenza il “severo giudizio” che questi, divenuto per altro Senatore del Regno, “recava sugli avvenimenti del 1860, che si rifiutava di chiamare «rivoluzione», perché furono meschino e superficiale rivolgimento”, dal momento che “nulla s’intese di quanto potesse veramente prender carattere di rivoluzione sociale, e il vecchio sistema dell’impiegatume, delle sinecure, dei monopoli, delle restrizioni economiche fu trasmesso intero da una ad altra fazione. Chi si domandò allora, fra tanti fumi di patriottismo, quale fosse lo stato reale del contadino, del proletario, nelle province meridionali d’Italia?”6. Per tutti gli abitanti dell’antico Reame borbonico, ma soprattutto per le classi subalterne, gravissime furono, in effetti, le conseguenze delle limitatezze, delle ottusità e delle ingerenze del “piemontesismo”, la sfrontata prepotenza con cui vennero utilizzate le ingenti riserve auree del Reame, pari a 500 milioni contro i 100 del Piemonte, il cieco egoismo con cui furono smantellati e trasferiti al Nord i più aggiornati macchinari dei più ricchi e promettenti opifici meridionali, a principiare dai telai, voluti dai Borboni per la produzione di sete e tessuti di celebre raffinatezza, che, dalla San Leucio prossima alla Reggia di Caserta vennero trasportati a Valdagno, per costituirvi la prima fabbrica tessile del Veneto. La stessa sorte toccò ai macchinari delle ferriere di Mongiana, spostati e utilizzati in Lombardia. Ma forse ancora più laceranti, perlomeno nella immediatezza, furono la tracotante inflessibilità con cui si applicarono le nuove leggi sulla tassazione personale, che nel 1866 venne fissata a 28 franchi pro capite, pari al doppio di quella comminata in età borbonica; l’imposizione della coscrizione obbligatoria, odiata e incomprensibile perché sottraeva le giovani braccia al lavoro dei campi; ma soprattutto l’impietoso accanimento della feroce e sanguinaria lotta contro il “brigantaggio”, sotto la cui denominazione, tuttora intesa come marchio d’infamia, venivano compresi non solo gli ignoranti e affamati malfattori quanto pure e soprattutto le larghe masse dei contadini, dei borghesi, dei proprietari terrieri, degli uffi- 06 B. Croce, Pescasseroli, in Storia del Regno di Napoli, Laterza, Bari 1953, p. 401. 93 cie a partire da quando le Lettere meridionali dello storico Pasquale Villari, cognato di Domenico Morelli e suo consigliere prediletto nella scelta dei soggetti storici da lui rievocati e interpretati in memorabili tele, furono pubblicate dapprima a puntate, su “L’Opinione” di Roma nel 1875, e quindi raccolte in volume nel 1878; e dunque nello stesso volgere di anni a cui occorre riferire l’elaborazione dei dipinti che prepararono o accompagnarono la nascita dell’Erede, il celebre quadro con cui Teofilo Patini segnò l’origine dell’arte sociale in Italia e attraverso il quale proclamò la necessità di aprire una nuova pagina di storia all’insegna della giustizia sociale, ribadendo in tal modo che con l’arte “si prepara la libertà, come si conquista con la rivoluzione”. 94 C. Patrignani, Emigranti abruzzesi alla stazione, L’Aquila, collezione privata. 95 96 SCHERMI TRICOLORI. IL RISORGIMENTO E IL CINEMA ITALIANO: PERCORSI E TENDENZE. di Antonio Di Fonso I classici Negli anni eroici della sua avventurosa storia il cinema si nutre di grandi personaggi, racconta i protagonisti, celebri o sconosciuti, che sarebbero diventati nell’immaginario popolare gli eroi dell’Italia risorgimentale. Già in piena epoca fascista e poi nel dopoguerra il cinema si avvia a diventare un prodotto industriale, senza perdere comunque nobiltà e sostanza culturale, in un impasto lievitante che approda a una sintesi felice di praticità imprenditoriale (i grandi produttori che finanziavano le opere) e creatività artistica (i registi, gli sceneggiatori e gli attori che le realizzavano). Del resto, la sua straordinaria capacità di coinvolgere gli spettatori di ogni età e condizione sociale ne fa subito uno strumento di comunicazione dirompente e alfabetizzazione ante – litteram dei gusti, delle emozioni e dei sentimenti popolari. Il cinema funziona come macchina dei sogni e del divertimento, ma riesce anche a far pensare, diffonde idee, contribuisce a costruire opinioni e consensi. È una mirabolante macchina nata per affabulare, raccontare storie, proporre personaggi veri e di fantasia: trasfigura, fruga dentro la (ancora) giovane identità degli italiani, illuminando sul grande schermo gli snodi cruciali del passato, selezionando le imprese celebri destinate a divenire epica e miracolo popolare. Nella temperie di quel periodo compreso fra gli anni Trenta e Cinquanta, dunque, il cinema italiano sceglie di raccontare il Risorgimento, ovvero la pagina della storia d’Italia che più delle altre si offriva alla celebrazione condivisa, intuendone la carica identificativa sprigionata dai suoi protagonisti e artefici, destinati tutti (da Cavour a Mazzini e Garibaldi) a diventare presto eroi ideali, santi laici e padri - “calpesti e derisi” ma poi risorti - di una Patria in cerca di spettatori. 97 Nel 1934 Alessandro Blasetti gira 1860, Goffredo Alessandrini nel 1954 Camicie rosse. Sono due film significativi, il primo diretto da uno dei maestri della nostra cinematografia che aveva attraversato il ventennio fascista, sperimentando generi diversi, dai telefoni bianchi alla commedia sofisticata fino al romanzone in costume; il secondo, divenuto un piccolo classico del genere storico – popolare, opera di un regista appartenente a quella cinematografia solida, fatta di artigiani e mestieranti di valore cresciuti negli studi di Cinecittà. In entrambe le pellicole il Risorgimento è raccontato sfiorando l’agiografia, i Mille sono giovani patrioti pronti al sacrificio e Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele II sono più vicini al mito che alla storia, identici a se stessi, o meglio a come l’immaginario collettivo li aveva fissati per sempre. Le battaglie, le diplomazie, gli intrighi e le vicende diventano avvenimenti segnati dalla necessità del fine che giustifica gesti e sacrifici, assecondano il destino che deve compiersi, mentre il sentimento patriottico e lo sventolio del tricolore vive già nei cuori dei protagonisti ancora prima del succedersi dei fatti storici. Qualche anno dopo, all’inizio degli anni Sessanta, Roberto Rossellini realizza Viva l’Italia, titolo quanto mai esemplificativo, un’opera che idealmente completa l’affresco dell’Italia che nella cinematografia del maestro del Neorealismo era iniziato nel dopoguerra e che adesso si concludeva, in pieno boom economico, ritornando alle radici della “nascita di una nazione”. In tale ricostruzione storica il processo risorgimentale rappresenta il momento iniziale, costituisce la linfa che alimenta e nutre le radici dello Stato unitario: ripercorrendo tutte le tappe della storia, dalla nascita fino al Ventennio fascista, dalla Liberazione alla Repubblica, il Risorgimento assume il ruolo di avvenimento chiave, spiegazione e comprensione di ogni successivo cambiamento sociale, politico e culturale dell’Italia unificata. Cavour, Mazzini, Garibaldi nella lettura rosselliniana anticipano i Costituenti, presagiscono la visione futura e la missione del loro agire storico. Il cinema di Rossellini, più di ogni altro autore, indubbiamente, rispecchia il clima culturale degli anni Sessanta, e si colloca dentro un orizzonte valoriale – come si dice in questi casi – che esigeva opere riassuntive se non proprio pedagogiche. Il Risorgimento, l’Unità d’Italia, la Resistenza e la Repubblica si manifestano e si spiegano 98 come momenti cruciali della storia italiana, e vengono incardinati di conseguenza tutti dentro un progressivo e lineare cammino, in cui il presente appare sempre come il risultato del passato. Altri due film sono di fondamentale importanza in questa direzione. Girati nel decennio 50 – 60, costituiscono due capolavori nella filmografia di Luchino Visconti: ci riferiamo a Senso, uscito nelle sale nel 1954, e a Il gattopardo realizzato nel 1963. Il rapporto tra il cinema e la storia risorgimentale diventa nelle opere di Visconti più complesso, alla lettura e all’urgenza della ricostruzione storiografica – che pure permane – si sovrappone – si pensi alle scene corali del Gattopardo, o alla ricercatezza dei costumi e delle scenografie viscontiane – l’interpretazione soggettiva del regista, la cui sensibilità orienta la rilettura della storia che viene filtrata attraverso il gusto culturale, la letteratura, l’arte, la musica. Le vicende e gli avvenimenti storici restano in primo piano, ma è evidente l’importanza che acquistano i personaggi, la loro interiorità. I sentimenti e le emozioni individuali, spesso inarrestabili e fatali che governano l’intrecciarsi della trama, sovrastano i fatti e gli episodi collettivi. Rimangono nella memoria di tutti alcuni momenti esemplari: la nobildonna, interpretata dalla bellissima Alida Valli che tradisce i patrioti e la causa dell’Italia, innamorandosi del tenebroso ufficiale austriaco in Senso; il cinismo del tormentato principe di Salina de Il gattopardo, che osserva con disincanto il mondo piccolo e meschino dei nuovi ricchi e delle nascenti classi dirigenti emancipate dopo l’Unità d’Italia, ben sapendo che ogni sforzo di cambiamento sarà vano, o meglio congeniale soltanto a rafforzare l’immobilismo economico e sociale. Nei due film il Risorgimento smarrisce la sua centralità di avvenimento epocale che assolveva anche alla funzione educativa dello spettatore, e rimane soltanto come materiale narrativo, ambientazione sontuosa, contesto e quadro di riferimento epocale. E così in primo piano affiorano e s’impongono i singoli personaggi, i loro sentimenti, l’interiorità, i destini individuali, le riflessioni sulla vita e sulla morte, il destino e l’etica delle scelte compiute dai singoli. I due film di Visconti ancora oggi vengono considerati classici insostituibili, capostipiti indispensabili di qualunque filmografia ragionata dedicata al cinema risorgimentale, e mantengono un’aurea di sacralità inviolabile, proponendosi quali modelli tematici e stilistici. 99 L’ altro Risorgimento Negli anni Settanta muta il contesto ambientale e sociale, il vento di ribellione e iconoclasta produce i suoi effetti anche nel cinema, e il Risorgimento diventa così oggetto di revisione storica o anche – molto più frequentemente – occasione e spunto di dibattito rivolto più all’attualità politica che alla ricostruzione documentaria. Film come Allonsanfan e Bronte, cronaca di un massacro sono al riguardo emblematici. Allonsanfan di Paolo e Vittorio Taviani è un film segnato dal clima dell’epoca e dai riferimenti espliciti alle divisioni interne della sinistra, combattuta e dilaniata in quel periodo tra le scelte rivoluzionarie e quelle riformiste. La vicenda del protagonista, interpretato da Marcello Mastroianni, un nobile patriota ex giacobino che alla fine sceglie di tradire i compagni in procinto di organizzare una spedizione rivoluzionaria al sud (chiari i riferimenti ai fratelli Bandiera e a Pisacane), ne è un esempio esplicito; come pure il fallimento dell’azione rivoluzionaria, rigettata dagli stessi contadini che dovevano essere liberati dai giovani patrioti, allude e rimanda ai velleitarismi ideologici della sinistra extraparlamentare degli anni della contestazione e del sogno “della scalata al cielo”. Dal punto di vista stilistico, la sapiente regia dei Taviani, spesso tendente al grottesco e al parodico, viene valorizzata al massimo dagli attori, esponenti di generazioni cinematograficamente diverse: le icone del film politico degli anni Settanta, Bruno Cirino, Claudio Cassinelli e la stessa Laura Betti, s’incrociano con il mestiere e la sapienza di un divo come Mastroianni e con il fascino di attrici come Lea Massari. Bronte, cronaca di un massacro di Florestano Vancini, che racconta il massacro compiuto dal generale Nino Bixio su ordine di Garibaldi a Bronte paese della Calabria, nasce come film per la televisione, e malgrado le semiclandestine programmazioni viene visto nel 1974 da quasi dieci milioni di spettatori. Il cinema in questo caso svolge una funzione di controinformazione, di smascheramento storico degli aspetti più sgradevoli e spietati della realpolitick risorgimentale, mostrando anche in modo antiretorico quello che una certa storiografia celebrativa aveva preferito occultare se non censurare del Risorgimento eroico. Il film, per molti aspetti duro e sgradevole, rimanda alla tradizione del 100 Neorealismo italiano di seconda generazione, quella per intenderci dei Rosi e dei Petri a cui lo stesso Vancini apparteneva. Altri film, di minore successo ma dallo stesso rigore documentario, possono rientrare nel filone cosiddetto “antiretorico” della cinematografia risorgimentale: ne ricordiamo uno, Quanto è bello lu morire accise di Ennio Lorenzini, dedicato alla tragica spedizione di Carlo Pisacane, i cui “trecento giovani e forti” compagni – molti dei quali arruolati direttamente nel carcere di Procida - vengono accolti e giustiziati dai forconi di quegli stessi contadini per i quali era stata organizzata l’impresa destinata a liberarli dalla schiavitù e dallo sfruttamento. Una lettura disincantata del Risorgimento la ritroviamo anche nel cinema del regista romano Luigi Magni, autore di una trilogia che ha saputo unire allo scrupolo dell’indagine storica la frequentazione disinvolta di situazioni e volti della commedia italiana, arruolando gli attori simbolo di una generazione e di un genere - da Sordi a Manfredi, da Tognazzi alla Cardinale - alla causa anticlericale. Il suo stile sarcastico, la disillusione e l’apparente cinismo dei suoi antieroi - ci viene in mente per esempio il personaggio del Monsignore interpretato da Nino Manfredi nel film In nome del papa re - rivelano in realtà una umanità di sostanza che respinge le ipocrisie e i falsi valori di una religiosità ridotta ormai a stanca liturgia di forme. La scena del processo farsa in cui un tribunale di cardinali e monsignori incartapecoriti e vegliardi, ormai fuori dal tempo e dalla realtà storica, emana il verdetto di condanna contro i due giovani accusati di un attentato alla caserma pontificia sancisce con amara ironia la fine di un’epoca e del potere temporale della Chiesa. Per quanto Magni abbia approfondito in modo quasi monografico la Roma del papa re, tratteggiando ambienti e personaggi, ricostruendo vizi e ritardi culturali di uno Stato pontifico repressivo e reazionario, soprattutto nei suoi film di maggiore successo si coglie comunque una volontà, uno sguardo complessivo che tende a ricostruire e a restituire in senso più ampio l’atmosfera e il clima che anticiparono i moti liberali e carbonari, o le speranze di quanti ebbero fede nella Repubblica romana, e prepararono il terreno politico alla breccia di Porta Pia. Tra i film più riusciti nella sua longeva attività spiccano, in ordine rigorosamente cronologico, Nell’anno del Signore, girato nel 1969, il già citato In nome del papa re, realizzato nel 1977, e infine In nome del popolo sovrano, uscito nel 1990. 101 La Storia alla fine della storia Negli ultimi anni il cinema italiano ha tralasciato le tematiche storiche, l’interesse per il Risorgimento è scemato, le energie e le tendenze degli autori e dei registi si sono dirette in altre direzioni. Il rinato interesse verso una cinematografia di denuncia sociale, da una parte, e le esigenze più commerciali che hanno privilegiato la sempiterna commedia, dall’altra, hanno sigillato questa sorta di damnatio memoriae di un genere. Invece, come talvolta accade, le tendenze culturali mutano, si rigenerano e riaprono spiragli fecondi, anche in una società liquida come la nostra l’imprevisto è dietro l’angolo, la sorpresa prepara i suoi agguati. Così, inaspettatamente è arrivato lo scorso anno il film di Mario Martone, Noi credevamo, a riaprire una pagina, a riscorrere i titoli e i capitoli del nostro Risorgimento, catturando interesse e pubblico, soprattutto quello dei giovani, riscuotendo premi e attestati prestigiosi. Il film, di durata assolutamente inconsueta – quasi 3 ore – per lo standard medio di oggi, pensato per la televisione e adattato su grande schermo, liberamente ispirato al libro omonimo di Anna Banti, racconta la storia di tre amici, Salvatore, Domenico e Angelo negli anni cruciali che vanno dalle repressioni borboniche fino alla spedizione di Garibaldi e alla nascita dello stato italiano, passando per attentati e ribellioni, divisioni feroci, odi incancellabili, furbizie e trasformismi. Gli attori sono tutti di livello e guidati dalla sapiente direzione di scuola teatrale di Martone conferiscono ai personaggi forza e personalità: da Luigi Locascio a Valerio Binasco – straordinaria la sua caratterizzazione di Angelo, imbevuto di un fanatismo quasi religioso che lo vedrà, perfino davanti al confessore prima di salire sul patibolo a cui era stato condannato per aver partecipato all’attentato a Napoleone III, ribadire la sua intemerata e assoluta fede politica –, da Toni Servillo a Renato Carpentieri e Luca Zingaretti che interpretano, rispettivamente, Mazzini, Poerio e Crispi. La vicenda divisa in capitoli, scandita in azioni sceniche ribadisce gli ideali di quella generazione di patrioti, restituisce la febbrile atmosfera di quegli anni, non ritraendosi di fronte alle sgradevolezze e agli opportunismi, non omettendo le amarezze – pensiamo alle scene finali, all’arresto da parte dell’esercito regolare degli ultimi irriducibili ex garibaldini, o al discorso di un cinico Crispi in un Senato desolatamente vuoto -, non tacendo 102 le sconfitte degli ideali mazziniani e democratici. Un film di altri tempi, verrebbe da dire, un’opera che si propone anche una funzione pedagogica e riepilogativa della vicenda storica, in cui risulta evidente la lezione del cinema di Rossellini e di Visconti; ma anche una aggiornata rilettura del Risorgimento, affrontato senza orpelli celebrativi e trionfalismi in uno stile dove sono ben presenti le esperienze dei Taviani e di tutta quella filmografia “antiretorica” di cui abbiamo parlato in precedenza. Omaggi, richiami, citazioni che la critica non ha mancato di evidenziare, riconoscendovi quella giusta eredità di sangue simbolo di garanzia e marchio di qualità della migliore scuola italiana. Dunque, in conclusione, proprio quella cinematografia, che un tempo veniva definita d’autore, capace di produrre opere originali e mature in grado di coinvolgere il grande pubblico senza arrendersi alle logiche più condizionanti del mercato e del “politicamente corretto”, riafferma la sua vitalità riaprendo una pagina della storia che sembrava dimenticata. Sono i film come Noi credevamo – proprio in quanto risultato e rielaborazione di una cultura cinematografica solida che ha attinto alle esperienze precedenti – a ritrovare per incanto la funzione di testimoni permanenti di un’epoca: essi sembrano destinati a uscire dalla cronaca e a consegnarsi al tempo lungo della Storia. Proprio in quelle vicende e in quelle passioni raccontate nell’avventura risorgimentale, si cela l’identità a lungo sognata da quella “giovane Italia” e si rinnova il senso di una contemporaneità finalmente riscattata. Filmografia 1860 di Alessandro Blasetti (1934) Camicie rosse di Goffredo Alessandrini (1954) Senso di Luchino Visconti (1954) Il gattopardo di Luchino Visconti (1963) Viva l’Italia di Roberto Rossellini ( 1960) Allonsanfan di Paolo e Vittorio Taviani (1974) Bronte, cronaca di un massacro di Florestano Vancini (1972) Quanto è bello lu morire accise di Ennio Lorenzini ( 1976) Nell’anno del Signore di Luigi Magni (1969) In nome del papa re di Luigi Magni (1977) In nome del popolo sovrano di Luigi Magni (1990) Noi credevamo di Mario Martone (2010) 103 L’ITALIANITÀ DI ENRICO FERMI “A sinistra il professore Enrico Fermi all’epoca in cui venne nominato Accademico d’Italia. A destra un saggio poetico del professor Fermi quando era bambino. Si tratta di una poesia che egli compose quando aveva soltanto nove anni, e che prova i sentimenti di profonda italianità dell’uomo che avrebbe in seguito dato un decisivo contributo alla scoperta dell’energia nucleare”.* * Dalla rivista “Candido”, Memorie di Oscar D’Agostino, n. 24-27 giu.-lug. 1958 e Atomi in famiglia di Laura Capon Fermi, Ed. Mondadori, 1955. 104 VOCI E SCRITTURA SAGGI, RIFLESSIONI, TESTIMONIANZE. 105 106 L’ABRUZZO DALLA CARBONERIA ALL’UNITÀ di Evandro Ricci L’Unità d’Italia, di cui si festeggia il centocinquantesimo anniversario, è il coronamento di un complesso di avvenimenti storici che si sono susseguiti nel tempo. È come trovarsi di fronte ad un quadro pittorico del quale guardiamo l’insieme, dimenticando le singole e numerose pennellate. Così l’Unità d’Italia trova la sua base sui movimenti politici iniziati dal 1815 ed anche prima. Numerosi sono gli episodi che hanno contribuito alla realizzazione del quadro storico finale. La Storia, infatti, compresa quella del Risorgimento Italiano, è fatta anche di piccoli avvenimenti, perduti nella visione panoramica nazionale. Le Società Segrete Con la sconfitta di Napoleone Bonaparte, il Congresso di Vienna (novembre 1814-giugno 1815) segnò l’inizio della Restaurazione che comprese il periodo che va dal 1815 al 1830. Negli stati europei si restaurò il potere assoluto dei sovrani. L’Italia fu divisa in tanti Stati, che l’Austria dominava direttamente ed indirettamente. I Re e gli altri capi di Stato nominavano i deputati scegliendoli nella classe della nobiltà e del clero. Ma i popoli si erano imbevuti dell’abolizione dei privilegi della nobiltà, dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, della proclamazione – sia pure teorica – della sovranità popolare. La media borghesia, i piccoli industriali, i commercianti, i professionisti, i giovani, soprattutto gli studenti, erano desiderosi delle novità ed abbracciavano e manifestavano idee liberali. Questa classe intermedia, fra i grandi proprietari terrieri e l’aristocrazia da una parte ed il popolo minuto delle città e delle campagne dall’altra, valorizzata dalla Rivoluzione Francese e messa in disparte dalla Restaurazione, vedeva minacciati i princìpi dell’uguaglianza che era stata la più preziosa con- 107 quista. Era la parte più evoluta della popolazione, ma numericamente minore e mancava di una visione unitaria dei metodi e dei fini da conseguire. Fu questa classe che si oppose inizialmente agli Stati della Santa Alleanza. Fra il 1815 ed il 1830 in quasi tutti gli Stati d’Europa, dalla Spagna alla Russia, la Storia registra congiure, sommosse, insurrezioni, colpi di mano finalizzati a sovvertire la Restaurazione del Potere Assoluto stabilita dal Congresso di Vienna. Erano, infatti, sorte le società segrete – che possono essere considerate come ramificazioni della Massoneria nata in Inghilterra nel XVIII secolo e giunta presto in Francia, Germania e Italia – le quali rivendicarono con la Costituzione l’elezione da parte del popolo dei deputati al Parlamento, che avrebbe ridimensionato il potere assoluto dei Re. Il termine “popolo”, tuttavia, aveva un significato molto ristretto. Anche la parola “liberale” aveva un significato molto ristretto; ebbe origine in Spagna nel 1820 quando i rivoluzionari insorti definirono “liberali” coloro che anelavano alla libertà, in opposizione ai “servili” che appoggiavano il governo autoritario con potere assoluto. La società segreta più importante del Risorgimento Italiano fu la Carboneria. I Carbonari, dunque, erano per lo più intellettuali, militari, borghesi, rappresentanti del basso clero. La loro bandiera era composta dei colori rosso, nero e azzurro; il rosso simboleggiava il fuoco come amor di patria; il nero simboleggiava la fede perché, come il carbone, si accende ed arde; l’azzurro simboleggiava la speranza che si leva in alto come il fumo azzurro. Essi iniziarono ad operare fra le popolazioni rurali ed il popolo minuto delle città. L’ignoranza e l’analfabetismo chiudevano il popolo come in un guscio di fronte ad ogni progresso e ad ogni novità. Le popolazioni rurali dedite prevalentemente alle attività agricole lavoravano dall’alba al tramonto conducendo la lotta per la sopravvivenza. Furono le Società Segrete a preparare ed attuare i moti. Oltre alla Carboneria operante in Italia, altre società segrete furono la Lega della Virtù e la Lega Studentesca in Germania, la Società Patriottica Nazionale in Polonia, l’Eteria in Grecia. La Carboneria fu attiva nell’Italia Meridionale, in Calabria, segnatamente in Abruzzo, prima 108 che altrove, durante il Regno di Gioacchino Murat. I membri della Carboneria si chiamavano buoni cugini, i luoghi di riunioni baracche, le loro riunioni vendite. Le vendite facevano capo alle Vendite Madri, alle Vendite Alte e ad una Vendita Suprema. Nel linguaggio i lupi indicavano i tiranni, la foresta era l’Italia, il carbone simboleggiava la libertà. Inizialmente la Carboneria fu favorevole ai Borboni contro Gioacchino Murat nominato Re di Napoli da Napoleone Bonaparte nel 1808. Il Murat governò fino al 1815. Interessante è la Circolare Segreta che il Ministro della Giustizia e del Culto, a nome di Gioacchino Murat, emanò preoccupato del proliferare della Carboneria e dei suoi ideali antinapoleonici e antigovernativi: Gabinetto del Ministro – Circolare Riservata – Napoli il 6 Ottobre 1813. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia e del Culto agli Arcivescovi, a’ Vescovi, ed agli ordinarj, alcune adunanze, composte per la più parte, di uomini popolari, dette perciò de’ Carbonari, cominciarono, non da molto, a riunirsi in varj luoghi del Regno. Sua Maestà non credette vietarle, sì perché è proprio di un Governo liberale il non vietare a’ cittadini alcun’azione indifferente, sì perché l’oggetto di tali adunanze appariva non solo innocente, ma anche virtuoso. Ma qualche fatto criminoso avvenuto ultimamente ha fatto conoscere che taluni malintenzionati , ammessi a tali adunanze, ove il maggior numero è di gente ignorante e facile ad essere illusa, hanno abusato di questo mezzo per macchinare de’ complotti, tendenti a ladronecci, ad assassinj, a saccheggi di pubbliche casse. S.M. ha creduto perciò necessario proibire siffatte unioni, divenute, per la esposta circostanza, oltremodo perniciose. Io v’inculco di secondare efficacemente co’ mezzi della Religione le giuste mire del Governo, ispirando avversione alle suddette adunanze, ove le persone ignoranti, sedotte da qualche socio perverso, possono trovarsi impegnate in azioni vietate dalla Società, egualmente che dalla Religione. 109 Avvertite però di portare in questo affare la più grande riserva. Guardatevi di mai predicare contro le dette adunanze, o di fare in pubblico qualunque avvertimento. I mezzi da adoperare non debbono essere che esortazioni individuali, fatte in segreto, opportunamente, e con prudenza. Ingiungete lo stesso segreto, e la stessa condotta a’ Parrochi, ed a’ Confessori, che crederete abbastanza prudenti per esser chiamati a parte di questo incarico. Riscontratemi del recapito di questa mia, e di tutto ciò che di mano in mano potrà occorrere. Ogni rapporto su questa materia mi sarà diretto in plico risevato a me solo. Il Governo in questa occasione vi onora di una gran fiducia. Son certo che vi corrisponderete pienamente. Vi ripeto la mia perfetta stima. Segue firma illeggibile. La Carboneria propiziò la caduta del Re Gioacchino Murat con la speranza che i Borboni, riottenuto il Regno, concedessero anche a Napoli la Costituzione già data alla Sicilia nel 1812. Caduto Gioacchino Murat, la Carboneria si adoperò per ottenere la Costituzione, pur rimanendo fedele alla dinastia borbonica. Nel Lombardo-Veneto i Carbonari volevano riconquistare l’indipendenza ed abbattere il dominio dell’Austria. In Romagna volevano uno Stato Repubblicano. Inizialmente ottenevano i risultati prefissati, ma i risultati venivano cancellati con facilità e rapidità dall’arrivo dell’esercito austriaco che imponeva di nuovo la Restaurazione del Potere Assoluto. I principali esponenti della Carboneria insorti subirono condanne a morte, carcere duro a vita o l’esilio. Moti rivoluzionari in Abruzzo L’Abruzzo si era già distinto per ragioni strettamente sociali accanto alla fioritura culturale del Molise nella seconda metà del Settecento, allorché il Cuoco, il Galanti, lo Zurlo costituirono la linfa vitale della cultura nel riformismo borbonico e resero nota la situazione drammatica delle condizioni economiche e sociali del Regno di Napoli, del Molise e dell’Abruzzo in particolare. Senso di abbandono e miseria regnavano fra le nostre popolazioni. 110 Tale situazione aveva determinato l’esplosione della rivolta antifeudale di Penne nel 1779. I contadini di Antrodoco ed i montanari aquilani si erano opposti all’invasione francese nel 1798 e nel 1806. Con le stesse motivazioni sociali si verificò la rivolta a Vasto nel 1799. Un significato sociale e politico ebbero gli scontri armati condotti da Giovanni Salomone di Barisciano e dal capo massa, successivamente promosso generale, Giuseppe Pronio di Introdacqua contro i Francesi. Forse furono queste le ragioni per cui Gioacchino Murat non apportò tangibili benefici all’Abruzzo, se si eccettua la costruzione della strada Napoleonica da Pettorano Sul Gizio al Piano delle Cinque Miglia. I Francesi, per punire il Pronio, programmarono la distruzione di Introdacqua con un bombardamento. Raggiunsero la Conca Peligna; a Roccacasale ci fu uno scontro cruento con la popolazione e con le truppe del Pronio; rimase ucciso anche il parroco di Roccacasale. Il Generale francese Championnet giustificò il mancato bombardamento di Introdacqua con le difficoltà incontrate nel piazzare i cannoni. Ma il Pronio, di notte, aveva ordinato di accendere numerosi fuochi nel suo paese per far credere che disponeva di molte truppe realiste. La Carboneria si era fatta interprete della sofferenza politica e sociale durante il governo francesizzante e nel 1814 organizzò la rivolta che coinvolse i centri di Città Sant’Angelo, di Penne e di Castiglione Messer Raimondo. Nella rivolta si impegnarono i fratelli Domenico, Achille e Clemente De Caesaris. Ritroveremo Domenico De Caesaris, dell’Abruzzo Ultra, deputato al Parlamento del Regno delle Due Sicilie nel 1848 insieme con altri illustri personaggi. I Borboni, dopo la Restaurazione, mantennero la regione Molise; divisero l’Abruzzo in Citeriore con capoluogo Chieti ed Ulteriore con le Intendenze di Aquila e di Teramo. Nel 1807 la Badia Celestiniana di Sulmona fu destinata a Collegio degli Abruzzi che, nel 1816, fu trasferito ad Aquila. Nel 1812 si formò ancora a Sulmona una biblioteca pubblica presso il Palazzo Comunale che successivamente fu unita alla Biblioteca della Badia Celestiniana. Anche la Biblioteca fu trasferita a L’Aquila nel 1816. Ciò risulta in una monografia scritta dal sulmonese Panfilo Serafini, monografia da inserire nell’opera Il Regno delle Due Sicilie. Il Dorrrucci ed il Serafini, da Sulmona, operarono per il risveglio 111 delle coscienze e per la diffusione delle nuove idee liberali. Il Serafini fu condannato il 21 marzo 1854 a venti anni di carcere duro, prima nel bagno penale di Montefusco, poi nella fortezza di Montesarchio in provincia di Benevento che aveva “ospitato” Luigi Settembrini e Carlo Poerio, ed infine nel carcere duro di Procida. Fu graziato il 29 agosto del 1859, ammalato di tisi e distrutto nel fisico. Morì a Sulmona nel 1864 all’età di quarantasette anni. Il 14 gennaio 1817 fu istituito ad Aquila il Real Liceo Regionale affidato ai Gesuiti. Le scarsissime provvidenze ed il mancato sviluppo di attività industriali e delle opere pubbliche acuirono lo spirito liberale della nostra Regione. “Quelli che hanno creato – scrive Alfredo Sabella (Rivista Abruzzese Anno LXIV – 2011 – n. 1, p.11) – la passione civile per la Patria Italiana, ed hanno tessuto i fili sottili ma resistenti perché nascesse una nazione italiana, sono stati le maestre e i maestri delle scuole elementari. Con azione continua e costante hanno insegnato agli italiani a parlare in italiano, abbandonando i dialetti…. Hanno insegnato le buone regole del comportamento civile, le prescrizioni igieniche, la compostezza nel parlare, nel rispettare e nell’essere rispettati. Hanno contribuito a vivificare la pazienza della storia perché da un popolo disperso in tanti stati nascesse una nazione…”. Il Libro Nero Subito dopo il Congresso di Vienna che sancì la Restaurazione, anche il popolo dei piccoli paesi in Abruzzo sentì il richiamo della libertà. Lo attesta la presenza delle Vendite Carbonare in moltissimi paesi documentata dal Libro Nero degli ecclesiastici carbonari della Città e della Diocesi di Valva e Solmona. A Popoli si tenne un incontro al vertice regionale fra i capi Carbonari delle tre province di Chieti, Teramo e Aquila. Alla riunione, con il titolo di Grande Oratore, partecipò don Francescantonio Bucciantonj canonico della Collegiata di Capestrano e maestro della scuola elementare. 112 Le vendite carbonare non erano poi tanto segrete. Il Bucciantonj, infatti, come risulta testualmente dalla sentenza emanata dalla Curia di Sulmona nel Libro Nero, è stato uno dei primi membri della Carboneria di Capistrano. Egli ci ha avuto il grado di Oratore e, quindi, dichiarato Grande Oratore nell’Unione Carbonica tenuta in Popoli da Capi Carbonari delle tre province di Chieti, Teramo ed Aquila. Ha tirati poi moltissimi all’ascrizione della vendita di Capistrano, cosa riuscitagli facile per l’influenza che aveva colle diverse Famiglie, esercitando l’impiego di Maestro di Scuola (che gli è stato direttamente inibito dal Sig. Intendente). Ha indotti diversi Luoghi dentro, e fuori di quella Baronia ad aprire diverse vendite, e nell’apertura ha fatto gioco colla sua facondia per disporre, e determinare l’occorrente… Nella VALLE PELIGNA, questi furono i sacerdoti che organizzarono le Vendite Carbonare nei seguenti paesi: – INTRODACQUA: Vincenzo Crognale, Gianloreto Susi, Francesco Susii, Serafino Ferri, il novizio Nicola Centofanti; – PACENTRO: Eligio De Chellis, Marco Di Lorenzo, Biagio Di Lorenzo; – PENTIMA (CORFINIO): Pietro Fabrizii canonico della Cattedrale di Valva; – PETTORANO SUL GIZIO: Ignazio Cipriani e Gaetano Porreca; – POPOLI: Ernesto Zecca, Giuseppe Spallone, Albino Villa, Loreto Scala, Domenico Carusi, Giancamillo Paolini, Concezio Zugaro, Giovanni Gaetani, il novizio Francesco Mancini; – PRATOLA PELIGNA: Ignazio Colella che aveva fondato la vendita a Castel Del Monte, Giuseppe Santangelo, Nunzio Presutti, Salvatore Fabrizi, l’accolito Vincenzo Galli, il suddiacono Vincenzo Margiotti; – PREZZA: Alessandro Franceschelli; – RAIANO: Luigi De Crescentis; – ROCCACASALE: Luigi Scarpone; – ROCCAVALLEOSCURA (Roccapia): Michele Arcangelo De Meis; – SAN BENEDETTO IN PERILLIS: Lodovico De Berardinis; – VITTORITO: Filippo Leanalli, Carlo Filippo Di Cesare; – SOLMONA: Damaso Amata, Filippo Pallozzi, Camillo Colamaggiore, Francesco Aloè, Pelino Strozzi. 113 VALLE DEL SAGITTARIO: ANVERSA: Onorato Agnitti, Francesco Agnitti, Domenico Incorvati; BUGNARA: Francesco Agnitti, Gabriele Sarra; CASTRO (CASTROVALVA): Nunzio Lodovigo Di Vito forse solo sospettato; FRATTURA: Giacomo Falcone iscritto a Scanno e Gabriele Sarra iscritto a Bugnara; – SCANNO: Alessandro Abrami, Vincenzo Ciancarelli, Felice Ciarletta, Giacomo Falcone; – VILLALAGO: Valerio Pollidoro, Giuseppe Mancini. – – – – – – – – – – – – – – – – – – VALLE SUBEQUANA: CASTEL DI IERI: Donato Pasquale oratore nella vendita di Castelvecchio Carapelle e Pelino Strozzi cappuccino della SS.ma Annunziata di Sulmona; GAGLIANO ATERNO: Berardino Croce, Francesco Vacca; GORIANO SICOLI: Alessandro Paulucci, Benedetto Paulucci; SECINARO: Domenico Barbati, Nicola D’Abruzzo. VALLE DEL TIRINO e oltre: BUSSI: Alessandro Franceschelli, Arcangelo Francescantonio; CALASCIO: Alessio De Spinosa, Vincenzo Saverio Vespa, Giovanni Alesio Torsini, Giandomenico Frasca; CAPESTRANO: Francesco Bucciantonj che partecipò al summit regionale di Popoli; CARAPELLE: Gianandrea Trojani, il chierico Filiberto Costa; CASTELVECCHIO CARAPELLE: Donato Pasquale originario di Castel Di Ieri, Giammatteo Milani; CASTEL DEL MONTE: Ignazio Colella originario di Pratola, Francesco Corrado, Donato Corrado, Vincenzo Coletta; OFENA: Vincenzo Chiola, l’ex frate Arcangelo Francescantonio originario di Bussi; ROCCACALASCIO: Pietro Giustizia; SANTO STEFANO: Domenico Rosciolelli iscritto alla vendita di Calascio, Giuseppe Tatoni iscritto alla vendita di Barisciano. BARISCIANO: Giuseppe Tatoni. 114 ZONA DEL SANGRO: – GAMBERALE: Emidio Terreri; – PIETRANSIERI: il novizio Giuseppe Amoroso, Maurizio D’Amico; – PIZZOFERRATO: Michelangelo Malocchi col fratello e il nipote, Marcantonio Coccia; – QUADRI: Ismaele Vizioli; – ROCCARASO: Epifanio Ferretti, Nicola Onofrii; – SCONTRONE: Feliciano De Felicis originario di Bugnara, Domenico Tiritilli. Le vendite carbonare erano ben note fra le popolazioni dei singoli paesi. Erano capeggiate dai sacerdoti che ne ricoprivano le varie cariche a partire dal semplice Ascritto (iscritto) al Convisitatore, all’Apprendente, al Partecipante, al Partecipante oratore, all’Oratore, al Segretario, al Conservatore del Bollo e del Registro, al Tesoriere, al Cassiere, al Supplente del Grande Oratore, al Grande Oratore, al Maestro Provvisorio, al Maestro di Cerimonie, al Maestro Oratore, al Supplente Maestro, al Vice Responsabile, al Vice Presidente, al Maestro, al Primo Assistente, al Mansionario Onorario, al Capo, al Gran Maestro, al Presidente e al Gran Maestro. Nel 1821 la Curia del Vescovado di Valva e Solmona fu molto attiva nel processare e condannare i sacerdoti carbonari. Le condanne erano varie. Il sacerdote veniva “sospeso dalla confessione”, “sospeso”, “sospeso a divinis”, “sospeso a divinis officiis”, “mandato agli esercizi”, “mandato ad un Convento”. La condanna di “sospeso dalla confessione” ovvero “sospeso dalla confessione in perpetuo” significava che la sospensione si limitava al sacramento della confessione ed a tempo indeterminato, salvo altra dicitura specificata. La condanna di “sospeso” ovvero di “sospeso a Divinis” o anche “sospeso a divinis Officiis” significava che il sacerdote veniva sospeso da tutte le funzioni sacre sacerdotali a tempo indeterminato, salvo diversa indicazione specificata. La condanna di “mandato agli esercizi”, da intendere “mandato agli esercizi spirituali”, significava che il sacerdote condannato avrebbe dovuto meditare sulla sua vita e in particolare sulla sua attività di 115 carbonaro per “ravvedersi” e pentirsi al fine di essere reinserito nelle sue attività missionarie sacerdotali. La condanna di “mandato al Convento di…” significava che il sacerdote veniva “condannato alla clausura nel Convento di…” Molti Conventi, infatti, svolgevano la funzione di carcere clericale dove venivano relegati i sacerdoti a tempo indeterminato, cioè all’ergastolo: il Convento dei Cappuccini, il Convento dei Filippini, ed il Convento dei Padri Riformati di Sulmona; il Convento dei Cappuccini ed il Convento dei Padri Riformati di Raiano; il Convento dei Cappuccini di Pacentro; il Convento degli Osservanti di Calascio; il Convento di San Giorgio di Goriano Valli; il Convento dei Padri Riformati di Capestrano; il Convento dei Padri Osservanti di Palena; il Convento della Maddalena di Castel di Sangro; il Convento dei Cappuccini di Ofena. Moti carbonari abruzzesi Organizzati dai Carbonari abruzzesi vi furono i moti del 1831 ad Amatrice e del 1833 ad Aquila capeggiati dai mazziniani Pietro Marelli ed Angelo Pellegrini. Nel 1837 ancora Penne, pur colpita dal colera, si sollevò e subì una dura repressione. Nel 1841 anche Aquila si sollevò agli ordini del mazziniano Luigi Falconio; questo moto implicò anche il Marchese Luigi Dragonetti che nel 1848 divenne Ministro degli Esteri nel Governo presieduto da Carlo Troya. Il 7 ed 8 maggio 1848, a Pratola Peligna, i contadini si ribellarono con violenza, con conseguenti riflessi sanguinosi. Doverosamente ricordiamo i rivoluzionari di Introdacqua: Croce Susi, Emanuele D’Eramo, Concezio D’Eramo, don Serafino Ferri, Giambattista Rubimarga, Emilio Mampieri e i fratelli Gaetano e Raffaele Tiberi. Croce Susi, nella sede comunale, con un bastone ruppe la testa della scultura rappresentante il Re di Napoli; per tale gesto fu subito imprigionato, dopo qualche mese seguirono la stessa sorte don 116 Serafino Ferri ed Emanuele D’Eramo. Croce Susi fu processato a L’Aquila il giorno 11 dicembre 1849 dalla Gran Corte Speciale e l’11 dicembre fu condannato a otto anni di relegazione nell’isola di Ventotene ed a pagare le onerose spese di giudizio. I deputati abruzzesi eletti il 1° maggio 1848 furono: – per l’Abruzzo Citra con capoluogo Chieti: De Thomasis Vincenzo, Luigi Cadorna, Goffredo Sigismondi, Silvio Spaventa, Domenico Pugliesi, Giustino Consalvi, Marino Turchi, Angelo Camillo De Meis; – per l’Abruzzo Ultra Primo con capoluogo Teramo: Clemente Belisario, Domenico De Cesaris, Giuseppe De Vincentiis, Michelangelo Castagna, Francesco De Blasis; – per l’Abruzzo Ultra Secondo con capoluogo Aquila: Pier Silvestro Leopardi, Luigi Dragonetti, Giuseppe Pica, Salvatore Tommasi, Enrico Berardi, Gaetano Giardini, Antonio Ferrante, Leonardo Dorotea, Leopoldo Dorrucci di Sulmona e Goffredo Sigismondo sulmonese ma nativo di Bomba, come lo Spaventa; – per la Regione Molise furono eletti: Gabriele Pepe, Martinangelo De Martino, Nazaro Colaneri, Domenico Trotta, Jacampa Lorenzo, Ferdinando Connavino, Michele Cremonese, Nicola De Luca, Stefano Jadopi. Annullate le elezioni del 1° maggio, il 14 giugno si ripetettero e furono confermati gli stessi eletti del 1° maggio. I moti rivoluzionari abruzzesi avvennero parallelamente ai grandi moti carbonari nei vari Stati in cui era divisa l’Italia. Il 1 luglio 1820, a Nola, i sottotenenti Morelli e Silvati, con il loro squadrone della cavalleria, marciarono su Avellino per poi proseguire verso Napoli appoggiati dal maggiore De Conciliis. Ai rivoltosi si aggiunsero le truppe comandate dal generale Guglielmo Pepe. Il Re Ferdinando I concesse la Costituzione. L’Austria spedì subito un esercito di centomila soldati che, ad Antrodoco, annientò la labile difesa offerta da Guglielmo Pepe. L’esercito austriaco attraversò le terre aquilane e peligne, risalì la Strada Napoleonica e piombò sulla Campania disperdendo le truppe del generale Carascosa schierate sul fiume Garigliano. 117 Ferdinando I rientrò a Napoli il 23 marzo 1821, abolì la Costituzione e compì le sue vendette. Il Risorgimento, nei suoi motivi profondi e nel suo universale senso umano, fu assai più una conquista di spiriti che una conquista di armi. La forza delle armi vi ebbe una parte secondaria perché le schiere che affrontavano le battaglie in campo aperto erano (come i Mille ed i giovani studenti toscani) volontari seguaci di un’idea e spesso erano quasi inermi. Fu più una storia di idee e di anime che una storia di battaglie, più martirologio e proselitismo che politica e strategia. Queste ultime sopravvennero con Cavour e con Vittorio Emanuele II, dopo l’impresa dei Mille di Garibaldi. Ora si sta cercando di rompere l’Unità nazionale, tanto faticosamente raggiunta, con una legge tanto discutibile quanto infausta. C’è chi vilipendia la bandiera nazionale, chi si allontana durante l’Inno Nazionale, chi disdegna di essere italiano. Saranno stati vani i sacrifici, i morti, le stragi, il tanto sangue versato per una causa così alta, per l’ideale di uno Stato uno, libero, indipendente? Bibliografia E. Ricci, La Carboneria in Abruzzo e le Vendite Carbonare nei paesi della Diocesi di Valva e Sulmona, Tipolitografia “La Moderna”, Sulmona 1991; Tiberio Menin, Atlante storico volume III, Minerva Italica, Bergamo 1968; Tuttitalia Enciclopedia dell’Italia Antica e Moderna, Abruzzo e Molise, Edizione Sadea Sansoni, Firenze 1965; Nuova Enciclopedia, Editrice Italiana di Cultura, Roma 1963; Franco Cercone, Abruzzo Terra di briganti, Edizione Quale Vita, Torre dei Nolfi 2006; Berardino Ferri, Un processo alla Gran Corte Speciale del 2° Abruzzo Ulteriore, Tipolitografia “La Moderna”, Sulmona 2001. 118 SALVATORE TOMMASI SCIENZIATO E PATRIOTA ABRUZZESE1 di Evandro Gay Salvatore Tommasi nacque il 26 luglio 1813 a Roccaraso, dove il padre, originario di Accumoli (Teramo), era stato trasferito come segretario comunale. Prima frequentò in Ascoli Piceno il Seminario, da dove fu espulso per aver partecipato a manifestazioni patriottiche, poi fu allievo del Liceo dell’Aquila e studente universitario a Napoli, dove conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1838, a venticinque anni. Dopo solo sei mesi gli fu affidata la seconda cattedra di clinica medica nella medesima università Federiciana, nella quale fu apprezzato docente fino al 1848, quando fu esiliato per motivi politici. Nello stesso anno sedette al Parlamento, quale rappresentante dell’Aquila. Il 10 febbraio 1848 Ferdinando di Borbone, re delle Due Sicilie, aveva concesso e giurato la Costituzione, ma il 15 maggio di tale anno le truppe regie aprirono il fuoco contro il popolo che manifestava per le strade: e fu una strage. Invano i ministri Conforti e Dragonetti scongiurarono il Re di far cessare il fuoco, anzi gli stessi deputati, riunitisi a Monteoliveto, furono aggrediti. Fu allora che Salvatore Tommasi sottoscrisse la “Protesta contro un atto di cieco dispotismo”, redatta da Pasquale Stanislao Mancini. Questo gli costò l’arresto insieme ad altri ventimila napoletani e la sua traduzione notturna al carcere di San Francesco, nella stessa cella di Silvio Spaventa. Poi prese la via dell’esilio, prima a Genova e poi a Parigi, Londra e Torino. Nel 1859 fu nominato professore all’Università di Pavia e come medico prestò la sua opera professionale anche nella battaglia del Ticino. Nel 1860 il “Grande Tessitore”, Camillo Benso, Conte di Cavour, prevedendo l’arrivo di Garibaldi e ancor più temendo l’arrivo di Giuseppe Mazzini a Napoli, inviò i suoi migliori uomini per preparare l’annessione al Regno. A metà luglio partì Silvio Spaventa, 01 Fonte: provinciaoggi, luglio-dicembre 1988. 119 che era professore all’Università di Modena, e il 13 agosto era a Napoli anche Salvatore Tommasi, che lì si unì con l’altro emigrato politico abruzzese Pier Silvestro Leopardi, deputato di Sulmona. Entrambi erano stati naturalizzati, diventando in tal modo cittadini piemontesi, e godevano di guarentigie in caso di arresto. Cavour aveva detto: “Annessione per acclamazione di popolo prima di Garibaldi, perché se egli arriva a Napoli con a fianco il Bertani l’annessione sfugge”. Tommasi scriverà a Cavour che a Napoli si attendeva Garibaldi con ansia ed entusiasmo e che da lui dipendeva tutto. Si formarono allora a Napoli due comitati, uno monarchico e l’altro repubblicano, ed entrambi decisero di inviare legazioni a Garibaldi per l’adesione al loro programma. Il generale, perciò, viene conteso al suo arrivo a Napoli. Il 7 settembre Pier Silvestro Leopardi ricevette il seguente telegramma: “Alle 10 saremo a Napoli, fate trovare alla stazione dieci cavalli da sella e una carrozza. Firmato Gizio”. Sotto lo pseudonimo di Gizio si nascondeva Salvatore Tommasi, che usò la denominazione del fiume omonimo, che bagna Pettorano, patria di sua moglie. E questo Leopardi lo sapeva. Però Garibaldi sceso dal treno fu prelevato dai repubblicani, che lo portarono alla foresteria, ove era la loro sede. L’aggancio col generale, pertanto, non riesce, con disappunto di Cavour. Intanto a Napoli giunge un battello proveniente da Marsiglia, pieno di repubblicani, comandati da Mazzini e da Aurelio Saliceti, abruzzese di Ripattoni, in provincia di Teramo, con a bordo tra gli altri Crispi, Saffi e Dumas. A Napoli si attende anche l’eroe ungherese Cossuth. Nel frattempo l’esercito piemontese, dopo la caduta di Ancona il 29 settembre 1860, è fermo sul fiume Tronto. Il Grande Tessitore allora ordisce un’altra trama. Bisogna raccogliere adesioni dei Comuni dell’Abruzzo alla nuova monarchia. Il Re Vittorio Emanuele deve entrare in Abruzzo perché chiamato dai municipi, dal popolo. Salvatore Tommasi viene incaricato di questa importante missione dal Comitato dell’ordine. In una lettera a Luigi Farini del 25 settembre 1860 dichiarava: “Io sto viaggiando gli Abruzzi dì e notte a palmo a palmo e vago nei singoli municipi e bisogna esser pronti a maneggiare il revolver per non essere sopraffatti”. A Napoli intanto si costituisce un Comitato di Salute Pubblica e Cavour è disperato perché teme una spedizione dei mille alla rovescia. 120 Ordina allora al Comandante di Genova di vigilare su tutti i porti, perché è possibile uno sbarco di Garibaldi. Urge che l’esercito si muova dal fiume Tronto. Il 2 ottobre telegrafa a Farini, il ministro che accompagna il Re: “Urge andare a Napoli!” Il 3 e il 4 ottobre altri due telegrammi di sollecito, il 5 ottobre un dispaccio, scritto in francese: “Per l’amor di Dio! Affrettate la vostra entrata negli Abruzzi”. Il motivo della prolungata sosta in riva al Tronto era chiaro: Vittorio Emanuele attendeva Salvatore Tommasi con gli indirizzi al re da parte delle municipalità abruzzesi, per giustificare dinanzi all’Europa tutta il suo ingresso nel Regno. Finalmente il 7 ottobre Salvatore Tommasi giunge in Ancona e alle ore 12, all’uscita dalla Messa di Vittorio Emanuele, consegna 280 delibere di annessione. “Bravo Tommasi!”, gli dice il Re, “questo giustifica il nostro passaggio”. Poi lo fece nominare Colonnello di Stato Maggiore e in divisa da colonnello lo volle accanto a sé nella carrozza reale e, visto da tutti, l’abruzzese Tommasi, naturalizzato piemontese, attraversò i paesi abruzzesi al fianco di Sua Maestà. Compiuta la missione affidatagli, Tommasi ritornò alla sua tranquilla Pavia, dove riprese le lezioni e gli studi. Nell’elezione del Primo Parlamento nazionale del 27 gennaio 1861 fu eletto deputato nel collegio di Cittàducale, allora in provincia dell’Aquila, però non sedette alla Camera. Vigeva allora la legge secondo la quale gli stipendiati dello Stato non potevano superare un decimo del numero dei deputati e Salvatore Tommasi non fu favorito dal sorteggio. Però il Re, memore della sua assoluta dedizione alla patria, lo nominò nel 1864 Senatore a vita. Morì a Napoli nel 1888 e al Senato del Regno fu ricordato con queste parole dal senatore Moleschott: “Dotto senza toga, professore senza boria, medico senza imposture, filosofo senza credersi infallibile, senatore di poca parola, eppure potente nell’affermare, sapiente senza scoramenti, Salvatore Tommasi era savio, forte e buono”. A lui nel 1883, quando era ancora in vita, i quaranta reggitori della Provincia dell’Aquila vollero intitolare la Biblioteca Provinciale, anche nota come “Tommasiana”. In seguito la città di Sulmona gli intitolò la piazza antistante la Biblioteca Comunale. 121 122 E. Gamba (Torino 1831-1883), Il voto di annessione dell’Abruzzo, Genova, Galleria d’Arte Moderna, tratto da “Dal Tronto al Sangro”, a cura di Ezio Mattiocco. A PROPOSITO DELLE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA di Rosa Giammarco Molto si è detto e scritto sugli eventi nazionali che hanno caratterizzato l’Unità d’Italia, poco è stato riportato sugli accadimenti “locali” e sull’apporto di territori, malamente considerati “minori”, che pure hanno contribuito a fare la storia d’Italia. In questo senso l’ Abruzzo ha ancora bisogno di conoscersi per farsi conoscere ed entrare meglio nel contesto della coscienza civile attraverso la rivalutazione delle attività e delle gesta compiute. L’Abruzzo vuole che si riscopra il suo ruolo, un ruolo né incidentale né minore che si inserisce con momenti fondamentali nella realizzazione dell’Unità d’Italia. Per questo motivo la Regione, partecipando al XXIV Salone Internazionale del Libro svoltosi a Torino dal 12 al 16 maggio 2011, con lo slogan “Abruzzo, crocevia dell’Unità d’Italia. Storia, cultura, valori e personaggi”, ha voluto far conoscere il notevole contributo dato. Sono stati presentati ed illustrati importanti documenti, fatti e personaggi, a testimonianza del significativo ruolo svolto. In particolare il Prof. Francesco Sabatini, Presidente Emerito dell’Accademia della Crusca, ha richiamato l’attenzione su tre documenti storici che provano il contributo dato dal Centro Abruzzo al Risorgimento: a) la lettera a stampa che Antonio De Nino di Pratola Peligna indirizzò il 1° ottobre 1860 “alla gente della campagna” per avvertirla della possibilità di “liberazione dalla sua secolare ignoranza”; b) i disegni patriottici che il Parroco di Pescocostanzo intercalò “agli atti di nascita registrati nel Libro parrocchiale della sua comunità dal 1862 al 1872”; c) una tela recentemente scoperta dal Prof. Sabatini ed esaminata dallo storico d’arte Vittorio Casale, che “il pittore piemontese Enrico Gamba istoriò, già nel gennaio 1861, per ricordare, lì in Piemonte, proprio il “Plebiscito d’Abruzzo”. 123 Su quest’ultima scoperta c’è stata molta attenzione. Il dipinto “Il voto di annessione dell’Abruzzo” (Torino 1831-1883) - Genova, Galleria d’Arte Moderna (tratto da “Dal Tronto al Sangro”, a cura di Ezio Mattiocco e promosso dalla Deputazione di Storia Patria e dall’Università Sulmonese della Libera Età - Casa Editrice Colacchi) è opera di un pittore torinese, Enrico Gamba, stretto collaboratore della corte sabauda. Rappresenta, su uno sfondo dove spicca maestosamente il Gran Sasso (riconoscibile il Grande Corno) il momento in cui gli abruzzesi, scheda in mano, si recano a votare. È raffigurato un variopinto corteo composto da una schiera di popolani, borghesi, aristocratici e clero che vanno a votare per il plebiscito consentendo a Cavour di compiere quell’operazione diplomatica e militare affinché Vittorio Emanuele II potesse varcare il Tronto (il nuovo Rubicone d’Italia). Sono riprodotti: due suonatori di cornamuse, un contadino a cavallo nell’atto di togliersi il cappello in ossequio alla bandiera con lo stemma dei Savoia, un gruppo di paesani, tra i quali si evidenziano tre rappresentanti dell’aristocrazia con il cilindro in testa, della borghesia con la bombetta, e del clero, un bambino ed un cane, che seguono il portabandiera, quattro giovani esultanti nell’atto di cantare, un pastore riconoscibile dal suo abbigliamento, un baroccio trainato da due buoi sul quale appaiono distesi altri contadini, e da un uomo che innalza un ritratto abbellito con ramoscelli d’olivo probabilmente inneggiante a Vittorio Emanuele II. Sulla strada in percorrenza, di fianco, una viandante, una figura femminile, che “addita” il corteo ad una bambina. Tutti gli elementi riportati nel quadro testimoniano l’ambito regionale nel quale l’azione si svolge, dall’ambientazione, ai caratteristici cappelli, alle “cioce” calzate e ai mantelli sdruciti. Spicca, con maggiore luce, la figura femminile. Quale significato attribuire a questa presenza? Al plebiscito potevano votare solo gli uomini, le donne erano fuori da questo diritto riconosciuto successivamente, ma questa donna è presente ed ha un ruolo illuminante. E a questo proposito il Prof. Sabatini ha ricondotto tale figura sí al costume abruzzese ma più precisamente al costume di donna di Pettorano sul Gizio. Tale accostamento, condiviso da Walter Capezzali, Presidente della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi, è rafforzato, oltre che dalla foggia del vestire così simile a quella del costume pettoranese, dall’omaggio che probabilmente il 124 pittore piemontese, visto che entrambi erano legati alla monarchia sabauda, ha voluto fare a Salvatore Tommasi, figura di spicco della cultura medico-scientifica del secondo Ottocento e protagonista cruciale nel processo di unificazione dell’Italia, sposato con la patriota Emilia Organtini, pettoranese, figlia di Francesco Saverio Organtini e di Margherita Bonitatibus, già morta in quella data. Altra ipotesi è che sia stato lo stesso Salvatore Tommasi a commissionare il quadro. Comunque sia è una stupenda rappresentazione di una pagina dell’epopea del popolo abruzzese e noi non possiamo che ringraziare sentitamente chi ci ha permesso di conoscerla, Ezio Mattiocco, Francesco Sabatini e Walter Capezzali. 125 126 L’ABRUZZO E L’UNITÀ D’ITALIA di Licia Mampieri La storiografia nazionale spesso ha trascurato aspetti ritenuti secondari nel complessivo contesto della unificazione del nostro paese, finendo in tal modo per fare un pessimo servizio ad una serena valutazione di quell’evento storico che ha riunito un territorio diviso fin dalla caduta dell’impero di Occidente. Il compiersi dell’evento unitario è da ricomporre in un succedersi di accadimenti politici e bellici che, a livello nazionale e regionale, hanno segnato il cammino della storia di 150 anni fa. Era il 1860 e nei pochi mesi dalla spedizione di Garibaldi da QuartoGenova alla discesa del Re Vittorio Emanuele a Caianello per incontrare il condottiero vincitore dal Regno delle due Sicilie, vi fu un susseguirsi di eventi che coinvolsero tutti i protagonisti del Risorgimento. La realtà preunitaria del Regno di Napoli comprendeva sei regioni, in cui una eletta schiera di liberali si muoveva nel senso di favorirne l’annessione al Regno di Sardegna. Ma il popolo ne era convinto? I Borboni sapevano farsi amare dal popolo, ma la borghesia colta era consapevole che il loro regno stava per crollare sotto la spinta di quei patrioti, soprattutto mazziniani, che volevano sì l’unità di Italia, ma sotto la bandiera repubblicana. La vita del Regno delle due Sicilie sino alla sua caduta ruotava intorno alla sua capitale, Napoli, ove l’Università Federico II, in tutte le sue discipline – soprattutto giurisprudenza e medicina – costituiva un punto di riferimento importante per tutto il paese. L’Abruzzo, dopo i moti del 1799, quando il Generale Giuseppe Pronio aveva sconfitto i francesi invasori ed i loro simpatizzanti, contribuendo in modo decisivo a riportare sul trono di Napoli Re Ferdinando, era tornata una terra relativamente tranquilla, anche se cellule carbonare cospiravano a L’Aquila ed altrove contro lo Stato borbonico. È così che dopo l’arrivo di Garibaldi, il 3 ottobre 1860, Napoli era ribollente di sentimenti contrastanti con tentazioni disgreganti e cospicue derive. Ed a Napoli era presente già il Comitato di azione di Giuseppe Mazzini per preparare la Repubblica. È in questo contesto che, mentre il Re e lo Stato Maggiore erano fermi ad Ancona, si attivò Salvatore Tommasi, medico e patriota. 127 Salvatore Tommasi era nato a Roccaraso il 26 luglio 1813 e morì a Napoli il 18 luglio 1888. Gli studi classici e la passione per la medicina lo portarono a divenire Docente all’Università di Pavia, ma il richiamo patriottico lo vide Deputato al Collegio di L’Aquila nel 1848 e deputato alla prima Camera italiana nelle elezioni del 27 gennaio 1861 per il Collegio di Cittàducale. Noi lo ricordiamo per la sua opera di mediazione con il primo Ministro Cavour ed il Ministro Farini, in quell’ottobre 1860, per convincere il Re ad attraversare il Tronto e recarsi a Napoli. È in questo periodo che il Conte di Cavour mise in atto tutta la sua diplomazia per creare le condizioni ottimali perché il Re si recasse a Napoli ed incontrasse Garibaldi. Sin dalla fine di settembre Cavour cominciò a telegrafare al Ministro Farini, che accompagnava il Re. I dispacci erano tutti in francese. Scriveva Cavour “Il faut sans perdre de temps diriger des troupes vers la frontière” ma tra il politico che voleva raggiungere subito il risultato e lo Stato Maggiore del Re, che era incerto e temeva il rischio di reazioni e rischio di conflitto, vi fu l’opera di Salvatore Tommasi che, come si legge dai telegrammi del Gover-natore Papa dell’Aquila, iniziò quella “santa missione” negli Abruzzi ed in Terra di Lavoro per raccogliere adesioni per l’annessione al Piemonte. È così che l’Abruzzo svolse un ruolo non secondario nei giorni cruciali per l’unità di Italia. I generali dello Stato maggiore aspettavano il sì delle popolazioni, ed il Re non voleva urtare le diplomazie europee che sino ad ora erano state acquiescenti verso l’azione del Piemonte. Tommasi, come lui stesso dirà, “andò viaggiando l’Abruzzo dì e notte” mentre il Re era fermo e titubante in Ancona. Finalmente il 7 ottobre 1860 il Re ricevette ad Ancona Salvatore Tommasi, lo ringraziò per l’opera svolta e lo invitò ad accompagnarlo oltre il passaggio del Tronto, inserendolo quale addetto allo Stato Maggiore. Vi è tutto uno sprone in quei giorni, ed un modo di dire: il Tronto come il Rubicone! E Cavour che il 5 ottobre manda un dispaccio al Ministro Farini, in cui scriveva: “… Fate entrare il Re in una città qualunque, e chiami Garibaldi a sé, lo magnetizzi e lo rimandi alla Caprera su di un vapore datogli in dono”. Vittorio Emanuele il 15 ottobre 1860 passò il fiume Tronto che segna il confine tra le Marche e l’Abruzzo e lo stesso giorno era a 128 Giulianova. Finalmente gli indugi erano stati sconfitti, anche su pressioni di Cavour che in un suo dispaccio in quei giorni telegrafava: “Maestà! Il passaggio del Tronto è più importante del Ticino del 1848”. Il 16 ottobre il Re giunse a Castellammare ed il 17 a Pescara dove visitò la Fortezza borbonica. Il giorno 19 ottobre fu a Chieti ed il 20 a Tocco da Causaria ed a Popoli. Nello stesso giorno il Re proseguì per Sulmona. Qui è bene riportare quanto riferito nell’opera di Raffaele De Cesare La fine di un regno: Dopo Popoli proseguì per Sulmona, si partì da questa città all’indomani. Il re passò sotto un grande arco di trionfo e andò alla chiesa di S. Panfilo dove fu ricevuto dal vescovo Mons. Sabatini, che intonò il Te Deum. Rimontato a cavallo attraversò la città. Tra nembi di fiori, cartelloni tricolori e grida esultanti. Arrivò alla sott’intendenza e ricevé le autorità. Nella sala maggiore vi era stato eretto un trono e posta su di esso una corona del valore di 12.000 ducati, fatta venire da Pescocostanzo e di proprietà di quella Chiesa parrocchiale. A Sulmona il Re fu ospite nella villa degli Orsini, sontuosamente addobbata. Il seguito alloggiò nella storica Badia del Morrone di Celestino V, allora ospedale militare. Villa Del Basso-Orsini è ancora oggi proprietà dei discendenti della famiglia gentilizia ed ancora oggi una targa in camera da letto ricorda il soggiorno del Re. Il 21 ottobre 1860 il Re arrivò a Castel di Sangro, dove ebbe notizia ufficiale degli esiti favorevoli del Plebiscito che vi era stato in tutte le Regioni dell’ex Regno di Napoli. Il 26 ottobre 1860 a Caianello avvenne lo storico incontro con Giuseppe Garibaldi. Poi il Re proseguì per Napoli. Nei giorni precedenti furono scambiati vari dispacci telegrafici tra Garibaldi, il Generale Cialdini ed il Governatore di Teramo. In uno di questi dispacci Garibaldi telegrafava di voler accogliere “i piemontesi come fratelli”. Ma sin da allora lo stesso Cavour già era prevenuto nei confronti del popolo dell’ex Regno di Napoli. Lo definì in un dispaccio “accozzaglia di gente” ed impose di distruggere l’azione mazziniana. Temeva soprattutto le gole di Popoli che erano tenute dalle truppe garibaldine del mazziniano Pateras. L’idea-guida di Cavour era che Vittorio Emanuele 129 dovesse divenire Re d’Italia in Abruzzo, prima che dieci anni dopo fosse proclamato Re d’Italia dal Parlamento in Campidoglio. L’Unità d’Italia, per noi abruzzesi, cominciò con la piemontesizzazione determinata e feroce. Determinata nell’imporre una legislazione complessivamente diversa dall’amministrazione dei Borboni, che se pur paternalistica, era accettata dalla gente; feroce, in quanto la repressione contro i realisti, considerati semplicemente briganti, diede corso ad una vera e propria guerra civile con massacri di uomini, donne e bambini, incendi di paesi e fattorie, incarceramenti e persecuzioni. Da quella vera e propria guerra mossa dai piemontesi cominciò la grande migrazione verso le Americhe delle popolazioni abruzzesi e meridionali, anche per sfuggire ad un’indegna miseria. Le Regioni meridionali e l’Abruzzo, sottomesse ma non piegate, aspettano ancora dallo Stato unitario giustizia e verità. Pier Silvestro Leopardi Oltre a Salvatore Tommasi ebbe rilievo, per l’Abruzzo e per Sulmona in particolare, Pier Silvestro Leopardi. Nato ad Amatrice il 31 dicembre del 1797 (oggi Rieti), nella provincia aquilana, Leopardi a sedici anni combatté contro Gioacchino Murat, nel 1821 fu Ufficiale nello Stato Maggiore del Generale Pepe. Imprigionato nel 1933, fu mandato in esilio. Si recò a Parigi ove collaborò con vari giornali e tradusse in francese le opere di Balbo, Gioberti e Massimo D’Azeglio. Nel 1848 ritornò in Patria e fu nominato dal Governo del Re di Napoli plenipotenziario presso il Regno di Sardegna e successivamente presso la Confederazione Svizzera. Venne anche eletto deputato al Parlamento del Regno delle due Sicilie. Alla restaurazione fu imprigionato per quattro anni e poi ancora esiliato. Noi lo ricordiamo in quanto nel 1861 venne eletto Deputato di Sulmona al primo Parlamento italiano, che corrispondeva alla VIII Legislatura del Regno di Sardegna. Alla Camera dei Deputati militò nelle file dei Conservatori. Nel 1865 fu nominato Senatore del Regno. Quando la capitale da Torino si trasferì a Firenze, la morte lo colse nella città toscana il 14 luglio 1870. 130 La sua attività parlamentare fu molto assidua e tante sono le petizioni e le prese di posizione in ordine ai diversi e svariati problemi inerenti il giovane regno d’Italia. Nel volume di Alberto Malatesta del 1946, che riporta l’indice di Ministri, deputati e senatori dal 1848 al 1922, il Leopardi è citato in tutta la sua ricca attività di deputato. Egli propone un ordine del giorno in seguito alle numerose interpellanze intorno all’amministrazione delle province dell’ex Regno di Napoli e della Sicilia, interviene nella discussione di un progetto di legge per l’abolizione dei vincoli feudali, si occupa di contribuire alla istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico, dopo l’unificazione dei debiti dello Stato unitario. Quello che più ci riguarda da vicino come regione Abruzzo, fu la sua determinazione nel caldeggiare la costruzione della strada ferrata da Napoli all’Adriatico, seguendo anche con emendamenti appropriati il progetto. La ferrovia Napoli-SulmonaPescara c’è ancora, anche se l’orientamento della gestione delle ferrovie, con molta miopia, è sempre quello di ridurne le corse o addirittura sopprimerle. La Rivista “L’illustrazione italiana” del 1911, in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia, cita il deputato Pier Silvestro Leopardi, unitamente a tutti gli altri deputati del primo Parlamento nazionale del Regno d’Italia, ricordandone meriti e virtù. Il Leopardi fu un patriota e contribuì alla nascita del Regno d’Italia, anche se lungo il corso della sua vita pubblica fu spesso combattuto tra il lealismo verso i Borboni e l’aspirazione ad unificare l’Italia. Giuseppe Tamburrino – l’ultimo dei briganti Grande impatto emotivo ebbe nell’immaginario collettivo abruzzese Giuseppe Tamburrino, figlio di Venanzio e di Agnese Ferri, che avviò, suo malgrado, la “carriera” di brigante quando, come narra mio padre, nel 1848, mentre acquistava del tabacco in una rivendita di sale e tabacchi in paese, si imbatté col sergente della Gendarmeria borbonica Remigio Ferri, il quale gli pestò a bella posta un piede. Ne nacque un tafferuglio e Ferri fu steso a terra dal Tamburrino che era alto quasi due metri ed aveva una forza erculea. Tamburrino fu tratto in arresto e 131 tradotto nel carcere di Introdacqua. Nella stessa notte egli forzò la porta del carcere ed evase. I miei ricordi sulla figura e le gesta di Giuseppe Tamburrino, ultimo brigante di Introdacqua, risalgono al tempo della mia infanzia, quando mio padre, prima di emigrare in Venezuela, mi raccontava di questo brigante altissimo, con una folta barba, che aveva conosciuto da ragazzo nel primo decennio del Novecento, quando egli, ormai libero e molto anziano, si sedeva dinanzi alla cantina di Consolata, ad Introdacqua, a raccontare la sua storia. Allora, in vecchiaia, era solo Zi Peppuccio, e si era talmente affezionato a papà che gli regalò il suo bastone di ulivo, dritto e nodoso, con la punta in ferro. Il bastone rimase sempre nella casa paterna anche quando mio padre era all’estero, ma dopo la sua morte mia sorella Maria se ne impossessò, e da allora io non l’ho più visto. Giuseppe Tamburrino nacque a Introdacqua il 27 maggio del 1829 e morì nel 1922. Allora il paese era molto popoloso, ricco di acque e di boschi, ed il Monte Plaia, con le sue “sbronze” mura megalitiche, offriva rifugio nei suoi antri e nella sua fitta boscaglia. È in quegli anfratti che, dopo la Restaurazione, si rifugiavano i briganti introdacquesi ricercati dalla Polizia Borbonica con il compito di ristabilire l’ordine dopo l’invasione dei francesi. Introdacqua è famoso in quanto ha dato i natali al Capomassa Giuseppe Pronio (1760-1804), poi divenuto comandante dei Tre Abruzzi per aver sconfitto i francesi, nonché al figlio Paolo, Generale comandante dei regi eserciti borbonici (1784-1853). Ma Introdacqua ebbe anche numerosi briganti, tanto da dare vita alla “banda degli introdacquesi” che, dopo il 1860, si diedero alla macchia per non essere arrestati dalla Guardia Mobile Nazionale del Mandamento di Introdacqua e Scanno. Giuseppe Tamburrino infatti, per la conoscenza del territorio montano e per la sua prestanza fisica, chiese ed ottenne in cambio della vita di arruolarsi nella Guardia Mobile Nazionale per contribuire alla repressione del brigantaggio e dei reazionari borbonici che erano ancora sbandati. Si macchiò di un delitto, per aver ucciso il 15 aprile 1861 il suo più acerrimo nemico, il brigante Ignazio Franciosa, compaesano, ma residente a Pettorano sul Gizio, tristemente noto per gli assalti alle diligenze che percorrevano la Via Napoleonica da Sulmona a Napoli e viceversa. 132 Più volte arrestato ed evaso, sotto il Regno dei Borboni Tamburrino si rifugiò per un periodo nella Tenuta Frasca dello Stato Pontificio, a disposizione proprio per accogliere i delinquenti che volessero ravvedersi. Chiusa la tenuta rifugio, rientrò ad Introdacqua ed essendo ancora ricercato si fece aiutare da alcuni paesani, tra i quali il custode dell’antico camposanto di Sant’Antonio, all’imbocco dell’omonima valle: ed era qui, come raccontava mio padre, che egli si rifugiava di giorno nascondendosi nelle tombe vuote e poi usciva di notte per scendere in paese e incontrare la sua donna. Non solo! Audace com’era, per sfuggire alla caccia del Tenente Camarda, si fece confezionare degli scarponi con il tacco sulla punta e la pianta sul tallone, in modo che le impronte sulla neve ne segnalassero il cammino all’inverso. Il suo soprannome era Colaizzo. Raccontava mio padre che Tamburrino amava feste e baldorie, tanto che nel Carnevale del 1859 era in paese a divertirsi, nonostante la presenza dei soldati che lo braccavano. Era talmente spavaldo che in un brindisi, auto celebrandosi, recitò così: “Io bevo questo vino a schizzo a schizzo alla salute di Giuseppe Colaizzo!” In un’altra occasione non sfuggì alla cattura e venne incarcerato, ma dopo pochi mesi evase di nuovo segando le sbarre della cella. Rimase alla macchia sino al cadere del Governo dei Borboni, quando, come già narrato, si arruolò nella Guardia Nazionale e poté godersi la lunga vecchiaia in pace. Gli Abruzzi intanto si avviavano, tra rottura e continuità, verso nuovi orizzonti, che, tuttavia, dopo l’arrivo dei piemontesi, furono miseria ed emigrazione. Bibliografia L’Abruzzo e l’Unità d’Italia – Estratto dall’opera La fine di un regno di Raffaele Di Cesare (parte II, pag. 460). – Indro Montanelli, Storia d’Italia –, vol.4. – Roberto Simari, Salvatore Tommasi: Il patriota del 1860, Editrice D’Amato, Sulmona, 1962. 133 – I dispacci telegrafici di Cavour, Farini, Garibaldi e altri sono conservati all’Archivio di Stato de L’Aquila ed all’Archivio Centrale dello Stato. – T. Sarti, Il Parlamento subalpino e nazionale, Terni 1890. Pier Silvestro Leopardi – Malatesta Alberto, Ministri e deputati d’Italia dal 1848 al 1922 (volume secondo). Tosi. Roma 1946. – Leone- Deputati e Senatori. Serie XLIII- Vol.II. – Rivista L’illustrazione italiana, anno 38, n.13, marzo 1911. Per il cinquantenario del Regno d’Italia. Giuseppe Tamburrino – L’ultimo dei briganti – Rocco Mampieri, Storia del Brigantaggio politico 1799-1861, Sulmona 1973. – Gaetano Susi, Il Monte Plaia nella storia e nella leggenda, Sulmona 1963. – Gaetano Susi, Introdacqua nella storia e nella tradizione, Sulmona 1970. – Francesco Ventresca, Personal Reminiscences of a Naturalized American, New York-Usa 1937. – Panfilo Monaco, Pettorano sul Gizio nella corona radiosa dei Cantelmo, Sulmona 1983. – Luigi Torres, Il brigantaggio nell’Abruzzo peligno e nell’Alto Sangro, 2001. 134 PANFILO SERAFINI, MARTIRE DELLA LIBERTÀ. di Gioacchino Casciato Alunno della classe III° B Scuola Media “Panfilo Serafini” “Fuori i barbari, fuori i barbari! Finchè l’Austria tiene un soldato fra di noi, l’Italia è nulla… Si conquisti prima la potenza e poi la libertà. Sia pure il dispotismo tra noi, ma fugga lo straniero”. Così scriveva il patriota risorgimentale Panfilo Serafini, attento osservatore e conoscitore della storia locale e “nazionale” del suo tempo, consigliando ai patrioti quella prudenza necessaria per non spaventare i Principi d’Italia con la parola Repubblica, T. Patini, Panfilo Serafini. visto che “il volgo tende all’unità monarchica… il Piemonte è forte ed ama Casa Savoia… Napoli ha un popolo per nulla maturo e semi repubblicano.” Panfilo Serafini era un carbonaro che non nascondeva le sue idee, un mazziniano che credeva nell’importanza di diffonderle, consapevole che i suoi Sulmonesi andavano sollecitati non a prendere baionette e cannoni, ma ad armare il pensiero. Dovevano dunque, i Sulmonesi, avere coscienza della propria dignità di esseri umani, delle proprie capacità, del ruolo che ad essi spettava nella società futura, liberi finalmente da superstizione, ignoranza e vassallaggio feudale. I mali possono essere curati solo se conosciuti, ed ecco che Panfilo Serafini, illuminista ed uomo di cultura, esamina la realtà sulmonese del suo tempo e ne coglie i limiti. “Non conoscendo il meglio ci crediamo sovrani dell’Universo nella nostra mediocrità,” e precisa “abbiamo ignoranza quasi universale, dovendo far poche eccezioni per coloro ch’ebbero da natura ingegno naturale o volontà ferma di progredire da sé nella via delle oneste discipline, o la fortuna di studiar fuori del Distretto”. Sottolinea inoltre con lucida amarezza, trattandosi di un insegnante- 135 patriota, che “la gioventù sulmonese e del nostro distretto, quantunque assetata di saper, non può soddisfare ad un desiderio: che le impedisca di abbandonarsi all’ozio e di crescere ignorante…”. Bisognava liberarsi dell’ignoranza, si diceva nella Francia del Settecento, e questo andava dicendo nell’Ottocento Panfilo Serafini, quando parlava della necessità di creare in Sulmona scuole capaci di dare un insegnamento più fruttuoso ai “fanciulli”, una specifica istruzione agraria per i nostri concittadini e pe’ proprietari delle terre vicine, visto che Sulmona è chiave e centro degli Abruzzi”, ma “il difetto d’associabilità, l’essere stimolati da non grandi bisogni, l’ignoranza del meglio, ed una certa inerzia che fa moltiplicar fra noi merciajuoli senza farci aver commercianti” . Si preoccupava dell’economia di Sulmona Panfilo Serafini, e ne voleva migliorare la realtà, guardando però alla distribuzione dei mezzi di vita piuttosto che alla quantità, perché “altrimenti potremmo avere alcuni ricchissimi in una città povera”. Giustizia, dunque, in tutti i settori della vita civile e politica, giustizia possibile solo con la libertà dall’ignoranza, dalla sopraffazione e dall’egoismo. Ma la libertà desiderata, quella di cui hanno tanto parlato e parleranno scrittori, filosofi, politici e cittadini comuni, è raggiungibile solo quando si ha la consapevolezza del suo significato e si è disposti a sacrificare tutto, anche la vita, per raggiungerla per sé e per farla godere agli altri, come ha fatto Panfilo Serafini. Una bella chiesa ne conserva le ossa, un busto ne mostra il volto all’entrata della Scuola Media a lui intitolata, ma dopo tanti anni dalla sua morte vi sono in Sulmona giustizia, qualità nell’insegnamento, valorizzazione delle persone oneste e capaci che vi operano e ricordo orgoglioso di chi ha bene operato nel passato per migliorare il presente? Solo con risposte affermative potremo dire che il martirio di Panfilo Serafini non è stato inutile e che la libertà nel rispetto degli altri, che lui ha sempre voluto, è un bene di cui godono i suoi concittadini di oggi, nipoti di coloro che non sono stati in grado di capirlo ed apprezzarlo. Solo in tal caso il tempo gli avrebbe reso giustizia e solo in tal caso la libertà sarebbe un bene acquisito. 136 GLI ANTITALIANI E LA QUESTIONE MERIDIONALE di Nicolina Nolfi Negli ultimi 25 anni, parallelamente al terremoto di tangentopoli e all’afflusso di extracomunitari, paragonabile in alcuni momenti ad una vera e propria invasione, i malumori e i risentimenti contro “Roma ladrona” da una parte e soprattutto la paura nei confronti del diverso che – ieri meridionale oggi straniero – veniva a togliere pane e lavoro all’industriosa e produttiva gente settentrionale, sono sfociati nella nascita della Lega Nord, passata in pochi anni da disorganizzata forza di lotta a partito di governo. Rozzi e beceri nel loro razzismo, grossolani e violenti nel linguaggio, ignoranti veri o falsi della storia d’Italia, i leghisti della prima ora, per il loro progetto di secessione, non solo si sono impadroniti dei simboli ampiamente utilizzati dai patrioti del Risorgimento, ma hanno dato luogo, per forza di reazione uguale e contraria, ad un’ampia fioritura di articoli, saggi e studi localistici di stampo prettamente “sudista”, vagamente infarciti di razzismo alla rovescia. L’inno di Mameli, riportato in auge da C. A. Ciampi, è ancora oggi pressoché sconosciuto ai più e, se le partite della nazionale di calcio ne hanno insegnato a tutti il ritornello, solo pochissimi ne conoscono il testo integrale: è stato Roberto Benigni a ricordare, dal palco di Sanremo, che Alberto Da Giussano era uno degli eroi simbolo dei nostri patrioti, impartendo, e non solo ai leghisti, una bella lezione di storia e di italianità. Molti giovani di oggi Alberto Da Giussano lo hanno conosciuto forse soltanto attraverso le bandiere della Lega, ma noi un po’ più avanti negli anni avevamo imparato a considerarlo un campione del sentimento nazionale già dai banchi della Scuola Media, commuovendoci alle rievocazioni delle antiche battaglie contro lo straniero con il Berchet del “Giuramento di Pontida” o con il Carducci della “Canzone di Legnano”. Peccato che questi cantori del Risorgimento siano stati, negli ultimi decenni, quasi banditi dalle antologie della scuola primaria: forse oggi non ci troveremmo a dover tollerare le volgari esternazioni del peggior leghismo di fronte alla bandiera o i 137 mugugni di altre componenti della società italiana in merito alla festa nazionale per i 150 anni dell’Unità. Quanto alla fioritura di storie e cronache del Sud, accanto a studi approfonditi ed obiettivi che – da qualunque parte d’Italia – si inseriscono nella tradizione dei Fortunato, dei Salvemini, dei Villari, se ne producono altri che, pur altrettanto ricchi di documentazione, mancano, a mio avviso, di quell’essenziale completezza di racconto e di quell’onesta obiettività di giudizio senza le quali crollano due fondamentali presupposti del fare storia: Terroni del pugliese Pino Aprile, dato alle stampe l’anno scorso, alla vigilia delle celebrazioni per la ricorrenza dell’unificazione, mi pare ne costituisca la sintesi perfetta. Frutto della passione e dell’amore per il Sud da parte di un giornalista profondamente legato alla sua gente, Terroni è un libro a tesi che, proprio perché scaturito da spinte emotive di per sé irrazionali, distorce la realtà storica deformando e adattando la verità a ciò che più preme dimostrare: secondo Aprile, infatti, il Sud – terra felice e ben governata, economicamente alla pari e, in certi settori, più prospera del resto d’Italia al tempo dei Borboni – è stato ridotto a condizioni di sudditanza e di progressiva inferiorità da una politica di espoliazione e di rapina delle sue risorse materiali ed umane, attuata, ieri come oggi, con fredda consapevolezza dai settentrionali o almeno per i settentrionali. Il libro si apre, da parte del nostro autore, con una professione di ignoranza di notevole impatto emotivo: “Io non sapevo che i piemontesi fecero al Sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto. Ma tante volte, per anni. E cancellarono per sempre molti paesi in operazioni “antiterrorismo”, come i marines in Iraq. Non sapevo che, nelle rappresaglie, si concedesse libertà di stupro sulle donne meridionali (…). Ignoravo che, in nome dell’Unità nazionale, i fratelli d’Italia ebbero pure diritto di saccheggio (…) e praticarono la tortura e (…) si incarcerarono i meridionali senza accusa, senza processo, senza condanna (…) briganti per definizione perché meridionali”. Noi invece sapevamo, da almeno 40 anni. La storia del Risorgimento, concepita come libera aggregazione di purissimi ideali di italianità intorno alla figura di Mazzini o alla spada di Garibaldi, 138 o come popolo che si desta dal suo sonno secolare per cacciare lo straniero, era stata sfrondata degli aspetti eccessivamente retorici e patriottardi in tempi molto più lontani, se vogliamo fin dal primo decennio dell’Unità. La riprovazione per i metodi adottati e la delusione per i risultati conseguiti erano infatti sfociate da una parte nella protesta dei patrioti e degli intellettuali, dall’altra in una serie di indagini e di inchieste tese se non altro a capire cosa non avesse funzionato. Gli errori commessi, gli aspetti più tristi, la tragedia sociale che la conquista del Sud aveva provocato erano emersi già dalle prime relazioni presentate in Parlamento non solo da deputati provenienti dal Meridione, ma anche da probi ed onesti funzionari piemontesi. Nei capitoli che ripercorrono l’impresa di Garibaldi, Aprile sembra scoprire solo adesso che il ricongiungimento dell’indipendente Regno delle due Sicilie al resto d’Italia non era avvenuto solo attraverso un’impresa animata da ideali unitari ma che, al contrario, era stata una guerra di conquista talora brutale. Per condurla al successo, ci si era serviti di ogni mezzo, ivi compreso l’appoggio dell’ “onorata società” che, forse proprio grazie alle vicende di quegli anni, si consolida in cosche sempre più potenti nel tempo e sempre più ramificate nello spazio. Nelle accorate pagine che rievocano, con dovizia di particolari, le tragiche gesta della guerra al banditismo, il nostro autore evidenzia gli orrori delle stragi, la ferocia e la crudeltà delle rappresaglie messe in atto dai piemontesi, soprattutto dopo la terribile legge Pica (ahinoi aquilano!) che consentiva di incarcerare e di uccidere chiunque: bastavano il sospetto o il possesso di un’arma, fosse pure una falce, una roncola, un’accetta. Noi sapevamo perfettamente invece. Fin dai tempi del liceo e, più tardi, nelle facoltà umanistiche, noi studenti eravamo obbligati a conoscere la realtà storica del periodo attraverso lo studio dei meridionalisti più accreditati, mentre quel fondamentale testo che è la Storia d’Italia 1861-1969 di Denis Mack Smith ci accompagnava per tutto il percorso universitario. Il puntiglioso, compassato, finissimo storico inglese, distaccato dalle passioni degli Italiani del Nord, del Centro e del Sud, fin da allora ci aveva fatto capire che orride stragi, feroci crudeltà e bagni di sangue 139 erano stati perpetrati su tutti i fronti, specialmente nei momenti in cui il “revanchismo” borbonico e quello contadino si erano intrecciati al brigantaggio e la lotta si era trasformata in una guerra di tutti contro tutti. La ferocia dei contadini in cerca della “Libertà” di verghiana memoria e la spietata repressione che ne era derivata avevano già dato ampie prove di sé a Bronte. I truci scenari delle esecuzioni e delle vendette dei briganti, secoli addietro, avevano terrorizzato persino gli eserciti dei viceré spagnoli e forse avrebbero ancora oggi qualche suggerimento da offrire ai cineasti dell’horror. Ma il nostro giornalista, così sollecito nell’enfatizzare gli eccidi “piemontesi”, su questi “dettagli” preferisce tacere. Eppure tutti sappiamo che la guerra, anche se provocata da giuste cause, diventa quasi sempre sul campo una “sporca faccenda”, ieri come oggi, dai campi di sterminio nazisti ai massacri di Saddam Hussein, dalle pulizie etniche dell’ex Jugoslavia alle torture dei presunti terroristi irakeni: emblematiche in questo senso sono diventate le foto della giovanissima soldatessa americana che schiaccia mozziconi accesi sui corpi nudi dei prigionieri ammassati gli uni sugli altri nella prigione di Abu Ghraib. La guerra… Dalle nostre parti una vecchia, saggia massima pratolana ne esprime, con rara efficacia linguistica, le devastazioni: “la ‘uerre’, a papà, scinciose tutte, tutte”, “la guerra, figlio mio, lacerò, ridusse a brandelli tutto” e, in quel “tutto” ripetuto due volte, sono inclusi non solo gli uomini e i paesi, ma anche i sentimenti ed i valori più elevati. Tornando, dopo questa breve digressione, alle tesi sostenute da Pino Aprile, quella di un’Italia meridionale prospera e ben governata dai Borboni, se non è una vera e propria leggenda metropolitana, è per lo meno un’affermazione assai azzardata e discutibile. Se è vero che Napoli, splendida per i suoi edifici, vivace per la sua cultura, all’avanguardia in Italia per le sue flotte, mercantile e bellica, era la terza città più ricca e popolosa d’Europa, è altrettanto vero però che accanto alla corte borbonica e a quello che oggi chiameremmo il suo “indotto”, brulicava da secoli e cresceva paurosamente negli anni l’enorme plebaglia affamata e miserabile dei lazzari conosciuti e temuti dai residenti e dai visitatori per gli atti di ordinaria, quotidiana criminalità. 140 Palermo ed alcune altre città del Sud, soprattutto in prossimità dei porti, avevano avviato qualche attività di tipo industriale, aziende di piccole e medie dimensioni specie nei settori tessile ed alimentare. Ma la stragrande maggioranza del territorio utile era campagna in pieno Medioevo, abitata da diversi milioni di persone: erano per lo più contadini senza terra e pastori senza gregge, sottoposti ai gattopardi della grande feudalità laica ed ecclesiastica o al rapace padronato dei nuovi ricchi che, all’arrivo dei Francesi prima e al formarsi dell’Unità poi, si erano impossessati di vasti latifondi accaparrando o usurpando le terre del demanio e della manomorta. Strade e ferrovie nel regno erano pressoché assenti, gli antichi boschi erano stati saccheggiati, acquitrini e paludi malarici ricoprivano vaste estensioni di terre in prossimità delle coste, dei fiumi e dei torrenti, il territorio, nel suo insieme, era in preda al più profondo dei degradi. Francesco Saverio Sipari, antenato di Benedetto Croce e sindaco di Pescasseroli nel primo decennio dell’Unità, sensibile ed attento ai problemi economici della sua regione e del Sud in genere, così descrive la condizione del contadino in una lettera ai censuari del Tavoliere delle Puglie, nel 1863. “Il contadino non ha casa, non ha campo, non ha vigna, non ha prato, non ha bosco, non ha armento: non possiede che un metro di terra in comune al camposanto. Non ha letto, non ha vesti, non ha cibo d’uomo, non ha farmachi. Tutto gli è stato rapito o dal prete al giaciglio di morte o dal ladroneccio feudale o dall’usura del proprietario o dalla imposta del comune e dello stato. Il contadino non conosce pan di grano, né vivanda di carne, ma divora una poltiglia innominata di spelta, segale o melgone, quando non si accomuni con le bestie a pascere le radici che gli dà la terra, matrigna a chi l’ama. Il contadino, robusto e aitante, se non è accasciato dalle febbri dell’aria, con sedici ore di fatica, riarso dal solleone, rivolta a punta di vanga due are di terra alla profondità di quaranta centimetri e guadagna ottantacinque centesimi, beninteso nelle sole giornate di lavoro, e quando non piove e non nevica e non annebbia. Con questi ottantacinque centesimi vegeta esso, il vecchio padre, 141 invalido della fatica e senza ospizio, la madre, un paio di sorelle, la moglie e una nidiata di figli. Se gli mancano più giorni gli ottantacinque centesimi, il contadino, non possedendo nulla, nemmeno il credito, non avendo che portare all’usuraio o al monte dei pegni, allora (oh io non mentisco!) vende la merce umana; esausto l’infame mercato, piglia il fucile e strugge, rapina, incendia, scanna, stupra e – mangia” (B. Croce – Storia del Regno di Napoli – Laterza ). In rivolta anarcoide contro le loro terribili condizioni di miseria, i braccianti del Sud – sui quali venivano a gravare anche gli obblighi della lunga leva – nel primo decennio dell’Unità avevano imbracciato il fucile; qualche decennio più tardi, prenderanno una valigia di cartone ed emigreranno oltre oceano. L’emigrazione costò loro ancora una volta lacrime amare per gli affetti che lasciavano a casa, per i disagi e le umiliazioni che li aspettavano a destinazione. Eppure, proprio attraverso il sacrificio di milioni di migranti, la tensione sociale si stemperò e, grazie alle loro rimesse, si ricreò una classe di piccoli proprietari terrieri in grado di tirare a campare in modo dignitoso. È doveroso però osservare che a partire non erano solo i meridionali; con loro si muovevano anche i braccianti delle zone più povere del resto d’Italia, dalle Langhe al delta del Po, dalla Sardegna ai paesi alpini. Lo spopolamento delle campagne indusse anche i “baroni” a più miti consigli al punto che si diffusero un po’ ovunque i contratti di mezzadria e colonìa. Nella Valle Peligna, il colono si chiamava “aquilone” e il tipo di contratto che stipulava con il proprietario terriero veniva definito, ai tempi di mio nonno, nel primo Novecento, “alla parte”; il padrone delle terre contribuiva con il denaro “alle spese” – sementi, acquisto di attrezzi, eventuali migliorie – poi divideva i prodotti della terra con il mezzadro in percentuali che variavano in base al valore delle colture. Riguardo alle scelte del governo italiano in materia industriale, nei primi decenni dell’unificazione, fu il libero scambio – esteso a tutto il territorio nazionale – a rovinare, per la spietata legge della concorren- 142 za, le imprese più piccole e più deboli, proprio come è capitato oggi ai piccoli negozi con la diffusione dei centri commerciali. Quanto ai trasferimenti da Sud a Nord operati dallo Stato o dai privati (la famiglia Orlando, per esempio, portò la sua azienda da Palermo a Genova), sono convinta che la logica ad essi sottesa sia stata la stessa che ha portato ieri la Siemens ad abbandonare la Valle Peligna, che induce oggi Marchionne a chiudere lo stabilimento di Termini Imerese, e cioè quella cruda e brutale del profitto. Persino la “piemontesizzazione” amministrativa alla lunga si è rivelata una scelta vincente, visto che, a 150 anni di distanza, sono ancora così vive le spinte centrifughe, sia pure di minoranze di Italiani del Nord o del Sud che siano. Per concludere: si può essere d’accordo con Pino Aprile sul fatto che le condizioni generali del Sud peggiorarono con l’unificazione – almeno nei primi decenni – e con il Sud peggiorarono anche le zone di campagna più povere del resto d’Italia. Si può concordare anche – in sintonia con la maggioranza degli storici – sul fatto che le scelte dei governi italiani in materia economica, in questo secolo e mezzo di storia, spesso si sono rivelate deleterie per il Sud, allargando la forbice esistente all’origine. Su tutte hanno influito non solo le ideologie dominanti delle maggioranze, ma anche gli intrecci complessi delle vicende internazionali. Centinaia di migliaia, forse milioni, di pagine sono state scritte sulle vicende storiche di questi 150 anni e sulla questione meridionale in particolare: sarebbe pertanto riduttivo e presuntuoso pretendere di darne una spiegazione esaustiva in queste brevi note. Mi limiterò perciò ad osservare che, se il divario economico tra le due Italie è tuttora rilevante, attribuirne la responsabilità ad un disegno consapevole di deliberato affossamento del Sud a favore dello sviluppo del Nord da parte delle classi dirigenti che in questi 150 anni si sono succedute al governo e all’amministrazione del Paese mi sembra, in tutta sincerità, fantapolitica. Il Sud non ha forse avuto sempre i suoi rappresentanti in Parlamento? Se questi nostri deputati e ministri – pochi all’inizio, proporzionati al numero degli abitanti dopo il suffragio universale – sono stati e sono così indegni e perversi, le responsabilità non sono 143 attribuibili al popolo meridionale che, ieri come oggi, li ha mandati al potere? E le connessioni mafia-politica? Sollevare polveroni, suscitare sterili polemiche, evidenziare le eventuali colpe altrui, minimizzando o, peggio, oscurando le proprie non serve a risolvere la “questione meridionale” né tanto meno a cementare lo spirito unitario che ancora oggi, dopo ben 150 anni, mostra qualche smagliatura. Al contrario certe posizioni faziose possono rafforzare le spinte separatiste che ogni tanto riemergono in Sicilia, possono alimentare gli spiriti “revanchisti” di eventuali altre formazioni “legasudiste”, possono magari portare acqua al nostalgico mulino del risorto partito neoborbonico: formazioni tutte, a Nord o a Sud, ridicole e piccine in tempi in cui la riduzione delle distanze, Internet, le migrazioni massicce, il degrado ambientale, la scarsità delle risorse energetiche ed alimentari – problematiche globali, comuni all’intera umanità – dovrebbero farci sentire, tutti, cittadini del mondo. Centocinquant’anni sono passati dal giorno in cui l’Italia ha cessato di “essere un’espressione geografica” per diventare una nazione, un risultato grandioso, inimmaginabile solo qualche anno prima, anche se è costato così tante lacrime, così tanto sangue. Sono convinta che se Massimo D’Azeglio potesse aggirarsi oggi per le strade delle nostre città o dei nostri paesi, dalle Alpi alla Sicilia, sarebbe molto soddisfatto ed esclamerebbe: “Finalmente anche gli Italiani sono fatti!” In questi 150 anni i nostri connazionali si sono spostati in lungo e in largo per la penisola e non solo da Sud a Nord ma anche in senso contrario ed incrociato. Le guerre, le grandi opere pubbliche, lo studio, il lavoro, la politica e persino le vacanze li hanno fatto incontrare e, nonostante le reciproche diffidenze o i millenari campanilismi, si sono scambiati idee, opinioni, saperi, usanze, tradizioni, ricette e soprattutto valori. La scuola, i giornali, la radio, la TV hanno insegnato la nostra lingua agli abitanti del più isolato paesello di montagna, della più piccola isola, del più sperduto casolare. Tutti noi Italiani ci riempiamo d’orgoglio ai riconoscimenti tributati dal mondo ai nostri artisti, alle affermazioni dei nostri atleti, ai successi del nostro cinema, all’eleganza della nostra moda, tutti noi ci 144 sentiamo partecipi alle sofferenze della nostra gente ad ogni catastrofe naturale o ad ogni grande tragedia privata, tutti noi ci vergognamo un po’ di fronte ai nostri scandali, alle gesta ingloriose delle nostre mafie, alle nostre città ricolme di “monnezza”. Siamo così simili nelle tante differenze che, se andiamo all’estero, agli stranieri di qualunque paese del mondo bastano pochi minuti perché ci rivolgano la domanda: Italiani? È giunto il momento per tutti noi di impegnarci in prima persona per cercare di risolvere i problemi più dolorosi che ancora ci affliggono affinché, alla domanda, come Nino Manfredi in “Pane e cioccolata”, possiamo finalmente rispondere con orgoglio: “Italiani, sì!”. Anzi… fratelli d’Italia. 145 146 LINGUA E DIALETTI NELL’ITALIA POST-UNITARIA di Evandro Gay L’anno 1861 è stato davvero un anno memorabile nella storia dell’Italia moderna; è quello infatti l’anno nel quale fu proclamata l’Unità d’Italia, anche se tale unità venne completata e portata a termine solo nel 1970 con la presa di Roma. Sin dal 1861, dunque, ebbero avvio importanti processi di trasformazione della vita nazionale in ogni suo settore, con conseguenti riflessi anche sulla lingua italiana, che prese a diffondersi presso strati sempre più vasti di popolazione, che erano rimasti per lunghi secoli dominio esclusivo delle parlate dialettali. L’italiano che parliamo e scriviamo al giorno d’oggi è nato sul modello del fiorentino letterario del Trecento, è stato sapientemente codificato nel Cinquecento dall’umanista veneziano Pietro Bembo e successivamente è assurto a lingua nazionale ad opera di Alessandro Manzoni. In un’Italia divisa politicamente questa lingua ha rappresentato per secoli il simbolo di una fratellanza ideale, ma è rimasta privilegio di una ristretta élite. Va ricordato comunque che, quando fu proclamata L’Unità, la lingua italiana parlata era quasi inesistente al di fuori della Toscana e della città di Roma, mentre i dialetti godevano di un vastissimo consenso sociale, in special modo nelle città più importanti del paese, quali Napoli, Milano, Venezia e Palermo, nelle quali il dialetto veniva usato non solo dagli appartenenti ai ceti più umili della popolazione, ma era di frequente utilizzato anche in circostanze ufficiali da personaggi importanti della vita nazionale. Non va dimenticato in proposito che lo stesso Vittorio Emanuele II, primo re dell’Italia unita, faceva uso del dialetto piemontese in ogni occasione. Un dato statistico ci dà l’esatta percezione della diffusione della lingua italiana in quel periodo: essa veniva usata quasi esclusivamente come lingua scritta, ma meno di un terzo della popolazione adulta sapeva scrivere, mentre tutti gli altri si esprimevano solo e soltanto in dialetto, tanto da far dire a Pasquale Villari nel 1866: “V’è nel seno 147 della nazione stessa un nemico più potente dell’Austria ed è la nostra colossale ignoranza, il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi”. Sempre a proposito di dati statistici, il censimento del 1861 aveva accertato che gli italiani capaci di leggere e scrivere erano meno di un quarto della popolazione, tenendo anche conto di coloro che sapevano a malapena apporre solo la loro firma. Secondo una stima del prof. Tullio De Mauro solo il 2,5% della popolazione era in grado di affrancarsi dall’uso della parlata dialettale, comprendendosi in tale percentuale anche coloro che avessero frequentato scuole post-elementari, 400.000 toscani e 70.000 romani alfabetizzati, in considerazione della contiguità dei loro dialetti con la lingua comune. Secondo altri studiosi, gli italofoni sarebbero stati circa il 9,5% della intera popolazione. Si deve anche precisare che nell’Italia pre-unitaria il grado di sviluppo delle istituzioni scolastiche era diverso tra Stato e Stato: tale grado era minimo nel Regno delle Due Sicilie e massimo nel Piemonte, dove sin dal 1840 era stata attuata una politica di istruzione popolare. Non a caso le punte di massima conservazione del dialetto si avevano nelle zone di scarsa urbanizzazione, unitamente all’insufficienza del sistema viario, che rendeva di difficilissima attuazione il processo di osmosi tra gruppi di popolazione. Con la costituzione della Stato Unitario la lotta all’analfabetismo e la diffusione della lingua italiana costituirono problemi politici, con i quali dovette misurarsi la nuova classe dirigente. Nel 1868 il Ministro dell’Istruzione, Emilio Broglio, chiamò Alessandro Manzoni ad occuparsi in concreto della questione e Don Lisander propose di inviare maestri fiorentini in tutte le scuole e di far trascorrere periodi di soggiorno a Firenze agli altri maestri, al fine di “risciacquare i panni in Arno”. Tuttavia, queste proposte non raggiunsero lo scopo prefissato di italianizzare il sistema scolastico, anche perché vi furono tenaci resistenze opposte dalle classi agiate di ispirazione cattolica e moderata. Ebbe invece una certa fortuna l’idea del De Sanctis, che nel 1880 diventò Ministro dell’Istruzione, di incoraggiare i docenti a porre in relazione i due sistemi espressivi, per far tesoro di quel fondo prezioso che ha il dialetto in comune con la buona lingua. 148 L’insufficiente preparazione degli insegnanti emerge dalle correzioni linguistiche di un precettore abruzzese, che da un lato sostituisce un vocabolo accettabilissimo come affitto col toscano pigione, mentre non corregge l’espressione faggioli, inciampando anche lui in un localismo fonetico, quando scrive cabbie in luogo di gabbie (da Italiano in Abruzzo dopo l’Unità, di P. Trifone, Chieti, 1990). Liberati, però, dall’isolamento ed entrati in contatto diretto con le parlate cittadine più italianizzate, i dialetti cominciarono ad avvicinarsi alla lingua comune. Tra le abitudini lessicali abruzzesi, citate da Fedele Romani (Abruzzesismi, Firenze, 1907) vanno ricordati i seguenti vocaboli e modi di dire: cocozza al posto di zucca, faticare per lavorare, stare per essere, trappeto per frantoio, gradinata al posto di scala, coppola per berretto, cercare al posto di chiedere, fidarsi invece di sentirsela, incaricarsi per prendersi cura, mettere e levare la tavola anziché apparecchiare e sparecchiare, ritirarsi al posto di rincasare, tiretto invece che cassetto, salvietta al posto di tovagliolo, ecc., ecc. Oggi, trascorsi ormai centocinquant’anni, l’ignoranza non è stata forse debellata, ma l’analfabetismo sì (dati ISTAT 2001: analfabeti 782.342) e l’italiano è diventato la lingua comune a tutti gli Italiani (dati ISTAT 2006: uso esclusivo del dialetto inferiore al 6%). Tutto questo è stato possibile grazie al miglioramento delle condizioni economiche ed al tasso sempre più elevato di scolarizzazione, ma anche grazie a fenomeni sociali come l’emigrazione interna verso altre regioni o città e il servizio militare, nonché alla progressiva diffusione dei mezzi di comunicazione di massa: la stampa, la radio, il cinema e, soprattutto, la televisione. Dall’Unità ad oggi l’Italiano ha attinto dai dialetti qualche migliaio di vocaboli, arricchendosi notevolmente, ma i dialetti, nel frattempo, non sono scomparsi, anzi, hanno riguadagnato terreno, affiancandosi alla lingua italiana. Questa lingua, venata di elementi locali (l’italiano regionale) è diventata la lingua parlata nelle situazioni informali anche delle persone colte. Italiano regionale sì, ma, appunto, Italiano. 149 150 L’UNITÀ DELL’ITALIA… DISUNITA di Raffaele Russo (Irmazio Glicone) La legge 17 marzo numero 4671, articolo unico, proclamò: “Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di Re d’Italia”. Una legge ad personam, mancante del classico riferimento “per grazia di Dio e volontà della Nazione”, correttiva in parte di anacronistica situazione della Penisola fino a quel giorno divisa in ben sette entità statuali. La completa unità geografica dell’Italia era ancora lontana da venire. Il Veneto entrerà a farvi parte nel 1866; Roma nel 1870; il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia nel 1918. Sarà Massimo D’Azeglio (1798-1866), uomo politico fra i più noti del Risorgimento, a pubblicare solennemente ne I miei ricordi il bando: “Il primo bisogno d’Italia è che gli Italiani si formino”. Ciò ovviamente in un contesto europeo di grandi Stati ben costituiti da secoli. Egli aveva contezza delle arretrate condizioni in cui gli Italiani versavano, afflitti da indigenza e analfabetismo. Ne è la prova la rilevante migrazione di fine ottocento dal Veneto e soprattutto dal Meridione. D’Azeglio aveva soggiornato a Torino, Firenze, Roma, Milano e nelle regioni centrali. Era stato presidente del Consiglio dei Ministri fino al 1857, quando gli successe Cavour. Letterato autore di opere fra le quali Ettore Fieramosca e La disfida di Barletta. Il suo appello si prefiggeva di dare agli Italiani una comune identità nazionale certamente di difficile realizzazione dopo circa due millenni di divisione e sudditanze a poteri locali e stranieri, pur se i più grandi poeti della nostra lingua continuavano a tener viva la memoria di Roma. Né l’esito favorevole della Prima Guerra Mondiale, né il ventennio fascista, con le sue ottiche espansionistiche imperiali, riuscirono a potenziare quella identità nazionale sempre carente ed aggravata dalla perpetua divergenza economico-sociale tra Nord e Sud della Penisola, riacutizzata dopo la Seconda Guerra Mondiale, tanto da rendere sempre validi gli epiteti “Polentoni” per i settentrionali e “Terroni” per i meridionali. 151 Ma la vera disunione territoriale, civile, amministrativa, culturale e socio-economia è stata decretata dalla Costituzione Italiana del 1948, articolo 116, che ripartendo la Repubblica in regioni, provincie e comuni attribuisce “alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia ed alla Valle d’Aosta, forme particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali”. Quindi crea le cosiddette Regioni a Statuto Speciale e Provincie Autonome a fronte delle restanti regioni a statuto ordinario, con conseguente discordanza civile ed economico-sociale ovviamente a favore dei cittadini residenti nelle regioni a statuto speciale. Ne derivano cittadini di Serie A e cittadini di Serie B. Bastano alcuni esempi: per l’acquisto della prima casa in Lombardia, una giovane coppia paga il 100% del mutuo più gli interessi; nel Trentino paga solo il 55% del mutuo a tasso zero, perché il 45% del mutuo e gli interessi li paga la Provincia. Per realizzare un capannone un’azienda lombarda paga il 100% del mutuo, un’azienda trentina solo il 40%, perché il 60% è a carico della Provincia. Scuola Materna: nei comuni lombardi la retta mensile è di 75 euro, in quelli trentini è pari a zero. Così il fondo di Solidarietà per le aree disagiate e depresse per i comuni piemontesi e lombardi e veneti, confinanti con le Regioni a Statuto Speciale del Nord, con dotazione triennale di 91. 000.000 di euro, si è operato un taglio del 70% riducendolo a 22.000.000 di euro. Per i comuni delle Regioni a Statuto Speciale nessun taglio. Gli esempi sono ancora numerosi. Di fronte a tale situazione i sindaci infuriati dei comuni del Nord, per ora circa 600, riuniti a Milano, minacciano di cambiare le carte geografiche dell’Italia Settentrionale usando quei referendum popolari che consentono di distaccarsi da una provincia per unirsi ad un’altra cambiando, in questo caso, regione, approdando in quelle a statuto speciale. Già molti cittadini piemontesi, lombardi e veneti, hanno cambiato residenza con il risultato di vedere spopolate le zone settentrionali del Paese. Questa è vera e propria secessione. È questa l’unità d’Italia. A che servono le Regioni a Statuto Speciale e le Provincie Autonome quando oggi è stata realizzata l’Europa Unita? La vera unità d’Italia è questa perché è … disunita. E non vale produrre dispersione di risorse per celebrare una unità che non esiste perché viaggiando gli Italiani nella stessa barca non si 152 comprende come alcuni siano sistemati in prima classe e gli altri ingabbiati nella seconda classe. Alla domanda se esiste una vera e propria unità si può rispondere di fronte ad una evidenza reale sicuramente sì, solo dal punto di vista della unità territoriale, come ebbe a definirla nel 1870 Metternich quale “espressione geografica”. Alcuni vedono nel federalismo un valido rimedio per realizzare l’auspicata unità ostacolata dal persistente divario Nord-Sud. È un disegno che purtroppo tende allo smembramento regionalistico dello Stato nazionale e alla sostituzione con organismi locali autonomi in un tricolorito Bel Paese purtroppo gattopardiano dove tutto cambi perché tutto resti come prima. Se federalismo vorrà realizzarsi deve essere solidale tra le varie aree nazionali. 153 154 GOFFREDO MAMELI di Beatrice Ricottilli Con l’elezione del parlamento nazionale il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia con capitale Torino. Restavano irrisolte alcune questioni anche se la soluzione sabauda riuscì a mantenere saldi e uniti i principi liberali e di nazionalità. Nel complesso, dai documenti si evince che il Risorgimento non fu un fenomeno di massa ma opera di una minoranza di uomini e donne, patrioti e patriote che ad uno ad uno, tasselli umani di un mosaico chiamato Italia, hanno colorato per noi, figli di oggi, di sangue e libertà le pagine ancora tutte da scrivere della grande Storia. Con tutti i mezzi si è cercata la strada dell’unificazione, ma forse la strada più appropriata a spandere nell’aria il seme della nazionalità è stata la musica. Durante tutto il Risorgimento la musica ha rappresentato la vera anima del popolo insorto e liberato. Tra tanti inni patriottici Il Canto degl’ Italiani di Mameli, conosciuto più semplicemente come inno, il 12 ottobre 1946 divenne il canto con il quale ci saremmo riconosciuti tutti fratelli e figli. Finalmente “l’Italia s’è desta”. Gotifredo Mameli dei Mannelli, più noto come Goffredo, nacque a Genova il 5 settembre 1827, figlio di Giorgio, comandante di una squadra della flotta del regno di Sardegna, e di Adelaide Zoagli di famiglia aristocratica genovese. Il giovane Goffredo dimostra presto il suo talento letterario con la composizione di versi di ispirazione romantica come “Il giovane crociato”, “L’ultimo canto”, “La vergine e l’amante”; ad appena vent’anni aderisce all’ideale liberale mazziniano. Nell’autunno del 1847 compone il Canto degli Italiani, musicato poco dopo a Torino da un altro patriota, Michele Novaro. Di 9 anni più giovane, anche lui genovese, Michele Novaro si trova nel 47 a Torino, terminati gli studi di composizione e canto, con un contratto di secondo tenore e maestro di cori dei teatri Regio e Carignano. Di indole mansueta e modesta, convinto liberale, Novaro dedica alla causa dell’indipendenza il suo talento 155 compositivo, musicando decine di canti patriottici e organizzando spettacoli e intrattenimenti per la raccolta di fondi destinati alle imprese di Garibaldi. Tornato a Genova dopo l’unità, si dedica con tutto se stesso alla scuola corale popolare che aveva fondato. Muore povero il 21 ottobre 1885, ma i suoi allievi gli erigono un monumento funebre nel cimitero di Staglieno vicino alla tomba di Mazzini. Anche il giovanissimo Mameli venne conquistato dallo spirito patriottico e, con un gesto divenuto memorabile, mettendo a repentaglio la propria vita, per festeggiare la cacciata degli austriaci nel 1846 espose il tricolore. Due anni dopo organizzò una spedizione con 300 uomini per raggiungere Nino Bixio durante l’insurrezione di Milano e combattere poi col grado di capitano dei bersaglieri sul Mincio; in virtù del successo riportato in quest’impresa venne arruolato nell’esercito di Garibaldi; compose un canto patriottico, il secondo, intitolato “Inno militare” musicato da Giuseppe Verdi. Tornato a Genova si dedicò ancora alla composizione musicale mentre diventava direttore del giornale il “Diario del Popolo”, volàno delle idee irredentiste nei confronti dell’Austria. Come vero patriota lo troviamo a Roma in aiuto a Pellegrino Rossi e a fianco di Mazzini, Armellini e Saffi il 9 febbraio 1849 per la proclamazione della Repubblica Romana, poi a Firenze per la fondazione di uno stato unitario tra Lazio e Toscana e ancora a Genova sempre al fianco di Nino Bixio nel movimento irredentista fronteggiato dal generale La Marmora; quindi nuovamente a Roma nella lotta contro le truppe francesi venute in soccorso del pontefice Pio IX che nel frattempo aveva già lasciato la città, e mentre il pontefice fuggiva Mameli accorso nella difesa della Villa del Vascello venne ferito, il 3 giugno, alla gamba sinistra dalla palla di un moschetto. Nonostante l’amputazione dell’arto effettuata il 19 dello stesso mese, come riporta una struggente lettera scritta da G. Mazzini, la cancrena ebbe il sopravvento e, dopo un mese d’agonia, il 6 luglio 1849, a 22 anni, il poeta patriota morì. Non sappiamo se all’ospizio della Trinità dei Pellegrini una mano pietosa gli posasse sui grandi occhi l’ultimo gesto caritatevole. Noi vogliamo pensarlo. Fu sepolto al Verano dove ancora oggi è visibile la tomba; poi nel 1941 le spoglie vennero traslate al Gianicolo. Nel 1975 l’Esercito Italiano gli dedicò la neo costituita “Brigata Corazzata Mameli”. Carlo Alberto Barrili, patriota, poeta, amico e biografo di Mameli, seppur molti anni più tardi lasciò questa testimonianza: 156 Torino: “Colà, in una sera di mezzo settembre, in casa di Lorenzo Valerio, fior di patriota e scrittore di buon nome, si faceva musica e politica insieme. Infatti, per mandarle d’accordo, si leggevano al pianoforte parecchi inni sbocciati appunto in quell’anno per ogni terra d’Italia, da quello di Meucci, di Roma, musicato dal Magazzari “Del nuovo anno già l’alba primiera” al recentissimo piemontese Bertoldi “Coll’azzurra coccarda sul petto” musicato dal Rossi. In quel mezzo entra nel salotto un nuovo ospite, Ulisse Borzino, l’egregio pittore che tutti i miei genovesi rammentano. Giungeva egli appunto da Genova; e voltosi al Novaro, con un foglietto che aveva cavato di tasca in quel punto: Tò, gli disse, te lo manda Goffredo. Il Novaro apre il foglietto, legge, si commuove. Gli chiedono tutti cos’è; gli fan ressa d’attorno. Una cosa stupenda! esclama il maestro; e legge ad alta voce, e solleva ad entusiasmo tutto il suo uditorio. Io sentii -mi diceva il Maestro nell’aprile del ’75, avendogli io chiesto notizie dell’Inno, per una commemorazione che dovevo tenere del Mameli- io sentii dentro di me qualche cosa di straordinario, che non saprei definire adesso, con tutti i ventisette anni trascorsi. So che piansi, che ero agitato, e non potevo star fermo. Mi posi al cembalo, coi versi di Goffredo sul leggio, e strimpellavo, assassinavo colle dita convulse quel povero strumento, sempre cogli occhi all’inno, mettendo giù frasi melodiche, l’una sull’altra, ma lungi le mille miglia che potessero adattarsi a quelle parole. Mi alzai scontento di me; mi trattenni ancora un po’ in casa di Valerio, ma sempre con quei versi davanti agli occhi della mente. Vidi che non c’era rimedio, presi congedo e corsi a casa. Là, senza neppure levarmi il cappello, mi buttai al pianoforte. Mi tornò alla memoria il motivo strimpellato in casa di Valerio: lo scrissi su d’un foglio di carta, il primo che mi venne alle mani: nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul cembalo e, per conseguenza, anche sul povero foglio; fu questo l’originale dell’inno Fratelli d’Italia”. Tutte le volte che, in piedi e con la mano sul cuore, si canta o si ascolta l’Inno di Mameli, quella lucerna agitata dalla passione e dalla poesia, nutrita del sangue buono del patriota, agita ed interroga le nostre coscienze e illumina il volto di chi ancora oggi, a quelle parole e a quella musica con orgoglio può rispondere: Sì, sono Italiano. 157 F. Hayez, Cavour (1864), Milano, Pinacoteca dell’Accademia di Brera. 158 LA MORTE DI CAVOUR di Gemma Di Iorio Il 6 giugno 1861, alle ore 7, spirava il conte Camillo Benso conte di Cavour, Presidente del Consiglio del Regno d’Italia. Il fratello Gustavo dichiarò che era caduto vittima di “un attacco delle nostre terribili febbri periodiche”. Fiorirono immediatamente supposizioni ambigue su veleni e sortilegi, oppure su una divina nemesi: in realtà non vi furono congiure né arcani, semplicemente il primo ministro morì vittima di un ennesimo tremendo attacco di febbre malarica, all’epoca malattia misconosciuta. Era nato nel 1810 a Torino, da famiglia facoltosa, proprietaria terriera di risaie, luoghi nei quali l’ambiente umido e l’acqua ferma favoriscono il moltiplicarsi dell’agente patogeno della febbre malarica, il Plasmodio, un microrganismo parassita che riconosce come serbatoio per vivere l’organismo umano e come vettore un particolare tipo di zanzara femmina, l’Anopheles. Il quadro clinico della malattia acuta si manifesta con segni di gravità diversa, il decorso della malattia è ciclico, prevede oscillazioni termiche, brividi improvvisi con innalzamento della temperatura corporea, alternati a periodi di profusa sudorazione con caduta della febbre per lisi. Questa alternanza, che può verificarsi ogni tre o quattro giorni, donde il nome di febbre terzana o quartana, è dovuta alla diffusione della tossina nel sangue; il procedere della malattia tra remissioni e recrudescenze coinvolge anche altri organi, come milza e fegato, con danni permanenti. Questa patologia era frequente in Italia; pare che verso la fine dell’ottocento si contassero ben 15.000 morti l’anno per malaria, con febbri estivo-autunnali. Solo nel primo novecento si procedette ad una bonifica sistematica delle aree malsane con prosciugamenti; nelle coltivazioni paludose come le risaie fu invece la profilassi e la terapia sistematica ad avere ragione della malattia. Venti anni dopo la morte di Cavour fu il medico francese Alphonse Laveran, allievo di Pasteur, a isolare il protozoo responsabile nel sangue 159 umano; le sue osservazioni vennero accolte con scetticismo e accettate in maniera definitiva in Italia solo a partire dal 1885, dopo che Ettore Marchiafava e Angelo Celli, due tra i principali malariologi italiani, riuscirono a trasmettere sperimentalmente la malaria attraverso iniezioni intravenose di sangue infettato e ad identificare il parassita. Fu infine lo studio di Camillo Golgi a permettere di scoprire l’esistenza di diversi tipi di plasmodio responsabili degli attacchi febbrili nell’uomo; per questa scoperta fu insignito del premio Nobel nel 1906. Si può supporre che Cavour avesse contratto l’infezione malarica molti anni prima nelle risaie di Leri, nel vercellese, dove viveva e amministrava il cospicuo patrimonio terriero, tentando anche innovazioni nelle colture e commerci speculativi. Negli ultimi quindici anni della sua vita era stato colpito da brevi indisposizioni, episodi che si rinnovavano varie volte nell’anno, duravano alcuni giorni e, trattati con salassi, venivano superati senza particolari difficoltà. Una lieve febbre fu registrata nel novembre 1860; un episodio più grave si ebbe nei giorni del Natale successivo. I sintomi manifestatisi la sera del 29 maggio 1861 parvero riconducibili ad una delle solite indisposizioni; il primo ministro rincasò dopo una lunga seduta in parlamento, dopo discussioni accese sul bilancio eccedente dell’anno 1860. Cenò con i familiari, poi cominciò ad avvertire brividi, un malessere indefinito seguito da vomito violento e da acuti dolori intestinali. Fu subito chiamato il dottor Rossi, allievo del dottor Tarella che per più di vent’anni aveva curato la famiglia. Rossi cercò prima di tutto di fermare il vomito, ma non ebbe successo. Ordinò quindi un primo salasso che parve ottenere la remissione della febbre. Il mattino seguente ne fu applicato un secondo e il pomeriggio un terzo. La pratica del salasso era comune a tutta la medicina del tempo, ogni qual volta si sospettava che un eccesso di sangue opprimesse il malato oppure fosse in corso un attacco di apoplessia, cioè una emorragia a carico di organi interni. La scuola medica torinese non faceva eccezione, anzi aveva fatto del salasso il suo credo. La febbre, alta per tutto il giorno, scomparve nel corso della notte. Venerdì 31 maggio Cavour si svegliò lucido e in forze, convocò addirittura i ministri per definire le questioni più urgenti. Nella notte torna- 160 rono prima i brividi, poi la febbre alta e il delirio. All’alba il dottor Rossi tentò di contrastare la febbre somministrando il chinino, ma il conte ebbe una crisi di vomito. Era già di uso comune in Europa la polvere di chinina o chinino, ricavata dalla corteccia dell’albero della China, detta anche polvere dei Gesuiti, che per primi l’avevano introdotta dal Perù (era nota infatti anche come polvere peruviana). Tuttavia veniva usata solo per curare in modo estemporaneo le febbri perniciose ed aveva un prezzo elevato. L’uso era malvisto dai medici perché contrastava con la teoria “umorale” galenica che l’accesso febbrile era causato da una materia, o fermento, che andava eliminata dall’organismo con proficue evacuazioni, fino alla guarigione, quindi tramite salassi ripetuti o clisteri. Chi non ricorda il Dottor Purgone di Molière? Vanificato ogni effetto del chinino, il giorno successivo il dottor Rossi praticò due nuovi salassi, che contribuirono a debilitare ulteriormente il fisico già provato del conte. Il lunedì mattina il delirio perdurava, il respiro del conte era sempre più breve, la sua sete implacabile, nonostante il ghiaccio tritato che gli veniva somministrato. Venne convocato il dottor Baffoni, un chirurgo, che praticò una nuova incisione «ma il sangue non sgorgò: a forza di comprimere la vena, giunsero ad estrarre due o tre once di sangue nero e coagulato». Seguirono fasi alterne, di lucidità e benessere alternati a delirio febbrile. Verso l’alba di giovedì 6 giugno 1861 le condizioni peggiorarono rapidamente: il conte era sudato e debolissimo; gli somministrarono una tazza di brodo e un bicchiere di vino, gli applicarono impiastri e pezze scottanti. Nessun rimedio sortì effetto, il polso rimase debolissimo e la sua parola divenne più difficoltosa. Alle sette del mattino morì. Il decorso della breve malattia del Conte Cavour ha tutte le caratteristiche di un attacco maligno di febbre malarica, che, essendo stato curato con i rimedi dell’epoca, lo condusse a morte. I medici convocati al suo capezzale furono corretta espressione del tempo: con estrema difficoltà, tra pregiudizi e dubbi, la medicina ini- 161 ziava a percorrere la via della ricerca e della scoperta nella fisiologia e della patologia, ma cozzava contro basi teoriche e pseudofilosofiche datate che si basavano su flussi umorali e influssi astrali. Ancora più lento fu il cammino della farmacologia, impaludata in rimedi primordiali come salassi, impiastri, brodi, enteroclismi. Basta ricordare che il brevetto della Bayer dell’aspirina, uno dei farmaci che ha rivoluzionato il mondo e che tuttora trova larga applicazione terapeutica, risale al 1899. Larga eco ebbe la morte prematura di Cavour: nel luglio 1861 alcuni giornali scientifici inglesi importanti, come il New England Journal of Medecine e il Lancet si scagliarono contro il comportamento ignorante e retrivo dei medici chiamati al capezzale di Cavour, rimproverando la loro rigidità e ottusità. In ogni caso nessuno avrebbe potuto evitare, con i rimedi del tempo, che la malaria stroncasse la vita dell’artefice dell’Unità d’Italia. 162 VOCI E SCRITTURA VERSI 163 Nicolina D’Orazio LA BREHANTÉSSE Durméve che na facce de quatrane mò che nu schiuóppe gli aveva ferute, scappènne pe’ la sélve andà nisciune, essa sóle, gli avéve retruate. Addurmite a gliu jacce, all’addijune, s’éve ammantate nche na vecchia scialle e s’eve abburretate la cammiscie attorre attorre andà stéve le sanghe. Àlema zòzze, óme zenza córe che magne pane e casce che na méne e che quel’àutre règge la pestole: tampe de sive e pórvele da spare. Quanta gènte èva accise Salvatóre! E proprie a ésse éva ite pe’ sórte de pèrde onóre e facce pe’ n’amóre cunsemate arrubbate pe’ le fratte… La criature nascètte na matine dentre a gliu stazze de nu pecurale, ca fo meserecòrdie de nu frate recòglie e purtàresele abballe. Pazze assassine ladre delenquènte che la vesacce sèmpre chiéna d’òre facéva piagne la pòvera gènte. Ma fòva gli ome sì, gliu prime amóre. 164 LA BRIGANTESSA Dormendo aveva il volto di un bambino ora che un colpo di fucile lo aveva ferito riparato nella selva dove nessuno, lei sola, l’aveva ritrovato. Addormentato all’addiaccio, a digiuno, s’era ammantato con un vecchio scialle e aveva arrotolato la camicia intorno intorno dove usciva il sangue. Anima sporca, uomo senza cuore che mangia pane e cacio con una mano e con quell’altra afferra la pistola: tanfo di sego e polvere da sparo. Quanta gente aveva ucciso Salvatore! E proprio a lei era toccata la sorte di perdere onore e faccia per un amore consumato rubato per le fratte… La creatura nacque una mattina dentro lo stazzo di un pastore che per misericordia un frate raccolse e portò con sé a valle. Pazzo assassino ladro delinquente Con la bisaccia sempre piena d’oro Faceva piangere la povera gente. Ma era l’uomo suo, il primo amore. 165 Sótte na cèrque, isse fridde n-tèrre, vita fenite come n’anemale. Nisciuna spranza cchiù, mala venture! Méssa n-galére o mòrta fucelate… Dialetto di Cansano 166 Sotto una quercia, lui gelato a terra, vita finita come un animale. Nessuna speranza più, mala ventura! Messa in galera o morta fucilata… 167 F. Hayez, Il bacio (1859), Milano, Pinacoteca dell’Accademia di Brera 168 Nicolina D’Orazio IL BACIO DI HAYEZ Nu frusce quéla vèste… … pedate de scarpóne. Spàseme la fémmene abbracciate a quigli óme. Nu vasce accuscì fòrte arrubbate annascusce sótte la scalenate nda la vèste strusce Stritte fòrte abbracciate contre la malasórte ómbre de portarréte… … stritte cóntre la mòrte. Nu vasce che se ficche pure déntre a le véne non è pentate, è vive, e jèsce da la téle. Dialetto di Cansano Il Bacio di Hayez. Un fruscio quella veste … / orme di scarpone. / Spasima la donna / abbracciata a quell’uomo. / Un bacio così forte / rubato di nascosto / sotto la scalinata / dove struscia il vestito. / Stretti forte abbracciati / contro la malasorte / dietro delle ombre / … stretti contro la morte. / Un bacio che ti penetra / pure dentro alle vene / non è dipinto, è vivo / ed esce dalla tela. 169 Nicolina D’Orazio W LA LEBERTÀ … Córe de mamma sé’, core de mamme, gliu figlie mì fatiche che’ la sarchije pussente gne le cèrque te’ le vracce… come na capenére so’ chiglije uócchije. Córe de mamma sé’, core de mamme, va a repiglià le pècure a gliu jacce le tòcche una peduna, e dapù mógne e repòrte alla case casce e latte. Córe de mamma sé’, córe de mamme, è l’óre de lassà bèstie e muntagne, pure gli prèute prèdeche la lòtte nen ze ne po’ chiù, le truóppe è truóppe. Córe de mamma sé’, córe de mamme, è scite all’annascusce a mezzanótte… e s’abbije addemane che’ gliu schiuóppe nen po’ repusà chiù, le sanghe je vólle. Córe de mamma sé’, córe de mamme, j ave ditte ca vave a mille a mille pare nu fremmecare che se móve… e se sente abbruscià gliu córe m-piette… … E pure alla muntagne vé’ la nóve: W la lebertà, l’Etalije è fatte! Córe de mamma sé’, córe de mamme, a quéla préte ave scritte gliu nóme. Dialetto di Cansano 170 W LA LIBERTÀ ... Cuore di mamma sua, cuore di mamma il figlio mio lavora con lo zappone possenti come una quercia tiene la braccia come una capinera sono quegli occhi. Cuore di mamma sua, cuore di mamma, va a riprendere le pecore allo stazzo, le conta una per una e poi munge e riporta a casa cacio e latte. Cuore di mamma sua, cuore di mamma, è l’ora di lasciare bestie e montagne pure il prete predica la lotta, non se ne può più, il troppo è troppo. Cuore di mamma sua, cuore di mamma, è uscito di nascosto a mezzanotte… e si avvia domani con il fucile non riesce a dormire, il sangue gli pulsa. Cuore di mamma sua, cuore di mamma gli hanno detto che vanno a mille a mille sembra un formicaio che si muove… e si sente bruciare il cuore in petto… … E pure alla montagna arriva la notizia: W la libertà, l’Italia è fatta! Cuore di mamma sua, cuore di mamma, su quella pietra hanno scritto il nome. 171 Maria Pia Palesse L’ITALIA AUNITE All’óre de la calla, ammónt’all’are m’ève calàte quasci na cecagne quanne s’appresentì all’assecrune na fémmene dappéte a la muntagne. ‘N cape la còcene e lu spianature nghe na póste de pane e la lasagne, na vrócche apù de vine pe’ l’arsure che rescève da sótte la tuvaje. Éve vestute cummà cchiù n’ s’aùse la vésta lónghe affin’ai calecagne nu scialle scure p’accappà le spalle chióchie de pézze nghe nu spache archiuse. Ma i pentantiffe d’óre e de curalle, capille nire nghe nu tuppe arréte, j’uócchie mmà du merícule de fratte vócch’a cerace e uance cummà sète. J’addumanniétte andò che se ne jève, a n’óra calle, vérse la muntagne, cuscì cunciate, e alloche chi ce stève da putésse gude’ chéla cuccagne. M’arrespunnì ch’allóche ce tenève lu nnamurate sì, ch’ève scappate dapù che nu giandarme lu cerchève pe’ fallu presenta’ ffa’ lu suldate. 172 L’ITALIA UNITA Al sol della canicola, sull’aia, ero pervasa da un dolce sopore quand’ecco che di contro alla montagna una donna m’apparve nel chiarore. Portava sulla testa un grosso cesto con vivande fumanti a profusione la brocca traboccante di vin fresco a completare quella libagione. I suoi vestiti eran fuori moda gonna che la caviglia s’intravede scialletto nero che la vita annoda di pezza lisa le babusce al piede. Ma gli orecchini d’oro e di corallo capelli neri accolti sulla nuca occhioni più lucenti d’un cristallo bocca a ciliegia e gote di velluto. Le domandai dov’è che se ne andava con quel gran caldo verso la montagna così vestita, e poi lì chi ci stava che gli portava quella gran cuccagna. Mi rispose che lì si nascondeva l’innamorato suo ch’era fuggito, dal gendarme inseguito, che il voleva arruolar con l’acerrimo nemico. 173 “Tiénghe a la macchie pure nu fratiélle e pàteme nen sacce andò se tróve. Pe’ lu pajése è tutte nu maciélle chi scappe e s’annascónne o è tradetóre. Ce lìvene le vracce a la campagne pe’ ji’ a servi’ stu Re de lu Piemónte nghe j’uómene alla férme, che se magne? Ciérte, nghe Franceschiélle n’ c’è cumbrónte! Se macìne le rane nóttetiémpe pe’ putéll’affrancà da lu canòne, e annascónne la róbbe è nu cemiénte pe’ purtà da magna’ ai desertóre. Ma se dapù ve’ côte a la spruvviste na fémmena, fernisce fucilate, lendanne o ardevénne bregantésse o, pe’ salvà la pélle, svrehugnàte.” Senténne le paróle che decìse faciétte pe’ mustramme resentite, ma jèsse, ch’ève ‘ntése, arrespunnìse “No! Nen se fa cuscì l’Italia aunite”. Dialetto di Sulmona 174 “Pure mio padre non so dove sia ed un fratello s’è dato alla macchia per il paese è tutta un’anarchia chi scappa e si nasconde e chi vivacchia. Ci tolgon chi lavora la campagna per servir un, che viene dal Piemonte. Con gli uomini arruolati, che si mangia? Non c’è con Re Francesco alcun confronto! Si macina al mulino nottetempo per non pagar la decima sul grano, nasconder le provviste è un gran tormento per rifornir di cibo chi è lontano. Ma se una vivandiera vien scoperta, senza più scampo lì-lì è fucilata e se sfugge diventa brigantessa o si salva, però disonorata.” Sentendo proferir queste parole tentai di reagire, risentita, ma quella, prevenendomi, rispose: “ No! Non si fa così l’Italia unita.” 175 Maria Pia Palesse NA LÈTTERE DE LENDANNE L’atra matine, pe n’ sapé’ che fa’ sajétte su le lamie a rvuceca’. Jève cerchénne na vécchia lantérne n-miézze a quile rehuòteche de mbiérne quanne che pe scansa’ nu pórtambrélle caschì na scatele de stagnarélle. S’ève arrapèrte e n-térre avé spaliàte tutte fujìtte gnallite e fruàte. N’arraccujétte vune, ncuriusite, nghe le scritte cecate e sculurite. Eve na léttra scritta a lu tatóne de lu tatóne mì, da na priggióne, ai tiémpe de i Burbune e Carebalde, Mazzine nghe i Savóje e i bregante. “Care cumbare - cuscì ncumenzévestiénghe n-galére pe scampà la léve. Te pórte chésta léttere alle scure cumpà Cicce, pe fótte la censure. Pirò nen è mó chéste la passióne, sóffre, cchiuttoste, pe la delusióne. Ci-avàvame credute, t’arrecurde, a Carebalde nuóstre e ai descurse de lu Mazzine che, se n’ se capève, pure nu fuóche n-piétte t’appiccéve. Ce pensavame ca l’Italia aunite fusce libbere e forte, no asservite a la curóne d’une de Savóje che, pe pute’ cunta’, tutte ce tóje. Fenanche ésse p’ammónte s’ha purtate l’óre de Banche nóstre accatastate 176 UNA LETTERA D’ALTRI TEMPI L’altra mattina per non aver da fare me n’andai in soffitta a sfaccendare. Non mi ricordo che andavo cercando fra quelle cianfrusaglie rovistando, quand’ecco, per scansar un portaombrelli, feci cadere una scatola di ferro. Si aprì e in terra cadder sparpagliati tanti foglietti gialli e logorati. Ne raccolsi uno per curiosità che a stento si poteva decifrar. Era una lettera scritta ad un mio avo da un suo amico che in galera stava, ai tempi dei Borboni e Garibaldi, Mazzini coi Savoia ed i briganti. Caro compare - così cominciava – m’hanno arrestato perché disertavo. Ti porta questa lettera, all’oscuro, compare Ciccio, per schivar censura. Ma non è questo che mi fa impressione, soffro, piuttosto, per la delusione. Ci avevamo creduto, ti ricordi, a Garibaldi nostro e ai discorsi di Mazzini che, se non lo capivi, pure un fuoco nel petto ti sentivi. Noi credevamo che l’Italia unita esser dovea libera, no asservita alla corona del re di Savoia che, per espander sé, a noi ci spoglia. S’è portato, perfino, su in Piemonte, l’oro di nostre Banche, per affronto, 177 pe fasse frabbeche e strade ferrate e a nu la tasse de lu macenate. Framménte a Carebalde, spruvvedute, la fine j’ha fatte fa’ de lu curnute”. Dialetto di Sulmona 178 così, lì fabbriche e strade ferrate e qui da noi la tassa al macinato. Mentre che Garibaldi, lusingato, ha fatto la figura del gabbato. 179 Maria Pia Palesse LA LUME AJARDE ANCORE La lume ajarde. Ancóre n’ s’ha rammórte. Se sénte l’uóje frije lu stuppine. Piagne la vécchie pe la mala sórte e préha e la spéranze n’ ha cumbine. Lu fije ch’alla macchie se n’ ha jite pare ca pe nu schiuóppe de trumbóne mo’ va scappénne ammónte pe ‘sse ripe appriésse a chii suldate de i Burbóne. Piagne la vécchie. N’ s’addune ca Mórte, méntre che préha, l’ha gnónte alla fine. L’utema hùttele allu córe ha scórte. Liénte lu cape je s’appóje ’n sine. La lume ajarde ancóre. N’ s’ha rammórte. Dialetto di Sulmona Il lume arde ancora - Il lume arde, ancor non s’è smorzato / e l’olio crepitar fa lo stoppino. / Piange la vecchia il suo cattivo fato / e prega con speranza senza fine. / Il figlio che alla macchia s’era dato / sembra per uno sparo di trombone / sui monti impervi or s’è rifugiato / insieme a quei soldati del Borbone. / Piange la vecchia e non scorge la morte / che, mentre prega, l’ha condotta al fine / Di sangue il cuore non ha più risorse. / Sul seno lei reclina il bianco crine. / Il lume arde ancora, oltre la morte. 180 Evandro Gay PE’ GRAZIE DE DDIE Lu vinte Uttobre ’Ottecientesessante Vettorie ’Mmanuele de Savoie, accumpagnate da cavalle e fante, se fermise na notte a la Badie, a nu casale ditte Ville Ursine, ’m-bacce a la grotte de Pietre Celestine. Se sunnì Frate Pietre da Murrone, che je mettise ’n-cocce na curone e je decì: «Recùrdete, Vettorie, che tu mo’ sci lu Rre de la nazione pe’ grazie de Ddie e ’n sta a fa storie, nen cementà lu Pape che sta a Rome!». Stu suonne je facì tanta ’mpressione e repartì penzenne a Carebbalde, che a Rome la ’uleve pijà d’assalde. E quande lu ’ncuntrise po’ a Teane e Peppe je mettì l’Italie ’n-mane, dicì: «Grazie, Peppì, ma mo’ te firme». Garebbalde capì e chela sere facise le balisce pe’ Caprere! Dialetto di Sulmona 181 Diana Cianchetta GIANNINA MILLI 1 Poitésse teramane de lu Resurgemiénte, sémpre e andodunque a ’mpruisà poisìe, de Cavur e Garebalde spalìe i sentemiénte, l’ardóre, le speranze, l’aidé e la fantasie. Declame i viérze ’nche l’ànema taliane, lu spirde naziunale tetille a ognedune: pè’ chèll’Etàlie che nn’è chiù luntane métte lu póce alla récchie de i Burbune. Vedè i culure de ’na bandiéra sóle, tenè appecciate la luce che già brille… Pé’ la Pàtrie Giannine s’accalóre, e rassume, pé’ fòrze, tutte i Mille. Dialetto di Sulmona 01 Milli Giannina, poetessa (Teramo 1825 – Firenze 1888). Improvvisatrice famosa, percorse tutta l’Italia dando “accademie” di poesia improvvisa, spesso animata da caldi spiriti nazionali. [Dizionario Enciclopedico Italiano – Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Roma 1970, vol. VII (LIEC-MOL)]. 182 GIANNINA MILLI Poetessa teramana del Risorgimento, sempre e dovunque a improvvisar poesie, di Cavour e Garibaldi diffonde i sentimenti, l’ardore, le speranze, le idee e la fantasia. Declama i versi con animo italiano, lo spirito nazionale titilla in ognuno: per quell’Italia che non è più lontana mette la pulce all’orecchio dei Borboni. Vedere i colori di una bandiera sola, tenere accesa la luce che già brilla… Per la Patria Giannina si accalora, e riassume, per forza, tutti i Mille. 183 Diana Cianchetta LU MUNUMÉNTE AI CADÙTE M’miézze a la Piazza Trésche de Sulmóne la nònna mé arrepé lu trainille e sénza manche farme nu sermóne caléve e rastraméve j’asenille. Lu spiéghe de raziune e de fermate éve la huérre quìnnece-deciótte quanne tató murise pe’ granate ’n trencére resbauzate sópre e sòtte. Nònna alla huérre l’óre avé dunate e nen tenéve chiù féde a lu dite; l’amóre pe’ la Patrie avé cuntate ma i s’éve repijate lu marite. E mó’ m’ bacce all’elénche marmurate nònne m’appeccéve fèrme e dritte, e scurrénne apù i nóme de i suldate de Giachemucce s’appunté a la scritte. Fra chii cadute recurdéve a ménte ndò stéve lu marite tant’amate che pe’ raunì a nù Triéste e Trénte le sangue pe’ la Patrie ave’ jittate. Manchéve lu sustégne a la famìjje, lu sole che spuntéve ògne matine; da sóle mantenéve tutte i fìjie e iéve pure jésse n’eruine… 184 IL MONUMENTO AI CADUTI In mezzo a Piazza Tresca di Sulmona mia nonna accostava il carrettino e senza farmi raccomandazioni scendeva per stramare l’asinello. La spiegazione di preghiere e sosta era la guerra quindici-diciotto, quando mio nonno morì per le granate in trincea sopra e sotto rimbalzate. Nonna alla guerra l’oro aveva donato, e non aveva più la fede al dito; l’amore per la Patria aveva contato ma le aveva portato via il marito. Di fronte a quell’elenco sopra il marmo mia nonna mi teneva ferma e dritta, e scorrendo poi i nomi dei soldati si fissava dove Giacomo era scritto. Fra quei caduti ricordava a mente dove stava il marito tanto amato che, per riunire a noi Trento e Trieste il sangue per la Patria aveva versato. Mancava il sostegno alla famiglia, il sole che spuntava ogni mattina; nonna da sola provvedeva ai figli ed era anche lei un’eroina… 185 La génte se reutéve a la Majélle, cencechénne raziune ’nghe la ménte, còcch’óme se caccéve lu cappiélle e nònneme piagnéve sulaménte. I’ ch’éve ’na pezzuta peccerélle vedé’ le sangue scòrre a la culònne, repeté’ réquie cum’a nu martiélle tremé’ ’mpaurite e me stregnéve a nònne. Dialetto di Sulmona 186 La gente guardava la Maiella, e biascicava le preghiere a mente, qualche uomo si toglieva il cappello e mia nonna piangeva solamente. Io che ero una piccola pizzuta vedevo il sangue giù per la colonna, ripetevo dei Requiem a martello e tremavo impaurita stretta a nonna. 187 188 VOCI E SCRITTURA PROSA 189 190 MARIANNINA La civetta riempiva col suo cucumeo il silenzio della notte. – Brutte signe... – disse tra sé e sé Terresina – la ciuetta o cante o piagne... – E intanto, prima di coricarsi nel giaciglio da poco rinnovato con le spoglie delle ‘mazzocche’, ammucchiava la cenere nel camino, sopra ci faceva un segno di croce e bisbigliava la giaculatoria: – Ie me coleche che’ Criste i che’ San Giuvanne Battiste, a cape aglie cape S. Mecchele, apped’aglie pede S. Battelummeo i S. Margarita... alle lenzola S. Necola... i le male lengue tra la vurasce... Ogni giorno somigliava a quello precedente, con la sacralità delle fatiche d’ognuno. D’intorno gli odori degli animali mansueti. Prima di rientrare, durante il bel tempo, Mariannina, poco più che bambina, figlia maggiore di Terresina e di Matteo, nel fontanile affogava per gioco i piedi sempre nudi, si divertiva a inventare per qualche momento lo zampillìo con giochi d’acqua, poi si tuffava in una corsa sfrenata sulla via polverosa e raggiungeva i fratelli nello stazzo. Mariannina era una bambina bella, delicata, e sembrava che poco avesse a che fare con la vita di quel poverissimo mondo. Era finita l’estate, ed era finito anche il bel tempo, ma il da fare non mancava mai. – Cuménzate a ‘mbarà cumma se fa a ‘mbrudelà le lendicchie, cuscì nen se cellane... – le disse la mamma. Le lenticchie raccolte, ormai essiccate, dovevano essere scottate per pochi minuti per essere conservate come scorta annuale senza che fossero ‘cellate’, bucate dalle larve in crescita in primavera. Le cimiciare si erano rintanate, gli uccelli di passo sparivano presagendo nell’aria l’inverno a venire. Il tempo rarefatto sembrava più immobile che mai. Le lenticchie stese sopra il pannone dovevano asciugarsi per essere poi infilate dentro i sacchetti nel ripostiglio scavato nel muro di pietra. Ed erano anche i giorni dei briganti. Sopra i monti, tra le fitte boscaglie di Forca la banda terrorizzava la popolazione con le sue incursioni. Erano giorni normali che si mescolavano a fatti straordinari ed irregolari. Mariannina pascolava nel prato le due pecorelle nel- 191 l’ultima erba calda. – Vide sempre se ce sta la ielata, sennò le pecore s’abbottene e crepene! – le diceva sua madre. Così a poco a poco i tramandi le insegnavano la vita. Qualche volta Mariannina guardava oltre la radura e immaginava i briganti. Lei non era come gli altri, non aveva paura perché non li aveva mai visti. E comunque, ogni tanto. quando si avventurava con i fratelli e con la madre per le contrade, avvertiva come un alito, ma non era il vento. Al tempo dei viaggi dei transumanti le donne, per far sì che gli orsi non assaltassero pastori e greggi, distribuivano lungo i tratturi latte e mele per saziare gli animali. Mariannina allora ogni tanto prendeva di nascosto del latte e delle mele dal fondaco per calmare anche la fame dei briganti. Oppure rubava un pezzetto di lardo o di strutto e lo deponeva al bordo della radura. Il padre intanto, aiutato dai figli maschi, preparava le sementi, si accordava con i vicini per le giornate ‘alla parte’, preparava la palizzata, la legna secca per il fuoco e stendeva le ‘vurancate’, alte fascine di rami frondosi di querce ‘scamollate’ legate con le ‘chiorte’ che odoravano all’aria. Il tempo che passava non cambiava lo stato della miseria, anzi, ogni giorno rendeva le condizioni senza misericordia. Don Carlo, il prete che aveva provveduto alla vendita carbonara, era stato allontanato. La famiglia di Don Lorenzo invece si era arricchita con l’aiuto di qualche scagnozzo. In sella ai cavalli, di buon mattino, arrivavano e scacciavano dai fazzoletti di terra i poveracci che, a colpi di frusta, rinunciavano al poco avere e finivano garzoni al suo servizio. Nella sua casa, sull’altura, scriveva il segretario di casa. Annotava minuziosamente le spese, i prestiti e i fatti importanti delle giornate. Fu proprio in quel tempo che ricevette la lettera di suo cugino don Fernando, notaio benestante che viveva a Roma che, appena ammogliato, gli chiedeva il favore di mandargli una giovane campagnola sana e di bell’aspetto, da tenere in casa al suo servizio. Don Lorenzo ci pensò un po’ ma non ci volle molto per farglielo questo favore a don Fernando. Dopo qualche giorno, infatti, fece chiamare Terresina e Matteo raccomandando di portare anche la figlia. Li accolse in casa, scrutò prima Mariannina, poi la mandò in cucina, dove si diffondeva un profumo mai sentito d’arrosto speziato, e subito, senza fatica, spiegò la cosa con poche parole. L’opulenza mai vista prima parlava per lui. Li congedò 192 con un sacchettino di soldi. – Là avrà di che sfamarsi... ogni giorno... – si convinsero, camminando per la via che li riportava a casa e che si restringeva sempre più tra i vicoli a raggiera. La madre le mise al collo una collanina di corallo, e con il padre che l’accompagnava Mariannina partì. Era terrorizzata ma non lo dimostrò per tutto il tempo che la portava a Roma. Ne cambiò un paio di traini, con il primo, in compagnia di due donne che andavano a barattare le verdure da rivedere con del vino, arrivò fino a Celano, poi con l’altro proseguì, lungo mulattiere, il viaggio fino a Roma, con altri mercanti. Per un breve tratto avvertì l’alito che non era vento, ma poi svanì... tutto sparì... la casa, il paese, la fonte e la gente, alle sue spalle. Si aprì un portonaccio e apparve uno scalone d’onore. Il padre la consegnò. Poi, con la schiena curva, riprese il viaggio di ritorno. – È finito il tempo di “Viva o re!” – furono le prime parole che udì Mariannina mentre saliva con la donna grassa che aveva aperto. La prima cosa che vide invece fu un gruppetto di quattro uomini ben vestiti, che fumavano il sigaro e che uscivano di casa. Un quinto giovane uomo, rimasto su, lo vide chinarsi per accomiatarsi dai suoi ospiti per poi andarle incontro. Don Fernando l’accompagnò per un attimo nel salottino; la moglie, donna Margherita, seduta tra chicchere e piattini conversava con un’ospite. Non la fece avvicinare, la guardò a distanza, senza parlare, quindi la donna grassa accompagnò Mariannina in una stanza al piano superiore, per un bagno caldo completo. La donna le diede un vestito largo, una cuffietta arricciata e un grembiulone, e poi, pane e frittata. Nella grande casa c’erano grandi quadri, grandi tavoli e tante stanze. Tutto sembrò gigantesco ai suoi occhi, e nuovi odori la attorniavano. La donna grassa le insegnò gli inchini e a togliere il piscio notturno dagli urinali dei padroni, a servire e via via tutte le altre faccende. I giorni a venire odoravano di lavanda nella biancheria, si riempivano di schiamazzi nei piccoli banchi di vendita rionale lungo le strade, di storie in lontananza. Don Fernando cercava di essere al riparo dai grandi eventi ma era sempre curioso di appurare, di sapere di quei giorni difficili... – Ci pen- 193 seranno quelli della Guardia Nazionale a quei briganti con l’unificazione... Come se non bastasse l’euforia della rigenerazione incombente. – Con la legge Pica, continuava, faranno piazza pulita di questi fuorusciti (delinquenti?). Oramai, non hanno scampo. Dopo le sue carte notarili, nel salotto, con i soliti amici, gli avvenimenti, le notizie che si rincorrevano e non davano spazio ad altri pensieri. – I briganti sono senza legge... non hanno un ideale... sono stati mercenari... sono solo banditi e razziatori... – si commentava. – Sono morti di fame che non hanno né posto né futuro... ma intanto ti fanno malcampare... E don Fernando: – Ci vuole prudenza... di questi tempi a Forca, per esempio, non ci devi passare senza protezione, e quella neanche basta... – Ma intanto pensava alle sue terre a fondo valle, ora terre di nessuno. – La fame caccia il lupo dalla tana... e poi... sicuramente hanno i loro protettori... L’ ospite di turno allora si accalorava: – Dal basso non viene mai la rivoluzione, la storia ci insegna... il papa, ‘o re’, i Francesi e Garibaldi, i Savoia... Che fine ha fatto il Re a Napoli, per dirne una? Sono questi che cambiano senza soccombere, non la plebe... dobbiamo esserne coscienti; quelli che non sono stati imprigionati tirano la carretta, zappano col bidente e i padroni se ne guardano bene dal denunciarli... è manovalanza a basso costo... Ora che non hanno più speranza di riportare i Borboni sul trono poi... al sud... – Questi analfabeti o ubbidiscono o si difendono così... per vendetta, per fame: la macchia o la morte o malpagati in clandestinità... I briganti ci sono sempre stati... in tutti i tempi... Il popolo non si sa unire e se lo fa, insorge con le ‘sarrecchie’ e con le picche... ma non ha legge... se non quella della pancia vuota... e quella non fa mai ragionare, non fa mai riflettere... – Ma ora che sono solo banditi ... quale alternativa? – Niente... ci stanno pensando i Piemontesi a questi meridionali, le guardie a stanarli... vedrete... e tra un po’ nulla sarà come prima. – E già, concluse uno dei quattro, questi meridionali sono analfabeti, sono ‘cafune’... si reggono le brache con le funi... non sono né padroni né servi. 194 A don Fernando non gli importava di parteggiare per nessuno e stava a guardare. Si limitava a restare a galla in quel tempo infernale e difendeva solo se stesso. Se ne erano viste delle belle in quegli anni, non apprezzava i tumulti passati né la nuova corona sabauda. In cuor suo, per quel che poteva, aveva simpatia per la corona napoletana. Mariannina poco capiva di quei discorsi, non conosceva quella lingua né comprendeva il succedersi dei fatti. Viveva quel tempo tra l’indifferenza della padrona e le occhiate del padrone. Si sentiva contenta solamente quando accompagnava la donna grassa al mercato. Lì, ogni volta, tra le merci e la gente, avvertiva una sensazione di leggerezza. Un giovane si teneva a distanza. Lei si sentiva addosso la sua presenza forte e discreta. Era alto e magro, dall’inconfondibile aspetto da zingaro. Portava un orecchino che faceva risaltare i suoi occhi scuri. Lei aveva nelle orecchie quel fiato che non era vento. Ogni sera, dopo aver sfaccendato per bene, si rincantucciava nella sua stanzetta. Rannicchiata s’addormentava stringendo tra le dita la sua collanina. Così il tempo passava con i suoi perché e i problemi della gente. E arrivò una notte qualunque, uguale a tutte le altre, buia e calda di sonno... Mariannina si sentì addosso lenti respiri profondi, un corpo pesante e caldo e una mano le strinse la bocca. Un urlo soffocato. Come un tuono, come un fulmine, come una pietra, come un fuoco, come un pugnale: Mamma, dove sei!!... E non fu più bambina. I giorni passavano, tra i padroni indifferenti e il silenzio. Anche altre notti passarano. Brevi scricchiolii della porta cambiarono le notti di Mariannina. La donna grassa che la teneva sempre d’occhio la vide impallidire sempre più. Misurò con un dito la distanza tra la collana ed il collo e le disse: – Tu sei incinta... – Poi fece in modo di procurarle un vestito ancora più ampio e quando arrivò il momento la condusse su un carretto in periferia. Mariannina si aggrappò a delle funi che pendevano nella stalla e partorì. La donna le tolse il bambino senza parlare, la sistemò nel casolare per qualche giorno, e poi la vita riprese di nuovo come prima, con Donna Margherita che rimaneva in silenzio tra i suoi merletti, don Fernando che non parlava più dei briganti e i servizi da sbrigare. 195 Arrivò il bel tempo. Per Mariannina nulla fu più uguale a prima. Dormiva con un coltellino sotto al guanciale così Don Fernando sfogò le sue voglie altrove, e piano piano lei maturò la fuga... – Meglio morire – pensò – che restare qui... – Preparò di nascosto un sacchetto con delle candele consumate e dei prosperi, si vestì con più panni che poteva, da sembrare quasi una zingara, scese lo scalone e scomparve tra le strade. Si avventurò sperduta e un po’ guardinga tra sentieri e valli con il sacchetto, un bastone e un coltello. Camminò a lungo. Campi e poi valli, in compagnia di donne che andavano a portare i canestri del desinare agli uomini nei campi. Vide uomini poco più che bestie trainare carretti e pietre, bifolchi smunti mimetizzati nei campi. Chiese l‘elemosina e cercò ripari notturni. Vagò tra i monti per giorni prima che riannusasse l’aria delle sue terre. Di notte accese dei focherelli per allontanare gli animali selvatici. Mangiò ‘mbriachelle’ secche, i frutti del biancospino e le erbe crude. – Meglio morire, meglio morire... – si ripeteva – che rimanere lì –. Salì le impervie alture in cui nessuno si avventurava facilmente e vide alcune povere croci da sepoltura. – ‘Ecche ce stanne i breghente!!! ... Ce sta la banda Cannone che deceva papà... – pensò e capì. Scrutò l’orizzonte e vide degli uomini a cavallo. – Forse sarranne quiglie della Guardia Nazionale... quiglie che deceva don Fernando... o so’ breghente? In un attimo si sentì sperduta. Guadagnò un sentiero verso un tramonto che odorava di tumarelle. Lo sterrato discendeva a tornanti giù, verso il basso. In lontananza sentì l’abbaiare di cani. Apparvero quattro casupole, e il vento portava l’odore del fumo dei comignoli. Fu allora che all’orizzonte udì degli spari. Rimase per un bel po’ immobile tra i cespugli e l’erba alta. Quando nell’aria tornò la calma e il silenzio della montagna, ebbe la forza di avvicinarsi. Il cielo scuriva, e nella penombra vide il corpo moribondo dello zingaro dall’orecchino. Col cuore in gola gli fasciò la spalla con lo scialle, poi lo accomodò alla meno peggio su una portantina di frasche e scese a valle. Lo sistemò sotto il primo muro di pietra che trovò a fianco di un fienile semiabbandonato. Dormì su un mucchio di paglia. All’alba un cane le ringhiava addosso mentre un uomo dalla lunga barba lo teneva a bada. – Stai lontano o dò fuoco alla paglia! – lei urlò senza neanche rendersene 196 conto mentre cercava di prendere un fiammifero dalla tasca. L’uomo, che si chiamava Giovanni ed era il padre di Francesco, il giovane dall’orecchino, la guardò con tranquillità e le porse una mano per aiutarla ad alzarsi. Alcune donne poco distanti si avvicinarono e scesero insieme fino alle casette. Con degli infusi lavarono e curarono la ferita del ragazzo. Mariannina lo vegliò, e intanto intuì la sua salvezza. Quel fiato che non era vento dall’ombra divenne aria calda e avvolgente. Le famiglie laboriose delle casette lavoravano sodo da stella a stella i loro campi aridi ed avevano cibo. ‘Caciotto’, era il soprannome di Francesco, si tolse l’orecchino, gli abiti da zingaro e accompagnò i giorni buoni di Mariannina nei prati in discesa, negli stazzi. Piano piano scordarono i brutti ricordi. Non parlarono più neanche di quello della guardia nazionale che aveva sparato a Francesco per una ‘rozzeca’ di formaggio e poi lo aveva schernito: – W Francesco o W Vittorio? – che era il vecchio espediente per togliersi lo scrupolo, sentirsi eroe e ammazzare qualcuno. Arrivò il mese di maggio: Giovanni e Francesco avevano tosato le pecore. Mariannina lavò e filò quella lana con le vicine. Antonetta, la matriarca, la chiamò vicino a sé e le disse piano: – Vai a raschiare un po’ di fuliggine dal camino... – Intanto l’acqua bolliva nel caldaio. Mariannina ubbidì. Antonetta prese quella polvere nera, la sciolse nell’acqua poi le disse: – ‘Mbàrete cumma se tegne la lana... – Mariannina affogò la lana nell’acqua nera poi la stese al sole: era color cannella. – La prossima la culure che’ le clocchie de nuce! – le disse poi ridendo. Ogni tanto mentre sfaccendava faceva finta di non sentire arrivare alle spalle Francesco, che di soppiatto l’abbracciava per rotolarla nel prato. A Forca i briganti continuavano ad assaltare e a derubare i viandanti. Le stagioni portavano a turno il proprio da fare. Ogni tanto un pellegrinaggio dalla Marsica si portava a S. Donato, a S. Gemma, alla Madonna della Libera, a Cocullo per S. Domenico. Dalle casette si sentiva in lontananza il canto della devozione. Qualcuno si avvicinava agli usci delle casette per un povero ristoro. Un giorno si fermò anche un tinaro. – Tecco tinaroooo!!! – si annunciava con voce sincopata. Riparò tine e bigonce. Finito il lavoro, ripartendo, in cambio di un bicchiere di vino lasciò un brandello bianco, rosso e verde a Mariannina: – Cu ce 197 aglie da fa’ che’ quiste? – gli chiese. Il tinaro le strillò: – Tienilo vicino al letto e mettilo tra i tuoi santucci: il rosso è il sangue dei martiri, il verde è la speranza e il bianco è la fede! Caracollò a valle cantando: – È la bandiera, dai tre colori... è sempre stata la più bella!... Mariannina senza chiedersi il perché lo pose tra un santuccio e un Gesù Bambino che ogni sera sfiorava con le dita della mano e che poi baciava, ogni volta, prima di dormire. Rita Pasquali 198 NINNA NANNA Ninna nanna figlio mio, chissà mai se lo vedrai tuo padre, è grande, bello, bello assai! Ninna nanna figlio mio. È partito giorni fa, ha portato poche cose con sé nella bisaccia, un po’ di pane, di formaggio, sale, acqua, niente di più. Ha lavorato sodo tutto il giorno su allo stazzo, sistemato le pecore, le forme grandi di vimini con il formaggio messo a seccare sulle travi di legno, poi è sceso al piano, a casa. Mi ha stretto forte, mi ha asciugato il viso con la mano, ha detto a bassa voce: «Tranquilla, io torno! Vado a Napoli! Arriva Garibaldi!». «Sei matto?» l’ho guardato dritto negli occhi, profondi e azzurri come un lago di montagna. «Quello è un miscredente!». Ha riso forte, scoprendo i denti bianchi. «Te l’ha detto il prete vero?» ha chiesto, continuando a sorridere; poi mi ha abbracciato stretta, si è aggiustato il cappello sulla testa e via, l’ho visto scomparire tra i campi, il bastone tra le mani, il fucile sulla spalla, con la bisaccia. Si era schiarito il cielo, dopo l’acquazzone, qui agosto finisce sempre così, spegne l’arsura della terra e bagna i semi nuovi, le poche cose che nascono prima della cattiva stagione. Hai pianto anche tu, figlio mio, dentro la culla di legno: che bella! tuo padre ha passato l’inverno a intagliarla, piccoli cerchi che si intrecciano, poi stelle a punta che si rincorrono. È di faggio chiaro, di un albero grande spezzato da un fulmine. Ha segato, piallato, incastrato a coda di rondine agli angoli le assi precise, limato, inciso, poi lucidato con cura ogni lato con cera calda. Profuma ancora di bosco. Ti ho ricamato lenzuola e cuscino tagliati da un lenzuolo di mamma, filato una coperta di morbida lana. Dormi adesso, figlio mio, tuo padre torna, deve tornare! Sono partiti insieme, un gruppo di forti, tutti giovani, accesi dal sole e dal lavoro, spinti a combattere da questa fame che ci scava dentro, dall’obbedienza che ci ha fatto schiavi, dal sogno di una vita diversa, dove la terra è finalmente nostra e il domani non fa più paura. « Viva l’Italia» hanno gridato con la mano alzata. Ninna nanna figlio mio, dormi sereno, cercherò farina per impastare, uova per mangiare, per me e per i miei vecchi. 199 Sarò forse a cogliere erba selvatica, oppure alla fonte per l’acqua, o sull’aia a stendere i panni, quando lui tornerà, sporco e affamato, con la fronte fasciata, lo riconoscerò subito. Si avvicinerà a casa, o ti vedrà che dormi nella cesta, ti prenderà tra le braccia e ti solleverà al cielo. Perché per te avrà lottato, per te. Avrà combattuto, lontano da qui, dove le terre sono più fertili e calde, dove le stagioni si alternano ricche di frutti; avrà incontrato uomini nuovi, che parlano un altro dialetto, avrà trovato una nuova bandiera, un nuovo re. Ninna nanna figlio mio, avrai nome Libero. Gemma Di Iorio 200 LO STRACCIO Le barelle entravano l’una appresso all’altra. I soldati portavano ancora le camicie rosse intrise di sangue raggrumato, alcuni ridotti da non potersi guardare; passi pesanti, sempre affrettati, dei barellieri, come se arrivare un attimo prima o dopo fosse questione di vita o di morte e non fossero costretti ad aspettare, i moribondi e i feriti gravi addossati l’uno all’altro nell’ospedale da campo, fuori all’aperto chi non era in pericolo di vita; i soccorritori stravolti quanto i feriti con l’impotenza stampata nelle facce sudate. Ordini sussurrati o gridati, perentori. E lamenti lunghi, urla d’animale come ruggiti o guaiti, alti tra invocazioni a madri, a Dio, alla Madonna; lo stridere di una sega sull’osso; rantoli: atroce sottofondo a un incubo, cui contribuiva l’odore di sangue ed escrementi che quello acre dei disinfettanti non riusciva a coprire. E infine il peggiore, quello della cancrena, dolciastro, nauseabondo, l’odore di morte prima che la morte impedisse di sentirlo. Di tanto in tanto qualcuno veniva portato via, il volto coperto, e lasciava il posto al caso più urgente tra quelli in attesa. Antonio ebbe la sensazione che tutti insieme formassero un unico corpo martoriato nella carne, frantumato nelle ossa, dilaniato nelle viscere, sanguinolento, maleodorante, osceno. Non distingueva il proprio odore da quello degli altri. Avrebbe potuto essere lui stesso a emanare quel tanfo di cancrena, a ululare, a pregare. Cercò di estraniarsi. Si concentrò su Libertà, Unità, Garibaldi, ma tutto quanto lo aveva appassionato fino alla battaglia sembrò sbiadire e dissolversi nell’aria fetida. «No, non mi lasciate proprio adesso! Che senso avrebbe questo inferno senza di voi…». Doveva aver parlato a voce alta perché un’infermiera si accostò a toccargli la fronte e dopo una appena percettibile esitazione tentò un sorriso rassicurante: il sorriso ai moribondi, pensò Antonio. Poi gli parve che il dolore scemasse, gli parve di non sentire più il suo corpo ferito. Allora si acquietò e pensò a Felicetta. 201 Se lo guardava incantata ogni volta che lui le parlava di Italia unita, di libertà dallo straniero, della dignità di cittadino che la nazione avrebbe dato anche ai più miseri. Felicetta non capiva una parola di quei discorsi, ma né lui né lei se ne preoccupava. Era analfabeta, Felicetta, ma soprattutto era convinta che non valesse la pena capire i ragionamenti dei maschi perché sapeva perfettamente quale sarebbe stata la sua vita: una frotta di figli e lavoro massacrante a casa e in campagna. Ma il fatto che avrebbe avuto accanto Antonio la riempiva di una impaziente beatitudine. Antonio invece sapeva leggere e scrivere. Quando era molto piccolo, il prete, don Saverio, aveva deciso che il bambino era troppo sveglio per restare ignorante, gli insegnò a leggere e a scrivere e poi gli prestò i libri che Antonio divorava, magari su un albero, per evitare che il padre gli strappasse dalle mani “quella perdita di tempo”. In cambio il ragazzo si rendeva utile come poteva in parrocchia e perché si era affezionato al prete e per ripagarlo dell’istruzione ricevuta. Proprio bazzicando intorno alla sacrestia aveva ascoltato i discorsi di don Saverio col figlio del farmacista, il nuovo notaio che veniva dalla città e altri sette o otto personaggi a cui si aggiunse il figlio del barone. E di nascosto aveva letto libri e fogli ben custoditi nell’armadio tra gli arredi sacri. Era lì che aveva imparato che il territorio chiamato Italia in parte era sotto l’Austria e in parte diviso in Stati di irrimediabile arretratezza che si reggevano grazie all’Austria, e che tutti gli italiani avrebbero dovuto trovare le alleanze giuste, un capo di stato e un generale carismatici, ma soprattutto la determinazione e il coraggio di combattere e liberarsi. Le aveva apprese così bene quelle cose che ora viveva in uno stato di esaltazione perenne. Tentò di fare adepti in famiglia ma suo padre si arrabbiò: «Chi credi di essere? Tu davvero pensi che perché leggi i libri sei diventato uno di “loro”? Ma non lo capisci che il tuo destino è questo?» e indicava con la mano i campi magri intorno alla casetta. «Sempre a pregare Dio che non venga la secca, che non piova troppo, che non grandini, sennó non puoi pagare il tuo baroncino padrone e per di più crepi di fame. Ti ci rompi la schiena su questa terra, pure se si chiama Italia. Miserabili siamo e miserabili resteremo, chiunque sia il re». 202 Naturalmente Antonio aveva un sacco di obiezioni da fare – che una volta finito lo sfruttamento degli stranieri, per esempio, gli italiani avrebbero provveduto fraternamente agli italiani poveri – ma le teneva per sé. Dopo lo sfogo del padre però divenne più attento alle necessità della famiglia, per una maggiore consapevolezza e per non alimentare altre polemiche. Giovane e forte com’era si alzava all’alba per pulire la stalla, zappare la terra, partecipare ai raccolti secondo il tempo e la stagione, sempre allegro e loquace, sempre presente all’occorrenza. E il padre pensò che l’ossessione del figlio era la benvenuta se le conseguenze erano quelle. Con Felicetta invece lui continuava i suoi lunghi monologhi e lei il suo rapimento estatico. Un giorno Antonio prese dalla tasca uno straccio messo insieme con tre stoffe diverse rimediate chissà dove: il bianco era ingrigito, il rosso stinto e il verde virava al giallo e per di più era liso. Era stato evidentemente cucito da mani inesperte e Felicetta non perse l’occasione per mostrare la sua competenza, una volta tanto: «E che, si cuce così?». «La vedi questa?» spiegò lui. «Un giorno sarà la bandiera di tutti gli italiani. Starà sulla facciata degli edifici importanti, nelle parate, sui tetti, dovunque». La ripiegò e: «Tienila tu» le disse. Felicetta conosceva già la bandiera, bianca con uno stemma colorato al centro, ma prese quella che Antonio le porgeva e pensò a una delle sue solite meravigliose farneticazioni. Antonio sparì. Non andò sui campi all’alba e non tornò a mangiare e a dormire. C’erano state nei giorni precedenti voci di battaglioni in movimento. Il Generale in persona, si diceva, avanzava con le sue truppe di volontari. Il padre capì e Felicetta pure. Quando giunse la notizia, Felicetta si vestì di nero. La madre disapprovò: «Non sei una vedova. La gente potrebbe pensare… O sì?» «Io sono una vedova. Non per quello che pensi tu. Non l’avrebbe mai fatto, mi ha sempre rispettato. Che stupida! Nemmeno quella gioia gli ho dato, e ora avrei un figlio suo» disse. La madre non fiatò, sollevata e insieme accorata per quella figlia adolescente improvvisamente adulta. 203 Anche al pellegrinaggio della Madonna delle Grazie Felicetta ci andò vestita di nero. La gente si accalcò dentro e fuori il piccolo santuario, ascoltò la messa, sfilò per inginocchiarsi davanti alla statua della Madonna e baciare la veste miracolosa, poi uscì e si sparse tutt’attorno per la colazione sul prato. Felicetta aspettò che la chiesetta si svuotasse e si trascinò in ginocchio lungo la navata fino alla Madonna. Tirò fuori dalla tasca il pezzo di stoffa, lo aprì ai piedi della statua, tentò con le mani aperte di allisciare le grinze della cucitura malfatta. Disse: «Madonna delle Grazie, lo vedi questo straccio? Non ti so spiegare che è, io non lo so, ma lui c’è morto per questo straccio e tu adesso mi devi fare la grazia: lo devi far diventare la nuova bandiera, deve sventolare sulla facciata degli edifici importanti, nelle parate, sui tetti, dovunque, proprio come diceva lui. Lo sai tu quello che significa e quello che devi fare». Non era una supplica. Era un ordine. Concettina Falcone 204 ALLA MIA BANDIERA CHE, COME UN FOGLIO DI CARTA, MI RENDE PRIGIONIERA E LIBERA. Leggera, sottile, silenziosa, alta su ogni umano sguardo. Il vento ti palpita e ti garrisce, il sole ti abbacina e ti risplende, la pioggia ti lava e t’inverdisce. Solo l’uomo ti ama o ti tradisce. È donna, la bandiera, perché è madre. È donna e madre come la Patria che però significa terra dei padri. Un uomo un giorno l’ha colorata con gli stessi colori dell’ardore e del desiderio di un altro uomo innamorato che, in una paradisiaca visione, poggiò lo sguardo sul mantello rosso che poco celava la veste bianca immacolata cinta di verdi erbe odorose della sua amata. Da uno sguardo d’amore di Dante poggiato sulla veste di Beatrice descritto nel II canto del Purgatorio si dice che nascano i colori e il senso della madre di tutti: la bandiera italiana. Il suo nome (“bandwa”, cioè segno, insegna) viene da lontano, da un popolo, i Goti, la cui lingua è l’unica tra quelle germaniche del gruppo orientale giunta fino a noi insieme con il verticalismo e l’arco a sesto acuto delle cattedrali che ancora oggi ammiriamo, nei paesaggi unici ed irripetibili delle nostre terre, stagliarsi a toccare il cielo e lo spirito di chi le osserva con il cuore. Sui pinnacoli più alti la bandiera viene issata e, fremendo sugli orizzonti aperti, riesce a coprire le nostre terre, i nostri mari, le immense città e anche ogni piccolo borgo abbandonato dall’uomo dove lei nella natura madre sta; nel rosso del papavero, nel verde delle forre, nel bianco della neve che scioglie piano senza perdere il candore. E dai pinnacoli più alti sfida le tempeste del cielo che pur sembra mare; forse anche per questo, nel mondo disegnato fuori dal nostro, ci chiamano “azzurri”. È azzurro l’ingegno dello scienziato e il genio del poeta, l’orgoglio dell’artista e di ogni uomo comune che sa di essere nazione. Dentro i tre colori della bandiera, dentro quel pezzo di stoffa è racchiusa la storia dei nostri padri, allora ci siamo noi, tutti noi, il popolo italiano. C’è il sangue della battaglia, il verde del campo che l’assorbe, il bianco del latte e dell’amore di ogni madre che ha nutrito il proprio figlio per consegnarlo come agnello sacrificale alla mensa della liber- 205 tà; allora la libertà nasce dal sangue e dal dolore, come dal sangue e dal dolore nasce ognuno di noi. Dopo viene la gioia, per la libertà acquisita, per la vita ricevuta. Era appena nata, la nostra bandiera, e già l’hanno trovata infangata e lacera, dilaniata dal piombo nemico, intrisa di lotta e di sangue eppure nascosta all’odio e all’ostilità sotto la giubba di un tenente a cui una palla di cannone ha asportato la testa lasciando alla morte beffarda gli occhi azzurri sbarrati dallo stupore dei suoi vent’anni sepolti in una tomba senza nome. Era solo un uomo, un giovane uomo. Solferino, Antrodoco, Calatafimi, non ha importanza il campo di battaglia, ma la terra, quella sì, la terra nostra nutrita di sangue e di ideale entrambi sopravvissuti alle carneficine. Continuava ad esalare, l’ideale, con gli ultimi sussurri del soldato, lo sguardo perso al cielo e al ricordo del viso della mamma confuso tra le nuvole. Morivano così, i più fortunati, con il tempo dell’ultimo pensiero e un lembo di bandiera ad assorbirne l’anima. Gli altri, tutti gli altri ricoprono di urla disumane i propri petti ansimanti oppure tremano; le labbra già secche di febbre e le ossa scomposte e devastate di cancrena e di sangue buttato, il sangue buono della gioventù e della fedeltà; lo stesso sangue che scorre ancora identico in ognuno di noi. È allora che la bandiera diventa sacra e soprattutto diventa patria. Alta sui pennoni ci costringe ad elevare lo sguardo proprio come si fa quando si nasce e si muore e silenziosa ci racconta di quanto sangue è colorata, di quanti fili d’erba è tessuta, di quanto respiro la sorregge di quanta vita offerta per la nostra libertà. Basterebbe ricordare. Quando si dimentica, allora si tradisce la bandiera e la patria. Ma la bandiera italiana aspetta benevola il ritorno del figliol prodigo e del traditore, se un giorno si accorgeranno di quanto senza lei siano davvero poveri e soprattutto soli. Ma lei, la bandiera italiana oggi sa perché l’amo. L’amo perché in qualsiasi parte del mondo io so di essere figlia sua e lei madre nostra. L’amo perché mi fa piangere di gioia e di dolore quando veste di luce la gloria degli atleti e ricopre di speranza la morte degli eroi. L’amo perché tra le soste e le ripartenze della vita è sempre lì ad aspettare che alzi su di lei lo sguardo come si fa con il sogno e la preghiera. 206 L’amo perché ha conosciuto tutti i pensieri degli uomini retti. L’amo perché ha colorato di libertà la vita dei nostri figli e li ha battezzati alla fonte eterna delle radici perciò della patria. L’amo perché come un foglio di carta imprigiona il mio pensare e lo libera poi in un filo d’inchiostro alto sui tetti e sulle strade, proprio come lei. Beatrice Ricottilli 207 208 F. S. Altamura, La prima bandiera italiana portata a Firenze nel 1859, Torino, Museo Nazionale del Risorgimento. 209 210 INDICE Presentazione di Maria Luisa De Matteis . . . . p. 5 La letteratura abruzzese e l’unità d’italia di Marco Del Prete . . . . . . . . da Ottaviano Giannangeli Ha minute lu sessande . . . . . . . . . . . . . . 27 . 28 ... ma l’ideal non muore di Concettina Falcone . . . . . . . . 31 . . SAGGI 9 “Arpa d’or dei fatidici vati”: sulle note del Risorgimento. di Sabrina Cardone . . . . . . . Le parole in musica del Risorgimento musicale Va pensiero (Giuseppe Verdi, Nabucco) . . . . Patria oppressa (Giuseppe Verdi, Macbeth) . . . Dal tuo stellato soglio (Gioacchino Rossini, Mosè in Egitto) Canzoni del Risorgimento. L’ispirazione popolare. Addio mia bella addio (Carlo Bosi, 1848) . . . La bella Gigogin (1858) . . . . . . . 55 . 59 “L’Italia chiamò”. Pittori Garibaldini. di Cosimo Savastano . . . . . 63 Schermi tricolori. Il Risorgimento e il cinema italiano: percorsi e tendenze di Antonio Di Fonso . . . . . . . . 97 L’italianità di Enrico Fermi . . 104 . . . . . . . . 45 52 . 53 . 54 211 VOCI E SCRITTURA: SAGGI, RIFLESSIONI, TESTIMONIANZE. L’Abruzzo dalla Carboneria all’Unità di Evandro Ricci . . . . . Salvatore Tommasi scienziato e patriota abruzzese di Evandro Gay . . . . . . . . 107 . . . 119 A proposito delle celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia di Rosa Giammarco . . . . . . . . 123 L’Abruzzo e l’unità d’Italia di Licia Mampieri . . . . . . . 127 . . . . . 135 Gli antitaliani e la questione meridionale di Nicolina Nolfi . . . . . . . . 137 Lingua e dialetti nell’Italia post-unitaria di Evandro Gay . . . . . . . . 147 Unità dell’Italia... disunita di Raffaele Russo (Irmazio Glicone) . . . . . 151 Goffredo Mameli di Beatrice Ricottilli . . . . . . . . 155 La morte di Cavour di Gemma Di Iorio . . . . . . . . 159 . Panfilo Serafini, martire della libertà. di Gioacchino Casciato . . 212 VOCI E SCRITTURA: VERSI. Nicolina D’Orazio La brehantésse . . . . . . . . 164 Nicolina D’Orazio Il bacio di Hayez . . . . . . . . 169 Nicolina D’Orazio W la lebertà . . . . . . . . 170 Maria Pia Palesse L’Italia aunite . . . . . . . . 172 Maria Pia Palesse Na lèttere de lendanne . . . . . . . 176 Maria Pia Palesse La lume ajarde ancore . . . . . . . 180 Evandro Gay Pe’ grazie de Ddie . . . . . . . 181 Diana Cianchetta Giannina Milli . . . . . . . 182 . . . . . . . 184 Diana Cianchetta Lu munuménte ai Cadùte 213 VOCI E SCRITTURA: PROSA. Mariannina Rita Pasquali . . . . . . . . 191 Ninna nanna Gemma Di Iorio . . . . . . . . 199 Lo straccio Concettina Falcone . . . . . . . . 201 Alla mia bandiera Beatrice Ricottilli . . . . . . . . 205 214 215 Finito di stampare nel mese di ottobre 2011 presso lo stabilimento tipolitografico Stampatutto di A.Vivarelli Pratola Peligna (AQ) 216
Scarica