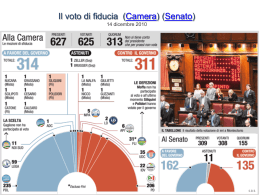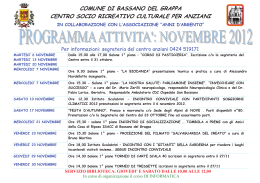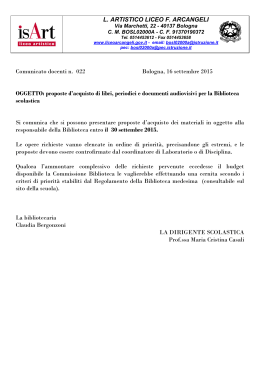la Biblioteca di via Senato mensile, anno vi Milano n. 11 – novembre 2014 BVS: ARTE Elena Schiavi e il sale della terra di luca piva STORIE DI CARTA Fra gli scaffali: librerie da leggere di massimo gatta BVS: ARCHIVIO MARTINI Fra le carte di Giuseppe Martini di giancarlo petrella LIBRO DEL MESE La Comedia di Dante con figure dipinte di gianluca montinaro GUERRA E LETTERATURA Agli inizi del ’900: fra militanza e intervento di marco cimmino la Biblioteca di via Senato – Milano MENSILE DI BIBLIOFILIA – ANNO VI – N.11/56 – MILANO, NOVEMBRE 2014 Sommario 4 BvS: Archivio Martini FRA LE CARTE DI GIUSEPPE MARTINI di Giancarlo Petrella 55 Guerra e Letteratura AGLI INIZI DEL NOVECENTO: FRA MILITANZA E INTERVENTO di Marco Cimmino 16 BvS: Arte ELENA SCHIAVI E IL SALE DELLA TERRA di Luca Piva 62 L’Altro Scaffale IN ALTO NEL CIELO, E IN BASSO SULLA TERRA di Alberto Cesare Ambesi 24 Storie di carta FRA GLI SCAFFALI: LIBRERIE DA LEGGERE di Massimo Gatta 67 Filosofia delle parole e delle cose LA FORZA DELL’IDEA: IL PENSIERO IN IMMAGINE di Daniele Gigli 33 IN SEDICESIMO – Le rubriche LE MOSTRE – L’INTERVISTA DEL MESE a cura di Luca Pietro Nicoletti e Luigi Sgroi 70 BvS: il ristoro del buon lettore L’IMMENSO OCEANO MARE di Gianluca Montinaro 50 Il libro del mese LA COMEDIA DI DANTE CON FIGURE DIPINTE di Gianluca Montinaro 72 HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO SI RINGRAZIANO LE AZIENDE CHE SOSTENGONO QUESTA RIVISTA CON LA LORO COMUNICAZIONE Fondazione Biblioteca di via Senato Biblioteca di via Senato – Edizioni Presidente Marcello Dell’Utri Redazione Via Senato 14 - 20122 Milano Tel. 02 76215318 - Fax 02 798567 [email protected] [email protected] www.bibliotecadiviasenato.it Consiglio di Amministrazione Marcello Dell’Utri Giuliano Adreani Fedele Confalonieri Ennio Doris Fabio Pierotti Cei Fulvio Pravadelli Carlo Tognoli Segretario Generale Angelo de Tomasi Collegio dei Revisori dei conti Presidente Achille Frattini Revisori Gianfranco Polerani Francesco Antonio Giampaolo Direttore responsabile Gianluca Montinaro Servizi Generali Gaudio Saracino Coordinamento pubblicità Ines Lattuada Margherita Savarese Progetto grafico Elena Buffa Fotolito e stampa Galli Thierry, Milano Referenze fotografiche Saporetti Immagine d’Arte - Milano Immagine di copertina Libro chiamato Buovo de Antona, Venezia, Francesco Venetiano, 1557 (esemplare Martini ora Libreria Carthaphilus), particolare Stampato in Italia © 2014 – Biblioteca di via Senato Edizioni – Tutti i diritti riservati L’Editore si dichiara disponibile a regolare eventuali diritti per immagini o testi di cui non sia stato possibile reperire la fonte Reg. Trib. di Milano n. 104 del 11/03/2009 Editoriale R icorda Massimo Gatta, in apertura al suo articolo che appare su questo numero de «la Biblioteca di via Senato», il «tragico destino» dello scrittore e libellista Niccolò Franco, impiccato a Roma, presso ponte Sant’Angelo, dall’Inquisizione l’11 marzo 1570. Mente arguta e penna pungente (tanto da lavorare – e in seguito litigare – con Pietro Aretino) Niccolò Franco pagò in proprio il prezzo dello scontro fra diverse fazioni della Curia romana, in seguito alla elezione al soglio di Papa Pio V. In uno scenario nel quale era solo una piccola e quasi insignificante pedina, Niccolò Franco venne punito, come esempio e monito, per colpe non sue. Viene da chiedersi quante volte, ancora oggi, pagano coloro che non sono colpevoli. Sono puniti non gli attori protagonisti ma le comparse. Vengono castigati gli innocenti e non i rei. Già, guardando al nostro presente, non tanto sembra mutato da quell’ormai lontano 1570... Gianluca Montinaro novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 5 BvS: Archivio Martini FRA LE CARTE DI GIUSEPPE MARTINI Spigolature collezionistiche di un libraio bibliografo GIANCARLO PETRELLA margine di un’inedita edizione del De arte amandi ovidiano in terza rima (in ottavo, cc. [56], [aa delicata questione della g8]) privo di sottoscrizione tiporarità dell’edizione, troppo spesso solo presunta o grafica. L’edizione, di cui non si accortamente manipolata anche conoscono oggi esemplari (la coper solleticare l’appetito degli pia Martini, che dovrebbe preignari collezionisti, merita una sentare «legatura in cuoio di più estesa digressione. Martini Russia, larga cornice dorata di non mente quando ostenta l’asornati a fiorami sui piatti, dorso e soluta rarità di un libro, di cui taglio dorati, eseguita da spesso rintraccia e segnala, dopo Thompson», sembra infatti scrupolosa recensio, i pochi altri sprofondata nelle cavità carsiche esemplari noti (a esempio in medel collezionismo), continua a rito all’edizione delle Facetie del creare non pochi grattacapi biPiovano Arlotto, Firenze, Giobliografici. Martini ne forniva vanni Stefano a istanza di Berinnanzitutto una meticolosa denardo di ser Piero da Pescia, c. Sopra: fotografia di Giuseppe scrizione tipologica, consapevo1515, avverte «apparentemente Martini. Nella pagina accanto: Tullia le che l’individuazione del caratuna delle sole due copie cono- d’Aragona, Rime della signora Tullia tere impiegato (in questo caso sciute... l’altra copia si trova nel- di Aragona e di diversi a lei, Venezia, un romano della misura di c. 115 la biblioteca del fu barone H. Gabriele Giolito, 1547, frontespizio mm sulle canoniche 20 linee di Landau di Firenze»). Parecchi testo: R115) fosse la chiave bidegli esemplari passati fra le sue bliologica per accertarne la promani, già lo si è intuito, erano (e quasi sempre sono babile paternità tipografica. Determinante per rimasti) copie uniche sconosciute ai bibliofili e agli ogni futura riflessione era soprattutto l’individuastudiosi, come accertava dopo accurate indagini zione di alcune lettere discriminanti, pertanto debibliografiche. E di ciò aveva ragione a vantarsi: scritte con precisione impeccabile (in inglese nella «apparently the only copy know of this book from scheda autografa, in italiano nel catalogo degli ina North Italian press (Lombardy or Veneto?)» a cunaboli, scheda n. 253, con riproduzione fotogra- Seconda e ultima parte L 6 Tullia d’Aragona, Rime della signora Tullia di Aragona e di diversi a lei, Venezia, Gabriele Giolito, 1547, dedica fica del recto della prima carta): «A with flat head, wide D, M with inclined shanks, rather narrow E with lower horizontal slightly mounting, g rising above, h like in type 114R of Johannes Petri at Florence, two lower case o (one larger), r with line at foot prolonged to right». L’impossibilità di spingersi troppo oltre avrebbe infine suggerito l’ipotesi bibliografica di un eponimo tipografo veneziano [Venice ?, Printer of Ovidius “De arte amandi”, c. 1472-73]. L’ipotesi resta ancora sostanzialmente valida (ISTC io00138700), potendosi forse attribuire allo stesso misterioso tipografo del De arte amandi anche l’edizione, altrettanto anonima, del Fiore di virtù c. 1472 (GW 9913) dietro suggeri- la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 mento di De Marinis (che si avvalse, a sua volta, della descrizione tipologica di Martini «caratteri tondi identici a quelli impiegati per la stampa di un volgarizzamento di Ovidio descritto da G. Martini nel suo catalogo d’incunabuli», e aggiunse la rilevazione della filigrana «il p gotico inscritto in un cerchio»).14 «The only copy know hitherto undescribed by bibliographers» registra in calce alla scheda dell’esile edizioncina (a4) sine notis (ma assegnata a Firenze, Bartolomeo de’ Libri, c. 1496) de Il sonaglio delle donne di Bernardo Giambullari, espressamente nella copia «from the library of Charles Fairfax Murray». L’esemplare Martini (di cui accerto l’aggiudicazione all’asta del 1934 per la cifra di 1000 franchi svizzeri),15 in raffinata legatura in marocchino rosso firmata Lloyd Wallis & Lloyd di Londra, sembra potersi identificare con l’unica copia oggi nota conservata alla Nazionale di Firenze (SANDER 3124; IGI 4296; ISTC ig00302600). In questa circostanza la sua ipotesi attributiva (che ancora regge, salvo possibile anticipazione della stampa di qualche anno), trovava sostegno nella descrizione del carattere R77 («probably in use 1496-99») fornita dal bibliografo inglese Proctor e negli specimina tipologici allegati al Catalogo degli incunaboli della British Library (BMC VI, p. 646, plate XLVI). «Apparently the only copy know of an edition hitherto undescribed» è l’identico invogliante annuncio segnato anche a margine dell’Istoria del Giudizio Universale in ottava rima [Brescia, Battista Farfengo, c. 1495]. Vale la pena approfondire il discorso su quest’ultima, analizzando la relativa scheda compilata a suo tempo da Martini. Lasciamo però per un attimo l’antiquario lucchese e cominciamo piuttosto dalla fine. A oggi le uniche scarne informazioni relative a quest’edizione si ricavano dall’autorevole Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW 10939), cui esplicitamente rimanda anche il più sintetico repertorio informatico ISTC (forse ben noto a chi frequenti, anche solo da cultore della materia, il libro del Quattrocento). Né novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 7 GW né ISTC forniscono alcun rimando a repertori precedenti, tantomeno quelli compilati da Martini (ma questo è un difetto piuttosto comune, tanto che complessivamente in ISTC riscontro solo una quarantina di citazioni dal ben più generoso catalogo Martini degli incunaboli). Non risulta inoltre alcun esemplare in biblioteche pubbliche, ma un’unica copia (probabilmente proprio quella Martini?) in una non meglio precisata collezione privata svizzera. GW ne fornisce (di prima mano?) una sintetica descrizione bibliologica (edizione in quarto, di 4 carte non segnate, carattere romano R78, testo su due colonne). Ulteriori informazioni, anche riguardo la tradizione editoriale del testo, si ricavano invece dagli appunti manoscritti di Martini, cui va il merito della scoperta di quest’edizione quattrocentesca bresciana di straordinaria rarità: Istoria del Giudizio Universale in ottava rima. Roman character, double columns, 47 lines to the page, 4 unnumbered leaves, without signatures or catchwords [a4]. Leaf 1r, col. 1: O Sancta trinita uno solo idio | senza principio & senza fine seti | & cio che si fa bon & lo rio | dinascose in palese uoi sapeti | prestame gratia a lo intellect mio | altissimo signore quando uoleti | chio possa stare al uostro seruitio | a deschiarare la historia del iudicio | . Leaf 4v, col. 2, line 46: in paradiso in quella superna oloria (sic) | al uostro honor finita questa istoria. 4to, cartone colorato. [Brescia: presbyter Baptista Farfengus, c. 1495]. Type 78R (Proctor, 4), with admisture of a gothic O (crossed diagonally by two parallel lines) and T2; Haebler’s Qu (I). Apparently the only copy know of an edition hitherto undescribed. Second edition, 94 ottavas. The earliest know seems to be that s.l, n. typ. & a. [Venice, Andreas de Paltasichis (?), c. 1490], 4to (Reichling 1229) of whitch the only copy know is in Biblioteca Marciana of Venice. The reprints are: under the title of El giuditio generale [Rome, Johannes Besicken & Martinus de Amsterdam, c. Lodovico Dolce, Libri tre nei quali si tratta delle diverse sorti delle gemme, Venezia, Giovanni Battista e Melchiorre Sessa, 1565, incipit libro I 1500], 4to (Hain – Reichling, 7777) also this known only in one copy in the Biblioteca Casanatense of Rome; under the title of Judicio finale e sonetti morali in 102 ottavas, [before 1515], in the Biblioteca Colombina Sevilla. It is known also an edition printed at Brescia, s.a. [16th century], 12mo, and one printed at Milano, 1643, 8vo; a copy of both was in the Library of Marquis Girolamo d’Adda and afterwards in that of the English collector Charles Fairfax Murray. Martini sostiene dunque l’attribuzione alla tipografia bresciana di Battista Farfengo (conferma- novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 9 Sopra da sinistra: s. Augustinus, De civitate Dei (in italiano) [Venezia o Firenze, Antonio di Bartolommeo Miscomini, c. 1476-78 - 1483], c. a1r; s. Augustinus, De civitate Dei (in italiano) [Venezia o Firenze, Antonio di Bartolommeo Miscomini, c. 1476-78 - 1483], colophon. Nella pagina accanto: Libro chiamato Buovo de Antona, Venezia, Francesco Venetiano, 1557 (esemplare Martini ora Libreria Carthaphilus) ta da GW e accolta da ISTC, che ne anticipano però la stampa di due anni) attraverso la consueta analisi del carattere impiegato (un romano della misura approssimativa di 78 mm su 20 linee di testo indicato appunto come R78). Il carattere è identificato nel romano R78 in uso al Farfengo, con la presenza ‘inquinante’ di O e T maiuscole gotiche, schedato da Proctor come «type 4 another small roman, wide M, rather sloping; Qu; single hyphen; paragraph mark; 20 ll. = 76-7 mm» e descritto con maggior precisione da BMC.16 La scomparsa di questo esemplare (oggi sepolto nelle pieghe del collezionismo privato e di cui non resta che la generosa riproduzione fotografica della prima pagina allegata da Martini alla scheda 221 del catalogo incunaboli) impedisce di verificare l’ipotesi fino in fondo. Trova dunque conferma anche la sua ipotesi degli anni Trenta che quella nelle sue mani fosse l’unica copia di un’edizione ignota ai bibliografi. Né da allora si sono fatti passi in avanti. Anche chi scrive, da una dozzina d’anni sulle tracce della produzione del Farfengo, non ha potuto che 10 arrestare le proprie ricerche alla scheda dell’archivio Martini. Il libraio, come consuetudine, in seconda battuta affronta l’intricata tradizione editoriale del poemetto, fonte di non pochi grattacapi. Le correzioni autografe suggeriscono un percorso di ripensamenti bibliografici che vale la pena seguire. Dapprima aveva infatti schedato quella del Farfengo come «the earliest know edition». Poi, evidentemente in seguito a nuove informazioni, corresse «second edition» e aggiunse nell’interlinea la tesi che la prima edizione nota dello stesso poemetto in 94 ottave (in prima istanza registrata semplicemente alla voce «other editions») fosse piuttosto quella tràdita dall’unicum della Marciana di Venezia censita da Reichling (di cui riporta dubitativamente l’ipotesi attributiva): «The earliest know seems to be that s.l, n. typ. & a. [Venice, Andreas de Paltasichis (?), c. 1490], 4to (Reichling 1229) of whitch the only copy know is in Biblioteca Marciana of Venice». Le correzioni passarono nel- la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 la versione definitiva, in italiano, pubblicata nel catalogo degli incunaboli: «seconda edizione di questo poemetto popolare di 94 stanze; la più antica conosciuta sembra sia quella s.l, n. di tip. e a. (Venezia, Andreas de Paltaszichis, c. 1490) in 4to (Reichling 1229) della quale la sola copia nota è quella della Biblioteca Marciana di Venezia». Gli risultano due edizioni sicuramente posteriori: l’edizione sine notis (ma assegnata, ancora dal repertorio di Hain con le correzioni di Reichling, alla tipografia romana di Johannes Besicken e Martinus de Amsterdam circa 1500) tràdita dall’unico esemplare della biblioteca Casanatense di Roma e un’edizione anonima (ma verisimilmente ante 1515) dal titolo Judicio finale e sonetti morali della Colombina di Siviglia che presenta però una versione ampliata di 102 ottave.17 Infine, segnala un’edizione bresciana cinquecentesca sine anno e un’edizione milanese del 1643, entrambe sopravvissute in un esemplare già del marchese Girolamo d’Adda e poi, come molte di quella collezione milanese, entrate a far parte della già più volte evocata raccolta Fairfax Murray. Martini aveva colto nel segno, negli anni Trenta, con pochi strumenti bibliografici a disposizione e senza l’appoggio di quei repertori informatici che oggi sorreggono chi si avventuri nel campo della ricerca bibliografica? La questione, come si è intuito, è particolarmente insidiosa e meriterebbe un più ampio discorso. Basti qui lo status quaestionis. GW (GW 10937; ISTC ig00307500) assegna alla tipografia veneziana di Bernardino Benali circa 1490 l’edizione trasmessa dall’esemplare della Marciana giudicata da Martini la più antica e conferma alla tipografia romana circa 1500 l’edizione tràdita dalla copia della Casanatense (alla quale nel frattempo si è aggiunta una seconda copia conservata presso la Walters Art Gallery di Baltimora: GW 10938; ISTC ig00307000). Martini era invece rimasto all’oscuro di un’altra edizione, sempre osti- novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 11 Nella pagina accanto: Ludovico Ariosto, Le Satire volgari in terza rima [Ferrara, Francesco Rossi], 1534 (esemplare Martini ora Libreria Carthaphilus). Sopra: Ludovico Ariosto, Le Satire volgari in terza rima [Ferrara, Francesco Rossi], 1534, risguardo: nota d’acquisto autografa di Giuseppe Martini datata 1918 e altre note bibliografiche natamente anonima, oggi nota tramite l’unica copia della Biblioteca Ambrosiana di Milano. GW (e ISTC in seconda battuta) sono propensi a ricondurla alla tipografia perugina quattrocentesca, ipotizzandone una datazione ai primissimi anni Ottanta del XV secolo [Perugia, Steffen Arndes, 1481: GW 10935; ISTC ig00306800], che ne farebbe dunque, a oggi, l’edizione più antica, anteriore sia a quella veneziana c. 1490 sia a quella bresciana da Martini datata c. 1495 e da GW retrocessa, senza sostanziali motivazioni, al 1493. Il poemetto dovette godere di discreta fortuna, come lascia intuire l’unico esemplare (oggi Bologna, Biblioteca Universitaria), rimasto altrettanto sconosciuto a Martini ma passato nelle mani del collega De Marinis, di un’edizione ancora sine notis che lascia piuttosto perplessi: già assegnata a Venezia circa 1500, sembra invece oggi ricondotta a un’anonima tipografia dell’Italia meridionale post 1500 (GW 10936; ISTC ig00307600). L’esempio dovrebbe assicurare i lettori ancora dubbiosi circa la complessità e perenne instabilità delle questioni bibliografiche. Non posso tacere di un’altra gemma estratta dallo schedario Martini. Nelle mani dell’antiquario di origini lucchesi passò un esemplare, oggi apparentemente dileguatosi, di un’altra edizioncina popolare di assoluta rarità. Sembra sopravviverne un’unica copia (a questo punto la seconda dopo quella Martini) già del bibliofilo cinquecentesco 12 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Appunto autografo a matita di Giuseppe Martini: «coll. completo» Hernan Colón che l’acquistò nel dicembre 1515 («Este libro costo en Roma medio quatrin por diziembre de 1515») e ora, come buona parte di quella raccolta, presso la Colombina di Siviglia.18 Si tratta di un anonimo poemetto di 35 stanze in terza rima (incipit: Va serua Italia or tene ascondi e cela) «che esorta l’Italia a risguardare alla sua gloria passata e di svegliarsi, terminando con un’allusione alla deposizione di Federico re di Napoli dopo la conquista del regno fatta da Luigi XII». In questo caso gli appunti di Martini sono insostituibile testimonianza bibliografica. Il poemetto non si estendeva per più di due carte nel formato in quarto (un mezzo foglio tipografico, lavoro di non più di una giornata con probabile facile ritorno economico) accompagnate da un’invitante piccola silografia in apertura (mm 44 x 97) con generica attinenza al testo «rappresentante una città fortificata, nello sfondo il mare e delle colline». La stampa, come spesso per questo genere di testi, non è sottoscritta dal tipografo, il che spinge Martini (sulla base verisimilmente dell’analisi tipologica, un romano R111) a ipotizzare «[Roma, Giovanni Besicken, c. 1502]» per quest’«edizione originale rimasta ignota ai bibliografi». Come Martini ne fosse venuto in possesso è storia già nota: probabilmente tramite De Marinis, dalla vendita all’asta della collezione di Fairfax Murray cui infatti l’esemplare, con raffinata legatura d’amatore, apertamente rimanda («legatura eseguita da Lloyd, marocchino arancio del levante, fregi interni e taglio dorato. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Charles novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano F. Murray»). I libri viaggiano, si sa. E anche quelli di Martini – esplicitamente riconoscibili dal suo ex libris e dalla firma autografa, ma più spesso soltanto da una più anonima nota a matita «Coll. Compl.» (collazionato completo) – si sono silenziosamente dispersi seguendo i sentieri non sempre ripercorribili del collezionismo. Le schede d’archivio offrono la più preziosa documentazione per mettersi sulle loro tracce, come nel caso dell’esemplare (manco a dirlo unico!) della versione in ottava rima de La novella di Gismonda e Guiscardo di Boccaccio attribuita a Brescia, B. Farfengo, c. 1491 che riemerge Oltreoceano (per la precisione a Chapel Hill, University of North Carolina Library). La scheda segnaletica fattane a suo tempo da Martini, che nel catalogo degli incunaboli approssimava una datazione c. 1498,19 coincide: «italian binding of the first half of the 19th century in red paper boards, red leather back, with the title stamped in gold on the front cover». Qualcosa riaffiora ancora sul mercato, persino a pochi passi dal luogo che ora conserva le schede autografe. Presso la Libreria Mediolanum di Luca Pozzi si rintracciano una manciata degli incunaboli a suo tempo affacciatisi dal Catalogo del 1934: l’intrigante e rarissimo Apollonio di Tiro ridotto in ottava rima da Antonio Pucci (Venezia, Gabriele di Pietro, 6 maggio 1478), nella vistosa copia in marocchino verde già Fairfax Murray (e poi De Marinis) che si aggiunge all’unica finora nota presso la Trivulziana di Milano (ISTC ia00926350);20 Boccaccio, Fiammetta, Venezia, Filippo di Pietro, 1481 (ISTC ib00736000), di cui sono censite sole 5 copie in Italia;21 la citata prima edizione in italiano (sine notis) del De civitate Dei [Venezia o Firenze, Antonio di Bartolommeo Miscomini, c. 1476-78 - 1483] (ISTC ia01248000) per la quale Martini aveva proposto con lucidissima analisi bibliologica l’attribuzione alla bottega veneziana del Miscomini circa 1477-78;22 il Trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze di Savonarola [Firenze, Bartolomeo de’ Libri, non 13 ante gennaio 1498] (ISTC is00236000).23 Gli scaffali della Libreria Carthaphilus di Giansandro Cattaneo restituiscono invece alcune raffinatissime edizioni cinquecentesche, tra cui un volumetto di soggetto aretiniano che cuce assieme Pietro Aretino, Tre primi canti di Marfisa (Venezia, Giovanni Andrea Valvassore e Florio fratelli, 1544) e Pietro Aretino – Lodovico Dolce – Francesco Sansovino, Capitoli … diretti a gran Signori sopra varie et diverse materie molto dilettevole, [Venezia, Comin da Trino?], 1540;24 e il poema cavalleresco illustrato Libro chiamato Buovo de Antona (Venezia, Francesco Venetiano, 1557),25 di cui si accertano i seguenti passaggi di mano: al frontespizio nota manoscritta di possesso sei-settecentesca «Marc’Antonio Ristorelli»; Cigerti (ex-libris); il bibliofilo ferrarese (1834-1918) Giuseppe Cavalieri (ex-libris); Giuseppe Martini (note a matita). Aggiungo almeno la rarissima princeps, allestita postuma contro la volontà degli eredi, di Ludovico Ariosto, Le Satire volgari in terza rima [Ferrara, Francesco Rossi], 1534,26 il cui risguardo, brulicante di note antiquario-bibliografiche a matita, confessa, se ben letto, un pedigree otto-novecentesco di primissima fascia: già del conte Giacomo Manzoni, fu poi di De Marinis, ma nel 1918 passò a Giuseppe Martini, come da nota autografa d’acquisto datata. Curiosissimo pare infine il destino di un centinaio di libri già appartenuti a Martini e ora, ironia della sorte, dopo nuovi passaggi di mano, riaffiorati proprio nel fondo antico della Biblioteca di via Senato, dove finiscono col ricongiungersi, un secolo più tardi, alle schede autografe che li riguardano. Non posso qui che proporne qualche rapido esempio, a cominciare da Le ciento novelle antiche (Bologna, Girolamo Benedetti, 1525)27 che già Martini descriveva nei suoi appunti «prima e rara edizione di questa ben nota raccolta di novelle pubblicata a preghiera del Bembo» e sarebbe stata 14 Pietro Aretino, Tre primi canti di Marfisa, Venezia, Giovanni Andrea Valvassore e Florio fratelli, 1544 (esemplare Martini ora Libreria Carthaphilus) aggiudicata all’asta del 1934 per la cifra di 220 franchi svizzeri, come accerto dalla copia Martini del catalogo d’asta con aggiudicazioni manoscritte a margine. Proseguendo, dal fondo antico di via Senato si riaffacciano entrambe le parti della non diffusissima raccolta lirica di Marcello Filosseno, con bizzarro titolo (come da appunti autografi di Martini) «interamente inciso in legno su di un lungo nastro serpeggiante» (Sylue de Marcello Philoxeno taruisino poeta clarissimo. Capitoli iuuenili. Capitoli senili. Stramboti senili. Disperate. Sonetti senili. Satyre, Venezia, Melchiorre Sessa e Pietro Ravani, 10 novembre 1516; Sylue de Marcello Philoxeno taruisino poeta clarissimo. Stramboti iuuenili CCCXLII. Sonetti iuuenili CCCCXX. Capituli non piu stampati la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 X et una epistola in laude dela virtu, Venezia, Melchiorre Sessa e Pietro Ravani, 10 novembre 1516).28 Martini, nel pieno della scheda, avvertiva: «La prima parte è ristampa dell’edizione antecedente col medesimo avviso dell’editore Gio. Battista Locatelli al lettore, ma colla data cambiata in kal. Iunii MDXVI e colla stessa dedica del Barberigo a Lucrezia Borgia. I Capituli non più stampati X e l’Epistola in laude de la virtù annunziati sul frontespizio furono omessi, non sappiamo per quale ragione. Le rime della seconda parte furono qui impresse per la prima volta». Altrettanto minuziosa e densa di aggiornati rimandi bibliografici la scheda riservata alla silloge lirica Tullia d’Aragona, Rime della signora Tullia di Aragona e di diversi a lei, Venezia, Gabriele Giolito, 1547, 29 di cui si trascrivono qui solo alcuni stralci, che danno bene l’idea della mole di lavoro, non solo meramente bibliografico, di cui Martini si sobbarcava: «prima e rara edizione dedicata da Tullia a donna Leonora di Tolledo duchessa di Firenze con una lettera senza data. I sonetti sono indirizzati al Duca Cosimo de’ Medici, a sua moglie Eleonora, Maria Salviati de’ Medici, Luigi di Toledo … e Piero Manelli. La seconda parte (cc. 14-19r) contiene sonetti di Tullia colle risposte di Simone Porzio, Muzio, Varchi … la terza parte (cc. 19v-26) la Tirrhenia del Muzio preceduta da una lettera dedicatoria alla poetessa; la quarta parte (cc. 27-40) sonetti indirizzati a Lei dal Muzio, Varchi … . Ristampata dal Giolito nel 1549 e 1560 e a Napoli, Antonio Bulifon, 1693, in 12mo. Questa ultima edizione omette la dedica a Leonora di Toledo e il sonetto all’Ochino come era da aspettarselo … Su Tullia d’Aragona (1505 ? – c. 1556), figlia della ben nota cortigiana Giulia Campana Ferrarese, la quale pretendeva di averla avuta dal card. Lodovico d’Aragona, vedi: Bongi, op. cit., I, pp. 150-99 … B. Croce, La lirica del Cinquecento, in La Critica, XXIX, 1931, VIII». Propongo infine un’ultima scheda, relativa all’edizione Lodovico Dolce, Libri tre nei quali si tratta delle diverse sorti delle gemme, Venezia, Giovanni novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano Battista e Melchiorre Sessa, 1565,30 ancora esemplare del suo modus operandi. Dapprima Martini enuncia i dati d’esemplare («esemplare proveniente dalla biblioteca di J. Gomez de La Cortina marchese di Morante»), quindi si dilunga in una dotta digressione filologico-erudita sull’opera e la sua fortuna: «prima e rara edizione di questo libro dedicato dall’autore a Giovanbattista Campeggio vescovo di Maiorca … più che un’opera originale il trattato è una traduzione con aggiunte dello Speculum lapidum di Camillo Leonardi di Pesaro, Venetiis, J.B. Sessa, 1502, in 4to [con aggiunta posteriore «Alla dedica segue un proemio dove il Dolce dice di aver raccolta da diversi questa materia e di averla divisa in tre libri»]; a causa di questo lavoro il Dolce si attirò addosso la taccia di plagiario, cosa che gli fu rimproverata anche da Apostolo NOTE 14 TAMMARO DE MARINIS, Appunti e ricerche bibliografiche, Milano, Hoepli, 1940, p. 18 n. 19. 15 Bibliotheque Joseph Martini 99 («La plus ancienne édition connue de ce petit poème satirique; le seul exemplaire existant de cette édition qui manque dans toutes les bibliographies»). 16 ROBERT PROCTOR, An Index to the Early Printed Books in the British Museum: from the Invention of Printing to the Year 1500. With Notes of those in the Bodleian Library, London, Kegan Paul-Trench Trübner, 1898-1906 (= London, The Holland Press, 1960), p. 478; BMC VII, p. 984. 17 SANDER 3173; K. WAGNER - M. CARRERA, Catalogo dei libri a stampa in lingua italiana della Biblioteca Colombina di Siviglia, Modena, Panini, 1991, n. 401 (riporta nota d’acquisto datata dicembre 1515 che giustifica quindi una datazione anteriore). 18 15 Zeno (cfr. Lettere, V, p. 320) … il libro, come contenente teorie di magia e di sortilegio in correlazione colle pietre preziose e le gemme fu proibito dal maestro del Sacro Palazzo con decreto del 16 dicembre 1605 e apparve per la prima volta nell’indice romano del 1607. L’opera non ostante la proibizione che continuò anche per tutto il sec. XVIII fu ristampata a Venezia, Sessa, 1617, in 8vo». Un controllo finale, per scrupolo. Il catalogo d’asta informa che l’esemplare, oggi in via Senato, non venne in quell’occasione venduto, ma fu, come altri pezzi di particolare pregio, «ritirato» dall’antiquario per la propria personalissima collezione. K. WAGNER - M. CARRERA, Catalogo dei libri a stampa in lingua italiana della Biblioteca Colombina, n. 439; EDIT16 CNCE 68142 non registra alcun esemplare oltre quello della Colombina. 19 Catalogo della libreria di Giuseppe Martini … Incunaboli, n. 76. 20 Catalogo della libreria di Giuseppe Martini … Incunaboli, n. 15. 21 Catalogo della libreria di Giuseppe Martini … Incunaboli, n. 65 («legatura in pergamena del sec. XVIII, in parte ricoperta con carta bruna al principio del sec. XIX … già appartenente a Maffeo Pinelli e De Bure»). 22 Catalogo della libreria di Giuseppe Martini … Incunaboli, n. 1. 23 Catalogo della libreria di Giuseppe Martini … Incunaboli, n. 325. 24 SANDER 516c; EDIT16, A2396; EDIT16 CNCE 2430, 2452. 25 Apparentemente sconosciuta a EDIT16. Fine seconda e ultima parte. La prima parte è stata pubblicata sul numero di ottobre 2014 26 GIUSEPPE AGNELLI – GIUSEPPE RAVEGNANI, Annali delle edizioni ariostee, Bologna, Zanichelli, 1933, II, pp. 3-4; EDIT16 CNCE 2571 registra 5 esemplari in Italia. 27 Milano, Biblioteca di via Senato, XVII-E. Copia appartenuta a sir Richard Wrottesley, Baronet (1721-1769), come da suo ex libris araldico. 28 EDIT16 CNCE 19051-52. Milano, Biblioteca di via Senato, III-A. Legatura antica in pergamena rigida con filettatura a secco ai piatti e al dorso, tracce di bindelle; taglio rosso; titulus manoscritto al dorso. 29 EDIT16 CNCE 2287. Milano, Biblioteca di via Senato, XV-G. Legatura ottocentesca in pieno marocchino bordeaux; titulus in oro al dorso; taglio e unghiatura dorati. 30 EDIT16 CNCE 17388. Milano, Biblioteca di via Senato, XVIII-A: legatura in piena pergamena floscia, con supralibros MDU. 16 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 17 BvS: Arte ELENA SCHIAVI E IL SALE DELLA TERRA Una pittrice dimenticata e un segreto svelato LUCA PIVA M olti storici dell’arte contemporanea hanno condiviso la propensione a escludere dai loro compendi le opere di autori difficili da catalogare nei ranghi di uno schema evolutivo predeterminato; a questo costume corrispondono repertori che, addentrandosi nel Novecento, si affollano di figure rappresentative del loro tempo ma talvolta mediocri, mentre accade che personaggi di elevata statura artistica paghino il loro temperamento indipendente andando dimenticati. A questa schiera merita di essere associata la pittrice Elena Schiavi, che ci ha lasciato dipinti di toccante qualità, e anche un piccolo nucleo di pubblicazioni che espongono un percorso di studi e riflessioni di inconsueta suggestione. Al suo lavoro è stata dedicata un’unica monografia, Elena Schiavi, edita a Milano nel 1981 da Vanni Scheiwiller (testo che la Biblioteca di via Senato conserva nel proprio fondo di Storia dell’arte), e introdotta da testi di Hans Sedlmayr, Pierre Courthion e Carlo Belli. A sinistra: Aglio su fondo azzurro, collezione privata. Sopra: copertina di Il sale della terra, Milano, Hoepli, 1961 Elena Schiavi nacque a Mantova nel 1914; si rivolse alla pittura da autodidatta, ma talento e studio la condussero già a diciannove anni a essere insegnante nella classe di affresco dell’Accademia Cignaroli, a Verona. Qui si trasferì, sposa dell’ingegner Piero Gazzola, l’esperto di restauro che medicò le ferite inferte ai monumenti cittadini dai bombardamenti alleati, e nella sua casa posta fra i vigneti della Valpolicella, a Negrar, rimase fino alla fine della sua vita giunta nel 2004. Nel corso degli anni Trenta partecipò regolarmente alle mostre sindacali lombarde e ad altre collettive, e dal 1943, con gli affreschi della parrocchiale di Moglia, diede inizio alla sua attività di decoratrice che lasciò i frutti più rilevanti nella Biblioteca Capitolare di Verona, nel tribunale di Bolzano e nel duomo di Benevento. Elena Schiavi imboccò la strada maestra del suo destino d’artista attorno al 1940, quando si accostò alla tecnica dell’encausto, che divenne il suo strumento di lavoro prediletto e l’oggetto di studi appassionati. La pittura a encausto, che ebbe larga applicazione nel mondo greco e romano, affida a un le- 18 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Finocchio su fondo blu, collezione privata gante a base di cera l’amalgama delle polveri variopinte che danno sostanza ai colori. Questi sono stesi sulla superficie del quadro a tocchi di pennello che vengono successivamente fusi a caldo; quest’ultimo passaggio conferisce alle superfici una tessitura sfumata e una trasparenza di singolare profondità, dovuta alla capacità propria alla cera fusa di attrarre la luce nel proprio spessore, così che i pigmenti che vi sono immersi ne vengano avvolti e cromaticamente accesi. Ricorrenti citazioni disseminate in testi antichi attrassero sull’encausto curiosità e indagini fin dal primo Rinascimento, e lo stesso Leonardo da Vinci tentò maldestramente di utilizzarlo a Palazzo Vecchio nella fallimentare impresa della Battaglia di Anghiari. Nel corso dei secoli, e in particolare nella prima metà del Novecento, molti pittori ritennero opportuno introdurre cera diluita nelle ricette per mesticare i colori, ottenendo tempere di pratico utilizzo e vivace effetto cromatico, ma na- turalmente non è lecito parlare di encausto in assenza di una combustione. La Schiavi si propose di impadronirsi precisamente del dimenticato segreto dell’encausto antico, rapita dal fascino arcano di cui numerosi caratteri concorrevano ad ammantarlo: la ricchezza misteriosa della sua materia, il fecondo ruolo metamorfico della sua componente ignea, il groviglio di vicende sconosciute in cui era andata smarrita la sua formula, gli indizi emersi da testi e documenti sparsi nella deriva dei secoli… La raffinata cultura letteraria di questa tardiva conterranea di Virgilio trovò sbocco dapprima in alcuni versi e in una raccolta di racconti. Dalla fine degli anni Cinquanta si concentrò sul tema della pittura a cera e fuoco, ed ebbe come esito la pubblicazione di alcune comunicazioni in riviste e in raccolte di atti congressuali, e, nel 1961, del volume Il Sale della Terra - La materia pittorica nell’antichità, impresso dalla stamperia veronese Valdonega ed edito a Milano da Hoepli, nel quale le sue ricerche trovarono una formulazione compiuta. Il ventennale percorso di studio fu messo in moto dalla caparbia volontà della pittrice di impadronirsi di uno strumento di lavoro «ineguagliabile» e si avvalse dell’ausilio di disparate discipline, fra le quali prevalsero filologia, chimica e archeologia: il «nocciolo del rompicapo» stava nell’interpretazione di alcuni passi di Plinio e di Vitruvio nei quali è menzionata, in termini che il tempo ha reso incomprensibili, la miscela da utilizzare per amalgamare le polveri colorate alle quali la combustione avrebbe conferito poi una qualità peculiare e preziosa. Facendo leva su una sovrana familiarità con le fonti classiche e sullo scandaglio di una bibliografia a stampa estesa dal principio del sedicesimo secolo alle pubblicazioni più recenti, l’autrice ci accompagna lungo un rabdomantico itinerario attraverso epoche e luoghi disparati: i laghi salati della valle inferiore del Nilo, dove si reca alla ricerca delle incrostazioni salmastre necessarie ai suoi esperimenti; i laboratori del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica di Parigi, dove esegue indagini novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 19 su campioni di opere antiche messi a disposizione dal Louvre e dal Museo Nazionale del Cairo; l’oasi di Sakkara dove la sabbia del Sahara egiziano ha custodito per venticinque secoli, sigillata dentro giare di creta, la chiave dell’enigma; le botteghe dei decoratori pompeiani di età imperiale, maestri dell’arte ustorea ai quali un’erronea consuetudine continua ad attribuire l’utilizzo dell’affresco; quella ove il fiammingo Jan van Eyck dosava gli olii e la cera che composero le sue vernici, destinate a loro volta ad essere esaltate dalla fiamma; gli ateliers dei pittori ottocenteschi, nei quali i segreti del mestiere coltivati per millenni furono rinnegati e persi; quelli contemporanei, dove «un ritegno congenito ai figli della nostra epoca tiene in castigo la mano destra di tutti noi». La conclusione a cui approdò questo laborioso tragitto fu che «il primo encausto lo fece il sole d’Egitto», ovvero che esso fosse una evoluzione della tempera a cera, ispirata dalla constatazione occasionale di come le opere portate a compimento a freddo risultassero arricchite dal calore del sole battente. Dagli egizi, che mai lo caricarono di alcuna implicazione di ordine estetico, passò ai greci, che lo promossero a veicolo di deliberata espressione artistica. La studiosa stabilì inoltre che l’ingrediente determinante nella composizione delle paste colorate fosse il natron, un carbonato di sodio disponibile in abbondanza in area nilotica, già impiegato nella imbalsamazione e in altre pratiche legate al culto dei morti. Un sale, dunque, non di origine marina, ma prodotto «da una germinazione oscura appartenente al grembo della terra», il cui nome, attraverso l’aggettivo ntrj che significa “puro”, deriva dalla radice ntr, che significa “dio”: «Essudava dalle pareti delle caverne preistoriche in efflorescenze che stillavano in colaticci, si addensavano in liquame o indurivano in formazione stalattitica per diventare alabastro. In quella sostanza acre andava in deliquescenza il tu- Il tavolino, collezione privata fo, l’arenaria, le rocce asfaltiche, silice, lignite e marmo. Da quelle essudazioni naturali salmastre era stato estratto il preziosissimo germe segreto, il quale secondo il concetto stesso che gli antichi avevano dell’orbe terracqueo, non solo era sopravissuto da età primigenie, ma costituiva il nutrimento della terra stessa». La profusione di dati e deduzioni scientifiche avrebbe potuto fare di questo libro uno scritto specialistico di faticosa lettura, se la vibrante formazione umanistica della scrittrice non fosse emersa a renderlo qualcosa di simile a un testo iniziatico, volto a riavvolgere il filo di un passato né scomparso né passato mai. Lungo il tragitto che la condusse a risolvere l’interrogativo di partenza, la Schiavi assecondò la propria avventurosa propensione a inoltrarsi nelle profondità della natura e della storia andando a perlustrare fondali dove sono rimasti intrecciati mito, scienza e conoscenza, per riportarne un tesoro di rivelazioni e suggestioni incompatibili con una forma mentis novecentesca. «La lunga escavazione del mestiere pittorico 20 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 21 Nella pagina accanto: Pianta di salvia, collezione privata. A destra: La giacca di Giona, collezione privata. mi condusse a scoprire misteri sotterranei che non rientravano in quelli che erano parsi i propositi per raggiungere una meta individuale. L’impulso a creare sospinse inconsciamente sul tracciato di una maniera di pensare - e cioè di essere - già esistita e perduta da molto. L’invenzione di un metodo nuovo per esprimersi, attraverso arte, si innestò in una ricostruzione che si rivelava connessa a età favolosamente remote». Gli argomenti proposti dalla Schiavi furono giudicati convincenti dalla comunità scientifica, che accolse Il Sale della Terra fra i testi di riferimento per gli studi in materia; le medesime conoscenze divennero fonte di profondo incantamento quando andarono a propiziare la sua attività creativa. Nelle quattro vetrate monumentali realizzate nel 1953 per il palazzo di giustizia di Bolzano, dove ancora una volta la potenza del colore è rivelata dall’intervento trasfigurante del fuoco, l’artista mostrò di saper governare con vigorosa franchezza molte figure articolate in composizioni drammatiche. La sua pittura da cavalletto si concentrò invece su soggetti più meditativi, immobili e immersi in un perfetto silenzio: gli ambienti della sua casa di campagna e gli oggetti familiari che la popolavano. Lo schema prevalente di queste opere dispone suppellettili domestiche, strumenti da pittore, ortaggi appena raccolti, mobili di famiglia, a occupare uno spazio ridotto a ridosso della cornice: alle loro spalle, simile alla bocca di un pozzo, si spalanca un fondale vuoto, oscuro o di tinta accesa ma singolarmente profonda, che invade lo sguardo e lo trascina in distanze da non misurarsi con il metro del vigile intelletto. Gli oggetti protagonisti della rappresentazione si allineano solennemente sulla soglia del quadro, definiti con l’educata schiettezza che fu propria alla pittura romana di genere, e la loro pre- senza acquista le sembianze di una apparizione: fusi nella ammaliante materia dell’encausto, si imbevono di una luce segreta che sembra emersa dal fondo di uno specchio colmo d’ombra, e abitano per sempre una contrada sottratta agli oltraggi della storia. I maestri della natura morta barocca si erano proposti di fissare i fuggevoli connotati di un istante colto fra la moltitudine di quelli destinati a consumarsi nel gorgo del divenire; all’opposto, nei dipinti della Schiavi il trascorrere del tempo appare non sospeso ma contraddetto e vanificato. Dando 22 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 A sinistra: L’Annunciazione, collezione privata. Sotto: copertina della Monografia Scheiwiller. Il dipinto riprodotto sulla medesima si intitola La camera dell’uva di nuovo respiro a un’arte che fu viva in giorni lontanissimi, la pittrice fa fiorire nel presente il passato remoto, senza ricorrere alla scorciatoia degli arcaismi comuni a tanta figurazione novecentesca, né ad alcun’altra forzatura stilistica che possa manifestare il gusto della sua o di alcun’altra epoca. Il suo legame con il mondo antico è sancito da una parentela di sangue e di spirito, nutrito dallo studio, ed esercitato nel lavoro con la ripetizione rituale di gesti e procedure ricevuti in eredità da genti lontane, che andarono alla scoperta della realtà senza reciderla dalle sue misteriose radici. Elena Schiavi si incamminò per strade rimaste a lungo deserte e raccolse echi dispersi di voci remote, a somiglianza del Pascoli dei Carmina che riconobbe nella lingua di Virgilio lo strumento capa- ce di dare corpo ai suoi più alti pensieri e fu poeta latino, non soltanto poeta in latino. Nel poemetto Crepereia Triphaena , egli si trova ad assistere al rinvenimento del sepolcro di una giovinetta romana, adorna dei suoi monili di promessa sposa e circondata dai giocattoli della sua recente fanciullezza: il millenario volto di ragazza affiora al suo sguardo come da una limpida acqua notturna, i capelli sparsi pettinati dalla corrente. La commozione trabocca in pianto: «Sed quid antiquis oculi videnti / nunc mihi effeti lacrimis madescunt?». Vive lacrime gli bagnano gli occhi, salendo da lontananze vertiginose; la magia del verso, o del colore, ha bandito l’arbitrio del tempo, lo sguardo penetra oltre la scorza delle apparenze, lo spirito incontra la patria che sempre attende il suo ritorno. novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 25 Storie di carta FRA GLI SCAFFALI: LIBRERIE DA LEGGERE Il commercio dei libri nella letteratura MASSIMO GATTA B enché nella prima di una rara serie di sei cromolitografie della LiebigappaiaunLibraio ambulante presso gli antichi Greci, non si può certo parlare di commercio librario se non a partire dalla prima metà del Cinquecento. Sarà infatti un letterato dal tragico destino come Nicolò Franco (impiccato a Roma dall’inquisizione l’11 marzo 1570), amico dell’Aretino e dotato d’incontenibile vena satirico-polemica ed estimatore di Erasmo, a scrivere una delle più antiche descrizioni del mestiere di libraio. Nell’ottavo dei suoi Dialogi piacevoli (Venezia, Giolito, 1539) Sannio così dice a Cautano: «Se ben l’arte di vender libri, pare la più facile, che si ritruovi, per esercitarla ben bene, bisogna altro, che haver bottega con la bella insegna apiccata dinanzi a la porta […]. Vi bisogna havere mill’altre industrie, e che tutte si sappiano mostrare a tempo, per guadagnare un bel tesoro ogni anno». Il libro del Franco verrà in seguito “purgato” dal domenicano Girolamo Giovannini da Capugnano che lo ristampa a Venezia nel 1593 (tipografi Francesco Zuliani e Giovanni Cerutto). Stranamente Franco non compare nel capitolo dedicato ai martiri del libro nell’aureo libretto Historie per gli Amici de’ Libri da Francesco Lumachi libraio fiorentino raccolte narrate e pubblicate (Firenze, Lumachi, 1910). Mentre è così ricordato da Leonardo Olschki in L’arte della stampa e i tipografi secondo le vedute di poeti e di eruditi tedeschi (Firenze, Olschki, 1909): « […] Né si può ammettere che il Morhof abbia dato per incuria il titolo che egli riferisce, al dialogo Il fonte Caballino, nel quale il Franco tratta di cose librarie: Sannio (sotto questo nome è nascosto l’autore stesso) dimostra a Cautano che il mestiere più utile del mondo è quello del libraio e gli dà – non senza satira – insegnamenti per bene eser- citarlo». Questo dialogo del Franco è stato ristampato in una delle eleganti strenne Marsilio (2005), col titolo Dialogo del venditore di libri 1539-1593, a cura di Mario Infelise, nelle due versioni, quella originale e quella di Girolamo Giovannini. Dopo un paio di secoli, durante i quali quasi nulla di significativo appare su di loro, si torna tra Otto e Novecento a parlare di librai e librerie. Agli inizi dell’800 Niccolò Bettoni pubblica il raro opuscolo Delle edizioni Bettoniane dialogo. Un tipografo, un librajo, un forestiere (Milano, 1828) a cui seguirà, 26 l’anno dopo, L’osservatore di Gasparo Gozzi (Napoli, 1829), in cui si incontra un libraio che «[…] stavasi nella bottega sua sedendo dietro al cancello». La letteratura dedicata ai librai potrebbe apparire esigua; al contrario molti librai e librerie sono presenti in romanzi, racconti, gialli, film, poesie, articoli, oltre che in giubilari, autobiografie, biografie e ovviamente saggi (del resto molti scrittori e poeti hanno un passato di librai). Saranno l’800 e il ‘900 i secoli d’oro della fioritura di una vera e propria letteratura libraria. Lo scrittore Charles Nodier in Le Bibliomane (1831) ricorda la figura di Théodore che amava compulsare cataloghi di librai; Nodier tornerà sul tema nell’anonimo Le Bibliomane ou le nouveau Cardillac (1836), attribuito a Nodier da Ramon Miguel y Planas, come ci ricorda Alberto Castoldi in Bibliofollia (Bruno Mondadori, 2004 e 2006). Nel racconto si narra la storia di un libraio che, volendo la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 impossessarsi di un libro molto raro, ne uccide il proprietario. Lo schema sarà il modello per Bibliomanie (1837), del sedicenne Gustave Flaubert, con la tragica figura del libraio-bibliofilo Giacomo, assassino di Baptisto per colpa di un libro raro. Ancora in pieno Ottocento incontriamo poi Palff, il libraio olandese protagonista di una sconosciuta commedia dell’avvocato Alberto Nota, Il bibliomane (Sonzogno 1829 e Interlinea 2001). In essa il libraio è amico e fornitore di Don Geronzio, il bibliomane del titolo, che non può sostenere la dote della nipote Faustina perché ha speso tutto nell’acquisto di libri; tema che troverà in seguito ampio sviluppo in Le crime de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut (1881) di Anatole France, libro sacro ai bibliofolli. Anche Benedetto Croce troverà il modo di parlare di librai, come in Stampatori e Librai in Napoli nella prima metà del Settecento (Strenna Giannini, novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 1892), ma anche nella lettera al libraio torinese Bourlot, edita nel ’48 e in quella al libraio Pescarzoli (Roma, catalogo libreria Paradiso, 1952). Del 1894 è invece The Adventure of the Empty House in cui il mitico Sherlock Holmes si traveste da vecchio venditore di libri per seguire un’indagine delicata, sarà questa l’unica avventura dove compare un libraio. Ma è il Novecento il secolo aureo per la nostra storia portatile della letteratura libraria. Nel 1910 appare infatti l’elegante libretto Historie per gli Amici de’ Libri da Francesco Lumachi libraio fiorentino raccolte narrate e pubblicate, Lumachi aveva già pubblicato brevi scritti dedicati al mondo librario, in seguito riuniti in Nella Repubblica del libro (Firenze, 1907), prefàto da Piero Barbèra. Ora la figura del libraio moderno (anche antiquario) ha preso consistenza e peso culturale. Non è più solo intermediario tra l’editore e il cliente ma assume un ruolo centrale nell’ampio contesto della storia della cultura e delle idee, come scriverà anni dopo Eugenio Garin, riferendosi all’editoria. Il libraio, e la libreria come luogo fisicosimbolico, sono storicamente crocevia di idee, teorie, aspirazioni, movimenti, transito periodico di cultura viva, ma anche di strani personaggi. Come dimenticare l’esperienza della Libreria degli 27 scrittori di Michail Osorgin, che nella Mosca della rivoluzione d’ottobre ospita letterati e poeti dissidenti di cui stampa, in copie uniche manoscritte, poesie e racconti che altrimenti non vedrebbero mai la luce; oppure le storie atipiche di librai come Umberto Saba, Giuseppe Rossetti nella Roma di via Veneto o quella di Agnese De Donato con la sua storica “Libreria Al Ferro di Cavallo”. Tornando ai primi del secolo scorso Sem Benelli in Tignola (Treves, 1911) ci mostra il libraio Teodoro Gonella nella cui libreria si svolge l’azione; quasi dieci anni dopo sarà Federigo Tozzi che in Tre croci (Treves, 1920) inserisce, nel più ampio e complesso scenario del romanzo, la figura del libraio impersonata dai fratelli Giulio, Niccolò e Enrico. Ogni categoria professionale ha un santo protettore e anche i librai ne hanno uno, San Giovanni di Dio, un portoghese del XVI secolo, fondatore dell’ordine dei Fatebenefratelli, il quale lavorò in Spagna come libraio ambulante, aprendo una piccola libreria a Granada (lo scrive Giuseppe Fumagalli a Formìggini in una lettera pubblicata nel ‘30 su «L’Italia che scrive»). E’ poi del 1934 Il libraio, una poco nota lettura pubblica (ristampata da Biblohaus) che l’allora giovane Cesarino Branduani fece la sera del 18 maggio nell’aula magna della 28 “Casa del fascio” di Milano ai soci dell’Istituto fascista di cultura e dell’Alleanza Nazionale del Libro, edita lo stesso anno da Hoepli. Branduani è figura topica del mondo librario, per una vita direttore della libreria Hoepli di Milano. Chi non ricorda le sue Memorie di un libraio (Longanesi, 1964 e Instar, 2005), con prefazione di Montanelli (che ne scriverà più volte), miniera di notizie e anche di simpatici pettegolezzi? Branduani aveva già pubblicato la plaquette Nozze d’oro coi libri 1907-1957, destinata agli amici. Contemporaneo all’opuscolo di Branduani è anche un raro libretto che Giovanni Scheiwiller stampa per “Gli Amici del Libro”, Il sabato del bibliofilo di Raffaele Carrieri (ristampato da Henry Beyle), rievocativo dei sabato hoepliani ideati dal libraio napoletano Mario Armanni, notevole figura di antiquario e uomo di libri, che Umberto Saba ricorderà tra i suoi numi tutelari e mèntore della sua discesa in campo come libraio antiquario nella Trieste del primo Novecento la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 (ne scrive in Storia di una libreria del ’64, ristampato sempre da Henry Beyle), dove apre la “Libreria Antica e Moderna” di via San Nicolò; rievoca questa grande esperienza libraria sabiana il recente La libreria del poeta. Nel ‘37 appare in inglese quello che è da considerarsi un pilastro della letteratura libraria, le Adventures of a Bookseller del libraio antiquario Giuseppe (Pino) Orioli, pubblicato come dodicesimo titolo nelle sue raffinate edizioni fiorentine della “Lungarno Series”. Questa rara prima edizione Orioli, intimo amico di Norman Douglas e di molti altri letterati, la volle stampare privatamente in 300 copie numerate e firmate. Inutile dilungarsi sulla “Lungarno Series”, che tra l’altro pubblicò nel ‘28 la prima edizione di Lady Chatterley’s Lover di Lawrence, perché lo ha egregiamente fatto Ornella De Zordo ne Una proposta fiorentina degli anni Trenta: The Lungarno Series. L’autobiografia di Orioli verrà tradotta in italiano, e ristampata sette anni dopo da Modernissima di novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano Gian Dàuli (Giuseppe Ugo Nalato); mentre l’ultima ristampa risale all’88 edita e prefata da un colto libraio antiquario, scrittore e editore milanese come Alberto Vigevani nelle sue edizioni Il Polifilo (Vigevani stesso ci ha lasciato un libro di ricordi del mondo delle librerie e del collezionismo librario, La febbre dei libri. Memorie di un libraio bibliofilo, che si aggiunge a quelli celebri di Sylvia Beach, Adrienne Monnier, Eva Veronese Ghibellini, Fidia Gambetti e Agnese De Donato). Ma già sento mormorare gli appassionati di letteratura gialla. Non temete, anche questo genere ci ha lasciato, tra furti e omicidi, notevoli tracce di librai e librerie, a partire dal nostro Augusto De Angelis in Le avventure poliziesche di De Vincenti, Sei donne un libro oppure in Giobbe Tuama e C. (entrambi editi da Minerva nel ’36, il secondo ristampato nel 2000 dalla Fondazione Rosellini di Senigallia e nel 2008 da Sellerio). Nello stesso ’36 appare la prima traduzione italiana de La bottega del libraio (The bookshop) di Aldous Huxley, presente nella raccolta di racconti Dopo i fuochi d’artificio (Milano, Mondadori, nella “La medusa”) che stranamente ha l’identico titolo di un raro romanzo di Bianca De Maj edito a Milano da Treves nel 1927 e che Garzanti ristamperà nel 1944 (rarissimo, non segnalato nell’ICCU). Il racconto di Huxley uscì nella raccolta Limbo and other stories (Chatto, 1920). Incontriamo poi Ellery Queen che in The French powder mistery (1937) ci mostra James Sprinter capo del reparto libreria del “Grande Emporio French”. Ma il maestro dell’hard boiled che ha introdotto un libraio nello scenario di un suo romanzo è il Raymond Chandler di The Great Sleep (1939), il primo romanzo in cui compare Philip Marlowe (che nel film di Hawks del ’45 ha il volto di Humphrey Bogart), sulle tracce di un pericoloso personaggio con sullo sfondo un libraio e la sua equivoca libreria. Ma visto che siamo finiti nel maremagnum del giallo, la nostra portatile letteratura libraria non può non segnalare i gialli di Marco Page (Harry Kurnitz), John Dunning, Lawrence Block e Julian 29 Symons. Del primo mi piace ricordare Fast Company (Edizione straordinaria), in cui il protagonista è un libraio-detective; del secondo come non citare Booked to die (La morte sa leggere) con il libraio-detective Cliff Janeway di Denver, che ritroveremo anche in The Bookman’s Wake (Le ceneri del corvo). Invece Block è il creatore dell’ex ladro e ora libraio Bernard Rhodenbarr, proprietario della libreria newyorchese Barnegat. Lo vediamo in azione in The Burglar Who Liked to Quote Kipling (Il ladro che leggeva Kipling), in The Burglar Who Studied Spinoza (Il ladro che studiava Spinoza), in The Burglar Who Traded Ted Williams (Il ladro che rubava figurine) e infine in The Burglar Who Thought He Was Bogart (Il ladro che credeva di essere Bogart). Quindi Symons, autore dell’eccellente biblio-mistery Bland Beginning (I falsi di Amberside), dove compare l’enigmatico libraio antiquario Jonathan Jacobs. Infine è la volta di Ghost Walk di Marianne MacDonald, non ancora tradotto in italiano, protagonisti la libraia 30 antiquaria Dido Hoare e la sua libreria. La nostra breve storia portatile della letteratura libraria volge al termine, ma prima vorrei ricordare altri scrittori che hanno voluto rendere omaggio, in maniera più o meno evidente, ai librai e alla loro meravigliosa attività: Giovanni Papini in Il libraio inverosimile (uscito in prima edizione da Vallecchi nel 1940 in Figure umane, ristampato infine da Henry Beyle), Luigi Bartolini in Ladri di biciclette, Marino Moretti in La libreria di Pazzo Pazzi, Giovanni Ansaldo (con lo pseudonimo di Stella Nera) in Un libraio misantropo e in Una vera signora in libreria (ristampato ancora da Henry Beyle), Diego Fabbri nella commedia La libreria del sole, George Orwell in Keep the Aspidistra Flying (Fiorirà l’aspidistra), Antonio Delfini in Un anno dopo, Isaac Asimov in Murder at the ABA (Rompicapo in quattro giornate), Michael Ende la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 in La storia infinita (ricordate la libreria di Carlo Corrado Coriandoli che apre il romanzo?), Indro Montanelli in Cesarino, Hélène Hanff in 84, Charing Cross Road, Piero Chiara in Vie di librai, Carlo Bernari in Il grande letto (Bernari stesso fu in gioventù libraio a Roma insieme a Pescarzoli). Ai giorni nostri invece Paul Auster in Sbarcare il lunario. Cronaca di un iniziale fallimento e in Follie di Brooklyn, Simenon in Il piccolo libraio di Archangelsk, Cathleen Schine in La lettera d’amore, Diane Setterfield in La tredicesima storia, Arturo Pérez-Reverte in Il Club Dumas, Åsne Seierstad in Il libraio di Kabul, Carlos Ruiz Zafòn in L’ombra del vento; e poi Claude Izner (pseudonimo delle sorelle libraie parigine Liliale Korb e Laurence Lefévre) in Il mistero di Rue de Saints-Pères e in La donna del Pére-Lachaise, con al centro il libraio-detective Victor Legris novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano della libreria parigina Elzévir, al quale fa compagnia il commissario-libraio Van Veeteren in alcuni thrillers di Nesser Håcan tra i quali mi piace ricordare Il commissario e il silenzio. Ma anche Hans Tuzzi (Adriano Bon) ci ha regalato almeno quattro gialli a sfondo librario (tutti editi da Sylvestre Bonnard) nei quali indaga il commissario Melis, così come al mondo della libreria sono ispirati Il libraio ubriaco di Aldo Luppi, Il libraio di viale Mazzini di Claudio M. Messina, Il libraio di Chiara Pedrotti, Un delitto in libreria di Gianfranco Cordì, Il libraio di Marco Lodoli, Il libraio di Selinunte di Roberto Vecchioni, Il libraio di Michael D. O’Brien. Mentre Giovanni Grazzini, nel suo La bottega di Gonnellone del 1959, ristampato molti anni dopo nella miscellanea di suoi articoli dal medesimo titolo (Milano-Napoli, Ricciardi, 1978) ricordava la bottega 31 fiorentina del grande libraio Ferrante Gonnelli (il Gonnellone del titolo). Non posso però terminare questo fin troppo breve viaggio letterario nelle librerie di ieri e di oggi senza citare il premio Nobel Orhan Pamuk che nell’autobiografico La valigia di mio padre, discorso d’accettazione del premio, così scrive: «[…] E la biblioteca lo dimostrava. Mio padre l’aveva costituita con i libri comprati durante i suoi viaggi all’estero, specialmente a Parigi e in America, e con quelli acquistati negli anni Quaranta e Cinquanta nelle librerie che vendevano libri in lingua straniera e in quelle che conoscevo bene anch’io. Negli anni Settanta, con i soldi che mi dava mio padre, compravo nelle vecchie librerie di Istanbul, con grande avidità, come se volessi riempire i vuoti della mia vita, libri usati dalle pagine ingiallite e polve- 32 rose. Quelle librerie fatiscenti e incredibilmente disordinate che si trovavano sui lati delle strade, nei cortili delle moschee, sotto i muri diroccati, mi influenzavano quanto i libri che leggevo». Negli ultimi tempi molti altri biblioromanzi sono usciti, dove più o meno figurano librai e librerie. Ad esempio La fortunata mattina di un venditore di libri senza padre di Carlo Brera, uscito in prima edizione da Longanesi nel 1982 e ristampato nel 2008 dall’editore Book Time, con uno scritto di Oreste del Buono. Poi via via: Il libraio di Atlantide di Manuel Pimentel (Il Punto d’Incontro), Firmin di Sam Savage (Einaudi), Il libraio di Kolos di Luca Larpi (Imago), Il libraio annuvolato di Mauro Fogliaresi (Marna), La lista di carbone di Christiana la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Ruggeri (Mursia), La libreria del poeta di Elena Bizjak Vinci e Stelio Vinci (Hammerle) incentrato su Umberto Saba libraio antiquario a Trieste; e ancora Al paese dei libri di Paul Collins (Adelphi), La libreria del buon romanzo di Laurence Cossé (Edizioni e/o), Hotel Bosforo di Esmahan Aykol (Sellerio), L’ultimo libro di Zoran Zivkovic (Tea), Il libraio notturno di François Foll (Piemme), Rue de l’Odeon di Adrienne Monnier (:punti edizioni), Assassinio in libreria di Lello Gurrado (Marcos y Marcos), L’odore dei libri di Vincenzo Caccamo (Culture), Piero Femore, il libraio di Torino (Trauben), Libraio per caso di Romano Montroni (Marsilio), fino a La libraia di Orvieto di Valentina Pattavina (Fanucci); La banda del formaggio e Siamo buoni se siamo buoni di Paolo Nori (marcos y Marcos), Una stanza piena di sogni di Ruta Sepetys (Garzanti), Il libraio di Parigi di Mark Pryor (Time Crime), Il segreto della libreria sempre aperta di Robin Sloan (Corbaccio) e da Genova il simpatico libraio-detective Andrea Serravalle, cultore e collezionista di Maigret (si chiama così anche la sua libreria antiquaria); è l’amico del cuore del commissario Falsopepe e lo aiuta in molte indagini delicate, come quelle narrate nei due bei gialli di Mario Paternostro, Troppe buone ragioni (Il Nuovo Melangolo) e Le povere signore Gallardo (Mondadori). Infine i recentissimi Lo strano caso dell’apprendista libraia di Deborah Meyler (Garzanti), Il libro dei ricordi perduti di Louise Walters (Corbaccio), Una piccola libreria a Parigi di Nina George (Sperling) e il delizioso La misura della felicità di Gabrielle Zewin (Nord), ovvero come una bambina può insegnare a un libraio ad amare i libri. Ma sulla scrivania del bibliografo è appena giunto anche un bel romanzo storico ambientato nella Sicilia del Cinquecento, La bottega di carta di Mario Alberghina (Giuseppe Maimone Editore, Catania): protagonisti due librai, of course! E senza dimenticare l’autobiografia di un appassionato libraio fiorentino, Alessandro Falciani in Felicemente annegato nei libri. Quarant'anni di un libraio fiorentino (Edizioni Firenze Leonardo, 2014). novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 33 inSEDICESIMO L E M O S T R E – L’ I N T E RV I S TA D E L LA MOSTRA/1 L’ULTIMO ARICÒ Ragioni inquiete a cura di luca pietro nicoletti aprirsi degli anni Novanta inaugura l’ultima, solenne e quasi tragica stagione della pittura di Rodolfo Aricò. È in quel decennio, che si chiude con la dipartita dell’artista nel 2002, che si tirano le fila di un discorso non solo espressivo, ma esistenziale, come a L’ voler compendiare gli esiti più alti delle fasi precedenti, fra intemperanze gestuali placate ma non sopite e spirito di geometria che, in più di un’occasione, ha collocato il suo lavoro sotto le insegne della pittura analitica. Eppure, nel suo temperamento si agitano MESE un’inquietudine che non poteva risolversi nell’algida, platonica impersonalità di una ricerca puramente votata a forzare i limiti ontologici del linguaggio espressivo. Già nel 1990, titolando un’importante monografia sull’artista, Giovanni Maria Accame parlava di Inquietudine della ragione. Era l’artista stesso, in fondo, a suggerire questa lettura: la parola “inquietudine” è frequente nei suoi scritti, con un’accentuazione proprio nel tratto finale della sua esistenza. Non stupirà quindi incontrare nel suo catalogo una tela del 1998 intitolata Pittura inquieta, che dà il titolo alla raccolta ma intensa mostra curata da Francesca Pola per le Gallerie d’Italia di Piazza Scala a Milano. Offrendo l’occasione di rivedere un significativo nucleo di opere tarde dell’artista oggi nelle collezioni di Banca Intesa San Paolo, la mostra offre spunti di riflessione su questo momento che Pola definisce, giustamente, di «drammatizzazione materiale e formale», caratterizzata da «sconfinamenti della materia oltre i margini consueti». Francesco Tedeschi, in uno dei testi in catalogo, pone invece l’accento sul «modificarsi delle soluzioni formali e spaziali che poneva la sua pittura in un rapporto dialettico, quando non antagonistico, Rodolfo Aricò, Sensus 2 34 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Rodolfo Aricò, Modificazione con la razionalità del costruire e con le norme dello spazio architettonico». Si comincia infatti a percepire la pittura, nel suo lavoro, come un soggetto in divenire. Rispetto alla stagione minimale che copre tutti gli anni Settanta, di cui i due decenni successivi ereditano l’utilizzo di telai sagomati che emancipano il quadro dalla dimensione della cornice, negli Ottanta e nei Novanta riemerge una dimensione esistenziale: anziché superficie colorata piatta e uniforme che produce un piano che esalta la geometria interna ed esterna dei contorni del campo, il segno torna a farsi vedere e a dichiarare la propria identità di linguaggio fatto di segni, trasparenze e colature. Intendeva probabilmente questo Accame quando, nella monografia del 1990, annotava che «il rapporto tra struttura e colore non è mai un rapporto di dipendenza, ma sempre e incessantemente di contaminazione tra due realtà distinte». Il punto ultimo su cui si arrestava il suo discorso, però, era il grande Sensus del 1988, pubblicato in copertina in quel caso e che accoglie fin dall’ingresso i visitatori di Gallerie d’Italia nella mostra attuale. Ma era un punto di arrivo che permetteva di compendiare la problematica generale di quella fase di Aricò esemplificandola con uno dei suoi vertici espressivi più compiuti. Vi si ritrova infatti una sottolineatura del dipinto come oggetto in senso “analitico” (il telaio sagomato) anziché come immagine ritagliata da un diverso piano spaziale e delimitata da una cornice-finestra; non manca però nemmeno una citazione a uno degli artisti che Aricò ha più amato: Barnett Newmann. La “cornice” dipinta (una riga verticale bianca a sinistra, due strisce nere sul lato verticale destro e sul margine inferiore) che ritaglia un campo blu quadrato all’interno del quadro, infatti, è quasi un esplicito omaggio al pittore americano e alla sua idea di astrazione che ambisce alle vette del sublime attraverso la campitura assoluta e profonda. Quel quadrato centrale, oltretutto, ritaglia al centro un’immagine di puro colore: è la pittura stessa, in fondo, il vero soggetto del quadro, ma on in quanto linguaggio autoreferenziale quanto come scelta di impatto emotivo attraverso il colore e il dilagare su dimensioni monumentali. In una fredda opzione analitica, infatti, non sarebbero state ammissibili le colature o certe zone di colore attenuato che mette in evidenza il segno del pennello: è un ritorno, forse, alla veemenza delle esperienze gestuali di Nuova Figurazione, fra fine anni Cinquanta e inizio Sessanta, quando il suo lavoro poteva essere messo in sequenza con le indagini di segno di Emilio Scanavino e Tino Vaglieri. Per tutti e tre, infatti, nel discorso figurale non c’era spazio per il colore: il monocromo grigio serviva a concentrarsi sul problema del segno. Il colore intenso e saturo sarà una scoperta dei decenni successivi che andrà a sovrapporsi a questo sostrato. Negli anni Novanta, poi, per Aricò arriverà il momento per una tavolozza dai toni più “teneri”, come ha giustamente fatto notare Francesca Pola, a indicare una stratificazione di novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano campiture che si manifestano per affioramenti. Al tempo stesso, Aricò ostenta qui il procedimento esecutivo del dipinto: la pennellata è evidente, e a questa si sommano interventi di collage applicati con le graffette a vista, con ulteriori interventi di pittura che accentuano la sensibilità epidermica della superficie e immettono elementi narrativi. Quell’inquietudine latente, insomma, comincia a dichiararsi in modo più palese, trovando un appoggio nella coeva produzione narrativa dell’artista. Aricò, infatti, è pittore che scrive, e con una finezza di analisi e di stile che raramente si incontrano negli scritti d’artista: merito della mostra attuale è di pubblicare otto racconti scritti dalla metà degli anni Novanta. Sono testi in cui l’artista apre un dialogo con i maestri del passato: nella finzione letteraria, infatti, egli è un narratore esterno che entra negli studi degli artisti e racconta in prima persona incontri e avvenimenti. E lui, sotto mentite spoglie di Aert de Gelder, l’allievo a bottega da Rembrandt, che nel suo ritratto somiglia pericolosamente al protagonista del Capolavoro sconosciuto di Balzac, eroe romantico che lotta titanicamente con la pittura, da cui però usciva con piglio «altero» e «regale». Ed è sempre lui a fare visita al vecchio Reynolds, su cui esprime un giudizio di condanna più morale che stilistico, come è l’acquirente di una tela ultima di Vermeer, in un’ipotetica bottega di Delft del Seicento, dopo la morte dell’artista amato e frequentato in vita. Ma parlando dei maestri del passato, dal Seicento fino 35 Rodolfo Aricò, Piacere tenebroso all’amatissimo Rothko, Aricò in realtà parla di sé: sono le sue, prima di tutto, le «tele in attesa di gesti» che le “feriscano” con il colore. I racconti di Aricò, secondo Tedeschi, avevano un valore “testamentario”, in quanto vi emerge «un forte e acuto senso della fine, la ricerca quasi del significato della fine; non tanto della morte […] ma della fine come stato d’animo, creativo e forse definitivo. La fine, e non la RODOLFO ARICÒ. PITTURA INQUIETA. GLI ANNI NOVANTA A cura di Francesca Pola MILANO, GALLERIE D’ITALIA 3 ottobre 2014 18 gennaio 2015 morte, come un passaggio di stato». Un senso delle cose ultime incombe in maniera ineluttabile. Aricò, però, era cosciente che questa doveva essere una condizione necessaria all’atto creativo. Lo dice chiaramente in Una risata indecifrabile, il primo di questi racconti: «La felicità che regna nel mondo non è stata congegnata per i grandi uomini. A loro è riservata un’altra felicità che sorge dal dolore, dalla solitudine, dall’annientamento, dalla consapevolezza che le sofferenze più furiose sono a un passo da loro, e gli enigmi più laceranti risiedono nel loro spirito; ed è solo a tali condizioni che questi astri magnifici che l’universo scaglia contro di noi, tra un secolo e l’altro, sono capaci di generare quelle opere che fanno la grandezza di tutti, anche dei miseri, degli inetti, degli sventurati». (lpn) 36 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 LA MOSTRA/2 / MANZÙ E MARINO Nuove letture n una lettera dei primi anni Settanta, l’editore e scrittore Gualtieri di San Lazzaro esortava Marino Marini ad accettare la proposta di Jacques Lassaigne di una sua mostra antologica presso il Musée d’Art Moderne della Ville de Paris: «La tua mostra a Parigi di scultura e pittura», scriveva, «è indispensabile, e potrebbe I costituire un monito. D’altra parte se ti rifiuti, ripiegheranno su Manzù o su Greco e sarebbe tutta colpa tua». Per l’editore di “X XXe Siècle”, amico e sodale dello scultore già dagli anni Trenta, che aveva da poco curato il primo catalogo generale della sua opera, l’arte di Marino aveva assunto un valore emblematico della crisi dell’uomo moderno: non a caso questo sarebbe stato un monito per un’umanità minacciata e logorata dalla modernità. Ma si può scommettere, parafrasando il titolo della mostra della Fondazione Magnani Rocca, che anche per lui Marino fosse “l’ultimo dei moderni”. Il suo parere su Manzù, oggi difficilmente condivisibile, doveva essere invece di ordine diverso. È invece un dato certo che sia Giacomo Manzù sia Marino Marini, due delle tre “M” della scultura italiana del dopoguerra insieme a Francesco Messina, avessero raggiunto in parallelo una posizione di tutto rilievo nel panorama nazionale e ottenuto un consenso internazionale in ascesa fra anni Cinquanta e Sessanta. Sono molti i punti di contatto fra i due, che la mostra e il bel catalogo curati da Laura D’Angelo e Stefano Roffi mettono in rilievo, secondo un modello di vite parallele che mette a confronto, su più livelli, due artisti che negli stessi anni, per vie autonome ma seguendo percorsi e sviluppando tematiche analoghe, hanno proposto due vie di conciliazione fra la tradizione italiana e l’aggiornamento alle istanze moderniste della scultura figurativa. Non si tratta, infatti, di un banale confronto di poetiche, che allinea trascrizioni di stati emotivi della fruizione, ma di un confronto che attraverso gli strumenti della migliore storia dell’arte oggi disponibili offre una più solida base documentaria e critica su cui avviare un discorso sul linguaggio espressivo calato nel suo tempo. Il principale merito di questa mostra, e soprattutto del suo catalogo, novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano è di offrire nuove e preziose chiavi di lettura a un tema su cui, in termini di poetica e di suggestioni, si sarebbe creduto non ci fosse più nulla da dire: al contrario, da alcuni dei saggi in catalogo, di autori che ci piacerebbe poter leggere più di frequente, arrivano le chiavi per leggere in modo nuovo opere e autori che sono da sempre sotto gli occhi di tutti. Ripercorrere le linee portanti, come fa Barbara Cinelli, del dibattito italiano intorno alla scultura nel secondo dopoguerra, non è una banale rassegna di frammenti critici, ma un brillante tentativo di connettere la ricezione critica dei due autori a una discussione più ampia, fra mostre personali biennali e quadriennali, facendo il punto su un tratto della cultura italiana, sui suoi slanci di aggiornamento e, soprattutto, sulle sue difficoltà di rinnovamento. Il confronto fra il “laico” Marino e il “cattolico” Manzù, entrambi instradati verso un rapido consenso internazionale, chiama in campo il problema di un primato dei valori etici su quelli formali, di un aggiornamento formale e di una questione di contenuto. In Manzù gli interpreti potevano vedere dei residui di cultura ottocentesca che rimontavano a Medardo Rosso; Marino, invece, sembrava indicare la via maestra del rinnovamento della scultura non in termini post-cubisti. Eppure, fa notare sempre la Cinelli, la critica, pur accordandogli un plauso generale, faticherà a cogliere quegli elementi di novità che Manzù, ad esempio, cercava di immettere nella scultura. In quel periodo, oltretutto, entrambi stavano frequentando con assiduità uno dei temi più chiacchierati e fenomenologicamente complessi delle arti figurative come il ritratto: il pollice di Manzù e la miretta di Marino, infatti, si posano sulla creta per cogliere i tratti dei Personaggi del XX 37 secolo, come recitava il titolo della famosa mostra dei ritratti di Marino, donati poi al Comune di Milano, nel 1972. E sia per capire il senso degli intellettuali di Marino quanto degli uomini illustri di Manzù non bastano, Nella pagina accanto: Marino Marini, Cavallo e Cavaliere 1950. Sotto: Giacomo Manzù, Bambina sulla sedia, 1955, fusione in bronzo 38 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Da sinistra: Marino Marini, Il trovatore, 1950, olio su tela, 100 x 80 cm; Giacomo Manzù, Cardinale seduto, 1957, fusione in bronzo come spesso si è fatto per la storia del ritratto, gli strumenti della fisiognomica: Manzù che ritrae Giovanni XXIII o, qualche anno dopo, il chirurgo Christian Barnard, infatti, sono fatti del mondo dell’arte che salgono agli onori delle cronache. Il saggio di Laura D’Angelo, infatti, raccoglie il frutto di indagini recenti sulla fortuna delle opere d’arte sulla stampa periodica, che restituisce uno spaccato autentico, e ancora poco sondato, di come questa poteva essere percepita, a livello di larga diffusione, nel proprio tempo. Era imprescindibile, a questo punto, interrogarsi, oltre che sui misteri della forma plastica, sui problemi posti dalla riproduzione fotografica della scultura: come mette in evidenza in maniera folgorante il saggio di Flavio Fergonzi, infatti, non solo l’occhio fotografico non è mai neutro nei confronti dell’oggetto, ma l’interpretazione che offre della forma è sia un atto critico sia un filtro per mostrare una scala di valori. In una rilettura complessiva degli apparati fotografici delle prime monografie sui due artisti, infatti, «non solo parlano le esclusioni e le inclusioni [di opere, n.d.r.], ma anche i tagli MANZÙ/MARINO. GLI ULTIMI MODERNI A cura di Laura D’Angelo e Stefano Roffi MAMIANO DI TRAVERSETOLO, FONDAZIONE MAGNANI ROCCA 13 settembre - 8 dicembre 2014 fotografici, le cancellazioni dei fondali, le sequenze di punti di vista diversi per la stessa opera». Oltre che “occhio del tempo”, dunque, la macchina fotografica stabilisce, di concerto spesso fra artista e fotografo, quali siano i valori da sottolineare (arcaismo, purismo o classicismo) e di quale “aura” si voglia caricare l’opera. Il gioco si consuma su pochi elementi, ma questi comportano delle scelte cruciali: se la scultura sia un oggetto nell’ambiente, con un suo “peso” che la poggia al suolo, o una pura immagine fluttuante in uno spazio incerto; e quando si tratta di volti, viene da chiedersi, ancora una volta, se si stia fotografando una forma plastica o facendo un “ritratto” della scultura stessa. (l.p.n.) novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 39 LA MOSTRA/3 BRAMANTE SECONDO PROGETTO Al Museo Palladio, a Vicenza er Palladio e Vasari, Donato Bramante (1444-1514) fu l’eroe della riscoperta della grande architettura classica: non solo rivoluzionò il concetto di spazio, ma reinventò l’immagine della chiesa e del palazzo rinascimentali. Ma come concepiva e progettava i suoi edifici, e come comunicava le sue idee a committenti e muratori? In occasione del quinto centenario della sua morte, il Palladio Museum di Vicenza ha realizzato una mostra in collaborazione con la Bibliotheca Hertziana, il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi e la Fondazione Piero Portaluppi di Milano. Al centro della mostra sarà il leggendario progetto autografo di Bramante per la basilica di San Pietro, P noto come Uffizi 20 A: “un semplice foglio di carta” come afferma Howard Burns, “ma pesa come una montagna”. “Siamo intorno al 1506 e nel concepire la più grande basilica della Cristianità per il Papa Giulio II, Bramante mette a punto un nuovo concetto di spazio architettonico ispirato a quello dei grandi edifici della Roma antica” – commenta il direttore del Palladio Museum Guido Beltramini – “E’ un processo per gradi, che Bramante registra sul foglio Uffizi 20 A mano a mano che esce dal suo cervello: il disegno è quindi una sorta di palinsesto, un diario di viaggio alla scoperta di quella che sarà l’architettura del Rinascimento”. Accanto al disegno Uffizi 20 A di Bramante, sono esposti altri disegni d’architettura cinquecenteschi, come quelli con cui Andrea Palladio studia opere bramantesche, oltre a trattati d’architettura nelle preziose edizioni originali, e disegni e modelli architettonici contemporanei di ricostruzione dei procedimenti mentali di Bramante. La mostra è un progetto del Palladio Museum basato sulle ricerche di Christof Thoenes, uno dei massimi specialisti al mondo di storia dell’architettura rinascimentale, che in decenni di studi ha distillato una sua lettura dei procedimenti di Bramante al tavolo da disegno, e l’ha sviluppata in una sequenza inedita di disegni interpretativi, realizzati con la collaborazione di Alina Aggujaro. DONATO BRAMANTE E L’ARTE DELLA PROGETTAZIONE VICENZA, PALLADIO MUSEUM 9 novembre 2014 8 febbraio 2015 40 LA MOSTRA/4 IL RITRATTO COME ICONA Mario Benedetto in via Broletto Mario Benedetto, in queste pagine: Ritratti, 2014 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 el corso degli anni Novanta, Mario Benedetto mette a punto una tecnica che pittorica che battezza “accept-painting”. Li si potrebbe collocare nella più ampia categoria dell’uso e riuso degli oggetti nell’arte contemporanea: attraverso materiali di recupero, si usano questi materiali eterogenei (ed eterodossi rispetto alla tradizione) per ottenere una nuova immagine. Anche i manifesti e la carta stampata, in quanto preesistenti all’opera, posso essere quindi considerati come “oggetti”. L’accept-painting, infatti, è sì un procedimento operativo fatto di collage e disegno che trova in questa la N propria identità linguistica, ma trova la sua ragione nella particolare applicazione che Mario Benedetto ne fa all’arte del ritratto. Non tutte le raffigurazioni di volti, infatti, sono ascrivibili al genere del ritratto; esiste poi una discriminante fondamentale, come si è accennato, nella dinamica novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano sociale che sta a monte del ritratto stesso e del rapporto fra la persona ritratta e l’artista che la ritrae: un crinale molto delicato, ma essenziale per una fenomenologia dell’immagine stessa. Mario Benedetto, in tal senso, ha realizzato l’equivalente moderno degli antichi cicli di Uomini Illustri: una galleria di ritratti di persone famose che, per meriti o per una particolare visibilità mediatica, hanno acquisito un particolare valore iconico. Per queste ragioni, il ritratto è in questo caso una sorta di commento visivo, più o meno esplicito, la ruolo che l’uomo politico, il leader carismatico o la diva del cinema ricoprono nel mondo delle immagini e in un più ampio contesto sociale. Sotto questo aspetto, la pratica dell’acceptpainting gioca un ruolo significativo: il testo può avere una funzione onomatopeica, rappresentare il proprio supporto dando un appiglio documentario (come nel caso del collage cubista e futurista) oppure, in questo caso in cui si devono integrare testo, immagine fotografica e BENEDETTO. UN’IDEA DI RITRATTO MILANO, SPAZIO CALABRIA, VIA BROLETTO 14 5-30 novembre 2014 41 immagine disegnata, fungere da commento più o meno esplicito al ritratto. Si rendeva necessaria, ovviamente, una gerarchia, chiaramente leggibile nell’economia dell’immagine, fra i vari interventi pittorici, fotografici e verbovisivi: il ruolo da protagonista è sempre dell’immagine dipinta, che affiora dal palinsesto come un’apparizione, o un’evocazione, a metafora della sovrapposizione di immagini come si presentano nel chiasso del moderno mondo urbanizzato (ben lontano dal ritmo lento della civiltà rurale) o negli insondabili meandri dei processi mnemonici. 42 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 L’INTERVISTA DEL MESE SETTECENTO MUSICALE ITALIANO Riflessioni del Maestro Alessandro Ratti su alcuni compositori poco noti del ‘700 di luigi sgroi aestro, sfogliando l’album dei grandi musicisti che la storiografia musicale ha accantonato o addirittura destinato all’oblio ci sono molti nomi sconosciuti ai più: Luchesi, Sarti, Porpora, Traetta, Anfossi…. da quale iniziare? Innanzitutto devo ammettere che mi risulta difficile poter iniziare da uno in particolare, perché si correrebbe il rischio di dare meno importanza agli altri. Quindi premetto che ognuno di questi compositori ha dato un notevolissimo contributo alla storia M ALESSANDRO RATTI ha studiato violino e pianoforte al Conservatorio di Parma e si è specializzato a Friburgo in violino barocco e a Stoccolma in direzione d’orchestra. Ha collaborato dapprima come assistente per alcuni direttori d’orchestra (De Marchi, Allemandi, Fritzsch, Abbado), rendendosi poi autonomo sia nel repertorio concertistico che in quello operistico in diversi paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Svezia e Finlandia). Ha vinto importanti borse di studio fra cui quelle della della Musica, con la sola sfortuna di esser vissuti in un’epoca che li ha visti offuscati dall’ombra di veri e proprio geni musicali quali Mozart, Haydn e Beethoven. In realtà proprio questi giganti, senza l’essenziale contributo dei compositori italiani, non avrebbero raggiunto così alte vette nell’arte. A questo proposito vorrei partire, seppur per una mera questione cronologica, da Nicolò Porpora. L’unico fra i compositori citati di cui non si conosce con esattezza la data di nascita. La figura di questo musicista mi ha sempre affascinato, in particolare per il fatto che iniziai a interessarmene quando, per uno studio storico artistico, una delle mie passioni parallele alla Musica, mi occupai di un dipinto di un artista napoletano nella cui tela si celava un manoscritto di Porpora. Mi accorsi che non esistevano molte notizie, ma soprattutto che poteva essere annoverato, sicuramente fino a qualche anno fa, fra quelli caduti in un certo senso nell’oblio. Di lui si sa che lavorò a Londra, per contrastare il potere di Händel e che fu il maestro di Farinelli, la più grande star di canto della sua epoca, un vero e proprio fenomeno musicale. Inoltre in uno suo soggiorno a Vienna, egli conobbe Fondazione R. Wagner di Bayreuth e della Accademia della Deutsche Bank di Francoforte-Akademie Musiktheater Heute. Ha inciso alcuni dischi dedicati al repertorio antico. Ha collaborato con lo storico dell’arte Francesco Barocelli sul tema della musica picta, con ricerche e relazioni di studi di carattere iconografico-musicale. Ha pubblicato un saggio sul rapporto fra la musica e l’arte nel Rinascimento attraverso uno studio sul Correggio dal titolo Correggio il pittore dell’armonia. novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 43 Haydn che gli chiese consigli sulla composizione. Ma la cosa per la quale Porpora fu unanimemente riconosciuto era la sua arte didattica per il canto. Oggi, a parte qualche piccolo tentativo, l’Italia dovrebbe puntare di più sulla sua rivalutazione di compositore, soprattutto cercando di mettere in evidenza le sue abilità tecniche di insegnante di canto, come dimostra il virtuosismo che seppe trarre dai suoi allievi divenuti ben presto i più richiesti al mondo. Già, il canto: arte eccelsa che da noi ha prodotto figure artistiche di grande rilievo, fino ai giorni nostri. Quali altre figure musicali meritano attenzione nel ‘700, sia rispetto al repertorio melodrammatico sia rispetto a quello strumentale? E di quali contributi importanti si può parlare? Questa domanda mi permette di parlare di due autori che maggiormente si sono distinti nei due campi di cui Lei mi chiede; il gioco del destino li ha voluti far nascere nello stesso anno a distanza di una settimana l’uno dall’altro. I due, con diverse provenienze geografiche, furono fra i più illustri esponenti della gloriosa scuola napoletana, ma mentre il primo si è dedicato più alla forma del melodramma, il secondo ha approfondito anche l’aspetto della musica strumentale. Parliamo rispettivamente del pugliese Tommaso Traetta (1727-1779) e del ligure Pasquale Anfossi. (1727-1797) Questi due personaggi, nonostante oggi risultino ai più ancora semisconosciuti, furono davvero geniali compositori se si considera il fatto che entrambi rappresentarono la fonte di ispirazione di celebri compositori come Gluck e Mozart. La ricerca musicologica più attuale sta, ad esempio, lentamente rivalutando da un punto di vista storico il lavoro di riforma dell’Opera che partì in origine da Tommaso Traetta. Egli aveva anticipato di qualche anno il lavoro modernizzatore di Gluck, un tedesco allievo per la musica strumentale di Giovan Battista Sammartini (1701-1775), il compositore milanese anch’esso non considerato appieno come vero padre della sinfonia, in quanto diede un contributo enorme a questa forma influenzando addirittura Haydn tanto che si pensa che nel catalogo di quest’ultimo siano finite erroneamente sue composizioni. Ora, sarebbe lungo parlare della riforma dell’Opera ad opera di Traetta che ebbe inizio al Teatro Ducale di Parma, chiamato dal Duca di quella città Filippo di Borbone, e quindi non mi soffermerei in questa sede. Quello che vorrei piuttosto rilevare è, come spesso accadde purtroppo in quel periodo, il fatto che molte primizie frutto del genio italico non furono considerate come tali a favore dei grandi e più potenti stati che vedevano nell’Italia una semplice accozzaglia di tesori dai quali attingere a piene mani, a volte misconoscendone appositamente l’origine per darsi maggior lustro. Del resto, era un’epoca storica che ci vedeva sottomessi alle potenze straniere. Destino simile lo ebbe Pasquale Anfossi. Dopo una lunga 44 carriera in Italia, Richiesto, ormai già famoso in patria dall’opera di Parigi e a Vienna - le due capitali che maggiormente si spartivano i “tesori” italici - il ligure si era distinto nel 1773 per alcuni lavori fra i quali il dramma giocoso La finta giardiniera, scritto l’anno successivo anche dal giovane Mozart. Quest’ultimo era un sincero estimatore del compositore italiano tanto da definirlo in una sua lettera come «molto cognito Napoletano» in quanto il compositore salisburghese era stato a Napoli appena quattordicenne, nel 1770 con il padre Leopold, dove probabilmente conobbe la musica di Anfossi. Come sostengono diversi musicologi, il salisburghese seguì gli schemi formali dell’opera dell’Anfossi riprendendone addirittura l’invenzione ritmica. Si pensa che Mozart adottò quella che si ritiene una tipica caratteristica dell’italiano, ovvero la divisione dell’aria in due parti, di tempo e ritmo diversi, attribuita ancor oggi a lui. Se nell’Opera seria la produzione di Anfossi è rivolta con decisione nel senso della riforma del suo amico Traetta e la sua originalità è improntata a una la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 musicalità di grande potenza drammatica, è la musica strumentale che egli cerca di curare di più rispetto ai suoi colleghi, componendo quasi una settantina di sinfonie. Nei suoi lavori si avvertono parametri musicali simili, se non addirittura identici, utilizzati successivamente da Mozart. Del resto, come non dimenticare il tema principale della sonata in Si bemolle Maggiore op. 24 n. 2 di Muzio Clementi (1752-1832)? Essa catturò talmente l’immaginazione di Mozart che dieci anni più tardi venne usata nella ouverture della sua opera Die Zauberflöte. Ciò amareggiò Clementi al punto che ogni volta che questa sonata veniva pubblicata egli si sincerava che venisse inclusa una nota che spiegava come questa musica era stata scritta anni prima del Flauto Magico. Non dobbiamo scandalizzarci troppo perché il plagio, in quei tempi, era pratica abbastanza diffusa. 46 Tuttavia il fatto di essere stati degli ispiratori o degli innovatori non è necessariamente attestazione di genialità. I capolavori di Mozart, Haydn sono immortali e mettono d’accordo sia la critica musicale che il gusto del grande pubblico. Che cosa resta degli autori italiani sopra citati di veramente valido, da proporre all’ascolto di chi vuole conoscerli? In linea generale se consideriamo il contributo ad esempio di Anfossi, a livello di genialità è stato sicuramente notevole in quanto proprio le sue idee hanno ispirato Mozart, e se è pur vero che la sua produzione non è composta esclusivamente di capolavori come nel caso del salisburghese il suo apporto non mi sembra di poco conto, come la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 del resto lo è stato per Vivaldi ispiratore di Bach o per altri nella storia della musica. Piuttosto, se osservassimo la questione più dall’alto, diciamo che c’è ancora molto da riscoprire anche fra le opere di alcuni compositori italiani. Non dimentichiamoci che l’opera dello stesso Mozart per un certo numero di decenni cadde nellfoblio dopo la sua morte. Se poi consideriamo il fatto che Mozart venne a studiare per un certo periodo in Italia e fu corretto da Padre Martini a Bologna per alcuni suoi errori nella prova di ammissione, una riflessione sul patrimonio musicale italico di quel periodo si può fare. Vede, in quell’epoca il nostro Paese rappresentava un faro artistico, musicale, letterario e architettonico per le altre nazioni, avendo accumulando un tesoro, anche solo dal lato puramente quantitativo, che non ha precedenti altrove. Dovremmo quindi guardare più attentamente a ciò che è stato prodotto negli anni d’oro e forse daremmo più rilievo a certi nostri autori oggi sottovalutati. Per rispondere alla seconda questione direi che per ognuno ci sono senza dubbio dei capolavori di cui suggerirne l’ascolto, pur molto difficile da attuarsi per la scarsità di incisioni o allestimenti. Per Traetta direi l’opera Ifigenia in Tauride o Ippolito e Aricia, per Porpora direi la Semiramide riconosciuta o l’Eumene, per Anfossi, fra quelle che mi vengono in mente, La finta giardiniera o le sue Sinfonie così come per Sammartini, le cui novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano innovazioni in questo ambito furono forse maggiori di quelle delle scuole di pensiero di Mannheim e Vienna. Approfitterei della sua competenza in materia di balletto… Anche in questo caso si può parlare di un’arte nata in Italia che ha fatto fortuna all’estero, in Francia e Russia in particolare. È proprio così. Domenico da Piacenza, Guglielmo l’Ebreo da Pesaro e Antonio Cornazzano, sempre di Piacenza, sono stati i primi con i loro trattati a codificare quella che già veniva chiamata “Arte del Ballo” presso le corti rinascimentali. È in questo periodo, infatti, che si sviluppò una forma ricercata di ballo che prevedeva norme da seguire e uno studio di passi e movimenti: la danza dei nobili, di diretta derivazione popolare, era ritenuta una vera e propria forma di educazione e veniva trasformata secondo le regole del perfetto cortigiano per ottenere un atteggiamento nobile e composto e adempire alle convenzioni sociali della cavalleria e della galanteria. La Francia dovette attendere più di centocinquant’anni prima di vedere redatto un primo trattato sul ballo, verso la fine del ‘500. Non è poi un caso che colui che diede origine al vero e proprio balletto in Francia, il danzatore, musico e attore fiorentino Giovanni Battista Lulli poi francesizzato in Lully a seguito della sua naturalizzazione, esercitò una considerevole influenza anche sullo 47 sviluppo della musica francese; molti musicisti fino al XVIII secolo, come Marc-Antoine Charpentier, Marin Marais, Jean-Philippe Rameau e lo stesso Gluck appena citato, solo per citarne alcuni, faranno infatti riferimento alla sua opera. E via fino all’Ottocento quando i primi balletti di Cajkovskij traggono ispirazione da quelle perle strumentali che l’operista Giuseppe Verdi aveva scritto poco prima. A tal proposito, mi vengono in mente le sue Quattro stagioni,i i balletti dell’opera Vespri siciliani scritti esclusivamente per adeguarsi al gusto dei teatri francesi dove erano d’obbligo. Come in precedenza, anche in questo caso, bisogna registrare l’assoluta invenzione e originalità che ha influenzato il prodotto di altre nazioni, 48 le quali hanno poi vantato ciò come loro personale conquista, senza tenere in considerazione la fonte dalla quale scaturiva. Se invece parlassimo di Andrea Luchesi e Giuseppe Sarti, compositori pressoché sconosciuti? Al primo si possono attribuire influenze relative alla musica sacra di Beethoven e al Requiem di Mozart… Andrea Luchesi (1741 -1801) è un compositore di origini venete che ha avuto il merito di riuscire nel repertorio la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 sinfonico quanto i tedeschi a lui coevi, tanto che i suoi lavori erano molto ricercati in Germania. Si pensa infatti sia stato la fonte ispiratrice del giovane Ludwig van Beethoven, dato che trentenne venne invitato a lavorare alla corte di Bonn succedendo poi al nonno di Beethoven come Maestro di Cappella. Ricoprì così tale carica per più di vent’anni, anni nei quali si formava il futuro genio tedesco che quasi sicuramente venne influenzato dall’italiano soprattutto per il repertorio sacro, nonostante non si abbiano, a tutt’oggi, riferimenti diretti negli scritti o in altri documenti. Il repertorio per ora esplorato risale però al periodo precedente il suo soggiorno estero, ovvero a quando risiedeva in Italia. Da notare che in questo periodo Luchesi si era già costruito una fama come strumentista di cembalo, tanto che la famiglia Mozart volle conoscerlo in uno dei loro viaggi nel nostro Paese e studiarne un concerto per eseguirlo in future accademie. Lo stesso Wolfgang ne era entusiasta e se ne può ipotizzare un influsso nel Requiem, anche se non ci sono prove inoppugnabili a riguardo. Giuseppe Sarti (1729-1802), invece, maestro del giovane Luigi Cherubini a Bologna dopo esser rientrato in Italia da soggiorni esteri che lo videro Maestro di Cappella alla corte Danese e insegnante a Londra, venne invitato a San Pietroburgo per dirigere la locale cappella musicale e passando da Vienna, vi conobbe Mozart. Questo compositore influenzò talmente il genio salisburghese che nella celebre scena della cena in Don Giovanni si può ascoltare l’aria “Come un agnello” tratta dalla sua opera Fra i due litiganti il terzo gode. Del lavoro in questione, il cui libretto aveva origine da le Nozze di Goldoni, Mozart fu particolarmente entusiasta. Pensi che il finale di quest’opera, abbastanza complesso perché basato su uno schema intricato nel quale si evolvevano gli eventi drammaturgici, venne utilizzato come modello per il finale del quarto atto delle Nozze di Figaro. In altre parole, possiamo dire che Mozart trasse materiale per due suoi capolavori immortali da un’unica opera del romagnolo Giuseppe Sarti. 50 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Il libro del mese La Comedia di Dante con figure dipinte La vicenda di un misterioso incunabolo veneziano GIANLUCA MONTINARO N ella Casa di Dante in Roma è custodito un esemplare di gran pregio della Commedia con il commento di Cristoforo Landino, stampato a Venezia il 18 novembre 1491 per i tipi di Pietro Piasi Cremonese, detto Veronese, “emendata” dal frate francescano Piero da Figino. Si tratta di una delle molte riedizioni del commento landiniano, il quale, a partire dalla princeps del 1481, impone la propria egemonia nella tradizione esegetica dantesca fino a tutto il Cinquecento, ben oltre la pubblicazione de Le terze rime (titolo preferito per il poema agli inizi del secolo) a cura di Pietro Bembo, nel 1502, con cui s’inizia la serie delle stampe di formato ridotto, con LA “COMEDIA” DI DANTE CON FIGURE DIPINTE iproduzione in facsimile dell’incunabolo veneziano del 1491, nell’esemplare della Casa di dante in Roma, con postille manoscritte e figure miniate. Quarta opera della serie “I commenti figurati” dell’Edizione nazionale dei commenti danteschi, Roma, Salerno editrice. Volume in facsimile di mm. R 325x225, 325 cc., rilegato a mano in piena pelle, con capitelli e tagli in colore, fregi e incisioni in oro e a secco sul dorso conformi all’originale; in custodia, con corredo di Commentario (a cura di Luca Marcozzi). Tiratura di 499 copie numerate da 1 a 499, oltre a 99 distinte con numerazione romana da I a XLIX. esiguo corredo interpretativo. Il valore dell’esemplare della Casa di Dante - distinto con la segnatura C 23 - è determinato dall’occorrenza ai margini del testo di numerose postille manoscritte, in volgare e in latino, e soprattutto da più di quattrocento pagine con miniature a colori, tra illustrazioni del poema dantesco e fregi vari, che lo rendono unico per la ricchezza e l’accattivante vivacità e freschezza delle raffigurazioni. Lo segnalava anche Marcella Roddewig nel suo ben noto e prezioso catalogo dei manoscritti della Commedia, nelle annotazioni alla scheda del codice registrato come «Casa di Dante, C H 1»: la studiosa lo riteneva uno degli incunaboli del poema più preziosi e più belli e definiva le miniature in esso contenute il più completo commento figurato alla Commedia esistente al mondo. Si ignorano le vicende di questo libro nel corso dei secoli fino al 1927, quando per la pri- novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano ma volta esso venne esposto all’attenzione degli esperti, dopo il suo acquisto da parte del Governo italiano. La destinazione definitiva presso la Biblioteca della Casa di Dante in Roma fu decisa da Pietro Fedele, ministro della Pubblica Istruzione dal 1925 al 1928; e dovette essere di poco successiva all’acquisto. Mentre, come detto, le notizie relative alla storia del manufatto risultano scarse e molto sommarie, varie e variamente articolate furono invece le opinioni espresse dagli studiosi nel vivace dibattito generato dalla scoperta dell’incunabolo, prin- cipalmente mirato a definire l’identità del suo postillatore e miniatore. Si possono distinguere due fasi negli orientamenti sulla questione: 1) nella prima, a partire dal 1927, la paternità delle postille e delle illustrazioni è unanimemente attribuita allo stesso curatore dell’ed. Piasi, il francescano Piero da Figino (revisore anche di edizioni successive) e le discussioni vertono, sostanzialmente, soprattutto sull’identità e il luogo d’origine del frate; 2) nella seconda, di oltre mezzo secolo posteriore, avviata dalle ricerche storiche e paleografico-lin- 51 guistiche di Giuseppe Frasso e storico-artistiche di Giordana Mariani Canova, concluse nel 1990, è invece ripresa con prospettiva nuova e dimostrata con solide argomentazioni la inattendibilità di tutta la linea argomentativa sviluppata nella disamina precedente, consentendo di orientare la ricerca verso risultati nuovi e insospettabili nel primo approccio al problema del nostro incunabolo. Problemi di paternità delle postille e delle miniature Come si è accennato, nella prima parte del Novecento si è a 52 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 lungo discusso sul tema della paternità delle postille manoscritte e delle miniature, attribuite entrambe a uno stesso autore, identificato quasi senza incertezze nel medesimo curatore dell’edizione veneziana, del quale inizialmente non si conosceva altro che il nome, cosí dichiarato nel colophon della stampa (carta 316 verso): Et Fine del comento di Christophoro Landino Fiorentino sopra la comedia di Danthe poeta excelle(n)tissimo. | E impresso in Vinegia per Petro Cremonese dito Veronese: Adi. xviii. di noue(m)brio. M.cccc.Lxxxxi. | emendato per maestro piero da fighino dell’ordine de frati minori. Ma l’esemplare miniato della Casa di Dante aggiunge subito dopo una postilla manoscritta, in scrittura minuta che si estende nel ridotto margine interno del foglio e nella stessa grafia delle chiose che costellano tutto il libro, in cui il postillatore scrive, a mo’ d’integrazione della dichiarazione del colophon: Che saria meglio non me ne havesse impazato [= ‘impacciato’], perché ho lassato molti errori come ignorante ch’io sono, dico io, frate Piero. Ma il Landino è ben huomo docto; et ha bene exposto; et è un bel dicitor in prosa nel stil materno. Sembra, in verità, che sia lo stesso «Piero da Fighino» che scrive, parlando di se stesso e del Landino commentatore. E così deve avere inteso un successivo possessore del volume, probabilmente settecentesco, che per dare fin dall’inizio un’informazione sul contenuto del libro - privo di frontespizio, come tutti i manoscritti antichi e generalmente gli incunaboli -, ha ritenuto di trascrivere quella nota con una più ampia indicazione in un cartiglio incollato poi sul verso del primo foglio del volume conservato: Dante Divina Commedia col comento di Cristofaro Landino Vinegia per Pietro Cremonese dito Veronese a dí 18 di Nove(m)brio 1491 emendato per un Maestro Piero da Fighino dell’ordine de’ Frati Minori. Già però nel 1929 un bibliografo e storico dell’arte anglo-francese, Seymour de Ricci, segnalò, in una cursoria lettera al direttore della rivista «La Bibliografia», come il Dante miniato del 1491 acquistato dal Governo italiano e affidato alla Casa di Dante in Roma fosse da collegare a un altro incunabolo miniato, questo petrarchesco (Le Rime e i Trionfi nella famosa edizione di Vindelino da Spira, Venezia 1470, editio princeps dell’opera), ugualmente arricchito di miniature e conservato nella Biblioteca Queriniana di Brescia, che presentava evidenti tratti di parentela con il volume romano, tali da rendere verosimile e molto probabile che i due manufatti fossero dovuti alla stessa mano o prodotti della medesima officina scrittoria. Questa segnalazione, per decenni dimenticata, è stata ripresa da Frasso nello studio Antonio Grifo postillatore dell’incunabolo queriniano G V 15. In quel documento, egli osserva: Lo studioso [de Ricci] non aveva [. . .] ritenuto utile ricordare [. . .] che il Dante romano, oltre a essere stato mirabilmente illustrato, era stato pure, così come il Petrarca bresciano, fittamente annotato. Comunque, l’importante osservazione di Seymour de Ricci, pur limitata all’aspetto propriamente decorativo dei due incunaboli, risulta ricca di suggerimenti – che trascendono l’ambito specifico al quale essa si applica – qualora venga coniugata con le [. . .] osservazioni del Moretti relative al Petrarca queriniano, cioè “essere il medesimo l’autore delle miniature e delle molteplici note dichiarative delle liriche petrarchesche”. novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano Focalizzata la probabile origine comune dei due cimeli, Frasso ha cercato conferme e documentazione attraverso un tentativo di ricostruzione della possibile fisionomia di chi aveva lavorato all’uno e all’altro incunabolo, partendo dai primi dati sicuri disponibili: la lingua delle postille (di chiara origine settentrionale) e la loro organizzazione. Successivamente ha studiato l’evanescente figura di Antonio Grifo. Si tratta di un poeta cortigiano e umanista vissuto probabilmente fra il 1430 e il 1510, di cui poteva anche delineare un profilo essenziale, al quale ricerche successive hanno consentito di portare ulteriori elementi, pur nella penalizzante carenza di documentazione storica. Fu probabilmente originario di Venezia, in cui è largamente attestato un casato Grifo nel XIV secolo. Quasi certamente visse a Padova, per studio, fra il 1456 e il 1466; autore fra l’altro di un ampio canzoniere lirico oggi conservato in un codice autografo nella Biblioteca Marciana, a sua volta ampiamente miniato con modalità molto simili a quelle dell’incunabolo romano e del Petrarca queriniano. Dopo il 1477, forse alla fine degli anni Ottanta, fu esiliato dalla Re- 53 pubblica: tutto il suo canzoniere è pervaso da riferimenti nostalgici a Venezia, che assume le sembianze di un “biforme animal”, lo stesso epiteto con il quale il poeta indica se stesso. Quanto al motivo del bando, esso va forse ricercato nella frequentazione della famiglia Sanseverino, di tendenze filomilanesi, iniziata probabilmente negli anni Ottanta, quando Roberto Sanseverino era capitano della Serenissima. Morto costui nel 1487 (l’evento è ricordato nel canzoniere con un capitolo in morte), seguì uno dei suoi figli allorché, dopo essersi riconciliati con Ludovico il Moro, 54 costoro abbandonarono Venezia nel 1489. Nel gennaio del 1491 ritroviamo il Grifo a Milano, al seguito di Galeazzo Sanseverino, se è lui il «Mess. Antonio Gri venetiano chonpagno d’Antonio Maria» per cui Leonardo da Vinci disegna un costume nell’occasione della parata organizzata da Galeazzo per il matrimonio tra Ludovico il Moro e Beatrice d’Este (Londra, British Library, Arundel, 263, c. 250r [. . .]): l’Antonio Maria citato può essere identificato con uno dei figli di Roberto Sanseverino; e a un altro dei figli di quest’ultimo, Gaspare detto Fracasso, che fu capitano al servizio di Ludovico il Moro tra il 1493 e il 1500, sono dedicati dal Grifo alcuni componimenti. A Milano Grifo trascorse l’ultimo decennio del secolo: Vincenzo Calmeta ricorda come alla corte di Ludovico il Moro fosse stata tenuta una lettura di Dante da parte di «uno Antonio Grifo, uomo in quella facultà prestantissimo » [. . .], che Ludovico ascoltava con grande piacere. Calmeta si trattenne a Milano tra il 1494 e il 1496: in questo periodo va collocato il culmine dell’attività di poeta cortigiano del Grifo, che testimonia della morte di Gian Galeazzo Sforza (1494) e dell’ascesa al trono di Ludovico (1495), di cui canta le lodi insieme con quelle di Beatrice d’Este. Non è la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 dato sapere per quanto tempo si trattenne a Milano dopo il 1496: i componimenti del suo canzoniere seguono le vicende del Moro e di Beatrice d’Este fino alla morte di lei, nel 1497, e all’invasione francese. Gli indizi ricavabili dal suo canzoniere per ricostruirne la biografia si fanno da qui in avanti scarsi, ma i riferimenti a vicende del primo Cinquecento lasciano intuire che egli visse fino al 1510 circa, passando gli ultimi anni in condizioni precarie. Non esistono documenti sulla sua morte, ma dalle ultime miniature del canzoniere marciano si può avanzare, tra altre possibili, l’ipotesi che il Grifo abbia finito i suoi giorni nel Veneto, verosimilmente nel feudo di Cittadella, residenza dei Sanseverino. Il Dante venne probabilmente pensato e realizzato dal Grifo nel contesto delle sue frequentazioni della corte sforze- sca di Milano, nel clima di quelle letture dantesche che, si è visto, secondo la testimonianza del Calmeta affascinavano Ludovico il Moro. La decorazione e la postillatura - in rapporto dinamico tra loro - vennero eseguite probabilmente a partire da poco dopo la stampa, nel 1491, per un omaggio a Galeazzo Sanseverino, figlio di Roberto, capitano generale dell’esercito sforzesco e sposo nel 1496 di Bianca, figlia naturale di Ludovico il Moro, come si ricava dal ricordato omaggio a lui riservato, all’inizio del canto XV del Paradiso, dove ne viene data la già vista monumentale raffigurazione fregiata della scritta: «Divo Fraccasso di Marte figlio» (c. 271v). Fracasso era il soprannome di Galeazzo Sanseverino, suggerito forse dalla prestanza fisica e dall’esuberanza nell’azione, per cui era anche detto l’Achille dei suoi tempi, giudicato a Venezia «il secondo huomo de Italia». Ma non si sa se il libro sia stato effettivamente consegnato e con quali vicende successive. Gli eventi che sconvolsero Milano e la famiglia Sforza alla fine del secolo indurrebbero ad escludere, per le ragioni sopra esposte, che la fase elaborativa possa essere andata oltre il 1498-’99. Del libro si perde ogni traccia nel corso dei secoli, prima di ricomparire agli inizi del ’900. novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 55 Guerra e Letteratura Agli inizi del Novecento: fra militanza e intervento Vicende belliche e letteratura nel XX secolo MARCO CIMMINO D opo il silenzio, che avvolse la poesia bellica per molti anni, nonostante l’infuriare in Europa e nel mondo di molte guerre, alcune delle quali lunghe e terribili, all’alba del XX secolo cominciò ad affacciarsi alla ribalta letteraria una nuova generazione di artisti, che rappresentarono il trait d’union ideale tra il ribellismo ottocentesco e romantico, di cui abbiamo già detto e che si produsse, in fondo, poco più che un’epica titanico-individuale, e la letteratura che, genericamente, si definisce “interventista”, ma che, in realtà, si dovrebbe definire “bellicista” o “polemista”, giacché postula un approccio dell’uomo alla propria esistenza e a quella altrui molto simile a quello che ha il soldato in guerra. Questi nuovi intellettuali furono i primi ad immaginare una società in cui tutti operino con valoroso impegno, dando la preminenza all’azione e al bene della comuni- tà, piuttosto che alla riflessione e al benessere individuale. Li abbiamo chiamati “militanti”, poiché ci è parso che essi riprendessero, nelle proprie idee, un concetto antichissimo di militanza, che, evolvendosi nei secoli, ha portato ad un’immagine di popolo permanentemente mobilitato, con ogni propria energia, per il raggiungimento di un benessere collettivo. Una storia, dunque, che ci pare provenga da molto lontano, e che trovò nella Grande Guerra e nell’interventismo il suo sbocco inevitabile. La storia ha voluto che, tra i due modelli politici più significativi del mondo greco, alla fine venisse esportato e tramandato quello ateniese, mentre quello spartano fu, viceversa, consegnato alla storia museale e, sostanzialmente, frainteso, prima di venire imbalsamato. Vero è che, come abbiamo visto in precedenza, la letteratura ateniese godette di una fioritura eccezionale, mentre a Sparta nessuno ebbe l’idea di trasmettere ai posteri virtù e gesta della propria città: come ebbe a dire lo storico latino Sallustio, i Romani non erano meno valorosi dei Greci in battaglia, ma non avevano nessuno che ne tramandasse il valore.1 L’importanza della propaganda appariva evidente anche ad un romano del primo secolo avanti Cristo. A questa cancellazione dalla memoria, inoltre, contribuì in modo importante un equivoco di fondo sul grado di partecipazione popolare alla gestione del potere. Sia ad Atene che a Sparta, in realtà, i pieni doveri ed i pieni diritti riguardarono percentuali estremamente esigue della popolazione, ma Sparta fu catalogata come un’oligarchia (tecnicamente, in realtà, si trattava di una diarchia), mentre Atene divenne il modello della democrazia e dell’isonomia, e, in tal modo, fu la madre di tutte le civiltà politiche a venire. Eppure, l’etica civile spartana van- 56 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Benedetto Croce all’interno della Libreria Internazionale Aldo Lubrano di Napoli tava origini più antiche e più nobili di quella della capitale attica: essa si fondava sul concetto antichissimo di cittadino-soldato, legato strettamente alla terra, almeno quanto gli ateniesi dipendevano dal mare. Oggi, diremmo di mobilitazione permanente. Già all’alba della coscienza occidentale, nei poemi omerici, possiamo riconoscere i segni di questo atteggiamento mentale. La società omerica era un esempio primitivo di mobilitazione permanente, in cui, se la città era in pace, il cittadino si dedicava alle proprie attività normali, ma che, in caso di guerra, vedeva ognuno scendere in campo, secondo le proprie possibilità ed il proprio rango. Il fatto che si trattasse di una civil- tà assai semplice e dalle relazioni sociali ed internazionali poco sviluppate limitò, di fatto, agli episodi bellici questa mobilitazione: quando, tuttavia, si svilupparono società più complesse, il cittadino, come vedremo, fu chiamato ad impegni assai più assidui. Abbiamo detto della società spartana: a Sparta, dall’adolescenza alla vecchiaia, lo spartiate (cioè il cittadino a tutti gli effetti) era tenuto a mantenere il proprio corpo in esercizio e le proprie armi in efficienza, per essere sempre pronto nell’eventualità di una guerra. Possiamo dire che la vita di un cittadino spartano del V secolo fosse, in pratica, un unico allenamento alla guerra e che la guerra fosse il fine ultimo dell’esistenza di uno spartano. Questo perché la grandezza di Sparta si fondava sulla guerra e non su altro. Il mondo romano introdusse, di fatto, un concetto più raffinato e sfaccettato di mobilitazione permanente. Il civis romanus aveva, in sostanza, due doveri, che lo accompagnavano per tutta la vita: quello militare e quello politico. Anche Roma fondò il suo prestigio sulla propria invincibilità militare, ma i Romani esportarono, sulla punta delle loro lance, anche la superiorità delle proprie leggi e del proprio senso dello Stato. Così, l’uomo romano, il vir, crebbe con due imperativi categorici: essere un disciplinato novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano combattente ed essere un disciplinato cittadino. Non a caso, la Roma repubblicana fu presa ad esempio dall’iconografia di tutti i regimi giuridico-militari della storia: il dovere, l’inflessibilità, il rigore, la disciplina, da allora hanno sempre avuto il volto severo dell’Urbe senatoria. Soltanto molti secoli dopo, sul finire del XIX secolo, questa idea di guerra come stile di vita si avviò ad inglobare il terzo ed ultimo suo elemento costitutivo: il lavoro. Fino ad allora, avevamo assistito all’affermazione di modelli di società incomplete, dal punto di vista partecipativo: quella feudale conosceva solo obblighi di carattere privatistico e privilegi, quella comunale si resse su governi di consorterie, di Gesellschaften, il mondo giacobino e liberale fu dominato dalle borghesie professionali. In nessun caso, protagonista dell’azione nazionale fu il popolo, inteso come totalità della Nazione, ma solo categorie determinate e sempre in funzione proprio delle loro caratteristiche sociali. In taluni periodi e in determinate circostanze, assistemmo anche a vere e proprie mobilitazioni totali, in cui tutti i membri delle comunità concorsero, ognuno a vario titolo, al raggiungimento di obiettivi ben precisi: l’edificazione delle cattedrali, le crociate, lo scavo dei navigli, ad esempio. Quello che mancò a questi picchi partecipa- 57 Giuseppe Prezzolini in un ritratto d’epoca tivi fu, naturalmente, la durata, dato il loro carattere di eccezionalità. L’unica variante introdotta dal marxismo a questa societas tripertita, vista nelle sue manifestazioni cronologiche, fu quella di considerare l’Europa (il mondo) come un’unica realtà sovranazionale, in cui, al posto delle Nazioni e dei popoli, i confini fossero tracciati, vertical- mente, dalle stratificazioni della piramide sociale. Naturalmente, questa divisione per classi dell’umanità non aggiunse una virgola al sistema preesistente, limitandosi a modificarne la classificazione. Al declinare del secolo dell’industrializzazione, invece, si cominciò a capire che esisteva un’altra strada verso il benessere comune e verso la ge- 58 stione del potere politico, che di tale benessere comune dovrebbe essere lo strumento. L’antica idea della mobilitazione permanente tornò a galla: non a scopi esclusivamente militari, o difensivi, ma per combattere una battaglia quotidiana, nell’eterna guerra della vita. Nasceva l’idea di mobilitazione totale permanente, in cui ogni singolo membro di un popolo avrebbe dovuto avere responsabilità e doveri, proprio come un soldato che, in battaglia, difenda la propria terra. Vi fu, nell’enunciazione di questi concetti, una forte carica retorica, molta utopia, una spiccata tendenza a confondere elementi socialrivoluzionari ed elementi mistico-tradizionali e, non ultima, una buona dose di narcisismo ideologico; tuttavia, possiamo dire con buona approssimazione che, a cavallo tra il 1880 ed il 1914, in quel crogiuolo che fu l’Europa di allora, elementi antichissimi dell’etica politica e del patriottismo, come l’idea della mobilitazione permamente, ed elementi assolutamente moderni, come l’idea della partecipazione totale della Nazione al tracciato dei propri destini, furono fusi in un’ unica lega. Era nato un metallo nuovo, che avrebbe dato i suoi frutti. IL PRAGMATISMO E L’IDEALISMO MILITANTE Roba da filosofi, verrebbe da dire: il pragmatismo, in soldo- la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 A sinistra: Tommaso Marinetti. Nella pagina accanto da sinistra: Friedrich Nietzsche; Giovanni Papini in un ritratto familiare con la nipote; Georges Sorel ni, fu un movimento filosofico che si proponeva di cambiare la società con la filosofia. E non si creda essere stato il ghiribizzo di qualche studentello esaltato: il suo più serio ed autorevole esponente, Giovanni Vailati, fu un filosofo di quelli veri, da mettersi alla pari con quelli che allora andavano per la maggiore, come Bergson e lo stesso Croce. Eppure, quest’idea di un intellettuale che interveniva direttamente nei processi storico-sociali, avrebbe dato esiti estremamente vari ed interessanti. Ammiratore di Vailati (e con lui di Sorel e di Bergson) fu il primo degli scrittori di cui ci occuperemo in questo paragrafo, dedicato agli intellettuali militanti, ai padri della letteratura italiana di guerra: Giovanni Papini. Di Papini si è detto tutto e il contrario di tutto: nessuno ne ha mai negato i meriti, ma, in fondo, non è mai stato letto seriamente. Egli è sempre stato catalogato come un pensatore ibrido, a metà tra la scienza vera ed il proprio destino privato, di toscano inquieto ed autodidatta. La prima cosa che intendiamo qui sottolineare di questa figura di scrittore-agitatore culturale è che, se non primo, tra i primi, si rese conto della direzione che aveva preso il vento del secolo nuovo: che le gherminelle positiviste, in cui anche lui era incappato da adolescente, non bastavano più a spiegare il mondo. C’era bisogno di altre strade, magari esoteriche, certamente scandalose e, soprattutto, in cui l’intellettuale diventasse la voce del destino comune, impegnandosi politicamente e culturalmente. Nel 1903, all’interno del quasi fatiscente palazzo Davanzati, a Firenze, il giovanissimo Papini inaugurò la prima delle riviste che l’avrebbero reso celebre e che ne avrebbero fatto un punto di riferimento culturale: il Leonardo. Era poco più che una fanzine, ma attirò l’attenzione del mondo culturale più emancipato e, probabilmente, fu la matrice da cui provenne la straordinaria messe di riviste che felicitò gli anni burrascosi che precedettero la Grande Guerra. Papini vi propugnava un suo pragmatismo novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano particolare, in cui al centro della questione esistenziale stava il rapporto tra l’individuo ed il mondo: come cambiare il proprio rapporto individuale con la società e le cose divenne il perno di questo personalismo, che, naturalmente, si contrapponeva inevitabilmente al collettivismo marxista. A ciò si aggiunga il fatto che, basandosi questo rapporto sulla volontà del singolo (in cui riconosciamo echi ben noti del pensiero di quegli anni, da Nietzsche allo stesso Sorel), esso sottendeva molti degli elementi che altri distillarono nel crogiuolo della guerra, facendone dottrina. Evidente, nell’impianto ideologico di Papini, era anche il peso dell’opera di D’Annunzio, come sempre imprescindibile, quando si debba parlare di primissimo Novecento. Papini scrisse sul Leonardo con lo pseudonimo di Gian Falco e il suo inevitabile sodale Giuseppe Prezzolini, di cui diremo più innanzi, con quello di Giuliano il Sofista. I due mescolavano pensieri profondi e voluttà romantiche (la battaglia pragmatista era ancora di là da venire), tanto che Croce giudicò Papini un idealista tout court, ma avevano ben chiara l’idea di una letteratura militante e di una figura di intellettuale il cui motivo d’essere era l’intervento nella vita e nella società: va da sé che, non molto tempo dopo, questa filosofia interventista avrebbe trovato ragioni assai concrete. Esaurita l’esperienza del Leonardo, nel 1907, di ritor- 59 no dal suo primo, fondamentale, viaggio a Parigi, Papini collaborò a La Voce, diretta da Prezzolini, che cominciò le sue pubblicazioni nel 1908, per arrivare, a fasi alterne, compresa una direzione di Papini, fino al 1913. Esplicitamente, dal gennaio del 1914, la pubblicazione, divenuta rivista quindicinale, da foglio settimanale che era, si autodefinì “…di idealismo militante”. Tra la fine del 1914 e il maggio del 1915, possiamo dire che alcuni nodi vennero al pettine: la rivista prezzoliniana si sdoppiò: La Voce gialla, diretta sempre da Prezzolini, divenne una pubblicazione prettamente politica, mentre La Voce bianca, diretta da De Robertis, ebbe un taglio eminentemente letterario. È un po’ come se le pagine della cultura di un quotidiano diventassero un altro quotidiano a loro volta. La ragione di questa svolta è chiara: propagandando una letteratura 60 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Da sinistra: copertina del primo numero (1º gennaio 1913) di Lacerba; un ritratto fotografico di Ardengo Soffici e Giovanni Papini nel 1909 militante, una rivista doveva, ad un certo punto, militare. Chi non si fosse sentito abbastanza deciso avrebbe dovuto e potuto andarsene: e De Robertis se ne andò. L’alta cultura e la cultura della mobilitazione permanente cominciavano a dividersi piuttosto nettamente. Era nell’aria una svolta radicale nei rapporti tra il pensiero e l’azione: questa svolta sarebbe stata rappresentata dal Futurismo. Papini fu un protofuturista, più che un prefuturista e, in seguito, un futurista ed un futurista pentito: egli, con la sua inquietudine e la sua rabbia intellettuale era inevitabilmente sfasato rispetto alle epoche letterarie, che, in quel periodo, erano fulminee. Quando pubblicò Il crepuscolo dei filosofi (1906), Papini aveva già del tutto rifiutato l’immagine del- l’intellettuale che interveniva astrattamente, con la propria riflessione, nel dibattito politico e sociale: era già per l’Avanguardia; e la prima delle avanguardie fu proprio il movimento di F. T. Marinetti. Dato che il Futurismo è uno dei grandissimi dimenticati e vilipesi nelle nostre antologie, che gli dedicano qualche paginetta di calligrammi, quasi che fosse l’angolo delle curiosità, da sempre è stato sottovalutato l’impatto che ebbe sui pensieri ed i comportamenti degli Italiani del primo anteguerra: esso fu, invece, determinante, pur con molte contraddizioni, nello spostare l’ago della bilancia verso la guerra. Qui basti sapere che Papini, tre anni prima del Manifesto futurista apparso sul «Figaro» (1909), aveva già assunto un atteggia- mento “futurista” nei confronti del mondo della cultura: egli cercava veicoli culturali rapidi ed efficaci, ed indicò lo scandalo come il principale tra questi. Proprio lo scandalo, il gesto plateale, lo schiaffo al pensiero borghese e all’intelligentsija ammuffita, sarebbero stati le armi del primo Futurismo: la provocazione, nei contenuti, nello stile, nell’azione. La parabola di Papini, del Papini futurista, parte di qui e si conclude, nel 1919, con la pubblicazione di L’esperienza futurista. In mezzo, però, vi sono anni cruciali: gli anni della Grande Guerra, in cui l’idea di mobilitazione totale permanente si sarebbe incarnata in una figura ben precisa: quella del volontario interventista. Papini non partecipò al primo conflitto mondiale, a causa della sua progressiva miopia, ma molti suoi amici e compagni si arruolarono con entusiasmo, e molti caddero da valorosi, per compiere il Risorgimento, ma anche per gettare le basi di un uomo nuovo: quell’uomo ipotizzato nelle pagine delle riviste d’anteguerra. Sia in quelle pragmatiste o personaliste, che in quelle di chiara matrice interventista, come Hermes, o nazionalista, come il Regno, che in quelle futuriste, come Lacerba, sulle cui pagine si propagandava di continuo l’idea di arte militante ed attiva. 62 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 L’Altro Scaffale In alto nel Cielo, e in basso sulla Terra Piccole ma preziose proposte di collezionismo ALBERTO CESARE AMBESI D ans le ciel e sur la terre è il titolo di un affascinante volume del 1886 scritto dall’astronomo Camille Flammarion (1842-1925) e per la prima volta tradotto in italiano nel 1929. Perché si è voluto ricordare quest’opera, più che invecchiata, sotto molteplici profili? Ma per una ragione semplicissima: perché conserva il pregio, non trascurabile, di abbracciare con un unitario sguardo “leopardiano” diversi paesaggi e armonie, come recita il sottotitolo. Certo, oggi ci si è abituati a tutt’altro linguaggio, sia in ambito specialistico sia nell’alveo divulgativo, ma resta il fatto, indubitabile, che, dopo la scomparsa di Isaac Asimov (1920-1991) non è più apparso sulla scena uno scienziato capace di esprimersi con doti narrative tanto spiccate quanto quelle del celebrato autore de La Fondazione, una “quadrilogia” che ancora attende una convinta e convincente interpretazione filosofica e meta-storiografica. Tant’è. Nell’attesa che un nuovo Asimov o che un moderno Flammarion - più modestamente - possano distogliere taluni strati del pubblico dalle ricorrenti volgarità televisive e da certe banalità cartacee, non resta che esplorare quanto l’antiquariato librario può offrire, malgrado che la ricerca risulti qualche volta - malagevole. La fiorentina Libreria Dante di Oreste Gozzini, per esempio, propone spesso autentiche pre- ziosità, ma mediante cataloghi che ignorano sistematicamente la ripartizione per argomenti, a favore dell’elenco alfabetico degli autori. Una piccola astuzia per indurre il potenziale acquirente a soffermarsi su ogni titolo? Forse. Ma quello che è certo è il fatto che risulta faticante la lettura di un fitto catalogo di 711 opere, volendo trovare una specifica disciplina. Certo, a volte con esiti fortunati, poiché, come si è già tacitamente osservato, la Libreria Dante si muove con autorevolezza in ogni settore dell’antiquariato librario. Ne ha offerto prova e controprova quando, con il più recente fascicolo, ha presentato un eccezionale Erbario del XIX secolo raggruppato in un volume in 4° legato in piena pelle nera, con piatti inquadrati da filetti a secco in oro e con il titolo, Flora, parimenti dorato. Opera per molti versi rara e delicata (ha come sigillo sul piatto anteriore un fermaglio di chiusura metallico), Flora è arti- novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 63 Nella pagina accanto: Ritratto di Camille Flammarion (1842-1925), conservato a Parigi, presso l’Osservatorio astronomico. Sopra: Camille Flammarion, L’atmosphere, meteorologie populaire, Parigi, 1888 (stampa presente a p. 163) colata su 173 carte, delle quali 86 numerate e 6 non numerate. Il suo contenuto è racchiuso nei seguenti dati: risultano applicati oltre 350 esempi di foglie e fiori veri di centinaia di specie di piante. La maggior parte degli esemplari sono classificati con un numero e con un nome (a volta latino, a volta italiano) ma- noscritti con chiara grafia sulle piccole etichette dell’ epoca usate per il fissaggio dei vari reperti. Il prezzo dell’erbario, in perfette condizioni, è di 650 euro. Ma restiamo ancora, per un momento, nel regno della botanica e non per capriccio o per pi- grizia, bensì, perché il testo che si sta per segnalare s’inserisce nella cornice delle preziose prime edizioni della fine Ottocento ed entro un contemporaneo scenario storico-enciclopedico con svariate sfaccettature. Fra breve, difatti, avremo davanti tre opere, tutte in più volumi, a ognuna delle quali sarà doveroso dedica- 64 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 A sinistra: un’ immagine tratta da La vita delle piante, di Anton von Marilaun Kerner. Nella pagina accanto, da sinistra: Johannes Ranke (1836-1916), in una foto del 1892; Friedrich Ratzel (1844-1904), in una vignetta di fine Ottocento; Justus Sustermans (1597-1681), Galileo Galilei, 1636 re una particolare attenzione, e sulla base di due eccellenti ragioni: 1) in quanto, pur avendo ciascuno dei saggi uno specifico senso compiuto, è altrettanto vero che si tratta di sette testi che facevano parte di una più ampia impresa editoriale di nove volumi complessivi presentata con il titolo di Storia Naturale; 2) perché i sette tomi di cui diremo potranno sollecitarci a ripensare con adeguato spirito critico i rapporti che legano le piante all’Uomo e l’Uomo all’ambiente, prima che ci si possa idealmente sollevare al cielo. Segnaliamo dunque, per prima, l’opera dell’austriaco Anton von Marilaun Kerner (1831-1896), La vita delle piante articolata in due volumi e racchiudente i seguenti argomenti: “Forma e vita delle piante”, nel primo volume (pp. XI, 1, 716) e, nel secondo, “Storia delle piante”, più un catalogo ragionato delle principali piante utili (pp.4, 947). Ulteriore pregio della coppia di tomi è l’apparato illustrativo, così articolato: 487 illustrazioni in b.n. nel testo; 25 (su 31) belle tavole in cromolitografia (6 con adesione reversibile della velina di protezione) e 40 tavole in b.n. Unico, difetto: il secondo volume risulta privo del frontespizio e delle pagine, in numeri romani, contenenti l’indice delle materie e delle illustrazioni. Una marginale incompiutezza che giustifica il prezzo richiesto di duecentotrenta euro. E si è al dunque. Cioè a di- novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano re: davanti ad opere che contribuiranno in modo determinante alla nascita dell’antropologia novecentesca: L’Uomo, lavoro in due volumi di Johannes Ranke (1836-1916) e le Razze umane, in tre volumi, di Friedrich Ratzel (1844-1904). Con trasparenti divergenze, è doveroso aggiungere, in specie nei confronti dell’ipotesi evoluzionista, accolta con cautela da Ranke e in gran parte condivisa da Ratzel. Difformità che già si riflettono nell’ordinamento dei rispettivi lavori, a prescindere dal piano generale dell’opera. Nel primo volume de L’Uomo, risulta affrontato, difatti, il tema dello “Sviluppo, forma e vita del corpo umano” e, nel secondo, ci si sofferma sulla ripartizione (forse frettolosa e un po’ grossolana) delle Razze umane in “moderne e primitive”. Nulla più e nulla 65 tico e del mondo nuovo”. Se ne convenga, pertanto: codesta classificazione che, tutto sommato, subordina l’etnografia alla geografia appare tanto interessante, quanto squilibrata. meno. Il più ampio lavoro di Ratzel, per converso, dedica l’intero primo volume a “I popoli naturali dell’Africa”; nel secondo affolla tutti “I popoli naturali dell’Oceania, dell’America e dell’Asia” e nel terzo analizza “I popoli civili del mondo an- Giovano comunque ad ambedue i testi l’accurato apparato iconografico, non mai esornativo. Anzi chiarificatore, soprattutto nei confronti della complessa scrittura di Ratzel. L’opera è in 4° ha una rilegatura coeva in piena tela, titolo e filettature oro al dorso. I suoi due volumi contano, rispettivamente, pp.650,(2) e XI, (1),664, Ha complessivamente 603 illustrazioni in b.n. nel testo e 33 (su 38) fra tavole in cromolitografia e carte su tavole doppie a colori. Al primo volume si registrano le mancanze 66 Da sinistra: Anton von Marilaun Kerner, La vita delle piante, immagine presente a p. 369; un ritratto di Isaac Asimov (1920-1992) delle pagine introduttive,contrassegnate dai numeri romani (indici delle materie e delle illustrazioni). Costo dell’opera novanta euro. Eguale il formato e analoghi i connotati tipografici del lavoro di Ratzel, peraltro integro in ogni parte, se si escludono le minime tracce d’uso alle coperte e due forellini marginali al bordi dell’occhietto del secondo volume. Più corposo, ovviamente, il numero delle pagine e delle illustrazioni, di volume in volume. Articolazione del testo: pp. XII, 815, (1) - XI (1), 907,(1) - VIII, 830. (2); elenco delle illustrazioni: 989 in b.n. nel testo, 43 tav., sempre in b.n. e 6 carte geografiche a colori. Prezzo richiesto: centosettanta- la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 cinque euro. Tutti i sette volumi della Storia Naturale qui segnalati vennero pubblicati, negli anni indicati, dalla Unione Tipografico-Editrice di Torino e le traduzioni curate da qualificati cattedratici. Arretriamo ora poco dopo la metà del Settecento. Riandando al 1766, troveremo difatti, docente all’università di Altamura, un sacerdote, d’insolita duttilità intellettiva, per quel tempo: il letterato e matemati- INDIRIZZI E RECAPITI LIBRERIA DANTE DITTA ORESTE GOZZINI Via Ricasoli 49-103r 50122 Firenze Tel.: 055/212433 co, Giuseppe Carlucci (?-1790), autore, fra l’altro, in quell’anno, previa adozione di un prudente anonimato, di un Ragionamento filosofico intorno al moto della Terra, nel cui contesto si condannavano le ingerenze della Chiesa entro la sfera scientifica e si rivendicava la libertà di poter divulgare ovunque il sapere che discendeva dalle esperienze e dagli studi di Galileo e Newton. Discorso, codesto, sorprendentemente “illuministico” sviluppato lungo 96 pagine, in 8°, e siglato, alla fine, da una tavola incisa in rame. Annotazione importante: l’esemplare posto in vendita dalla Libreria Oreste Gozzini a 450 euro si presenta con una moderna cartonatura “radicata” che ne garantisce la conservazione per il futuro e corrisponde alla prima edizione dell’opera stampata a cura di Vincenzo Flauto. novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 67 Filosofia delle parole e delle cose La forza dell’idea: il pensiero in immagine L’allegoria di Eliot: «chiare immagini visive» DANIELE GIGLI L’ inferno, lo conosciamo tutti prima o poi. Il nostro personale, almeno. Che conosciamo, che riconosciamo anche perché fin da ragazzini maestri e professori ci schiantano davanti il paradigma di ogni inferno, l’Inferno con la maiuscola, la buca sordida costruita da Dante «in pro del mondo che mal vive». Ma perché questo inferno, perché questa somma di parole e ritmo, di versi e immagini, di storie e similitudini, sa così bene descrivere tutti i nostri inferni, gli inferni di chiunque vi si ponga innanzi con mente aperta e Da sinistra: Giovanni Stradano (1523-1605), Visione dell’Inferno dantesco, litografia a colori (1570 circa), Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana; Gustave Dore (1832-1883), Inferno canto X 68 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 Sopra: Gustave Dore (1832-1883), Inferno canto XIII. A destra: Sandro Botticelli (1445-1510), Mappa dell’Inferno, Roma, Biblioteca Vaticana cuore libero? L’allegoria, ci dicono da sempre dotti medici e sapienti; quell’allegoria così meccanica, così noiosa, così prevedibile, da non poter presto sembrare a chiunque abbia un cuore vivo uno «sterile gioco enigmistico»: così dice T.S. Eliot, nel secondo dei suoi saggi su Dante,1 così dice la pelle di ogni sano appassionato dell’arte della parola. C’è però forse un equivoco, dietro questo ingeneroso giudizio che istintivamente diamo all’allegoria, ed è un equivoco cui non sono estranei dotti medici e sapienti. Quegli inse- gnanti, cioè, che nella stragrande maggioranza dei casi a malapena riescono a leggere tre endecasillabi di fila prima di correre a porsi, ammorbando gli studenti, la domanda fatale: «Che cosa voleva dire il poeta?» Eh, già, che cosa? Probabilmente ciò che ha detto. Sennò avrebbe detto altro, o scritto un saggio, o un articolo di giornale. Ma noi, no. Noi proprio non lo accettiamo e anteponiamo la pur utile parafrasi allo schianto con le parole così come si danno. Perdendo in tal modo, è ancora Eliot a insegnarcelo, la parte mi- gliore. «A una prima lettura del canto I dell’Inferno non consiglierei di preoccuparsi dell’identità della Lonza, del Leone o della Lupa. È preferibile ignorare, non interessarsi di ciò che queste figure significano. Dovremmo piuttosto considerare non tanto il significato delle immagini, ma il processo inverso, ossia quello che permette a chi possiede un’idea di esprimerla in immagini». Questa è infatti, «per un poeta capace», l’allegoria: «chiare immagini visive». Questo utilizzo delle immagini è, secondo Eliot, il modo novembre 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano rappresentativo della visione. Un modo che oggi razionalmente rifuggiamo, ma che «era un tempo un modo più espressivo, più interessante e più ordinato di sognare». Quale sia lo scopo, è presto detto: condividere con il lettore qualcosa che resterebbe altrimenti inesprimibile. «Il tentativo di Dante consiste nel far vedere a noi ciò che egli ha visto». Ancora una volta, siamo nel campo del paragone, del «come». Non per nulla, insiste Eliot, il metodo allegorico richiede l’«uso di un linguaggio molto semplice e di pochissime metafore». «Allegoria e metafora», infatti, «non vanno d’accor- do», perché mentre la metafora, o la metafora travestita da similitudine, allargano e confondono un’immagine di base, la similitudine opera il processo inverso: comprime più immagini in una sola, perciò chiarifica, illustra. Così, è ancora Eliot a riportarlo, quando nel XV canto dell’Inferno scrive «E sì ver’ noi aguzzavan le ciglia/ come ’l vecchio sartor fa ne la cruna», Dante fa un’operazione apparentemente simile, ma profondamente diversa dallo NOTE 1 Tutte le citazioni sono tratte da T.S. Eliot, Dante II (1929), in Studi su Dante, Bompiani, Milano 2001, pp. 15-63. 69 Shakespeare di Antonio e Cleopatra che racconta di lei che «pareva dormisse/ come se volesse catturare un altro Antonio/ nella sua rete di grazia». Anche se è strutturata come una similitudine, infatti, catturare nella sua rete di grazia è in realtà una metafora; anzi, si tratta di due metafore sovrapposte. Giochi da linguisti appassionati? Anche, ma non in prima battuta. In prima battuta c’è infatti la transitività del linguaggio e quindi la comunicabilità di un’esperienza umana. L’eterna e sempre nuova sfida dell’arte: dire ciò che non si può dire, vedere e far vedere ciò che sembra non esserci ma c’è. 70 la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 BvS: il ristoro del buon lettore L’immenso Oceano Mare Una eccelsa Taverna sugli scogli di Marina del Cantone GIANLUCA MONTINARO G iù, da Sant’Agata sui due Golfi, per la lunga e ripida discesa. Curve e tornanti; e olivi e fichi e agrumi e fichi d’India. Eppoi ancora, sempre più in basso, tornanti e curve; e olivi e fichi e agrumi e fichi d’India. Infine eccola, Marina del Cantone: piccola baia - splendida perla - nascosta, quasi incastonata, sotto Punta Campanella, in estremità fra Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Qui, sola e tutta bianca, davanti al mare, si trova la Taverna del Capitano, storico e blasonato locale che la famiglia Caputo gestisce da quattro generazioni. Arrivarvi è come approdare alla locanda Almayer, luogo ove prende dimora uno dei protagonisti di Oceano mare di Alessandro Baricco (opera di cui la Biblioteca di via Senato possiede copia nella prima edizione, stampata a Milano, da Feltrinelli, nel 1993): il professor Ismael Bartleboom. «Sono arrivato al mare. La locanda è ospitale; proprio davanti alla spiaggia. La sera si alza la marea e l’acqua arriva fin quasi sotto alla mia finestra. È come stare su una nave». E come su una nave da crociera, alla Taverna del Capitano, le immense finestre del ristorante affacciano sul Taverna del Capitano Piazza delle Sirene Marina del Cantone Massa Lubrense (Na) Tel. 081/8081028 blu profondo delle acque. L’ambiente è confortevole e rilassante. Il servizio attento e solerte. La cucina parla il linguaggio del mare con piatti solo all’apparenza semplici ma che in realtà sono dimostrazione di studio e conoscenza approfondita sia della materia prima (che viene sempre valorizzata e mai snaturata) che dei processi di cottura. Così gli scampi e ricci di mare all’olio extravergine di oliva sono un tuffo nell’elemento equoreo. Mentre la trafila di pasta secca con sugo di scorfano, peperoncini verdi “friarielli” e pomodoro racconta tutta la tradizione di questa terra. Il vino non può che essere una grande bollicina che, per mineralità ed effervescenza, ben bilancia la tendenza dolce della pasta e la gras- sezza dei crostacei. Non può che essere, quindi, che un Ca’ del Bosco. Non può che essere quindi l’ultimo nato della maison di Erbusco: il Dosage Zéro Noir “Riserva”, annata 2005. Un vino siderale: un 100% pinot nero (proveniente dalla vigna Belvedere, “magico” luogo tra i più elevati della Franciacorta, a 466 metri sul livello del mare), affinato per nove anni in bottiglia, che esprime al massimo grado aroma, struttura e persistenza. Un vino sontuoso, barocco, sterminato. Come sontuosa, barocca e sterminata è la “piccola”… zuppa di pesce dello chef Alfonso Caputo. Servita su un immenso piatto (che più che stoviglia pare vassoio), alterna tranci - spinati - di tutto il pescato del giorno a molluschi e crostacei. I crostini di pane, a lato, lentamente si bagnano nel dolce pomodoro. In questo morbido sugo è racchiusa l’esperienza della Taverna del Capitano, e quasi lo spirito di questo luogo. «Il muto esistere di acqua e terra». Lo zuccherino dell’oro rosso e la sapidità dei doni del mare. Non si abbia pudore quindi a inzuppare il pane, avvoltandolo in questo concentrato di vita: «potrebbe essere la perfezione: immagine per occhi divini». 72 HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO GIANLUCA MONTINARO Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è docente a contratto presso l’università IULM di Milano. Storico delle idee, si interessa ai rapporti fra pensiero politico e utopia legati alla nascita del mondo moderno. Collabora alle pagine culturali del quotidiano «il Giornale». Fra le sue monografie si ricordano: Lettere di Guidobaldo II della Rovere (2000); Il carteggio di Guidobaldo II della Rovere e Fabio Barignani (2006); L’epistolario di Ludovico Agostini (2006); Fra Urbino e Firenze: politica e diplomazia nel tramonto dei della Rovere (2009); Ludovico Agostini, lettere inedite (2012); Martin Lutero (2013). la Biblioteca di via Senato Milano – novembre 2014 ALBERTO C. AMBESI Alberto Cesare Ambesi (1931), scrittore e saggista, ha insegnato storia dell’arte e semiotica all’International College of Sciences and Arts e all’Istituto Europeo del Design. Fra le sue opere si ricordano qui: Oceanic Art (1970), L’enigma dei Rosacroce (1990), Atlantide e Le Società esoteriche (1994), Il panteismo (2000), Scienze, Arti e Alchimia (riedizione ampliata e rinnovata di un precedente saggio, Hermatena, Riola, 2007) e le particolari monografie Nella luce di Mani (2007) e Il Labirinto (2008). È stato critico musicale del quotidiano «L’Italia» e ha collaborato alle pagine culturali de «La Stampa». MARCO CIMMINO Marco Cimmino (Bergamo, 1960). Storico, membro della Società Italiana di Storia Militare e socio accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, si occupa prevalentemente di Grande Guerra. Collaboratore Rai, scrive su molte testate. Membro del comitato scientifico del Festival Internazionale della Storia di Gorizia, è uno dei responsabili del progetto èStoriabus. Tra i suoi saggi più recenti: La conquista dell’Adamello (2009), Da Yalta all’11 settembre (2010) e La conquista del Sabotino (2012), finalista al premio Acqui Storia 2013. MASSIMO GATTA Massimo Gatta (1959) ricopre l’incarico, dal 2001, di bibliotecario presso la Biblioteca d’Ateneo dell’Università degli Studi del Molise dove ha organizzato diverse mostre bibliografiche dedicate a editori, editoria aziendale e aspetti paratestuali del libro (ex libris). Collabora alla pagina domenicale de «Il Sole 24 Ore» e al periodico «Charta». È direttore editoriale della casa editrice Biblohaus di Macerata specializzata in bibliografia, bibliofilia e “libri sui libri” (books about books), e fa parte del comitato direttivo del periodico «Cantieri». Numerose sono le sue pubblicazioni e i suoi articoli. DANIELE GIGLI Daniele Gigli (Torino, 1978) lavora nella conservazione dei beni culturali. Studioso di T.S. Eliot, ne ha curato alcune traduzioni, tra cui quelle di The Hollow Men (2010) e Ash-Wednesday, di imminente uscita. Ha pubblicato le plaquette Fisiognomica (2003) e Presenze (2008) e sta attualmente lavorando al libro Fuoco unanime. LUCA PIETRO NICOLETTI Luca Pietro Nicoletti, storico dell’arte, si interessa di arte e critica del Secondo Novecento in Italia e in Francia. Ha pubblicato: Gualtieri di San Lazzaro. Scritti e incontri di un editore italiano a Parigi (Macerata 2013). GIANCARLO PETRELLA Giancarlo Petrella (1974) è docente a contratto di discipline del libro presso l’Università Cattolica di Milano-Brescia. Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione per la I fascia di insegnamento di Scienze del libro e del documento. È autore di numerose monografie fra cui: L’officina del geografo; Uomini, torchi e libri nel Rinascimento; La Pronosticatio di Johannes Lichtenberger; Gli incunaboli della biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia (2010). Ha curato le mostre Petrarca alla Trivulziana e Libri mei peculiares. Collabora con «Il Giornale di Brescia» e la «Domenica del Sole24ore». LUCA PIVA Luca Piva (Piove di Sacco, 1960), saggista e illustratore, si interessa a temi e spunti della tradizione figurativa e letteraria italiana, in particolare nelle sue espressioni di ambito veneto, per lo più di periodo tardo. Nella sua bibliografia figurano due saggi pubblicati in «Padova e il suo Territorio» (Invito allo studio del Cristo di Arzerello, 2010; Una triste visita di Giovanni Comisso a Piove di Sacco, 2011). Sta lavorando ora a una raccolta di storie narrate da architetture. È in procinto di pubblicare un saggio su alcuni aspetti poco divulgati del rapporto fra D'Annunzio, Venezia, e il culto della Serenissima. LUIGI SGROI Luigi Sgroi (Milano, 1961) lavora in ambito artistico, interessandosi alle “vie del corpo”. Spazia dal teatro d’avanguardia, al mimo classico, al buddhismo zen e, dal 1990, alle varie forme dello yoga. BEVI RESPONSABILMENTE IL PRIMO CREMAMARO BEVILO GHIACCIATO.
Scarica