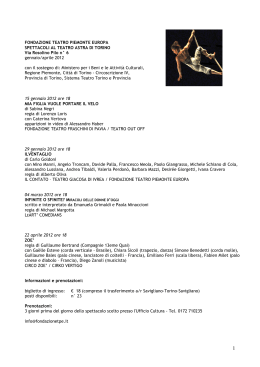cantiere regia — 29 Cantiere Regia L a cura di Leonardo Mello e Ilaria Pellanda a regia nel teatro musicale oggi è il tema di questa articolata e ampia ricognizione, che coinvolge una nutrita schiera di «addetti ai lavori», dagli stessi registi ai compositori, dai critici agli studiosi (che ringraziamo tutti per aver aderito alla nostra iniziativa, che ha visto in Mario Messinis una fonte irrinunciabile e preziosa di consigli e suggerimenti). A tutti loro abbiamo posto un breve, conciso e generico quesito, riportato poco sotto, lasciando ciascuno libero di esprimere la propria opinione, senza imporre limiti di grandezza né per eccesso né per difetto. Ne è nata un’inchiesta corale di grande spessore, che affronta la questione dai più svariati punti di vista, fornendo chiavi interpretative, analisi storiche e anche qualche spunto polemico. Senza alcuna pretesa di esaustività, offriamo a tutti le diverse risposte che abbiamo raccolto, lasciando a ognuno il compito, speriamo gradito, di leggerne in controluce i dettagli secondo il proprio gusto e le proprie convinzioni. Il nostro quesito «Come tutte le forme espressive, anche la regia del teatro musicale segue orientamenti e ridefinizioni in linea con il periodo storico in cui è inserita. Quali sono secondo lei gli elementi essenziali e irrinunciabili del lavoro registico al giorno d’oggi?» cantiere regia Hanno gentilmente risposto Daniele Abbado, Claudio Ambrosini, Lorenzo Arruga, Giorgio Barberio Corsetti, Giorgio Battistelli, Marco Bellussi, Leonetta Bentivoglio, Lorenzo Bianconi, Carla Bino, Mario Bortolotto, Sandro me minimo ci si trova a dover decidere, di volta in volta, quale livello di finzione siamo disposti a stabilire, o a tollerare. Oppure, nei casi migliori, l’interpretazione teatrale ingloba già la finzione nella drammaturgia che mette in atto. L’interpretazione sembra essere il corollario implicito di qualsiasi tentativo registico. Credo che il tema dell’interpretazione sia, a qualsiasi latitudine, il più grande generatore di equivoci. Da qui deriva la figura del regista-demiurgo, una figura spesso ingombrante e abbondantemente superata dai fatti. Se siamo in grado di ribaltare questa credenza e questa mentalità, si può affermare che il testo contiene già in sé la sua, o meglio, le sue interpretazioni. E che qualsiasi testo ci presenta lo sforzo dell’autore di raggiungere una coerenza attraverso, o a partire da elementi non necessariamente coerenti. Se lavora con questa consapevolezza e con questi strumenti, il regista può abbandonare la fastidiosa tendenza di considerare il suo lavoro come modalità di affermazione della propria identità soggettiva. Il testo non solo viene prima, ma è la vera priorità. Il lavoro del regista deve consistere principalmente nel saper far parlare il testo. Quando è in grado di portare in luce aspetti nuovi di un testo, di metterlo in circolo nel processo di comunicazione che si svolge con il pubblico, di portarlo vicino o dentro o davanti alla sensibilità del pubblico di oggi: allora il lavoro del regista trova il suo compimento. Stiamo parlando di teatro musicale. Quindi è bene ricordare che per «testo» va intesa la totalità del testo, a partire dalla scrittura musicale – tanti se ne dimenticano. A questi dati, che possiamo ritenere quasi scontati, vorrei aggiungere una considerazione più precisa, che credo ne consegua in modo di- Cappelletto, Robert Carsen, Giancarlo Cobelli, Mariano Dammacco, Emma Dante, Hugo De Ana, Gianfranco De Bosio, Pippo Delbono, Guido De Monticelli, Paolo Fabbri, Ivan Fedele, Siro Ferrone, Cesare Fertonani, Paolo Gallarati, Marco Gandini, Massimo Gasparon, Adriano Guarnieri, Gerardo Guccini, Denis Krief, Cesare Lievi, Davide Livermore, Giovanni Mancuso, Giacomo Manzoni, Gian Paolo Minardi, Luca Mosca, Giorgio Pestelli, Pier’Alli, Paolo Pinamonti, Pier Luigi Pizzi, Mario Pagotto, Emilio Sala, Toni Servillo, Alessandro Solbiati, Luigi Squarzina, Federico Tiezzi, Dino Villatico, Michelangelo Zurletti. Daniele Abbado Cercare di rispondere a questa domanda implica in partenza altri interrogativi. Come oggettivare i dati di una esperienza che in gran parte è inevitabilmente soggettiva? Come sintetizzare in poche argomentazioni un tema così vasto? In realtà la domanda presuppone il riferimento a una consapevolezza storico-critica che nell’evolversi della regia teatrale degli ultimi decenni sembra non essere più eludibile. Si tratta di una consapevolezza che è all’opera nella pratica quotidiana; quante volte capita di dirci, su un palcoscenico, frasi come: «Questo oggi non si può più fare»? È a partire da questi presupposti che cercherò di dare alcune risposte. Senza scomodare Diderot, Brecht e tutta l’evoluzione della regia nel Novecento, mi sembra inequivocabile che il Teatro da oltre due secoli si trova a fare i conti con il tema della finzione scenica, non più accettabile come dato in sé scontato. Non esiste una posizione neutrale del regista o dell’interprete: co- retto: elemento essenziale del lavoro registico è la chiarezza narrativa. Certo, di fatto è sempre stato così: qualsiasi regia, in qualsiasi tempo, nasce come racconto scenico, e la chiarezza è un suo tratto indispensabile. In realtà, ogni epoca propone e afferma diversi stati e modi della sensibilità – etica, estetica, politica – e il lavoro del regista si colloca esattamente su questo terreno. L’importanza stessa della narrazione è stata messa a dura prova, quando non decisamente negata per lungo tempo, e il suo riaffermarsi come aspetto costitutivo del teatro di oggi, a partire dalla relazione che lega gli autori al proprio pubblico, mi sembra una conquista decisiva della nostra modernità. Compito del regista è immaginare, nel realizzarlo, un racconto scenico che include nel suo farsi i propri spettatori. Penso sia chiara questa formulazione: la regia istituisce il proprio pubblico, nel caso migliore istituisce un pubblico che non c’è ancora, o che ancora non è consapevole di immaginare quelle cose. Mettere in primo piano il racconto: racconto del testo, del personaggio, dello spazio; tutto deve poter concorrere ad un unico gesto narrativo. Questo modo di pensare e di procedere porta sulla strada della massima semplicità possibile. Credo che questa semplicità, unita alla forza di una narrazione scenica chiara e riconoscibile, vada incontro e valorizzi la capacità immaginativa dello spettatore, all’opposto di un approccio registico concettuale o illustrativo, ridondante o inutilmente spettacolare. Non è più possibile affrontare un testo del teatro musicale come *Si ringraziano Chiara Squarcina e Arianna Silvestrini per la redazione delle risposte di Robert Carsen e Hugo de Ana. 30 — cantiere regia Il Fantasioso che volesse dar sfogo impunemente, ma non senza profitto, alle proprie turbe creative e nel contempo imporsi agli oc- parte e quando e come entrare, e altrettanto poi uscire. Invece quello che il regista deve assolutamente cercare è il «konzept», l’idea-chiave alla luce della quale stravolgere l’opera. Extra-volgere! Tenendo presente che più si contraddice l’intenzione del librettista e del compositore, più si noterà l’intervento del regista. Quanto ai compositori, di solito non capiscono niente delle musiche che scrivono. Quindi, se per caso, aprendo la partitura, l’occhio inavvertitamente vi cada sull’indicazione «timidamente», si dia subito istruzioni al cantante affinché si atteggi a un tono spavaldo, e così via. Bisogna saper interpretare. Il regista alla moda tenderà poi a preferire le opere dei compositori defunti, che non possono più protestare quando si sposta qualche scena da un atto all’altro o si fa qualche bel taglietto… Tantomeno dovrà preoccuparsi di mantenere la parola data ai vivi, anzi, accetterà tutte le proposte che càpitano, pronto a lasciare la barca per un’offerta più allettante. E, progettando, mai dimenticherà l’equazione psicologica: costi alti = lavoro importante. Quindi spenda e spanda, e la stima crescerà. E magari disegni anche le scene e i costumi. Tanto chiamare scenografi e costumisti aggiunge solo confusione. E se proprio si vuol risparmiare, lo si può sempre fare sulle voci, sugli strumenti, sull’amplificazione, sulla preparazione musicale. Inoltre, a proposito di budget, baderà a che il suo compenso sia adeguato e, soprattutto, superi di gran lunga quello del librettista e ancor più quello del compositore che, in fin dei conti, non lavora che per 2 o 3 anni alla stesura della sua opera, mentre al regista si chiede di star lì a far prove per ben 20, e talvolta addirittura 30 giorni. Insomma, in tutti gli aspetti, sia dato a Cesare quel che è di Cesare; o vogliamo insinuare che la Storia dell’Opera sia stata fatta dai musicisti e non dai registi? chi del mondo potrebbe scegliere – tra le professioni che oggi non richiedono una preparazione specifica – la regia di opera lirica. Nessuno gli chiederà infatti se sia in grado di leggere la musica o di seguire una partitura, né cosa egli sappia davvero di tecniche di emissione e di altre problematiche connesse con il canto e, tantomeno, di correnti compositive o di prassi esecutive. Basterà che si attenga ad alcune semplici regole – come quella di non ascoltare nessuno –, riassumibili in un unico concetto: meno ne sai, meglio è. La prima categoria cui non bisogna dar retta sono i cantanti. È noto come siano pieni di pretese assurde come il voler esser lasciati cantare sul proscenio, così da far arrivare la voce nel centro del teatro, veder bene il direttore e sentire altrettanto bene l’orchestra. Tutte fisime. Un cantante ha un’aria solistica, ricca di sfumature e mezzetinte, che magari ha studiato per mesi? Lo si metta in fondo alla scena, di spalle al pubblico a sgolarsi contro la parete di fondo. Una cantante ha un assolo veloce, che presupporrebbe di potersi muovere con scioltezza pari a quella della sua parte vocale? La si faccia camminare con le stampelle e a gambe ingessate, e così via. Bisogna sempre spiazzarli! Solo così si può esser certi di generare in loro una vera tensione interpretativa. E per quanto riguarda poi la prossemica, l’euritmia, i bilanciamenti, i movimenti sulla scena? Farli derivare direttamente dagli esiti delle prove, che devono naturalmente essere di durata adeguata (una vera regia non può certo essere frutto di tempi ristretti). E come strutturare quotidianamente la prova? Nella prima parte: tutti stesi per terra, assopiti, a fare yoga. Nella seconda parte, lasciare i cantanti liberi di aggirarsi, sul palcoscenico, senza una meta precisa ma «interrogandolo». Questo è il segreto: interroger l’espace! È lo Spazio infatti, non certo il regista, che deve dir loro cosa fare e da che Beh, mi fermo qui e chiedo subito venia per non aver saputo resistere alla tentazione di ricalcare, almeno per un po’, le orme di Benedetto Marcello, portando esempi che con la realtà hanno un rapporto puramente casuale. Cioè (mi) son tutti accaduti, ma sono stati qui citati in ordine casuale. Fortunatamente, comunque, le cose non stanno sempre così. Ci sono ovviamente, e non pochi, registi sensibili e preparati, in grado di capire a fondo anche la musica più recente. E che sanno che la regia, soprattutto per un’opera nuova, è forse l’aspetto essenziale, perché ne stabilisce l’incipit, ne cristallizza la prima comparsa. Sembra banale dirlo, ma la regia d’opera dovrebbe esser fatta sulla musica, come una coreografia, e non (solo) sul libretto. Il libretto del Fidelio, per esempio, può portare a pensare a un’atmosfera opprimentemente cupa, che si rivela invece poi pervasa dalla luminosità utopica delle note di Beethoven. I libretti poi lesinano, e non sempre a torto, sulle didascalie. Ma le partiture di solito ne contengono e gli interventi dei cantanti son passo passo coadiuvati da indicazioni di intenzione. E qualora anche queste mancassero, ci sono le numerosissime prescrizioni di dinamica e di agogica, che un regista accorto dovrebbe cercare di tener presenti, pur nella libertà della sua realizzazione. La partitura del Wozzeck di Berg è qualcosa di assai diverso dal libretto della stessa, pur ricco di didascalie, a sua volta diverso dall’originale di Büchner. O – altro semplicissimo esempio tra gli infiniti possibili – l’indicazione «piano» per il cantante e «sottovoce» per l’orchestra è, nella rossiniana Aria della calunnia, un suggerimento che può esser tenuto presente sia sul piano musicale che registico. Talvolta il libretto, ma perfino il titolo, o il soggetto, possono fuorviare. Luigi Nono aveva concepito il suo Prometeo come una drammaturgia priva di un protagonista centrale, di un (unico) personag- un oggetto del passato: questa è una posizione fintamente acritica, che mira a conservare una idea di «tradizione» al massimo consolatoria. Questa idea si accompagna normalmente al bisogno di esprimere, sul palcoscenico, sensazioni di sfarzo, ricchezza di immagini e di materiali, rivelando spesso impotenza narrativa e interpretativa, che è lo stesso. Il teatro musicale di oggi è in grado di valorizzare il nuovo, dimostra di non provare paura verso i nuovi linguaggi – siano essi della musica, della scena, o di altri ambiti già prossimi o assimilabili. Nella pratica scenica odierna mi sembra sanata la dicotomia tra innovazione e tradizione; anzi, la comprensione e la valorizzazione della nostra tradizione musicale e scenica contribuiscono a rendere più preciso e aperto il nostro sguardo sul domani. In conclusione, spero che la breve ricognizione che ho tentato di fare sia chiara e comprensibile. E convincente. Ne guadagneremmo un atteggiamento più orizzontale e aperto che ci può portare a considerare i capolavori del passato come materia viva e urgente per la nostra sensibilità di uomini di oggi. E a considerare di pari livello la bellezza dei testi di Monteverdi come di Stravinskij, di Mozart come di Berg, di Giuseppe Verdi come di Stockhausen; dei lavori che vengono scritti nei nostri giorni e di altri che verranno scritti nel futuro. Claudio Ambrosini cantiere regia La regia alla moda cantiere regia — 31 da un ologramma e i cannoni da fasci di raggi laser. Qui, per concludere, sta la differenza fondamentale tra la messinscena di opere del repertorio e quelle contemporanee e, a maggior ragione, di quelle in prima esecuzione assoluta. I capolavori del passato permettono un certo grado di libertà interpretativa, di deviazione dalla lettura tradizionale, proprio perché esiste una tradizione: l’opera, la sua trama, i personaggi, il contesto, l’assunto sono ben noti, tanto da sopportare anche forti «deformazioni». L’anamorfosi può funzionare. Nel caso invece delle opere nuove, sarebbe di grande aiuto se il regista ponesse tra i suoi obiettivi primari il (rap-)presentare le intenzioni degli autori, facendosi loro portavoce e tenendo presente che egli sta lì stabilendo il modello, il punto di partenza e quindi di riferimento, la lettura/epifania/ostensione primaria con la quale si confronteranno – e dalla quale eventualmente poi potranno anche divaricare – tutte le edizioni successive. È un Ur-Fassung da cui dipendono tutti, non solo gli autori ma soprattutto pubblico e critica, che in quel momento sono oggetto di un vero imprinting. Questo ruolo ab ovo, che inaugura il piano visibile/vivibile di una nuova opera lirica, fa dell’apporto registico una questione cruciale. Intuizione, sensibilità, disponibilità sinergetica (ma anche dialettica, benvenga!), capacità di essere camaleontici, talvolta quasi speculari con gli autori e nello stesso tempo creativamente tesi a «pantografarne» in modo originale, autonomo, l’assunto fino a dimensioni all’inizio forse solo intravviste, sono alcune delle componenti del talento necessarie per la comune buona riuscita. Dovere del compositore è certo fare un’opera che stia in piedi anche al solo ascolto, ma quando questa esce dal guscio e cerca di volare, dovrebbe essere stata provvidenzialmente trasformata, da un mago amico, in farfalla. cantiere regia gio che in carne e ossa lo raffigurasse sul palcoscenico. Anzi, neanche c’era, il palcoscenico. Era una scelta radicale che esprimeva l’evoluzione del suo pensiero teatrale, una visione che reimpostava concettualmente l’opera e colorava di un senso diverso la presenza delle voci, dei cori e della stessa orchestra. Naturalmente, morto il compositore, non son mancate le sorprese… Il rapporto con la musica dovrebbe invece essere reso tanto naturale da sembrare congenito. Un esempio magistrale ne è la resa visiva che il compianto Jean-Pierre Ponnelle fece della Sinfonia d’apertura de Le nozze di Figaro (di quest’opera esiste un suo video Deutsche Grammophon, una vera maraviglia dalla prima scena all’ultima ma bastano i primi cinque minuti per capire che è la regia di un genio): le note di Mozart vengono «spiegate», rese esse stesse personaggio dalle immagini, dai gesti, dai movimenti sulla scena e da quelli della telecamera. Tutto inventato, eppure tutto così (piacevolmente) utile, e bello. Un accordo maggiore, forte, imperioso scuote l’orchestra? Ecco che si intravvede Figaro, intento a ripulire la soffitta, mentre solleva un quadro che ritrae il baldanzoso Conte di Almaviva. Le note della Sinfonia si fanno poi affettuose, melanconiche? L’inquadratura vira dolcemente su un cassetto socchiuso che contiene delle lettere d’amore e sorvola un altro ritratto, collocato però un po’ in disparte: è quello della Contessa, ormai trascurata dal marito… Chi guarda non si rende nemmeno conto che gli si stanno subliminalmente presentando, una per una, le «carte» con cui verrà tra poco giocata la partita. Ecco un caso di (grandissimo) regista che sapeva ascoltare, «leggere» la partitura, e tradurla. Ma non mi sto certo dichiarando contrario all’innovazione, anzi. Quando bruciò la Fenice e le scene andarono distrutte, bastarono i magnifici, surrealmente espressivi costumi di Achim Freyer, e la sua regia essenziale, per farne un Don Giovanni comunque bellissimo. Quello da cui penso ci si debba guardare sono le modernizzazioni precotte, le «attualizzazioni» più o meno prevedibili: non dimenticherò mai l’incauto acquisto di un pubblicizzatissimo video di Così fan tutte, che risultò ambientato in un McDonald’s, con i cantanti in cannottiera e jeans. Sembrava la registrazione non di uno spettacolo, ma di una qualunque prova; per la semplice ragione che tra il settecentesco linguaggio della musica, e il novecentesco linguaggio di tutto il resto non c’era assolutamente nessuna relazione. Se queste cose hanno senso, allora hanno senso anche i proverbiali film sull’antichità girati a Cinecittà negli anni sessanta, in cui – attorno a Ursus, o Ercole o Maciste – si vedono spade brandite da comparse vestite da legionari, che si son dimenticati di togliere dal polso l’orologio… Capisco che – anche a causa delle pressioni del marketing – non sia facile e che comporti delle rinunce, ma bisognerebbe cercare di resistere all’epidemia di «trasposite acuta» e puntare invece a uno scavo quasi maieutico del testo musicale, cercando di far emergere le potenzialità insite in ogni partitura. Un certo andamento intervallare, un melodizzare frammentato, la presenza di sincopi nella parte vocale, di rubati o di trattenuti o di «sforzati» seguiti da «subito pianissimo» possono suggerire possibilità teatrali probabilmente più interessanti che semplicemente prendere Galileo e travestirlo da Einstein. E se l’opera è su Napoleone sarebbe auspicabile – almeno alla prima messinscena – non trovarsi davanti Hitler, o la Campagna di Russia al posto di Waterloo; e, ove si canti di una «assoluta necessità di avere più cavalli», esser indotti a pensare a quelli con la criniera e non quelli a pistoni… Fatta salva questa coerenza, l’Isola di S. Elena può benissimo poi essere resa da un bonsai, Paolina Bonaparte Lorenzo Arruga I registi comincino per prima cosa a studiare l’opera che mettono in scena, realtà che mi sembra troppo spesso trascurata. Giorgio Barberio Corsetti Nel teatro musicale, anche nell’opera di tradizione, vi sono potenzialità enormi. L’Italia non ha avuto Goethe, Kleist, Schiller, ma Rossini, Donizetti, Verdi, Bellini… La nostra grande stagione romantica non è rappresentata dal teatro di prosa ma da quello lirico. Possediamo un patrimonio enorme, che però è sempre rimasto rinchiuso dentro una visione letterale e polverosa. Mentre invece credo che, così come si reinterpretano i classici della prosa, ci sia la possibilità di fare la stessa cosa anche nell’opera, senza pensare che quel mondo sia antico e immodificabile. La lirica infatti, esattamente come le grandi drammaturgie, può raccontare non solo il passato ma anche il tempo in cui noi viviamo, perché stringe sempre una relazione con il nostro mondo. Non c’è niente di meno realistico dell’opera. Anche quando sono raccontate delle storie riconoscibili, la convenzione è così forte che porta lontano da ogni possibilità di realismo. Nel bel mezzo dell’azione parte un’aria e il protagonista racconta quello che ha in testa, non quello che sta accadendo. È come una specie di monologo interiore cantato, in cui attraverso la voce e la musica si esprimono i sentimenti. Sappiamo benissimo che la voce va oltre la parola: come gesto, come emissione esprime il desiderio profondo, 32 — cantiere regia sentimentale e passionale. Esprime cioè qualcosa di primario. Perciò anche dentro una convenzione così forte vi sono dei punti di fuga estremamente interessanti. Proprio in questi punti di fuga è insito il mio interesse per la lirica, non nella pura riproduzione di antichi schemi o modelli, che oltretutto non si sa nemmeno esattamente quali fossero. In realtà si può reinventare tutto completamente, anche se non amo le regie che lavorano contro il testo (in questo caso per testo voglio ovviamente intendere la partitura): tutte le grandi opere hanno una densità e una profondità all’interno della quale è possibile scandagliare elementi forse mai esplorati prima. Non c’è alcun bisogno di portarli fino a degli estremi che si esauriscono in se stessi. Credo che la sfida per un regista sia quella di mettere in scena la musica e non il libretto. Ora per esempio sto lavorando su Zelmira di Rossini, che è un’opera musicalmente molto potente, con tutti gli elementi tipici di questo autore, per cui improvvisamente da una situazione concreta, rinchiusa in schemi musicali abbastanza riconoscibili, scatta un ritmo e una tensione musicale talmente forti da trascinare lo spettatore da un’altra parte, al di là dalla situazione che il compositore stesso ha istituito attraverso quello che il libretto racconta. Quando io dico mettere in scena la musica intendo il tentativo di dare corpo alle immagini, alle sensazioni, al pensiero che essa provoca, che è un tipo di pensiero estremamente diverso da quello suscitato dalla parola. Il canto va a toccare un punto intermedio tra l’intelletto e i sentimenti, una zona che affiora dal profondo. La regia dovrebbe valorizzare questo elemento con le immagini. Anche quando siamo in presenza di opere schiettamente narrative, attraverso la voce e la musica nascono continue aperture verso la parte nascosta di noi stessi. E quelle aperture sono straordinarie, attraver- Giorgio Battistelli so di loro c’è la possibilità di tirare fuori l’invisibile, quello che non si vede e non si conosce. Fondamentale è poi il lavoro che ha a che fare con l’interpretazione. Penso che sia necessario mettere i cantanti nella condizione di interpretare, senza esaurire la propria espressività in un gioco di virtuosismo vocale. Più un cantante riesce a interpretare, cioè a vivere l’esperienza del suo personaggio attraverso la sua vocalità, più canta bene. Perché il canto, come dicevo, trasporta verso qualcos’altro, è legato a doppio filo all’emotività. Perciò più si riesce a far vivere ai cantanti queste emozioni più l’interpretazione, al di là del puro virtuosismo, sarà potente. Questo significa anche incastonarli dentro delle immagini che non parlano solo al pubblico, ma anche ai cantanti stessi, in modo che riescano a comprendere dove sono e cosa stanno facendo in quella particolare regia (e non solo in quella particolare opera). Per tutto questo i registi dovrebbero poter lavorare con i cantanti, e questo cozza contro l’abitudine tutta italiana di farli arrivare all’ultimo secondo. La grande possibilità di rinnovamento del teatro musicale sta proprio nel lavoro di interpretazione che si può fare con il regista e con il direttore d’orchestra, che dovrebbero lavorare insieme. In chiusura vorrei aggiungere qualche parola sull’opera contemporanea. A me è capitato di mettere le mani su lavori che non erano mai stati rappresentati prima. In quelle occasioni si scopre il mondo di un compositore, che è ancora tutto da esplorare. Normalmente prima si ascoltano i brani al pianoforte, o al computer. Poi, quando arriva l’orchestra, si scopre per la prima volta la musica. E questa scoperta avviene quando ci si è già lavorato sopra. È qualcosa di una potenza incredibile. È come agire intorno a un oggetto misterioso, una specie di scrigno, che rimane rinchiuso fino a quando non arriva l’orchestra a disvelarlo. teso la musica come una presenza consolatoria o decorativa. Oggi ci troviamo di fronte a opere liriche dove la regia spesso è un supporto all’opera stessa: la musica produce, soprattutto nel teatro, un pensiero debole, o meglio non possiede un pensiero sufficientemente forte da potersi sorreggere anche senza l’elemento visivo. Questa situazione ha prodotto il cosiddetto teatro di regia, che di fatto consiste in un’autoreferenzialità del regista che si appropria dell’opera musicale e ne costruisce un oggetto quasi autonomo, o quanto meno ne offre una personale, autonoma visione. Basta pensare alla Fura dels Baus, con la quale d’altro canto ho lavorato in passato: sono degli animali straordinari di teatro, dei grandi visionari e surrealisti ma si appropriano letteralmente dell’opera (non importa se sia di Battistelli o di Wagner) facendola diventare un’altra cosa. Molto frequentemente l’approccio registico si connota per una tale trasgressione che non si può più parlare di traduzione scenica, ma invece di tradimento: l’opera stessa diventa estranea all’originale. Per tutti questi motivi il rapporto tra regia e musica è delicatissimo, e spesso la prima prevarica la seconda. Se si parla di teatro musicale d’arte, in tutte le forme e sfumature che può assumere, io credo che l’asse portante, la drammaturgia intrinseca debba essere quella della musica, che stabilisce quali sono le arcate temporali delle varie sezioni dell’opera e la presenza della parola: è sempre la musica che deve determinare quanta parola e quanto silenzio devono essere presenti. Per dirla in breve, è la drammaturgia musicale che rende viva l’opera. I registi sono spesso dei guastatori, soprattutto per quanto riguarda la musica contemporanea, oppure possono essere dei simpatici provocatori o ancora dei pionieri, nel senso che ci fanno intravedere delle sfaccettature nuove di un Don Carlos, di un Rigoletto, di un Don Giovanni… In questo senso ricordo almeno Peter Sellars, Robert Lepage e Robert Carsen. cantiere regia È un tema estremamente dinamico, che cambia con una velocità impressionante. Quello che cambia è proprio il rapporto tra l’elemento visivo e quello uditivo, tra ciò che si guarda e ciò che si ascolta. Vi sono delle forze contrastanti: da una parte è vero che c’è una maggiore sintonia e una maggiore sensibilità in relazione a ciò che per anni è stato teorizzato come l’asse trasversale, cioè l’interdisciplinarietà di un oggetto e di un pensiero artistico che possa attraversare i vari linguaggi. Oggi questo è possibile. Dall’altra parte ci sono però delle velocità diverse, l’accostamento di questi linguaggi produce delle energie che possono essere positive o negative. Le differenti forme espressive hanno dei tempi che sono completamente diversi. Noi siamo portati ad accettare, tollerare, comprendere un elemento visivo – anche astratto, complesso e complicato – ma riusciamo con molta maggiore difficoltà a compiere la stessa operazione sul versante uditivo. Il più delle volte oggi un lavoro di musica contemporanea d’arte è tollerato assai meno del suo equivalente in ambito visivo. E questo ovviamente accade anche all’interno di un’opera lirica, la cui stessa etimologia prevede la riunione di linguaggi diversi come scenografia, costumi, movimento, musica… A volte si vengono realmente a creare delle asimmetrie tra questi vari linguaggi. Il difficile è proprio costruire un’arte dove effettivamente tutte queste manifestazioni espressive camminino con lo stesso rigore. Se prendiamo in considerazione il cinema, vediamo ad esempio che un regista come Pasolini, rigorosissimo nella ricerca della parola e della visionarietà poetica, nella scelta della stessa singola inquadratura, si è sempre avvicinato alla musica con un approccio molto meno esigente. La stessa cosa la ritroviamo in Carmelo Bene: un altro grande artista, maniacale per quanto riguarda la propria parola e il proprio corpo, che ha però sempre in- cantiere regia — 33 Marco Bellussi A domanda chiara risposta chiara! Gli elementi essenziali ed irrinunciabili del lavoro registico sono sostanzialmente due: 1. La capacità/umiltà di mettersi al servizio del testo; 2. Lo sforzo di conciliare la «narrazione» della vicenda con l’eccellenza della dimensione estetica. Nel caso specifico del teatro musicale occorre aggiungere poi un terzo requisito irrinunciabile: 3. La ricerca di una gestione dell’azione scenica sintonica al dettato della partitura. Una breve argomentazione: 1. Mettersi al servizio del testo significa leggerlo con occhi «vergini». Arduo... ma ancor più necessario nel cosiddetto «grande repertorio». Mai cadere nella tentazione di interpretare prima di conoscere. 2. La responsabilità di chi opera nel settore delle arti figurative è immensa. Siamo noi a determinare i canoni estetici del nostro tempo. Non lamentiamoci delle brutture del mondo se, noi per primi, non riusciamo a creare bellezza! 3. Al terzo requisito tengo particolarmente. Credo ad una regia che sia strumento di esecuzione della partitura... cerco un movimento scenico sintonico agli «affetti» musicali voluti dal compositore. Concludo dicendo che non ritengo sensata una preventiva diffidenza per gli adattamenti e trasposizioni delle coordinate spazio-temporali delle trame. In teatro tutto si può e deve fare, purché nel rispetto del testo e del pubblico. Leonetta Bentivoglio cantiere regia Quello della regia è il tema cruciale del teatro musicale nel nostro tempo. Come contenere in poche righe una riflessione significativa su un argomento tanto decisivo? Faccio un mio piccolo tentati- ti quasi. Nel quintetto della stupefazione, un lepido gioco di scena increspa l’interminabile «Buona sera»: la borsa che il Conte ha somministrato di soppiatto a Basilio («Via, prendete medicina») sguscia di mano in mano, il barbiere lestofante la ghermisce al maestro di musica, la lancia al Conte, che la dondola sotto il naso di Bartolo per subito rilanciarla a Figaro, mentre Basilio cerca invano d’acchiapparla e infine se ne va con le pive nel sacco. Alla «gran pausa» – tableau vivant dei quattro attori rimasti – Figaro esibisce gongolante la borsa-trofeo: a passo felpato rientra Basilio che zàcchete, gliela soffia e via. Con un niente, la laboriosa estromissione dell’intruso don Basilio si è arricchita di un contrappunto scenico che la giustifica e la illeggiadrisce: una piccola delizia di vecchia e buona scuola. L’indomani, altro teatro, regista e scenografo di grido. Al «siete giallo come un morto» fioccano cataletti, barelle, carri funebri, croci a lutto, candelabri da morto; Basilio viene scarrozzato per la scena da una squadra di barellieri e beccamorti, un prete spuntato da chissà dove gl’impartisce l’estrema unzione, mentre Rosina e Bartolo vanno sù e giù per un montacarichi a vista. Non si tratta più di togliersi dai piedi l’importuno, bensì di farlo fuori, di fargli la festa. La levità di Beaumarchais Sterbini Rossini scade in caricatura sguaiata, sberleffo grottesco, dissacrazione à la page. Plumbeo. Le regìe d’opera si distinguono in belle e brutte più che in «tradizionali» e «creative». Le une come le altre possono vivificare il meccanismo drammatico o appesantirlo fino a farlo stramazzare. Ma gli allestimenti «innovativi» – quelli che muovono dall’idea che «tanto l’opera è un museo» e perciò occorre «svecchiarla» – sono più degli altri esposti a un rischio tipico delle età decadenti: coltivare la cuisine pour les cuisiniers, tessere un gioco per iniziati, mandare messaggi cifrati. Di quanti spettacoli «innovativi» e «trasgressivi» si vede da lontano che strizzano l’occhio alla regìa dell’amico o del riva- vo, peccando – com’è ovvio – di approssimazione. Difficile, o impossibile, parlare di elementi «essenziali e irrinunciabili» nella regia operistica. Cosa c’è di «essenziale e irrinunciabile» nel lavoro di un artista, per sua stessa natura libero e non condizionabile da norme precostituite? Ha ancora senso dibattere sulla legittimità di un’interpretazione registica, dopo tutto ciò che è accaduto in questo campo negli ultimi decenni del Novecento? Prendiamo il cardine di tanta parte delle discussioni critiche: lo spostamento dell’epoca d’ambientazione di un’opera. Ci sono stati aggiornamenti di un libretto orrendi e pretestuosi, ed altri di magnifica coerenza; così come abbiamo assistito sia a letture registiche fedeli alla tradizione e al tempo storico richiesto dal libretto che finivano per risultare di una noia irritante, sia ad allestimenti rispettosi del libretto e capaci di conquistare il pubblico e di alimentare la comprensione del valore dell’opera grazie alla loro splendente e correttissima bellezza. Non esistono regole oggettive. Saper cogliere la sostanza espressiva del testo, instaurare insieme al direttore una percepibile sintonia tra palcoscenico e orchestra, rendere credibile la recitazione degli interpreti (eppure anche questo non vale di fronte a certe regie di Bob Wilson, che traducono i cantanti in segni disumanizzati e astratti, ma ciò nonostante appaiono teatralmente efficacissime): questo è ciò che conta. Per farla breve: la qualità dell’esito. Lorenzo Bianconi In due sere consecutive, due diversi Barbieri di Siviglia. Regista e scenografo spagnoli, per la prima volta in Italia: Siviglia da cartolina, balcone e gelosia, lampioni all’angolo, il moño sulla nuca. Tutto scorre senza intoppi: l’abile sarto taglia l’abito in maniera che non lo si no- le, sollecitano lo squittio compiaciuto del critico tale o del letterato talaltro, stuzzicano il palato blasé del sovrintendente X o del direttore Y? È fatale che l’ambiente teatrale incubi il narcisismo: poco male, se si tengon saldi i termini della comunicazione teatrale – a un capo l’opera allestita, all’altro lo spettatore – e se si concepisce la regìa al servizio di questi due termini, non in funzione delle public relations del regista. La regìa è un mezzo, non un fine. Il teatro ha anche una missione pedagogica: oggi più che mai, col deprecato invecchiamento del pubblico. Ormai non possiam più dire che «tanto tutti conoscono» Il barbiere di Siviglia o La bohème o Il trovatore: per molti, il «museo» è un luogo dove non hanno mai messo piede, dove attendono chi li conduca per mano. In ogni platea c’è una percentuale non trascurabile di spettatori che quell’opera la vedono e la sentono per la prima volta, e desiderano innanzitutto capire Rossini e Sterbini, Puccini e Illica e Giacosa, Verdi e Cammarano; perciò sono riconoscenti al regista che gli faciliti il (gradito) compito di guardare e ascoltare e capire, che gli eviti la (sgradita) sensazione di essere tagliati fuori da un divertimento per soli intenditori. Il regista che per amor di sé e dei suoi pari non si curi di questa quota di spettatori – una quota che importa crescere, non scoraggiare –, che per disgusto del già visto e del già fatto vuole stravolgere e strafare, si assume una ben grave responsabilità. (Del resto la regola della «prima volta» vale per tutti noi, e vale sempre. Quando ci sediamo a teatro o mettiamo su un disco o riprendiamo un romanzo, stipuliamo tacitamente con noi stessi una convenzione estetica primaria: facciamo finta che quel melodramma, quel quartetto, quel racconto lo vediamo lo sentiamo lo leggiamo per la prima volta, mettiamo tra parentesi la nostra preconoscenza per poter meglio giocare l’avventura intellettuale della riscoperta e della comprensione. Chiaro che la preconoscenza non cessa, anzi ci aiuta a meglio com- 34 — cantiere regia prendere un’opera che magari conosciamo a memoria: ma solo la sazia disappetenza dell’annoiato ha bisogno di spezie ed elisir che gli àlterino i sapori noti per procurargli l’effimera eccitazione d’un gusto sempre diverso). Quel che dico mortifica la creatività del regista? No, perché la creatività – lo sanno tutti, anche se lo dimentichiamo spesso – si alimenta innanzitutto dei limiti che le sono posti; e il suo margine di libertà è comunque sempre amplissimo, nell’interpretazione pertinente del testo musicale e drammatico. È nel regno dell’impertinenza che la creatività appassisce, infestata dall’arbitrio. Carla Bino Non si guarda una pièce di teatro come un quadro, per le emozioni estetiche che procura, ma la si vive concretamente. Non ho dei canoni estetici. Non mi sento legato ad alcuna epoca passata anzi mi sono sconosciute, e non mi interessano. Mi sento profondamente impegnato solo verso l’epoca in cui vivo e le persone che vivono con me. Credo che una totalità possa contenere nello stesso tempo barbarie e sottigliezza, riso tragico e riso volgare, che una totalità nasca dai contrasti e più questi contrasti sono importanti, più questo tutto è palpabile concreto vivo. Tadeus Kantor, Il teatro indipendente, 1.Credo, in Il teatro della morte, Ubulibri, Milano 2000, p. 33. ca e razionale, scontatamente legata ai meccanismi del racconto (che comunque mancano, e che sono gli unici ad essere timidamente ricercati da talune proposte di regia, ma non è questo il punto), quanto quello della comprensione relazionale, emotiva, per cui si è completamente coinvolti in un fatto poetico, impastato di gesto, vista, udito, dove il gesto ha un suono, una luce ed un respiro. Mettere in situazione, mi sembra la necessità irrinunciabile della regia d’opera. Ossia legare, dove la scena, ciò che via accade e ciò che si vede sia un tutto armonico con ciò che si sente in virtù di una «legatura di portamento» che segna l’inizio e l’andamento del respiro. Mettere in situazione, che implica, però, la rinuncia ai vezzi melomani e allo stupore della scena magnifica, tanto quanto la prosa dovette rinunciare al rigore filologico e letterario dei drammaturghi, agli stereotipi della recitazione canonica e della scena mimetica. Mettere in situazione, per vedere le parole e i gesti della musica. In una parola ridare al teatro musicale il teatro, che ne è stato cacciato o che vi è relegato in una posizione del tutto accessoria. Ma, allora, bisognerà tenere presente che nel nostro tempo il teatro non si contempla, come diceva Kantor. E dunque l’opera non si ascolta e non si guarda. Almeno non solo. Mario Bortolotto Le strade sono evidentemente due: o un regista intende allestire quell’opera o non intende allestirla. Ci sono registi che, qualunque cosa facciano, rispettano letteralmente quello che l’opera è, e questa dunque viene rappresentata come gli autori l’hanno immaginata. Oppure si può falsarla, cominciando a spostarla nel tempo, negli ambienti, nello spazio, dando tutt’altro significato ai sentimenti luogo delle relazioni (di tutte le relazioni) tra chi agisce e chi guarda agire. Teatro come evento, esperienza, azione efficace, ossia azione che accade ed è parte della vita di chi partecipa del suo accadere. Questo fu il terremoto «poietico» che cambiò il teatro sul finire del XIX secolo rivoluzionando tutto, dal lavoro degli attori, al modo di concepire gli spazi teatrali, alla scenotecnica e con essi influì pesantemente sul sistema produttivo, sul pubblico e quindi sul mercato. Il teatro era cambiato: non poteva più essere solo qualcosa che si guarda, ma era divenuto qualcosa che si vive. Questo discorso sembra non poter essere valido per l’opera in musica. Almeno per tre ragioni, ormai strutturali: il genere, che vive la storica inconciliabilità delle componenti, per cui azioni, musica e macchina scenica hanno pesi diversi; il meccanismo produttivo, in qualche modo legato alle dinamiche del titolo che fa cassetta e alla notorietà degli interpreti; il pubblico, le cui attese sono orientate e prevedibili, dipendenti in modo pressoché direttamente proporzionale all’età e alla competenza. Il risultato, certo generalizzando, è che l’opera si ascolta e si vede. Quasi mai si vive, unendo all’ebbrezza dell’ascolto e della visione di una scenografia meravigliosa (quanto c’è di manierista in questo modo di guardare: «la meraviglia, ohimé, degli intermezzi») la partecipazione emotiva alla situazione poetica della quale si è spettatori. Non lo si fa, se non raramente, perché la situazione è secondaria, impalpabile, mai agita; a volte ignorata per ragioni di tecnica vocale (e di divismo), o per lasciare spazio allo stupore della scena. E dire che la musica spesso chiama l’azione, la suggerisce, la contiene quasi fosse una didascalia implicita, tanto che se quel gesto fosse «cavato» dalle note che lo porgono così insistentemente, ecco che sulla scena il suono si incarnerebbe in quella, appunto, che si chiama azione efficace. Il risultato sarebbe non tanto quello della comprensione logi- e alle azioni dei personaggi. In questo caso non si è più di fronte a un fatto interpretativo, ma ci si trova invece davanti a un fatto inventivo, che – come tutti i fatti inventivi – può essere eccellente o mediocre. Per fare degli esempi, non si può negare che registi della statura di Strehler o di Visconti fossero molto fedeli all’opera originale, perché si ripromettevano di rappresentare quello che Verdi, Mozart, Wagner e così via avevano scritto. Ma un’operazione di questo genere non diventa necessariamente ripetitiva o monotona, perché le indicazioni che dà un testo per quanto riguarda l’ambiente sono sempre piuttosto vaghe. Se si trova scritto «la scena si finge in Venezia» ci si può legittimamente domandare «quale Venezia? quella di Tintoretto, quella di Tiziano, quella di Renoir, quella di Emilio Vedova?» La seconda strada è quella di creare uno spettacolo di totale invenzione, che in certi casi può anche riuscire gradevole. Ricordo molto bene un Don Pasquale di Donizetti con la regia di Menotti, che è un grande uomo di teatro: lui anziché nel primo Ottocento l’aveva ambientato nell’Italia del 1920, cioè all’inizio del fascismo. Ernesto veniva in scena in camicia nera, come si usava appunto in quegli anni sciagurati. Questa pratica è molto in voga in certi teatri tedeschi e degli Stati Uniti (non certo i più importanti), che hanno un vero e proprio furore inventivo, cercano di escogitare sempre qualcosa di nuovo. Evidentemente a loro non piace l’opera tradizionale e tentano di crearne un’altra. Non so quale sia la liceità morale di tutto questo, perché se io fossi un compositore non vorrei che mi cambiassero o eliminassero né una nota né una virgola. Ma il più delle volte i compositori sono morti. Se si guardano i manifesti degli spettacoli, si può facilmente vedere che spesso il nome del regista è riportato più in grande rispetto a quello del direttore d’orchestra. Ma per imparare a dirigere un’orchestra ci vogliono molti anni di studi accaniti, mentre sovente i registi sono sbarbatelli che hanno messo per cantiere regia Così Kantor riassumeva la propria ricerca di un’azione teatrale che fosse efficace, viva, tanto reale quanto antirealistica, tanto palpitante quanto non mimetica. Articolava in modo personale ciò che altri maestri del Novecento teatrale avevano seppur diversamente detto, togliendo al teatro la funzione di rappresentare e riprodurre la realtà, divenendone copia, e lavorando piuttosto sul suo essere cantiere regia — 35 la prima volta il piede in palcoscenico. Eppure godono di un notevole credito. Probabilmente a molti piace veder camuffare la cose, trovando comico, divertente, umoristico cambiare i rapporti affettivi tra i personaggi. Facendo un paragone tra regia lirica e regia di prosa la seconda è innegabilmente più facile, per la semplice ragione che non ha di fronte il problema del tempo, inteso come ritmo. Il regista operistico deve tenere conto che le battute e le note sono quelle, e non può prolungare i movimenti. Dovrebbe quindi, almeno teoricamente, conoscere la partitura. La mania di fare delle «controazioni» disturba terribilmente: costruire un’azione principale in primo piano e un’azione secondaria dietro fa sì che l’attenzione dello spettatore venga distolta, perché questi cerca di comprendere anche la seconda, e nel frattempo, con ogni evidenza, non può seguire la musica. Ricordo un Don Carlos allestito a Roma da Luchino Visconti: mentre in proscenio i personaggi cantavano, dietro passeggiavano dei levrieri tenuti a guinzaglio. Queste meravigliose bestie, così ben tenute, attiravano molto di più l’attenzione dell’orrido soprano che cantava in quel momento: meglio un cane bello che una donna bruttissima… Ma il Don Carlos non è la storia di un gruppo di levrieri. Sandro Cappelletto Robert Carsen Qualsiasi regia racconta una storia già scritta. Pertanto ognuno le storie le traduce sottolineando certi aspetti piuttosto che altri e, in tutta sincerità, quando affronto un testo creo una visione, una prospettiva narrativa che rispecchi la mia personale concezione per cui un Teatro non è un Museo. Anzi un Teatro è un luogo dove lo spettatore può interagire con quanto viene presentato e capire che la storia riguarda personaggi non così dissimili, per sentimenti pensieri e azioni, all’umanità d’oggi. Pertanto una regia esprime un punto di vista che non potrà piacere a tutti, certo, ma che avrà la valen- cantiere regia Se don Giovanni abita nel Bronx e indossa i jeans; se Wotan ha il doppiopetto, il fax e il Lap-top e il Walhalla è l’ultimo piano di un grattacielo del potere; se il san Francesco di Olivier Messiaen predica agli uccelli che lo ascoltano zampettando dalle braccia di una croce formata da monitor dove appaiono proiezioni di videoclip ornitologici; se Nerone e Poppea si amano di fronte a un Colosseo tra- sintesi in tempo reale tra suono, canto, azione, tempo e spazio scenico, che rappresenta la vitalità incorrotta dell’opera, giunta ormai al suo quinto secolo di vita. Scriveva Virginio Puecher al tempo della prima rappresentazione di Hyperion di Bruno Maderna, alla Biennale di Venezia del 1964: «Dal primo abbozzo che Maderna mi descrisse scaturì subito, urgente, determinante, la necessità che un altro che non fosse lui credesse nelle stesse cose, credesse innanzitutto nel valore di operare insieme in vista, ai margini, di un prodotto che ne fosse la conseguenza umana e artistica… L’insieme che ne è risultato, l’opera, è qualcosa di prematuro, forse, di spigoloso, di schematico. Ma ha il valore per noi di un alfabeto nuovo, di cui saremmo orgogliosi di aver almeno inventato la lettera a». Puecher considera «l’opera» non un opus preesistente e definitivo che richiede semplicemente di essere riprodotto, ma un insieme che trova la sua vera vita, il carattere, soltanto nell’invenzione scenica. La prima, la successiva, la giusta, la sbagliata, l’ennesima, e viva. sformato in sfascio di auto rotavate; se Madama Butterfly muore su una scena spoglia, inondata da una luce di ghiaccio, così incongrua alla sua Nagasaki. Nella storia della lirica, il secolo scorso e l’attuale saranno ricordati, anche, come il periodo che ha reso protagonista il regista d’opera, una figura professionale che appare, con stabile dignità di presenza nella locandina, verso la metà del secolo scorso e tanto più dilata il proprio margine creativo quanto più i cartelloni diventano ripetitivi, centrati sui titoli del repertorio: si chiede allora allo sguardo del regista di introdurre elementi di novità, di rilettura, di provocazione e proposta, talvolta di illuminazione di quel complesso sistema drammaturgico che è un’opera lirica. «Il regista d’opera? È servito a prolungare l’agonia del melodramma per altri cinquanta anni»: la battuta di Luca Ronconi è celebre almeno quanto la replica di Franco Zeffirelli: «Certo lui ha fatto di tutto per accelerarla, questa agonia». Già Theodor Adorno indicava la centralità del problema: «La permanente crisi dell’opera si è palesata ormai come crisi della rappresentabilità delle opere». Il filosofo della musica raccoglieva le estreme riflessioni wagneriane sulla possibilità stessa per l’immagine sensibile – la scena, i costumi, il gesto attoriale – di dare degno contenuto narrativo all’indipendente e autonomo sistema di segni contenuto in una partitura per orchestra e voci. La «scena invisibile» immaginata da Wagner, insoddisfatto dai primi allestimenti delle sue opere, nei quali ogni soluzione registica gli appariva riduttiva rispetto alla profondità delle connessioni e degli sviluppi musicali, diventava così un’ipotesi sensatissima, che lascia alla profondità delle immagini, invisibili appunto, schiuse al pubblico dall’ascolto e dalla sua memoria il compito di una degna rappresentazione. Eppure, è al regista che ancora si chiede di compiere quel lavoro di za di far incontrare concettualmente le persone. È necessario che ci sia la volontà e il coraggio di confrontarsi con il nuovo, questo è alla base dell’arte come lo è il tentativo continuo di avvicinarsi al divino. Un aspetto questo che Wagner aveva capito molto bene, infatti aveva trasformato l’idea di teatro in una religione che permetteva di avvicinarsi al divino attraverso la musica. Non dimentichiamo che il teatro è capace di elevare l’uomo al di sopra delle piccolezze e delle banalità della vita quotidiana e l’opera, in particolare, attraverso l’alchimia del libretto (l’intelletto) e della musica (l’emozione) aspira a sfiorare il divino. Quindi perché viva questo connubio occorre la disponibilità di mettersi in discussione, di non vivere il teatro come un museo ma come un luogo dove riscoprire e rivivere storie che conosciamo da sempre ma da un altro punto di vista, sotto una prospettiva inedita. Giancarlo Cobelli Nel mio metodo di lavoro credo di non essermi mai posto il problema della differenza tra uno spettacolo di prosa e uno d’opera. Il mio approccio è identico in entrambi i casi. Certo la lirica stilizza di più, perché c’è la musica, c’è il canto che conduce il pensiero lontano. Parto sempre dal perché nasce un testo, e questo spiega anche le mie scelte, che hanno sempre cercato di privilegiare le opere e i compositori più stimolanti, come per esempio Prokoviev e Berlioz, che mi mettono con le spalle al muro e con i quali ingaggio una sfida sempre nuova. La meraviglia del teatro lirico sta nel rendere il canto accessibile e naturale agli spettatori, un po’ come se i protagonisti parlassero. La cosa più importante è avere un concetto chiaro da cui partire: la storia deve uscire con evidenza. È questo che 36 — cantiere regia interessa il pubblico, e il teatro si fa soprattutto – o soltanto – per il pubblico. Il resto è un pastrocchio, con scene zeppe di oggetti e figure ridondanti, che finiscono per occupare totalmente l’attenzione degli spettatori. Mi piace la rarefazione: quando affronto un’opera desidero entrare dentro un mistero. Amo l’esoterismo, di cui il teatro è certo sede privilegiata. Cosa può interessarmi vedere cento ballerine che danzano ciascuna con il proprio cestino di fiori? Così si confonde l’opera lirica con un magazzino, si rende tutto brutto e volgare, affollato e costosissimo. Amo più di tutto la sintesi. Quando mi dicono che non si può fare teatro perché mancano i soldi dentro di me penso sia un momento benedetto: basta con l’accumulo esteriore e con la superficialità. La scoperta di Prokofiev, con la messinscena dell’Angelo di fuoco, per me è stata fondamentale, perché piano piano, un passo alla volta con un’enorme fatica, sono riuscito a capire cosa volesse dire l’autore. Perché se non si capisce cosa vuol dire un’opera, di qualsiasi tipo essa sia, cosa si può dire al pubblico? Se non hai compreso un testo, una partitura, allora riempi il proscenio di attrezzerie e sontuosità, fai volare le aquile a teatro. È il trionfo dell’iperbole, che considero un segno di stupidità. Mariano Dammacco Emma Dante Premetto che finora non ho mai fatto un lavoro di regia di un’opera musicale e non ho quindi gli elementi per poter fare un ragionamento completo sull’argomento ma posso immaginare un inquadramento, un percorso attraverso il quale certamente mantenere una coerenza, una coincidenza con la contemporaneità, col presente. Se da un lato ritengo necessario dare a un’opera la sua giusta collocazione nell’epoca in cui si propone, nello stesso tempo è importante non snaturarla. Cominciando a lavorare su Carmen mi sono resa conto, nell’approccio con l’elemento «costume», che era importante, in primis, mantenere la radice simbolica del personaggio, rivisitando e interpretando il suo costume senza snaturare la sua profonda natura. In questo modo non si perde la fonte, l’origine, ma nello stesso tempo si interpreta l’opera senza però imitarla. Questo accade anche con la messinscena di un testo classico, imitare Amleto, oggi, non serve più a nessuno, provare a interpretarlo, invece, ci farebbe ritrovare la necessità di ascoltare la sua disperazione. Carmen è viva soltanto se rinasce ogni volta, se ritorna vergine ad ogni amplesso e soprattutto se muore per sempre nel momento in cui il coltello le trapassa le viscere. L’opera monumentale che si ostina a rimanere, rischia di essere imitata, di mummificarsi nel corso della storia, di congelare la musica e il suo movimento. Credo, infine, che la regia di un’opera la faccia la musica con il suo cantiere regia Ho avuto la possibilità di cimentarmi con la regia d’opera grazie al Circuito Lirico Lombardo che mi ha affidato la messinscena del Così fan tutte di Mozart nel 2007 e del Don Pasquale di Donizetti nel 2008. Queste due esperienze sono state per me una grande occasione di crescita professionale, artistica e personale, peraltro all’interno di un ambito molto differente da quello in cui ho quasi sempre lavora- scagni realizzato da Federico Tiezzi. Penso che ci siano oggi i presupposti per inoculare nel teatro musicale il germe di un vero lavoro teatrale organico che non sia limitato alla ricerca di una veste per uno spettacolo musicale. to, ovvero il cosiddetto Teatro di Ricerca. Così, da ultimo arrivato, cerco di rispondere alla domanda posta. Mi sembra che il lavoro di regia del teatro musicale si nutra della contemporaneità soprattutto attraverso un potenziamento tecnologico degli strumenti di lavoro tradizionali: si considera primario l’aspetto scenografico e visivo e oggi si può curare tutto questo con strumenti sempre più raffinati: grazie alla tecnologia le installazioni scenotecniche possono ora muoversi da sole, con dei motori, senza un evidente intervento umano; oppure si possono sovrapporre all’azione sulla scena degli inserti video sempre più elaborati, in tal senso ricordo la bellissima messinscena di Tosca di Puccini firmata da Hugo De Ana. Questa è una strada sicuramente vincente che offre allo spettatore effetti e suggestioni. Credo però che, accanto a questa sorta di aggiornamento e potenziamento tecnologico degli elementi tradizionali della regia d’opera, si possa investire in una politica artistica di nutrimento del lavoro del cast con le acquisizioni tecniche novecentesche del lavoro di regia e d’attore. Penso si debba coinvolgere il cast in una analisi approfondita del testo, nel caso dell’opera dell’aspetto musicale prima ancora che del libretto. Credo si debbano offrire agli interpreti gli strumenti per un lavoro dettagliato sul proprio corpo, sulla propria gestualità, sulle intenzioni del personaggio da interpretare, sulla relazione con gli altri personaggi e lo spazio scenico, insomma sul loro lavoro di attori. Tutto questo può portare a liberare i corpi dei cantanti da quelle rigidità fisiche o da quei deficit di espressività, non tanto dettati da esigenze di postura e respirazione indispensabili al canto, quanto da uno studio dell’arte scenica forse sottovalutato e antiquato. Anche il contributo delle cosiddette masse, dagli artisti del coro ai mimi, può arricchirsi dell’esperienza di attori, danzatori e coreografi: un pregiatissimo esempio è, in tal senso, il lavoro di messinscena dell’Iris di Ma- ritmo e i suoi silenzi, con la sua aria sonora che riempie i vuoti e viene risucchiata dal respiro dei personaggi. Hugo De Ana La regia dell’opera lirica risente della contaminazione che connota il mondo in questo momento, in tutti gli ambiti. L’arte è un prodotto della società e rispecchia quello che succede al suo interno. Non soltanto il cinema o il teatro di prosa rappresentano le problematiche attuali: anche nell’opera lirica, e anche quando si lavora con un soggetto che appartiene a un altro periodo storico, si possono utilizzare degli elementi attuali per cercare di avvicinare il più possibile la storia allo spettatore. In questo momento il teatro di prosa, l’opera lirica, il balletto, insomma tutte le arti sono interessate da una grande contaminazione. Le performance, che sostituiscono ad esempio le mostre di pittura, non hanno niente a che vedere con quello che la gente può pensare sia il lavoro di un pittore accademico o non accademico, che lavorava con la tela e in uno spazio che oggi non esiste più. La nuova tecnologia, oggi, sta cambiando completamente il mondo dell’opera e della rappresentazione in generale, così come tanti spettacoli, tanti film sono caratterizzati anche da una grande contaminazione operistica. In questo momento è tutto molto mescolato, come fosse una grande pentola in cui tutto si mischia, ma in cui tutto serve. L’importante è che lo spettatore possa apprezzare il risultato. Credo che l’elemento essenziale sia condurre un lavoro di approfondimento molto accurato sulla musica, sul soggetto e sulla verità di ogni personaggio, sulla sua carne, la sua polpa, il suo sangue... Il fatto che si esprima cantando non vuol dire che si tratta di un perso- cantiere regia — 37 naggio di cartapesta. Il lavoro da svolgere nella regia non è né quello di conformare filologicamente i costumi all’epoca né, al contrario, sceglierne necessariamente di contemporanei. Non sta qui la modernizzazione di un’opera. Più di tutto è importante indagare in profondità il rapporto che esiste fra la musica, la storia e i soggetti coinvolti. Credo che il lavoro registico debba puntare, innanzitutto, sui personaggi, per farli vivere e per renderli veri; e oggi ci sono molti cantanti giovani che aiutano assai i registi ad approfondire questo nuovo modo di vedere l’opera. Penso che, in un modo o nell’altro, quasi tutti i registi contemporanei, al di là delle possibilità offerte oggi dalla tecnologia, puntino soprattutto a trovare una verità conducendo un lavoro di ricerca con i cantanti. E questo mi sembra il punto più importante da sviluppare anche nel futuro. Gianfranco De Bosio Fortunamtamente l’arte non ha una ricetta precostituita. La cosa importante è che quello che arriva sia qualcosa in grado di trasportare in una dimensione musicale, che permetta di vivere l’esperienza artistica più col cuore, con le emozioni, con la pancia che con l’intelletto. Questa è la cosa interessante del teatro musicale: vivere il teatro come se si stesse ascoltando un brano musicale. Al giorno d’oggi il teatro patisce un po’ l’esser divenuto vecchio, un luogo dove la riproduzione dei grandi drammi della storia e dell’essere umano ha perso quella forza propulsiva originaria per diventare mera ripetizione, qualcosa di un po’ noioso e di un’intellettualità media. L’intellettualità alta, invece, è qualcosa di più leggero e libero come ad esempio quella di un bambino. Se pensiamo all’opera odierna, si tratta di una forma assolutamente conservatrice per quel che riguarda il libretto. Ma io credo che il rispetto possa tranquillamente implicare la negazione: non credo che il rispetto di un’opera implichi la totale fedeltà al libretto. Nel mio lavoro, sono più rispettoso nei confronti della musica, dove c’è una composizione che va oltre il tempo e la contingenza. Il libretto invece spesse volte è stato fatto in un periodo dove ad esempio ancora non c’era Silvio Berlusconi, in un periodo in cui i mostri erano altri. A questo punto l’arte deve sempre saper valutare i tempi, e anche quando si riproduce qualcosa che appartiene al passato non ci si deve limitare a una riesumazione di cadaveri. La musica non ha tempo: posso sentire la musica del Settecento, quella del Barocco, Frank Zappa, ecc. Nel teatro musicale la cosa fondamentale è il farsi trasportare in un non-tempo. Bisogna certo avere una predisposizione mentale, ma non necessariamente essere colti: forse l’essere più liberi da certi schemi, saper ascoltare i silenzi. Oggi c’è una grande paura del silenzio. Nella mia Menzo- cantiere regia L’impostazione del quesito mi sembra un po’ teorica. In realtà le principali differenze tra lirica e prosa, per quanto riguarda la regia, sono di carattere tecnico: nella lirica il regista non è l’artefice dello spettacolo, ne forma parte insieme ad altri artisti. I protagonisti veri di un’opera sono – oltre naturalmente al musicista – il direttore d’orchestra e i cantanti principali. Nella prosa l’autore non ha il peso definitivo che ha il musicista nell’opera. Sul testo scritto il regista ha la possibilità di un lavoro personale molto più forte. Nella musica al contrario questa personalizzazione è impossibile. Se si prende ad esempio una qualsiasi aria, ci si rende subito conto che i tempi sono quelli, e le variazioni ritmiche le decide il direttore con i cantanti. Il regista può, se è buon amico del direttore o degli interpreti, ottenere dei consensi o dell’aiuto. Ma non può cambiare la struttura musicale, Pippo Delbono il ritmo. Quando il musicista è vivente poi, è lui che ha l’ultima parola. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Azio Corghi al suo Gargantua, che è stato un successo clamoroso, anche grazie alle scenografie di Luzzati: in quell’occasione il musicista era sempre con noi. In casi come questo il regista può dare una personalità alla messinscena, e venire ricordato più del direttore d’orchestra. Ma se ripenso al mio allestimento del Ballo in maschera a Vienna, con Abbado e Pavarotti, non posso non riconoscere che – anche se la regia era interessante e la scenografia l’aveva firmata ancora Luzzati – il vero protagonista era Abbado. La regia d’opera è costretta a un ruolo marginale di per sé, anche se ci sono alcune fortunate eccezioni. Affrontare Shakespeare o Cechov in un certo senso è diverso, anche perché sono opere molto rappresentate, e quindi l’interesse del pubblico non si rivolge al testo ma al modo in cui viene messo in scena e interpretato. Questo può accadere anche nella lirica, ma c’è sempre il filtro della musica, e dunque del direttore d’orchestra. Una maggiore libertà la si può ottenere nel caso di regie cinematografiche, cioè di opere filmate che diventano veri e propri lungometraggi. In questo caso il regista torna a essere protagonista, sceglie le inquadrature e gli ambienti, mentre il cantante non ha l’obbligo di seguire il direttore d’orchestra, ma solo di andare in sincrono con le immagini. Quanto poi al problema dell’attualizzazione, che vede estimatori e detrattori, io credo che il punto discriminante sia la qualità artistica della regia. Ho visto spettacoli «moderni» magnifici e altri inutili e pretestuosi, e la stessa cosa si può dire delle rappresentazioni in stile classico. Quando l’attualizzazione diventa routine, come accade ora in Germania, diviene convenzionale come una rappresentazione «storica». gna, ad esempio, c’è tutta una prima parte di silenzio che è assolutamente una musica: silenzio vuol dire musica! Certamente più difficile da ascoltare. Senz’altro sa ascoltare meglio il silenzio una persona che vive su una montagna piuttosto che uno che, pur intelligente e colto, vive nel frenetismo di una città in cui il silenzio sarebbe solo fonte di angoscia. Il teatro è sempre musica ed è sempre ritmo. La menzogna è uno spettacolo fortemente politico ma tutto costruito come una coreografia e come un’opera. La musica mi è assolutamente amica nell’aiutarmi a dire ciò che voglio dire. Non ci sono regole. Bisogna avere passione, amore, bisogna essere liberi dalle analisi del cervello e della mente. Ascoltare la musica nelle cose, con gli occhi e con lo stomaco. Io concepisco il teatro sempre come una musica e come ritmo. Anche nei dipinti c’è musica, e anche quando guardo Picasso la vedo! Guido De Monticelli Nel 1926, a una prova di lettura del Revisore di Gogol’, Mejerchol’d diceva ai suoi attori: «Noi siamo qui attorno al tavolo per raggiungere una nuova risonanza del testo. Se c’è una nuova messinscena, una nuova situazione, ma il testo ci suona ancora vecchio, questo significa versare del vino nuovo in un otre vecchio. Devono risuonare nuove tonalità, nuovi ritmi. Deve esserci un atteggiamento nuovo verso tutte le parti. […] Noi non vogliamo fare gli originali. Fino ad oggi un personaggio l’hanno fatto rosso e noi lo facciano nero, una biondina la facciamo assolutamente castana. Queste sono inezie. Noi ci attacchiamo a queste cose solo per toglierci da un punto morto. Io amo molto questo testo, ma incomincio a odiarlo, vedendo come procede il nostro lavoro». Da sempre i grandi interpreti si sono trova- 38 — cantiere regia ti a dover lottare con il materiale che trattavano, a disseminare il loro cammino di ostacoli, di impedimenti, di ribaltamenti, che a prima vista suonavano ai più come gratuite eccentricità: in realtà lo facevano per togliersi da un punto morto, per scuotersi da una serie di «tradizioni» stratificatesi via via nella storia, e a tal punto incrorostatesi da rendere quasi indistinguibile l’opera dall’«otre vecchio» che la conteneva. Diciamo la verità: gran parte di quegli «impedimenti», di quei fertilissimi ostacoli stanno scritti, nel caso dell’opera lirica, proprio nella partitura, nella quale i ritmi sono dettati in maniera assai più perentoria di quanto non accada in un copione di prosa. E come suoni il testo lo si può sentire fin dalla prima «prova di sala». Ed è proprio dalla relazione intensa e non scontata con quegli elementi, con quelle «costrizioni», che nascono le visioni più vive, capaci di liberare il vino nuovo dall’otre vecchio. In questo senso non ho mai capito – confesso – l’eterna querelle che oppone i sostenitori dell’innovazione più spinta a coloro che propugnano i valori della fedeltà e della «tradizione». Mi sembra chiaro che ogni operazione che, in nome di una pretesa tradizione, si esaurisca in una forma, sia pure raffinata, di illustrazione, non possa che condurre a quel punto morto da cui ogni «artista sincero» sente di doversi scrollare. Quanto alla gratuità di certe forme di eccentrismo, basta la musica, col suo procedere inesorabile e indifferente, a svelarne – nel caso – l’inanità. Il fatto è che ogni qual volta appare in teatro un’interpretazione realmente innovativa, di quelle destinate a lasciare il segno, essa si manifesta immediatamente anche per la sua «necessità». Una necessità nuova, in cui l’opera si rivela in una luce inedita, ma nella quale ci troviamo avvolti da una strana, stupefacente forma di «inevitabilità». Come a dire: «È chiaro, è così, non poteva essere che così!». Noi sap- Certo: il regista di prosa è più libero e più solo. Ma allora dovremmo chiederci come mai i grandi maestri della scena, coloro che la regia la inventarono nei primi decenni del Novecento, dichiaravano di nutrire per i loro fratelli d’arte, i cantanti, i danzatori, i musicisti, un sottile senso di invidia. Era proprio la nostalgia di uno spartito, di una grammatica, di un linguaggio comune, di un «solfeggio» di cui l’attore, nel silenzio del suo testo, non poteva disporre. E allora, oltre a utilizzare la musica come formidabile strumento di pedagogia per l’attore, impegnarono la loro ricerca a costruire quel linguaggio, a porre «limiti» alla loro libertà. Contraintes, li chiamava Jacques Copeau, per il quale la dote più preziosa di un regista era la dote dell’ascolto. Attraverso di essa ci si poteva accostare alle Fourberies de Scapin come a uno spartito musicale, scoprendoci un mondo di suoni, il ritmo strascicato dei passi di Molière, gli scorci sfuggenti del suo corpo e del suo volto, il rapido ansimare maramaldesco del suo respiro. Più «obblighi», forse, ma quanta più «musica» da scoprire! Se è a questa forma di ascolto a cui ci allena il teatro in musica, allora sarà sempre ricco dei più preziosi insegnamenti e delle più sorprendenti scoperte. piamo che fino ad ora non è mai stato esattamente così e che potrà un giorno anche essere diverso, ma siamo colpiti – ed è questa, forse, la fonte più vera della nostra emozione – da quanto quell’interpretazione è stata in grado di cogliere, di strappare, potremmo dire, e di rivelarci, la «musica» che era in noi. Di quel ritmo che unisce attore e spettatore Mejerchol’d diceva che era «tempo incantato». Ed è davvero qualcosa che concerne ogni forma di teatro, in musica o in prosa, poiché ogni forma di teatro, nel momento in cui si compie, su un palcoscenico, davanti a una sala di spettatori, è per sua natura, e non può non essere, un atto di contemporaneità. Ogni epoca, attraverso i suoi interpreti e il suo pubblico, trova il suo «tempo incantato», che s’incardina insensibilmente nel tempo vivo da cui scaturisce. In questo senso penso allora si possa affermare che ogni nuova interpretazione di un’opera (di musica o di prosa) è – al suo meglio – un atto di rinnovata, profonda, aderenza a quell’opera, un atto che ce la rivela di nuovo, sorprendentemente. Ma è poi realmente paragonabile il lavoro di un regista di prosa e quello di un regista alle prese con un’opera lirica? Apparentemente il regista di prosa è molto più libero: può disporre del testo come meglio crede, può adattarlo, ricomporlo, tagliarlo, rendendolo organico all’operazione che condurrà assieme ai suoi attori. E la «musica», il ritmo attraverso cui «suonerà» il testo è appannaggio suo e della sua compagnia. Mentre il regista d’opera, che se ne fa della sua spiccata personalità, di tutte le sue idee, della sua nuovissima concezione, se poi la musica continua, ostinata e imperterrita, a seguire il suo corso? E poi vogliamo finirla di identificare la regia lirica con l’allestimento e tutt’al più la movimentazione dei cantanti? E allora vedremo che, nell’accezione più ampia e accettabile di regia, dovremo, a pieno diritto, coinvolgere ciò che ne è in fondo il motore primo: la direzione d’orchestra. to. Fatta com’è essenzialmente di un codice grammaticale — la notazione — che contiene indicazioni esecutive di gran lunga più prescrittive rispetto alle altre componenti che essa stessa ingloba (quella letteraria anzitutto, ma anche tutte le dimensioni sceniche), la partitura musicale ha infatti caratteri di definizione molto superiori a qualsiasi testo solo verbale. Dunque, il regista si trova a doversi misurare con una realtà drammaturgica ben più complessa e strutturata (proprio in quanto ben più cogente) di quella del teatro di parola. Nato come operazione interpretativa intesa a far emergere il profondo dei testi e a renderlo palese al pubblico, il cosiddetto «teatro di regìa» negli ultimi decennî è stato spesso vittima di quella deriva arbitraria e superficiale di cui dicevo. Come nei confronti del patrimonio edilizio, a mio avviso bisogna distinguere con fermezza gli àmbiti d’intervento: evitare le manomissioni — anche geniali — del patrimonio storico, esercitare invece una più ampia libertà inventiva solo su prodotti totalmente nuovi. Se è vero che la dimensione performativa, in quanto estemporanea ed effimera, non ha certo la materialità di un manufatto concreto, è però indubbio che nel momento in cui una musica viene riproposta essa ci si presenta come analoga a qualsiasi altra opera d’arte, anche se intangibile. È all’atto della sua riproduzione sonora che essa si realizza nella sua pienezza, quello è il momento in cui l’ascoltatore/spettatore ne percepisce la concretezza sensibile: dunque, di fatto, la sua transitoria ma non meno reale esistenza. In tali occasioni, menomarne l’integrità o manometterne i connotati equivale a sfregiare un dipinto: il danno non sarà stabile per l’opera, ma per la sua percezione nella memoria dell’ascoltatore/spettatore sì. L’unico compito del regista, di fronte a un’opera del passato, è secondo me quello di «leggerla» per lo spettatore di oggi, e farsene tramite puntando alla sua sostanza, senza però tradirne la lettera. In Paolo Fabbri cantiere regia La regìa d’opera corre oggi pericoli soprattutto a causa dei registi, che molto spesso sembrano operare incuranti o addirittura a dispetto dei testi, e accarezzare l’idea di presentarsi come co-autori che li reinventano. È proprio a contatto con un teatro a forte testualità come quello d’opera che il ruolo del regista risulta invece particolarmente delica- cantiere regia — 39 cosa consista tale sostanza è la vera sfida per tutti noi, e su di essa dovremmo concentrarci tutti. Scrivendo nel 1807 a Giovanni Simone Mayr (il più celebre compositore d’opera italiana dei suoi tempi), la famosissima primadonna Teresa Giorgi Belloc non si attribuiva «altro merito, che di passabilmente eseguire la divina Sua musica. Il merito e la gloria d’un bel fabbricato appartengono esclusivamente all’architetto, e l’operaio non c’entra che per la fatica del Suo dorso». Dunque, in quanto interprete lei poteva ambire al massimo al vanto di efficace esecutrice di volontà creative altrui, non certo arrogarsi i titoli di una qualche fasulla co-autorialità, e men che meno pretendere di saperla più lunga dell’autore. C’era un edificio — l’opera —, c’era chi l’aveva inventato e progettato. Solo dopo venivano tutti quelli chiamati a realizzarlo: a suon di «fatica» del loro «dorso», certo, ma anche — possiamo aggiungere noi, derogando dall’understatement della Belloc — grazie alla loro intelligenza, sensibilità, acume ermeneutico. Il tutto fondato, sempre e comunque, sull’indispensabile conoscenza storica. Ivan Fedele Siro Ferrone È economicamente e esteticamente immorale il livello dei cachets dei registi d’opera. Soprattutto se misurato con i livelli di altre retribuzioni teatrali e artistiche nel campo variegato dello spettacolo. Lo stesso si può dire a proposito degli scenografi e – perché no – dei cantanti? Ma nel caso dei registi, la questione si pone in termini an- cantiere regia Non si può parlare della regia di un'opera di teatro musicale in astratto, prescindendo dalla considerazione delle qualità che l’opera stessa dovrebbe possedere per proporsi ad un ascolto che ne possa cogliere il senso attraverso i suoni e i segni. Pur nella varietà degli stili, degli intenti, delle diverse declinazioni e al di là delle facili tentazioni convenzionali e/o «scandalistiche», mi sembra che queste qualità siano, in fondo, quelle di sempre: dimensione narrativa, originalità dello stile, fondamento archetipi- ra. Dipende dalla persone e dalle personalità, naturalmente. Quello che io chiedo ad un regista (tanto quanto a un direttore d’orchestra o a un solista) è che «interpreti» l’opera e non si limiti a confezionarla professionalmente, secondo formule stereotipate, seppur efficaci. Questo implica, da parte loro, un approfondimento del testo che va al di là delle note della partitura stessa, in quanto necessita di uno scavo in profondità dal quale l’interprete deve portare alla luce le assonanze che scopre tra l’opera e la sua sensibilità. Se ciò avviene non c’è rischio di travisamenti, anzi, la musica può solo arricchirsi di senso. Io auspico tante e differenti regie di una mia stessa opera. Ne sarei felice. Vorrebbe dire che avrebbe stimolato diverse soluzioni e trovato altrettante assonanze. Non esiste un solo modo di dire una cosa! La ricchezza e varietà d’interpretazioni è un valore assoluto per l’arte. Ma poichè sono rari, quasi inesistenti, i registi che sappiano leggere una partitura, spesso la messa in scena è estemporanea, o, peggio ancora, preconcetta (cioè «concepita prima» del contatto con la musica e, quindi, a priori) risultando così un universo a parte, impermeabile alle esigenze della musica stessa. Diciamo la verità: a quante regie di questo tipo abbiamo assistito? Tante, direi, troppe! co e forte impatto emozionale (e non semplicemente o banalmente emotivo). Si tratta, alla fine, di «rappresentare» qualcosa, e queste qualità sono indispensabili affinché un’opera possa avere la possibilità di «arrivare» a coloro che la ascoltano e vedono. Per il resto confidiamo nel talento di chi la scrive e di chi la suona perché, sennò, tutto sarebbe vano! Ma ci sono anche delle qualità che il pubblico dovrebbe possedere affinché quest’unione possa verificarsi: curiosità, libertà dal pregiudizio, vero amore per la musica e il teatro musicale, apertura (anche critica, certo!) a nuove interpretazioni dell’opera d’arte. La curiosità è ormai un’attitudine in via d’estinzione. Non parliamo poi dei pregiudizi che, nella vita in generale, contaminano la nostra esistenza e la relazione tra gli uomini. Per quanto riguarda poi l’amore vero per l’opera musicale in generale, quella che in genere chiamiamo «passione» per la musica, questa non può prescindere da un interesse sempre rinnovato per il nuovo che si affaccia all’orizzonte. Ma a questo sentire e vivere l’arte con curiosità e interesse si sta via via sostituendo un atteggiamento feticistico, da una parte, e un disincanto un po’ cinico, dall’altra. Non è qui il luogo per farne un’analisi sociologica, ma è una considerazione che mi sembra condivisibile, un dato di fatto sotto gli occhi di tutti. E veniamo alla domanda vera e propria che riguarda il rapporto tra la regia e la partitura che deve essere messa in scena, perché, ricordiamocelo, la musica resta e le regie passano… In realtà si tratta del rapporto che s’instaura tra il compositore dell’opera (vivente o non) e colui che si assume il compito fondamentale di metterla in scena. Questo rapporto compositore-regista può essere di diversa natu- che più gravi poiché – e parlo per le esperienze personali vissute da spettatore o da analista-testimone – il carattere esornativo o autoreferenziale della regia è già di per sé uno spreco intollerabile nella maggioranza dei casi. Rari gli esempi di interpretazioni/allestimenti necessari. Spesso si contrattualizzano registi solo per il loro presunto «nome», perché – si dice – il pubblico «alla moda» li richiede. Sono proprio i segni della decadenza di un’arte che si è fatta tanto tautologica e autoreferenziale quanto accecata dal suo isolamento dal resto della società. Sarebbe necessario imparare a costruire spettacoli e cartelloni di costo minore e trarre dalla condizione di necessità gli stimoli per «inventare». Mezzi minori non significano una minore forza creativa. Anzi, credo proprio che dallo stato di necessità potrebbe derivare un abbassamento della presunzione egocentrica che finisce spesso per sopraffare la drammaturgia musicale. Ci si dovrebbe dedicare meno alla conciliazione delle necessità inderogabili dei cantanti con le necessità inderogabili dell’assetto scenico in cui si rispecchia il narcisismo dei registi e pensare piuttosto a una subordinazione degli uni e degli altri alle ragioni della drammaturgia. Il problema è che la drammaturgia è come la costituzione democratica: dovrebbe regolare i rapporti dei diversi cittadini del palcoscenico, ed è invece un semplice regolamento condominiale che serve a far convivere interessi solo corporativi. Cesare Fertonani Il teatro musicale è un prodotto collettivo molto complesso, che si fonda sulle relazioni e sull’interazione di diversi linguaggi, ciascuno dotato di proprie capacità semantiche ed espressive (parola, musica, azione, gestualità, scenografia, danza). Riflettere sulla regia, oggi, 40 — cantiere regia significa dunque toccare nel vivo i problemi che riguardano la prassi del teatro musicale. Credo che, prendendo le mosse dalla realtà incontestabile del teatro di regia anche in ambito musicale, si possano intanto identificare, in linea di principio, due estremi entrambi inaccettabili: da un lato, una regia che si limita a seguire pedissequamente le indicazioni e didascalie contenute nel libretto – ed eventualmente anche nella partitura – intendendole in senso rigidamente prescrittivo (cosa peraltro ormai rara giacché nega l’idea stessa del teatro di regia); dall’altro, una regia che tende di fatto a ignorarle nella lettera come nella sostanza drammatica. Nel primo caso si avrà uno spettacolo «pulito» e «scrupoloso» nei confronti delle presunte intenzioni degli autori, forse non privo di certo garbo ma presumibilmente piatto e poco interessante dal punto di vista drammatico (peccato comunque non veniale, questo, specie in un’epoca in cui il teatro d’opera rischia sempre più di sclerotizzarsi, di fossilizzarsi in una nicchia museale che allontana il pubblico dei giovani anziché attirarlo). Nel secondo caso si avrà invece uno spettacolo magari di per sé affascinante, ma che ha poco a che fare con la sostanza, drammatica e musicale, dell’opera messa in scena: uno spettacolo di fatto autonomo, frutto per così dire della pura immaginazione creativa del regista e che potrebbe essere stato concepito per qualsiasi opera – o quasi. Nel mezzo, tra questi due estremi paradossali, tutto – o quasi – diventa possibile. Il teatro di regia è interpretazione e credo che oggi nessuno voglia metterne in discussione i presupposti e le ragioni culturali. E, come ogni interpretazione, la regia è un oggetto che va a sovrapporsi all’oggetto di cui si occupa, cioè l’opera da mettere in scena. Ma come ogni interpretazione che ambisca a essere, oltre che viva, fondata e dunque credibile – per non trascendere nel flagrante fraintendimento, nell’atto di arbitrio gratuito e violento – la regia deve considerare essenziali e irrinunciabili alcuni aspetti. Penso che Paolo Gallarati il più importante sia quello di affrontare con onestà intellettuale la drammaturgia musicale delle opere che si mettono in scena; in altri termini, la comprensione e il rispetto di un codice. Per ogni regista lo sforzo di comprensione nei confronti della drammaturgia musicale dell’opera che sta per mettere in scena dovrebbe essere il punto di partenza obbligato. E, com’è ovvio, perché questo sforzo abbia senso il lavoro registico deve aver assimilato almeno una certa conoscenza del contesto storico, musicale e culturale di cui le opere sono il prodotto. Non voglio assolutamente sostenere che sia inammissibile ambientare Così fan tutte ai giorni nostri, il Ring nell’orrore della guerra nella ex Jugoslavia o La traviata su una stazione satellitare nello spazio, al contrario: non importa che cosa si fa, ma come la si fa. Ciò che conta davvero è la capacità di analizzare un’opera a fondo per individuarne i nuclei cruciali dal punto di vista drammaturgico e musicale; e poi il lavoro di elaborazione creativa su questi nuclei, sui temi portanti e sugli snodi decisivi dell’azione con idee forti, inventive e coerenti sul piano tanto rappresentativo quanto narrativo: idee che sappiano rilanciare e rendere attuali i significati delle opere messe in scena. A tale proposito assai auspicabile è il coordinamento, come minimo, o ancora meglio la convergenza di intenti che dovrebbe stabilirsi tra i due maggiori responsabili nella realizzazione spettacolare dell’opera: il direttore d’orchestra e il regista. Gli allestimenti in cui la regia sceglie una via e la direzione musicale ne prende un’altra hanno, in genere, il fiato corto. E un ulteriore aspetto che mi pare molto importante per la regia nel teatro musicale è l’accurato lavoro sullo stile esecutivo, sulla recitazione e sulla gestualità attoriale dei cantanti; un lavoro troppo spesso trascurato, forse perché è faticoso, ingrato e richiede un tempo che durante le prove è raramente disponibile. tezza, in contrapposizione con l’interiorità del padre, pieno d’amore. In questa duplicità di corpo e anima, esterno e interno, consiste l’essenza drammatica del personaggio. Non è necessario vestirlo da giullare, con il costume a bande colorate e i campanellini sul cappello; ma non si può eliminare l’immagine del corpo sofferente che, attraverso la musica, definisce l’identità stessa del personaggio. Altro esempio. Trasportiamo pure Il trovatore dall’ambiente gitano del Quattrocento, che so io, in un accampamento di guerriglieri sudamericani: nulla andrà sciupato se Azucena, che ha perduto la madre e ucciso il figlio, sparandogli una pistolettata per errore, invece che bruciandolo nel fuoco, sarà pur sempre una creatura che con questi lutti è stata tagliata fuori dalle sorgenti della vita. Il fuoco, però, ci deve essere: sarà magari un rogo di pneumatici usati, invece che di fascine, ma non può mancare. La fiamma è l’immagine concreta di un’ossessione interiore, di un fatto passato, ma anche la sintesi dei due principi fondamentali che animano la vita drammatica e musicale dell’opera: fissità e mobilità. Toglierlo è impossibile. Quindi la libertà va esercitata nel rispetto dei rapporti essenziali che caratterizzano la vita dei personaggi, quella dell’ambiente e dell’azione drammatica. Molta importanza possono assumere alcuni oggetti. Nella Traviata, ad esempio, non si può rinunciare allo specchio che compare nel primo atto, quando Violetta scopre sul proprio volto dapprima un pallore presago, indi nell’ultimo, quando constata la trasformazione subita dalla propria immagine a causa della malattia. Non è indispensabile, si badi bene, la presenza dello specchio in quanto tale, ma è necessario fornire allo spettatore l’immagine dello specchiarsi, che si può ottenere anche con oggetti diversi, o con gesti allusivi, come, ad esempio, fingere di osservarsi guardando il palmo della mano. Quello che è importante è preservare la funzione che gli oggetti assumono al di là della loro qua- cantiere regia A teatro può accadere di tutto: allestimenti che trasportano l’opera in tempi e ambienti diversi possono apparire più fedeli di altri, scrupolosamente rispettosi dell’ambientazione originaria; così come succede che spettacoli cosiddetti tradizionali sembrino più nuovi, giovani e moderni di quelli basati sui logori luoghi comuni della pseudoavanguardia. La regia lirica ha un merito enorme: sviluppatasi impetuosamente dopo la seconda guerra mondiale, ha rinnovato un tipo di teatro polveroso, stereotipo e finto, salvandolo dall’estinzione. Oggi, però, si rischia di disamorare il pubblico con elucubrazioni mentali e soluzioni visive incomprensibili o totalmente estranee al testo rappresentato. Non sono infrequenti i casi in cui lo spettacolo non si capisce, se non viene preventivamente spiegato. Come risolvere allora il dilemma, in modo da trovare un equilibrio tra conservazione e innovazione? I capolavori del teatro universale, e di quello musicale in particolare, offrono inesauribili spunti interpretativi, ma posseggono alcuni dati inoppugnabili su cui poggia l’intera costruzione musicale, narrativa e drammatica e di cui il regista deve tenere conto, rispettando i rapporti interni definiti dal libretto e, soprattutto, dalla partitura. Non si tratta di sostenere una vincolante adesione alla lettera del testo, ma di individuare quei pilastri portanti che permettono al testo stesso di acquistare significato, reggersi come struttura e vivere come forma organica. Alcuni di questi punti fermi sono facilissimi da cogliere perché espliciti; altri vanno snidati nell’intimità della forma musicale e richiedono da parte del regista una particolare sensibilità musicale. Per esempio, la deformità di Rigoletto è l’immagine della scellera- cantiere regia — 41 mento per la comprensione del senso. La fase di analisi è una propedeutica necessaria alla rappresentazione, e quanto più la prima sarà approfondita e dettagliata tanto più pertinente sarà la messa in scena. Un procedimento di scomposizione delle parti significanti è metodo pertinente per comprenderle meglio considerate nella loro singolarità: le parole, il loro significato, le valenze acustiche, la cronologia della loro realizzazione nel tempo dell’azione, le relazioni di influenza e la loro combinazione definiscono il personaggio che prende forma in qualità di oggetto semantico, agisce in base a una situazione e secondo un rapporto con gli altri personaggi. L’opera lirica si genera dalla convivenza di due testi, prosaico e musicale, che non hanno gerarchia: seppur con dinamiche leggermente differenti, essi contribuiscono in egual misura alla definizione di un significato. È quindi altrettanto necessario lo studio approfondito delle strutture musicali, della semiotica del suono, della vocalità e della sua espressione. Un regista di opera lirica deve essere consapevole di una cultura musicale, deve averne una conoscenza assolutamente articolata che ne comprenda tutti i campi, sinfonico, cameristico, lirico-vocale. La musica e la sua potenza espressiva veicolano l’emozione senza intermediazioni, il senso dell’espressione musicale si realizza nell’animo di chi ascolta in una immediatezza espressiva di grandissimo impatto che rappresenta l’unicità della musica quale mezzo superiore di comunicazione. Il regista di opera lirica non può quindi essere tale senza una particolare predisposizione alla emotività musicale, deve lui stesso essere musicista nel senso spirituale del termine. In questa sensibilità ha compimento la creatività che coglie aspetti e significati sottesi, i quali elaborati e riorganizzati in relazione agli altri concorrono a una tonalità generale del significato identificativa del- avvicina a quella del cinematografico. È dunque sacrosanta, davanti a certi spettacoli, la ribellione di chi, penetrando in profondità il significato delle forme musicali, constata in che misura possa essere ignorata la funzione essenziale della musica teatrale: quella di plasmare il teatro. Una ribellione che talvolta proviamo tutti, come forte, però, è il nostro compiacimento quando il regista lascia sprigionare dalla musica la forza creativa che dà fisionomia ai personaggi, luce e colore alle scene e ai costumi, ritmo ai movimenti e ai gesti dell’azione; tutte cose che la regia operistica può esaltare in una simbiosi tra musica e spettacolo dall’effetto potentissimo e, nel ricordo, indelebile. la interpretazione. La rappresentazione di un’opera è il correlativo oggettivo della drammaturgia realizzata dalla parola e dalla musica. Il regista che ha studiato il significato tramite l’intuizione e l’analisi utilizza gli elementi (spazio, luce, azione scenica, costume, espressione) in una composizione originale e significativa di una immagine che possa illustrare la drammaturgia in modo chiaro ed evidente secondo una proporzione delle parti in relazione al tutto scandita dalla particolare tonalità dell’interpretazione. La tonalità che il regista vuole evidenziare in Traviata è dunque la solitudine di una donna, la consapevolezza di una morte imminente, l’attesa di un Alfredo, il desiderio di una morte dolce, l’insieme di tutti questi aspetti? Come sarà allora la camera di Violetta e il suo «sogno seduttore»? La scena, i costumi, la luce sono oggetti che concorrono alla verità della drammaturgia, si correlano all’immagine come sintagmi di un linguaggio che procede per analogia, metafora, allegoria o metonimia evidenziandone il senso. È la grammatica di questo linguaggio che rappresenta l’unicità della rappresentazione. Il pensiero – sensuous thought – si traduce in forma che ha valore nel momento in cui trasmette quel pensiero con verità – non ha concretezza considerare una verità della forma per se stessa. Da un punto di vista tecnico, il regista deve adempiere al ruolo di condurre le parti concorrenti allo spettacolo nella direzione della drammaturgia del testo e incentivare la creatività, lo studio, la dedizione di quelle parti (scenografo, light designer, costumista, cantanti) nel rendere più denso il linguaggio con cui trasmettere il significato: affidarsi soltanto alla propria individualità è riduttivo e sterile, rinunciare a collaboratori che nella loro specificità hanno raggiunto in anni di lavoro e approfondimento alti livelli di professione addirittura dannoso. In questa prospettiva e nella considerazione della predominante forza espressiva della musica, collaboratore di prima cantiere regia lità specifica, che può andare dalla verosimiglianza alla più astratta stilizzazione. In ogni caso quel gesto deve esserci, perché diventa, nel progetto verdiano, la figura teatrale, concreta, della memoria; riflette il dramma presente ma rimanda, per contrasto, alla bellezza passata; fa corpo, quindi, con l’esistenza stessa del personaggio, segnandone la parabola, dall’inizio alla fine dell’opera. Toglierlo, come ho visto fare, non solo rende incomprensibili i gesti di Violetta, ma elimina una fondamentale connotazione psicologica ed esistenziale della protagonista. Se un legame essenziale può dunque mettere in relazione il personaggio con determinati oggetti, ancora più decisivo sarà il suo rapporto con l’ambiente. La musica, sotto questo aspetto, è molto più cogente del teatro di prosa: definisce le caratteristiche dei singoli luoghi e il rapporto di spazio, luminosità, tempo che li collega o li contrappone l’uno con l’altro. Con troppa disinvoltura si trascura, ad esempio, la differenza tra interno ed esterno, solitamente indicata dal compositore con la massima chiarezza. Oltre al problema della scenografia e dei costumi, molto impegnativo, nel teatro d’opera, è il lavoro necessario per far recitare i cantanti come attori di prosa. È stata questa l’esigenza primaria che ha dato impulso alla regia operistica e ne ha determinato la straordinaria fioritura nella seconda metà del Novecento. Il vero problema del teatro lirico sta però nel rendere credibile e naturale un’azione ritmata sul tempo della musica. L’opera, sotto questo profilo, è molto più complessa del teatro recitato e l’opera italiana, per numeri chiusi, è molto più difficile da rendersi scenicamente del dramma musicale di tipo wagneriano, per il divario che la caratterizza tra tempo della rappresentazione e tempo rappresentato, nonché per il continuo mutamento delle inquadrature con cui la musica rappresenta il dramma, conferendogli una mobilità che la Marco Gandini «Il sol cruento mio pensier le dà forma e come vera mi presenta allo sguardo una chimera» Piave-Verdi, Macbeth La definizione del ruolo e funzione di un regista specificatamente di opera lirica richiederebbe di identificare prima le caratteristiche e le strutture di un’opera lirica come genere teatrale e le generali funzioni di regista, la brevità dell’intervento richiede quindi una certa sintesi e circoscrizione. Il regista di teatro viene investito della responsabilità dello studio di un testo dato e della trasmissione dei significati contenuti in quel testo – diversamente per esempio da un regista di cinema che crea assieme agli autori un testo originale. L’analisi del testo non può prescindere da un’istruzione letteraria ed artistica, da un corredo conoscitivo di natura umanistica quale stru- 42 — cantiere regia posizione è il direttore d’orchestra: non c’è espressione scenica vera che non sia in assoluta simbiosi con l’espressione musicale, il tempo, lo spazio e l’azione possono essere essi stessi definiti in termini musicali di crescendo emotivo, diminuendo del pensiero, allargando dell’azione, i luoghi dell’azione ricorrersi in un rubato. Il regista deve altresì avere i mezzi e le capacità di tradurre in realtà le idee e il concept di uno spettacolo, capacità che vengono acquisite in anni di pratica e crescita professionale. A conclusione del mio breve commento mi sento di dover sottolineare la responsabilità civile di quanti sono chiamati al lavoro attorno all’opera lirica, noi registi, i direttori d’orchestra, i direttori di teatri, i critici, i professori, gli stessi cantanti, le accademie e i conservatori. La difesa del patrimonio artistico rappresentato dall’opera lirica è di primaria importanza, in quanto essa ancora oggi rappresenta uno strumento raffinato ed efficace alla comprensione dell’uomo e del suo pensiero, opera d’arte del XXI secolo a cui dobbiamo rendere l’onore della diffusione della cultura italiana nel mondo tramite la nostra lingua e musica. Massimo Gasparon Adriano Guarnieri Ho avuto con i registi esperienze diverse, che posso tuttavia unificare dicendo che sono abituato a dare loro una sorta di canovaccio, cantiere regia La definizione di regia operistica pone certamente delle problematiche più complesse rispetto ad un qualsiasi testo puramente teatrale. Noi registi d’opera del XXI secolo dobbiamo ideare allestimenti destinati ad un pubblico estremamente composito per età, estrazione sociale e livello culturale. Ed in generale lo spettatore contemporaneo è molto più sensibile al livello visivo dello spettacolo, spesso ponendo in secondo piano l’aspetto letterario o filosofico dell’opera. Ciò è dovuto sicuramente allo sviluppo straordinario della tele- io credo nella forza delle idee, dei contenuti, delle emozioni: comunicare significa mettere in comune e, in quanto regista, devo condividere le mie emozioni e i miei pensieri con lo spettatore. La forma della comunicazione può essere più o meno aggiornata, ammiccante all’ultima moda, trasgressiva ma certamente non può essere incomprensibile. La non comprensibilità annulla la ragione d’essere del teatro, vanifica la comunicazione. La ricerca ossessiva della nuova forma, della forma in quanto vuoto contenitore, rifugio infantile alle incertezze dell’uomo, oramai rende ogni sperimentazione artistica già prevedibile, già nota. Ma mentre le arti in genere spesso non si pongono la questione di essere o non essere accessibili al pubblico, il teatro e le discipline teatrali devono confrontarsi con spettatori presenti ogni sera, vivi e avidi di emozioni e sensazioni. L’obiettivo della regia deve raggiungere l’unità dei contenuti in una forma chiara e percepibile dal pubblico nella sua totalità, senza però rinunciare ad una funzione educatrice che trasmetta messaggi. Una forma di emozionalità razionale, di trasgressione concessa alla propria mente, attraverso lo sfogo della passione. E cercando anche l’equilibrio tra una certa forma di intrattenimento senza rinunciare alla vocazione letteraria del melodramma, imprescindibile per comprenderne e goderne appieno il valore. Essere regista d’opera ci obbliga ad esprimere e a mettere in scena le nostre ansie, i nostri dubbi, le nostre passioni. E non si può mentire, non si deve mentire, pena la solitudine che su di un palcoscenico diventa ancora più agghiacciante. visione e del cinema che, attraverso il controllo delle tecniche della visione, condizionano fortemente ogni nostra percezione: allo stesso tempo pur vivendo in un clima di estrema ricchezza e varietà dei mezzi espressivi, spesso siamo circondati da una povertà di contenuti a volte decisamente imbarazzante. L’opera lirica può ancora proporre un sistema artistico espressivo decisamente completo e coinvolgente, che però non rinuncia a pretese di comunicazione alta, spesso portatrice di un messaggio spirituale o politico o sociale. La sua originale unicità consiste nell’utilizzare tutte le arti (scultura, pittura, architettura, poesia, musica, danza) e fonderle in una forma di spettacolo ancora amata dal pubblico nonostante i suoi 400 anni di vita. E la sua forza consiste nell’utilizzo della musica, soprattutto nell’esecuzione dal vivo in un teatro. Il linguaggio musicale impone un ritmo narrativo e drammatico speciale all’opera lirica, in quanto la musica strumentale rappresenta un linguaggio parallelo a quello verbale cantato, con una struttura propria. L’opera necessita di coerenza drammaturgica, in quanto il testo poetico è indissolubilmente legato alla musica e pertanto poco manipolabile. A mio avviso la Poetica di Aristotele ha sempre prescritto più che un’unità di luogo, di tempo e di azione, una coerenza drammaturgica che deve guidare lo spettatore nel processo catartico. Credo che un approccio serio e consapevole delle proprie responsabilità artistiche e sociali per un regista dei nostri giorni sia quello di una razionalità espressiva, sentimentale ed emotiva; e che la catarsi, in fondo, rimanga assolutamente parte integrante della vera forma teatrale. Se consideriamo la regia del teatro musicale una forma di espressione e di comunicazione, a mio avviso noi registi dovremmo sempre utilizzare un linguaggio già dato. Strana la presunzione del nostro secolo di volere creare sempre nuovi linguaggi artistici individuali, che il pubblico dovrebbe di volta in volta imparare. Molto più semplicemente di scrittura scenico-registica non tanto per indicare i movimenti, le figure, o come dev’essere la loro creatività, quanto piuttosto per farli partecipare dei respiri temporali e vitali della partitura e delle sue immagini più profonde. Che il regista sappia o non sappia leggere la musica a me non interessa. La mia scrittura musicale procede come in un film, sequenza per sequenza, con una struttura temporale ben precisa. All’interno di ogni sequenza descrivo quanto di musicale avviene, indicando anche le durate temporali di questi avvenimenti, che non alludono a una narrazione, a un qualcosa che si deve tramutare in teatralità. Ed è proprio la musica che dà poi al regista il giusto stimolo a estrarre una sua partitura. Ecco allora che il confronto finale avviene fra due partiture: una musicale e una registica fra loro speculari. La loro unione permette quella che considero l’utopia massima, perché credo che alcun musicista sia mai arrivato a una fusione totale. Fornire al regista il canovaccio di cui parlavo poc’anzi, gli consente dunque di elaborare una partitura sua propria con la quale poi, sequenza per sequenza, mi metterò a confronto. Tutto ciò a cui il regista dà vita nella sua partitura deve avere un confronto con il corrispettivo musicale. Più che di una tecnica registico-teatrale, si tratta di una metodologia registico-video-teatrale: entrambe le partiture, quella musicale dalla quale sgorga quella registica, sono in completa autonomia. Dall’unione di queste due autonomie si dovrebbe avere unicum: l’idea di compresenza fra musica e regia. Gerardo Guccini Poco tempo fa, in occasione della Tavola rotonda «Il sipario strappato» (Teatro Comunale, Bologna, 29 aprile 2008), ho riepilogato alcuni inquadramenti sulla regìa lirica contemporanea. Da allora cantiere regia — 43 non ho svolto altre indagini in materia, eppure, tornando ora sull’argomento, mi sembra di avere mancato di riconoscere e indicare, in tale precedente occasione, il principale esito storiografico delle interazioni fra il teatro lirico e le molteplici forme della teatralità novecentesca e contemporanea. Quando si tratta di conoscenze umanistiche, dal classico due più due può anche risultare un esito tanto imprevisto e spiazzante da risultare, sulle prime, addirittura invisibile. Con ciò intendo dire che le implicazioni di dati in sé ovvi non sono necessariamente ovvie. Nel nostro caso si tratta addirittura di capovolgere il consolidato rapporto di subordinazione culturale e storica della regìa lirica rispetto a quella teatrale. Le connessioni fra l’opera e il mondo teatrale dipendono dalle possibilità di spesa degli enti lirici e dalle strategie delle direzioni artistiche. Per questo, le si considera attraverso i loro esiti scenici, ma mai in quanto indizi di un sistema culturale in mutamento. Eppure, a partire dagli anni ottanta, tali interazioni hanno mutato i precedenti assetti, suscitando dall’interno dell’opera nuove leve di registi lirici ed inquadrando in questo ruolo artisti della performance estranei alle dinamiche rappresentative del teatro drammatico. Mentre, nel corso del Novecento, la regìa teatrale ha adattato le proprie risorse alle esigenze degli allestimenti operistici determinandone l’aggiornamento, in età postnovecentesca, sono piuttosto gli allestimenti lirici che riconducono alle prassi della regìa le evoluzioni del teatrale. luogo di ideali, un luogo di costruzione di un mondo ideale e non la rappresentazione aberrante della proposizione della vita quotidiana. Il teatro è un po’ come una chiesa. Wagner parla di «dramma sacro»: c’è una sacralità nel teatro, succeda quel che succeda apriamo sempre il sipario! Per quel che riguarda il rapporto cantante/attore, credo si recitasse sulle scene liriche fin dall’Ottocento. Leggendo Verdi e quello che chiedeva ai suoi cantanti, ci si può rendere conto di come pretendesse da loro anche tecniche attoriali. I cantanti italiani sono bravissimi, hanno una preparazione formidabile e un’intuizione incredibile. Sanno recitare perché hanno un senso innato del teatro. Io, come regista, devo offrire il mio parere e il mio aiuto dal punto di vista tecnico. Uno spettacolo si costruisce a partire dalla storia, dall’incontro fra un essere umano con un’esperienza di vita – l’attore – e un essere che sta sulla carta: il personaggio. La nostra esperienza di vita viene nutrita per nutrire la costruzione del nostro personaggio. Direi che a teatro, ad ogni modo, bisogna lasciare il «se stesso» un po’ fuori, nell’anticamera, e prendere invece fra le pieghe della nostra memoria quegli elementi di vita che servono a nutrire il personaggio. Non penso che quest’ultimo possa avere una funzione psicoanalitica: non credo che il teatro sia il luogo dove si possano portare i problemi personali. Il teatro è piuttosto un’avventura umana. Del tutto esaltante! * Gerardo Guccini, a seguito del breve quesito sulla regia, ha sviluppato una più ampia riflessione, di cui queste righe sono l’incipit e che verrà pubblicata in altra sede. Cesare Lievi Denis Krief ry Bertini. La «Gielen-Ära» era appena terminata. E con essa il così detto teatro di regia aveva festeggiato in quel luogo i suoi primi e grandi fasti: Ruth Berghaus, Kirchner, Neuenfels, Musbach e i loro drammaturghi capitanati da Klaus Zehelein avevano sondato, analizzato, ribaltato nella loro interpretazione critica le opere più importanti del repertorio operistico, distrutto l’immagine leziosa e un po’ polverosa del teatro in musica della tradizione, assaltata con l’energia e l’irriverenza ideologica del post-sessantotto la convenzione rappresentativa ereditata dal passato tendente, in maniera dichiaratamente consolatoria, più alla riconciliazione che alla rottura. Il pubblico all’inizio si era indispettito. Aveva protestato. Disdetto gli abbonamenti e preso la via di teatri d’opera più tranquilli e tranquillizzanti, sparsi in abbondanza nei dintorni della metropoli sul Meno. Ma poi aveva finito con l’abituarsi, l’adeguarsi e anche col gradire. La stampa era stata tutt’altro che neutrale. Ritenendosi una sorta d’avanguardia culturale nella società massificata della Repubblica Federale Tedesca, aveva fortemente appoggiato tale rivoluzione critico-estetica trasformando in breve l’Opera di Francoforte in un esempio per tutta la Germania e l’Europa. Per quanto mi riguarda – il caso mi aveva spinto ancora giovane da quelle parti – di quella stagione ero stato uno spettatore attento, interessato. E di essa mi aveva colpito la forza, l’intelligenza, la temerarietà con cui veniva posto il problema della regia nell’opera lirica, ma anche la professionalità e l’energia inventiva con cui tale problema veniva risolto. Mi avevano, invece, lasciato perplesso il taglio fortemente ideologico e intellettualistico, a volte culminante in arbitrii e vere assurdità; alcune soluzioni estetiche «informi» dove il brutto era assunto indiscriminatamente come categoria estetica positiva (serviva a distruggere il «culinario» sempre presente comunque cantiere regia Ho iniziato la mia carriera, come regista d’opera, a Francoforte nel 1989 con La clemenza di Tito di Mozart: scenografia di mio fratello Daniele, costumi di Mario Braghieri, direzione musicale: Ga- Bertolt Brecht diceva che per far del teatro ci vuole: un teatro, appunto, un testo e degli attori. Il teatro lo abbiamo, penso alla Fenice e a tanti altri formidabili teatri in Italia, e la gente che vi lavora è davvero eccezionale. Il teatro non è solo un luogo fisico, ma anche gli uomini che vi lavorano. Abbiamo maestranze formidabili in Italia: cori, orchestre, uffici che lavorano benissimo. Per quanto riguarda i testi, il repertorio ce ne ha regalati in abbondanza: Donizetti, Wagner, Puccini, Strauss, ecc. Per quel che riguarda gli attori, i cantanti, apro invece una polemica. C’è un costume che deve infatti avere termine: il fatto che gli attori non vengano alle prove. Come si può preparare un buono e onesto lavoro teatrale quando mancano gli attori, i principali protagonisti del teatro?! Si tratta di un momento di crisi perché mancano i soldi, certo: ma è giusto cancellare delle prove perché non ci sono gli attori? Questo gioco infantile deve finire, per cominciare invece a lavorare seriamente. I cantanti non vengono alle prove perché spesse volte sono impegnati in altri allestimenti e arrivano quando piace a loro. Penso che questo modo di fare non sia più accettabile. Chi vuole lavorare in questo ambito deve farlo per la gioia di fare teatro, per la gioia di offrire al pubblico delle opere formidabili. Chi viene a teatro for take the money and run, per prendere i soldi e scappare deve essere cancellato dal palcoscenico. Soffro molto per questo problema, una questione che non è solo italiana. Anche se i soldi sono pochi, penso che i teatri non debbano essere chiusi. Il teatro esiste dal Cinquecento prima di Cristo, è più vecchio della prostituzione forse. Nasce nell’Atene meravigliosa e perdura fino a ora. Chi potrebbe cancellare una cosa che esiste da così tanto tempo? Sarebbe un delitto. Quello che possiamo fare è lavorare seriamente assieme lasciando da parte i capricci. Il teatro è un 44 — cantiere regia na dall’assunto, per me irrinunciabile, che il teatro deve parlare alla contemporaneità. Contemporaneità non significa necessariamente lo spostamento temporale dell’opera in scene e costumi moderni, ma la riconoscibilità degli affetti della drammaturgia musicale. Al contrario l’idea museale di messinscena porta ad uno scollamento tra la realtà degli affetti della drammaturgia e la società, facendo passare un concetto deleterio gravissimo nella mentalità del pubblico, a cui non si dà credito di intelligenza, ovvero l’idea di «carino», «bellino», «elegantissimo», di non perturbante, non disdicevole. Il teatro all’opposto è da sempre una terra di crisi, specchio per la società, uno specchio capace di evidenziarne a volte aspetti affatto rassicuranti (Don Giovanni, per esempio, è rivoluzione. La rivoluzione eccita e terrorizza, ma il «teatro museo» a volte rimuove questo concetto facendola passare per un catalogo di amplessi: in Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, 91 in Turchia, 1003 in Spagna, per un totale di 2065 scopate e non azioni di rivoluzione). Il pubblico è intelligente, anche quello più conservatore, la gente riconosce il valore e la coerenza. Il pubblico dell’opera va amato, perché è l’unico che ha una continuità storica con la cultura del nostro paese, ed è proprio per questo che non va rinchiuso in una sorta di museo o immerso in una Jacuzzi rassicurante con acqua tiepida e bollicine in cui non pensa (il teatro di Verdi per esempio è la più alta forma di teatro politico a 360 gradi espressa dalla nostra società: puttane, handicappati, traditori, malati terminali sono alcuni dei protagonisti verdiani costantemente passati sotto la CENSURA del tempo). Io penso che il regista d’opera debba avere coscienza di tutto questo e per comunicare la meraviglia di questo patrimonio con la forza espressiva data dalla partitura deve avere oltre alla cultura e alla creatività, la tecnica. fioritura di senso improvvisa e inaspettata, dove i segni si incontrano con la vita. Non la illustrano. Non la spiegano. E tanto meno la giudicano. Ma per arrivare a questo dovevo rinunciare all’estetica del brutto tanto cara al teatro di regia che aveva trionfato proprio nel luogo che mi ospitava, dovevo liberarmi di giustificazioni ideologiche e pregiudizi. Ma non solo; dovevo impegnarmi in qualcosa di più difficile: tentare un’estetica della bellezza. E con l’aiuto di mio fratello come scenografo provai a farlo. Per quanto invece riguarda la conduzione dei cantanti e la loro articolazione in personaggi, non disegnai delle figure dal carattere netto e statico, ma cercai di farle affiorare dalle varie situazioni drammaturgiche e musicali come fossero parti di un bassorilievo che sotto gli occhi dello spettatore acquistava lentamente forma, carne e umanità; cercai cioè di individuare quel punto in cui la rappresentazione cessa di essere tale diventando visione e poesia. Non so se ci riuscii del tutto. È probabile di no. Ma questo fu il mio impulso, la mia ricerca, come lo è del resto anche ora ogni volta che mi accingo a tradurre in segni, azioni, movimenti, atmosfere e visioni, il libretto e la musica di un’opera. Per seguire orientamenti e ridefinizioni in linea con il periodo storico in cui siamo, dobbiamo conoscere profondamente la materia che studiamo, ovvero la drammaturgia musicale. Per drammaturgia musicale intendo (come da seconda prattica monteverdiana) il risultato del rapporto fra armonia e poesia, che sottintende la conoscenza perfetta del libretto e delle fonti letterarie, ma altresì della musica, delle prassi esecutive, della tecnica vocale di ogni repertorio. Un regista d’opera non può non essere musicista. La conoscenza della musica, della partitura, della tecnica vocale grazie alla quale si esprimono i cantanti sono le componenti base attraverso cui sviluppare/creare spettacoli nuovi che parlino in maniera potente alla contemporaneità. L’ego registico deve mettersi a disposizione della drammaturgia e divenire un decoder attraverso cui amore, odio, tradimento, passione, politica espressi nel teatro musicale di ogni secolo vengono riconosciuti come affetti presenti oggi nella società. Un regista d’opera deve conoscere la tecnica vocale. È la componente attraverso cui entrare in rapporto davvero creativo con i cantanti, che non sono mai stati dei ciccioni spara acuti, ma attori che veicolano con l’eterna arte del canto la credibilità dei personaggi che interpretano. Conoscere la tecnica vuol dire proteggerla e metterla in relazione al gesto attoriale. Senza una buona esecuzione vocale l’idea registica viene sminuita. Il rapporto tra agito registico e vocalità è osmotico. Il gesto nasce dalla musica, il gesto nasce dalla voce e la sua densità deve armonizzarsi con la densità dell’impegno vocale. Solo allora possiamo giocare in scena in modo non generico, contemporaneo, efficace per servire la realtà degli affetti in musica. Conoscere la tecnica vocale vuol dire parlare il linguaggio dei cantanti, entrare in rapporto intimo con loro per estrarre il massimo della loro sensibilità attoriale. cantiere regia nel genere opera) ma soprattutto mi aveva irritato il conservatorismo (certamente inconsapevole) nella gestualità dei cantanti sempre fortemente espressiva e articolata autonomamente rispetto agli altri interpreti. In altre parole: il gioco teatrale inteso come relazione e risultato di intrecci-vortici di tali relazioni veniva completamente ignorato, per cui le modalità di narrazione dell’azione erano le stesse della tradizione: statiche, esteriori, tendenti più all’effetto e alla spettacolarità che alla rilevazione dei personaggi e dei loro conflitti. Insomma in quelle regie pur tanto ammirate mi mancava «l’esprit de finesse», il gioco di reazione e controreazione dei personaggi, il loro avvicinarsi e allontanarsi, il loro affermarsi e negarsi. Io non volevo trovare sul palcoscenico figure già delineate in partenza, ma vedere il loro lento e problematico costruirsi, il loro farsi in un insieme contrappuntistico tutt’altro che prevedibile. Certo sapevo che tale impostazione avrebbe portato a risultati diversi a seconda delle opere prese in esame, alcune sarebbero state per la loro struttura e forma musicale più adatte, altre avrebbero mostrato resistenze, difficoltà, forse addirittura totale riluttanza e inadattabilità, ma allora (e certamente anche oggi) mi sembrava la forma più giusta per avvicinarmi come regista alla forma opera. Ma torniamo alla Clemenza di Tito di Francoforte nel lontano 1989. Come mi accostai a essa? Come la tradussi sul palcoscenico? E come la interpretai? Nella definizione del Konzept mi guardai bene dal ricorrere ai sistemi teorico-ideologici allora molto in voga. Marx, Freud, lo strutturalismo in tutte le sue versioni, il post-strutturalismo ecc. mi sembravano teorie che, applicate all’interpretazione di un fatto artistico, erano in grado più di verificare la propria capacità di lettura che aprire in modo nuovo e sorprendente quell’universo complesso di segni che è un’opera. E io miravo proprio lì. A quell’apertura, a una Davide Livermore TecnicaMente C’è teatro musicale e teatro musicale: il teatro musicale italiano, ad esempio, non sempre parte dall’assunto dato dalla suggestione di questa inchiesta, ovvero che la regia segua orientamenti e ridefinizioni in linea con il periodo storico in cui è inserita; spesso invece essa è legata ad un’idea museale di messinscena, lonta- cantiere regia — 45 L’opera è il prodotto più alto della cultura italiana. Pochissime persone al mondo studiano ancora l’italiano, non esistono neanche più i documenti ufficiali della comunità europea in italiano; l’unico e l’ultimo luogo in cui l’italiano è lingua veicolare è nei teatri d’opera nel mondo, che sono tanti, sempre pieni e che in un anno producono più di 1000 rappresentazioni di opera in lingua italiana. Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Ezio Greggio, Maria De Filippi, Manuela Arcuri, Raoul Bova oltre Ventimiglia, Chiasso o il Tarvisio sono semplici turisti. Mentre, per esempio, Eva Mei e Antonino Siragusa con cui sto lavorando in questi giorni sono due delle tante autentiche star italiane di fama internazionale, completamente ignorate da un sistema di politica sottoculturale e di entertainment che predilige il non valore, la mediocrità e che vuole affermare una società senza radici storiche culturali, facilmente governabile e manipolabile. Io come artista sono un agente politico. Come regista d’opera sento la responsabilità della continuità storica della cultura italiana. Una scelta di tipo interpretativo è sempre una scelta di tipo politico. Nella nostra società l’opera rappresenta ancor più una possibilità di emancipazione dalla mediocrità e questo è possibile attraverso la tecnica, la conoscenza della drammaturgia musicale, della tecnica vocale, del rapporto con la nostra società, in altre parole con un concetto che la sottocultura spazzatura del nostro tempo rimuove completamente: lo studio e la passione. Giovanni Mancuso Il problema è che il compositore spesso partorisce idee complete di teatro musicale e le partiture tendono alla comprensione di elementi cosiddetti «extramusicali» ma che sono strutturali ed essenziali proprio come quelli più tradizionalmente musicali. Quindi, la natura della partitura è spesso quella di un microcosmo autosufficiente e dettagliato; poi, entrando in teatro, compaiono gli specialisti, si materializzano le diverse competenze che reclamano la loro autonomia e rivendicano apporti non meramente esecutivi ma creativi. E qui succedono i disastri. Allora tanto vale non cercare alcun elemento essenziale, irriducibile, irrinunciabile (a meno che non vogliate stabilirlo di fronte ad un notaio) e cominciare a pensare l’opera (o qualcosa che potremmo anche chiamare diversamente) fin dall’inizio in una prospettiva collettiva, rinunciando ognuno (compositore, regista…) a una porzione di autorialità (nel cinema è proprio così) per avventurarsi finalmente in qualche territorio meno esplorato. Oppure saremo sempre destinati ad essere etichettati dal pubblico come i parenti poveri della tradizione, gli «ammodernati» (per dirla come Berlusconi). Per concludere allora, un paradossale manifesto di una nuova idea di regia del teatro musicale potrebbe cominciare così: Non vi siano regole e limiti o elementi irrinunciabili nella definizione di teatro musicale e di regia. Avventuratevi nel teatro musicale senza definire ruoli o territori anche a costo di rischiare collaborazioni con pazzi, dementi e delinquenti (a me è successo). cantiere regia Poiché non ritengo di avere opinioni o esperienze interessanti a proposito (a parte uno spiacevole allestimento dal quale non tratto al- cun insegnamento se non quello di tenermi alla larga da buffoni e disonesti) ho pensato di realizzare una breve indagine sulle opere allestite in Italia quest’anno. Ebbene, in circa 45 teatri, italiani – dal Teatro alla Scala al Multisala Cinema Nuovo Lioni – durante la stagione 2008/09 vengono allestite 106 opere, 55 delle quali vengono rappresentate in più teatri. Il campione di ubiquità è la Carmen con 14 diversi allestimenti, seguita da Butterfly (12), Tosca (11), Traviata (10), Rigoletto, Turandot, Boheme, Aida (7); Italiana in Algeri (6) e così via. Una curiosità? Ben 4 Medium di Menotti !! (tassi al limite della tossicità). Le opere di autori viventi o contemporanei quest’anno sono addirittura 15: Pagotto, Goebbels, Jarrell, Berkeley, Nyman, Ambrosini, Solbiati, Lombardi, Nicolini (tenetevi forte: un’opera su libretto di Paolo Limiti!), Furlani, Testi, Rihm, Melchiorre, Ligeti e Bregovich. Ma è degno di nota il fatto che ben 8 di questi siano concentrati al Teatro dell’Opera di Roma; insomma un’anomalia tempestivamente risolta con una probabile futura rimozione di Nicola Sani (l’anomalo). In questa pletora asfissiante di repertorio, la figura del regista non può che attenersi a routine collaudate, a schemi semplici o clichè meccanici buoni per allestimenti rapidi e indolore. E d’altro canto, meglio così. Possiamo forse immaginare 106 diverse e autorevoli letture e interpretazioni ogni anno? Negli altri casi, in quelli che si verificano per anomalia, errore e distrazione, potrebbero anche nascere felici occasioni di collaborazione tra compositore e regista ma, per carità, non facciamo come al solito: non ricalchiamo i soliti schemi, quelli buoni soltanto per vecchie signore pseudocolte impellicciate. Giacomo Manzoni Credo che il rapporto col regista sia sempre diverso, anche a seconda del tipo di lavoro teatrale che il compositore ha svolto. Per quel che riguarda il mio primo lavoro, un’opera in un atto intitolata La sentenza del 1960, si tratta di un’elaborazione di idee riguardanti un tipo di teatro molto legato a una tradizione di stampo brechtiano e del Piccolo Teatro di Milano. Ne fu regista Virginio Puecher, assistente di Strehler per molti anni che ha poi lavorato in proprio mantenendo l’impostazione ricevuta al Piccolo. Con lui mi trovai in perfetto accordo: anche il testo dell’opera, infatti, era di derivazione brechtiana. Mi affidai quindi senza remore alle idee registiche di Puecher. E proprio con Puecher lavorai anche ad Atomtod, opera in due atti del 1964. In questo caso subentrò in maniera forse ancora più determinante la figura dello scenografo, Josef Svoboda. Si trattava di un lavoro teatrale molto diverso dal precedente, anche per il tipo di linguaggi e materiali musicali usati: in qualche modo mi ero indirizzato con chiarezza sulla via di un certo linguaggio musicale. Su testo di Emilio Jona, si trattava di un’opera contro lo sterminio atomico. In questo caso lavorammo in équipe: in un primo momento mi confrontai con Jona per la stesura del libretto, e in una seconda fase anche con Puecher e Svoboda per capire bene quali fossero le possibilità scenografiche. Il lavoro presentava infatti delle difficoltà notevoli, come ad esempio quella di far rientrare una doppia sacena su di un palco molto ristretto. E in relazione alle idee proposte da Svoboda, anche la musica doveva tenerne conto. Le soluzioni di Svoboda furono geniali e di grande efficacia scenica e anche Puecher dovette seguirle. Per Massimiliano Robespierre, del 1974, vede ancora la regia di Puecher. Ancora una volta, l’importanza dello scenografo fu fondamentale. In realtà si trattava di uno scultore, Giuseppe Spa- 46 — cantiere regia mettere alcuni paletti, con l’acutezza e la sapienza che lo contraddistingue, Paolo Fabbri il quale, nella consapevolezza dell’impossibilità di ripristinare filologicamente, a differenza di quanto avviene per una partitura musicale, l’originarietà di uno spettacolo – in effetti ho ricordi assai deludenti di alcuni rari tentativi di allestimenti «com’era, dov’era» – indicò alcuni punti fermi nell’osservanza dei generi, nel rispetto dei dislivelli sociali dei personaggi, come pure quello del ritmo drammatico e quindi delle funzionalità originarie dei singoli brani. C’è da chiedersi se tutto ciò sia sufficiente o addirittura necessario, anche perché devo riconoscere come, nei miei ricordi, alcune trasgressioni a tali indicazioni hanno lasciato un segno positivo. Penso, andando indietro negli anni, a quel Rigoletto ambientato a Chicago, ai tempi di Al Capone, messo in scena da Jonhatan Miller, che dietro lo sconcertante salto cronologico non tradiva la ferrea tensione del «far breve» verdiano, o al Wagner rivisitato da Chéreau come pure quello di Kupfer, proposte che toccavano certe zone magmatiche di quello sconfinato, polivalente universo; anche perché, e questo credo sia un paletto insormontabile, mai prevaricanti il passo musicale. Come invece mi è parso essere l’intervento recente, sempre sulla Tetralogia, della pur estrosa Fura dels Baus, dove l’invenzione visuale, indubbiamente straordinaria nella sua sofisticata tecnologia, finiva per calamitare l’attenzione dello spettatore, allontanando sullo sfondo la trama musicale pur intessuta sapientemente da Metha. Tanti sarebbero gli esempi da rievocare, un elenco che le cronache musicali, pur nella crescente ristrettezza degli spazi che sono loro riservati, arricchiscono ogni giorno – leggo proprio oggi di Ratto dal serraglio napoletano che occupa qualche colonna per il topless di una comparsa, trovata tra le tante del pur non banale Michieletto che ha ambientato il Singspiel sullo yacht di un boss della camorra – unico appiglio per la loro sopravviven- sultato fu straordinario. Quest’opera rimane un domani disponibile ad altri registi e concezioni senza che ci sia in alcun modo qualcosa di predisposto, senza che ci siano indicazioni sceniche precise, senza nulla di vincolante per chi affronterà questo lavoro. In un lavoro ipotetico che facessi in futuro, probabilmente mi porrei il problema del rapporto col regista in una maniera ancora diversa: penso infatti che ci siano modi differenti di confrontarsi con l’aspetto registico. Un aspetto, questo, che mi sembra molto attraente nell’ambito dell’attività teatrale di un compositore. za. A riprova che è sempre più difficile trovare del «pane comune». cantiere regia gnulo, che realizzò una bellissima scenografia in acciaio: un numero di tonnellate davvero notevole che mise in agitazione tutto il teatro. Si temeva infatti che, sotto quel peso, sarebbe sprofondato il palcoscenico e spezzati i cavi che reggevano certi pesi calati dall’alto. Su questa idea di scenografia, poi, Puecher lavorò in una maniera che in questo caso fu meno concordata con me. Questo comportò alcuni problemi e lentezze. Si tratta di un’opera che poi non è più stata fatta con una regia e una scenografia diverse e che mi piacerebbe un giorno veder rinascere in una concezione differente, più compatta e unitaria. Fino a questo momento, le figure di regista e scenografo furono per me di massima importanza, implicando l’ambizione di un rapporto d’équipe al momento della nascita dell’opera. Con l’ultimo lavoro, Doktor Faustus, del 1988, su testo di Thomas Mann, presi una posizione diversa, considerato anche il fatto che il testo lo ricavavo direttamente dal romanzo di Mann. Decisi di scrivere un’opera che fosse aperta all’intervento del regista, al punto che in un primo tempo inserii addirittura le indicazioni scenografiche ricavate dallo stesso romanzo. Ma all’ultimo momento decisi di togliere tutto ciò che era indicazione ambientale e di lasciare il testo nudo a disposizione del regista. In questo caso, fu Bob Wilson ad assumersi la responsabilità di inventare liberamente l’impostazione dell’aspetto scenico. Fece un lavoro di grande perfezione e rispetto per la musica, prestando molta attenzione anche alle mie indicazioni. Capii fin da subito che stava lavorando con grande passione e interesse per l’opera, e lo lasciai libero nelle sue scelte. Man mano che il tempo passava, il lavoro otteneva sempre più una forma compiuta, convincente e legata al carattere stesso della musica. E questa fu una cosa molto bella perché pur non avendo io dato istruzioni e non avendo discusso preventivamente con il regista, vidi che la sintonia sgorgava da sé durante il lavoro di questo grande personaggio. Il ri- Gian Paolo Minardi Il tema è imbarazzante, anche perché ormai è pane quotidiano per chi frequenta i teatri; con tutte le complicazioni che un genere «primario» per antonomasia come il pane prospetta a chi entri in una panetteria; quale pane? Comune, condito, senza sale, croccante, arabo, pugliese ecc.ecc. Figuriamoci quando si tratta di una lettura scenica, da sempre insidiata da quella precarietà che aveva allarmato Verdi, indotto a mettere qualche puntino sulle i con le «disposizioni sceniche»; per non parlare di Wagner, il vecchio Wagner che deluso dagli allestimenti bayreuthiani confidava agli amici il sogno ideale di un teatro invisibile, mutando l’equazione fondativa della sua drammaturgia – Wort, Ton, Drama – nel termine più impalpabile di «azioni visibili della musica». Da allora è accaduto di tutto, alla funzione regolatrice del «metteur en scène» è subentrato il regista, addirittura il «Dramaturg» e dalla lettura si è passati alla «ri-creazione» o all’«azione parallela», come proponeva il titolo di una tavola rotonda svoltasi a Bologna nel 2006 nell’ambito dei «Colloqui di musicologia» del Saggiatore musicale. Ricordo che in quell’occasione tentò di Luca Mosca Nella mia esperienza di compositore la collaborazione con i registi è stata ed è fondamentale. Soprattutto nella fase precedente l’inizio delle prove, momento in cui faccio loro ascoltare la musica da me ideata. Ritengo di notevole importanza il fatto che il regista con il quale mi confronto sappia di musica. Anche per questo, per citare un esempio, mi sono trovato molto bene con Davide Livermore nella realizzazione del Signor Goldoni (cfr. VMeD n. 17, p. 38): Livermore è un ex tenore che quindi conosce perfettamente i problemi che un allestimento teatrale d’opera può comportare. Cantare è infatti difficilissimo e cantare recitando lo è ancora di più: la Callas è stato un miracolo pressoché unico in questo senso. Ecco perché penso che la prima condizione che deve sussistere ai fini di una buona riusicta teatrale sia il potersi confrontare con un regista che conosca bene i problemi del canto e che abbia a disposizione dei cantanti in grado di rispondere alle sue sollecitazioni. È fondamentale che un regista possa lavorare a fondo sulla recitazione. A essere sincero, mi interessa poco uno spettacolo in cui l’impronta registica sia molto forte: è invece necessario che sia io a fare lo spettacolo. La musica che scrivo, infatti, va a condizionare molto l’impianto registico, in quanto nelle mie partiture è quasi già tutto scritto: quello che devono fare i cantanti, i loro movimenti e la durata che questi movimenti devono avere. Per questo pretendo che un regista rispetti quello che ho scritto. Almeno finché sono in vita! Faccio un lavoro molto approfondito quando compongo, e anche dal punto di vista registico penso di proporre una partitura che cantiere regia — 47 è già quasi completa. Se un compositore scrive davvero ciò che ha in mente traducendolo in note e tempi musicali, il lavoro del regista è veramente molto più facilitato. Mario Pagotto A mio parere, al di là delle mode e delle tendenze culturali, il lavoro di regia musicale non può prescindere dalla comprensione tecnica ed estetica di una partitura musicale. Sembra una banalità, ma come tutte le cose ovvie e semplici, spesso non viene applicata. I motivi sono molti e spesso il più importante è la ricerca dell’originalità per l’originalità. Una tautologia che ha creato mostri estetici e non solo in ambito registico. La competenza musicale di un regista è l’unico modo che un regista ha per garantirsi la libertà interpretativa. Nella mia piccola esperienza mi sono trovato a discutere con dei registi, perché mi sembrava che le loro idee non collimassero con le mie. In effetti era così, ma poi ho colto che l’interpretazione musicale della mia opera era corretta, fondata su ineccepibili presupposti, semplicemente metteva in luce un altro aspetto della drammaturgia musicale, non messo a fuoco nemmeno dal sottoscritto. Giorgio Pestelli cantiere regia Pur assecondando le esigenze visive dei tempi moderni (in particolare phisique du rôle degli interpreti, dignità figurativa delle scene ecc.), la regìa operistica deve partire dal presupposto che la drammaturgìa di un’opera è definita dalla musica: monologhi e pezzi d’assieme, caso, quelle cioè di una cultura che si autodistrugge perché delude l’utenza generale, pur solleticando un’élite fanatica. Di questo rischio pochi, di quanti fanno cultura, sono là a prenderne coscienza e non so di quale generazione visto che il trend di chi si lascia tentare da provocazione e dissacrazione è trasversale ed attacca come una malattia differenti età. Ma questi pochi sembrerebbero ormai frange di un mondo in estinzione, un mondo che guarda ancora con pudore a quel rapporto musica/teatro che ha animato i dibattiti del Novecento (ohimè un secolo fa!) ed incendiato i sogni dei grandi compositori. Cos’è la drammaturgia? Quelli del new trend se lo chiedono? Non mi sembrerebbe. Già il libretto tout court è stato abbandonato da tempo. Il sottoscritto, pur non rigorosamente osservante, lo ha sempre ritenuto un onesto moderatore dell’arbitrio, un buon vecchio a cui chiedere consiglio per evitare di dirottare il racconto scenico nella irrazionalità dell’azione senza punti di riferimento. Quello che comunque considero elemento irrinunciabile è una drammaturgia che parte dalla musica, che costituisce l’evento scenico alimentandolo con i significati profondi che la musica emana. Eppure oggi non è così! Una verità che sembrerebbe innegabile è contraddetta da una evidenza spesso disarmante. La maggior parte della new dramaturg y parte invece da se stessa, da un proprio arbitrio, da un’idea, una scintilla prometeica che presume di infiammare tutto il palcoscenico, in realtà umilia la musica, riducendola ad ancella, reinventando una trama arbitraria con cui la partitura lotta vanamente, soccombendo. Ma questa idea non ha per lo più evoluzione, stagna su se stessa, non è drammaturgia poiché ignora lo sviluppo musicale, i processi percettivi. Allora è spesso lo scandalo, ad erigersi a demiurgo, quella provocazione che spesso seduce direttori dei teatri, ansiosi di essere à la attese e soluzioni, pause fra un scena e l’altra, musica di interni e di esterni, musica notturna e diurna ecc., e quindi non deve contraddire queste posizioni morali e questi «ambienti». L’errore più grave di una regìa è quello di credere che la musica sia insufficiente con i suoi mezzi a significare una idea e che pertanto necessiti di una regìa che espliciti idee facili da cogliere, anche se estranee o contrarie a quelle su cui quell’opera è nata. Naturalmente, il criterio vale in generale e sarà da fare anche una distinzione da un’opera a un’altra; di solito, i capolavori hanno una regìa implicita già realizzata cui è bene attenersi (e il regista di genio saprà sviluppare i motivi dell’opera, metterci «del suo» anche senza smentire quello che l’opera dice da sola), mentre opere problematiche o parzialmente riuscite possono o devono servirsi di un intervento registico più personale, inventivo e innovatore. Pier’Alli Moderni, non attuali La questione se ci sono elementi essenziali ed irrinunciabili nella regia del teatro musicale di oggi, lascia sottintendere un pericolo in atto, ma è altresì fragile ed intempestiva dal momento che quasi tutte la fortezze del buon senso e del gusto sembrano ormai espugnate. Da molte parti si plaude a questa sorta di invasione barbarica, in un clima di globalizzazione innovativa che sembra modernità. Per molti versi direi distruttiva di un’autentica memoria e di una cultura che ci appartiene! Mi auguro infatti che questo quesito, sanamente posto, nasconda il grave sospetto, se non la paura, che sia la musica stessa ad essere in pericolo. Con tutte le conseguenze del page, cioè europei. Quando non è, più fortunatamente, lo scandalo è un assillo spietato ad attualizzare ad ogni costo, manipolando ogni credibilità della storia, con la pretestuosità di un concetto che fa violenza alla stessa ragione di esistere della musica. Quando non è tutto questo, è la religione minimalista che svuota il palcoscenico sostenendo con molta arroganza intellettuale che il concetto è più forte di una scenografia, che la musica va pensata e che è compito dello spettatore riempire il nulla con la propria immaginazione. In poche parole una candela è più emozionante di un incendio che la partitura prescrive. Nel paradosso ciò può essere anche vero, se non fosse il melodramma a stabilire una proporzione inconfutabile tra un evento grandioso dell’orchestra ed il suo riflesso visivo sulla scena. Davanti a questo spettacolo desolante il direttore persiste a dirigere, con il suo sacro fuoco, un mondo che sta solo nella partitura, ma che il palcoscenico ignora, anzi destituisce. Non si aggiunge spesso a tutto questo l’astuzia di elevare a filosofia un problema finanziario? Resta comunque il fatto che questi stilemi della new dramaturg y, quando non sono frutto di una geniale intuizione, che allora vanifica qualsiasi riserva, diventano rapidamente obsoleti, un cliché di semplificazioni brutali, feticci di una filosofia della negatività che vede il mondo sempre come un campo di sterminio, un manicomio dell’alienazione, una latrina degli affetti, un deserto delle illusioni. E quanto terrore della storicità e del costume! Che in questi ghetti del pensiero le trame dell’opera funzionino non ha pressoché nessuna importanza, importante è fare tendenza e lucrarvi possibilmente, come avviene nelle arti visive. È sufficiente una critica autoreferenziale a perpetuarne il faticoso ed inutile ripetersi. La messa in scena italiana soffre, è inutile negarlo, un complesso di inferiorità di fronte all’arroganza intellettuale nordica che vuol colonizzare con una nuova estetica, la terra troppo solare del melo- 48 — cantiere regia pito dalla ipocrita mediocrità del comportamento etico dei «Germont», nessuno andando a teatro si lascia coinvolgere, come «Emma Bovary» nel teatro di Rouen, dal «sestetto» della Lucia di Lammermoor. Pur tuttavia lo spettacolo lirico continua a mantenere inalterata la sua capacità di emozionarci, farci riflettere, offrirci opportunità conoscitive nuove, ma tutte queste passano principalmente attraverso gli aspetti visivi dello spettacolo ed è qui che risiedono le ragioni di interesse per l’opera dal vivo. Personalmente sono profondamente interessato e difendo le ragioni di quello che viene definito oggi il «teatro di regia». Quell’idea di teatro che era nata nelle esperienze pionieristiche della «Kroll Oper» di Berlino diretta da Otto Klemperer tra il 1927 ed il 1931 o nel lavoro di Max Reinhardt a Salisburgo o più recentemente negli spettacoli di Walter Felsenstein alla «Komische Oper» di Berlino negli anni cinquanta e sessanta. Teatro di regia a cui, volenti o nolenti, dobbiamo anche buona parte delle ragioni dell’interesse, della persistenza e della vitalità del teatro lirico in questi inizi del XXI secolo. Ma la regia lirica, che alla fine degli anni venti, proprio nei paesi di lingua tedesca gettava le fondamenta anche teoriche del suo sviluppo, non era e non può essere considerata come un lavoro, per quanto elegante e raffinato, di semplice invenzione scenografica o di creatività nei costumi, al contrario, la regia è tutt’altra cosa. E se il teatro di prosa ha elaborato una serie di riflessioni teoriche e di esperienze concrete sui protocolli del suo modus operandi (da Stanislavski o da Antoine all’attualità più recente)2 non sempre ciò è successo al teatro lirico, che ancor oggi molte volte sembra vivere come nelle prove del dramma giocoso donizettiano delle Convenienze ed inconvenienze teatrali, seppur aggiornate. Sono convinto che solo una continua innovazione registica pos- municare a suo modo i suoi segreti, facendo in modo che questi segreti continuino ad essere sorgente di verità profonde. Negli ultimi trent’anni abbiamo assistito ad un interesse sempre maggiore nella vita dei teatri lirici per la dimensione registica, per le ragioni dello spettacolo. Vero protagonista della furtuna di un’opera lirica non è più il cantante, come accadeva agli inizi del secolo scorso quando nasceva l’opera di repertorio con la celebre Aida del centenario all’Arena di Verona, promossa dal tenore Giuseppe Zanatello; non lo è più il direttore d’orchestra, come accadeva negli anni cinquanta e sessanta, con la memoria delle grandi star dei primi «microsolco», da Furtwaengler a von Karajan, da Boehm a Solti; artefice del successo è diventato oggi il regista. A lui sono affidate in gran parte le ragioni del risultato o meno di uno spettacolo, sul suo lavoro si concentra il grande interesse della stampa specializzata e del lavoro delle direzioni artistiche, sono gli aspetti scenografici e registici a determinare ampie e vivaci discussioni nel pubblico. Di questo mutamento varie sono le possibili ragioni. È evidente che con la nascita del repertorio sono mutate le ragioni di fruizione dello spettacolo, senza scomodare Adorno e la sua analisi relativa al fatto che «la ricezione di determinati prodotti musicali può allontanarsi fino alla rottura dalle loro origine e dal loro senso sociali»,1 oggi il frequentare il teatro lirico adempie a funzioni sociali ed estetiche molto diverse. Nessuno, asssistendo oggi ad una Traviata, è col- sa mantener vivo l’interesse per l’opera, innovazione che significa intelligente dialogo tra un testo che appartiene ad un passato piu o meno lontano e il presente, in un dialogo tra un sistema di convenzioni, che non si possono dimenticare, e la nostra contemporaneità. Limitare la questione ad un problema di fedeltà alla tradizione è una maniera errata di porre la questione, è un falso problema: la tradizione registica non esiste, se non come creazione di ciò che noi crediamo sia una tradizione. Quando il 29 ottobre del 1789 al Teatro Nazionale di Praga iniziò la fortunata e ancora oggi viva avventura del Don Giovanni mozartiano, il teatro era illuminato alla luce delle candele. Che cosa significa oggi rispetto di una presunta tradizione registica del Don Giovanni mozartiano? Significa regredire ad una forma di spettacolo che prescinda dalla luce elettrica nella sala? La regia lirica è un atto inevitabile di interpretazione, di traduzione, di reinvenzione continua, è un atto ermeneutico a cui non credo sia né possibile né legittimo porre dei limiti. Se pensiamo al metodo di lavoro di Felsenstein nella sua «Komische Oper» su alcuni testi più o meno celeberrimi, con cantanti non certamente famosi (Carmen (1949), Flauto magico (1954), Traviata (1955), La piccola volpe astuta (1956), Les contes d’Hoffmann (1958), Otello (1959), ci troviamo di fronte ad un vero lavoro di «regia teatrale». Lavoro che iniziava indiscutibilmente con un lungo periodo di prove e certamente i suoi cantanti non erano le star discografiche che volano da un teatro all’altro in maniera fin troppo disinvolta. O se pensiamo ai tempi di prove richiesti da Strehler e la sua polemica con la direzione del Festival di Salisburgo rispetto alla realizzazio- 1 T.W.Adorno, L’opera lirica, in Intrdoduzione alla sociologia della musica, Torino Einaudi, 1971, p.87. 2 Cfr. Les répétitions de Stanislavski a aujourd’hui, a cura de Georges Banu, Arles, Actes Sud, 2005. cantiere regia dramma per importarvi brume e desolazione, clonando fantasmi nati da traumi bellici, da sensi di colpa che l’arte pretende esorcizzare rifiutando se stessa, il gioco, negando la bellezza. Chi parla esperimentò negli anni novanta nuovi linguaggi per creare Wagner in una modernità espressiva. Trasformò il palcoscenico in un campo di visioni illimitate, introducendo il cinema come mezzo ideale per narrare il mito e la Weltanschaung wagneriana. Oppure, per contro a questa grandeur del teatro totale, realizzò quel modello di teatro musicale, minimalista, un vuoto bianco assoluto con corpi/oggetto, che fu il beckettiano «Winnie dello Sguardo». In altre parole, fui e sono paladino della modernità che non vuole dire mera provocante attualità. Credo cioè nella modernità del linguaggio, non nella spoliazione del senso misterioso della musica. Quello che viene tradito, quando non è deriso, nello scenario che ho descritto, è il senso stesso del melodramma, il suo valore simbolico nella rappresentazione del mondo. È evidente che solo in questa prospettiva le vicende, per lo più improbabili raccontate dal dramma musicale, assumono una valenza che va ben oltre la problematica psicologica o politica dell’hinc et nunc. Oggi è il mistero stesso della musica che rischia di essere svuotato, la sostanza metaforica dell’azione musicale, quella sua capacità di comunicare con gli archetipi, di rendere vera l’illusione, palpabile il sogno. Illusione, sogno, sacralità, sono relitti di una società di trasformazione così profonda da voler distruggere la propria memoria? Non posso e non voglio credere che la scena voglia rappresentare la propria morte e negare allo spettatore di domani l’autenticità, la necessità vitale del suo desiderio, quello di specchiarsi nella musica come atto di immersione catartica e di trascendenza. Se resta imprescindibile questa fede, bisogna considerare ineludibile il senso di una drammaturgia con la quale la musica possa co- Paolo Pinamonti cantiere regia — 49 ne del Flauto magico proprio su questo tema del tempo a disposizione delle prove,3 o se più recentemente riflettiamo sul metodo di lavoro di Herbert Wernicke, uno dei maggiori registi dell’ultima generazione prematuramente scomparso,4 e che in Italia non ha quasi mai lavorato, con il quale lo spettacolo nasceva già nelle audizioni preliminari per la scelta dei cantanti, audizioni che lui voleva fare con la direzione del teatro e con il direttore musicale; possiamo cogliere il significato più vero di un serio teatro di regia. Solo nel momento in cui i «registi» chiedono ai direttori dei teatri dei lunghi periodi di prove con i cantanti (anche se siamo comunque ben lontano dai tempi di lavoro degli stessi registi con gli attori per preparare qualsivoglia spettacolo di prosa!), solo in questo caso credo si possa parlare di vero teatro di regia. E qui dobbiamo aprire una dolorosa parentesi, quanti, di coloro che fanno il mestiere di dirigere un teatro lirico o un festival, hanno la forza di vincere le resistenze dei cantanti, dei loro agenti e le pressioni del cosiddetto «star system», predisponendo dei piani prove adeguati e dei tempi di maturazione di uno spettacolo corrispondenti ad un progetto registico e musicale condiviso tra direttore, regista, scenografo e cantanti? O preferiscono cedere alle istanze dell’economia dello spettacolo, alle esigenze dei cantanti e ridurre i tempi di produzione? Solo seri tempi di prova garantiscono la possibilità di liberare lo spettacolo da quegli stereotipi di una recitazione lirica che, come notava alla fine degli anni venti Heinrich Ströbel, facevano si che il termine Opernhaft, «operistico», fosse sinonimo di polveroso, vecchio, ripetitivo, stantio.5 L’esatto contrario di quella grande forza emotiva che Monteverdi rivendicava allo «stile rappresentatitivo» e che costituisce ancor oggi un elemento di grande vitalità. Un interessante «teatro di regia» nasce anche e soprattutto quan- Pier Luigi Pizzi do il regista sa partire dalla musica, sa far nascere lo spettacolo dalla specifica drammaturgia musicale, dalla concretezza della invenzione musicale, con i sui tempi, le sue suggestioni «affettive», il suo particolare sistema di convenzioni. Come scriveva Berg: «Anche per il lavoro di regia si presuppone una conoscenza precisa della musica».6 Quella conoscenza della musica che fra i registi delle ultime generazioni, Giorgio Strehler o Luca Ronconi, Achim Freyer o Herbert Wernicke, Graham Vick o Klaus Michael Grüber, Peter Brook o Stephan Braunschweig, Bob Wilson o Luc Bondy, David Poutney o Robert Carsen, Peter Stein o Christoph Marthaler, Eimuntas Nekrosius o Peter Konwitschny, Günter Krämer o i fratelli Hermann, Toni Servillo o David Mc Vickar, Pier Luigi Pizzi o Lluis Pasqual, Andrei Serban o Emilio Sagi, Mario Martone o Damiano Michieletto, Klaus Guth o David Alden, Patrice Chéreau o Alex Olle e Carlos Padrissa hanno dimostrato di possedere. sa cultura teatrale dei cantanti e dei direttori d’orchestra). Ricordo l’ultima volta che ho visto un autorevole collega tedesco, noto specialista di Bellini: mi confidò che il suo più grande cruccio, abitando in Germania dopo trent’anni di vita italiana, non era la cucina o il clima, bensì l’aver dovuto rinunciare ad andare all’opera «per colpa di quelle orrende regìe alla tedesca». E faceva l’esempio della Semiramide nell’astronave di Star Trek o di Violetta in chemioterapia. Eppure, se non si basa su un «Konzept» del tutto estraneo alle dinamiche e ai possibilia testuali, anche una regìa che forzi il tradizionale modo di interpretare un’opera può contribuire a far emergere nuovi strati di senso e nuove potenzialità di lettura. L’abbiamo sperimentato tante volte con i lavori di Patrice Chéreau, Peter Brook, Jonathan Miller, Robert Carsen, ecc. E poi non è affatto detto che l’allestimento più «tradizionale» sia necessariamente più vicino ai valori immanenti del testo (a parte il fatto che tali valori, come dicevamo, non sono immobili e immutabili). La morte di Mimì è chiarissimamente indicata tanto nell’autografo di Puccini quanto nel livret de mise en scène di Albert Carré per la ripresa dell’opera a Parigi (con Puccini presente). Mimì muore, anzi si addormenta, senza che nessuno se ne debba accorgere, quando il motivo di reminiscenza si interrompe sulla dominante di re bemolle maggiore. Segue una lunga pausa. Ma è una tradizione diffusa (e sbagliata) accorciare la pausa e far morire Mimì in corrispondenza del successivo accordo di si minore, facendo perdipiù cadere in quel momento il braccio inerte di Mimì dal manicotto. Il «tradizionalista» Zeffirelli fa così, ma nell’attualizzazione di Baz Luhrmann, che in molti considererebbero antipucciniana, si ritorna al dettato d’autore. Ecco: delle due tendenze che animano il lavoro registico, quella estetico-teatrale (lo spettacolo in sé) e quella drammaturgico-interpretativa (il rapporto col testo), io credo che la seconda non debba mai essere sacrificata al- Per il regista teatrale è imprescindibile la più assoluta LIBERTÀ di interpretazione, concezione ed espressione, al servizio di un TEATRO ETICO, non condizionato da pressioni politiche, non influenzato da settarismi, non limitato da pregiudizi, non fuorviato dalle mode, guidato dal rispetto per chi ha creato la musica e i testi da rappresentare, rassicurato dalla fiducia nel proprio mestiere, aperto alla ricerca e all’evoluzione, disposto all’autocritica, ostile a tutto ciò che è sistematico, convincente nella proposizione del progetto artistico, capace di stupire, di sedurre, di suscitare emozioni. Emilio Sala cantiere regia Se vogliamo pensare l’opera come genere teatrale, e non come concerto scenicamente travestito, ogni discussione anche aspra ma costruttiva sui problemi della sua realizzazione registico-spettacolare deve essere salutata con gioia. Tanto più che, a parte le solite geremiadi dei tradizionalisti nostalgici, tale discussione è del tutto assente nel dibattito culturale. Orbene, partendo da una concezione del testo come processo, più che come stato cristallizzato una volta per tutte, è evidente che, nell’ambito di performing arts quali il teatro e la musica, la messinscena e l’esecuzione corrispondono a momenti relativamente autonomi in cui il testo viene continuamente riaggiornato e rivitalizzato. C’è chi ritiene che l’enorme sviluppo novecentesco del «teatro di regìa» abbia reso fin troppo autonomo il testo-performance con il risultato dei separati in casa: la musica dice una cosa e lo spettacolo ne dice un’altra. E non c’è dubbio che quello della scarsa cultura musicale dei registi sia un problema reale (come lo è la scar- 3 Cfr. Giorgio Strehler per il Flauto magico (1974). 12 propositi di regia, 4 note e un’intervista, a cura di Loredana Manni, in «Acustical Arts and Artifacts – Technology, Aesthetics, Communication», an international Journal, promosso dall’Istituto per la musica della Fondazione G. Cini di Venezia, n.4, 2007, pp.9-12. 4 Sull’attività di Herbert Wernicke (1946-2002) si veda: Harmonie bleibet Utopie. Herbert Wernicke Regisseur und Bühnenbildner, Berlin, catalogo dell’esposizione curata dalla Akademie der Künste 29 gennaio – 26 marzo 2006. 5 «Das Veraltete, Hohle, Aufgeputza nannte man geringschätzig ‘opernhaft’». Cfr. Heinrich Ströbel, Klemperers «Holländer», in «Melos», 1929, febbraio, ristampato in «Melos», 1958, gennaio, p. 28. 6 Alban Berg, Istruzioni pratiche per lo studio di Wozzeck, in Suite lirica, a cura di Anna M.Morazzoni, Milano, Il Saggiatore, 1995, pp.23-30:28, 50 — cantiere regia la prima. Certo, ci sono delle regìe drammaturgicamente inesistenti e teatralmente stupende (vedi, spesso, gli spettacoli operistici di Robert Wilson). Ma, se si vuol far del bene all’opera, per me è irrinunciabile partire sempre dalla drammaturgia musicale e costruire lo spettacolo senza dimenticare mai il rapporto con i valori, certo instabili epperò riconoscibili, del testo. Toni Servillo cantiere regia Io lavoro fondamentalmente nella prosa, anche se ho alle spalle una decina di allestimenti lirici. Quello che l’esperienza mi insegna è che nel teatro parlato l’occasione e il momento fondamentale che vanno coltivati sono quelli dell’hic et nunc, cioè dell’essere lì in quel momento, vale a dire la ricerca di un’efficacia tutta legata all’atto, con il suo corredo di matericità e di fisicità. La differenza con la lirica è che se pure anch’essa contiene un momento di teatro come quello che ho appena descritto, essendo la musica sua componente essenziale questa dimensione del tempo viene dalla stessa musica naturalmente spostata e condotta in una zona di atemporalità emotiva, riportando indietro le nostre emozioni, o al contrario proiettandole in avanti. L’hic et nunc è sollevato dalla sua materialità e contingenza. Da qui deriva il problema della regia lirica, che deve tenere costantemente gli occhi puntati sulla drammaturgia musicale, più che a quella che nasce dal libretto (che comunque non intendo sminuire, perché la sua funzione è molto importante). Ma la drammaturgia sta tutta nella musica, e l’efficacia di una regia d’opera credo stia proprio in questo equilibrio di piani di lettura tra ciò che ci passa sotto gli occhi e ciò che la musica sottrae alla visione e impone all’ascolto, in una maniera che a volte sorprendentemente contraddice ciò A parte il legittimo dubbio sull’utilità di molte di queste operazioni, poiché se si tratta di riproporre la Traviata per farla conoscere dal vivo a un pubblico auspicabilmente più giovane, o per darne nuovo godimento agli appassionati di sempre, penso che spesso sarebbe sufficiente riproporre alcuni degli allestimenti consacrati, il che svolgerebbe un buon compito di divulgazione, abbattendo nel contempo i costi. Affinché abbia senso una nuova regia di un’opera estremamente di repertorio bisogna essere davvero sicuri che il regista sia in grado di proporre una nuova visione, un taglio che riveli aspetti non indagati. Il che è assai raro. Confesso di essere molto diffidente però su buona parte di quelle regie che, soprattutto qualche decennio fa, si sovrapponevano all’opera stessa, spesso snaturandola, rivelando per lo più una mania di protagonismo del regista: la migliore nuova regia di un’opera nota è a mio parere quella di chi riesce a integrare novità di punto di vista e rispetto per l’impianto narrativo originario. I due estremi opposti (tautologico raddoppio di una narrazione iper-nota o suo totale stravolgimento) sono per me inutile il primo e irritante il secondo. Caso differente è quello in cui si sia di fronte ad un’opera di tradizione di minore notorietà, vuoi in quanto opera minore di autore noto, vuoi in quanto meno noto l’autore stesso. In questo caso la regia ha una doppia responsabilità, poiché si tratta sia di far conoscere l’opera stessa, quasi certamente ignota ai più, sia di giustificarne la ripresa in tempi moderni, trovandone il senso nell’oggi. Il margine d’azione è certo stretto e l’equilibrio difficile. Vi è poi l’altro caso, quello che ovviamente mi interessa di più, cioè il compito della regia in un’opera in prima esecuzione. La cosa mi tocca assai da vicino, in quanto proprio in questi giorni sta andando in scena la mia prima opera al Teatro Verdi di Trieste e in quanto una seconda è in progetto e sarà messa in scena nel settem- che si vede. Da spettatore uno spettacolo lirico, quando è al massimo delle sue potenzialità espressive, mi ripropone l’emozione forte, radicale, profonda, scandalosa di una scena primaria in termini psicanalitici. Molto spesso anche in un’opera lunga e complessissima, che affronta i temi più svariati, c’è un punto nel quale questa componente di drammaturgia musicale, di sollecitazione sensoriale ci porta in zone altre del nostro vissuto, non necessariamente legate al momento cui stiamo assistendo. E questo permette di risvegliare in noi ora il senso di colpa, ora la scoperta dell’erotismo, ora un rapporto filiale, ora una sfrenata ambizione... È una vera e propria scena primaria, come ho detto. Di conseguenza l’operazione registica a mio parere dovrebbe tendere a mettere in equilibrio l’hic et nunc del teatro in sé – che è la materia del libretto – e la drammaturgia musicale, in un pareggio equilibrato (per quanto possibile) che faccia scaturire nel cuore dello spettatore le emozioni profonde legate a una sfera inconscia. Alessandro Solbiati Penso che la risposta vada suddivisa: ben diversa infatti è, nel teatro musicale, la responsabilità della regia in caso di allestimento di un’opera di tradizione e, invece, nel caso della messa in scena di un’opera nuova. Partiamo dalle opere di tradizione, rispetto le quali il regista diviene vero e proprio «autore» dello spettacolo, data l’assenza del compositore: anche qui, e non per eccesso di sottigliezza, distinguerei due casi. Molto spesso, anzi, troppo spesso, per quanto riguarda i teatri italiani, si è di fronte a nuovi allestimenti di opere estremamente note. bre 2011. Un’opera nuova DEVE essere un’affascinante avventura a due tra compositore e regista, anzi a tre, comprendendo anche lo scenografo. Penso non si possa più concepire il caso in cui il compositore componga autisticamente solo e il regista intervenga in seguito, in totale autonomia: mi ritengo molto fortunato nell’essermi potuto avvalere in entrambi i casi che mi concernono, uno giunto alla sua attuazione ed uno ancora tutto da realizzare, di quello che ho sempre sognato essere il rapporto autore-regista, e questo anche perché sono stato splendidamente aiutato dai teatri committenti: ho potutocioè lavorare con i registi prescelti, e prescelti in base a precisi requisiti di sintonia personale ed artistica, ben prima di incominciare la composizione, stabilendo un rapporto di nutrimento reciproco tra idee sceniche e atto compositivo. Penso che questo sia irrinunciabile ed essenziale nella regia di una nuova opera: il lavoro coordinato con il compositore durante, e non dopo, la composizione crea le condizioni per dar forma nel miglior modo possibile al cuore stesso di un’opera di teatro musicale, il perfetto equilibrio tra gesto scenico e gesto musicale, tra arco narrativo sul palcoscenico e in buca. Come già dicevo per quanto riguarda un’opera di tradizione, ancor più in un’opera nuova scena e musica non si devono raddoppiare didascalicamente, ma devono procedere in forte relazione reciproca eppure in autonomia, nutrendosi ed arricchendosi a vicenda. Affinché ciò succeda, è necessario che il compositore comunichi le sue «fantasie sceniche» al regista al momento del progetto compositivo e che il regista gli rimbalzi tali fantasie, arricchite ed eventualmente modificate dalla sua esperienza e dalla sua creatività, con la possibilità di ampliare l’immaginario non soltanto scenico del compositore ma anche quello strettamente musicale, se il compositore è in grado, e deve esserlo, di mettersi in gioco. cantiere regia — 51 Luigi Squarzina Dino Villatico Il palcoscenico ritrovato Per una parte del pubblico italiano, incredibile, ma ancora oggi il melodramma non è teatro, bensì una sorta di concerto in costume, una masherata musicale. Il gioco delle scene deve apparire come un caleidoscopio sorprendente. Abbassato al gusto mediocre di un popolo mediocremente istruito (la percetuale di laureati in Italia, compresi i paesi dell’Est, è la più bassa di Europa e lo stesso dicasi per la percentuale di laureati che seggono al Senato e in Parlamento, e stendiamo un velo pietoso sul livello dell’istruzione musicale anche dell’italiano che si dice colto), il gusto del pubblico italiano è disinformato e spaventosamente in ritardo rispetto a ciò che accade nei teatri del mondo: basti vedere di che livello e di che tensione intellettuale sono gli spettacoli che ci vengono per esempio dalla Lituania. Ma inoltre il pubblico italiano si dimostra in genere anche poco interessato a conoscere come va e che fa il resto del mondo, pa- cantiere regia La differenza principale tra la prosa e la lirica – per quanto possa sembrare banale – sta tutta nella durata. Un’opera può variare al massimo di uno, due minuti, bisogna sempre obbedire alla musica. Più ancora che al libretto. O meglio: bisogna considerare i rapporti tra libretto e musica e non sempre questi rapporti sono facilmente definibili. Si parla spesso male dei libretti, ma ci sono parole straordinarie, che funzionano proprio perché il compositore stava appresso al librettista, lo tartassava. Questo il regista deve capirlo, deve creare un vero e proprio wortondrama. In fondo Wagner ha codificato quello che è sempre stato. Un’altra cosa importante è l’elemento visivo, che deve sempre creare stupore, deve insomma interpretare lo spirito dell’opera in modo inatteso. Cosicché la gente, spontaneamente, dica tra sé: «Non avevo mai pensato a questo». Personalmente appartengo alla schiera – piuttosto numerosa – dei registi che passano dalla prosa alla lirica senza conoscere la musica, e quindi hanno bisogno di un grande aiuto. Hanno soprattutto la necessità di frequentare molto il direttore d’orchestra. In tutt’Europa, e specialmente in Germania, c’è un grande teatro di repertorio, dove La traviata o Sigfrido sono allestiti contemporaneamente da dieci teatri. Loro quindi devono per forza mandare in scena Sigfrido in bicicletta, oppure vestito da palombaro. Noi non siamo costretti a questo. Se inventiamo non è perché lottiamo contro una possibile assuefazione, lottiamo semmai contro la tradizione, che rappresenta il passato. abbi trovato una parola corrispondentissima proprissima equivalentissima, tuttavia non hai fatto niente se questa parola non è nuova e non fà quell’impressione che facea nei greci”(il corsivo è mio). E traggo dal libro sapienziale per eccellenza del Novecento questa affermazione che mi giustifica: «In realtà ogni lettore, quando legge, è il lettore di sé stesso. L’opera è solo una sorta di strumento ottico che lo scrittore offre al lettore per consentirgli di scoprire ciò che forse, senza il libro, non avrebbe visto in sé stesso. Il riconoscimento dentro di sé, da parte del lettore, di ciò che il libro dice, è la prova della sua verità»(Marcel Proust). Federico Tiezzi Se mi chiedo cosa sia la regia lirica, mi viene in mente di dire: la conoscenza e approfondimento della musica, della quale la regia compie, attraverso la scrittura scenica, un equivalente (penso a Longhi/ Piero della Francesca). La musica è il nostro testo sia nelle sue strutture armoniche sia sulle necessità ritmiche e di tempo. Ogni regista parla personalmente con la musica: nel mio caso il colloquio è anche con il musicista, primo creatore, che spesso mi appare, fantasma, in sogno nei giorni precedenti alle prove, a comunicarmi la sua volontà. E così dopo avere studiato a fondo la musica per capire cosa vuole, ecco che, secondo le indicazioni del mio maestro Edward Gordon Craig, posso eseguire, tradurre il testo nel mio teatro secondo il principio warburghiano delle tavole d’orientamento. Al finale c’è la creazione di immagini del profondo, capaci di legarsi in una catena di miele e di rose, allo spettatore: immagini da udire, musica da vedere. Mi è insomma indifferente lo stile antico o moderno di espressione: valuto solo la relazione strutturale e musicale. Sì, anche l’idea, l’invenzione, nella sua novità e unità rispetto al dramma. Sì, anche la necessità rispetto all’idea prima del regista. Amo Leopardi. Mi affido a un suo brano che esprime al meglio l’idea di traduzione che affido al regista: «Molte volte noi troviamo nell’autore che traduciamo, per esempio greco, un composto, una parola che ci pare ardita, e nel renderla ci studiamo di trovargliene una che equivalga, e fatto questo siamo contenti. Ma spessissimo quel composto o parola comeché sia, non solamente era ardito, ma l’autore la formava allora a bella posta, e però nei lettori greci faceva quell’impressione e risaltava nello scritto come fanno le parole nuove di zecca, e come in noi italiani fanno quelle tante parole dell’Alfieri, per esempio spiemontizzare... Onde tu che traduci, posto ancora che go di una vanagloria autoreferenziale. La sorpresa barocca che animava gli spettacoli del melodramma seicentesco si è oggi immiserita nello sfarzo posticcio di qualche stoffa di plastica e nell’effetto bozzettistico di qualche piazza o paesaggio di pacchiano realismo: «Uh! sembra proprio Parigi», esclamerà qualcuno ad apertura di sipario sulla soffitta di Rodolfo, oppure si vedranno donnette con le ceste piene di verdure e formaggi avviarsi al cortile del carcere dov’è imprigionato Florestano (non invento: l’ho visto con i miei occhi!). E perciò le grida di protesta, le urla scomposte, i fischi, i buuh quando un improvvido regista abituato a leggere Shakespeare come un drammaturgo di oggi commette l’imperdonabile crimine di credere che anche Verdi sia un drammaturgo di oggi. Ma come! Violetta con gli abiti di Armani o le pellicce di Fendi? E perché no? L’opera venne rappresentata sulle scene del Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853, il libretto colloca l’azione a «Parigi e sue vicinanze, nel 1850 circa». La cosa destò scalpore e per la prima si retrocesse l’azione di un secolo. Ma già l’anno dopo vennero rispettate le indicazioni del libretto. Ciò significa che gli abiti sulla scena e quelli nei palchi e tra la gente in piedi in platea, di dame e di cavalieri, fossero di foggia simile. E le suppellettili, sedie, divani, poltrone, scrivanie, tavoli da gioco, le stesse di qualunque casa borghese del tempo. Come in un’opera buffa. E qui stava lo scandalo: non già l’ambientazione contemporanea in sé, che nell’opera comica era di regola, ma che l’ambientazione fosse contemporanea in un’opera seria, vale a dire in una vicenda tragica. Si possono scrivere commedie dell’oggi, ma tragedie solo del passato. Come se Racine non avesse mai scritto un Bajazet! Il pubblico poi si abituò, e l’ambientazione ottocentesca restò, al punto che Violetta è immaginata sempre in abiti romantici o, tutt’al più, come fece Visconti, del Secondo Impero. In tal modo però si perde proprio quell’effetto di contemporaneità voluto sia da 52 — cantiere regia Sans que de tout le jour je puisse voir Titus.7 La bellezza suprema del passo è anche affidata al calcolo delle rime: «même», stesso, riferito a «vous», voi, voi stesso, che fa rima con «aime», ama, come se la donna volesse una conferma verbale, oggettiva, col solo pronome, di un amore che invece le viene negato, «nous» e «vous» che fanno rima, noi e voi, quasi a unirli, e la rima terribile «Bérénice» «finisse», Berenice, finisca. «Titus» resta isolato, separato da ««Bérénice», ad attuare una separazione anche nella rima, tra i due amanti. La rima arriva con il verso seguente: ed è terribile! Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus!8 «Titus» fa dunque rima con «perdus», perduti. È come l’eco sonora della catastrofe temuta, Berenice si dice da se stessa che per lei Tito è perduto. ÈÈ molto più che una premonizione: è la previsione di ciò che accadrà tra breve. Il conflitto tragico tra ciò che si vorrebbe e ciò che non è permesso è abissale: non c’è bisogno di dei o di fato, è finito un amore, e nessuna volontà può rianimarlo. Come Fedra è innocente della passione che la travolge, Tito è incolpevole del fatto di non amare più Berenice. Non potrebbe più amarla nemmeno se si obbligasse ad amarla. Berenice dal canto suo sa che la fine di quell’amore è anche la fine della sua vita (e così avverrà). Se mi sono così dilungato nell’analisi di questi versi, sublimi quanto quelli di Saffo, o più tardi di Baudelaire («Sois sage, ô ma Douleur!»9), quasi fosse l’analisi di un’aria, non è per caso. Racine mobilita tutto un repertorio retorico che rinnova dall’interno, musicalmente, e non solo per via delle rime, ma con le riprese tematiche, le ripetizioni, i concatenamenti d’immagini, di parole, e di suoni: «dans un mois, dans un an»; poi amplificato, quasi uno sviluppo te- cantiere regia Verdi che da Piave (e prima di loro da Dumas figlio). Tra l’altro un aspetto notevole di quest’attenzione alla contemporaneità è il fatto che la commedia di Dumas sia solo dell’anno prima, 1852. Così come era un seccesso recente (1836) sulle scene di Madrid il dramma El Trobador di Antonio García Gutiérrez su cui si basa l’opera omonima (cioè, in italiano: Il Trovatore) di Verdi. Ciò ci induce a riflettere su due cose: che anche il melodramma è teatro, ed è sempre teatro contemporaneo, anche quando proietta l’azione in epoche passate. Nel Giulio Cesare di Shakespeare, il condottiero romano apostrofa sua moglie Calpurnia con l’epiteto di «madam». E lo stesso fa Tito nella Berenice di Racine, che si rivolge alla sua amante chiamandola «madame» e per di più dandole del voi. Il termine madame (da mea domina) era ignoto agli antichi romani, così come l’uso del pronome di cortesia. Nel Re Giovanni Shakespeare, inoltre, fa sparare i cannoni, che faranno la loro comparsa solo due secoli dopo. E per indietreggiare alle origini del teatro occidentale, nell’Edipo a Colono di Sofocle Teseo indice una votazione popolare per decidere le sorti del vecchio Edipo cieco. In un’epoca che si suppone mitica e in cui goveranavano dei monarchi assoluti e nella quale dunque non esistevano assemblee, e tanto meno assemblee popolari democraticamente elette, che votassero decisioni politiche: Teseo era anche lui un monarca assoluto, ma nella tragedia di Sofocle si comporta come Pericle, e come se fosse lo stratego a capo di uno stato democratico. Ciò non vuol dire che la contemporaneità debba essere sempre esplicitata dalla messinscena. La congruità va vista volta per volta. E del resto nessun sistema garantisce il risultato. Si può fare uno spettacolo bello sia realizzando visivamente le indicazioni temporali del testo sia ignorandole. Del resto chiunque abbia una certa familiarità con il fare artistico sa che non esistono regole per garantire la bellezza. Le regole garantiscono solo la coerenza di ciò che si fa. Si può scri- vere una bella tragedia sia rispettando le unità aristoteliche (in realtà Aristotele non diede mai prescrizioni) sia ignorandole. Le unità di azione, luogo e tempo sono in genere rispettate nei film gialli, soprattutto da Hitchcock, perché accrescono la tensione drammatica. Del resto era per questo che venivano utilizzate nella tragedia classica francese. Nella Berenice di Racine non accade quasi niente: per cinque atti Tito non si risolve a congedare la regina di Bitinia. E i due non s’incontrano mai. Salvo che alla fine. Quando Berenice viene congedata. C’è però, prima del colloquio definitivo, un momento in cui Tito, vedendola sopraggiungere, scappa. E la scena resta per un attimo vuota. Berenice, entrando, è sconvolta dall’avere visto l’amato fuggire da lei. Questo suo sconvolgimento è preparato dalla scena vuota, uno spazio deserto che rappresenta come meglio non si potrebbe la distanza tra i due, l’ormai definitiva cancellazione del loro amore. Solo lei non lo sa ancora, ed è per questo sconvolta. Le parole, gentili ma gelide, di Tito, alla fine, le confermeranno l’inesorabile distacco. Ebbene, questa fine, questo distacco è già deciso all’inizio del primo atto: se ne protrae per cinque la dichiarazione, e che tutto avvenga però in uno stesso spazio e nel giro di poche ore accresce nella donna, e nel pubblico, l’ansia, l’angoscia, la disperazione di una verità temuta come la morte, ma che si rivelerà appunto mortale, una fine senza ritorno: «pour jamais!». Tra i versi più belli del teatro di tutti i tempi: Je n’écoute plus rien; et pour jamais, adieu. Pour jamais! Ah! Seigneur, songez-vous en vous-même Combien ce mot cruel est affreux quand on aime? Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse, Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, matico, in «que le jour recommence et que le jour finisse». Al lettore di scoprire le altre finezze stilistiche e poetiche del brano. Ma si osservi ancora una cosa: Berenice dà del voi all’imperatore e lo chiama «Signore». Non è certo l’uso delle dame romane, e sia pure nel Palazzo dell’Imperatore, ma è certo l’uso delle dame parigine e della corte di Versailles. La vicenda di Berenice rispecchiava certo nelle dame del pubblico secrete affinità, angosce simili. Ecco: questo è il teatro. E anche se si tratta di teatro parlato, ha convenzioni come quello musicale. Intanto, Racine lo scrive in versi. E gli uomini a casa o per le strade non parlano in versi. Nemmeno parlano in prosa, come crede il povero borghese di Molière. Anche la prosa, infatti, come il verso, si costruisce. La prosa di Molière (ma anche di Pirandello) non è certo la parlata spontanea di un uomo qualunque. E allora perché dovrebbe parere strano recitare cantando? E perché il fatto di cantare dovrebbe abolire il teatro? O perché dovrebbe abolirlo la danza? Recitazione, canto e danza sono tre modi di attuare il teatro. Anzi in molte culture, quella greca e quella giapponese, per esempio, il teatro nasce proprio con la combinazione di questi tre modi di rappresentazione: la parola parlata, la parola cantata e la danza. È merito dei registi, soprattutto tedeschi, avercelo fatto vedere realizzato sulla scena. Non a caso anche Pina Bausch è tedesca. 7 Non ascolto più niente; e addio, per sempre. / Per sempre! Ah! Signore, riflettete tra voi / come quest’espressione crudele è terribile per chi ama? / Tra un mese, tra un anno, come sopporteremo, / Signore, che così tanto mare mi separi da voi? / Che il giorno ricominci e che il giorno finisca, / senza che mai Tito possa vedere Berenice, / senza che per tutto il giorno io possa vedere Tito! 8 Ma che errore è il mio, e che pensieri perduti! (soin è intraducibile, lo rende bene il latino cura, il termina italiano cura non significa la stessa cosa). 9 Si saggio (sta’ buono), o mio Dolore. cantiere regia — 53 de alla rappresentazione musicale della situazione che fa nascere un sentimento, o addirittura una passione, la musica, come già nel melodramma seicentesco, e come avveniva nella coeva opera buffa, si vede obbligata a seguire l’andamento dell’azione e a trovarne le analogie formali di scrittura musicale che possano far risultare drammaturgicamente verosimili gli andamenti musicali: in parole povere il compositore deve ora inventarsi una nuova drammaturgia musicale, in quanto il sistema delle arie scandite e separate dai recitativi secchi non basta più. Già Handel aveva avvertito questa nuova esigenza drammatica. E i suoi ultimi oratori, soprattutto profani, ne sono una splendida illustrazione. Ma in fondo anche gli oratori e le passioni bachiane, per non parlare delle sue cantate, avevano individuato una nuova via drammaturgica. Il nuovo non nasce mai nel deserto. L’invenzione geniale di Gluck sta nell’abolire lo stacco tra il suono dell’orchestra che sostiene le arie e il suono più scarno del basso continuo che regge i recitativi. L’orchestra suona sempre, anche nei recitativi. Ciò crea una continuità musicale che si fa continuità drammatica. Lo sforzo con cui Rossini (e anche lui abolì il recitativo secco nell’opera seria) e, ancora di più Beethoven, costruiscono, poi, una nuova drammaturgia musicale, proprio ampliando i tipi possibili di aria, attingendo ampiamente anche alle forme strumentali, non sarà senza conseguenze. A Beethoven, a dire il vero, questo merito ancora non è sufficientemente riconosciuto, si dice e si scrive anzi spesso che gli mancherebbe il senso del teatro, che compone splendide pagine sinfoniche ma senza peso drammatico, il che è assolutamente falso: a dimostrare il contrario basta da sé tutta la prima parte del secondo atto del Fidelio. Vero è invece che per lo sviluppo e la storia del teatro musicale nei secoli XIX e XX le soluzioni formali del Fidelio sono decisive e importanti quanto quelle di Rossini e di Verdi. E anche se sulle prime sembra vincente la carta tando. Come nel secolo scorso ci ha dimostrato Maria Callas. Per quanto riguarda la scelta della forma musicale adatta a una situazione drammatica, si pensi all’aria «Che farò senza Euridice» nell’Orfeo ed Euridice di Gluck. È un rondò. Non un’aria col da capo. Il rondò, col ritorno ossessivo di un tema, rende perfettamente il pensiero ossessivo della perdita che sconvolge Orfeo. Che questa fosse l’intenzione di Gluck è dimostrato dal fatto che precedentemente, nel dialogo con Euridice, l’aria di Euridice «Che fiero momento!» è un’aria col da capo, perché lì Euridice vuole solo mostrare a Orfeo la sua sofferenza di non essere guardata dal marito. E le basta dirlo due volte: la sua non è un’ossessione, ma il sentimento immediato di una situazione. Per un teatro costruito sulla meccanica dei sentimenti (si diceva «affetti») a comunicare al pubblico questa rappresentazione di disperazione istantanea è sufficiente, anzi indispensabile, perché metabolizzata dalla memoria teatrale del pubblico come aria «di affetti», la convenzionale aria col da capo. Dunque Gluck non abolisce l’aria col da capo, come pur troppo si legge ancora in qualche saggio o paragrafo di storia musicale male informati, ma la subordina alle esigenze di una nuova drammaturgia musicale, che prevede non già l’isolamento di un sentimento, o di una riflessione sul sentimento, nello spazio singolo dell’aria, ma il suo inserimento in una situazione drammatica, l’aria insomma si fa aria di un sentimento in azione e non più la sua semplice (per modo di dire) rappresentazione. Su questa via l’articolazione formale del teatro musicale si fa via via più complessa. Dato che l’unità drammaturgica non è più l’aria che racchiude e circoscrive il sentimento nella rappresentazione allusiva d’una forma musicale chiusa, ma che ora il dramma si esten- di Rossini, che di fatto comunque amplifica e stravolge la funzione drammatica dell’aria, sono proprio le soluzioni beethoveniane, più ancora di quelle wagneriane, a indicare la strada alla nuova drammaturgia musicale del Novecento. Basti pensare solo a Berg, Shostakovich, Janácek e Stravinskij. Ebbene, i nuovi registi tengono conto proprio di questo. Dunque, al contrario di quanto credono coloro che li accusano di tradire il testo, si dimostrano assai più rispettosi della partitura, delle sue esigenze formali, che non i registi che si limitano a illustrare l’azione con belle scene e bei costumi, che magari rispettano l’ambietazione di un’epoca, ma non si curano affatto della recitazione dei cantanti sulla scena. Lo aveva già fatto vedere bene Wieland Wagner, soprattutto nella bellissima messinscena del Tristano, quando organizzava gli effetti di luce non su una realistica rappresentazione del giorno e della notte, bensì sul trascolorare delle armonie orchestrali. Come mai a Bayreuth? e come mai il nipote stesso di Wagner? Il teatro moderno nasce sullo scorcio del XVIII secolo tra Francia e Germania. Ma è in Germania che s’imposta un nuovo criterio di rappresentazione teatrale, e che si crea una figura ignota nei teatri degli altri paesi: il drammaturgo. Che non è lo scrittore di opere teatrali, ma colui che riscrive la drammaturgia di un’opera, per esempio l’Amleto di Shakespeare, per affidarlo al gruppo particolare di attori che dovrà recitarla in un preciso e singolo teaatro. Due grandi nomi stanno all’inizio di quest’avvincente avventura teatrale: Lessing, ad Amburgo, e Goethe, a Weimar. Proprio l’Amleto fu scelto da Goethe per questa sua nuova esperienza teatrale e lui stesso recitò il ruolo del principe danese. Mi piacerebbe con la macchina del tempo tornare indietro e assistere a quello spettacolo, che sarà stato sicuramente esaltante, vista anche l’eco che se ne ebbe non solo in Germania. Goethe non si limitò a tradurre in tedesco la tragedia cantiere regia Ma in fondo l’idea che nel melodramma sia la musica a dover condizionare, in maniera esclusiva, la messinscena è relativamente recente. È ovvio che qualsiasi messinscena debba rispettare le esigenze musicali, ma la musica è solo una delle componenti di uno spettacolo musicale. Il melodramma nasce come opera teatrale, altrimenti il compositore avrebbe scritto un oratorio, il quale da parte sua è poi tutt’altro che indifferente all’efficacia di strutture ed effetti teatrali. Si pensi a certi interventi della folla urlante nelle Passioni bachiane. Ma si tratta di un teatro immaginario, mentale: un «teatro della mente», come nel madrigale drammatico. La questione è bene espressa da Monteverdi, quando affida il prologo dell’Orfeo alla Musica, ma poi si affretta altrove a dichiarare che la musica debba essere «serva dell’oratione». Il prologo mette in risalto il nuovo ruolo drammaturgico assunto dalla musica. Ma l’apparente correzione è invece una precisazione del significato e della struttura di tale ruolo. La musica, come poi in Wagner (ma in realtà in tutti i grandi musicisti drammaturghi: Handel10, Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi), non ha una strutturazione autonoma, ma la sua costruzione obbedisce di volta in volta alle esigenze drammaturgiche del testo, il che non significa trascurare le forme musicali, ma adoperare quelle che di volta in volta meglio si adattino alle esigenze del dramma da rappresentare. Wagner si sbagliava quando accusava il melodramma italiano, e in particolare Rossini, di sacrificare le esigenze drammaturgiche alle esibizioni di virtuosismo canoro. Semplicemente era un’altra concezione del teatro, ma sempre di teatro si trattava. Adelaide Ristori, la più grande attrice italiana prima della Duse, dichiara nelle sue memorie di avere avuto per modelli di recitazione due straordinarie cantanti: Isabella Colbran e Maria Malibran. Non avrebbe potuto citarle, se esse, oltre che grandi cantanti, non fossero state anche grandi attrici. O più esattamente; attrici che recitano can- 10 Ritengo corretto adottare l’ortografia inglese del cognome, adottata dallo stesso compositore quando assunse la cittadinanza britannica. 54 — cantiere regia nato ritmo di rock. Carsen ci restituisce la brutalità della situazione che scandalizzò i perbenisti contemporanei di Verdi: ma i perbenisti non mancano mai, in tutte le società e in tutte le epoche, e specie nell’ipocrita e scostumata Italia di oggi. Paradossalmente, questa nuova concezione teatrale ripristina il palcoscenico di un teatro che, fino alla fine del Settecento, ma anche oltre, era il teatro anche italiano. Che cosa sono, infatti, l’Antigone, l’Agamennone, l’Oreste, l’Alcesti di Alfieri se non riscritture del dramma classico? E, più tardi, in pieno clima romantico, che cos’è il Macbeth di Verdi se non una riscrittura, in chiave di drammaturgia musicale, della tragedia di Shakespeare? E chi non si è sentito rapito, commosso, a vedere, proprio qui a Venezia, in due stagioni della Biennale tra di loro lontane, Il Sogno di una notte di mezza estate e l’Amleto di Shakespeare messi in scena in maniera scarna, dura, essenziale, e tuttavia piena di fantasia, da Peter Brook? Michelangelo Zurletti La risposta è implicita nella domanda, quando si parla di regia «in linea col tempo in cui è inserita». Viviamo in un’epoca tecnologica e anche l’opera deve vivere di analoga rapidità, bando ai fronzoli. Ma non è sempre così semplice. Su alcune questioni possiamo essere d’accordo subito: le Norme con le corna, le zingare vestite di stracci, le gitane con le mela in bocca non si possono più vedere. E anche le Norme nei grandi magazzini, le zingare nelle stazioni termali. Ma quando l’essenziale viene eliminato è più difficile consentire. Se Uno dice a Altro «porgimi il nappo», Altro potrà porgergli un bicchiere da osteria o uno di cristallo o una coppa da champagne o un secchio ma qualcosa con cui possa bere o brindare. Siamo cantiere regia di Shakespere, tagliò anche alcune scene e altre ne riscrisse da capo, per adattare il testo alla propria interpretazione: una tragedia della volontà, una sorta di prefigurazione di Werther, il quale a sua volta deve molto alla figura del principe danese. Amleto e Werther insomma hanno perduto i riferimenti concettuali con cui interpretare la realtà, divenuta per loro incomprensibile, e la loro volontà ne resta paralizzata, sconfitta. Una tragedia della perdita di Dio, e della solitudine dell’uomo moderno. Goethe scrive pagine mirabili, nel Wilhelm Meister, per spiegare questa sua interpretazione. E nel Prologo in teatro del Faust ci dice che cos’è per lui il teatro moderno. L’impostazione di Goethe e di Lessing resta fondamentale nella storia del teatro tedesco, fino a Wagner, il quale non ha mai preteso che una messinscena fosse immutabile, e resta determinante fino ad oggi. Wagner d’altra parte fu il modello del nuovo teatro nordico, e in particolare scandinàvo (Ibsen, Strindberg), e poi di quello russo di Stanislavskij e Mejerchol’d, e da Mosca l’esempio si diffonde nel nuovo teatro europeo e americano, nel nuovo cinema tedesco e americano. Ma gli influssi si fanno sentire anche in Francia e in Inghilterra. Assai meno in Italia. Nonostante Pirandello. È curioso comunque che l’influsso del teatro wagneriano si faccia sentire più nel teatro parlato che in quello musicale. Ecco perché poi quando alcuni drammaturghi, soprattutto tedeschi, e alcuni registi, non solo tedeschi, applicano anche al teatro musicale questa nuova concezione del teatro, che viene da Wagner e da Stanislavskij, ma anche dalla tradizione tedesca goethiana, sono da molti interpretati come dei profanatori. Eppure l’impronta goethiana arriva fino a Hölderlin che riscrive l’Antigone di Sofocle, poi a sua volta riscritta da Brecht, e la versione brechtiana tradotta in inglese è il testo messo in scena dal Living Theatre. Ma non diversamente si comporta Hofmannsthal quando riscrive l’Elettra di Sofocle, adottata poi pari pa- ri da Richard Strauss per la sua Elektra. E qui si richiude il cerchio. Wieland Wagner dunque non faceva una rivoluzione ma ritornava alle origini concettuali del teatro di Wagner. E lo stesso fa suo fratello Wolfgang quando per il nuovo allestimento dell’Anello, a Bayreuth, nel 1976, proprio nell’anno del centenario della fondazione del teatro, chiama a curarne la regia l’allora giovane e spericolato Patrice Chéreau, e a dirigerlo il diabolico compositore d’avanguardia Pierre Boulez, che però era stato già chiamato da Wieland a dirigere il Parsifal nel 1971. Il lettore di queste note possiede adesso i punti di riferimento per capire la nuova regia del melodramma e del teatro musicale in genere e goderne. Una sola esemplificazione: La Traviata alla Fenice messa in scena da Robert Carsen. Parte del pubblico – e dei musicisti! venni rumorosamente aggredito in una calle di Venezia da un tonitruante musicista veneziano, il quale aveva letto la mia critica entusiasta e si era invece sentito oltraggiato da quella regia! – parte del pubblico, ripeto, e, ahimé! anche della critica, si sentì dunque offesa dall’esplicita caratterizzazione del ruolo sociale attuato da Violetta nella vicenda: durante il preludio del primo atto, alcuni suoi clienti si alzano dal letto, l’abbandonano e la pagano! che orrore! avranno pensato in molti. Ma come si permette questo mascalzone screanzato! Ma scusate, rispondo: che mestiere faceva Violetta, nel romanzo e nel dramma di Dumas, dove si chiama Margherita, e nell’opera di Verdi? e come si vendica di lei Alfredo nel secondo atto se non sbattendole in faccia i soldi del suo compenso di prostituta? Ebbene, tutto ciò nell’oramai tradizionale rappresentazione di salotti romantici si perdeva. Come nella distanza temporale, dopo un secolo e più, avevano perduto la loro carica eversiva i ballabili che Verdi insinua dapperttutto: valzer, polche, galop, come se oggi un compositore facesse ballare alla protagonista della sua opera il più scate- arrivati a un risparmio di attrezzeria che supera la miseria. E basta coi frac per discutere dei massimi sistemi sul Walhalla, basta con le fabbriche dimesse o i sottoscala o l’assortimento metallurgico, basta con le divise, con i cattivi vestiti da nazisti. La regia deve alludere, deve darci semmai una seconda lettura ma non sostituirsi agli autori. Se vediamo un Radames che scava una fossa come un becchino e contempla un cranio riesumato non abbiamo più informazioni sulle guerre d’Egitto di quelle suggerite da Verdi. E quale magnanimità possiamo aspettarci da un Selim Pascià tatuato, che emerge dal mare da provetto pescatore subacqueo e fa il trafficante di droga? ◼ Nelle fotografie. Registi: a sinistra: Adolphe Appia, Gordon Craig, Kostantin Sergeevič Stanislavskij, Max Reinhardt, Vsevolod Ėmil'evič Mejerchol'd, Bertold Brecht,Giorgio Strehler, Luchino Visconti, Klaus Michael Gruber; a destra: Peter Brook, Robert Wilson, Luca Ronconi, Luc Bondy, Peter Stein, Patrice Chéreau, Ejmuntas Nekrosius, Christoph Marthaler, Herbert Wernicke, Peter Stein. Autori: a sinistra: Claudio Monteverdi, Baldassare Galuppi, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner; a destra: Giacomo Puccini, Alban Berg, Arnold Schoenberg, Richard Strauss, Igor Stravinskij, Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Karlheinz Stockhausen, Bruno Maderna, Luciano Berio, Luigi Nono.
Scarica