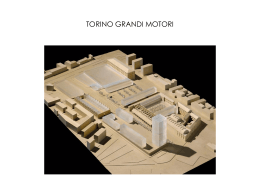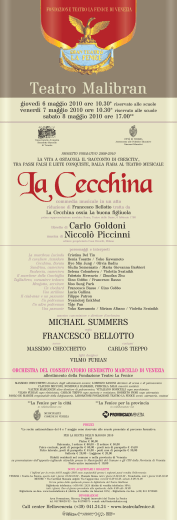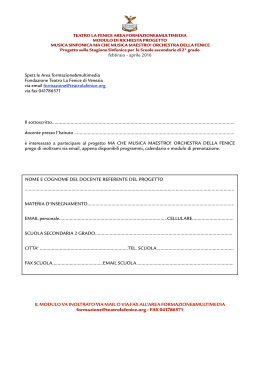VENEZIAMUSICA e dintorni Edizioni La Fenice VeneziaMusica e dintorni n. 55 – giugno 2014 Testata in corso di registrazione Direttore responsabile Giampiero Beltotto a cura di Leonardo Mello VeneziaMusica e dintorni è stata fondata da Luciano Pasotto nel 2004 Editore Fondazione Teatro La Fenice Campo San Fantin San Marco 1965 30124 Venezia Realizzato da Dali Studio S.r.l. VENEZIAMUSICA e dintorni Edizioni La Fenice Sommario 3 4 Lo spirito della musica di Venezia 4 Un festival per il dialogo tra culture di Cristiano Chiarot 6 Spazi e generi a confronto di Fortunato Ortombina 8 Una festa della musica di Cesare De Michelis 36 A passo di danza di Franco Bolletta 38 Pino Donaggio, il ragazzo col violino di Giò Alajmo 40 Paolo Conte, un ritratto di Alberto Massarotto 42 Opera 42 Una «Tosca» essenziale e sintetica di Serena Sinigaglia 44 «Re Lear», il sogno incompiuto di Verdi di Chiara Facis Il festival e la città Conversando con un’imprenditrice a cura di Leonardo Mello 48 Chi ben comincia… Sulle farse veneziane di Rossini di Giorgio Gualerzi 12 «Hôtel Europe» di Bernard-Henri Lévy A colloquio con il filosofo francese a cura di Silvia Manzoni 49 Dintorni 14 Due «nemici pubblici», Michel Houellebecq e Bernard-Henri Lévy 16 Venezia-Parigi: andata e ritorno di José Sasportes 54 Carta Canta 19 9 10 2 Editoriale Sulla «Maratona» dei compositori di Mario Messinis 49 Harold Bloom racconta Shakespeare a cura di Pietro Tessarin e Bruce Boreham 52 Juvenice, l’Associazione Giovani Amici della Fenice Modelli e archetipi della «Carriera di un libertino» di Gianfranco Vinay 54 Le recensioni di Giuseppina La Face Bianconi 21 Una cronaca d’eccezione per il «Rake’s Progress» di Vera Stravinsky 56 Pietro Bertoja scenografo e fotografo 23 Una recensione d’annata 25 «Un capolavoro del mio tempo» Una conversazione con Damiano Michieletto a cura di Leonardo Mello 28 W.H. Auden e l’immaginario «camp» di Franco Buffoni 30 «Maneggiare il destriere in un stretto cortile» «L’Eritrea» di Giovanni Faustini e Francesco Cavalli di Nicola Badolato 32 Ellen Rosand e il Seicento veneziano di Lorenzo Bianconi 34 «L’Eritrea», un gioiello riscoperto di Olivier Lexa | VENEZIAMUSICA e dintorni EDITORIALE «E uropa o barbarie»: questa è una delle frasi più emblematiche di Hôtel Europe, la pièce di Bernard-Henri Lévy che sarà data in prima mondiale a Venezia il prossimo luglio. Il monologo, il cui debutto assoluto avverrà in giugno a Sarajevo, dove è anche ambientato, narra l’imbarazzo provato da un uomo nel dover scrivere e pronunziare un discorso sulla storia e sul futuro dell’Europa proprio lì, nelle zone in cui il vecchio continente ha fatto conflagrare, cento anni fa, uno dei conflitti più cruenti che l’umanità ricordi, per poi ripetere l’errore ottant’anni dopo, con la guerra fratricida celebrata nell’ex Jugoslavia. Il filosofo francese, da sempre refrattario a qualsiasi totalitarismo e schierato apertamente contro ogni violenza e sopraffazione, approfitta della coincidenza dei cento anni dall’inizio della prima guerra mondiale per proporre attraverso il teatro un modello d’Europa diverso, incentrato sulla civiltà e sull’apertura e teso a recuperare il profilo umanistico che ha contraddistinto per molti secoli questa parte del mondo. Ecco dunque l’imbarazzo iniziale, che paralizza il protagonista, trasformarsi in un appello alla speranza, di cui il monito citato all’inizio è la punta dell’iceberg. Che questo spettacolo, dopo il debutto bosniaco, venga proposto a Venezia si veste a sua volta di un particolare significato simbolico. La città lagunare infatti ha sempre avuto, almeno in passato, una connotazione profondamente europea. E a questa vocazione alla mescolanza e al dialogo tra popoli e culture fa diretto riferimento il festival «Lo spirito della musica di Venezia», che accoglie la pièce di Lévy. Giunta alla seconda edizione, la rassegna organizzata dalla Fenice espande ancora i propri confini, sia sul versante dell’offerta che su quello spaziale, coinvolgendo nel progetto moltissimi luoghi naturalmente «teatrali» della città d’acqua. Ponendosi come obiettivo prioritario quello di proporre a cittadini e ospiti un programma estremamente diversificato – che va dalla musica novecentesca e contemporanea al recupero di gioielli del passato, dalla danza d’autore alle composizioni sacre e barocche – il festival, come nota Cesare De Michelis, si presenta come una vera e propria festa della musica che ricorda da vicino i fasti del passato, quando in laguna era attivo un numero di teatri incredibilmente superiore a quello delle principali capitali europee. E agli «interni», sale teatrali e ridotti, si aggiungeva la grande vitalità degli spettacoli all’aperto, che si trattasse di commedia dell’arte o di concertini di strada. Sin dal titolo scelto per la manifestazione, il Teatro veneziano sembra voler proprio far riferimento a quel tipo di atmosfera, che è sempre andato di pari passo con la circolazione delle idee e delle persone, in una dimensione di ospitalità diffusa che forse ora è necessario recuperare. In chiusura si segnala, in queste pagine, un’intervista ad Harold Bloom, il più grande critico letterario americano, autore del celebre Canone occidentale. Questa conversazione, registrata in esclusiva, ha inaugurato La Fenice Channel, la nuova web radio che la Fondazione lirica ha messo in onda il 2 giugno, costituendo un’inedita collaborazione con un quotidiano nazionale come «la Repubblica». VENEZIAMUSICA e dintorni | 3 Lo spirito della musica di Venezia UN FESTIVAL PER IL DIALOGO TRA CULTURE L di Cristiano Chiarot* a seconda edizione del festival «Lo spirito della musica di Venezia» riprende e amplia il progetto dell’anno passato, concentrandosi con ancora maggior forza sulle radici culturali che hanno contraddistinto la storia della nostra città. Siamo partiti da una constatazione: Venezia, per storia e vocazione, è un crocevia: di popoli, tradizioni, culture, modi di intendere ed esprimere l’arte. Quest’apertura, questa mescolanza hanno dato luogo a esperienze musicali di straordinaria importanza, facendo della città lagunare uno dei centri propulsivi dell’elaborazione artistica e intellettuale europea. Dunque quest’anno ci siamo voluti concentrare sui rapporti e le influenze, antiche e moderne, che hanno contraddistinto questo «laboratorio permanente» che è stata e ancora è Venezia. Abbiamo inteso il festival come luogo dove sviluppare un dialogo tra civiltà diverse, consapevoli che l’elaborazione culturale favorisce naturalmente l’incontro e lo scambio. In quest’ottica si colloca, ad esempio, la particolare attenzione rivolta ai rapporti che sono intercorsi tra la nostra città e la tradizione musicale francese, rapporti consolidati nel tempo che hanno dato – in entrambe le sponde delle Alpi – risultati di grandissimo livello. Ma le connessioni non si limitano al solo ambito delle sette note, come dimostra la prima mondiale di Hôtel Europe di Bernard-Henri Lévy, che ha scelto Venezia per parlare al mondo d’Europa, quella che esiste oggi e quella che dovrebbe nascere in futuro recuperando l’umanesimo che l’ha sempre caratterizzata e prestando maggiore attenzione alle diversità culturali. Senza entrare nel dettaglio degli appuntamenti, vorrei porre l’accento su alcune linee-guida che 4 | VENEZIAMUSICA e dintorni abbiamo seguito nell’immaginare il programma. Da un lato, dopo l’Otello verdiano della scorsa stagione, proponiamo ora un’opera moderna come il Rake’s Progress di Stravinsky. Questa è una scelta tutt’altro che casuale, anzi si inserisce con forza nell’orientamento che ci siamo prefissi. La carriera di un libertino infatti è un esempio perfetto di quella fertile mescolanza cui accennavo poc’anzi. Il compositore russo rappresenta di per sé la figura dell’artista apolide, che si nutre delle atmosfere incontrate nel suo eterno peregrinare. La sua musica ha ascendenze slave, francesi, tedesche, americane, che corrispondono ai luoghi prediletti della sua biografia, tra i quali non possiamo dimenticare proprio Venezia, dove è sepolto e con la quale ha avuto sempre una relazione privilegiata, scegliendola come palcoscenico proprio per il debutto assoluto del Rake’s Progress, nel lontano 1951. Nella stesura composita di quest’opera, poi, non si può non citare l’apporto determinante del librettista, un grande poeta anglosassone come Wystan Hugh Auden, che dunque pervade il componimento di ulteriori ascendenze. Riproporre questo lavoro di Stravinsky rientra quindi quasi naturalmente negli obiettivi che ci siamo dati. Altro punto fondante è l’attenzione alla contemporaneità, intesa come musica che nasce e viene ascoltata oggi. In questo senso abbiamo voluto riprendere la fortunata iniziativa della scorsa edizione, dando vita a una nuova Maratona destinata a quaranta compositori, questa volta veneziani e francesi, che presenteranno altrettante prime assolute commissionate dalla Fenice. * Sovrintendente Fondazione Teatro La Fenice Obiettivi Non poteva d’altro canto mancare uno sguardo verso il glorioso passato di Venezia: ecco dunque che – oltre alle esibizioni della nostra Orchestra Barocca – presentiamo L’Eritrea di Francesco Cavalli, una delle perle della produzione melodrammatica lagunare, nata dalla proficua collaborazione tra il musicista e un poeta d’eccezione come Giovanni Faustini e andata in scena nel 1652 al Teatro Sant’Aponal. Un’altra delle convinzioni da cui siamo partiti è la necessità, in epoca contemporanea, di un dialogo tra le varie forme in cui si declina l’arte. Convinti che non si possa più ragionare per compartimenti stagni, abbiamo dedicato uno spazio ancora maggiore alla danza – classica e di oggi – considerandola la forma artistica dove con maggior evidenza il movimento si fonde con il suono. Nella stessa volontà di andare oltre i generi si colloca anche – reiterando la collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa – il coinvolgimento di un artista visivo, Isaac Julien, in un progetto core- ografico speciale. Essendo impossibile dare conto di tutte le iniziative, mi limito in chiusura a due ultime considerazioni. La prima riguarda l’utilizzo degli spazi. Sin dall’inizio di quest’avventura abbiamo voluto diramare la musica in tutta la città, comprese isole e terraferma. Quest’anno, oltre alla cornice inimitabile di Palazzo Ducale, abbiamo coinvolto luoghi storici come la Chiesa della Pietà o il Museo di Ca’ Pesaro, per citarne soltanto due, affermando e accrescendo la volontà del festival di essere sempre più presente e diffuso. L’ultima annotazione riguarda il coinvolgimento di tantissime istituzioni culturali all’interno del festival, perseguendo uno tra i principali obiettivi che si pone la Fenice, il «fare rete» e divenire il trait d’union delle molte energie attive nel nostro territorio. Non potendo citarle tutte chiudo con un grande ringraziamento a queste realtà come ai dipendenti del nostro Teatro, che con il loro entusiasmo hanno reso possibile questo progetto. VENEZIAMUSICA e dintorni | 5 Lo spirito della musica di Venezia SPAZI E GENERI A CONFRONTO S di Fortunato Ortombina* e prendiamo in considerazione anche il Prefestival del 2012, «Lo spirito della musica di Venezia» giunge ora alla sua terza edizione, continuando anno dopo anno a svilupparsi nella scia data dal titolo simbolico che abbiamo scelto. Il che non significa proporre soltanto musica veneziana, ma recuperare appunto quello spirito di grande apertura verso il mondo che ha caratterizzato la città nei millenni, partendo da quegli autori che, nel corso dei secoli, hanno riconosciuto a Venezia un primato assoluto in questo senso. Quest’anno, ad esempio, l’appuntamento inaugurale è il Rake’s Progress di Stravinsky, la cui prima mondiale venne eseguita alla Fenice con il compositore stesso sul podio. Su queste basi di partenza abbiamo suddiviso il programma in diversi filoni. Il primo che balza all’occhio è quello del teatro musicale, che inizia proprio con l’opera di Stravinsky, e vede significativamente Damiano Michieletto alla regia. Questo progetto, realizzato insieme all’Opera di Lipsia, è infatti per noi l’ideale continuazione del Don Giovanni mozartiano, essendo Tom Rakewell, il protagonista, in un certo senso una vittima dello stesso mito. L’altra grande novità è L’Eritrea di Francesco Cavalli, che presenteremo a Ca’ Pesaro. Cavalli è estremamente conosciuto nel mondo, e sue opere, come L’Orione, sono state più volte realizzate negli ultimi decenni. È un autore molto prolifico, che ai suoi tempi ha goduto del successo di una star e, in quei primi anni di esistenza del teatro d’opera, ha incarnato al meglio la figura del compositore/imprenditore. Molti dei suoi lavori sono però rimasti negli archivi marciani, senza essere mai più ripresi. Tra questi L’Eritrea, 6 | VENEZIAMUSICA e dintorni che va ora in scena in prima mondiale in tempi moderni. La scelta di Ca’ Pesaro si inserisce all’interno della volontà di allargare gli spazi destinati alla musica, per condurre lo spettatore a respirare l’aria e a inebriarsi della luce di questa città. L’allestimento, interamente prodotto dalla Fenice, occuperà il salone principale del palazzo, quello che si affaccia sul Canal Grande. Suonerà un gruppo di strumentisti di area veneto-veneziana, sotto la direzione di Stefano Montanari, mentre l’impianto registico è affidato a Olivier Lexa. Ca’ Pesaro non è un teatro, ma nel Seicento i saloni erano tra i luoghi deputati a operazioni del genere, quindi la locazione di questa rappresentazione avrà criteri direi «filologici». Una seconda sezione riguarda poi la musica propriamente sinfonica. In particolare vorrei soffermarmi sui due appuntamenti al cortile di Palazzo Ducale. Il primo concerto, diretto da Diego Matheuz, offrirà un programma composito, formato da un’Ouverture di Verdi, un’altra di Rossini e L’uccello di fuoco di Stravinsky. All’inizio però vi sarà una suite sinfonica di Pino Donaggio, grande compositore di colonne sonore oltre che di celebri canzoni, cui conferiremo un premio. Ogni anno infatti il festival intende offrire un riconoscimento a una personalità del mondo della musica veneziano. Il secondo concerto, curato da John Axelrod, vedrà la Sinfonia Dal nuovo mondo di Dvořák, anticipata da un’altra composizione dello stesso Dvořák: si tratta di musiche di scena per l’Otello di Shakespeare. Questo elemento crea un trait d’union con l’Otello verdiano realizzato l’anno scorso nello stesso luogo, che verrà ripreso nel 2015. * Direttore artistico Fondazione Teatro La Fenice Obiettivi Grande attenzione sarà poi dedicata agli organici più piccoli, che proporranno musica sacra o da camera. Per citare anche qui solo qualche esempio, la nostra arpista, Nabila Chajai, eseguirà un concerto interamente dedicato a compositori francesi che hanno scritto pezzi per il suo strumento. Inoltre vi sarà un recital di musica novecentesca, da Debussy a Kurt Weil, di Monica Bacelli. Sul versante sacro, il Duomo di San Lorenzo a Mestre ospiterà un programma per organo e tromba, mentre alla Pietà si esibiranno i Virtuosi Italiani, formidabile formazione dedita al repertorio barocco. Com’è ormai tradizione della nostra manifestazione, anche questa volta abbiamo rivolto uno sguardo attento alla musica d’oggi. Gli appuntamenti destinati al contemporaneo sono più d’uno. Mi limito qui a citare il più importante, la seconda edizione della Maratona dei compositori, dove trovano spazio quaranta prime assolute nell’arco di un’unica giornata, ciascuna delle quali durerà circa cinque minuti. Mettere insieme stili e sensibilità diverse, ne abbiamo avuto la riprova lo scorso anno, accresce molto l’interesse del pubblico. Sul palco ci sarà l’Ex Novo Ensemble, compagine specializzata nella nuova musica. Oltre all’evento rappresentato dal monologo Hôtel Europe di Bernard-Henri Lévy, che ha scelto il nostro festival per il suo debutto, non mancheranno aperture verso forme espressive limitrofe alla musica. In particolare nell’ambito della danza, cui, con un convegno internazionale incentrato su Salvatore Viganò, la nuova versione del Gala internazionale e il Progetto coreografico, in cui sono uniti ballo e arte visiva, abbiamo voluto dare ancora più risalto che nel 2013. Infine, un ultimo filone legato all’altra musica, che abbiamo organizzato insieme a Veneto Jazz, e che vedrà, tra le altre cose, la partecipazione di Paolo Conte. Insomma, un programma stratificato, che si estende sia cronologicamente che spazialmente, aderendo sempre più al nostro tema-guida, quello spirito della musica di Venezia che caratterizza tutte le scelte compiute. VENEZIAMUSICA e dintorni | 7 Lo spirito della musica di Venezia UNA FESTA DELLA MUSICA P di Cesare De Michelis* er un mese a Venezia la musica nella varietà dei suoi modi invaderà teatri, palazzi e cortili per testimoniare ancora una volta la complessità di quel legame che intreccia con l’isola ormai da molti secoli. Non si tratta di una nuova stagione di uno dei suoi teatri e neppure semplicemente di un altro festival, quanto piuttosto di una vera e propria festa della musica che riafferma con grazia ed entusiasmo la resistenza di un’affinità che perdura e persino si rafforza nella varietà degli incontri e degli incroci che hanno prodotto e ancora producono frutti preziosi. La musica e naturalmente il teatro hanno sempre avuto accoglienza calorosa a Venezia e così questo rito di gemellaggio acquista anche il senso di una testimonianza oltre ogni oblio, ogni cambiamento d’umore e di gusto. Venezia, lo riscopriamo in ogni occasione, è uno straordinario spazio scenico nel quale la teatralità si esalta compiuta nella pluralità delle sue forme espressive, nella varietà dei suoi stili, nella ricchezza delle invenzioni autoriali, che restano vive oltre il proprio tempo fino a noi è anche aldilà. Quest’estate il fil rouge attraversa soprattutto la Francia e si misura con il barocco come autentica aurora della modernità, sua prima e definitiva affermazione, per giungere fino a noi con il debutto mondiale di un monologo attualissimo di Bernard- Henri Lévy, Hotel Europe, nel quale si incroceranno i destini di guerra iniziati giusto un secolo fa e ripetutisi in questo mare nostrum Adriatico sino a ieri, com’è drammaticamente evidente nella memoria di quanto è accaduto nel 1914 ma anche vent’anni fa a Sarajevo. Una stagione lunga un intero anno Approvo incondizionatamente l’iniziativa del Teatro La Fenice. Finalmente si è realizzato un progetto che da tempo covava ma che solo nel 2013 ha trovato realizzazione, confermandosi poi quest’anno. Il recupero dei luoghi, la varietà dell’offerta riusciranno ad accontentare tutti i gusti, estendendo di fatto il cartellone del Teatro all’intero anno, e così includendo, con proposte di qualità, anche il periodo estivo. Sono molto contento che, nonostante immagino sia uno sforzo dal punto di vista produttivo, la nostra città possa avere una programmazione estiva di alto livello che riunisca cittadini e turisti colti. Mi sembra un’idea che valorizza Venezia da molti punti di vista, ma certo ciò che più mi interessa è la valenza culturale del progetto complessivo. Non entro nel merito dei singoli appuntamenti limitandomi a esprimere un apprezzamento totale per quest’iniziativa. Massimo Cacciari * Scrittore e critico letterario – Già Ordinario all’Università di Padova 8 | VENEZIAMUSICA e dintorni Contesti SULLA «MARATONA» DEI COMPOSITORI N di Mario Messinis* ella progressiva sparizione delle grandi figure della nuova musica italiana, Bruno Maderna rischia l’oblio anche perché le sue opere più decisive sono molto complesse e di largo organico, difficili da realizzare dati i tempi di prove divenuti sempre più contratti. Sul piano della ricerca molto aveva fatto Giovanni Morelli, e la Fenice realizzò la prima assoluta del monumentale Requiem. Occasioni isolate con una splendida eccezione l’anno scorso: la Maratona ideata, nel quarantennale della morte del musicista, dal nostro Teatro e fortemente voluta da Cristiano Chiarot. Si tratta di una iniziativa singolare e anche eccentrica: una quarantina di autori impegnati in brevi frammenti a ricordo del grande compositore. I pilastri della nuova musica, da Maderna a Nono, da Donatoni a Sciarrino, riemergevano sullo sfondo non come egemonia culturale ma come ansia sperimentale. Quasi assenti le presenze neoromantiche o le contaminazioni con la «popular music». Non c’erano interventi elettronici, ma le analisi strumentali talora sembravano nascere da riflessi tecnologici, con un comune interesse per la composizione del suono. In quest’emozionante Maratona si imponeva la competenza e la versatilità dell’Ex Novo Ensemble. Ad apertura di programma, due inedite pagine pianistiche, Contrappunti n. 1 e Interludi n. 1 (1976-1982) di Ernesto Rubin de Cervin, scrittore e musicista solitario e poetico, recentemente scomparso. È una polifonia astratta nella quale affiorano i meccanismi seriali della Scuola di Darmstadt filtrati attraverso Bach e l’avanguardia storica viennese. Ancor più ricca e felicemente articolata la replica della rassegna, che si svolgerà il prossimo luglio sempre nell’ambito del festival lagunare della Fenice: una quarantina di opere nuove offriranno un panorama esauriente degli attuali orientamenti compositivi. Sorprende nella programmazione la conoscenza delle tendenze più vitali della nuova generazione italiana. Opportunamente i brani saranno non più di tre, ma di cinque minuti. Inoltre si ascolteranno ancora nella prossima stagione inediti lavori sinfonici in omaggio a Morelli. Un’occasione rara per i compositori di oggi di poter disporre dell’Orchestra. * Critico musicale VENEZIAMUSICA e dintorni | 9 Lo spirito della musica di Venezia IL FESTIVAL E LA CITTÀ Conversando con un’imprenditirce I a cura di Leonardo Mello l festival «Lo spirito della musica di Venezia» si estende in modo tentacolare per tutta la città, interessando dunque anche le realtà produttive che qui lavorano. Incontriamo Gloria Beggiato, proprietaria dell’Hotel Metropole, uno degli alberghi più importanti del centro storico, per chiederle quali sono, dal suo punto di vista, le ricadute di un progetto del genere. Sono entusiasta di quest’iniziativa, perché, trattandosi della Fenice, sono certa della qualità. Nel mio lavoro ho sempre più compreso l’importanza che ricopre l’avere un rapporto con i propri clienti, guidarli all’interno delle offerte che la città produce. Quest’estate poi si svolge anche la Biennale Architettura, che attrarrà un pubblico molto probabilmente interessato alle manifestazioni di tipo musicale programmate dal festival. Mi sembra che, anche sul versante della comunicazione, la Fenice abbia fatto dei grossi passi avanti. Per poter a mia volta indirizzare le persone che soggiornano da noi ho la necessità di essere informata, con anticipo, sui programmi. Soltanto in questo modo infatti è possibile stabilire un collaborazione biunivoca: unendo le forze si possono raggiungere obiettivi importanti. Una rassegna così stratificata, con proposte variegate e diffuse nell’intera città, è certamente un’occasione ghiotta per i visitatori, a patto – come dicevo – che ne siano informati. E i grandi alberghi, dove è accolto un certo tipo di pubblico, possono essere un importante anello di congiunzione. Nel flusso turistico, ha riscontrato, durante la 10 | VENEZIAMUSICA e dintorni tradizionale stagione del Teatro, dei picchi di prenotazioni legate a singoli eventi musicali? Questo dato non lo potrei affermare con certezza, forse perché non l’ho mai tenuto sotto diretta osservazione. Ma mi riprometto di farlo ora, sulla scia dell’entusiasmo che mi hanno provocato i nuovi programmi della Fenice. Il Metropole ha intenzione di dedicare degli spazi al Teatro, con dei pacchetti personalizzati per i suoi spettatori. Quindi nel prossimo futuro potremo monitorare meglio questo aspetto. Il festival cade in un periodo dell’anno particolare, quando normalmente gli eventi culturali si riducono o addirittura svaniscono. A maggior ragione mi sembra un’ottima idea crearlo, e magari renderlo un appuntamento fisso. Per Venezia, dal punto di vista turistico, luglio e agosto sono «intermedi»: non siamo in altissima stagione, ma nemmeno nella bassa stagione invernale. Il pubblico estivo cerca una Venezia diversa, quindi è potenzialmente attratto dalle proposte culturali. Tornando allo specifico al festival, per fare solo un esempio ho trovato molto intelligente organizzare appuntamenti musicali il venerdì prima del Redentore, che è uno dei momenti di massima affluenza turistica. Così il cliente può contare su due momenti contigui di offerta spettacolare. Parlando più in generale, com’è, nella sua esperienza, la relazione tra grandi strutture alberghiere e istituzioni culturali? Il più delle volte è assente la programmazione Contesti e la comunicazione. E senza questi due elementi è impossibile dare vita ad alcuna sinergia. Per questo insisto ancora sul rapporto avviato con la Fenice. È quella la strada giusta, basta sedersi intorno a un tavolo e condividere opinioni ed esigenze. Così sarà possibile costruire un progetto comune, che coinvolga anche gli enti pubblici, per trarne tutti reciproco vantaggio: gli alberghi, le istituzioni culturali e soprattutto le persone che vengono qui in vacanza. I veneziani sono piuttosto insofferenti nei confronti dei flussi turistici. Be’, c’è turismo e turismo. Dubito che chi sceglie Venezia per seguire un concerto o uno spettacolo d’opera, e che spesso soggiorna da noi, possa creare problemi o disagi ai residenti. Le chiedo infine come giudica il rapporto tra le diverse realtà alberghiere cittadine. È un tasto dolente. Io, anche nella veste di vicepresidente dell’Associazione Albergatori, ho sempre incontrato molti freni. C’è poca apertura nei confronti della programmazione culturale. Si fa troppa politica, e quindi vengono meno le energie per poter operare assieme unendo le forze. Perciò ho dato le dimissioni dall’incarico. A Venezia, non soltanto per quanto riguarda gli albergatori, manca il dialogo. Forse perché, di fronte a tanta bellezza, si crede che dialogare non sia necessario. Invece, per individuare il tipo di turismo più congeniale alla città sarebbe necessaria una collaborazione a tutti i livelli, che purtroppo, almeno per ora, non si vede. VENEZIAMUSICA e dintorni | 11 Lo spirito della musica di Venezia «HÔTEL EUROPE» DI BERNARD-HENRI LÉVY A colloquio con il filosofo francece C a cura di Silvia Manzoni* hiuso nella camera di un albergo di Sarajevo che l’aveva già ospitato vent’anni prima, assalito dai ricordi del passato, un uomo, «probabilmente uno scrittore» (interpretato dall’attore francese Jacques Weber), riflette a voce alta. Ha solo due ore per preparare un discorso per le commemorazioni dello scoppio della guerra del 1914. Sono passati cento anni dal grande conflitto mondiale. E appena venti da quello, su scala più piccola, di cui la città balcanica è stata testimone e martire. Ma l’ispirazione tarda a venire e gli interrogativi su cosa dire di quest’Europa dai valori contraddittori, spesso poco coraggiosa nelle sue scelte, gli impediscono di trovare il flusso delle parole. Una trama lineare, quasi scarna e due ore di monologo intenso per abbordare grandi temi d’attualità: è così che il filosofo francese Bernard-Henri Lévy ha deciso di parlare dell’Europa, in una pièce (Hôtel Europe) che è una lunga riflessione sull’identità del Vecchio Continente, sui suoi demoni, le sue contraddizioni ma anche le sue più alte aspirazioni. Il conflitto nell’ex Jugoslavia, Lévy l’ha vissuto in prima persona: nel paese in guerra l’intellettuale francese aveva girato il film-documento Bosna! nel 1993 e, sulle barricate, aveva conosciuto un altro intellettuale, Dino Mustafic, all’epoca cameraman dell’esercito bosniaco, che oggi è il regista del nuovo spettacolo. Hôtel Europe non poteva dunque che essere rappresentato in prima mondiale, il 27 giugno, nella città che fa da sfondo alla pièce, a cento anni meno un giorno dall’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando che fu all’origine dello scoppio della guerra. Ma appena qualche giorno dopo, l’11 12 | VENEZIAMUSICA e dintorni luglio, in prima assoluta, lo spettacolo esordirà al Teatro La Fenice di Venezia, e sarà il momento-clou del festival «Lo spirito della musica di Venezia». Dal 9 settembre sarà in scena al Théâtre de l’Atelier di Parigi e successivamente in tournée in Francia. Perché proprio Venezia per la prima assoluta? Sono particolarmente fiero di esordire alla Fenice perchè sono uno di quei francesi per i quali l’Italia è una seconda patria. Amo moltissimoVenezia, che per me è una città fondamentale, una delle grandi capitali dell’Europa dei valori. La mia carriera oltretutto è strettamente legata a questa città: il mio primo libro La barbarie dal volto umano è stato pubblicato una quarantina d’anni fa, con una prefazione di Leonardo Sciascia, da un editore veneziano, Marsilio, e da allora il legame non si è mai spezzato. Mi sento un cittadino veneziano. Crede che la Fenice sia il palcoscenico giusto per Hôtel Europe? Ritengo che sia il luogo ideale dove lanciare un grido d’allarme sulla crisi della civilizzazione europea. Nel 1938 uno dei più grandi pensatori moderni, Edmund Husserl, lanciava un messaggio della stessa natura da Vienna. Nel 2014 un filosofo contemporaneo farà lo stesso dal palcoscenico della Fenice di Venezia. Ma, al di là di questo, penso che La Fenice sia il più bel teatro del mondo. L’ho conosciuto la prima volta nel 1966 e mi ha subito fortemente impressionato. Le emozioni che ho sentito * Giornalista Bernard-Henri Lévy quella volta si ripetono a ogni visita. Per questo ho provato una grandissima gioia quando mi è stata proposta questa opportunità, che condivido con i miei amici di Sarajevo che hanno lavorato alla realizzazione dello spettacolo, primo fra tutti Dino Mustafic, probabilmente uno dei più grandi registi europei. Oltre a questa personale soddisfazione, penso che non sarebbe potuto accadere niente di meglio al mio testo. Chi è il protagonista di Hôtel Europe? Un uomo profondamente europeo nel cuore e nello spirito, che sente l’Europa come la sua grande patria. È francese, italiano, veneziano... ma, soprattutto, è europeo. Seduto davanti al computer, nella sua camera d’albergo, a Sarajevo, deve prepare un discorso sull’Europa presente e futura, che pronuncerà davanti a cittadini venuti da tutti i Paesi. Ma è bloccato perché prova uno scontento interiore, un malessere indefinito. Davanti ai suoi occhi passano le silhouette di personaggi tristemente presenti nell’attualità: Vladimir Putin, Marine Le Pen e i tentativi del suo movimento populista di distruggere i valori comuni... Queste figure sollecitano in lui molte domande e ampie perplessità... Pensa alla Grecia culla della civilizzazione europea, alle principali questioni filosofiche, al conflitto tra Husserl e Heidegger. È attraversato da sentimenti diversi: rabbia, speranza, euforia, delusione... È un monologo, un genere particolarmente difficile, che Jacques Weber interpreta in maniera brillante. Poi c’è un colpo di scena che fa sì che il discorso sarà alla fine pronunciato. Quindi un lieto fine che fa ben sperare anche per l’Europa... Venendo a vedere la pièce si capirà perché la speranza di costruire un’Europa migliore, in fondo, resti ancora intatta. Con questo spettacolo ho voluto esprimere il malessere della civiltà europea, lanciando un grido di rabbia contro chi l’ha provocato. Vorrei offrire degli spunti di riflessione ai miei concittadini d’oggi e ridare concretezza al sogno europeo. È una pièce sull’Europa della cultura, dello spirito, dell’azione. Un’Europa capace di dire no a Putin in Ucraina, capace di non chiudere meschinamente le sue porte, di mostrarsi unita quando deve parlare di grandi temi internazionali, come il genocidio avvenuto in Rwanda.Un’Europa, infine, coraggiosa, fedele ai suoi principi di universalità che sono le sue basi, insomma tutto il contrario di quella velleitaria che vediamo oggi. Pensa che l’ideale europeo sia in pericolo? Se non lo resuscitiamo rapidamente andremo di certo verso tempi bui. Un tempo si diceva «Socialismo o Barbarie» e penso di aver pronunciato queste parole proprio a Venezia nel 1976. Quarant’anni dopo bisogna cambiare questo slogan con «Europa o Barbarie». Quando si sentiranno queste parole pronunciate da Jacques Weber si capirà anche però perché resto ottimista: credo che malgrado la mediocrità degli uni e la vigliaccheria degli altri ci siano serie ipotesi perché l’Europa abbia la meglio. VENEZIAMUSICA e dintorni | 13 Lo spirito della musica di Venezia DUE«NEMICI PUBBLICI», MICHEL HOUELLEBECQ E BERNARD-HENRI LÉVY N el 2008, per i tipi di Flammarion/Grasset & Fasquelle, è uscito Ennemis Publics, il graffiante scambio epistolare tra Michel Houellebecq e Bernard-Henri Lévy, dove vengono trattate con sagacia e ironia le più varie questioni legate alla politica, alla cultura e al ruolo dell’intellettuale. Pubblichiamo qui, dall’edizione Bompiani (2009) le prime due lettere (pp.5-8 dell’edizione italiana). Bruxelles, 26 gennaio 2008 Caro Bernard-Henri Lévy, tutto come dicono, ci separa, a eccezione di un punto, fondamentale: siamo entrambi individui piuttosto disprezzabili. Specialista delle imprese destinate a fallire miseramente e delle buffonate mediatiche, disonori persino le camicie bianche che indossi. Amico dei potenti, immerso fin dall’infanzia in una ricchezza oscena, sei il simbolo di quella che certe riviste di modesto livello come «Marianne» continuano a chiamare la «gauche-caviar», e che i giornalisti tedeschi definiscono più finemente Toskana- 14 | VENEZIAMUSICA e dintorni Fraktion. Filosofo senza pensiero, ma noo senza relazioni, sei inoltre l’autore del film più ridicolo della storia del cinema. Nichilista, reazionario, cinico, razzista e vergognoso misogino: collocarmi nella poco attraente famiglia degli anarchici di destra sarebbe ancora farmi troppo onore; fondamentalmente, non sono che un beauf. Autore piatto, senza stile, sono assurto alla notorietà letteraria solo in seguito a una inverosimile mancanza di buon gusto dimostrata, alcuni anni fa, da critici disorientati. In seguito, per fortuna, le mie provocazioni bolse hanno finito con lo stancare. Noi due simboleggiamo perfettamente lo spaventoso sfascio della cultura e dell’intelligenza francesi registrato di recente, con severità ma con esattezza, dalla rivista «Time». Non abbiamo contribuito affatto al rinnovamento del panorama musicale francese. Non figuriamo neppure nei titoli di Ratatouille. Le condizioni per il dibattito ci sono tutte. Michel Houellebecq Bernard-Henri Lévy Parigi, 27 gennaio 2008 Il dibattito? Tre piste possibili, caro Michel Houellebecq. Pista numero 1. Bravo. C’è tutto. La tua mediocrità. La mia nullità. Il nulla sonoro che fa da pensiero. Il gusto che abbiamo della commedia, quando non dell’impostura. Da trent’anni mi chiedo in che modo un tipo come me abbia potuto, e possa ancora, darla a bere. Trent’anni che, stanco di aspettare il lettore in gamba che sappia smascherarmi, moltiplico le autocritiche bolse, senza talento, inoffensive. Ebbene, ci siamo. Grazie a te, con il tuo aiuto, forse ci riuscirò. La tua vanità e la mia. La mia immoralità e la tua. Come direbbe un altro disprezzabile, ma di alta levatura, tu metti le tue carte in tavola, io le mie… Che sollievo! Pista numero 2. Tu, d’accordo. Ma perché io? Perché dovrei lasciarmi coinvolgere in questo esercizio di autodenigrazione? E perché dovrei seguirti nella tendenza che manifesti per l’autodistruzione fulminante, esecrante, mortificata? Non mi piace il nichilismo. Detesto il risentimento e la malinconia che lo accompagna. E ritengo che la letteratura serva soltanto a contrastare questo depressionismo che è, più che mai, la parola d’ordine della nostra epoca. In questo caso potrei adoperarmi per spie- gare che ci sono anche corpi felici, opere riuscite, vite più armoniose di quanto sembrino pensare gli anorgasmici che ci detestano. Mi riserverei una parte secondaria, la vera, quella di Filinto contro Alceste, e mi deciderei a fare un sentito elogio dei tuoi libri, e, già che ci sono, dei miei. È un’altra possibilità. Un altro modo di aprire la discussione. E per finire, pista numero 3. Risposta alla domanda che facevi l’altra sera, al ristorante, quando ci è venuta l’idea di questo dialogo. Perché tanto odio? Da dove viene? E come mai possiede un tono, una virulenza così estremi non appena si tratta di scrittori? Entrambi, infatti, ne siamo vittime. Ma, assai più serio è il caso di Sartre, rigettato dai suoi contemporanei. Quello di Cocteau che non ha mai potuto vedere un film sino alla fine perché c’era sempre qualcuno che lo aspettava all’uscita per rompergli il muso… Pound nella sua gabbia… Camus nella sua redazione… Baudelaire che descrive, in una lettera terribile, «la razza umana», coalizzata contro di lui… La lista sarebbe lunga. Poiché si dovrebbe prendere in considerazione l’intera storia della letteratura. E forse (sarebbe la mia tesi) bisognerebbe tentare di sondare il desiderio specifico degli scrittori. Quale desiderio? Ma il desiderio di non piacere! Il gusto della riprovazione. La vertigine, il godimento dell’infamia. Scegli tu. Bernard-Henri Lévy VENEZIAMUSICA e dintorni | 15 Lo spirito della musica di Venezia VENEZIA-PARIGI: ANDATA E RITORNO S di José Sasportes* i deve per forza essere modesti, poiché scrivere sui rapporti culturali Italia-Francia o soltanto sui rapporti Venezia-Parigi richiederebbe dei volumi, e qui dobbiamo limitarci a dei semplici accenni per evidenziare l’importanza dell’argomento. Negli anni sessanta del secolo scorso Vittore Branca ha promosso alla Fondazione Cini delle conferenze su tali rapporti nel secolo dei lumi e nel 1988 Maria Teresa Muraro ha curato il volume L’opera tra Venezia e Parigi con gli atti di un’altro convegno alla Fondazione. In quell’occasione ho parlato di Marmontel musa dei balli a Venezia. Lì mettevo in risalto il contributo indiretto di Marmontel agli sviluppi del ballo pantomima a Venezia, giacché alcuni dei suoi Contes Moraux avevano ispirato dei coreografi italiani che li avevano portati in forma di danza sui palcoscenici della laguna. Accadde lo stesso con il suo romanzo Les Incas, che fu pure all’origine di diversi melodrammi cantati in laguna. Questa importazione era il risultato di traduzioni che si pubblicavano a Venezia, essendo la città uno dei poli della diffusione in Italia del pensiero oltremontano. Lo scambio è cominciato, però, più presto, e in senso inverso, con l’esportazione dell’opera veneta a Parigi, e questo sin dall’inizio del Seicento, con l’apertura a Venezia dei primi teatri pubblici d’opera. Cosi la fortunata Finta Pazza data al Teatro Novissimo di San Giovanni e Paolo nel 1641 fu portata a Parigi per volontà di Mazzarino e presentata nella Salle du Petit Bourbon nel 1645. La corte fu così colpita dallo spettacolo, e in particolare dalle danze disegnate da Giovanni Battista Balbi e della magia degli allestimenti di Giacomo Torelli, 16 | VENEZIAMUSICA e dintorni che decise di dare alla stampa le incisioni di Valerio Spada, raffigurando appunto le danze che avevano più colpito, quelle dei selvaggi, degli struzzi e delle scimmie. La Finta Pazza rappresentò l’introduzione del melodramma a Parigi, ma, malgrado questo primo successo, o proprio per causa sua, i posteriori movimenti verso la radicazione dell’opera italiana a Parigi furono contrastati dai poeti-librettisti e dai musicisti locali, in primis dal fiorentino Giovanni Battista Lulli, diventato Lully. Nel Settecento, Venezia era alla moda in Europa, e Parigi, da sempre vogliosa di seguire la moda, quando non le toccava imporla, la ritrovava a teatro. Grande fu la recezione dell’opera-ballo Le carnaval de Venise di André Campra nel 1699, che riprese il soggetto nelle Fêtes Venetiennes del 1710. Al contrario dei teatri italiani, dove la sete di novità portava a un rinnovamento costante del repertorio, a Parigi le opere che piacevano duravano a lungo e così negli anni cinquanta Casanova ha potuto ancora vedere le Fêtes Venetiennes e lasciarci una curiosa descrizione: «Dopo una sinfonia molto bella nel suo genere, eseguita da un’orchestra eccellente, si alzò il sipario e vidi uno scenario che rappresentava la piazzetta di San Marco vista dall’isola di San Giorgio: ma notai con sorpresa che il Palazzo Ducale stava alla mia sinistra, e le Procuratie e il Campanile a destra. L’errore troppo buffo, e vergognoso nel nostro secolo, cominciò a farmi ridere, e anche Patu, quando lo informai, ci rise. La musica, quantunque bella secondo il vecchio stile, mi divertì per un po’ perché mi era nuova, ma poi * Scrittore e storico della danza Venezia e la Francia finì con l’annoiarmi; mi affliggeva in particolare la monotona linea melodica punteggiata di acuti fuori proposito. Questo tipo di melopea francese vorrebbe sostituire quella che credono la melopea greca e il nostro recitativo, che i francesi detestano e non detesterebbero se conoscessero la nostra lingua». Casanova ha avuto anche l’opportunità di vedere il ballerino Louis Dupré, le grand Dupré, idolatrato dai parigini, che non gli suscitò grandi impressioni a causa dell’esiguità dei suoi movimenti se paragonati alla destrezza dei danzatori italiani. Questo contrasto fra le due scuole è stato segnalato lungo tutto il secolo. Il sistema teatrale francese centralizzato e monopolista non accettava concorrenza e la semplice festeggiatissima presentazione della Serva Padrona di Pergolesi nel 1752 suscitò una polemica sulle qualità contrastanti del genio musicale italiano e francese che sbocciò nella cosiddetta Querelle des Bouffons e determinò una delle tante espulsioni dei commedianti italiani dalla Francia, sempre segnati da ritorni trionfali, finché nel 1762 arrivò Goldoni alla Comédie Italienne. Nel campo coreografico e musicale il confronto fu agguerrito, poi l’antagonismo fra due modi di concepire il melodramma ha fatto sì che nel Settecento la Francia sia stato l’unico Paese in Europa a non subire la colonizzazione sistematica della danza e del melodramma italiani. Contro questo dominio, l’infido Ange Goudar parlava di brigandage de la musique italienne. La situazione fu momentaneamente risolta con la creazione nel 1789 del Théâtre de Monsieur, cioè il fratello del re, futuro Luigi XVIII, aperto alle novità italiane, sotto la guida di Giovan Battista Viotti. Dal 1801 Parigi avrà un Thêátre Italien, a immagine dell’Italian Theatre di Haymarket a Londra. Da allora in poi i grandi musicisti italiani furono di casa a Parigi, e per segnalarlo basta ricordare Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi. Così come le grandi ballerine italiane, a cominciare da Maria Taglioni, domineranno l’Opéra fino alla fine del XIX secolo. Un piccolo elenco: Carlotta Grisi, la prima Giselle (1841), Fanny Cerrito, Sofia Fuoco, Carolina Rosati, Claudina Cucchi, Caterina Beretta, Amalia Ferraris, Amina Boschetti, Rita Sangalli, Giuseppina Bozzachi, la prima Coppelia (1870), Carlotta Zam- belli, ecc.. Assenti loro, molti balletti non potevano andare in scena. In Italia, le polemiche intorno al melodramma non interessavano poiché la produzione operistica francese non arrivava. Così come non arrivarono a Parigi le polemiche coreografiche italiane fra Angiolini e Noverre che a partire dal 1774 interessarono tutte le piazze italiane. In quest’ambiente si deve mettere in risalto una particolarità veneziana. Dopo la faida scatenata al Teatro Ducale di Milano fra Noverre, Angiolini e i loro sostenitori, il Teatro alla Scala ignorò i balli del primo, viceversa al San Carlo di Napoli, dove comandava il noverriano Charles Le Picq, i balli di Angiolini non furono mai visti. A Venezia, però, trovarono posto sia i balli di Noverre, portati dai suoi discepoli – e qui si vendettero più lavori suoi che a Parigi negli stessi anni – sia quelli di Angiolini, messi in scena da lui stesso: un altro esempio dell’eclettismo del pubblico di Venezia con i suoi molti teatri. I balli danzati alla Fenice nella serata inaugurale del 1792 furono di Onorato Viganò, ma subito dopo venne Salvatore Viganò, che propose una sua versione della Figlia mal Custodita, ballo creato a Bordeaux da Jean Dauberval, sotto il quale Viganò aveva danzato a Londra nel 1791. Questa coreografia, in svariate versioni, costituisce l’unico ballo rimasto fino a oggi nei repertori internazionali. A Parigi arrivò solo dopo, al Théâtre de la Porte Saint Martin nel 1803 e all’Opéra nel 1828. Il secolo romantico aveva il suo fulcro a Parigi e la sua influenza arrivò nella laguna ormai austriaca, ispirando diversi libretti. Fra le opere di Verdi che hanno avuto le loro prime alla Fenice come Ernani (1844) o Rigoletto (1851), l’ispirazione veniva da Victor Hugo, e Alexandre Dumas figlio determinò La traviata (1853). Più tardi, a Roma,troviamo Eugène Scribe all’origine di Un ballo in maschera (1859). Nella seconda metà dell’Ottocento s’impone all’Opéra di Parigi la formula del grand opéra, che obbligava a includere in ogni opera un atto dedicato al ballo. Era un’imposizione ai compositori che volevano avere le proprie opere date in città, e tutti, ivi compreso Verdi e Wagner, anche se controvoglia, si sono sacrificati a questo rituale, ereditato dalla tradizione settecentesca. In Italia però, fino ad allora, si era sempre inteso che opera e ballo fossero VENEZIAMUSICA e dintorni | 17 Lo spirito della musica di Venezia separati nelle lunghe serate di spettacolo. Come, per esempio, alla Fenice, nel 1843, Attila di Verdi con La bella fanciulla di Gand danzato dalla diva Fanny Elssler, versione di un ballo di Albert dato l’anno precedente a Parigi, e nel quale il secondo atto si svolgeva in un palazzo a Venezia e la prima scena del terzo atto in una villa sul Brenta. Il modello francese finì per essere adottato in Italia sotto la designazione di opera-ballo, prima per le opere d’importazione di Meyerbeer o di Gounod, dopo per quelle italiane, come il Don Carlo di Verdi alla Fenice nel 1869 o La Gioconda di Ponchielli alla Fenice nel 1884. Soluzione fatale per la danza italiana alla quale fu riservato sempre meno spazio, finché le serate all’opera si accontentarono del solo melodramma. La formula fu applicata ancora più radicalmente a Parigi, dove la produzione di balli diminuì drasticamente verso la fine del secolo XIX. Una tale desertificazione coreografica e la voglia di vedere danzare giustificarono forse l’immenso successo dei balli di Manzotti a Parigi, nel nuovo Eden Théâtre, a due passi dell’Opéra, dove il solo Excelsior ha avuto più di cento rappresentazioni nel 1884. Fu lì che Mallarmé vide la Cornalba e vi s’inspirò per scrivere le sue famose Divagations. All’inizio del Novecento le avanguardie hanno messo in discussione l’assetto tradizionale del ballo e del melodramma, ma né la Francia né l’Italia hanno saputo rinnovare i loto teatri musicali, malgrado i vari futurismi. Le novità maggiori furono le opere russe portate da Diaghilev all’Opéra e i suoi Ballets Russes (1909-1929), che in Italia non hanno riscosso l’applauso unanime raccolto altrove. I Ballets Russes non si sono mai visti a Venezia, nonostante l’interesse di Diaghilev per portarli alla Fenice. Un libro recente di Antonio Foscari, Tumult and Order, sulla folle époque veneziana vista dalla villa Malcontenta, ha rivelato che i veneziani hanno comunque avuto un assaggio di Ballets Russes nel 1927 quando Lydia Sokolova e Serge Lifar danzarono in una scena appositamente allestita da Diaghilev nei giardini del Palazzo Papadopoli. 18 | VENEZIAMUSICA e dintorni Gli anni del fascismo non agevolarono l’intercambio franco-italiano, che a un certo punto fu anche interdetto. Il dopoguerra aprì nuove prospettive, soprattutto per la presenza dell’opera italiana a Parigi e per le Biennali di Musica a Venezia. Da segnalare i trionfi parigini di due uomini di teatro italiani, pure registi d’opera, Luca Ronconi e Giorgio Strehler, il primo con il suo Orlando Furioso nel 1969, il secondo con la sua direzione del Théâtre d’Europe all’Odéon, con spettacoli memorabili come la Trilogia della Villeggiatura di Goldoni, senza dimenticare le esemplari messinscene delle opere di Mozart all’Opéra. Fu sotto l’influsso dei brillanti risultati delle stagioni di Carolyn Carlson all’Opéra, che Italo Gomez decise nel 1980 di invitarla a creare una sua compagnia alla Fenice, da anni senza un corpo di ballo. La sua ambizione, riuscita, era quella di creare un polo fuori dalle regole dei teatri lirici, da dove iniziare un rinnovamento dell’anchilosata danza italiana. Di fatto nei tre anni della permanenza della Carlson alla Fenice sono cresciuti i ballerini italiani che hanno sviluppato la cosiddetta nuova danza, i cui protagonisti furono dopo accolti a Parigi, come Caterina e Carlotta Segna. Un punto finale in questo breve e magro scorcio intorno a vicende ricchissime e non riassumibili in poche righe lo può dare una sorprendente novità venuta alla luce in un cd della Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda e dedicato a Giovan Battista Viotti, che ricordammo come il primo direttore del Théatre de Monsieur nel 1781. Si suona il «Tema e variazioni per violino e orchestra» del 1781, e all’ascolto troviamo esattamente la musica della Marseillaise, che Rouget de Lisle diceva di avere scritto nel 1791, quando Viotti era già emigrato a Londra. Un plagio, o meglio un furto vero e proprio, ma questo, sotto l’angolatura dell’interscambio fra due culture, è quello che meno importa. Conviene invece rilevare, in tempi di rigurgiti nazionalisti dalle due parti delle Alpi, che l’inno francese fu scritto da un italiano, a sua insaputa. The Rake’s Progress MODELLI E ARCHETIPI DELLA «CARRIERA DI UN LIBERTINO» L di Gianfranco Vinay* a Carriera d’un libertino, l’opera che fu accolta e interpretata come il culmine del neoclassicismo di Stravinsky è innanzitutto il culmine di una drammaturgia musicale sviluppatasi all’interno della vicenda stilistica personale. Uno stile che era sbocciato in tutta la sua pienezza all’epoca dei primi balletti in collaborazione con la compagnia di Diaghilev e i cui principi fondamentali sarebbero rimasti inalterati nel corso di più di mezzo secolo: la durata temporale come struttura-base di una forma a mosaico, il ritmo come elemento dinamico, un’espressività anti-patetica, anti-sentimentale, anti-psicologica basata su una gestualità di tipo rituale; l’armonia, il timbro, il contrappunto utilizzati in modo originalissimo sia rispetto alla tradizione che all’avanguardia. È evidente che tale stile, inaugurato e sviluppato nell’ambito del balletto, avrebbe trovato difficoltà ad adattarsi a generi teatrali che coniugano musica, gesto, scena e vocalità. Scartato il melodramma non solo per motivi poetici, ma anche perché la sua dinamica patetica e sentimentale era agli antipodi delle categorie stilistiche di Stravinsky, egli sperimentò diverse soluzioni che, da Mavra (1921) in poi, si baseranno sullo stesso principio: ogni numero operistico sviluppa uno o più «gesti» musicali che caratterizzano la situazione drammatica mediante atteggiamenti espressivi differenziati ricalcati su modelli tratti da un vastissimo repertorio. La trasposizione in musica di questi gesti presi in prestito dalla tradizione del passato permette a Stravinsky di variare continuamente atmosfera nel corso delle diverse scene, senza però esprimere direttamente emozioni e sentimenti dei personaggi, praticando qualcosa di simile alla «teoria degli affetti» di barocca memoria. Nonostante l’importanza indubbia che questi modelli assumono nella strutturazione dell’opera essi non attenuano mai lo smalto inconfondibile del suo stile, che se ne appropria in modo osmotico. Stravinsky definì questa osmosi fra stile e modelli con il termine di «manière», e riconobbe in Oedipus Rex l’opera-oratorio che lo rese consapevole dell’utilizzazione creativa di tale principio. Ogni nuova composizione introduce nuove maniere che contribuiscono a determinare la sua «tinta» specifica, ma anche altre già introdotte in opere precedenti sono riprese e rigenerate. Man mano che gli anni passavano e il catalogo stravinskiano si arricchiva di nuove opere, il processo parodistico si trasformò sempre più in un processo autoparodistico. La carriera di un libertino è un vaso ricolmo di queste maniere, vecchie e nuove. Quelle nuove, generate dalla versificazione inglese e dall’ambientazione della vicenda, saranno immediatamente riprese nella Cantata. Quelle vecchie coprono lo spazio di un trentennio – l’arco intero del cosiddetto periodo neoclassico. Da quando Stravinsky si lasciò scappare che aveva ascoltato Così fan tutte assieme a Auden all’epoca della loro collaborazione alla sceneggiatura, diversi musicologi, anche in tempi recenti, si sono affannati a cercare le fonti mozartiane e le analogie tematiche. Disponendo di un ricchissimo serbatoio di maniere personali Stravinsky non aveva bisogno di citare o ricalcare modelli mozartiani. * Musicologo – Université de Paris VIIIa VENEZIAMUSICA e dintorni | 19 Lo spirito della musica di Venezia Diverse delle maniere ricorrenti nella Carriera di un libertino derivano da Apollon musagète, ed è proprio l’animazione creata da un accompagnamento ricco di formule ritmiche «danzanti» che apparenta Stravinsky a Mozart. Il fatto che queste maniere funzionino benissimo sia in un balletto che intendeva ricreare una classicità sovratemporale coniugando Lulli con Cajkovskij, sia in un’opera ambientata nel 20 | VENEZIAMUSICA e dintorni Settecento, può far capire in che misura i modelli siano stilizzati. Sospesi tra un passato indeterminato e il presente dell’attualizzazione stilistica, più che di modelli assumono la funzione di archetipi. Il modello è qualcosa che si ricalca, un disegno di cui, sotto la copia, si percepiscono i contorni, l’immagine originale. L’archetipo è qualcosa che si rigenera, che appare ogni volta sotto una forma diversa. The Rake’s Progress UNA CRONACA D’ECCEZIONE PER IL «RAKE’S PROGRESS» T di Vera Stravinsky he Rake’s Progress andò in scena al Teatro La Fenice l’11 settembre 1951, nell’ambito della XIV Biennale Musica. Qui di seguito presentiamo il divertente racconto che di quella serata ha lasciato Vera Stravinskij. Il testo è tratto da Enzo Restagno, Schönberg e Stravinsky, il bel volume uscito per Il Saggiatore nel 2014. A sua volta lo studioso trae la citazione da Igor’ Stravinskij e Robert Craft, Ricordi e commenti, traduzione italiana di Franco Salvatorelli, Adelphi, Milano 2008. Era una sera di caldo soffocante e scirocco. Le calli vicino al teatro erano sbarrate da corde per tenere a bada il Quarto Stato durante la processione d’arrivo, sebbene la maggioranza degli appartenenti agli Stati 1-3 non arrivasse a piedi ma fosse depositata da gondole e motoscafi direttamente all’ingresso laterale del teatro sul canale. […] Tra le facce immediatamente familiari nel foyer, una di familiarità remota venne verso di me con un’espressione molto emozionata. Si trattava di Zinovij Peskov, il figlio adottivo di Maksim Gor’kij, visto l’ultima volta nel Caucaso durante la Rivoluzione russa. Ma il generale Peskov fu presto sopraffatto dalla ressa di altri vecchi amici venuti a giudicare e a «presenziare» altrimenti allo spettacolo. La Fenice quella sera sfolgorava in onore del debutto, e mazzi di rose, come bouquet di debuttanti, ornavano ogni palco. Ma all’interno la bellezza di questi ricetti era men che a fior di pelle, il velluto avendo apparentemente sofferto ad opera delle tarme. Avevano altresì bisogno di deodoranti, il che poteva essere in parte la ragione delle rose. I sedili erano scomodi, e si fronteggiavano, come ne- gli scompartimenti ferroviari europei, di modo che gli occupanti del lato verso il palcoscenico (cioè gli uomini, se educati) sono rivolti verso il fondo del teatro: una disposizione più adatta alle cavallette, che pare abbiano le orecchie riposte nell’addome e nelle gambe. Sfolgorava anche il pubblico, ad eccezione dell’inviato del «New York Times», il cui servizio sull’evento si rivelò in armonia non solo con il suo abbigliamento ma con la sua perenne dedizione al luogo comune. In Italia, niente che si rispetti comincia in orario. Durante il lungo indugio davanti al sipario i miei pensieri tornarono alle settimane di preparazione e alle prime conferenze con registi e direttori d’orchestra. […] E pensai anche, durante l’attesa, agli echi nell’opera della vita cosiddetta privata di Igor’: la partita a carte, per esempio; gli arpeggi del clavicembalo che imitano il modo di mescolare il mazzo di Igor’; e lo «staccato» dello stesso strumento che rammenta il suo modo di farle schioccare sul tavolo. Auden aveva visto Igor’ fare dei solitari, sentendolo magari sbottare in qualche gros mot russo quando usciva la carta sbagliata, e questo a sua volta poteva aver suggerito l’idea dell’«Al Diavolo!». Pensavo anche a come il dito puntato sul pubblico nell’Epilogo – «tu e tu» – fosse stato ispirato da Walter Huston nell’Oro del demonio, un film che a Igor’ piacque molto. Alle 21.35, puntualmente in ritardo di trentacinque minuti, Igor’ entrò nel golfo mistico e si inchinò profondamente al pubblico, che sebbene ultra demi-mondaine sembrò applaudirlo con una nota di sincero apprezzamento. Poi si volse all’orchestra, in modo che solo i suoi straordinari bozzi occipitali e il piccolo gesto energico furono visibili, VENEZIAMUSICA e dintorni | 21 Lo spirito della musica di Venezia e cominciò. I cantanti erano Robert Rounseville, non del tutto emerso da una carriera a Broadway, scelta felice per la parte di Tom Rakewell, Elisabeth Schwarzkopf, una Anne serena e perfetta; Hugues Cuénod, un sottile Sellem; e Jennie Tourel, che nella parte della diva Baba avrebbe potuto fare la sua uscita grandiosa in groppa a un elefante senza rischiare un risolino […]. Igor’ non rivendicava a questa musica altro merito che di essere convenzionale. Ma che belle invenzioni ci sono, anche: le progressioni armoniche alla fine della prima metà della cavatina, la modulazione per «O wilful powers», la trasformazione del motivo di ballata nelle scene finali, le rappresentazioni stilizzate della paura di Tom nel cimitero 22 | VENEZIAMUSICA e dintorni (le doppie appoggiature), e la loro ricomparsa nella scena della sua pazzia. Sembrava che Igor’ avesse riservato le sue ispirazioni più belle per il finale, in «Venus, mount thy throne», nel duetto del «foolish dream», e in «Where art thou, Venus?», che per me è musica fra le più toccanti che Igor’ abbia mai scritto. La «prima assoluta» fu per molti versi una rappresentazione sperimentale, che a tratti, a dire il vero, andava quasi a rotoli, e in generale era alquanto velleitaria. Nondimeno essa trasmise molto del senso vero dell’opera, e credo che tutti, tranne l’opaco newyorchese, la seguirono con commozione. Dopo andammo a una festa post-mortem alla Taverna La Fenice, che non si sciolse fino all’alba nebbiosa. The Rake’s Progress UNA RECENSIONE D’ANNATA I di Mario Messinis l 17 aprile 1976 La carriera di un libertino è tornata in Fenice in un fortunato allestimento di Virgtinio Puecher. Riproduciamo la recensione di allora, firmata da Mario Messinis per «Il Gazzettino» e uscita il 20 dello stesso mese. La carriera di un libertino di Stravinsky (la storia di un dissoluto che soggiace alle tentazioni e alla fine finisce in manicomio), è un deliberato omaggio all’operismo comico del Settecento, e al Così fan tutte mozartiano, in particolare. Ma è anche, ovviamente, un’opera che rispecchia una temperie culturale squisitamente novecentesca. Di qui il problema, tutt’altro che agevole, della sua interpretazione scenica. Stravinsky, quando la presentò alla Biennale di Venezia, nel 1951, richiese una versione rappresentativa che doveva rispettare, alla lettera, le convenzioni dell’operismo settecentesco, quasi si trattasse del Figaro o del Così fan tutte mozartiani, appunto. Virginio Puecher, invece, opta per una soluzione meno semplice e più deliberatamente critica. Punto primo. La carriera, nonostante l’apparente disimpegno linguistico, visto che è costituita da una specie di mosaico di citazioni della tradizione melodrammatica (finte o reali, poco conta), è un’opera profondamente seria. Dietro le apparenze di una semplice favola c’è una posizione dichiaratamente didascalica e moralistica. Strawinsky, insomma, esige che lo spettatore partecipi ad un giudizio che egli stesso dà della storia. Non a caso i modelli sono ridotti a stereotipi: i miti-Faust come Mefistofele (il libertino Tom è infatti uno strumento nelle mani del diavolo) sono in fondo ridotti ad involucri cavi, privati delle loro profonde motivazioni: proprio perché, su una materia svilita, si appunta con più decisione la crudele osservazione del musicista. È questo, in fondo, lo stesso nucleo centrale della regia di Puecher, il suo momento massimamente significativo: Tom Rakewell, il libertino, ci appare così sulla scena come un Faust idiota e svampito, preda della furbizia corriva e teatrale del diavolo-maggiordomo, Nick Shadow. Le tentazioni, sembra dire Stravinsky – con una punta di acida censura cattolica – distruggono l’uomo, lo riducono ad un imbelle strumento del destino. Ma la sua «predica» il compositore la svolge con il partito della futilità e del gioco, seguendo in questo anche le indicazioni del suo perfetto librettista, Winston Auden. Il virtuosismo manieristico e l’intarsio, a scatola cinese, delle situazioni, inserite in un geometrico avvicendarsi di fatti, chiuse entro l’asettico involucro della favola, è alla base infatti dell’invenzione, insieme letteraria e musicale. Ma non c’è una rivitalizzazione del Settecento, bensì una successione di calchi esanimi e sublimi, una esasperazione archeologica, che poi coincide con il recupero di lingue morte, ripensate dall’autore come fossili astorici, ridotti a parvenza, a emblemi di un mondo travolto e inghiottito dal tempo. Il gioco, allora, si allea al cimiteriale: Stravinsky passeggia tra i musei della civiltà occidentale per estrarre le tessere gelidificate di una testimonianza perduta. La tragicità dell’opera, allora, corrisponde alla stessa operazione sul linguaggio che si preclude deliberatamente la felicità della creazione. È chiaro che questa implacabile vicenda di contaminazioni lessicali condotta con l’arido calcolo del perfetto artigiano, rifiuta prima di tutto lo psicologismo per puntare sulla finzione. Di qui le molte sottolineatuVENEZIAMUSICA e dintorni | 23 Lo spirito della musica di Venezia re ironiche della regia (al limite anche suggestionate dal didascalismo brechtiano), l’ironia, per esempio, nel primo quadro, del mondo puritano e borghese del Settecento inglese, delle convenzioni familiari; oppure la meccanicità giocosa nella figura di Baba la turca, la donna barbuta sposata da Tom, come semplice abbandono «all’atto gratuito», e così via. Continuamente, insomma, lo spettacolo tende a sottolineare che ciò che accade sulla scena è finto; allo stesso modo il montaggio compositivo allude ad un Settecento che viene a sua volta cancellato attraverso l’accostamento simultaneo alle fonti più disparate, da Mozart a Ciaikovski, allo stesso Stravinsky; l’ingordigia filologica, allora, postula il più totale livellamento del materiale storico, che è poi lo sconvolgente impegno di modernità che questo capolavoro propone. Il discorso di Stravinsky tuttavia rimane, mozartianamente, ambiguo. Le sue lucide geometrie, con l’implacabile avvicendarsi di manichini inerti, sono come periodicamente folgorate da inconsapevoli e contratte evasioni liriche, che punteggiano continuamente l’opera: è la rivincita del materiale disseccato, che ripropone l’espressivo, magari come metafora. Anche questo aspetto è stato sottolineato da Puecher, visto che la sua regia opera su due piani: il gioco, al limite parodistico, dei burattini, e la serietà dell’assunto, quale si rapprende intorno alla figura della «salvatrice» Anna, che rincorre utopisticamente l’idea della redenzione dell’amato. Ci sarebbe solo da osservare che nella musica il problema non è risolto in modo deciso, ma l’ambiguità, con la conseguente duplicità dei piani drammatico-musicali, è inestricabile e non didatticamente e teatralmente definibile. Ma Puecher opera con molta discrezione e le sue scelte le individua mantenendo inalterato l’impianto favolistico della vicenda. Le scene e i costumi sono stati attuati dal Collettivo dell’Accademia di Brera (è un lavoro di scuola eccellente: varrebbe la pena forse riproporre un simile esperimento anche con gli allievi dell’Acca- 24 | VENEZIAMUSICA e dintorni demia di Venezia) e riescono molto accortamente a ricreare, attualizzandoli, certi temi cari all’iconografia del Settecento inglese, incline ad una severità cromatica e figurativa. Solo nel quadro finale – che rappresenta il manicomio, con un bell’effetto di evidenza teatrale nelle scheletriche impalcature sceniche – si sarebbe voluto un più esplicito riferimento all’evocazione arcadica, al sogno ellenistico, caro a Stravinsky: che è l’apoteosi classicistica concepita però come inevitabile destino di morte. Alla fine, appunto, il libertino crede di essere Adone e ravvisa in Anna Venere e rende omaggio al motivo dell’evasione, ma come allusione al tema classico della follia. L’attendibilità della regia di Puecher (che giunge a Venezia dopo essere stata collaudata in vari teatri italiani), è confermata anche dal lavoro rigoroso condotto sui personaggi singoli, che si muovono come veri attori, contestando le troppo viete consuetudini del mondo del melodramma. Spiccano i tre autorevoli protagonisti – l’amletico, remissivo, ma anche intensamente patetico, nel quadro d’epilogo, Lajos Kozma, nei panni dello sventurato libertino, l’arrogante e musicalissimo Claudio Desderi in quelli del servo-Mefistofele e la delicata, sognante Lella Cuberli, nel ruolo di Anna. Ben riuscite anche le caratterizzazioni burlesche di Baba la Turca (Rosa Laghezza) e del venditore all’asta (Oslavio di Credico). Negli altri ruoli figurano infine Graziano del Vivo, Rosetta Arena, Giovanni Antonini. Anche il coro, felicemente preparato da Aldo Danieli, è molto efficace e si muove con agevolezza in un ruolo complesso. L’aiuto regista è Patrizia Gracis, che ha curato anche una mostra sul Settecento inglese. La direzione di Ettore Gracis, dopo qualche squilibrio nei primi quadri, ha definito con composita timidezza la complessa trama cameristica dello strumentale, obbedendo ai principi, squisitamente stravinskiani, di un discorso non emozionato, che nell’epilogo però si libera nell’ascesi religiosa. Felici gli interventi solistici delle prime parti dell’orchestra. Successo cordiale. The Rake’s Progress «UN CAPOLAVORO DEL MIO TEMPO» Una conversazione con Damiano Michieletto I a cura di Leonardo Mello ncontriamo Damiano Michieletto, il regista cui è stato affidato l’incarico di allestire The Rake’s Progress. Come si è avvicinato a questo lavoro di Stravinskij/Auden? È un’opera che amo molto e che considero già parte della storia del teatro musicale, pur essendo stata composta «recentemente» rispetto al repertorio cui siamo abituati. È uno degli esempi più riusciti della fusione tra libretto e musica, per cui la ritengo un capolavoro, un’opera «elettrizzante». Come si immagina il personaggio principale, Tom Rakewell? Vive un viaggio. A un momento iniziale di innocenza segue un percorso costellato di tentazioni, non a caso Tom è accompagnato dal diavolo, che lo conduce in situazioni extra-ordinarie, come lo sposarsi con una donna barbuta, di cui non si capisce bene l’identità sessuale, oppure frequentare un bordello, per citare due esempi. Il maligno lo porta insomma in contesti ai limiti. E tutto quello che sta ai limiti attrae l’uomo, perché rappresenta qualcosa di pericoloso e allo stesso tempo affascinante. Basta pensare, facendo un paragone extramusicale, a tutte le persone appassionate di Formula Uno: l’umano è irresistibilmente attratto da tutto quanto è estremo e potenzialmente rischioso. Questa spasmodica ricerca del protagonista alla fine si conclude in un manicomio, dove il degrado è massimo e il processo di autodistruzione raggiunge il culmine. Secondo lei c’è un giudizio moralistico da parte degli autori? Questa vicenda è dichiaratamente definita «una favola». E come tutte le favole al termine si incontra necessariamente la morale. Nell’epilogo tutti i personaggi vengono fuori, ricalcando una struttura di stampo mozartiano, e invitano in modo diretto il pubblico a stare attento al diavolo e al suo potere fascinatorio. Tuttavia io non credo mai nell’arte che propone una morale. In questo caso ci troviamo semplicemente di fronte a un monito: Stravinsky e Auden mettono gli spettatori al corrente di un rischio, ma lo stesso rischio è di fatto il tema centrale di tutta l’opera, ne costituisce l’elemento emozionante. Del resto è quanto accade nel Don Giovanni. Qual è il personaggio che suscita emozioni e per il quale lo spettatore va a teatro? Proprio Don Giovanni, anche se incarna la figura di un demone che distrugge la vita di tutti. La carriera di un libertino si focalizza proprio su questo tema, prendendo spunto da una serie di incisioni di William Hogart, ispirandosi alle quali il poeta inglese ha creato un libretto. Quali sono gli elementi principali dell’allestimento? Ho cercato di trovare una metafora per rendere in maniera simbolica il racconto di questo viaggio. A livello spaziale lo spettacolo è ambientato in una piscina, che all’inizio si presenta piena di soldi e dove avviene una vera e propria orgia: il denaro si mescola all’elemento carnale. Poi lentaVENEZIAMUSICA e dintorni | 25 Lo spirito della musica di Venezia mente questa piscina si riempie di altri elementi, fino a svuotarsi del tutto. Nel finale diventa sporca di fango e raffigura l’immagine di un luogo di degrado, in cui si consuma la tortura e la morte di Tom. Ho voluto progettare una messinscena graffiante, come a mio parere è la musica, ma al medesimo tempo molto ironica e autoironica. Il modo di Stravinsky di lavorare i personaggi è connotato da un forte senso di ironia. Il diavolo, che è una presenza costante nella storia, cambia moltissime identità: una volta è vestito da prete, un’altra da postino e così via, a sottolineare l’impossibilità di dargli un volto univoco. Si nasconde dietro a qualsiasi figura e dietro a qualsiasi nome. L’opera, come fonte di ispirazione, è fortemente legata al Settecento, non solo in termini figurativi, attraverso le incisioni di Hogart, ma anche in termini formali, con un richiamo dichiarato a Mozart. Tuttavia in scena non vi è alcun riferimento a quel periodo storico, perché ho preferito trasporre la vicenda ai giorni nostri. 26 | VENEZIAMUSICA e dintorni Ci sono differenze tra il lavoro sul melodramma classico e quello invece dedicato a una composizione moderna? In realtà è un problema che non mi sono posto. Posso dire che per me è stato molto stimolante confrontarmi con materiali composti nel 1951, perché mi ha riportato a un’epoca molto più vicina a quella cui appartengo. Questo mi dà coraggio, e spero infonda coraggio anche alle istituzioni teatrali nel ricercare chi oggi è in grado di comporre musica e di scrivere libretti. Penso sia assolutamente necessario proporre un teatro musicale contemporaneo. Credo molto nella forza intellettuale ed emotiva di questo genere espressivo, e nella sua capacità di superare le barriere linguistiche e andare oltre i confini nazionali. In questo senso per una volta non mi sono sentito ancorato al passato, ma ho provato invece la gradevole sensazione di partecipare a un’operazione artistica che fa parte del mio mondo. The Rake’s Progress W.H. AUDEN E L’IMMAGINARIO «CAMP» W di Franco Buffoni* ystan Hugh Auden, librettista di The Rake’s Progess, è uno dei principali poeti del Novecento inglese. Pubblichiamo qui un saggio inedito su di lui composto da uno dei massimi suoi studiosi italiani e autore, tra le altre cose, della monografia audeniana L’ipotesi di Malin. Se il camp è un modo di vedere il mondo come un teatro dell’innaturale e dell’artificio, uno stile che celebra l’eccentricità e sublima il Kitsch, trasformandolo in una forma di eccellenza estetica per snob supremi, per meta-snob, per chi è in grado di apprezzare perversamente ciò che l’élite culturale disprezza… il camp allora è il dandismo nella cultura di massa: è Oscar Wilde che diviene W.H. Auden. Una degli esempi ricorrenti – quando si vuole «spiegare» il connubio Kitsch-camp – è quello della Drag Queen. C’è persino chi – storicamente – vuole riconoscere in questo connubio la matrice di una fantomatica «sensibilità gay». Forse un briciolo di ragione l’hanno anche costoro, perché prima che il movimento prendesse piede, quindi prima del 1969 (l’anno di Stonewall) o, se si preferisce, prima del 1967 – quando l’omosessualità venne depenalizzata in Inghilterra – tale «sensibilità» non poteva esprimersi se non nella consapevolezza della teatralità quotidiana: gli omosessuali erano costantemente costretti a recitare un ruolo. Al riguardo mi piace citare un passaggio dal Manifesto dal Gay Liberation Front inglese del 1970: «Abbiamo recitato per tanto tempo, siamo attori consumati. Adesso possiamo cominciare a vivere, e sarà un gran bello spettacolo!» Nel 1970 W.H. Auden era ancora vivo: sarebbe mancato tre anni dopo a Vienna, solo in una stanza d’albergo, ma reduce dal trionfo della sua ultima pubblica lettura. Nel 1970 Auden era anche impegnatissimo a incrociare l’attrazione per l’affascinante giovane poeta Josif Brodskji – appena espulso dall’Urss e da lui prontamente raccolto in aeroporto proprio a Vienna – con la passione dominante per le messe in canto della chiesa di Roma e la grand opéra italiana del Sette/Ottocento. Le messe in canto e la grand opéra sono anche la fonte prima di camp-inspiration per i libretti scritti da solo – o a quattro mani con l’ex compagno Chester Kallman – nei due decenni precedenti. Anche in poesia in senso stretto troviamo ampia documentazione di un Auden camp nella produzione precedente. In questa Love Feast, per esempio, pubblicata nel 1951: In an upper room at midnight / See us gathered in behalf / Of love according to the gospel / Of the radio-phonograph. / Lou is telling Anne what Molly / Said to Mark behind her back; / Jack likes Jill who worships George / Who has the hots for Jack. // Catechumens make their entrance; / Steep enthusiastic eyes / Flicker after tits and baskets; / Someone vomits; someone cries. // Willy cannot bear his father, / Lilion is afradi of kids; / The Love that rules the sun and stars / Permits what He forbids. // Adrian’s pleasure-loving dachshund / In a sinner’s lap lies curled; / Drunken absent-minded fingers / Pat a sinless world. // Who is Jenny lying to / By long-distance telephone? / The Love that made her out of nothing / Tells me to go home. // But that Miss Number in * Poeta e critico letterario VENEZIAMUSICA e dintorni | 27 Lo spirito della musica di Venezia the corner / Playing hard to get… / I am sorry I’m not sorry… / Make me chaste, Lord, but not yet. Dove troviamo i catecumeni e l’intertestuale allusione dantesca all’Amore che muove il sole e l’altre stelle; l’invocazione diretta al Lord e persino il riferimento a Lui con l’iniziale maiuscola. Il tutto però ricondotto e – in qualche modo – ridotto a battuta con la menzione del «gospel of the radio-phonograph» e soprattutto nell’invocazione finale: «Make me chaste, Lord, but not yet». Rendendo in questo modo ancora più ambiguo l’imperativo «See us» della prima strofa: è rivolto al lettore o al Lord dell’ultima strofa? E di quale «love» si tratta? Di quello con la lettera minuscola della prima strofa o di quello con la maiuscola della penultima? Tenendo anche conto del titolo della raccolta in cui The Love Feast appare: Nones, che va tradotto «Ora nona» col pensiero rivolto ai catecumeni che aprono la terza strofa. (Doveva suonare – a orecchie anglosassoni a Auden contemporanee – più o meno come oggi chez nous «le tre di notte»). L’atmosfera è da grande Gatsby dei poveri. Magari sono anche studenti con ricca famiglia alle spalle, ma la soffitta, l’upper room dove stanno, è miserella. Però le sostanze agite, gli sguardi, i dialoghi, i sottintesi e i sotterfugi sono quelli disinvolti descritti da Fitzgerald. Vent’anni dopo, tuttavia: Nones raccoglie infatti poesie composte negli Stati Uniti nell’immediato dopoguerra. Ma il distico che in particolare ci connota Auden nel ruolo di icona camp si trova alla fine della seconda strofa. Scrivere con disinvoltura in quegli anni (e pubblicare il testo senza dimenticarlo nel cassetto): Jack likes Jill who worships George / Who has the hots for Jack costituiva un atto di notevole coraggio. La seconda guerra mondiale era finita da poco. New York e San Francisco avevano appena accolto nei loro immensi porti centinaia di migliaia di Jack e di George provenienti dai fronti dell’Atlantico e del Pacifico. E molti tra loro non avevano nessuna voglia di tornare nello Utah o in Colorado a fare il farmer o il carpenter per sentirsi chiedere da zii e cugini: «Perché non ti sposi?». In quegli anni duri in marina – infine – i loro «hots» si erano anche molto liberati. Sorsero così 28 | VENEZIAMUSICA e dintorni – e proprio a New York e a San Francisco – le prime comunità gay modernamente intese. E Winstan Hugh, il poeta celebrato, ne registra callidamente la presenza. Lui, che nel 1947 – con la pubblicazione di The Age of Anxiety – aveva ormai raggiunto la fama mondiale. Anche in quell’opera sempre alle prese con il suo straripante «sé», ma quanto elegantemente mimetizzandosi. Quant è il più interessante e camp dei tre personaggi maschili dell’Età dell’ansia; è un pensionato sessantenne che trascorre le giornate alla biblioteca nazionale leggendo libri di mitologia classica, e – a differenza degli altri characters: il quarantenne ufficiale medico Malin («maligno», palese proiezione di Auden stesso sulla scena), il ventenne marinaio canadese Emble (da «emblema») e la trentenne profuga ebrea Rosetta (dalla celebre stele egizia) – ha ormai raggiunto la pace dei sensi: condizione essenziale per poter ascoltare e osservare con pietà e distacco le trame sentimentali degli altri tre personaggi. Si incontrano da perfetti sconosciuti in un bar di New York nell’inverno del 1944. Solo la radio – che che interrompe i programmi musicali con un bollettino di guerra – li induce a fare conoscenza, dapprima per commentare le notizie, quindi per intraprendere un duplice e fantastico viaggio nel tempo e nello spazio: dalle origini dell’homo sapiens sulla terra all’età moderna; e attraverso le sette età dell’uomo, già cantate da Shakespeare in As You Like It, dall’infanzia alla vecchiaia. Intanto – sotto lo sguardo serafico di Quant – si intrecciano i desideri dei due uomini giovani in licenza breve e di Rosetta, ben truccata e pettinata, che a New York si è rifatta una vita lavorando sodo in un ufficio import-export, e che non riesce a trovare l’uomo giusto: solo proposte one night standing le capitano, come quella dello splendido marinaio che ora la invita a ballare. Ma Emble non aveva abbassato lo sguardo nemmeno quando Malin lo osservava nello specchio del bar, anzi… al punto da far pensare all’ufficiale: Girlishly glad that my glance is not chaste / He wants me to want what he would refuse Quant intanto scuote il capo lasciando cadere a terra la cenere dal suo sigaro. Alla chiusura del bar, i quattro si ritrovano in The Rake’s Progress strada; Rosetta li invita nel proprio appartamento per concludere la serata, in cuor suo sperando che solo Emble accetti. Invece salgono tutti, e sono altri sguardi, musiche, pensieri, drinks fino a quando Quant invita esplicitamente Malin a lasciar soli gli altri due. Rosetta accompagna Malin e Quant all’ascensore, ma prima fa cenno a Emble di aspettarla in camera da letto. Risale, si rinfresca, lo raggiunge e lo trova sonoramente addormentato. L’umiliazione e la rabbia esplodono nel canto del dolore ebraico: Sh’ma’ Yisra’el. Sulla strada intanto Malin (sapendo di mentire) promette a Quant di tornare presto a trovarlo; e l’opera si chiude con Quant che gli volta le spalle borbottando tra sé qualcosa di incomprensibile. Dylan Thomas, di sette anni più giovane di Auden, seppe perfettamente fotografare Auden contribuendo non poco a costruirlo come icona camp. Scrisse nel 1938, dopo che Auden, comunista dandy, ricevette il più importante riconoscimento per la poesia dal governo conservatore: «Auden è esattamente ciò che il pubblico letterario inglese crede che un poeta inglese moderno debba essere. Ha ricevuto una educazione perfetta e costosa, eppure è deliziosamente eccentrico: è un ribelle, cioè un comunista ufficiale, ma da ragazzi si fa sempre così… quindi gli danno la medaglia regia. Ha uno splendido senso dell’umorismo. Non è uno di quei bohèmien disimpegnati di una volta: questo significa che non si ubriaca in pubblico. Significa che veste come un professore e non come uno stupido artista. Persegue fedelmente le sue idee sulla fratellanza umana: ama il prossimo tuo e se possibile brama il suo culo. Ma non trucca le carte: è un vero uomo. È esattamente ciò che dovrebbe essere. Che blateri puri il suo vecchio comunismo! Si tratta solo del naturale spirito di rivolta di un giovanotto. Comunque non converte nessuno. Assegnare riconoscimenti conservatori a quegli anticonservatori che si mostrano socialmente innocui è un eccellente palliativo, un calmante, un’abile mossa del nostro Paese». Per capire di chi e di che cosa stiamo parlando vi invito a osservare alcune foto di Auden, in particolare quella scattata da Cecil Beaton nel 1930 a uno splendido Winstan ventitreenne, con modernissimo (per i tempi) doppio profilo: Auden nar- ciso si attrae e avvicina le labbra di Winstan alle proprie. Era l’epoca della Berlino di Weimer con il sodale ex amante Christopher Isherwood, e Auden frequentava le palestre di pugilato (guardategli in altre foto le unghie smangiate, le lunghe mani ossute), invitando i peggiori ragazzacci tedeschi a fare la lotta nudi con lui sull’erba dei parchi la notte: di nuovo il camp, e per una volta letteralmente. L’origine del termine camp, infatti, non è né volgare né offensiva: è solo ironica. Viene da «campeggiare», e l’ironia appartiene a quei bontemponi dei gay inglesi ante litteram, che solevano per l’appunto «piantare le tende» nei pressi degli accampamenti militari, per alleviare le fatiche dei soldiers dopo le esercitazioni. Una dimensione – questa di Auden lottatore nudo sull’erba – alla quale solo la poesia è riuscita a rendere giustizia. Si vedano ad esempio, dalla prima strofa di Atlantis, i versi …you / Must therefore be ready to / Behave absurdly enough / To pass for one of the Boys, / At least appearing to love / Hard liquor, horseplay and noise. Frase nella quale in nuce è contenuta la parte più genuina della poetica di Whitman e preconizzata quella di Pasolini a Roma negli anni cinquanta. Della Verità, vi prego, sull’amore, naturalmente non parlo: Quattro matrimoni e un funerale ha solo divulgato e resa fruibile l’icona camp presso strati sociali e latitudini prima a essa estranei, contribuendo a solidificare il dandismo nella cultura di massa. Ma per chiudere nell’ambito della medesima sottocultura con cui ho iniziato, vi regalo questi versi dal Coro di For the Time Being: Mary may be pure, / But, Joseph, are you sure? / How is one to tell? / Suppose, for instance… Well… Se nell’immaginario camp si possono pertanto trovare Madonna e Andy Warhol, Greta Garbo e Fassbinder, i Velvet Underground e Jean Cocteau, Coco Chanel e Mae West, mi pare corretto riconoscere anche a W.H. Auden un ruolo dominante, prima di scivolare nel dominio di Marcella Bella e Pamela Harriman, Nancy Reagan e Britney Spears. VENEZIAMUSICA e dintorni | 29 Lo spirito della musica di Venezia «MANEGGIARE IL DESTRIERE IN UNO STRETTO CORTILE» «L’Eritrea» di Giovanni Faustini e Francesco Cavalli V di Nicola Badolato* enezia, 17 gennaio 1652: L’Eritrea, la sedicesima opera di Francesco Cavalli (1602-1676) compare per la prima volta nel Teatro di Sant’Apollinare (S. Aponal), una sala decentrata, tra le più anguste e mal equipaggiate della città, già impiegata per la rappresentazione di commedie dopo esser stata adibita, ancor prima, a magazzino. Non era questo il primo melodramma rappresentato nel Sant’Aponal: nell’ottobre 1651 il teatro era stato preso in affitto da un’impresa guidata dal giovane drammaturgo Giovanni Faustini (1615-1651), presto affiancato dal fratello maggiore Marco (1606-1676), e nel carnevale 1651/1652 era stato inaugurato con due lavori anch’essi di Cavalli, L’Oristeo e La Rosinda, su libretto dello stesso Faustini, che aveva progettato di rappresentare di lì in avanti due opere per stagione. Ma i piani furono bruscamente interrotti dalla subitanea e prematura morte del librettista, avvenuta a Venezia il 19 dicembre; per la stagione 1651/1652 andarono comunque in scena La Calisto (rappresentata per una manciata di recite a partire dal 28 novembre) e per l’appunto L’Eritrea. L’Eritrea rappresenta l’ultimo capitolo della decennale e proficua collaborazione tra Faustini e Cavalli, iniziata nel 1642 al San Cassiano con La virtù de’ strali d’Amore e proseguita poi nello stesso teatro con L’Egisto (1643), L’Ormindo (1644), La Doriclea (1645) e Il Titone (1645), infine consolidata con i drammi dati al Sant’Aponal. Le opere composte da Cavalli su libretto di Faustini rappresentano il nucleo preponderante della sua produzione nel decennio 1642-1652. Il sodalizio tra i due fu decisivo per la codificazione e il con- 30 | VENEZIAMUSICA e dintorni solidamento delle principali tendenze di scrittura del teatro d’opera veneziano sulla metà del secolo, attraverso una produzione di drammi costruiti a partire da alcuni loci letterari comuni, con intrecci che propongono una struttura destinata a divenire canonica: due (o tre) coppie di amanti, sulle prime separate, sono infine ricongiunte dopo mille ostacoli e peripezie. Colpi di scena, lettere falsamente rivelatrici, lamenti, canti nel sonno, pazzie reali o simulate, liete agnizioni costellano la narrazione ed assurgono man mano a convenzioni irrinunciabili agli occhi (e agli orecchi) degli spettatori. Questi ingredienti si ritrovano tutti anche nell’Eritrea. Il soggetto intreccia le vicende di una principessa assira, l’eroina eponima, costretta ad assumere l’identità del defunto fratello Periandro per salvaguardare il trono regale e assecondare così i piani della madre Mirsilla, la quale aveva inscenato la morte della figlia al posto di quella del maschio, e per quest’ultimo aveva già predisposto le nozze con Laodicea regina di Fenicia. Lo scambio fa uscir di senno il principe Teramene, innamorato di Eritrea e afflitto dalla (presunta) morte di lei: per tutto il dramma – complice lo spettatore, ignari gli altri personaggi – questi continuerà a scorgere l’amata nelle vesti di Periandro. Eritrea è però innamorata del principe egiziano Eurimedonte, il quale, credendola morta, si getta tra le braccia di Laodicea. Non mancano nel corso del dramma le consuete scenette comiche collaterali, condotte da paggi e damigelle (Lesbo e Misena) o, tra un atto e l’altro, da nane e parassiti (così secondo lo Scenario * Musicologo L’Eritrea stampato in occasione della première). Un intreccio assai attorcigliato e complesso, condotto con maestria da Faustini verso l’agnizione e lo scioglimento, che riuniscono le coppie Eritrea-Eurimedonte e Teramene-Laodicea nel canonico lieto fine. Una trama assai apprezzata dagli spettatori dell’epoca, ormai avvezzi a simili peripezie. «Ogni cavaliero sa maneggiare il destriere in una larga piazza, non tutti lo possono fare in un stretto cortile»: così scrive lo stampatore Giacomo Batti nel dedicare il libretto a Marc’Antonio Correr (nobile veneziano, fra i principali partner economici nelle imprese dei fratelli Faustini negli anni ’50), coll’intento di celebrare l’abilità del «celebre litterato» recentemente scomparso «dopo la tessitura di undeci opere»; ed è davvero complessa la trama ordita da Faustini nell’Eritrea, difficile da condurre soprattutto per «l’angustia del teatro, piciolo per ricever una regina, tanti prencipi, tanti personaggi». Lo scenario dell’Eritrea, come gli altri di Faustini, sembra a prima vista inventato di sana pianta. Eppure l’intreccio sarà scaturito più probabilmente dal mascheramento di topoi preesistenti, presi dagli stilemi narrativi tipici del romanzo, della novellistica – soprattutto quelli vicini al gusto letterario della veneziana Accademia degli Incogniti –, del teatro di parola e dei canovacci dei commedianti. In un siffatto intreccio di genere romanzesco-avventuroso, le scene che prevedono l’intervento di personaggi «astratti» e divini, così frequenti nei primi drammi dati a Venezia, restano ai margini della rappresentazione, da dove poco possono incidere sugli sviluppi teatrali della vicenda: nell’Eritrea le uniche deità (Borea e Iride) compaiono infatti nel prologo. L’eredità di Giovanni Faustini costituì una preziosa fonte di materiali rappresentativi ancora a distanza di un decennio dalla sua morte. La stessa Eritrea godette di una serie di riprese successive: fu allestita a Bologna nel 1654 ad opera dello sceno- grafo Pietro Antonio Cerva; a Genova nel 1655 col titolo mutato in Le vicende d’amore e con aggiunte musicali di Egidio Biffi; a Napoli nel 1659 con i Febi Armonici; a Venezia nel 1661, nel Teatro di San Salvatore «con nove aggiunte d’incerto autore»; infine a Brescia nel 1665 e a Milano nel 1669 con la compagnia del cantante-impresario Pietro Manni. Di ripresa in ripresa, la versione originale del dramma non andò esente da modifiche, aggiunte e tagli che in certa misura tendevano ad avvicinarla ai gusti più recenti. Ne è esempio lampante la riedizione veneziana del 1661, per la quale fu scritto un nuovo prologo, venne inserito un nuovo personaggio ridicolo (Trinano), il paggio Lesbo mutò nome in Florindo, e furono inserite nuove scenette comiche. Numerose arie furono inoltre interpolate a fine scena, furono tagliate le seconde strofe di arie precedenti e alcune arie strofiche furono sostituite da forme più complesse. Ancor più significativi delle aggiunte furono i tagli, che coinvolsero la gran parte dei recitativi, alcuni duetti e due monologhi del forsennato Teramene. Proprio per rendere più palesi le «mille cose... aggionte e levate», il nuovo libretto dell’Eritrea fu pubblicato – forse su richiesta di Marco Faustini – insieme con la ristampa della prima versione (col cambio di data da 1652 a 1662 sul frontespizio). Risale a quasi quarant’anni fa la prima rappresentazione dell’Eritrea in tempi moderni, proposta nell’autunno 1975 nel Wexford Festival Opera, Irlanda sudorientale, secondo l’edizione della partitura preparata e diretta da Jane Glover in un allestimento curato da Ian Strasvogel e Franco Colavecchia. Da allora le vicende amorose della principessa assira non sono più state rievocate sui palcoscenici dei teatri d’opera. Vi riappariranno nella prossima estate, dall’8 all’11 luglio, in un’attesa coproduzione del Teatro La Fenice e del Venetian Centre for Baroque Music. VENEZIAMUSICA e dintorni | 31 Lo spirito della musica di Venezia ELLEN ROSAND E IL SEICENTO VENEZIANO di Lorenzo Bianconi* L’opera veneziana del Seicento «tira». È soprattutto Francesco Cavalli ad offrire un pascolo abbondante e sapido a musicisti, registi, melomani, studiosi. Lo comprovano le riprese, sempre più frequenti e fortunate, promosse in questi anni dalla Fenice – ultima per ora L’Eritrea (luglio 2014) – come da tanti altri teatri e festival europei e americani. Ci sarà una sottile congenialità tra l’aura libertina che spira nei drammi per musica di metà Seicento – nel dettato scherzevole, nell’intreccio ghiribizzoso, nella visione disincantata del mondo e degli uomini – e il nostro sempre più acuto anelito di libertà intellettuale, in un’epoca che come la presente non lesina dubbi né angustie né smarrimenti? Le riscoperte teatrali e discografiche vanno di pari passo con la reviviscenza degli studi. In questi ultimi anni, in Italia come all’estero, le ricerche su Cavalli e in genere sul dramma per musica veneziano hanno registrato un’impennata, tra i musicologi come tra gli storici del teatro e delle lettere italiane, in termini di approfondimenti storici, indagini critiche, edizioni di testi e partiture. Questo air du temps trova ora da noi una splendida conferma editoriale. Un imprenditore culturale piccolo ma insigne – le Edizioni di Storia e Letteratura, fondate a Roma in tempi bui (1942) da un prete coraggioso e fiero come don Giuseppe De Luca – ha condotto in porto un’impresa ragguardevole, pubblicando la versione italiana di un caposaldo come la monografia di Ellen Rosand su L’opera veneziana nel XVII secolo: la nascita di un genere, quasi ottocento pagine di erudizione e di intelligenza critica. L’edizione statunitense, del 1991, era entrata d’emblée nel novero dei «classici» di storia della musica. Poter 32 | VENEZIAMUSICA e dintorni disporre ora di una traduzione accurata, condotta sotto lo sguardo dell’autrice da tre giovani studiosi esperti del campo (Nicola Michelassi, Pietro Moretti e Giada Viviani), è un lusso per il melomane come per il musicologo, per lo storico del teatro come per il filologo, alla fin fine per ogni uomo o donna di cultura: giacché, trattandosi di teatro d’opera, abbiamo qui a che fare con un fenomeno e con dei testi – letterari e musicali – che, scavalcando le siepi e le staccionate tra discipline diverse, fanno parte della storia della cultura tout court. Per la precisione, il sottotitolo originale del libro additava non tanto la «nascita» quanto la «creazione» di un genere, il melodramma, poi destinato in Italia e nel mondo a fulgidi destini. La sfumatura non è trascurabile, come ha giustamente osservato Paolo Fabbri nel presentare l’opera a Bologna lo scorso 14 maggio. Ellen Rosand rintraccia ed evidenzia infatti nelle origini lagunari del genere «melodramma» non già il semplice frutto di un’evoluzione storica quasi obbligata e ignara, alla stregua di un fenomeno biologico, bensì il portato di una plastica energia creativa che non sarebbe potuta sbocciare né fiorire se non attraverso l’iniziativa militante – a tratti contraddittoria e conflittuale, ma alla fin fine concorde – di musicisti e poeti e uomini di teatro venuti da fuori e di intellettuali veneziani dotati di un notevole spirito d’avventura filosofico ed economico, consapevolmente esposti sul fronte avanzato della sperimentazione letteraria e sociale. Questo quadro, che nel libro di Rosand è * Musicologo - Ordinario di Musicologia e Storia della Musica all’Università di Bologna L’Eritrea al tempo stesso brulicante e distaccato come in un «telero» del Veronese, è sbalzato a vivo, attraverso l’analisi delle molte componenti e implicazioni dell’opera in musica allo stato nascente: questioni di poetica, problemi di organizzazione e gestione, riflessi ideologici (la frequente esaltazione del mito della Repubblica), le tecniche per metà sperimentali e per metà routinières di librettisti e compositori, la seduzione erotica che promana dai cantanti e dalle cantanti, il sistema delle forme poetiche e musicali, l’insorgenza di convenzioni che – come nel caso del lamento – si tramanderanno sull’arco delle generazioni, nessun aspetto sfugge allo sguardo minuzioso, al disegno panoramico. L’indagine è saldamente ancorata allo scrutinio dei testi, con abbondante riferimento ai libretti, generosamente descritti e citati, e delle partiture: gli esempi musicali, perlopiù inediti, tengono da soli più di duecento pagine. Una pacchia. Al di là di questa monumentale monografia, Ellen Rosand ha accumulato molti meriti sul fronte dell’opera veneziana. Basti menzionare l’edizione critica delle opere di Cavalli, avviata nel 2012 per l’editore tedesco Bärenreiter, lo stesso cui si devono le edizioni critiche di Bach Rameau Mozart Rossini Schubert Berlioz; la direzione dello Yale Baroque Opera Project, che a New Haven coltiva congiuntamente la ricerca scientifica e l’allestimento sperimentale di opere di Monteverdi Cavalli Sacrati Händel; la promozione di un convegno internazionale di studi su Cavalli (sempre a Yale, 2009), di cui ora sono usciti gli Atti (Readying Cavalli’s Operas for the Stage), uno scrigno di novità documentarie, erudite, critiche. L’operosità della scienziata è stata ripetutamente riconosciuta, in patria e all’estero (nel 2012 Rosand ha ricevuto dal Quirinale una medaglia); ed è ora celebrata in una lussuosa Festschrift, dal titolo Word, Image, and Song, che testimonia la venerazione degli allievi e di tanti estimatori: sono due volumi, il primo interamente dedicato al Seicento italiano, il secondo a saggi su Händel Bach Beethoven Schubert eccetera; vi compare l’ultimo lavoro condotto a termine da un amico comune, Giovanni Morelli, nel 2011, sull’amatissimo Metastasio. Grazie, Ellen. Ellen Rosand, L’opera a Venezia nel XVII secolo: nascita di un genere, traduzione di Pietro Moretti, Nicola Michelassi e Giada Viviani, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, pp. xxvi-790; ISBN 9788863725056 (ed. originale: Opera in Seventeenth-Century Venice: the Creation of a Genre, Berkeley, University of California Press, 1991); 75,00 euro. Readying Cavalli’s Operas for the Stage: Manuscript, Edition, Production, a cura di Ellen Rosand, Farnham, Ashgate, 2013 («Ashgate Interdisciplinary Studies in Opera»), pp. 440; ISBN 9781409412182. Word, Image, and Song, I: Essays on Early Modern Italy, Rebecca Cypess, Beth L. Glixon e Nathan Link, Rochester - Woodbridge, University of Rochester Press - Boydell & Brewer, 2013 («Eastman Studies in Music», 101), pp. 414; ISBN 9781580464543. a cura di VENEZIAMUSICA e dintorni | 33 Lo spirito della musica di Venezia «L’ERITREA» UN GIOIELLO RISCOPERTO C di Olivier Lexa* on l’iniziativa di promuovere la prima esecuzione in tempi moderni dell’Eritrea di Cavalli e Faustini, la direzione del Teatro La Fenice riprende quella che era una lunga tradizione veneziana, l’ambizioso revival cavalliano. Ovviamente è all’Italia e più particolarmente alla Città dei Dogi che dobbiamo la riscoperta del suo più grande compositore del Seicento: nel 1913, Taddeo Wiel è il primo a programmare delle scene d’opera di Cavalli – in questo caso al Conservatorio «Benedetto Marcello». Più tardi, dopo la Didone del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Carlo Maria Giulini, è alla Biennale di Venezia che dobbiamo la prima esecuzione in tempi moderni delle Nozze di Teti e Peleo, avvenuta nel 1959. L’opera è diretta da Filippo Crivelli a San Giorgio Maggiore e lo spettacolo è oggetto di una delle prime trasmissioni d’opera dalla RAI. Due anni più tardi, il Teatro La Fenice programma Ercole amante, prima di tornare più recentemente a Cavalli con un nuovo allestimento della Didone nel 2006 (spettacolo ripreso alla Scala due anni più tardi), e nel 2008 con La virtù dei strali d’amore. Oggi, sappiamo che interessarsi a Cavalli non è meno fondamentale che studiare Rossini o Verdi: non fu l’autore del Giasone il compositore che raggiunse più popolarità durante la sua vita, prima dell’avvento dei due maestri del belcanto dell’Ottocento? Non è adesso recitato nei quattro angoli del mondo, incontrando un successo sempre maggiore? Se a Cavalli è capitato di essere meno eseguito di altri grandi compositori d’opera italiani (Monteverdi incluso) ciò è dovuto alle difficoltà della produzione delle sue opere, certamente più 34 | VENEZIAMUSICA e dintorni complessa di quella, ad esempio, di un Orfeo – per cui si è sempre disposto di una magnifica partitura, limpida, precisa, stampata e pubblicata a Venezia nel 1609. Prima delle trascrizioni moderne, nessun lavoro di Cavalli ebbe modo di essere oggetto di stampa; è d’altronde il destino di molte opere veneziane del Seicento, le cui riprese erano rare e non giustificavano, in un contesto economico complesso, la pratica faticosa e costosa della pubblicazione. Le sole fonti disponibili per gli interpreti del XX secolo erano dunque i manoscritti, spesso incompleti e difficili da decifrare. Era perciò comune che i coraggiosi che preferivano produrre una Didone piuttosto che un’Aida si ritrovassero a dover trascrivere e pubblicare una partitura, comprensiva delle parti d’orchestra e dei ruoli dei numerosi cantanti (da dodici a venticinque). Questo comportava una drastica lievitazione dei costi di produzione e dei tempi di preparazione, e spesso anche l’abbandono dell’operazione a favore di opere con partiture già pubblicate. Per essere chiari: se avessimo avuto per Cavalli materiali musicali simili a quelli delle opere di Mozart, Rossini e Verdi, il compositore veneziano sarebbe, da molto tempo, al centro del repertorio delle sale liriche di tutto il mondo; infatti Cavalli, le opere del quale sono state le più eseguite nell’Europa del Seicento, piace sempre di più al pubblico di oggi. Con le sue arie brevi, istantaneamente seducenti, e la sua ineguagliabile arte del recitativo, Cavalli è uno dei soli musicisti del XVII secolo a comporre * Regista - Direttore artistico del Venetian Centre for Baroque Music L’Eritrea in uno stile immediatamente riconoscibile; stile che non abbandonò a nessun costo, scelta che lo rese vittima, alla fine della sua carriera, del cambiamento della moda. La fluidità contraddistinse questo autore, capace, all’interno della stessa opera, di passare con sconcertante disinvoltura dal recitar cantando all’aria passando per l’arioso, dall’emozione tragica alle scene più spassose; fu inoltre in grado di fare in modo che la musica non intralciasse mai il teatro – l’una sostiene l’altro e si abbelliscono vicendevolmente raggiungendo un livello di perfezione raramente concepita nella storia. Non ci pare bizzarro dunque che, più di chiunque, Cavalli sia stato imitato; è lui che fissò i canoni dell’arte lirica. I suoi lamenti ispirarono tanti compositori – tra cui Purcell nella sua famosa aria di Dido, «When I am laid in earth». I sonni (Atys di Lully), le scene infernali (Rameau), le arie con tromba (Haendel) e, oltre il periodo barocco, il buffo domestico (Leporello), il travestimento (Cherubino), il duo d’amore (Tristan und Isolde), la scena di pazzia (Lucia di Lammermoor), la scena della lettera (Tatiana in Eugène Onegin), l’invocazione (Ulrica nel Ballo in Maschera)… Tutto questo trova origine in Cavalli. Non posso dunque nascondere la mia felicità nel partecipare alla prima esecuzione in tempi moderni di uno dei suoi capolavori, L’Eritrea. Come La Calisto, questa opera è il risultato di una decina di creazioni di Cavalli e Faustini, il tandem lirico più fruttuoso del Seicento italiano. Nell’Eritrea, la prima cosa che colpisce l’occhio è la concentrazione dell’intreccio che si sviluppa attorno a un numero limitato di protagonisti: l’opera ne conta solo undici; questo permette una grande efficacia del ritmo teatrale. La totalità del primo atto è particolarmente spassosa. I travestimenti dell’Eritrea danno infatti luogo a vari malintesi: il principe Teramene ama il re Periandro (Eritrea travestita) che a sua volta è folle d’amore per il principe Eurimedonte (riassumiamo: un uomo ama un uomo che ama un altro uomo). Più tardi, Misena, che non sa che Periandro è in realtà Eritrea, ha la favolosa idea di travestirlo da donna per farla evadere dal palazzo (riassumiamo: a una donna travestita da uomo viene proposto di travestirsi da donna). Non bisogna trascurare Laodicea, innamorata di Periandro che, non sospettando che essa sia in realtà una donna, si lamenta esplicitamente del carattere platonico della loro relazione: «Correte, entrate, entrate in questo petto. Portatemi il diletto» (I, 6); Periando (Eritrea) ritarda sempre la sua approvazione. Alla fine, il consenso sfocia per l’incoronazione di Teramene, definitivamente impazzito: la demenza è chiamata a salire sul trono! Il librettista firma, dopo la sua grande opera mitologica La Calisto, un’opera quasi priva di divinità, al punto che Laodicea viene a lamentarsi: «Oh dio, che si farà? (…) Per noi nume custode in ciel non è?» (II, 12). All’epoca della sua composizione, L’Eritrea ebbe un successo immenso; entrò infatti nel Pantheon delle rare opere riprese a Venezia vari anni dopo la loro creazione. Confesso che vivere e lavorare a Venezia da ormai cinque anni mi ha molto aiutato nella comprensione di questo repertorio, così tipicamente veneziano… Per L’Eritrea, il mio lavoro si appoggerà soprattutto su due punti: la dimensione comica del testo e la gestualità barocca. Peraltro contare sulla collaborazione dei Musei Civici è una grande fortuna: trattandosi di un intreccio che si svolge in un palazzo reale, disporre di Ca’ Pesaro corrisponde a un sogno… Per concludere, grazie alla fiducia del Teatro La Fenice, abbiamo l’enorme felicità di organizzare un convegno internazionale il 12 luglio, che riunirà i più grandi specialisti di Cavalli. Oggi, tramite la volontà della direzione del Teatro, Venezia è capofila del revival del suo repertorio lirico ed è un privilegio potervi partecipare. VENEZIAMUSICA e dintorni | 35 Lo spirito della musica di Venezia A PASSO DI DANZA I di Franco Bolletta* l festival «Lo spirito della musica di Venezia» ha dimostrato sin dalla sua prima edizione molta attenzione all’arte della danza. Quest’anno saranno a lei dedicati quattro diversi momenti: un convegno sulla figura del celebre ballerino/coreografo Salvatore Viganò, curato da José Sasportes, la trilogia La Divina Commedia – Inferno, Cantica e Paradiso, spettacolo ispirato all’opera dantesca e ideato da Emiliano Pellisari e Mariana Porceddu per l’italiana No Gravity Dance Company, e due appuntamenti divenuti ormai canonici: la terza edizione del Gala internazionale di danza e la seconda edizione del Progetto coreografico. Per esigenze di brevità mi concentro sugli ultimi due. Il nostro Gala, che ha scadenza annuale, si differenzia dalle consuete proposte di questo tipo, normalmente incentrate sulle grandi stelle, che arrivano all’ultimo momento, decidono il programma e hanno costi altissimi. Abbiamo invece voluto capovolgere l’idea: dopo aver visitato o comunque contattato le più importanti Accademie di danza internazionali abbiamo selezionato i migliori allievi che hanno finito il loro percorso didattico e sono già stati scelti da una compagnia (o che al più hanno appena un anno di esperienza nel corpo di ballo). La procedura, nel nostro campo, è infatti sempre la stessa: è impossibile che un giovane, appena finito l’iter accademico, diventi immediatamente una star, deve necessariamente muovere i primi passi nella carriera professionale. Le prime due edizioni, 2012-2013, ci hanno regalato vere e proprie eccellenze, che ora – anche in virtù della partecipazione alla nostra iniziativa – hanno già raggiunto importanti traguardi. Quest’anno siamo molto fortunati, perché, per fare 36 | VENEZIAMUSICA e dintorni solo un esempio, saranno presenti i due «laureati» all’ultimo Gran Prix de Lausanne, ormai da anni la più attesa manifestazione del nostro settore: Mikio Kato e David Navarro Yudes. Siamo riusciti a farli partecipare tutti e due, perché entrambi escono dall’Académie «Princesse Grace» del Principato di Monaco. Poi, per citare soltanto qualche altro nome, ci saranno Claire Teisseyre e Neven Ritmanic, una coppia di giovani e bravissimi danzatori che provengono dall’École de Danse de l’Opéra National de Paris, o ancora, dall’English National Ballet School, un’altra magnifica coppia, formata da Isabelle Brouwers e Jinhao Zhang. Quest’anno inoltre abbiamo voluto dare importanza a uno dei linguaggi che è ormai usato comunemente da moltissimi coreografi contemporanei, ma che non è mai stato ancora ufficialmente riconosciuto, l’hip hop. Il Gala sarà chiuso da quella che oggi viene considerata la più importante formazione del mondo, la francese Pokemon Crew. Questo gruppo, esplosivo, ha già superato un passaggio cruciale: l’hip hop è universalmente conosciuto per le sue figure acrobatiche, ma la Pokemon Crew è già passata alla «fase due», nel senso che ha creato vere e proprie coreografie, nelle quali esiste una traccia così ben organizzata che permette alle loro evoluzioni di raccontare una storia e quindi di assumere un significato narrativo. Questi artisti chiuderanno la serata con dieci minuti di quello che solitamente viene chiamato free style. Quanto al programma, come di consueto il Gala ripercorre la danza nelle sue più celebri espressioni del passato, dal * Consulente per la danza del Teatro La Fenice Danza Lago dei cigni al Don Chisciotte, ma accoglie anche composizioni contemporanee. Sul versante classico, poi, presenteremo una chicca, il pas de deux Il carnevale di Venezia, una coreografia realizzata nell’Ottocento e raramente riproposta, che è ormai appannaggio del repertorio del Bolshoi e del Marijinskij. Infatti a eseguirlo saranno due ballerini di San Pietroburgo, Sofia Ivanova-Skoblikova e Andrei Arseniev. Il cartellone di danza termina poi il 25 luglio con il Progetto coreografico, che è biennale ed è realizzato dalla Fenice in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa. L’idea, ormai rodata, è quella di mettere insieme un coreografo e un artista visivo per dare vita a uno spettacolo. Quest’anno i due prescelti sono rispettivamente il tedesco Patrick Eberts e l’inglese Isaac Julien, che hanno deciso di intitolare il pezzo The Garden. La serata sarà composita, nel senso che questa per- formance occuperà la seconda parte, mentre nella prima il Bundesjugendballet di Amburgo eseguirà altre due coreografie, la prima ideata dal giovane italiano Sasha Riva, che lavora anche lui ad Amburgo e da noi è praticamente sconosciuto. Seguiranno le Petrushka-Variations di John Neumeier, che supervisionerà l’intero evento. In questo modo ci sarà data anche la possibilità di conoscere una realtà come quella del Bundesjugendballet, creato proprio da Neumeier. Non si tratta infatti di una compagnia: ogni due anni Neumeier seleziona artisti da tutto il mondo, per poi scegliere quattro ragazze e quattro ragazzi, che per un biennio seguono una sorta di «super master», venendo pure retribuiti. Non è solo un’esperienza didattica ma anche professionale, perché questi giovani realizzano delle vere tournée europee. Infine, tengo a sottolineare che la musica sarà eseguita dal vivo, evento raro in questo tipo di iniziative. VENEZIAMUSICA e dintorni | 37 Lo spirito della musica di Venezia PINO DONAGGIO, IL RAGAZZO COL VIOLINO P di Giò Alajmo* ino Donaggio era poco più di un ragazzo quando tornò a casa da Milano con un contratto da cantante. Il promettente violinista del Conservatorio di Venezia, nato a Burano nel 1941, era deciso a dimostrare al padre che c’era per lui una strada diversa da quella del concertista o del violino di fila. Gli anni sessanta offrirono ai giovani dell’epoca ottime opportunità per il successo istantaneo. Era l’epoca del twist, del rock’n’roll, della giovane televisione. Ma anche la melodia italiana provava strade moderne e Donaggio aveva talento e fortuna. Nel 1965 portò a Sanremo una sua idea, «Io che non vivo». Una delle cantanti straniere al Festival, Dusty Springfield, ascoltò e tornò a casa con la partitura in borsetta. Ne fece una versione in inglese «You Don’t Have to Say You Love Me» che ebbe tale successo in America che Elvis Presley volle inciderla, pubblicandola in diciotto album. E dopo di lui altri. E altri. E «Io che non vivo» diventò così famosa nel mondo che quasi si perse cognizione che il suo autore era un italiano, di Venezia. Lo scoprì Brian De Palma, il regista italoamericano innamorato di Hitchcock, che si trovò improvvisamente orfano di Bernard Herrmann, il musicista di Psycho, e scommise per la colonna sonora di Carrie su questo per lui sconosciuto autore veneziano che aveva scoperto dalla colonna sonora di A Venezia, un dicembre rosso shocking di Nicholas Roeg, che un amico, tornato da Londra con il film in cassetta, gli aveva consigliato. Brian cercava un autore diverso dai soliti musicisti di Hollywood, e questo Donaggio faceva al caso suo. Ma c’era da trovare anche qualcuno che scrivesse per il film un 38 | VENEZIAMUSICA e dintorni paio di canzoni e il regista non aveva idee chiare su chi potesse scriverne di adatte. Pino Donaggio andò al piano e cominciò a suonare: «Conosci questa?». E dallo strumento uscirono le note di «Io che non vivo». De Palma annuì. Chi non conosceva una delle più famose canzoni di Elvis? «L’ho scritta io». Brian De Palma sgranò gli occhi e capì che aveva trovato non solo il compositore in grado di sostituire Hermann, ma anche l’autore delle canzoni che cercava. Ogni volta che telefono a Pino Donaggio è al lavoro su qualche musica, nella sua casa vicino al Ghetto, in studio dall’amico Paolo Steffan a Treviso o nel suo studio personale alla Salute, sempre che non stia partendo per qualche Paese dell’Est dove le orchestre costano meno e suonano meglio di tante altre. Il suo curriculum di autore di colonne sonore è ormai lungo e vario: thriller, commedie, film d’impegno sociale, storici, serie tv, perfino un’esperienza con Tinto Brass e le nove serie tv di «Don Matteo», presto la decima, con protagonista un altro veneziano, Terence Hill. Questa volta sta dando gli ultimi ritocchi alle musiche di La buca di Ciprì, commedia ironica con Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi e Rocco Papaleo che uscirà a novembre. «Ci sono delle parti di piano solista per le quali – racconta Donaggio – ho lavorato con Stefano Bollani. L’idea era costruire musiche un po’ anni quaranta, un po’ jazz. Bollani è un geniaccio. Ha suonato quello che avevo scritto e gli ho lasciato spazi per improvvisare sul tema». Quando la Fenice fu restaurata e riaperta dopo * Critico musicale Altre musiche l’incendio la nuova inaugurazione fu celebrata con diversi concerti di vario tipo e grandi musicisti venuti a rendere omaggio al teatro rinato dalle ceneri un’altra volta. Fu bello vedere sul palco anche Elton John, saltuario cittadino veneziano, ma ricordo che chiesi all’allora sindaco Costa: va bene Elton John, ma perché non Donaggio? Pino era lì a godersi lo spettacolo in uno dei palchi di prima fila. Gli feci la stessa domanda. Sorrise e alzò le spalle. «Qualcuno mi disse all’epoca che avrebbero fatto qualcosa per me quando avessi vinto un Oscar», ricorda oggi con la stessa sobrietà. Il 9 luglio la Fenice gli renderà omaggio, questa volta davvero, con un premio e un concerto nel cortile di Palazzo Ducale durante il quale saranno presentati due omaggi alla sua musica, il tema «Museum» dalla colonna sonora di Carrie, e una versione per coro e orchestra sinfonica di «Io che non vivo». Con la Fenice ha un rapporto speciale: «A undici anni ero nel loro coro di voci bianche. Studiavo canto corale ed ero stato scelto. Esordii in Carmen con Corelli, Simionato e la giovane Scotto e poi rimasi due o tre anni cantando Il cavaliere della rosa, Mefistofele e altre opere così». Hollywood fu una svolta nella sua vita, ma scelse alla fine di non lasciare Venezia. Tutto merito di un aereo e di uno spavento. «Stavamo lavorando con De Palma a Dressed to Kill e presi l’aereo a New York per tornare a Venezia. Dopo un’ora di volo mi sveglio sentendo una voce in spagnolo che urla “Al fuego! Al fuego!”. Mi giro e vedo dal finestrino l’ala con un motore in fiamme. Io sapevo poco di aerei, non pensavo potessero spegnere un motore in fiamme durante il volo. Ero terrorizzato. Il comandante disse che dovevamo tornare indietro e che in un’ora saremmo stati a New York. Ci mettemmo due ore e mezza. Lì presi subito un altro aereo, tornai a Venezia e a casa mi arrivò lo shock in ritardo. Il medico disse che l’esaurimento nervoso che avevo latente sin dai tempi delle canzoni, di Sanremo e dei rapporti con la discografia era esploso. Mi ci vollero dieci anni per uscirne. Nel frattempo ho lavorato ancora con De Palma ma prendevo il Concorde per restare in aria meno possibile. Mi è venuta sempre meno voglia di prendere aerei e ho cercato di lavorare di più qui, Liliana Cavani, Abel Ferrara, Rubini, o Fragasso con cui vinsi il globo d’oro per Palermo-Milano solo andata e che come molti altri passò alle fiction tv e quindi anch’io». Cambiare film è per lei come cambiare pelle ogni volta. Ma qual è lo stile Donaggio? I critici dicono che mi vengono bene i thriller, ma soprattutto che faccio melodie importanti. Io vengo dallo studio del violino e sono quindi portato a non fare solo rumori ed effetti ma anche a scrivere una musica che può stare in piedi da sola. Vengo dalla musica classica, ma, anche se ho praticato molti generi, l’impronta si sente. Ho fatto thriller ma anche commedie, e francamente non sapevo di avere attitudine al thriller. I film di Hitchcock li guardavo ma non ascoltavo la musica. Alle colonne sonore sono arrivato assolutamente per caso, perché Roeg era a Venezia e visto che era qui per girare A Venezia rosso shocking mi chiese perché non potevo fare io le musiche. Fu un caso anche l’incontro con De Palma. Herrmann era morto da poco. Anche lui scriveva usando gli archi come faccio io, in questo siamo abbastanza vicini. Io cerco di cambiare musica a ogni film, adattarmi al momento. Non amo quelli che portano la loro musica nel film qualunque film sia. Venezia: che pregi e che difetti? È una città fantastica, a cui sono legato da sempre. Qui ho scritto quasi tutte le mie cose. Mi è costato qualche sacrificio non spostarmi da qui ma la amo tantissimo. La odio anche, perché è diventata una kasbah, da turismo di massa, che non si sa cosa e quanto porti a parte la confusione. È una città del Settecento, di quando si andava a remi, ed è così piena di motoscafi, taxi, barche a motore che a remi non puoi più andare. È piena di venditori ambulanti ovunque, alle Zattere vedi un mare di alghe, passano le grandi navi che dicono non facciano danni ma vedi l’acqua impazzire dal risucchio. Sarà che ho 72 anni, però preferisco uscire solo di sera quando non c’è più confusione. E quando le ombre possono diventare una nuova idea da trasformare in musica… VENEZIAMUSICA e dintorni | 39 Lo spirito della musica di Venezia PAOLO CONTE, UN RITRATTO T di Alberto Massarotto* ra le iniziative organizzate festival «Lo spirito della musica di Venezia» in collaborazione con Veneto Jazz si inserisce anche il concerto di Paolo Conte, che il 2 luglio sarà a Palazzo Ducale. Con l’occasione presentiamo una biografia ragionata dell’artista piemontese. Passano gli anni ma di sicuro non le sensazioni che rimangono legate a certi luoghi dalle buie e sudice ambientazioni, illuminate a malapena di riflesso dal lento lampeggiare dell’insegna di un bar malandato in cui i tintinnii dei bicchieri vengono ovattati da spesse tende di fumo che scivolano tra il faticoso avvicendarsi del dietro le quinte della routine quotidiana. Spesso a raccontarcele è proprio l’occhio privilegiato del proprietario del mitico, quanto immaginario, bar Mocambo, ripercorrendo quell’inconfondibile fil rouge attento a imprimere una serie di ritratti per consegnarli attraverso la voce di Paolo Conte. Impossibile non collegare il nome del bar a successi come «Gli impermeabili» e «La ricostruzione del Mocambo» che tra gli anni settanta e ottanta lo hanno elevato a vero e proprio simbolo generazionale al punto da riproporne l’ambientazione in più canzoni dando corpo a una saga che, per il tipo di sensazioni evocate nei testi di Conte, non poteva che protrarsi fino alla «Nostalgia del Mocambo». Negli anni in cui il mondo della discografia riusciva ancora a investire sui giovani cantanti, tanto da potersi permettere di attendere il successo di vendita anche ben oltre il primo tentativo, si inseriscono i primi due dischi di Paolo Conte, che recano entrambi nome e cognome dell’avvocato di 40 | VENEZIAMUSICA e dintorni Asti. Non bisogna dimenticare che le prime prove discografiche arrivano dopo un periodo esclusivamente autoriale in cui il musicista è impegnato a confezionare una serie di canzoni per personalità di spicco per l’epoca quali Caterina Caselli («Insieme a te non ci sto più»), Patty Pravo («Tripoli 1969»), una giovanissima Giuni Russo al tempo in cui portava ancora il suo primo nome d’arte, Giusy Romeo («No amore»), Dalida («La speranza è sacra»), senza tralasciare le ripetute collaborazioni con Adriano Celentano («Chi era lui», «La coppia più bella del mondo» e «Azzurro» solo per citarne alcune). Proprio quest’ultima valse a Conte un ulteriore sodalizio artistico che perdurò negli anni, quello con il paroliere Vito Pallavicini. La discografia rappresentava per Paolo Conte un mondo del tutto nuovo, se si pensa al cantante come al giovane laureato in giurisprudenza dalla forte predisposizione alla musica, coltivata fin dall’infanzia attraverso i dischi americani acquistati dal padre di contrabbando durante gli anni del fascismo, tormentato dal bisogno di condividerla con gli amici più cari. Di sicuro il proibizionismo che la dittatura ha imposto in Italia anche in campo musicale ebbe un effetto boomerang sulla personalità di Conte, al punto da accrescere in maniera esponenziale il desiderio di penetrare quella musica così affascinante e proibita, e portandolo, insieme al fratello Giorgio, alla formazione di svariati gruppi con i quali potersi esibire allinterno delle manifestazioni più varie nel lungo periodo che ha contraddistinto la gavetta. * Pianista e musicologo Altre musiche Molte delle passate collaborazioni artistiche si riversarono in durature amicizie, riaffiorate successivamente in occasione di una serie di esibizioni che lo videro al fianco di Piero Ciampi, Nada e Renzo Zenobi. In questa occasione la stessa cantante livornese incise alcune tra le canzoni più note di Conte come «Avanti bionda», «Arte» e «La fisarmonica di Stradella». Una serie di partecipazioni come concorrente a vari quiz musicali e successive ospitate televisive facilitano il contatto con importanti esponenti dell’ambiente musicale. Tra tutte è divenuta ormai storica l’esibizione con Lucio Dalla che alla fine degli anni settanta conduceva il programma televisivo dal titolo «Il futuro dell’automobile e altre storie», oltre al fortunato vincolo che per molti anni legherà il cantante alla città di Sanremo attraverso il Premio Tenco. Il 1979 è l’anno della consacrazione: il successo arriva con la pubblicazione di Un gelato al limon, disco che contiene alcuni titoli di punta della sua intera carriera. Prima tra tutte «Bartali», dedicata al famoso ciclista e inclusa successivamente persino all’interno della scaletta di Banana Republic, lo storico e fortunatissimo tour dell’accoppiata Lucio Dalla/Francesco De Gregori. Gli anni ottanta, oltre che per una serie di festeggiamenti dedicati alla sua figura, sono segnati dalla pubblicazione di un album decisivo per la carriera del cantante: il disco, Paris milonga, contiene «Via con me», ancora oggi la sua canzone più nota e rappresentativa. Il successo travolgente spinge Conte a pubblicare a nemmeno un anno di distanza Appunti di Viaggio dove, agli echi swing e jazz che risuonano nella memoria dai dischi del padre, si inseriscono ritratti di mondi esotici in cui le immagini e i suoni tratteggiano città geograficamente lontane e spesso semplicemente sognate. Un altro album etichettato Paolo Conte, il terzo della serie, oltre a guidare i fan attraverso le vicende del Mocambo, decreta il definitivo sdoganamento del cantante come protagonista di numerosi concerti dal vivo che lo portano a farsi notare soprattutto in Francia, seduto al pianoforte posizionato al centro della sua band. Vengono così organizzate lunghe tournée internazionali in cui i momenti migliori vengono racchiusi all’interno di Paolo Conte Live, il primo di una lunga serie di dischi registrati dal vivo. Il suo stile si concretizza sempre di più in una visione del mondo filtrata attraverso l’intimità del cantante, in cui atmosfere e melodie dialogano con i Café chantant nella Francia d’inizio secolo. Ne è un segno distintivo la tendenza a impreziosire i testi di differenti apporti linguistici derivanti dall’incontro di più lingue al fine di assecondare la brillantezza della musica attraverso una valorizzazione della componente ritmica, senza incorrere nel rischio di sacrificare il contenuto e il significato del testo, esaltato da una serie di scioglilingua srotolati a ritmo di Jive. Nascono in questo modo le inconfondibili «Dont Throw It In The W.C», in un inglese capace di lasciare il posto al dialetto piemontese in «Sijmadicandhapajiee», scivolando con disinvoltura fino alla lingua napoletana con «Vite da sosia». Paolo Conte continua a coltivare la passione per la pittura che – oltre a concretizzarsi in numerosi dipinti che si rendono capaci di raffigurare il mondo che la sua voce è portata ad esprimere attraverso le canzoni – si riversa in anni recenti in Razmataz, progetto multimediale lungamente meditato all’interno del quale vengono fuse le varie discipline artistiche filtrate attraverso la sensibilità del cantante. Il disco prende così le mosse da uno sceneggiato radiofonico che sfocia in un progetto di operetta multimediale, dove alla colonna sonora e ai brani si aggiungono tavole interamente dipinte dal musicista attraverso l’utilizzo di diversi tipi di tecniche, al fine di rivivere le fasi della scalata al successo di una ballerina africana sullo scenario dell’amata Parigi in stile anni venti. Negli ultimi anni la pubblicazione di una serie di dischi celebrativi e di brani inediti si inseriscono all’interno di un inarrestabile slancio che anima lo spirito di Conte sin dagli anni della gavetta, in cui il cantante ardeva dal desiderio di travolgere il pubblico con la stessa forza e passione che contraddistingue la sua musica. VENEZIAMUSICA e dintorni | 41 Opera UNA «TOSCA» ESSENZIALE E SINTETICA I di Serena Sinigaglia* l 16 maggio scorso è andato in scena un nuovo allestimento della Tosca pucciniana, interamente realizzato dai laboratori del Teatro La Fenice. La regista, Serena Sinigaglia, esponente di spicco del teatro di ricerca e non nuova alla lirica, spiega il suo approccio all’opera. Tosca è un’opera che colpisce perché è breve, intensa, sintetica. Non è un’opera corale, ma basata su grandissime figure, che poi sono solo due, la protagonista e l’antagonista, ovvero Tosca e Scarpia, cui si aggiunge ovviamente Cavaradossi. Nel mio allestimento sono partita da questa considerazione iniziale, e ho intenzionalmente eliminato tutti gli orpelli. Ma quest’operazione segue, in realtà, le stesse indicazioni di Puccini, che teneva molto all’asciuttezza, come è chiaro dalle sue didascalie. Il compositore in più occasioni afferma la volontà di asciugare rispetto al dramma di Victorien Sardou, da cui l’opera trae il soggetto. Dunque, anche se non si vedono – almeno nell’accezione convenzionale – la Chiesa di Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese o Castel Sant’Angelo, penso di essere stata estremamente filologica. Nel mio lavoro parto da un concetto espresso da un grande uomo di teatro, Konstantin Stanislavskij, il concetto di reviviscenza: quando si affronta un’opera lirica, tanto più se di repertorio, esattamente come quando si mette in scena Shakespeare, bisogna cercare di riportare alla vita qualcosa che è museo, che è «morto» finché non siamo noi a porci in relazione con esso. Ecco allora nascere il tentativo di dare vita a Tosca, oggi che viviamo un periodo di crisi assoluta, non solo di valori, ma 42 | VENEZIAMUSICA e dintorni generale, un periodo di distruzione di ogni cosa, a partire dall’ecosistema. Queste riflessioni ci conducono a una parola molto utilizzata – e spesso abusata – negli ultimi tempi: attualizzazione. Ma cosa significa attualizzare? Forse far mettere i jeans ai cantanti? Mi sembra una sciocchezza. In questo caso mi è parso meglio mantenere l’ambientazione scelta da Puccini, quell’inizio d’Ottocento in cui si fronteggiano da una parte la Rivoluzione Francese e dall’altra il papato e l’imperatore: un’epoca di grande crisi e di acuto conflitto sociale. In questo contesto si scontrano due forze irriducibilmente antitetiche: da una parte c’è Scarpia, che rappresenta tutto ciò che in ognuno di noi, in ogni essere umano, è la tensione al male. Credo che Puccini in lui incarni le nostre pulsioni peggiori e perverse, che portano necessariamente alla distruzione. Le energie che, invece, mirano alla liberazione del proprio io nel rispetto degli altri – impersonate da Tosca – sono più fragili, vengono facilmente distrutte, però quando riescono a imporsi ci regalano capolavori come «E lucevan le stelle» e «Vissi d’arte», i momenti più lirici dell’opera. Ebbene queste due forze in opposizione inconciliabile si scontrano sul palcoscenico esattamente come nella nostra vita: tutto questo, come libera associazione di idee, a me ricorda da vicino la dissoluzione di Pompei ed Ercolano, dovuta esclusivamente all’incuria. È di questo che ci parla oggi Tosca, è questa – a mio parere – l’unica possibile «attualizzazione»: se non siamo in grado di contrastare il male che c’è dentro di noi, da tutti i punti di vista, distruggiamo il mon* Regista Opera do e creiamo bruttura. Tosca è bellissima perché è piena di difetti, non è per nulla ideologica. È l’altra parte di Scarpia. Tra lui e lei la linea di confine è labilissima. Infatti sono passionali allo stesso modo, è davvero uno scontro tra titani. La differenza sostanziale sta nel fatto che Tosca sceglie la passione per la vita e non per la morte, per la bellezza e non per la distruzione. Ma non lo fa attraverso un ragionamento razionale, vive quella passione a livelli estremi. Non pensa premeditatamente di ammazzare il tiranno, si trova nelle condizioni in cui, per legittima difesa e per un impulso a cui lo stremo della lotta l’ha portata, arriva a ucciderlo. Non c’è ideologia, c’è vita, c’è accadimento, con tutte le complessità e le contraddizioni del caso. Come Scarpia, che è altrettanto ricco di complessità, e che Puccini riesce a rendere in modo sublime. Da tutto ciò deriva l’impianto scenografico. L’opera si apre con un sipario che somiglia a quello della Fenice, solo che è scalcagnato, più povero, più rovinato. Sull’incipit musicale questo sipario, invece di aprirsi, crolla. La scena che si vede poi è un’enorme pedana di palcoscenico, con delle crepe tutto intorno e una più grossa al centro, come se la natura stesse premendo per esplodere, per uscire fuori. Un po’ come accade ai teatri abbandonati, dove appunto la natura prende il sopravvento, le assi si deteriorano, saltano, si rompono. A parte questa enorme pedana, c’è uno spazio completamente vuoto, dove sopravvivono soltanto gli elementi essenziali alla drammaturgia: il cancello della cappella degli Attavanti, la statua con l’acquasantiera e un grande cavalletto su cui Cavaradossi disegna. Già nel corso del primo atto pezzi del pavimento si staccano. Quando entra Scarpia i suoi sgherri, ovvero l’esercito imperiale che a lui risponde, cominciano a effettuare una perquisizione molto violenta, cercando delle prove – come recita il libretto – dopodiché iniziano a distruggere tutto. Perciò si crea un vero e proprio cratere, da cui emergono delle montagne di terra nera. In seguito, durante i cambi d’atto, il pavimento si spacca sempre di più, e infine si arriva, nel terzo atto, al momento in cui questo palcoscenico è completamente sventrato, tranne un piccolo brandello di assi che sono sopravvissute e che assomigliano alla piattaforma di Castel Sant’Angelo, in estrema sintesi. Ma queste assi sono, anche, il simbolo della barca, con la quale Tosca e Cavaradossi sognano di partire e si confidano reciprocamente il desiderio di una vita diversa e felice. In quel momento di sogno, queste aperture liriche si accompagnano, nella mia interpretazione, ai quadri di Cavaradossi. Ed essendo immagini di bellezza in un mondo di distruzione, ho voluto utilizzare delle semplici proiezioni, come se nella bruttura l’arte ti aiutasse almeno a sognare e a rappresentare un’armonia e una bellezza, che se non si realizza nella realtà può sempre restare viva nell’immaginazione. (testo tratto dalla conversazione pubblica tra Serena Sinigaglia e Fortunato Ortombina, tenutasi alle Sale Apollinee della Fenice il 13 maggio) VENEZIAMUSICA e dintorni | 43 Opera «RE LEAR», IL SOGNO INCOMPIUTO DI VERDI L di Chiara Facis* a profonda venerazione di Verdi per Shakespeare e la sua produzione drammaturgica ha fatto sì che il musicista non solo abbia studiato attentamente il teatro shakespeariano per approfondire e meglio delineare la psicologia dei personaggi nelle sue opere liriche – Verdi definiva Shakespeare «il grande maestro del cuore umano» –, ma abbia altresì musicato alcuni tra i principali lavori del Bardo in quelle che si possono individuare come fasi cardinali della sua produzione. Per quanto concerne l’indagine psicologica, si può notare in questi termini come – al di là dello iato epocale e di qualsiasi differenza – il drammaturgo inglese e il musicista italiano rivelino un aspetto in comune di singolare interesse, cioè un determinato senso della moralità. Entrambi artisti di teatro, abituati alle mondanità, Shakespeare e Verdi denotano infatti, ciascuno nei contenuti delle rispettive opere e secondo il proprio mezzo d’espressione, un’aperta condanna nei confronti della colpa e del vizio. A ben guardare, ogni lavoro teatrale shakespeariano è una riflessione su un vizio capitale. È, ad esempio, la condanna dell’avarizia di Shylock nel Mercante di Venezia, la denuncia dell’accidia –anche se simulata – in Amleto, la punizione dell’invidia e dell’avidità di potere in Macbeth, ancora dell’invidia di Jago e dell’ira in Otello, della superbia di Re Lear, tragico cervo alla fonte, che si compiace di chi lo tradisce e scaccia chi gli è fedele, firmando così la propria condanna. L’attenzione che Verdi riserva, come fanno del resto anche altri musicisti del suo tempo, all’indagine dell’inconscio, lo porta ad attribuire un’importanza sempre crescente alla drammaturgia delle sue opere, soprattutto a partire 44 | VENEZIAMUSICA e dintorni dalla trasposizione in musica del Macbeth (1847). Scrive in proposito Verdi a Cammarano: «Vorrei che Lady non cantasse... vorrei in Lady una voce aspra, soffocata, cupa... che avesse del diabolico» (23-XI-1848)*. L’esigenza di esprimere i caratteri dei personaggi nel contesto della tragedia scozzese con una vocalità inconsueta e più aderente al linguaggio parlato che alla linea melodica, denota in Verdi una sofferta fase di ricerca che lo condurrà – non senza rinunce, malintesi e sacrifici – ai capolavori della sua piena maturità artistica. L’attenzione del musicista si orienta dunque verso il teatro shakespeariano nei momenti cruciali della parabola evolutiva della sua produzione lirica. La prima versione del Macbeth nasce dunque tra la fine della prima produzione verdiana – precedente l’Attila (1846) – e quel fruttuoso periodo compositivo che culminerà nella trilogia popolare (1851- 1853), in cui si delineeranno in modo incisivo i tratti definitivi della fisionomia musicale del Verdi operista. L’inquietudine creativa del genio di Busseto fa sì che egli, già nella scelta del soggetto per il Rigoletto – tratto dal dramma di Victor Hugo Le roi s’amuse –, consideri la sua produzione operistica alla luce di un più vasto e profondo processo evolutivo, in vista di una drammaturgia più complessa e antimanichea, priva di una netta distinzione fra caratteri positivi e negativi, indirizzato inoltre a una maggior elaborazione della partitura orchestrale, come si potrà constatare nei capolavori della piena maturità, quali Un ballo in maschera (1859), La forza del destino (1862), Don Carlos (1867 per la versione * Musicologa Opera francese; 1884 per il Don Carlo, edizione italiana). In una parola, all’inizio del quinto decennio dell’Ottocento, il genio verdiano preconizza nel suo teatro lirico quella che sarà l’opera del periodo pre-decadentistico, con tutto l’insieme di novità e difficoltà – previste sia nel lavoro del compositore, sia nella fruizione del pubblico – che essa comporta. In questa fase produttiva di grande fervore, dunque, Verdi, in vista del progetto d’una nuova opera lirica, guarda nuovamente a Shakespeare e parla a proposito della Tempesta col suo editore francese Léon Escudier e di Amleto con l’amico scrittore e traduttore Giulio Carcano, conosciuto nell’ambiente culturale legato al salotto della contessa Clara Maffei. Ma è la traduzione del Lear, data alle stampe con successo proprio da Carcano nel 1843, a convincere Verdi circa il soggetto di un’opera che egli sta progettando per il Teatro La Fenice. All’uopo, Lear è perfetto. All’inizio del 1850, Verdi ne parla dunque con Salvatore Cammarano – stimato librettista che ha già collaborato con lui per Alzira (1845), La battaglia di Legnano e Luisa Miller (1849); gli invia un soggetto articolato in atti e scene con una lettera d’accompagnamento in cui scrive: «Il Re Lear si presenta a prima vista così vasto, così intrecciato che sembra impossibile cavarne un melodramma: però, ben esaminatolo, parmi che le difficoltà senza dubbio grandi non sieno insuperabili. Voi sapete che non bisogna fare del Re Lear un dramma con le forme presso a poco fin qui usate, ma trattarlo in una maniera del tutto nuova, senza riguardo a convenienze di sorta. Le parti parmi possano ridursi a cinque principali: Lear, Cordelia, Buffone, Edmondo, Edgardo. Due comprimarie: Regana e Gonerilla [...]. Due comprimari bassi: Kent e Glocester [...], il resto seconde parti». (18-II-1850). Verdi sembra aver già chiaro l’impianto di un’opera la cui elaborazione lo impegnerà per un decennio abbondante – dal 1851 al 1862, cioè fino alla composizione della Forza del destino. Ma la complessità del soggetto induce Cammarano, già minato da una grave malattia, a lasciare in secondo piano il Lear per privilegiare invece, nel 1852, la stesura del libretto del Trovatore che purtroppo non riuscirà a ultimare. La morte lo coglie infatti quello stesso anno e tocca pertanto a Leone Bardare, pubblicista e scrittore suo assi- stente, completare il libretto dell’opera ispirata al dramma di Gutiérrez. Nella mente di Verdi, costretto a cercare un altro librettista per il suo Lear, si profila allora il nome di Antonio Somma, avvocato friulano, per sette anni direttore artistico al Teatro Grande di Trieste (1840- 1847), residente a Venezia dal 1849. Apprezzato drammaturgo, già al suo esordio teatrale con la tragedia Parisina (1835) il Somma aveva raccolto notevoli consensi. Verdi, dunque, in questo periodo essenziale nella sua evoluzione stilistica, cerca un esperto di drammaturgia dotato di una capacità di sintesi atta ad imprimere al linguaggio lirico una nuova, singolare intensità e Somma fa al caso suo. Per quanto concerne il parere di alcuni critici del nostro tempo, pronti a bollare di mediocrità i versi del librettista friulano (ad es. «Sento l’orma de’passi spietati», Ballo in maschera, atto II), si è opposta l’opinione eminente di Francesco Flora che ha individuato un’ascendenza manzoniana nella scrittura di Somma («S’imparò a distinguere […] il romore di un’orma», Promessi sposi, I Edizione, 1825-1827). Non solo. Lo stesso Verdi non mancò mai di esprimere allo scrittore la sua stima, anche e soprattutto a livello epistolare. Nel 1853 prende quindi l’avvio il nuovo progetto per la tragedia shakespeariana, che però si rivela fin da principio alquanto laborioso e tormentato. In un primo tempo, compositore e librettista optano per uno schema in cinque atti. Poi Verdi, tenendo presente alla luce della sua esperienza la temperie del pubblico, decide di ridurre il progetto nelle sue dimensioni e scrive: «Io sarei peraltro d’opinione di ridurre il melodramma in tre atti od al più quattro. Nell’atto primo la divisione del regno colla partenza di Cordelia (che sarebbe un’aria): le scene delle due corti successivamente e finirei coll’invettiva del Re là dove dice che “farà cose tremende, non sa ancora quali saranno, ma ne avrà spavento la terra”. L’atto secondo lo comincerei con Lear addormentato: Cordelia lo assiste (sublime duetto); ecc. ecc. Battaglia: e scena ultima. Prime parti: Lear, Cordelia, i due fratelli Edgardo, Edmondo, il Pazzo, che farei forse contralto. Comprimari: Gonerilla, Regana, Kent ecc. Il resto seconde parti. I pezzi capitali di quest’opera parmi capire fin d’ora che saranno l’introduzione coll’aria di Cordelia, la scena della tempesta; la scena del giudizio; il duetVENEZIAMUSICA e dintorni | 45 Opera to di Lear e Cordelia; e la scena ultima. Ecco quello che pare a me, del resto nella vostra saggezza fate quello che stimate meglio. Abbiate solo in vista la necessaria brevità. Il pubblico s’annoia facilmente!» (22-V-1853). Somma, dunque, riduce in un primo tempo gli atti a tre condensando il II e il III in un II atto e riassumendo i IV e V in un III atto. Poi, compositore e librettista scelgono definitivamente una struttura in quattro atti. Ligio alle fitte disposizioni e annotazioni di Verdi, Somma effettua due stesure del libretto per il Lear. Il lavoro viene ultimato nel 1856. A questo punto è d’uopo notare che, da quanto riferisce Simonetta Ricciardi**, «del Re Lear esistono tre documenti autografi di Somma e uno di mano di Verdi». I primi sono le due ricordate versioni complete e le varianti effettuate da Somma alla prima versione del libretto. Verdi, probabilmente tra il dicembre 1853 e il febbraio 1854, copia di suo pugno la prima versione del Lear integrandovi la revisione del poeta. La copia autografa del compositore costituisce dunque la versione intermedia tra le due stesure complete del libretto. I manoscritti di Somma e quello di Verdi si trovano riprodotti e trascritti da Gabriella Carrara Verdi***. All’epoca, tuttavia, il lavoro di Verdi e Somma non vede le scene. C’è qualcosa che non convince il maestro, sia a livello librettistico, sia per quanto concerne la parte musicale. Altre opere da lui composte negli anni 1853-1859 trovano compimento e rappresentazione, dopo Il trovatore, rispettivamente, La traviata (1853), i Vespri (1855), Simon Boccanegra e Aroldo (1857). Non che per questo stima e fiducia di Verdi nei confronti di Somma vengano a scemare. Sempre col librettista friulano, il maestro di Busseto porta in scena Un ballo in maschera nel 1859 con notevole successo. Con ogni probabilità, secondo il parere più accreditato dagli esperti, il Lear non trovò ideale compimento e rappresentazione perché Verdi non potè mai trovare a parer suo un adeguato cast d’interpreti. Il musicista era in primo luogo alla ricerca di un baritono di primo livello per la parte protagonistica, voleva un artista completo, di carattere incisivo e comprovata esperienza, ma fra gli interpreti del suo tempo, Verdi non ne trovò alcuno che, secondo il suo giudizio, fosse degno della statura artistica richiesta dal ruo- 46 | VENEZIAMUSICA e dintorni lo. Inoltre, il compositore si rammaricava per non aver potuto disporre di una soprano come Maria Spezia per la parte di Cordelia, che egli aveva curato in modo particolare per lo spessore emotivo e affettivo richiesto dal personaggio. La Spezia, già acclamata Violetta e Leonora nel Trovatore, pur di voce esile, era assai stimata da Verdi che la definiva «di talento grande, anima e sentimento di scena» (11-XI-1856). Per quanto concerne la parte musicale dell’opera, si ritiene, con le debite riserve della ricerca, che alcune arie del Lear siano confluite nella più prossima Forza del destino. A tale proposito, Leo Gerhartz – come buona parte della critica – ritiene che l’aria di Leonora nel I atto della Forza del destino – «Me pellegrina ed orfana» – corrisponda a tutti gli effetti alla prima aria di Cordelia nell’atto iniziale del Lear, che si apre con lo stesso verso. Esempi**** Aria di Cordelia (dal Re Lear) Aria di Leonora dalla Forza del destino Me pellegrina ed orfana Lunge dal ciel natìo Sospinge il fato mio Sospinge a stranio lido... Ai flutti inesorabili Piena di sue memorie Col mio dolor m’avvio! dannato a eterno pianto Non ho per te che lacrime Dolce Inghilterra...e addio! Senza immortale angoscia Non ti si lascia...addio! Me pellegrina ed orfana Lungi dal patrio nido Un fato inesorabile Colmo di tristi immagini, Da’ suoi rimorsi affranto E’ il cor di questa misera Ti lascio, ahimè, con lacrime, Dolce mia terra! Addio! Ahimè, per me non avrà termine Sì gran dolore!... Addio! Il Lear resterà fra i sogni irrealizzati di Verdi. Eppure il musicista non si arrende. Nell’ultima lettera a Somma, dopo il trionfo del Ballo, Verdi scrive al librettista di avere «diversi poemi in portafoglio, compreso il vostro magnifico Re Lear». (17-XII1863). Dopo la morte del drammaturgo (1865), il musicista progetta una rappresentazione del Lear a Parigi, come attesta una lettera a Escudier (30-VI1865), poi abbandona l’idea perché ritiene l’opera di carattere troppo innovativo e audace per il pubblico parigino; preferisce presentare per l’occasione il Don Carlos (1867). Tuttavia, Verdi non vuole Opera abbandonare quel progetto tanto agognato. Anche nel corso degli anni novanta, come osserva il Nardi*****, ne riparla con Boito, egregio e ultimo suo librettista, ma è ormai tardi. Dopo l’Otello, penultimo, magistrale incontro con Shakespeare, sarà il sorriso del Falstaff, capolavoro dell’opera comica, a mettere il punto definitivo sulla sorte del cervo alla fonte, sfumata alla luce dell’ironia. Il maestro concluderà il suo ultimo lavoro teatrale con una fuga a dieci voci, ultima sfida di estrema sapienza compositiva, ai colleghi di Francia e Mitteleuropa. Un’uscita superba dalla scena lirica, pur nel costante rimpianto di un sogno rimasto incompiuto. Riferimenti epistolari: i Copialettere, archivio di S.Agata,Villa Verdi. Pascolato:”Re Lear e Ballo in maschera. Lettere di Giuseppe Verdi ad Antonio Somma”, Città di Castello, ed. Lapi, 1913. ** Carteggio Verdi-Somma, Istituto nazionale Studi verdiani, Parma, 2003. *** Per il «Re Lear», Istituto di Studi verdiani, Parma 2002. **** Dal libretto autografo di Verdi. ***** Piero Nardi, Vita di Arrigo Boito, Mondadori, Milano 1942. * VENEZIAMUSICA e dintorni | 47 Opera CHI BEN COMINCIA... SULLE FARSE VENEZIANE DI ROSSINI N di Giorgio Gualerzi ei primi quindici anni dell’Ottocento sorte particolarmente felice toccò al San Moisè, diretto concorrente degli altri due principali teatri veneziani, il San Benedetto e La Fenice. Ospite fortunato fu un ragazzo di talento, Gioachino Rossini, che per quelle scene, fra il novembre 1810 e il gennaio 1813, scrisse cinque farse in un atto, la prima delle quali (La cambiale di matrimonio) rappresentò l’esordio teatrale del giovanissimo autore. Il loro successo – buono per La cambiale di matrimonio e La scala di seta, grandissimo per L’inganno felice, mediocre per L’occasione fa il ladro e infine molto contrastato per Il signor Bruschino – costituì la premessa per il completo, e prolungato nel tempo, trionfo di Rossini. Naturalmente il contributo dei cantanti – alcuni dei quali particolarmente versati nel genere buffo – non fu estraneo al buon esito complessivo. Innanzitutto spicca Rosa Morandi (1782-1824), la prima Fanny della Cambiale di matrimonio, già nota per avere preso parte come Dorabella alla prima scaligera di Così fan tutte (1807). Il che non le aveva impedito di sviluppare una spiccata vocazione sopranile, che le permise di affermarsi in un più ampio repertorio comprendente opere scritte appositamente per lei dai maggiori operisti del tempo. La Morandi – che nel 1819 fu la prima interprete di Eduardo e Cristina – ebbe modo di brillare ripetutamente nelle opere serie rossiniane, rivelandosi cantante completa: «Voce intonatissima, estesa, flessibile, splendido metodo, azione gentile, espressione toccantissima» erano i pregi che un cronista coevo lodò dopo una Zelmira a Firenze. A Venezia accanto alla Morandi c’erano Luigi Raffanelli (1752-1821) e Nicola De Grecis (1733-?), due fra i più appluditi «buffi». Entrambi mediocremente dotati sul piano vocale, si rifacevano puntando sulle risorse interpretative che consentirono loro di calcare a lungo le scene. È invece del 1812, in occasione dell’Inganno felice, il primo incontro di Rossini con un tenore di rilievo sul versante dell’opera buffa: si trattava del marchigiano Raffaele Monelli (1782-1859), dotato di un notevole registro acuto messo in evidenza nella complessa aria di Bertrando. E fu ancora l’Inganno felice a propiziare due incontri determinanti per il prosieguo della carriera di Rossini. Isabella era Teresa Belloc (1784-1855), vocalista dalle straordinarie risorse tecniche e dal vivace temperamento, valorizzate le une e le altre nell’Italiana in Algeri e ancor più dalla Ninetta della Gazza ladra. «La signora Belloc è orribilmente brutta», scriveva Stendhal, «ma se è “in giornata” è forse la prima cantante-attrice d’Italia». Addirittura fondamentale per le fortune del compositore fu l’incontro con Filippo Galli (1783-1853), colto nel momento della decisiva trasformazione da tenore in basso. Per altri trent’anni sarà una colonna portante del teatro lirico, soprattutto nel campo dell’opera seria. Le sue note «simili al tuono», come le definirà il solito Stendhal, saranno messe più volte a servizio di Rossini, del quale Galli tenne a battesimo Fernando nella Gazza ladra, Maometto II nell’opera omonima e soprattutto Assur in Semiramide. * 48 | VENEZIAMUSICA e dintorni Critico musicale Dintorni HAROLD BLOOM RACCONTA SHAKESPEARE H a cura di Pietro Tessarin e Bruce Boreham arold Bloom è uno dei massimi critici letterari americani, celebre tra le altre cose per opere fondamentali come Il canone occidentale e Il genio. In questa intervista esclusiva, che inaugura La Fenice Channel – la nuova web radio del Teatro veneziano, che ha esordito sulla rete il 2 giugno scorso – affronta uno degli autori prediletti, William Shakespeare, posto anche al centro del citato Canone. Professor Bloom, in un suo famoso libro lei definisce William Shakespeare «inventore dell’uomo». Potrebbe spiegare in breve questo concetto? Questo è un argomento che va trattato con molta cautela, perché il suo fraintendimento ha dato luogo a un mucchio di sciocchezze, sia da parte di altri critici che da parte dei miei detrattori. Uso il termine «invenzione» nel medesimo modo nel quale lo utilizzano lo stesso Shakespeare, Samuel Johnson e la tradizione retorica: intendo cioè la parola «invenzione» come processo euristico, attinente alla scoperta del linguaggio. Non intendo certo dire che Shakespeare sia stato «inventore» al pari di Thomas Alva Edison, che ha creato la lampadina. Cito Johnson quando afferma che «l’essenza della poesia è invenzione»: questa è l’accezione del termine in retorica, e io lo uso in questo modo, intendendo con «invenzione» la scoperta dell’uomo tramite l’esercizio del linguaggio e del pensiero. Tutto ciò di cui parla Shakespeare è sempre esistito, infatti, ma se non ce l’avesse mostrato sotto una certa luce, forse non l’avremmo mai visto o riconosciuto. C’è però un’altra questione fondamentale, relativa ai caratteri. Prima di Shakespeare essi, nell’ambito della letteratura creativa, sono stati rappresentati in modi diversissimi, dalla narrativa al teatro alla poesia all’epica. Ma il grande drammaturgo inglese, insieme a Montaigne (che è quasi suo contemporaneo e verso il quale ha qualche debito) e a Cervantes forma un trio che, in maniera differente, ha saputo dare nuova enfasi alla rappresentazione del carattere: Montaigne ne crea uno, gigantesco: se stesso; Cervantes due, Sancho Panza e Don Chisciotte, il cavaliere dalla triste continenza. Tuttavia in questo senso Shakespeare è unico, perché ci fornisce cento diversi caratteri nei personaggi principali delle sue trentotto opere teatrali, e mille altri nei personaggi minori: ognuno parla, si comporta e pensa in modo diverso. Questo è il suo miracolo. Tra le molte pièce shakespeariane, alcune parlano di Venezia, e nella prefazione a una di esse, Il mercante di Venezia, lei fa tra l’altro un riferimento divertente alla natura «birichina» della città lagunare e dei suoi abitanti. Come va letto questo testo? Credo che il malinteso più frequente in tutte le interpretazioni moderne del Mercante sia ignorare che si tratta di una commedia, non di una tragicommedia, di un dramma o tantomeno di una tragedia. Agli occhi di Shakespeare e del suo pubblico Shylock risulta essere un villain comico. Naturalmente non è così che lo si rappresenta oggi, per una serie di complessi motivi sociologici, politici e storici. Ma vorrei ricordare che nella compagnia del Bardo questo ruolo forse veniva incarnato dal primo attore, Richard Burbage, ma molto più proVENEZIAMUSICA e dintorni | 49 Dintorni babilmente dal clown Will Kempe, vestito con una parrucca rossa e una gabardina. Si tratta insomma di una caricatura, molto affine al suo modello, Barabba, l’ebreo di Malta protagonista dell’omonima straordinaria pièce di Christopher Marlowe, che cronologicamente viene prima. Certo Shakespeare, essendo Shakespeare, non costruisce una semplice figura di «cattivo comico», ma crea invece un personaggio dotato di tantissime sfumature. In ogni caso, la tradizione moderna di interpretare Shylock come carattere tragico mi sembra del tutto errata. Qual è secondo lei il rapporto che lega Shakespeare a Marlowe? È una relazione molto complessa. Qualche anno fa, ai tempi di Shakespeare: The Invention of the Human, ho scritto che Shakespeare «ha semplicemente ingoiato Marlowe allo stesso modo in cui una balena inghiotte un pesciolino. Ma che quest’ultimo gli ha provocato un mal di pancia duraturo…». Marlowe è sempre presente in Shakespeare, ma è una presenza che dev’essere esorcizzata. Probabilmente l’esperienza determinante della vita artistica di Shakespeare è accaduta quando lui era ancora giovanissimo e non faceva il drammaturgo ma l’attore. Quando cioè ha assistito alla rappresentazione della prima parte di Tamerlano il grande. In quell’occasione ha potuto vedere sul palcoscenico Edward Alleyn – il grande interprete tragico di Marlowe – esercitare ciò che quest’ultimo definisce «la patetica della persuasione», vale a dire la potenza dell’eloquio che permette a Tamerlano di sedurre il mondo. E Shakespeare osservava intorno a lui 2500, 3000 persone completamente stregate e ipnotizzate dall’incantesimo della scrittura di Marlowe, il suo pentametro tremendo, i suoi periodi vaganti, la straordinaria retorica teatrale. Quest’esperienza ha lasciato in lui una lezione duratura sulla forza che il linguaggio drammaturgico esercita sul pubblico. Penso che di tutte le influenze che Shakespeare ha subito questa sia la più importante, anche perché la più pragmatica. Credo che Shakespeare abbia sempre sentito un debito nei confronti di Marlowe, da cui è nata l’esigenza di esorcizzarlo, riuscendovi però solo in parte: l’ombra del suo predecessore è sempre presente. 50 | VENEZIAMUSICA e dintorni Anche alla fine della Tempesta, nessuno si rende conto di essere di fronte a una versione shakespeariana dell’ultima opera di Marlowe, il Doctor Faustus: Prospero è semplicemente il nome italiano di Faustus, entrambi significano «il favorito». Ma al posto di Mefistofele come aiutante Shakespeare affianca a Prospero un vivace angioletto come Ariel. Vuole dirci qualcosa su un’altra opera «veneziana», Otello? Riguardo Otello ho una convinzione profonda, che spesso mi ha fatto entrare in polemica con i miei colleghi. Sono convinto che tutta la tragedia sarebbe percepita in modo assai diverso partendo dal fatto che il matrimonio tra Otello e Desdemona non si sia mai consumato. Se si legge il testo con attenzione ci si accorge che – nel brevissimo arco di tempo nel quale si svolge l’azione, un giorno, una notte e parte del giorno dopo – Shakespeare non ha lasciato alla coppia il tempo di consumare le nozze (e non sembra che Otello lo desideri particolarmente). Questo cambiamento di prospettiva è avvalorato dalla scena conclusiva, la vera climax drammatica della pièce, quando Desdemona raccomanda ad Emilia di fare il letto con le lenzuola matrimoniali, non ancora macchiate del suo sangue virginale, nella speranza di unirsi finalmente con il suo signore. Lui stesso, prima di ucciderla, le dice: «Non farò scorrere il suo sangue». Non macchierò quelle lenzuola. Poi la strangola a morte. Bisogna sempre tenere a mente che Shakespeare è un drammaturgo analitico e molto subdolo. Man mano che procede nella sua carriera, quello che intende dire al pubblico supera di gran lunga quanto invece è contenuto nei versi. Amleto è un esempio di questa complessità. Shakespeare non ci dice mai da quanto tempo dura il rapporto amoroso tra Claudio e Gertrude: questo pensiero è l’unico davvero insopportabile per Amleto, che proprio per questo non lo esplicita mai a parole. Se infatti quella relazione è antica, di molto precedente alla morte di Amleto padre per mano del fratello, si apre la possibilità che Amleto sia figlio di Claudio, o quantomeno nasce spontaneo il dubbio. Ecco perché, quando ha già levata la spada alle spalle dello zio, si blocca dicendo che se lo uccidesse in Dintorni quel momento, mentre prega, gli farebbe un favore mandandolo in paradiso. Ma è una sciocchezza, nessuna teologia afferma un concetto del genere, e Amleto stesso non ci crede. Ciò che lo ferma è la profonda paura che si tratti del proprio padre carnale. Del resto questa è una questione che riaffiora in Shakespeare. Nel Giulio Cesare molti personaggi accennano al fatto che Bruto sia figlio naturale di Cesare. I romani danno per scontato che lo sia. E sia Bruto che Cesare sembrano saperlo. Questo rende l’omicidio, l’accoltellamento, l’ultima ferita inferta ancora più terribili, perché non si tratta «solo» di regicidio, ma di un atto di parricidio. Ecco perché Cesare rivolge a Bruto quelle parole in latino: «Et tu, Brute?» Il punto è che Shakespeare non ce le dice queste cose. Vuole che ci arriviamo da soli. Sapere chi è il proprio padre, nella vita come in Shakespeare, o in Shakespeare come nella vita, è davvero una faccenda complessa. Il vecchio detto: «Raro nella vita è l’uomo che conosce il proprio padre» Shakespeare lo tiene sempre a mente, ed è un tema che ricorre in altre opere, come ad esempio Racconto d’inverno. Per concludere un’ultima domanda: che rapporto intreccia il teatro di Shakespeare con gli elementi musicali presenti nella sua epoca? Oltre alle grandi opere teatrali, Shakespeare compone anche sonetti e alcuni altri eccellenti poemi narrativi. Ma è un dato di fatto che le pièce – siano tragicommedie, tragedie o commedie – sono sempre punteggiate da canzoni. Le più riuscite direi che sono quelle di Autolico in Racconto d’Inverno, e i brani di Ariel nella Tempesta, che è assai ricca di interventi musicali, gran parte dei quali suonati da un liutista. Non sappiamo con certezza se, oltre alle canzoni, la musica accompagnasse o meno il grosso del teatro shakespeariano. Ma sicuramente c’è un legame molto stretto con quei brani. Basti pensare al canto di Ofelia, alla «Canzone del salice» di Desdemona, alle melodie folli eseguite dalle streghe nel Macbeth, al magnifico buffone di Re Lear... VENEZIAMUSICA e dintorni | 51 Dintorni JUVENICE, L’ASSOCIAZIONE GIOVANI AMICI DELLA FENICE I l luogo comune secondo il quale musica d’arte e nuove generazioni sono destinati a incontrarsi sempre di meno è smentito da Juvenice, vale a dire dall’Associazione Giovani Amici della Fenice, attiva dall’anno scorso. Il suo presidente, Manuel Meneghel, spiega i motivi che l’hanno spinto a fondarla. L’Associazione nasce nel 2013, anche se già prima avevo costruito una pagina Facebook con lo scopo di intercettare i giovani che avevano il desiderio di frequentare la Fenice. L’idea era sorta dopo aver scoperto che esisteva un network a livello europeo, chiamato Juvenilia, che riunisce tutte le associazioni giovanili presenti presso i teatri lirici. Ci siamo dunque chiesti perché non creare qualcosa di simile anche a Venezia. Il concetto chiave da cui siamo partiti è che ci sono molti giovani che amano l’opera: da lì è iniziato tutto, e devo dire che il Teatro ha risposto molto rapidamente alle nostre richieste, mettendoci in contatto con l’area formazione, dove abbiamo stabilito la sede. Con questo settore abbiamo cominciato a collaborare sin da subito, per esempio realizzando le cartoline digitali per le prove generali, da inserire su Facebook, e comunque favorendo il passaparola in rete. In cambio possiamo contare su una quota di biglietti per le prove. Nel luglio 2013 abbiamo costituito legalmente l’Associazione e dal gennaio di quest’anno abbiamo cominciato ad accettare nuovi soci. Attualmente siamo in cinquantacinque. Quali sono i requisiti per iscriversi? L’unico è quello legato all’età: il tetto massimo 52 | VENEZIAMUSICA e dintorni sono i trentaquattro anni compiuti. La quota associativa è di quindici euro l’anno, quindi assolutamente accessibile. Il lavoro che svolgiamo è ovviamente del tutto volontario, nessuno ci guadagna niente. Che tipo di attività avete sviluppato in questo breve tempo? Abbiamo un nostro sito, e siamo in stretta relazione con le altre Associazioni italiane ed europee di questo tipo, che sono circa una trentina. Stiamo cercando di riunirle tutte qui a Venezia, in occasione dell’assemblea generale, e per il momento abbiamo già il consenso del Teatro. In Italia esistono cinque Associazioni formali e altri tre gruppi meno strutturati. L’idea di fondo è essere aperti a trecentosessanta gradi sulla città e sul territorio. Collaboriamo con la Fenice, naturalmente, ma anche, per esempio, con il Venetian Centre for Baroque Music e con Palazzetto Bru Zane, con il quale abbiamo anche organizzato un evento a Parigi. Vorremmo poi prossimamente lanciare un progetto con il padovano Caffè Pedrocchi, per un’insolito happy hour in cui proporre musica dal vivo. Quali problemi incontra, secondo lei, un ragazzo che vuole avvicinarsi alla musica? Anche se può sembrare strano, il primo problema, a mio parere, non riguarda l’accessibilità dei teatri. Ancor prima bisogna tener conto di come si usufruisce oggi della musica. È del tutto evidente, per esempio, che molto difficilmente la musica classica può essere ascoltata con l’iPod viaggiando in treno. Bisogna dunque, da un lato, creare un collegamen- Dintorni to con le forme d’ascolto tipiche di oggi: se si vuole parlare ai giovani ci si deve confrontare con queste nuove modalità di fruizione. Dall’altro lato, però, è innegabile che i teatri continuino a esercitare un fascino che non si riesce a trovare all’interno di un iPod. Quindi bisogna far passare il concetto che questi luoghi, oltre che produrre e presentare musica, sono anche spazi bellissimi, che non devono essere visti come cattedrali impenetrabili, appannaggio esclusivo di ricchi e melomani, ma invece essere percepiti come una casa. Per fare soltanto un esempio, vorremmo far capire ai ragazzi che con tre euro possono entrare alla Fenice, pagando il biglietto d’ingresso, e con altri due bere uno spritz al bar delle Sale Apollinee. Con cinque euro dunque possono prendere l’aperitivo in teatro, mentre a pochi passi l’orchestra sta provando. L’obiettivo che perseguiamo è convincere i giovani che si possa usufruire del teatro non solo in maniera statica e convenzionale, come se si andasse al cinema, ma anche come spazio di relazione. Come è nata in lei questa grande passione per la musica? Provengo da una famiglia normale, ma, come in tutte le famiglie normali, anche nella mia si incontrano dei musicisti. Il mio primo contatto è avvenuto attraverso la sorella di mia madre, che era una pianista: quando andavo a casa sua potevo usare il pianoforte per suonare le mie canzoncine. Poi c’era anche il fratello di mio nonno, che cantava in chiesa: era appassionato di lirica e collezionava audiocassette con le opere. Questo è stato il mio primo rapporto con la lirica. In seguito ho anche voluto provare la carriera di violinista, iscrivendomi al Conservatorio. E, anche se poi ho abbandonato l’idea, mi è rimasta questa forte passione, che mi ha spinto a creare l’Associazione, per fare rete con le altre realtà e dare la possibilità a tutti di conoscere e di amare la musica. (l.m.) VENEZIAMUSICA e dintorni | 53 Carta canta LE RECENSIONI di Giuseppina La Face Bianconi* S tefano Melis, docente nel Conservatorio «Luigi Canepa» di Sassari, è esperto di teoria musicale e didattica dell’ascolto. Si occupa del Novecento storico e di musica contemporanea, in particolare di György Kurtág. L’editore Albisani, nella collana «Chiavi d’ascolto», pubblica un suo volumetto su Il Concerto per orchestra di Béla Bartók, dedicato all’analisi e all’ascolto del capolavoro. Composto nel 1943 per la Boston Symphony Orchestra su commissione di Serge Koussevitzky, il Concerto fu la prima opera di Bartók nell’«esilio americano»: il musicista si era trasferito negli USA per sfuggire alla guerra, in aperto contrasto con l’ideologia totalitaria. Nel testamento stilato il 4 ottobre 1940, pochi giorni prima d’imbarcarsi, scrisse parole indimenticabili: «Fino a quando in Ungheria vi sarà una piazza o una strada che porterà questi due nomi (Hitler e Mussolini), io desidero che nel Paese non vi sia né strada né piazza né monumento pubblico che porti il mio nome e che nessuna lapide commemorativa sia posta in un luogo pubblico». Melis ricostruisce con scioltezza e bravura il tormentato quadro storico, focalizza le problematiche che il musicista dové affrontare negli States – dapprima le sue esibizioni pianistiche con la moglie non ebbero successo, né egli si adattava all’American way of life –, descrive la genesi dell’opera, accolta con favore dal pubblico e dai critici, che sottolinearono la lodevole propensione del compositore magiaro nel riscoprire i va* Ordinario di Musicologia e Storia della Musica all’Università di Bologna Stefano Melis Béla Bartók: il concerto per orchestra, Bologna, Albisani Editore, 2013 («Chiavi d’ascolto», 7), 128 pp., ISBN 9788895803173; 13,50 euro. Andrea Sessa, Il melodramma italiano 1901-1925. Dizionario bio-bibliografico dei compositori, Firenze, Leo S. Olschki, 2014 («Historiae Musicae Cultores», CXXVI), 2 tomi, IX-1009 pp., ISBN 9788822262721; 90 euro. I drammi musicali veneziani di Benedetto Ferrari, Nicola Badolato e Vincenzo Martorana, Firenze, Leo S. Olschki, 2013 («Historiae Musicae Cultores», CXXVIII), XXXVI-345 pp., ISBN 9788822263032; 43 euro. a cura di 54 | VENEZIAMUSICA e dintorni Carta canta lori melodici della tradizione e nel tenere a freno l’asprezza delle dissonanze e del ritmo. Melis descrive minuziosamente la partitura, la sua struttura, gli elementi costitutivi del linguaggio, in primis il rapporto con la musica popolare, cui Bartók aveva dedicato ricerche e studi approfonditi. Il volumetto, che comprende una discografia ragionata, una bibliografia essenziale, un utile glossario, può essere utilizzato fruttuosamente dagli studenti e dai docenti, ma anche dai semplici musicofili. Ci auguriamo che la collana «Chiavi d’ascolto» incrementi la produzione di monografie come questa: sono strumenti preziosi per la crescita culturale e musicale. Andrea Sessa è giornalista di professione e melomane per passione. Esce ora da Olschki Il melodramma italiano 1901-1925, che fa seguito a un analogo «dizionario bio-bibliografico» dedicato ai compositori d’opera attivi tra il 1861 e il 1900 (apparso nel 2003). Qui Sessa tratta ben 1323 musicisti, che, sebbene in pochi abbiano raggiunto il successo, hanno nondimeno lasciato un’impronta tangibile nella storia del teatro d’opera del primo quarto del Novecento. Nel dizionario si possono inseguire le scelte preferenziali dei soggetti: fiabe, vicende esotiche, ispirate alla Bibbia, alla mitologia, ai santi, al medioevo; dal 1915, con l’entrata in guerra, si aggiungono anche lavori a sfondo patriottico. Il dizionario dà notizie di musicisti mi- nimi, come Giovanni Battista Curti, cieco, autore di Giacinta e La Serenissima, o Arnaldo Filipello, autore di Damone e Pizia nonché del vaudeville On milanes in mar, poi attivo in Svizzera. Parecchi gradini più su si collocano Alberto Franchetti, Arrigo Pedrollo, Antonio Smareglia, ma anche stranieri che come Robert Stolz ebbero rapporti con l’Italia. Le schede offrono anche la trama delle opere, soprattutto le meno conosciute. In appendice figurano se non altro i titoli dei compositori maggiori, per i quali l’autore ha saggiamente rinunziato a schede apposite: Cilea Giordano Leoncavallo Mascagni Puccini. I due volumi di Sessa, strumento di ricerca per musicologi, sono nel contempo un piacevole testo di consultazione per il musicofilo curioso. L’editore Olschki di Firenze pubblica in un ricco volume I drammi musicali veneziani di Benedetto Ferrari, a cura di Nicola Badolato e Vincenzo Martorana. Si tratta dei sei libretti che, tra il 1637 e il 1644, lanciarono l’opera in musica nei teatri impresariali di Venezia, dunque gli incunaboli di un genere destinato a plurisecolare fortuna. Ferrari, nato a Brescello, era musicista di suo, suonatore di tiorba, compositore, forse cantante: la musica dei suoi drammi è perduta, ma restano tre libri di splendide Musiche a voce sola. La lettura dei libretti, tessuti su soggetti mitologici (Andromeda) o cavallereschi (Armida) o avventurosi (Il pastor regio), offre a piene mani spunti di drammaturgia barocca immaginosa e spiritosa. VENEZIAMUSICA e dintorni | 55 Carta canta PIETRO BERTOJA SCENOGRAFO E FOTOGRAFO Maria Ida Biggi (a cura di), Pietro Bertoja scenografo e fotografo, Alinari, Firenze 2013. «La preparazione artistica di Pietro Bertoja trova applicazione immediata nella collaborazione con l’attività teatrale del padre Giuseppe che, dopo essere stato valente collaboratore di Bagnara al Teatro La Fenice, firma in questo teatro nel 1840 alcune impegnative scenografie per gli allestimenti di Semiramide di Gioachino Rossini e Maria Stuarda di Gaetano Donizetti. […] La ditta Bertoja, padre e figlio, lavora stabilmente a Venezia, negli anni in cui la Fenice è aperta, quindi fino all’aprile 1859. In questo periodo vengono prodotti molti spettacoli di opera e balletto per i quali la scenografia continua ad assumere un ruolo considerevole e determinante per il loro successo. […] Pietro è molto attivo nell’atelier familiare, benché in questi stessi anni sia molto impegnato con le produzioni nei teatri di altre città. […] Nel corso della seconda metà dell’Ottocento collabora con diversi teatri in numerose città italiane, tra cui Bologna, Ferrara, Fiume, Mantova, Pesaro, Piacenza, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza, come si può dedurre dai disegni da lui firmati e datati, oltre che dalle cronologie dei singoli teatri. […] Pietro nel suo lavoro scenografico e teatrale si distingue dal padre per una maggiore attenzione alle novità tecnologiche e all’uso dei nuovi sistemi di illuminazione, anche perché l’epoca in cui si trova ad operare permette l’utilizzo della luce elettrica che in teatro ha comportato una grande rivoluzione scenotecnica ed estetica. Pietro Bertoja dedica molta energia alla 56 | VENEZIAMUSICA e dintorni ricerca di effetti scenografici ottenibili attraverso le trasparenze utilizzando tulle, veli, tele sottili che – illuminate dal retro, o comunque in modo innovativo – possano creare una differente situazione scenica, anche senza grandi movimenti di elementi costruiti. I suoi disegni acquerellati in cui, grazie all’uso del colore liquido, riesce a rendere gli effetti luministici sono un’importante testimonianza della sua indagine estetica». Questo è un estratto del lungo ed esauriente saggio di Maria Ida Biggi, che apre Pietro Bertoja scenografo e fotografo, l’esaustivo catalogo curato dalla stessa studiosa e dedicato al grande inventore di scenografie veneziano. Il volume documenta la sua attività di scenografo teatrale e fotografo, valorizzandone la complessa figura nel panorama della seconda metà dell’Ottocento veneto e contiene – oltre a quello iniziale della Biggi – saggi di Gabriella Olivero, Linda Selmin, Mercedes Viale Ferrero e Marianna Zannoni, oltre a una cronologia e un ampio catalogo dei lavori teatrali, suddivisi in produzione per opera, danza e prosa, e a un vasto repertorio della sua produzione fotografica. I materiali pubblicati, molti dei quali inediti, derivano in parte da ricerche eseguite in questa occasione e permettono di confermare la modernità di Bertoja nella sperimentazione delle sue invenzioni tecniche e dall’applicazione delle innovazioni illuminotecniche e pittoriche. La documentazione pubblicata proviene per la maggior parte da collezioni private, oltre che dal Museo Correr di Venezia, dal Museo Civico di Pordenone e dall’Archivio Alinari di Firenze. (l.m.) VENEZIAMUSICA e dintorni Una festa della musica di Cesare De Michelis Sulla «Maratona» dei compositori di Mario Messinis di L’«Hôtel Europe» Bernard-Henri Lévy Venezia-Parigi: andata e ritorno di José Sasportes Ellen Rosand e il Seicento veneziano di Lorenzo Bianconi Chi ben comincia... Sulle farse veneziane di Rossini di Giorgio Gualerzi Pino Donaggio, il ragazzo col violino di Giò Alajmo I libri di Giuseppina La Face Bianconi Edizioni La Fenice
Scarica