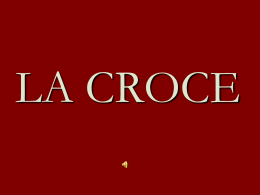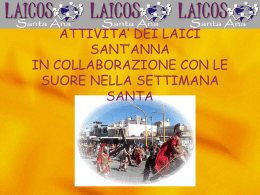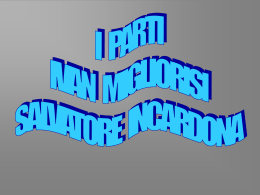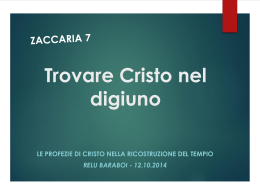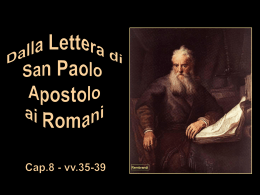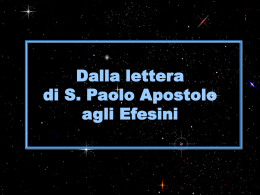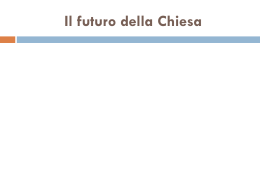KAIRÓS Una vita differente Anno VIII n. 1 Settembre 2005 Indice La Parola Una vita differente Silvia Girola 3 La Tradizione I frutti dello Spirito. L’amore Giuseppe Angelini 17 La Preghiera Cantico 1 Cr 29,10-13 27 Se cerchi un libro 29 Kairós – La Parola LA PAROLA Silvia Girola UNA VITA DIFFERENTE MEDITAZIONI SULLA PRIMA LETTERA DI PIETRO INTRODUZIONE «II Dio di ogni grazia, che vi ha, chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo la breve sofferenza, vi confermerà, vi renderà forti e saldi» (1 Pt 5,10): questa frase riassume bene l'intento principale della Prima lettera di Pietro, quello di confermare nella fede, mediante l'esempio di Cristo, alcune comunità cristiane che vivono un'ora di crisi. Composto con buona probabilità a Roma (cioè, metaforicamente, «Babilonia»: 1Pt 5,13) alla fine del 1 secolo d.C. da un autore che si richiama all'autorità di Pietro (nel commento mi riferirò a lui chiamandolo semplicemente Pietro), questo testo si presenta come una lettera circolare più precisamente uno scritto omiletico-catechetico cui è stata posta una cornice epistolare - indirizzata alle comunità cristiane che sono in diaspora nei territori dell'Asia Minore (cfr. 1 Pt 1, 1). Si tratta verosimilmente di comunità composte sia da membri provenienti dal paganesimo, come dimostrano alcune espressioni che si riferiscono al loro passato idolatrico (cfr. 1Pt 1,18; 2,9-10; 4,3), sia da cristiani di origine giudaica, come si può ipotizzare sulla base della loro familiarità con i testi dell'AT (sempre citati nella versione greca dei LXX), utilizzati con grande frequenza dall'autore. 3 Kairós – La Parola Il corpo della Prima lettera di Pietro, pur estremamente compatto in sé, può essere strutturato come segue: 1) INDIRIZZO E SALUTO (1 Pt 1, 1-2) 2) BENEDIZIONE TRINITARIA (1Pt 1,3-12) a) Dio Padre il rigeneratore: 1Pt 1,3-5 b) Gesù Cristo l'amato, ossia l'amore per Gesù Cristo: 1Pt 1,6-9 c) Lo Spirito Santo all'opera nei profeti e negli evangelizzatori: 1Pt 1,10-12 3) LA DIGNITA’ DELLA VOCAZIONE CRISTIANA (1 Pt 1, 13-2, 10) a) Santità: 1Pt 1,13-21 b) Rigenerazione: 1Pt 1,22-2,3 c) La chiesa, casa e popolo: 1 Pt 2,4-10 4) OBBLIGHI DELLA VITA CRISTIANA (1 Pt 2,11-3,12) a) Obblighi tra i pagani: 1Pt 2,11-12 b) Obblighi verso ogni creatura: 1Pt 2,13-20 c) Inno cristologico: 1Pt 2,21-25 d) Comportamento del cristiano nella vita matrimoniale: 1Pt 3,1-7 e) Comportamento del cristiano all'interno della comunità: 1Pt 3,8-12 5) ESORTAZIONE Al CRISTIANI NELLA PERSECUZIONE (1Pt 3,13-5,11) a) Parenesi ai cristiani nella prova ed esempio di Cristo: 1 Pt 3,13-22 b) La sequela in attesa della parusia: 1 Pt 4, 1 - 11 c) La beatitudine di coloro che soffrono con Cristo: 1Pt 4,12-19 d) Parenesi a tutta la chiesa: 1 Pt 5,1-11 6) EPILOGO (1Pt 5,12-14) Le comunità cui la lettera è indirizzata vivono, si diceva, una situazione di crisi o, per usare le parole di Pietro, di «tentazione, prova» (peirasmós: 1,6; 4,12); ciò appare evidente, anche solo a una prima lettura del testo, dalla frequenza con cui l'apostolo ricorre al linguaggio e alle immagini che riguardano la sofferenza, il patire. Ma di cosa si 4 Kairós – La Parola tratta? Il primo pensiero va certamente alle persecuzioni che i cristiani in quest'epoca subiscono, sia a Roma sia in Asia Minore, da parte del potere romano; se anche non si è certi che si tratti di vere e proprie persecuzioni organizzate, occorre in ogni caso pensare all'ostilità e alla diffidenza nutrita dai pagani verso la recente e minoritaria fede cristiana, vista come superstitio nova et malefica (Svetonio). Ma la nostra lettera pare riferirsi anche a qualcosa d'altro, forse ancora più delicato: le comunità cristiane alla fine del 1 secolo d.C. si trovavano ad affrontare la crisi della scomparsa della generazione apostolica, quella che aveva mediato di persona il legame con Gesù Cristo e, di conseguenza, col primo fiorire della forma vitae cristiana. La reazione a tale crisi si configurava probabilmente come un indurimento della forma istituzionale, forse anche con il rischio di comportamenti autoritari da parte di chi presiedeva le comunità cristiane. L’esistenza di tali pericoli è rivelata dal modo in cui la nostra lettera, richiamandosi all'autorità di Pietro, tenta di operare un'interpretazione in termini nuovi della vicenda cristiana, o meglio di riportarla alla sua freschezza iniziale: si ricorda che la chiesa (si noti che mai viene usato il termine ekklesía!) è una fraternità (1Pt 2,17; 5,9), che essa è una comunione di comunità che vivono in condizione di paroikía (1Pt 1,17), cioè di pellegrinaggio, che i cristiani sono pároikoi kaì parepídemoi (1Pt 2,11), stranieri che risiedono temporaneamente in questo mondo. E, elemento decisivo, l'unico vescovo (epískopos: IPt 2,25) di queste comunità è Gesù Cristo, «il Pastore dei pastori» (archipoimen: 1Pt 5,4), che tutte le guide delle comunità sono chiamate a prendere a modello. Questa esemplarità di Cristo è posta peraltro davanti agli occhi di tutti i cristiani, che sono esortati a mettersi in cammino dietro a lui: «Cristo soffrì per voi, lasciandovi un esempio, affinché ne seguiate le tracce» (1Pt 2,21)! 5 Kairós – La Parola LA DIFFERENZA CRISTIANA RADICATA NELLA RESURREZIONE DI CRISTO (1Pt 1,1-12) Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti stranieri nella diaspora nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia,[eletti] secondo la preconoscenza di Dio Padre attraverso la santificazione dello Spirito, i . n vi . sta dell'obbedienza e dell'aspersione del sangue di Gesù Cristo: grazia e pace a voi in abbondanza. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po’ afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell’oro che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata cercando di indagare a quale momento o a quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il vangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo 6 Kairós – La Parola L'indirizzo è assimilabile a quello delle altre lettere apostoliche, contrassegnato da mittente e destinatari cui è rivolto il saluto. La sua singolarità consiste nel mettere in rilievo la «stranierità» quale cifra della differenza cristiana: se noi cristiani non siamo capaci di vivere tale differenza rispetto agli altri uomini, cosa possiamo pretendere di comunicare loro, o come possiamo pensare di compiere qualcosa per loro? Tale incipit ci interroga anche sull'oggi della chiesa di Dio: perché temere il fatto di essere nuovamente una minoranza nella società, se questo non è altro che un ritorno alla situazione originaria della chiesa? Il Signore Gesù torna a direi: «Non temere, piccolo gregge ... » (Lc 12,32). All'indirizzo iniziale segue la benedizione, secondo un procedimento tipicamente giudaico, poi ereditato dagli autori neotestamentari. Questa benedizione compendia la storia di salvezza nell'oggi del credente che ama Cristo, e in questo modo ci pone una domanda semplice ma essenziale: abbiamo ancora il coraggio di trasmettere alle nuove generazioni cristiane la centralità assoluta dell'amore per Cristo, un amore forte, virile, appassionato? 1Pt 1,1-2 Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti stranieri nella diaspora nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia,[eletti] secondo la preconoscenza di Dio Padre attraverso la santificazione dello Spirito, i . n vi . sta dell'obbedienza e dell'aspersione del sangue di Gesù Cristo: grazia e pace a voi in abbondanza. Pietro l'apostolo In apertura della lettera, è sufficiente che l'autore si presenti quale Pietro, l'apostolo di Gesù Cristo, perché tutti i cristiani lo identifichino, ne rievochino la storia e la testimonianza, ne 7 Kairós – La Parola riconoscano la funzione di capo dei Dodici e quindi il ruolo eminente che egli ha nella chiesa apostolica, per un preciso mandato del Signore. Sappiamo che il suo nome originario era Shim'on, ma Gesù gli diede il nome di Kefa', «Roccia», tradotto poi in greco con Pétros (cfr. Mt 16,17-18; Gv 1,42) nel momento in cui la chiesa intraprendeva la sua missione in mezzo ai pagani. Egli si definisce apóstolos, cioè inviato di Gesù Cristo; più avanti si dirà mártys, testimone delle sofferenze di Cristo, anziano, anzi co-presbitero, infine padre (ossia maestro) di Marco, che è con lui a Babilonia, cioè Roma (cfr. 1Pt 5,13). Tale identificazione del mittente mostra la consapevolezza di una vera autorità apostolica: chi ha intestato questa lettera a Pietro sapeva di avere un'autorità, in forza della quale poteva scrivere da Roma a comunità lontane dell'Asia Minore, forse comunità visitate da Pietro stesso (cfr. 1Cor 1,12). I cristiani, eletti e stranieri L'indirizzo della lettera è altamente significativo perché la designazione dei destinatari, pur così vaga a livello di identificazione e provenienza geografica, è molto precisa a livello di identità spirituale. Essi sono definiti come segue (1Pt 1,1): - «eletti» (eklektoi); - «stranieri nella diaspora» (parepidemoi diasporás), cioè coloro che abitano presso un popolo non loro. C'è qui una vera ermeneutica dell'esistenza cristiana nel mondo. I cristiani sono presentati mediante l'accostamento di due termini che evocano la tensione dialettica vissuta dai credenti, in una chiara coscienza che oggi purtroppo è andata perduta: i cristiani sono eletti, scelti, separati da parte di Dio, come il popolo dell'AT, scelto tra tutti gli altri popoli (cfr. Dt 7,6; Am 3,1-2), come gli «eletti di Dio» della comunità di Qumran. E’ proprio questa appartenenza a Dio li rende 8 Kairós – La Parola «stranieri nella diaspora»: ecco la differenza cristiana, ciò che distingue i cristiani dagli altri uomini. E si faccia attenzione alla forza di questo accostamento lessicale: «stranieri nella diaspora», stranieri disseminati, che non danno vita neppure a una colonia in mezzo agli altri uomini! La scelta di Dio separa a tal punto gli eletti dalla mondanità che costoro, vivendo in modo inedito, appaiono stranieri ai loro concittadini, senza patria nel tempo e nello spazio. E’ la scelta, l'elezione che li rende tali. I cristiani sono dunque parepídeimoi, cioè «soggiornanti in terra straniera», «forestieri»; a questo termine è legato anche il concetto di paroikia (cfr. 1 Pt 1, 17), che indica «l'abitare accanto», in condizione di residente di passaggio, il cui contrario, katoikia, designa invece «l'abitare nel proprio paese» (cfr. Nm 24,2 l; 1 Cr 7,28). I due vocaboli parepidemos e pároikos, presenti più oltre in forma di endiadi (1 Pt 2,1 l; cfr. Lv 25,23), sono già attestati, secondo la versione greca dei LXX, in passi significativi dell'AT. Quando, p. es., Abramo dichiara di risiedere di passaggio e da forestiero tra gli ittiti, lo fa definendosi pároikos kaì parepidemos (Gen 23,4); nel Sal 38,13 il salmista chiede a Dio di ascoltare la sua preghiera, perché egli è un forestiero, uno straniero davanti a lui (pároikos... kai parepidemos), come tutti i suoi padri; David, in 1Cr 29,15, nella sua preghiera di benedizione e ringraziamento a Dio, riconosce che tutti i figli di Israele sono forestieri e pellegrini (pároikoi... kaì paroikoúntes) davanti a Dio. Anche la chiesa cristiana primitiva si definirà paroikoúsa, forestiera nelle città di questo mondo (cfr. Martirio di Policarpo, prologo; Clemente di Roma, Prima epistola ai Corinzi, proemio), e un famoso passo dell'A Diogneto (5,5) giungerà a descrivere i cristiani come coloro che «abitano una loro patria, ma come forestieri (pároikoi); a tutto partecipano come cittadini e a tutto sottostanno come stranieri; ogni terra straniera è patria per loro e ogni patria è terra straniera». Ma possiamo scorgere le radici di tale concezione cristiana 9 Kairós – La Parola proprio nella nostra lettera, il cui autore è sedotto dall'idea della stranierità (cfr. IPt 1,17), al punto da farne il sottofondo dell'intera sua comunicazione di fede. Per quanto riguarda la parola «diaspora», nei LXX è la denominazione usata per indicare la dispersione del popolo di Dio tra le genti pagane. Tale dispersione dapprima venne sentita come un castigo di Dio, causato dall'inadempienza da parte di Israele delle clausole dell'alleanza e strettamente legato alla distruzione di Gerusalemme (cfr. Dt 28,54; 30,1-5; Ger 34,17-22). In seguito essa fu recepita come benedizione, perché comportò la «semina» di Israele nel mondo e la possibilità della confessione e dell'annuncio del Dio unico a tutte le genti e a tutte le culture (cfr. 1Mac 15,15-24). E’ proprio questa seconda accezione di diaspora che è assunta dalla chiesa nascente per qualificare la propria presenza nel mondo, contraddistinta da mancanza di patria nel tempo e nello spazio. La chiesa vive come una minoranza tra i non cristiani, in una situazione esposta e difficile, ma anche piena di possibilità positive, coerente con la sua vocazione alla testimonianza. E qui si faccia attenzione: i cristiani sono stranieri non perché considerano il mondo cattivo, non perché se ne separano con disprezzo, non perché il mondo li ripudia, ma perché essi, mediante l'elezione di Dio, sono stati sottratti al mondo. Eletti-stranieri è un binomio pieno di tensione tra storia salvifica e storia profana: non vi è cittadinanza per i cristiani nel mondo, perché la loro cittadinanza vera, il loro stile di vita è nei cieli (cfr. Fil 3,20; Eb 11,13-16; 13,14; A Diogneto 5,9) ed essi non possono avere alcuna patria che non sia il regno di Dio! Si tratta dunque di mettere in atto quel movimento delicatissimo contenuto nelle parole di Gesù: «stare nel mondo senza essere del mondo» (cfr. Gv 17,11-16). 10 Kairós – La Parola Dal Padre, nello Spirito, per il Figlio L'elezione, che colloca i cristiani come «stranieri nella diaspora», riposa sulla «preconoscenza» (prógnosis) di Dio, ossia la sua volontà, in quanto conoscenza efficace che crea ed elegge (cfr. Rm 8,29-30). Ma Pietro approfondisce tale elemento, fino a creare una straordinaria formula trinitaria (IPt 1,2), in cui l'elezione: - avviene secondo la preconoscenza di Dio Padre (katà prógnosin theoú patrós), vero principio e fondamento della fede del credente; - si attua attraverso la santificazione dello Spirito (en haghiasmó pnetimatos), energia che può santificare l'uomo; - è compiuta in vista dell'obbedienza di/a Gesù Cristo (eis hypakoèn lesoú Christoú): l'obbedienza di Gesù al Padre conduce il credente a obbedire allo stesso Cristo. E tale azione trinitaria culmina, non a caso, nell'«aspersione del sangue di Gesù Cristo (eis rantismòn haimatos Iesoù Christoù), immagine dal sostrato veterotestamentario (cfr. Es 24,8), evocata per indicare la Nuova Alleanza, quella celebrata dai cristiani nel battesimo e nell'eucaristia. Si noti, in sintesi, l'estrema densità del v. 2: un rinvio all'elezione che ha origine nello spazio della Triunità di Dio e giunge ad aprirsi allo spazio ecclesiale. E agli eletti che fanno parte di questo luogo itinerante che è la comunità cristiana sono infine indirizzate «grazia e pace»: cháris kaì eiréne, ossia l'amore di Dio, fonte di ogni dono, e lo shalom, la vita piena, binomio che riassume in sé l'intera esperienza di salvezza. La benedizione trinitaria Dopo il saluto, Pietro innalza la sua benedizione a Dio, dal quale dipendono il messaggio contenuto nello scritto e la sua buona accoglienza da parte dei destinatari. Si tratta di una benedizione tanto ricca nei contenuti quanto intricata nell'esposizione. E’ però possibile risolvere la complessità di 11 Kairós – La Parola questo testo attraverso l'individuazione di una struttura portante dall'andamento trinitario. Dio è benedetto: - perché ci ha rigenerati in vista di una speranza viva e di un'eredità incorruttibile attraverso la resurrezione di Gesù Cristo (Dio Padre il rigeneratore: vv. 3-5); - l'azione del Padre ci colma di gioia, nonostante le prove, grazie all'amore che proviamo per Gesù Cristo (Gesù Cristo l'amato, ossia l'amore per Gesù Cristo: vv. 6-9); - animati da questo amore possiamo conseguire lo scopo della nostra fede, la salvezza profetizzata e testimoniata dallo Spirito santo (azione dello Spirito santo: vv. 10-12). Dio Padre il rigeneratore Dio Padre è dunque benedetto innanzitutto perché ci ha rigenerati, cioè ci ha fatti rinascere nella sua grande misericordia (1Pt 1,3). L’esperienza cristiana è caratterizzata da un novum rispetto all'AT. I figli di Israele sono figli di Dio e Dio è loro Padre (cfr. Dt 14, l; 32,5; Sal 89,27; Is 1,2; Os 11, 1), ma più che di una esperienza, si tratta in questo caso di una condizione vissuta dalla nascita, nel solco delle generazioni. Per i cristiani vi è invece una rigenerazione - certamente fondata sul battesimo, di cui però qui non si parla - presentata quale frutto dell'azione misericordiosa di Dio (cfr. anche Gv 3,3-8 e 1Gv 3,9): ebbene, questa nuova nascita è orientata a una speranza viva che ha il suo fondamento nella resurrezione di Gesù dai morti, ed è questo evento, solo questo evento, la garanzia della nostra fede! Non lo si ripeterà mai abbastanza. Gesù Cristo l'amato, ossia l'amore per Gesù Cristo Vi è una gioia grande, autentica, sperimentata dal cristiano, gioia dovuta alla speranza di cui si è detto sopra, che non viene meno neppure nelle prove, elementi pedagogici e di verifica della qualità della fede; si tratta in ogni caso di prove 12 Kairós – La Parola passeggere, al termine delle quali la fede, ora provata come nel fuoco, si rivelerà a lode, gloria e onore dei credenti, nell’ora dell'apocalisse. dell'apokálypsis, della manifestazione di Gesù Cristo (1Pt 1,7). Con grande audacia - che nel NT conosce un parallelo solo in 1Cor 16,22: «Chi non ama il Signore sia anàtema» -Pietro sottolinea che questa gioia si esprime soprattutto nell'amare Gesù Cristo: «Voi amate Gesù Cristo senza averlo visto e credete in lui, senza per ora vederlo» (1Pt 1,8). La relazione vitale che intercorre tra il credente e Cristo è una relazione d'amore. Come i credenti dell'AT sono quelli che amano Dio, fino ad essere definiti «amanti del Nome» (Sal 5,12; 69,37; 119,132), così i cristiani sono quelli che amano personalmente Gesù e aderiscono a lui incondizionatamente, pur senza averlo visto: «Beati quelli che senza avere visto crederanno!» (Gv 20,29). E Paolo, in 2Cor 5,16, fa eco: «Se anche avessimo conosciuto Cristo secondo la carne, oggi non lo conosciamo più così». Il cristiano ne è consapevole: non ha visto Gesù vivente, e questo può essere per lui motivo di frustrazione, ma lo vedrà presto. D'altronde, il suo amore per Cristo significa che la sua fede non è quella di un militante fede posta in una ideologia, in un'utopia -, ma è adesione a una persona vivente! Il cristiano è chiamato ad amare con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze non soltanto Dio (cfr. Dt 6,5), ma anche Gesù di Nazaret, Dio e uomo, costituito Signore e Messia: la vera passione del cristiano dovrebbe essere quella di amare Gesù Cristo, di giungere a contemplarlo con gli occhi del cuore, nella coscienza che Gesù stesso lo ha visto e lo ha amato per primo! La Chiesa gioisce dunque innanzitutto per questo amore, esulta di gioia su tutta la terra perché ama Gesù Cristo, il quale ritornerà e avrà la sua apocalisse. Questa apocalisse, di conseguenza, non sarà solo rivelazione di Gesù, ma anche della Chiesa come sposa amante, pronta per lo sposo (cfr. Ap 19,7-8; 21,2.9). Solo allora, per la grazia del suo Signore, la Chiesa riceverà lode, gloria e onore, ossia riceverà la sua piena manifestazione 13 Kairós – La Parola Lo Spirito santo all'opera nei profeti e negli evangelizzatori Questa salvezza, che ci è garantita dalla resurrezione dì Gesù e che sarà manifestata nell'ora della sua venuta nella gloria, è un grande anelito dell'uomo, è una brama, addirittura una concupiscenza degli uomini e degli angeli. E questa brama dipende dallo Spinto santo, il desiderio di Dio in noi (cfr. Rm 8,27). Lo Spirito santo era presente nei profeti, i quali proprio grazie a lui potevano indagare e scrutare la salvezza destinata a tutti gli uomini; era presente nei servi della Parola che hanno annunciato l'Evangelo; è presente nell'Evangelo stesso: nei profeti pre-testimoniava, negli annunciatori dell'Evangelo post-testimonia un'unica e medesima realtà, Cristo nella sofferenza e nella gloria. In questo modo la nostra lettera interpreta l'intera storia di saIvezza come una vicenda animata dallo Spirito santo, il quale ha ispirato e continua a ispirare la comprensione della direzione della storia stessa. Questo Spirito santo (I Pt 1, 12) è lo Spirito di Cristo (tò pneúma Christoú: 1 Pt 1, 11) che ha reso i profeti testimoni- ante litteram del mistero pasquale, ed è lo stesso Spirito che ha abilitato gli evangelisti a testimoniare il medesimo mistero. I profeti e gli apostoli sono al servizio dei credenti: vi è un'unità grande e profonda della storia che confluisce nella chiesa, nella comunità dei credenti, gli eletti che conoscono cose che anche gli angeli bramano contemplare (1 Pt 1, 12). In breve: tutto l'AT è pervaso dallo Spirito di Cristo, è riempito da Cristo stesso nella sua esistenza pre-sarchica, prima della sua incarnazione. Cristo preesistente era accanto a Dio prima della fondazione del mondo (cfr. 1Pt 1,20); Cristo ha parlato per mezzo dei profeti, quale oggetto delle profezie (cfr. Gv 8,56; 12,41; Eb 11,26); Cristo è presente all'interno della testimonianza degli evangelizzatori; Cristo verrà nella gloria, portando a compimento la nostra gioia. 14 Kairós – La Parola 1. La condizione del cristiano: l’essere straniero Le parole di indirizzo della nostra lettera dovrebbero interrogarci sulla nostra identità cristiana oggi: ogni cristiano deve farlo, così come ogni comunità e chiesa. Si tratta cioè di sentire questa lettera come indirizzata anche a noi non più insediati nella «cristianità», bensì in una situazione di minoranza tra uomini non cristiani e in massima parte indifferenti al problema religioso. Il mondo in cui noi cristiani siamo collocati è il luogo della grazia di Dio, è il mondo che Dio ama (oggi come ieri, non lo si dimentichi!), ed è in esso che siamo chiamati a vivere da discepoli di Gesù, manifestando la differenza cristiana: non una differenza culturale, ma una differenza di vita, frutto della santificazione operata dallo Spirito santo in noi. Penso a cosa significhi per me oggi vivere come straniero in questo mondo. Come esprimo la “differenza cristiana”? 2. Il fondamento: l’essere rigenerati da Dio in Cristo L’evento della resurrezione, che costituisce la garanzia della vita futura del credente, anzi il suo stesso inizio, rigenera i cristiani in vista di una speranza viva (1Pt 1,3) e di un'eredità incorruttibile (1Pt 1,4): il fatto di essere generati da Dio rende figli, e i figli hanno diritto all'eredità (cfr. Gal 4,7). Non si tratta però di essere eredi della terra, secondo la promessa fatta ai figli nell'AT (cfr. Gen 15,7; Es 32,13), un'eredità corruttibile e caduca. No, l'eredità donata ai cristiani rinati è sicura e certa, perché viene custodita da Dio nei cieli, allo stesso modo in cui Dio stesso custodisce i credenti sulla terra; e poiché questi sono gli ultimi tempi, tale eredità è prossima a manifestarsi, ad avere cioè la sua apocalisse (1Pt 1,5). Non si dimentichi, a tale proposito, la coscienza dei primi cristiani, espressa mirabilmente nella lettera agli Ebrei: 15 Kairós – La Parola Nella fede morirono tutti costoro [i nostri padri], pur non avendo conseguito i beni promessi, ma avendoli visti e salutati da lontano, dichiarando così di essere stranieri e pellegrini sulla terra... Tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, non conseguirono la promessa [fatta ad Abramo]. Dio aveva in vista qualcosa di meglio per noi, perché essi non ottenessero la pienezza senza di noi (Eb 11, 13.39-40). Con quali linguaggi abitualmente so esprimere su me e sul mondo il senso della speranza e del futuro. Cosa significa per me l’esercizio della speranza cristiana? 3. Il fine: la salvezza dell’anima non senza sofferenza «Esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite lo scopo della vostra fede, la salvezza delle vostre vite (psychón)» (1Pt 1,8-9). Fede e amore stabiliscono un legame con Gesù Cristo così forte da innescare un processo di gioia indicibile e gloriosa, nella consapevolezza che qui sta la salvezza della vita nella sua totalità (il concetto greco di psyché corrisponde a quello ebraico di nefesh, ossia il soffio vitale di tutto l'uomo). Noi siamo chiamati a questa salvezza, che è il vero e proprio scopo (télos) della nostra fede, quale salvezza dal peccato, dalle potenze mondane, dalla morte. Tutto ciò avverrà in pienezza nell'apocalisse di Gesù Cristo, alla fine dei tempi: ma la gioia che già oggi canta nel nostri cuori è un'anticipazione di ciò che attendiamo con perseveranza, la certezza che quando il Signore si manifesterà «anche noi saremo manifestati con lui nella gloria» (Col 3,4) e «saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3,2). Riconsidero se il mio stato di vita è abitualmente pensato come uno stato gioioso, di una umanità pienamente realizzata. Mi interrogo su cosa comporti il fatto di un “amare senza vedere” nella quotidianità della vita spirituale. 16 Kairós – La Tradizione LA TRADIZIONE Giuseppe Angelini I FRUTTI DELLO SPIRITO Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, contro queste cose non c'è legge. (Gal 5,23) L’AMORE Il primo dono dello Spirito ricordato da Paolo è quello supremo; anzi quello che da solo riassume nella sua interezza il senso della vita secondo lo Spirito, l'amore. La lingua cristiana, come molte volte è stato sottolineato, ha coniato un termine nuovo per designare l'amore oggetto del comandamento di Dio, e anzi sintesi di ogni comandamento di Dio; infatti agape, il termine al quale il Nuovo Testamento ricorre per dire amore, assume una densità di significato che è senza corrispondenti nella lingua greca precedente. Quella densità di senso è nutrita certo anche dal precedente uso che già la versione greca dei Settanta faceva del termine. È nutrita però soprattutto dal riferimento alla figura dell'amore di Cristo. La decisa ragione di novità che la figura dell'agape mostra rispetto ad ogni altra figura di amore conosciuta in precedenza nella lingua greca non autorizza tuttavia una sbrigativa contrapposizione di essa a tutte quelle figure. Non autorizza, in particolare, quella contrapposizione tra agape ed eros, che viceversa è ripetutamente proposta nella tradizione cristiana tutta. Mentre eros sarebbe l'amore inteso come desiderio, come tensione cioè rivolta al bene capace di saturare l'indigenza del soggetto, agape sarebbe amore oblativo e 17 Kairós – La Tradizione dimentico di sé. Appunto qnesta definizione di agape, prodotta per antitesi rispetto ad eros, alimenta l'illusione della coscienza cristiana che sia possibile amare a procedere, per così dire, univocamente dal cielo; o magari dalla considerazione estatica del modello offerto dal Signore Gesù Cristo; in ogni caso, a procedere da altro luogo rispetto a quello costituito dalle ragioni di prossimità tra gli umani disposte dal rapporto tra uomo e donna, tra genitori e figli, tra fratelli, e in genere dal rapporto civile. Tutte queste forme di prossimità umana apparterrebbero al registro dell'eros, e non dell'agape. Per cercare lo Spirito, che solo consente di vivere davvero, è necessario che l'uomo si strappi all'abitudine e cerchi nella notte. In quella notte, s'intende, nella quale egli si trova come immerso, quando esca dalle luci artificiali e non affidabili, alle quali viceversa si affida la vita di questo mondo. L’espressíone questo mondo ha assunto nella tradizione cristiana, e prima ancora nei testi del Nuovo Testamento, una connotazione decisamente negativa. Questo mondo non è quello creato da Dio; è invece quello creato dagli uomini, e più precisamente dai figli di Adamo. È quello al quale fa riferimento la vita comune della città. È quello la cui consistenza pare scontata, capace cioè di tenersi ferma e sicura a prescindere dalla qualità delle scelte di ciascuno. Quando l'espressione sia così intesa, questo mondo appare come fonte di illusione e di inganno. Per vivere l'uomo deve usci re da esso. Il programma radicale della fuga mundi non è certo soltanto moderno. Esso è chiaramente proposto dalla prima forma assunta dalla vita religiosa; da quella che soltanto poi sarà chiamata vita religiosa. Ci riferiamo alla forma di vita prospettata dal monachesimo. Fino ad oggi, il monaco occidentale, iscritto nella tradizione benedettina, tra gli altri 18 Kairós – La Tradizione voti (obbedienza e stabilità del luogo) professa questo, della conversio morum, della conversione dunque dei costumi: una tale conversione non si consuma mediante la scelta iniziale di un giorno, ma chiede la quotidiana ripresa. Il monaco non fugge da questo mondo una volta sola; all'iniziale fuga visibile segue una fuga interiore, realizzata mediante la correzíone dei pensieri, delle fantasie, dei desideri, delle passioni, che dura tutta una vita. L’amore secondo l'Imitazione dl Cristo Alla visione della vita quale fuga mundi si riferisce con insistenza l'ideale cristiano proposto dalla spiritualità del Medio Evo. Nel trapasso dalla stagione medioevale a quella moderna si colloca la cosiddetta devotio moderna. Questa corrente di spiritualità è ispirata prossimamente dalla tradizione cisterciense e insieme da quella francescana. Più remotamente, dipende da quella tradizione di Agostino, che segna profondamente tutto il cristianesimo occidentale; ci riferiamo qui in particolare alla visione della vita cristiana quale vita interiore, sequestrata cioè rispetto alla inaffidabile esteriorità dei rapporti mondani. Non uscire fuori, ma rientra in te stesso. Essa lascia il segno più profondo nella storia della spiritualità moderna attraverso l'Imitazione di Cristo, Appunto da questo libretto scegliamo tre pagine, che illustrano la figura dell'amore quale frutto dello Spirito. Chi segue me non cammina nelle tenebre, dice il Signore. Queste sono le parole con le quali Cristo ci raccomanda di imitare la sua vita e i suoi costumi; soltanto in tal modo saremo illuminati e finalmente liberati da ogni cecità del cuore. La nostra cura suprema sia dunque questa, meditare sulla vita di Gesù. Il suo insegnamento 19 Kairós – La Tradizione supera quello di tutti i santi, e chi avesse il suo Spirito vi troverebbe una manna nascosta. Accade però che molti, pur ascoltando spesso il Vangelo, sentano un desiderio piccolo; la ragione è che essi non hanno lo Spirito di Gesù. Chi vuole comprendere in pienezza le parole di Cristo e gustarne il sapore, deve cercare di conformare tutta la sua vita a Lui. Non sono infatti le parole alte e profonde a fare l'uomo giusto e santo; è invece la vita virtuosa che rende l'uomo caro a Dio. Serve assai più sentire compunzione che conoscerne la definizione. Di che vantaggio sarebbe conoscere tutta la Bibbia e tutti i detti dei filosofi, senza amore e senza la sua grazia? Vanità delle vanità, tutto è vanità, tranne che questo, amare Dio e servire Lui solo. In questo consiste la sapienza suprema: tendere al regno celeste mediante il disprezzo del mondo. [ ... ]. Ricorda spesso quel proverbio che dice: l'occhio non si sazia mai di vedere, né l'orecchio mai di udire. Cerca dunque di staccare il tuo cuore dall'amore delle cose visibili e di passare a quelle invisibili. Coloro che seguono la voce dei sensi esterni infatti macchiano la propria coscienza e perdono la grazia di Dio. «Ricorda spesso quel proverbio che dice: l'occhio non si sazia mai di vedere, né l'orecchio mai di udire». Contro questo desiderio vago propone una lotta strenua la devotio moderna. Essa raccomanda con insistenza ossessiva di chiudere gli occhi sul mondo intero, e aprire invece il libro santo. La figura dell'amore proposta in quello scritto, descritta come imitazione di Cristo, non fa riferimento alle opere proposte dal rapporto con il prossimo, il servizio dunque, il perdono, la misericordia. Quantomeno, non procede dalla considerazione di questo rapporto, per determinare la qualità 20 Kairós – La Tradizione dell'amore. La figura dell'amore è invece descritta come esercizio assiduo, quasi ostinato, della meditazione del testo evangelico. Le immagini proposte dal libro sacro, conosciute a memoria, dovrebbero dare forma ad un altro mondo, più sicuro rispetto a quello variopinto e vago, che gli occhi inseguono. Immagine sintetica della vita diventa dunque l'imitazione di Cristo, appunto; soltanto chi segue me non cammina nelle tenebre, dice il Signore; soltanto in tal modo saremo illuminati e finalmente liberati da ogni cecità del cuore. La cura suprema della vita diventa «meditare sulla vita di Gesù». Attraverso una tale meditazione è possibile guadagnare «il suo Spirito», trovare in tal modo la «manna nascosta», la quale sola consente di vivere e non morire nel deserto di questo mondo. Non basta certo soltanto meditare. Accade infatti che molti, pur ascoltando spesso il Vangelo, sentano un desiderio piccolo; essi non hanno lo Spirito di Gesù. Chi vuole comprendere in pienezza le parole di Cristo e gustarne il sapore, deve cercare di conformare tutta la sua vita a Lui. «Serve assai più sentire compunzione che conoscerne la definizione», avverte il libro. Questa figura della compunzione costituisce una virtù caratteristica della tradizione spirituale monastica. Soltanto quello che punge l'animo, che trafigge, anche edifica. Non edificano nulla invece le parole, le quali saziano il desiderio di sapere. Come si vede, l'amore cristiano è definito in prima battuta quale amore di Dio. L'amore cristiano è quello al quale dà espressione chiara il comandamento supremo: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Gesù stesso effettivamente dice che proprio questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Gesù aggiunge però un secondo comandamento, qualificato 21 Kairós – La Tradizione come simile al primo, amerai il prossimo tuo come le stesso; non si deve forse riconoscere che questo comandamento, pure soltanto secondo, non può essere aggiunto in seconda istanza al primo, ma concorre fin dall'origine a definire il senso del primo? Beato colui che comprende che cosa sia amare Gesù, e che cosa sia disprezzare se stesso a motivo di Gesù. Occorre lasciare il diletto a favore dell'unico diletto; Gesù vuole essere amato in maniera esclusiva e al di sopra di tutte le cose. L’amore della creatura inganna ed è molto precario; l'amore di Gesù è fedele e perseverante. Chi aderisce alla creatura caduca, con essa cade; chi abbraccia Gesù, rimane fermo per sempre. Lui soltanto dunque sia il tuo amore e tienilo stretto come un amico; quando tutti ti lasceranno, egli non ti lascerà, non permetterà che tu muoia per sempre. Da tutte le cose infatti, che tu lo voglia o no, dovrai alla fine separarti. Tieniti stretto accanto a Gesù, sia che tu viva sia che tu muoia; affidati all'amore fedele di colui che solo può esserti di aiuto, quando tutti gli altri verranno meno. Il tuo amato è fatto così, non ammette che ci siano altri, vuole possedere da solo tutto il tuo cuore e sedere in esso conie siede un Re sul suo trono. Se tu sapessi fare il vuoto di ogni creatura, allora Gesù con desiderio dovrebbe venire ad abitare presso di te. Scopriresti che tutto è perduto, ciò che è affidato agli uomini e non a Gesù. Non fidarti dunque e non appoggiarti su una canna che oscilla al vento, perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria cadrà come il fiore del campo. Sarai presto deluso, se guarderai soltanto all'apparenza esteriore degli uomini. Se cerchi il tuo sollievo e il tuo guadagno negli altri, sempre da capo sentirai ch'esso 22 Kairós – La Tradizione vien meno. Se invece cercherai Gesù in tutte le cose, certo lo troverai. Se cerchi te stesso, anche troverai te stesso, per la tua rovina. Nuoce infatti l'uomo a se stesso più di ogni altro, più che il mondo intero e di tutti i suoi avversari, quando non cerchi Gesù. La riflessione dell'Imitazione di Cristo si riferisce qui in maniera precisa all'amore per Gesù stesso. Un tale amore è posto in antitesi nei confronti di ogni altro amore umano. Ogni altro amore è ricondotto infatti alla categoria del diletto, inteso come piacere, o compiacimento; al diletto così inteso è contrapposta la figura dell'unico Diletto, che è appunto lo stesso Signore Gesù Cristo. Questa antitesi sorprende e lascia perplessi. Effettivamente c'è motivo per essere perplessi. C'è però motivo per essere perplessi anche di fronte a parole di Gesù, che, almeno ad una prima lettura, sembrano assai prossime a quelle proposte dall'Imitazione di Cristo. Ci riferiamo in particolare alla dichiarazione perentoria che Gesù propose nel giorno in cui vide che molta gente andava con lui. Egli parve quasi scoraggiare questa gente, e disse: Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo (Lc 14,26-27). Il rischio che la nostra fede abbia dubbio bisogno del conforto di una compagnia, per sussistere, è assai consistente. Mentre l'amore che è dono dello Spirito deve di necessità passare attraverso la strettoia della solitudine. Soltanto a condizione di essere passati attraverso quella porta stretta, sarà possibile riconoscere anche la verità 'profetica' di ogni altro affetto umano. Gesù risorto, presso il lago di Tiberiade, 23 Kairós – La Tradizione chiederà a Pietro: Mi ami più di costoro? Soltanto a seguito della sua risposta positiva, Gesù conferma a Pietro la sua vocazione: Seguimi. In quel momento, nota il vangelo, Pietro si volse indietro a guardare quel discepolo che Gesù amava; chiese allora al Maestro: Signore, e lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi (cfr. Gv 21,19-22). Il breve dialogo suggerisce in maniera efficace quale sia la verità della meditazione dell'Imitazione di Cristo. L’amore di Gesù chiede di passare attraverso la prova della solitudine. Il senso di questa necessità è più diffusamente illustrato in un ulteriore passo dell'Imitazione di Cristo, che di seguito riportiamo. In esso l'amore di Gesù è posto in alternativa rispetto all'amore dell'amico, dunque all'amore che si nutre di consolazioni sensibili. E tuttavia è poi riconosciuto come anche le consolazioni spirituali assumano consistenza di consolazioni sensibili; non potrebbe trattarsi di consolazioni, se non sensibili. È in tal modo descritta, affidandosi alla traccia suggerita da un salmo (il Salmo 30), un'esperienza, che certo è di sempre, che tuttavia assume consistenza particolarmente insistente nell'esperienza della persona moderna. La solitudine pare imposta a questa persona dalla rarefazione di quel tessuto di relazioni civili, che un tempo pareva assegnare con più sicura univocità al singolo un nome, una figura, e quindi anche compiti relativamente precisi e da tutti riconosciuti. Pareva assegnare al singolo - come oggi si dice - un'identità. La rarefazione delle relazioni sociali opera per se stessa nel senso di consegnare il singolo al criterio del sentire per cercare la propria identità sfuggente. Appunto questa circostanza espone il singolo all'esperienza di vertiginose oscillazioni. Lo stato d'animo è quasi tutto. Il rimedio a tale precarietà della vita, e dello stesso rapporto religioso, è cercato, dall’Imitazione di Cristo, nella direzione 24 Kairós – La Tradizione immediata ed esclusiva della fede, dell'invocazione dunque, che assume la forma del grido. Questo rimedio è certo, alla fine, quello radicale. E tuttavia esso non può azzerare l'altra via, quella volta alla rinnovata scoperta del vincolo di prossimità che da sempre lega gli umani gli uni agli altri. Il carattere immediato ed esclusivo della via tutta interiore della preghiera minaccia di immunizzare il credente nei confronti di un compito, al quale invece egli non può sottrarsi, in particolare per praticare il comandamento dell'amore; quello appunto di ritrovare le ragioni di prossimità con i suoi fratelli. L’esperienza della vita entro una cella, propria dei monaci, e propria della stessa devotio moderna, anticipa i tratti di un'esperienza destinata a divenire comune nella nuova situazione civile; minaccia insieme di proporre di tale esperienza una comprensione intempestivamente escatologica. Per amore di Dio, impara a staccarti anche dall'amico che ti è caro e necessario. E non considerare cosa grave l'essere abbandonato da un amico; dovresti infatti sapere bene che noi tutti dobbiamo alla fine separarci gli uni dagli altri. Grande e lunga è la lotta che l'uomo deve combattere dentro di sé, prima che impari a superare pienamente se stesso e verso Dio volga consicurezza tutto il suo affetto. Fino a che l'uomo rimane piegato su se stesso, scivola con facilità sulle consolazioni umane. Colui invece che davvero ama Cristo, che segue con amore tutte le virtù, non inciampa su quelle consolazioni, non cerca dolcezze sensibili; cerca invece esercizi difficili e sostiene dure fatiche a motivo di Cristo. Quando accada che ti sia concessa da Dio una consolazione spirituale, accoglila con gratitudine; considera però sempre che essa è dono di 25 Kairós – La Tradizione Dio, non invece tuo merito; e dunque non ti esaltare. Non gioire troppo, non abbandonarti a vane presunzioni; sii piuttosto ancor più umile a motivo del dono, ancor più cauto e timoroso in tutti i tuoi atti, perché passerà quell'ora e da capo verrà la prova. E quando la consolazione ti è tolta, non scoraggiarti subito; con umiltà e pazienza attendi la nuova visita del cielo, perché Dio può farti da capo dono di una grazia e di una consolazione ancora più grandi. Questa non è cosa nuova e inaudita per coloro che hanno esperienza dei cammini di Dio. Nei grandi santi e nei profeti antichi spesso c'è stata questa esperienza alternante. Uno di essi, vivendo un momento di grazia, così esclamava: Nella mia prosperità io ho detto: Non sarà scosso in eterno. Venendo poi a mancare la grazia prima conosciuta, aggiunge: quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato. Non si dispera però nel momento in cui vive una tale esperienza, piuttosto invoca con più insistenza e dice: A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio. Alla fine raccoglie il frutto della sua preghiera e rende testimonianza d'essere stato esaudito: Il Signore ha ascoltato è ha avuto pietà di me; Egli si è fatto mio aiuto. In che modo? Hai convertito il mio pianto in gioia e mi hai rivestito di letizia. 26 Kairós – La Preghiera LA PREGHIERA CANTICO 1 Cr 29,20-13 SOLO A DIO L’ONORE E LA GLORIA “Dio Padre resuscitò Cristo dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro. (Efesini 1,20-21) Questo intenso cantico di lode, che il Libro delle Cronache pone sulle labbra di Davide, ci fa rivivere l’esplosione di gioia con cui la comunità dell’antica alleanza salutò i grandi preparativi fatti in vista della costruzione del tempio. Rileggendo dopo secoli quell’evento, il Cronista intuisce i sentimenti di Davide e quelli di tutto il popolo, la loro gioia e la loro ammirazione per quanti avevano dato il loro contributo. Ma non si sofferma che brevemente sulla soddisfazione umana, per porre subito al centro dell’attenzione la gloria di Dio: Tua, Signore, è la grandezza… tuo è il regno… La grande tentazione che sta sempre in agguato, quando si realizzano opere per il Signore, è quella di mettere al centro se stessi, quasi sentendosi creditori di Dio. Davide, invece, attribuisce tutto al Signore. Non è l’uomo, con la sua intelligenza e la sua forza, l’artefice primo di quanto si è realizzato, ma Dio stesso. Davide esprime così la profonda verità che tutto è grazia. Di qui lo slancio contemplativo di questi versetti. Sembra che 27 Kairós – La Preghiera all’autore del cantico non bastino le parole, per confessare la grandezza e la potenza di Dio. Egli lo guarda innanzi tutto nella speciale paternità mostrata a Israele, nostro padre. E’ questo il primo titolo che esige la lode. Lo sguardo dell’autore si allarga poi al cosmo intero: Tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Tutto ciò che di bello e di grande l’uomo sperimenta, deve essere riferito a Colui che è all’origine di ogni cosa e tutto governa. La preghiera scandita in questo Cantico riporta l’uomo alla sua dimensione di “povero” che tutto riceve. Sii benedetto, Signore Dio di Israele, nostro padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Tuo è il regno, Signore; tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria; tu domini tutto; nella tua mano c’è forza e potenza; dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo E lodiamo il tuo nome glorioso. Preghiamo. Insegnaci, Signore, a riconoscere ogni giorno la tua paternità e la tua grazia. Donaci un cuore povero capace di accogliere con gioia i frutti dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. 28 Kairós - Recensioni SE CERCHI UN LIBRO Nelle braccia di Maria. La via dell´abbandono all´amore di Dio Slawomir Biela Città Nuova € 14.00 "L´abbandono di Maria alla volontà del Padre, che sulla croce intimamente si unisce a quello abissale del Figlio crocifisso e abbandonato, è , infatti tutto e solo un abbandono all´Amore. L´abisso chiama l´abisso. Le parole del Salmo sembrano ritmare queste pagine, alla fine indicandoci in Maria, abisso dell´umiltà amorosa che in sé attira e accoglie, per tutta l´umanità, l´abisso dell´amore infinito della Trinità Santa, l´icona della Chiesa e, in essa, di ciascuno di noi Il roveto che arde Giuseppe Cremascoli Città Nuova € 9.00 Il roveto che arde è il simbolo del rapporto di ogni creatura con il Creatore nella quotidianità e, dunque, del valore incorruttibile di tutto ciò che accade perché in relazione con l´Eterno. Secondo questa prospettiva, l´Autore osserva e medita su fatti e realtà di oggi - dai grandi avvenimenti "celebrati" dalla cronaca agli episodi più insignificanti offrendo al lettore piccole, preziose perle di riflessione. La lettura di questi brevi capitoli diventa occasione per arrestare il tempo che fugge e costruire un´oasi di meditazione nella frenesia della vita quotidiana. 29
Scarica