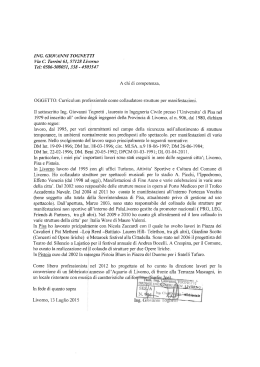1 GIACOMO BEZZI GUIDA RAPIDA DELLA COSTA ETRUSCA (un viaggio ideale da Cecina a Tirrenia con visita della città di Livorno) 2 INDICE DEI CAPITOLI DELLA GUIDA RAPIDA DELLA COSTA ETRUSCA DA CECINA A TIRRENIA CON VISITA ALLA CITTÀ’ DI LIVORNO UNO SGUARDO D’INSIEME A TANTI PERCHÉ ******************************************* 1 LE VIE D’ACCESSO AUTOSTRADALI, QUELLE FERROVIARIE... 2 ...E LA REGINA DELLE STRADE: IL TRATTO PISANO... ...E QUELLO CECINESE 1° ITINERARIO CLASSICO 3 CECINA: DALLA PRIVATA LUXURIA ALLA FERROVIA CHE NON C’E’ PIÙ’ 4 VADA: LE SECCHE E LA SABBIA BIANCA 5 ROSIGNANO : FRA SODA CAUSTICA E CIMELI ETRUSCHI 6 CASTIGLIONCELLO: DA LUOGO DI DELIZIE ELLENISTICHE A TERRITORIO PER VIP (O PRESUNTI TALI) 7 QUERCIANELLA: UN CASTELLO PER IL MINISTRO DEGLI ESTERI 8 SULLE RAMPE DEL ROMITO: INCONTRI RAVVICINATI 9 UN PASSO INDIETRO: LA SCUOLA DI CASTIGLIONCELLO 10 MONTENERO: DUE DIVI DELL’OPERA ED UN SANTUARIO PER TUTTA LA REGIONE 11 UN PO’ DI SOCIOLOGIA: A LIVORNO TUTTO E’ GRANDE: VIE, PIAZZE, PALAZZI, TEATRI , CINEMA E SPAZI PORTUALI 3 2° ITINERARIO CLASSICO 12 UN LUNGOMARE SIGNORILE CON BARACCH(IN)E, RICORDI DI PITTORI, CAVALIERI E CALCIATORI 13 L’ACCADEMIA NAVALE, UN AMMIRAGLIO TESTARDO ED UN LAZZARETTO CHE NON C’E’ PIÙ’ 14 ALTRI LAZZARETTI, UNA FONTE DI ACQUA VIVA E LA VILLA DELL’AMMIRAGLIO 15 I BAGNI DIPINTI DA FATTORI E LA TERRAZZA DEL MUSICISTA CONTESTATO 16 LO SCOGLIO DELLA REGINA, I SOGNI TURISTICI E LA REALTÀ’ SUGLI SCALI DEL CANTIERE NAVALE 17 TRE EMBLEMI DELLA LIVORNESITA’: IL FOSSO REALE, I QUATTRO MORI E LE FONTANE DEL TACCA 18 LA FORTEZZA VECCHIA: DA FORTILIZIO PISANO A PALCOSCENICO PER BALLETTI 19 UN’ALTRA GRANDE FORTEZZA, LA NUOVA VENEZIA E LA CITTÀ’ MULTIETNICA 20 TRE CHIESE PER TRE RITI, UNA REPUBBLICA DIMENTICATA, IL MERCATINO DEI SURPLUS ED UN MASCAGNI PRODUTTORE DI MOTOCICLETTE 21 PIAZZA DECHIRICHIANA, TRE MONUMENTI A DUE GRANDUCHI, CISTERNINI E CISTERNONI 22 IL LEONE DI SAN MARCO IN DIFESA DELLA REPUBBLICA, UNA SCISSIONE FAMOSA ED UN CANALE (TEORICAMENTE) NAVIGABILE APPENDICE 23 LA CITTÀ’ MULTIETNICA A TAVOLA: DA UNA ZUPPA TURCA A UN CAZZOTTO INGLESE ED AL PARMIGIANO SUL NERO DI SEPPIA ELOGIO DEL CACCIUCCO, DEL PONCE E DEGLI ALTRI PIATTI DI LIVORNO 24 SOPPRESSATE GIGANTESCHE E LA EX NUORA DELLA REGINA P.R.-WOMAN DEL SASSICAIA 4 ELOGIO DEL CINGHIALE E DEI VINI ELOGIO DELL’OLIVA E DEL SUO OLIO L’AUTORE SENTE IL DOVERE DI RINGRAZIARE : • il Consorzio Tirreno Promo Tour - Cècina • la Coop. Caesar - Cècina • l’APT di Livorno e Costa degli Etruschi - Livorno • 30 Giorni, rivista mensile - Livorno • l’Agenda di Livorno millenovecentonovantanove, Giuliani Comm. Ed.-Livorno • Slow-Food ed. - Bra-CN • Aldo Santini • la Guida Turistica d’Italia, Ist. Geogr. De Agostini - Novara • Il Sommelier, rivista bimestrale della FISAR - Pisa • Tribuna Economica, notiziario mensile della CCIAA - Livorno 5 UNO SGUARDO D’INSIEME A TANTI PERCHÉ 1 LE VIE DI ACCESSO AUTOSTRADALI... ************************************* er chi vuol recarsi a Livorno per - ad esempio - un imbarco sui traghetti per la Sardegna, la P Corsica o le Isole dell’Arcipelago Toscano, le vie autostradali da percorrere sono per sommi capi le seguenti: • se proviene dall’area fiorentina - e, conseguentemente, da quella bolognese o dal resto d’Italia toccato dall’Autostrada del Sole - deve percorrere l’autostrada A11 fino a Pisa Nord, innestarsi sulla A12 Genova-Rosignano e proseguire verso sud fino alla sua uscita di Livorno; • se proviene, invece, dalla Versilia - e, conseguentemente, dall’area spezzina e dalle direttrici che proprio in quell’area provengono da Genova e da Parma - deve percorrere la A12 in direzione sud, uscendo al solito svincolo di Livorno; • se, infine , proviene da sud, e cioè dalla Maremma o più semplicemente da Cucina, deve percorrere all’incontrario la tratta Rosignano-Livorno della A12. Il percorso è breve e l’autostrada, poiché attraversa terreni che una volta erano fètide paludi ed acquitrini melmosi, poggia tutto su piloni. La spesa di costruzione di tutti quei piloni fu immensa e, per ammortizzarla, si pensò bene d'applicare tariffe robuste. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la tratta autostradale Rosignano-Pisa (o viceversa) dalla A12 è la più cara d’Italia e forse d’Europa, ed è evitata con cura dagli automobilisti incalliti e dai camionisti e, quindi, non è molto trafficata. Sennò, c’è sempre l’alternativa delle superstrade e delle vecchie quanto gloriose strade nazionali. Fra le prime, merita un cenno particolare, per chi proviene dall’area fiorentina di cui so pra,la 6 * superstrada Firenze-Livorno (con diramazione per Pisa all’altezza di Pontedera, dove la FI-LI fa una grande ipsilon): non è mai stata un capolavoro di ingegneria e chiunque può constatarlo per i continui sobbalzi cui viene assoggettato soprattutto nella sua parte mediana, nel samminiatese ove sta per finire il Valdarno Inferiore ed inizia la Piana di Pisa. Per chi proviene da quella cecinese, c’è, invece, * il raddoppio della strada statale n° 1 Aurelia, chiamato tout-court La Variante: opera pubblica agognata per decenni e dall’appellativo talmente accattivante da dar nome persino ad una trattoria. Nasce nel Grossetano ma manca ancora- come nel tratto di Quercianella, alle porte di Livorno di alcuni spezzoni per essere del tutto percorribile: anche in questo caso, ci sono dubbi in fatto di ingegneria stradale, ma è già molto che il raddoppio ci sia, con grande gaudio di camionisti e di automobilisti incalliti. .... QUELLE FERROVIARIE, *********************** E’ ovvio che a Livorno si può arrivare anche comodamente in treno, dal momento che la città è situata sulla linea Torino-Genova-Pisa-Roma e vi fermano tutti i treni, pendolini ed Eurostar compresi. La stazione centrale di Livorno - ci sono anche altre stazioncine periferiche: alcune sono scalimerci in funzione del porto, altre (come Ardenza ed Antignano) sono per passeggeri ma hanno quasi con funzioni balneari - è gigantesca ed ha un atrio che la fa assomigliare un po’ a quella di Genova-Brignole. La facciata, poi, sembra a prima vista copiata da quella di Torino-Porta Nuova. Essendo una stazione di puro transito, non ha derivazioni: ma i cambi sono abbastanza frequenti e garantiti a Pisa, da dove si può agevolmente raggiungere o provenire da e per: 7 * Firenze-Bologna-Milano (o Bari) o Firenze-Arezzo-Roma, oppure da e per * Lucca-Pistoia-Prato o Aulla-via Garfagnana Sulla linea inversa, e cioè verso Roma, ci si può fermare a Grosseto e di qui prendere le linee che, attraverso l’Alta Maremma e l’Amiatino, raggiungere Siena con vista sulle Crete, ora tanto di moda. Ma attenzione: la linea è a binario unico, e i treni sono tutti locali e perdipiù a nafta. L’unico difetto della stazione di Livorno-Centrale è nel fatto che essa è molto periferica (è quasi in campagna per cui ha una bella vista su orti rachitici e canneti) rispetto al centro commerciale della città, al Porto Mediceo ed alla Stazione Marittima. Il complesso è databile agli anni Venti e, forse, era destinato a far da fulcro allo sviluppo turisticoambientale di una Livorno che sognava di conquistare la palma di Perla del Tirreno non ancora detenuta da Viareggio. Infatti erano i tempi degli annulli postali “Visitate l’Italia” ed una forma seppur primordiale di turismo si stava affacciando. Il neonato Ente del Turismo di Livorno fece addirittura stampare dei manifesti nei quali si elencavano le attrattive turistiche della città che poteva offrire bagni di scoglio e di sabbia, fonti termali calde e salutari, alberghi confortevoli, escursioni in campagna, gite in battello e via elencando. Ma era un sogno che rimase nel cassetto, perché poi venne il secondo conflitto mondiale e la città fu rasa al suolo dai bombardamenti alleati. Il dopoguerra fece il resto e la città puntò tutto, dopo la ricostruzione, su di un’industrializzazione in parte forzata. Il quartiere della stazione divenne, allora, sempre più periferico e circondato da rioni anonimi di case popolari, e di palazzine tutt’altro che capolavori di architettura. Uno stabilimento di acque termali - la Montecatini sul mare, diceva la pubblicità che allora si chiamava réclame - situato a fianco al suo corpo centrale della stazione chiuse i battenti. 8 I collegamenti degli autobus urbani Stazione-Centro o Porto sono abbastanza frequenti durante il giorno (e per di più feriale): molto scarsi per non dir inesistenti, dopocena, la domenica e gli altri giorni comandati. Meno male che ci sono i tassì. 2 ... E LA REGINA DELLE STRADE ******************************* er i romantici ed ai nostalgici delle strade statali, invece, rimane pur sempre valido il per- P corso delle vecchia Strada Statale n°1 Aurelia che qualcuno chiamò, con non poca enfasi, la Regina delle Strade. Nasce a Roma come tutte le altre vie consolari e ha un andamento quasi parallelo alla costa tirrenica. Conduceva - e conduce tuttora - oltre Ventimiglia nel Midi della Francia, verso quella Provenza la cui etimologia è elementare: quella regione del sud della Gallia era una delle province dell’Impero ed è ricca tuttora dei segni lasciati dalla colonizzazione romana. Nel tratto toscano che conduce a Livorno, l’Aurelia ha tratti paesaggistici spettacolari alternati da altri insignificanti. IL TRATTO PISANO... Provenendo da Pisa, ad esempio, attraversa una pianura piatta che non presenterebbe al turista attento nessun elemento di curiosità se non vi fosse la presenza di due località che ebbero il loro momento di triste notorietà alla fine del secondo conflitto mondiale. Prima, sulla sinistra di chi viaggia verso Livorno, • Coltano, dove, per un paio d’anni e dopo la fine delle ostilità, fu gestito dagli Alleati un grande campo di concentramento ove furono imprigionati sia i soldati della RSI sia i collaboratori di quell’ultimo disperato momento della storia del partito fascista: l’ospite più celebre di Coltano 9 fu certamente Ezra Pound, ma c’è chi giura di avervi conosciuto Enrico Ameri, Giorgio Albertazzi e Walter Annichiàrico, che, pochi anni dopo, sarebbe divenuto Walter Chiari. Poi, poco oltre, sulla destra, • Tòmbolo, che fu, sì, un grande deposito di materiale bellico e di generi di conforto (sigarette, soprattutto) della Quinta Armata americana e della sua famosa 92ma divisione Buffalo - quella tutta di neri che sfondò nell’aprile del ‘45 la Linea Gotica ed arrivò fino a Genova - ma anche il ricettacolo di ogni nefandezza e di ogni vergogna. Fu persino tema (“Tòmbolo”, appunto, con Aldo Fabrizi) o sfondo (“Senza pietà” con Carla Del Poggio) di due pellicole neorealiste del ‘46-47 che qualcuno avrà rivisto con curiosità perché riproposte anni fa sia dalla tivù nazionale sia da alcune emittenti private. Dei due affairs si parla ancora, nel pisano e nel livornese: ma sottovoce e con pudicizia.. Oggi, a Coltano, che fu una grandissima tenuta agricola dei Medici, poi dei Lorena, del Demanio dello Stato unitario ed infine dell’Associazione Nazionale Combattenti, e dove Guglielmo Marconi installò un suo centro radio le cui antenne sono riprodotte sui biglietti da 2000 lire, si fa dell’agriturismo e vi sono delle colture sperimentali per la produzione biologica e biodinamica. Tòmbolo è, invece, da quel lontano 1944, una enclave americana chiamata Camp Darby: è circondata da barriere di filo spinato e da molto mistero. Ambedue le località sono incluse nell’immenso territorio del Parco Naturale di San RossoreMigliarino e Massaciuccoli, che si estende dalle porte di Livorno a quelle di Viareggio: comprende di tutto, dalle grandi tenute agricole alle pinete litoranee, da un ippodromo all’unico lago della Toscana ove aleggia ancora lo spirito di Giacomo Puccini. L’attuale tracciato Pisa-Livorno dell’Aurelia è degli anni ‘30-40 di questo secolo: il vecchio percorso, invece, è stato retrocesso al rango di strade provinciali che si chiamano Via Livornese, a Pisa, e, ovviamente, Via Pisana, a Livorno. 10 Poco oltre Coltano e Tòmbolo, una zona dominata da una grande raffineria e da altri impianti della petrolchimica, ha un topònimo che la dice lunga su quella che doveva essere la salubrità del luogo: la zona si chiama, infatti, Stagno e non vi è alcun riferimento all’omonimo metallo. Infatti la parola stagno significa anche pozzanghera, acquitrino: acqua stagnante, in poche parole con conseguente malaria e tutte le complicazioni del caso. La grande raffineria dii cui si parla ora è di proprietà di una dei tanti bracci secolari dell’ENI, ma, in origine, era quella che oggi si direbbe una joint-venture tra la Montecatini, che ebbe come fondatore il livornese Guido Donegani,e l’ANIC, acrostico di Azienda Nazionale Idrogenazione Carburanti. Infatti, quest’ultima - forse una derivazione dell’AGIP ante-Mattei - avrebbe dovuto, attraverso la sua tecnologia, raffinare scisti bituminosi, ligniti, rocce asfaltiche, petrolio greggio rumeno, messicano ed albanese per dare a un paese stretto nelle gabbie delle sanzioni economiche i prodotti energetici di cui necessitava. Era il 1937; tre anni dopo, la raffineria di Stagno andò in cenere sotto i bombardamenti aereonavali britannici. Poi la ricostruzione, il subentro dell’americana Esso alla Montecatini, l’abbandono anche della Esso fino ai nostri giorni. Un’alternativa all’Aurelia è una strada nazionale che i vecchi pisani, e non solo essi, chiamano la Via di Marina (sottinteso: di Pisa). All’inizio è un lungarno e, poi, un lungomare. Inizia da un incrocio sull’Aurelia a pochi metri dalla riva sinistra dell’Arno nella zona popolare di Porta a Mare dominata dal grande stabilimento della Saint-Gobain. Prosegue fino a Bocca d’Arno - e cioè alla foce del fiume - sotto una ininterrotta galleria di platani. Il viaggio è reso ancor più suggestivo dal fatto che, a metà di questo che è un vero e proprio lungarno, una breve deviazione sulla sinistra porta alla Basilica di San Piero a Grado, uno dei monumenti romanici più belli e meno conosciuti della Toscana e, per conseguenza, dell’Italia intera. La tradizione vuole che la grande basilica sia stata costruita nel luogo ove San Pietro, giunto 11 da Roma per catechizzare la gente della Tuscia settentrio nale, era sbarcato dopo aver risalito l’Arno. La Basilica di San Piero a Grado ha l’aspetto di una grande nave a secco di pietra verrucana ed ha il particolare di avere due absidi e di non aver portale. Da non perdere. La strada, poi, giunta a Bocca d’Arno dove il fiume si getta nel Tirreno, fa una grande curva verso sud, per attraversare l’abitato di Marina di Pisa, cittadina costruita un po’ cerebralmente alla fine del secolo scorso per assecondare la voglia di bagni di mare della popolazione di Pisa. Prosegue in litoranea fino a Tirrenia - altra cittadina artificiosa nata sulla fine degli anni trenta sotto forma di città-giardino com’era di moda all’epoca e, per miracolo, rimasta tale - e la sorpassa. Dopo pinete ombrose e ruderi di vecchie colonie marine dell’Opera Balilla, la strada, infine, arriva nella zona industriale di Livorno fra depositi petroliferi costieri, docks, grandi stabilimenti chimici, e canali di bonifica. ...E QUELLO CECINESE Provenendo da Cècina, invece, dopo aver attraversato una zona ancora un po’ campagnola - ma dove sono insediate da decenni alcune importanti realtà della cantieristica italiana minore - l’Aurelia corre diritta come un fuso. Alla destra di chi corre verso Livorno appaiono in secondo piano alcune azzurre colline che ospitano alcuni minuscoli paesi appartenenti amministrativamente alla provincia di Pisa. Sono nell’ordine: • Guardistallo, • Montescudaio e • Riparbella. Non direbbero nulla a nessuno, se nel secondo di essi non esistesse una produzione vinicola che oggi si chiama di nicchia e che è molto considerata negli ambienti ultrasofisticati dell’enologia. 12 Nel piccolo comune di Montescudaio si producono, infatti, tre vini a d.o.c. con una prevalenza di un rosso d’alto bordo. La produzione non è a livello industriale, ma è conosciuta nei locali di classe che ostentano cappelli e forchette varie e che, quindi, sono da affrontare con una buona dose di virilità. ITINERARIO CLASSICO 3 CECINA DALLA PRIVATA LUXURIA ALLA FERROVIA CHE NON C’E’ PIÙ’ *********************************************************************** ècina non ha alcunché che ne mostri un passato glorioso: è una cittadina ricostruita C dopo le devastazioni del secondo conflitto mondiale ed è stata abitata fino ad un mezzo secolo fa da una popolazione totalmente dedita all’agricoltura. Poi ha scoperto il mare. La sua Marina, le sue spiagge e le sue pinete, dopo essere state per decenni luogo di villeggiature familiari - perché la più a buon mercato della costa - di intere generazioni di fiorentini, di pisani e di livornesi, sono divenute col tempo tutto un campeggio. Poi, dopo i campeggi, si sono fatti avanti i villaggi turistici, i résidences e tutto quanto fa turismo balneare e Torre di Babele. Ma Cècina non ha mancato, in questi ultimi anni, di ricordarsi che, sulle colline alle spalle di quella zona paludosa finita di bonificare negli anni trenta del Novecento, avevano vissuto gli Etruschi. ed i Romani. Ha attrezzato un piccolo museo archeologico nella villa “La Cinquantina” che, dopo essere stata adibita a ricovero di coloni mandati colà a dissodare terreni fino a qualche anno prima paludosi, fu proprietà nientemeno che di Francesco Domenico Guerrazzi, che vi morì nel 1873. Il prolifico letterato e drammaturgo livornese, patriota e triumviro dei moti antilorenesi, l’aveva acquistata per farvi il suo buen-retiro estivo; eravamo in pieno periodo romanticod il fatto che il 13 Guerrazzi avesse scelto quella zona di malaria, di miseria e di morte per le sue vacanze, fece colpo negli ambienti letterari dell’Italia appena unificata. La villa si trova nel bel mezzo della campagna, poco dopo l’abitato di San Piero in Palazzi che è la frazione di Cècina più settentrionale, andando verso Livorno. Dall’Aurelia bastano pochi chilometri in direzione-mare, e la villa appare col suo parco ombroso di al- beri ad alto fusto. Oggi la Cinquantina ospita, oltre al museino archeologico di cui sopra, anche un museo ru- rale - o di contadinerie - ove sono raccolti attrezzi e utensili adoperati dai poveri cristi che colonizzarono questo tratto di Maremma Toscana. Attiguo alle due zone museali, c’è anche un piccolo ristorante che serve piatti e prodotti tipici, nonché una piccola enoteca con assaggio di vini locali: servono per attirare verso la cultura bagnanti, turisti e campeggiatori all’insegna del prendeteli-per-la-gola. Cècina è alla foce del fiume omonimo che nasce dalle falde dei monti di Volterra, città dalla quale proveniva una famiglia agiata di origine etrusca che aveva latinizzato in Caecina il suo vero nome che era Ceikna. Quasi a metà strada tra la cittadina ed il mare, in località San Vincenzino e poco un vecchio zuccherificio, si credette di aver trovato la villa che fu di lontano da Albino Cècina, il patrizio che vi aveva residenza e che diede nome a tutta la zona. Non solo, ma gli antichi portolani indicavano proprio quel luogo, non lontano né dal mare né dalla foce del fiume Cècina, come Albini villa. La villa effettivamente era esistita, tant’è vero che se n’era parlato in diverse occasioni nel cor- so dei secoli. Fu solo nel Settecento che si capì che un piccolo poggio - poco più che una gobbetta della piatta campagna cecinese - doveva essere stato il luogo ove sorgeva la villa patrizia, da dove i suoi abitanti potevano guardare verso il mare che arrivava a lambirla. Si capì anche che, in epoca imperiale, la villa attribuita ad Albino Cècina doveva essere un grande complesso a metà strada tra il centro di una grossa tenuta agricola ed un luogo di delizie quasi di fronte al Tirreno. 14 Gli scavi per l’individuazione certa della serie di edifici furono, nel corso dei due secoli suc- cessivi, piuttosto discontinui: solo in questi ultimi decenni, però, i lavori sono stati condotti in maniera sistematica e tutta la zona è divenuta un parco archeologico destinato alla fruizione di tutti. Allora, si scoprirà che la villa romana di San Vincenzino aveva giardini ed orti, cisterne per l’acqua piovana ed un efficientissimo sistema di riscaldamento, bagni e terme a volon tà: il tutto ricoperto di decorazioni raffinate. Mosaici, dipinti, sculture e bassorilievi. Una privata luxuria, per dirla con Cicerone. La valle del fiume Cècina (o Valdicècina) è un territorio molto esteso, amministrativamente equamente diviso tra le province di Livorno e di Pisa. Proprio la sua estensione fece, nel secolo scorso, un piccolo miracolo: la valle interna fu collegata a Cècina, che è sulla Torino-Roma, da un braccio ferroviario che congiunge tuttora la cittadina con Saline di Volterra . Qui da sempre si scava il salgemma che il Monopolio di Stato impacchettava per la distribuzione su tutto il territorio nazionale come sale da cucina. La stazione di Saline era, a sua volta, collegata con la sovrastante Volterra con un curioso quanto efficiente braccio ferroviario a cremagliera per il servizio-passeggeri che fu sempre abbastanza considerevole, anche se tutt’altro che allegro. Infatti la ferrovia a cremagliera serviva soprattutto a chi, da tutta l’Italia, doveva recarsi in quella città per visitare o parenti malati di mente od altri congiunti ergastolani. Volterra è stata, infatti, fino a qualche anno fa, la sede di uno degli ospedali psichiatrici più grandi d’Italia e mentre vi è tuttora, nella sua maestosa Fortezza Medicea, un carcere di massima sicurezza con tanto di 41\bis. Il tronco ferroviario a cremagliera Saline-Volterra fu inaugurato nel 1912 con tre bande musicali ed un telegramma - risultato poi fasullo - di Gabriele D’Annunzio che a Volterra aveva soggiornato per scrivere il suo “Forse che sì, forse che “ e che aveva definito di vento e di macigno quella città. E non aveva tutti i torti. 15 l tronco a cremagliera, però, durò poco: una quarantina d’anni appena, prima di essere dismesso e poi demolito. Il fattaccio avvenne negli anni ‘50, quando si avvicinava l’èra del consumismo ed era meglio far fuori tutto quello che poteva sapere di antico, di stantìo e di sabaudo. Fu così che si perpetrò un orrendo delitto contro il turismo perché oggi il treno a cremagliera Sali ne-Volterra e viceversa sarebbe una attrazione non da poco: sarebbe oggetto di culto fra i non pochi amanti di storia delle comunicazioni in genere e delle ferrovie in particolare e attirerebbe con corse speciali scolaresche di mezza Europa, giapponesi attoniti e turisti di tutto il mondo. La storia della demolizione anni cinquanta della ferrovia a cremagliera Saline-Volterra è per certi versi molto simile a quello che avvenne, qualche anno dopo, sull’Appennino Pistoiese, ove, a furor di popolo, fu demolita la FAP (Ferrovia Alto Pistoiese) che con- giungeva la stazione FF.SS. di Pracchia, sulla linea Pistoia-Bologna detta Porrettana, a Mammiano, oltre San Marcello: aveva la colpa di aver troppi passaggi a livello. Anche tra Pisa e Livorno un’altra ferrovia - ma questa volta turistico-balneare - fu demolita negli anni ‘60: quella che oggi ancora molti nostalgici ricordano come il Trammino e che collegava Pisa a Livorno via Bocca d’Arno, la sua Marina e quella che sarebbe poi divenuta Tirrenia. Da Pisa il Trammino partiva da Piazza Sant’Antonio, da dove oggi partono gli autobus per tutta la provincia pisana; a Livorno la sua stazione terminale era alla Barriera Margherita, proprio davanti all’Accademia Navale. Tanto per rimanere in Toscana, furono anche demolite, sempre negli stessi anni, la PisaPontedera, la Pontedera-Lucca, e, perché no?, la ferrovia Carrara-Fantiscritti detta più semplicemente la Marmifera perché serviva essenzialmente al trasporto dei blocchi di marmo. Ma chissà quante altre ferrovie sono state in quegli anni demolite: ci sarà qualcuno chesaprà tenere questo conto? 16 4 VADA: LE SECCHE E LA SABBIA BIANCA **************************************** oco oltre Cècina e la sua Marina, altre spiagge. P Come quelle di Vada dalla sabbia sbiancata dagli scarichi a mare degli stabilimenti della Solvay. Nulla di pericoloso; anzi: una curiosità, dal momento che sul Tirreno spiagge bianche non ce ne sono mai state dalle ère geologiche in poi. Cosa molto importante per gli sportivi, invece, è il fatto che, nel mare davanti a questo paese, una serie di secche - o bassi fondali - note appunto come Secche di Vada, siano fra i luoghi più pescosi di tutto il Mediterraneo. Sono a circa quattro miglia marine dalla costa ed in passato erano il terrore dei naviganti; oggi sono il paradiso dei pescatori subacquei che arrivano qui in ogni stagione dell’anno con le pinne, il fucile e gli occhiali. Che fossero luogo di naufragi d’altri tempi è testimoniato dal fatto che innumerevoli relitti di navi dell’epoca ellenistica e romana furono trovati in zona; spesso avevano a bordo carichi di anfore onerarie per il trasporto di olio, vino o di granaglie In epoche più recenti fecero naufragio alle Secche di Vada • il Tabarka, grosso mezzo da sbarco della Regia Marina che, proprio qui, urtò contro una mina vagante ed • il famoso Genepesca, grande nave frigorifera di ottanta metri che apparteneva all’omonima società peschereccia livornese. In tempi di autarchia, la Genepesca era il massimo nell’approvvigionamento ittico in Italia: poi tutto cambiò ed ora ci pensano russi e giapponesi a rifornire di merluzzo il peschereccio dei Bastoncini Findus. 17 Qualche chilometro prima di Vada, nella già citata frazione cecinese di San Piero in Palazzi, avvenne, verso la fine degli anni Cinquanta, una piccola rivoluzione industrale: due ex studenti d’ingegneria non ancora trentenni ed appassionati di mare diedero vita ad un cantiere navale. Nulla di eccezionale, se si pensa che eravamo ai primi saloni nautici di Genova, con tutto l’entusiasmo che ne seguì, in pieno miracolo economico italiano. Lo strano, invece, è che nel cecinese di cantieristica navale nessuno aveva mai sentito parlare: forse qualche maestro d’ascia aveva costruito qualche barcone nel secolo scorso. Ma qui si trattava non più di barche di legno, ma di panfili in vetroresina. E, poi, Cècina non era né Viareggio né Rapallo, col loro contorno di gente se non proprio ricca, almeno facoltosa: era appena uscita dalla sua antica fame di paese ai limiti della malaria e non disponeva neanche di qualche attracco come si deve, se non di una specie di porto-canale alla foce del fiume che prende il suo nome. I due studenti - ambedue, come si suol dire, di buona famiglia - si diedero da fare e vararono le prime barche da diporto che andarono a ruba. Poi, anche barche da lavoro, pescherecci e perfino motoscafi veloci per la Marina Militare. I soci, come sempre accade, un giorno si divisero: ognuno prese la propria strada, ed i cantieri divennero due. Oggi i cantieri navali del cecinese sono più di una ventina. Anche nei pressi di Vada, a San Gaetano, sono stati scoperti, durante campagne di scavo durate vari decenni e spesso interrotte, i resti di un complesso che comprendeva spaziosi magazzini, forse un mercato e due edifici adibiti in epoca romana a bagni pubblici. Le costruzioni dovevano far parte di un abitato romano che sorgeva sul mare fra la seconda tà del primo secolo ed il sesto d.C. e che doveva chiamarsi Vada Volaterrana, a me- dimostra- zione che l’influsso della città etrusca era ancora importante. Nei pressi, inoltre, doveva esserci un porto, od almeno un luogo atto agli attracchi, che gli cheologi hanno ubicato nell’area che oggi è occupata dal pontile della Solvay. ar- 18 I magazzini (od horrea) sono grandi vani rettangolari, hanno il pavimento in argilla e furono senz’altro utilizzati per attività artigianali e commerciali. Confinanti con questa specie di ipermercato, gli edifici termali destinati ad attività igieniche e ricreative. Il complesso nascondeva però altri piccoli segreti: si pensi che tutto fa credere che fosse sta- to costruito su un precedente insediamento etrusco, poiché sono state trovate tracce di capanne che i nostri enigmatici antenati usavano già nei secoli ottavo e settimo a.C. come postazioni di caccia o di pesca. Gli oggetti d’uso quotidiano che furono trovati fra i ruderi, sono gelosamente conservati nel Museo Archeologico di Rosignano Marittimo, al quale ci si può rivolgere, durante l’estate, per delle visite guidate. 5 ROSIGNANO: TRA SODA CAUSTICA E CIMELI ETRUSCHI ********************************************************** ’Aurelia prosegue toccando Rosignano Solvay, un’appendice industriale del comune di L Rosignano Marittimo, dominata da un gigantesco stabilimento chimico tutto tubazioni e ciminiere sbuffanti di proprietà della Solvay. E’ questa una multinazionale belga che qui mise radici nei primi del secolo, cominciando con la produzione del bicarbonato di sodio, ma che oggi è la più grande produttrice italiana di soda caustica, prodotto base per tutta l’industria chimica nazionale. L’insediamento del grande stabilimento iniziò, infatti, nel 1914 e da allora il paese è la frazione più attiva del comune. 16.000 abitanti, oggi, contro gli zero di una ottantina d’anni fa, quando questo territorio della pianura costiera, altro non era che una landa desertica della Maremma Settentrio-nale. 19 In seguito la Solvay iniziò anche la costruzione dei villaggi per i propri dipendenti, sullo stile di quanto avrebbero fatto, in seguito, a Pontedera la Piaggio ed a Pisa la Saint-Gobain, tanto per citare gli interventi urbanistici di questo tipo più famosi in Toscana. Si trattò della costruzione dal nulla di una vera e propria città-giardino - della quale restano a testimonianza le larghe zone a verde e le case unifamiliari - dal momento che, in Europa, stava prevalendo questo concetto di città ideale per i lavoratori. La Solvay appartiene a quella triade di industrie francòfone che, in Toscana, fecero fortuna e, senza le quali, parlar di industrializzazione nella regione è alquanto azzardato. Le altre due erano: * la Larderel, che, prima, sfruttò i soffioni boraciferi dell’Alta Valdicècina per la produzione di acido borico e derivati e, poi, produsse la prima energia elettrica di origine geotermica, ali- mentando delle turbine con la forza che scaturiva dalle viscere della terra. Diede anche nome ad un paese, Larderello, che oggi è abitato quasi esclusivamente da impiegati e pensionati dell’ENEL che ha fagocitato a suo tempo tutto quello che fu dei Larderel e delle varie società elettriche che seguirono. Il paese è famoso fra tutte le scolaresche d’Italia che vi sono trasci- nate a forza dagli insegnanti di scienze che vogliono farle assistere allo spettacolo dei soffio- ni in quella che alcuni chiamano un po’ mente La Valle dell’Inferno; da non enfati ca- perdere da parte dei fotografi, data la spettaco- larità del paesaggio industriale; e, poi * la Saint-Gobain che, a Pisa, nel rione di Porta a Mare ed ad un passo dal Canale di Na- vicelli, produsse i vetri piani per le finestre di quasi tutta l’Italia, prima di mettersi a produrre cristalli di sicurezza per auto ed, ora, vetri blindati per la difesa contro gli assalti della cri- minalità. Alle spalle di Rosignano Solvay, su un piccolo colle, sorge il capoluogo del comune: Rosignano Marittimo. Una deviazione è consigliabile, perché il paese è bello, in posizione amena e con panorama su tutta la costa. 20 E’ sede municipale di un comune molto esteso che comprende, come si vedrà, anche località di alto livello: prende nome anch’esso da dei patrizi di campagna di origine etrusca: i Rosini. Alcuni eruditi parlano, invece, di Rasinii. Erano, come i loro affini Caecina già citati, dei ricchi possidenti con fattorie molto estese e centinaia di schiavi al loro servizio. Lasciarono, tutti quanti, tracce che - passati i secoli bui, il Rinascimento portato dai conquistatori fiorentini, ed i secoli della Decadenza - vennero riscoperte e valorizzate nel secolo scorso ed in quello che sta per terminare. Tant’è vero che Rosignano Marittimo è sede di un piccolo ma succulento museo archeologico che ha sede in uno dei palazzi costruiti durante il periodo granducale. Il museo archeologico di Rosignano Marittimo, allestito nelle sale del Palazzo Bombardieri che è sito nel cuore del paese, custodisce reperti provenienti un po’ da tutto il territorio comunale, ed in particolare modo dagli scavi di San Gaetano di Vada e di Castiglioncello. E’ stato voluto nel 1957 da un gruppo di archeologi locali, ed ospita via via anche mostre di altri reperti provenienti da altri territori poco lontani ma ricchi di un passato etrusco-romano a dir poco affascinante: questi territori erano chiamati Agri Volaterrani e Pisani e corrispondevano grossomodo all’attuale pianura costiera ed al promontorio dell’attuale Castiglioncello. Il nerbo dell’esposizione di Palazzo Bombardieri è costituito dai corredi della necropoli di quest’ultima località, che assommava a ben trecento tombe di varia epoca: da quella etrusca a quella ellenistico-romana: un arco di sette-otto secoli. Un’urna etrusca d’alabastro alla moda volterrana aveva custodito, due secoli prima di Cristo, le ceneri di Velia Cerinei, forse una signora della nobiltà rurale della costa o della nuova società di arricchiti che abitava il promontorio e ne aveva fatto luogo di delizie. Si trattava, in genere, di gente di origine etrusca che - fino a qualche generazione prima - non aveva nulla di nobile: anzi. 21 Ma era gente ricca; che si era fatta tutta da sola coi commerci che si svolgevano nel porticciolo sottostante e che aveva mercanteggiato coi fenici ed altri nomadi del mare: conosceva a memoria il detto latino secondo il quale il denaro non puzza (pecunia non olet) e si era fatta costruire ville con giardino, aveva tradotto i cognomi etruschi (forse impronunziabili) in latino: quella che i milanesi chiamano bonariamente la dané-society. Tutta questa gente della borghesia oriunda etrusca, poi, una volta morta, era stata onorata dai parenti e dai discendenti con tombe ricche ed eleganti. Il primo archeologo di Castiglioncello fu, intorno al 1870, quel Diego Martelli politico e mecenate fiorentino, amico ed anfitrione dei pittori della Macchia e proprietario della tenuta che aveva come suo punto focale la zona ove è adesso il Castello Pasquini, e sotto la quale furono trovate le prime tombe. La sua opera fu proseguita una trentina d’anni dopo, agli inizi del ‘900, da Luigi Adriano Milani, che ricopriva la carica di soprintendente agli scavi ed ai musei archeologici dell’Etruria e di direttore del Museo Archeologico di Firenze. Il buon Milani volle, inoltre, che a Castiglioncello venisse allestito un museino con tutte le cose ritrovate sotto il promontorio, e così fu fino al 1973, quando tutto fu trasferito a Firenze. Gli ultimi ritrovamenti risalgono a due o tre anni fa, quando furono ripresi gli scavi dopo anni di oblio. Il Museo di Palazzo Bombardieri ospita anche • anfore ed orci provenienti da ritrovamenti subacquei alle Secche di Vada, e • altri oggetti d’uso quotidiano ritrovati in una necropoli più recente (V secolo d.C.) che trovata sotto il cuore di Rosignano, ed infine • numerosi reperti d’epoca medioevale e rinascimentale recuperati durante il restauro del Castello. Durante il Rinascimento si trasferì a Rosignano - che non si chiamava ancora Marittimo - una piccola colonia di abitanti di Montelupo Fiorentino, quel paese del Valdarno Inferiore che è fa- 22 moso per essere di fronte a Capraia (“da Montelupo si vede Capraia, Dio li fa e poi li appaia”: è un detto popolare toscano che più o meno tutti conoscono). Su ordine dei Medici che a Rosignano, agli estremi confini settentrionali della malarica Maremma, avevano una delle loro più grandi tenute agricole - e dove anche Lorenzo il Magnifico si recò più volte per delle battute di caccia nel vicino padule di Vada - la colonia montelupina aprì alcune fornaci per la produzione di stoviglie ed altri manufatti in terracotta di uso quotidiano che, fino ad allora, erano importati da zone lontane. Un’operazione analoga, sempre nello stesso periodo storico e sempre con gente di Montelupo, fu fatta in un’altra zona toscana diametralmente opposta: nel Mugello, ove la famiglia Medici, che era di origini mugellane, aveva un’altra grande tenuta, a Cafaggiòlo. Montagne di cocci, rottami delle lavorazioni dei montelupini, sono state trovate sotterrate o sul fondo di pozzi alla maniera di Montelupo, in varie zone sia a Rosignano sia nel Mugello. Rosignano è detto Marittimo, ma non è sul mare: sembra un nonsenso, ma è proprio così. Ma se scorrerete la toponomastica di questa parte della Toscana litoranea, troverete numerose località che si definiscono marittime e che, invece, sono lontane dal mare parecchi chilometri: come • Campiglia Marittima, • Monteverdi Marittimo, e • Casale Marittimo. Proprio a Casale Marittimo, che è alle falde dei monti di Volterra, in un podere immerso una campagna pressoché spopolata, si aveva da secoli la percezione che vi avessero in abitato e sepolto i loro morti i nostri enigmatici padri etruschi. Era vero, perché già nell’Ottocento fu trovata una tomba a cumulo che fu smontata e porta Museo Archeologico di Firenze ed ivi, seguendo la moda dell’epoca, ricostruita e ri un giardino. ta al montata in 23 Ma altri scavi seguirono nel tempo, e si scoprì che il luogo custodiva altre tombe etrusche. Fu- rono amorevolmente portati alla luce molti reperti che fecero dedurre agli studiosi che la ci- viltà etrusca di Casale Marittimo aveva delle strane quanto affascinanti affinità con altre civiltà del Mediterraneo Orientale, tant’è vero che si parla di una cultura orientalizzante. Questo nel linguaggio degli archeologi: ma, allora, che rapporti c’erano fragli Etruschi che vivevano sulle colline della Maremma Toscana - e non erano navigatori -ed i popoli dell’Asia Minore? I reperti etruschi di Casale Marittimo - alcuni dei quali di rara bellezza - sono custoditi ora al piano superiore del museo archeologico della Villa Guerrazzi o della Cinquantina di Cècina: ci sono corredi funebri maschili e femminili, armi, oggetti di devozione e piccole cose di uso quotidiano, nonché due splendide sculture raffiguranti due personaggi forse altolocati perché dotati di cinturoni molto decorati. Rosignano prese l’appellativo di Marittimo nel 1862, perché c’è anche un Rosignano Monferrato, in provincia di Alessandria che proprio sul mare non è: ma gli altri paesi, perché sono marittimi ? Sempre all’interno, si trovano tre paesini che ricordano anch’essi qualcosa: * Castelnuovo Misericordia, che deve il suo appellativo al fatto di essere stato nel Me- dioevo al centro di ricchi possedimenti della Misericordia di Pisa, fondata da Giorda- no da Rivalto, santo frate del Duecento ed inventore degli occhiali da naso e per questo citato da Umberto Eco nel suo “Il nome della rosa”; poi * Nibbiaia, tutta circondata da una folta macchia mediterranea e campo-base per scursioni nell’entroterra: è particolarmente cara ai naturalisti, perché è ricca di molte espe- cie botaniche come il leccio, il lentisco, l’erica e la ginestra. Infine, * Gabbro, che prende nome dal tipo di macigno su cui sorge, e dove passò gli ultimi anni di fervida vita artistica Silvestro Lega, uno dei massimi esponenti della corrente pittorica dei Macchiaioli. Particolare frivolo: a Gabbro è nata Nada. 24 Durante la torrida estate del 1530, partì da Rosignano una colonna di volontari che, attraversata tutta la Valdicècina, si congiunse nei pressi di Volterra con l’esercito raccogliticcio di Francesco Ferrucci che era asserragliato in quella città; i rosignanesi vollero così dimostrare la loro fedeltà alla Repubblica Fiorentina della quale il Ferrucci era il massimo comandante militare, e della quale il loro paese era una delle ultime colonie meridionali dopo la caduta definitiva della Repubblica di Pisa. Non solo: ma la colonna dei rosignanesi seguì l’esercito fiorentino - quando le truppe di Ferrucci ebbero lasciato Volterra dopo una sortita temeraria dalle sue mura - fino all’Appennino Pistoiese, con una marcia forzata durata parecchi giorni. Era una disgresssione pensata ed attuata dal generale fiorentino e tendente a raggiungere alle spalle passando da Pistoia e Prato, Firenze che era assediata dagli spagnoli assoldati dai Medici cacciati dalla città. Ma la mossa strategica del Ferrucci non ebbe successo: le sue truppe furono inseguite e raggiunte dagli spagnoli comandati dal napoletano Fabrizio Maramaldo (o Marramao?) nei pressi dell’attuale San Marcello e furono sterminate col suo comandante, pochi chilometri oltre, a Gavinana. Nessuno dei rosignanesi sopravvisse. Sopravvive, invece, il ricordo di quel tragico fatto militare in una celebrazione che si tiene a Gavinana ogni anno d’estate, ed alla quale partecipa anche una delegazione di Rosignano Marittimo. A Rosignano ebbe i natali Pietro Gori, scrittore ed agitatore anarchico dei primi del secolo. Fu anche poeta e paroliere: suoi sono i versi di “Addio Lugano bella”, inno - fino a qualche decennio fa - dell’anarchismo italiano. Evocava un congresso che avrebbe dovuto aver luogo in terreno neutrale, in Canton Ticino, se gli anarchici non fossero stati ricacciati oltrefrontiera, in territorio dell’odiato Regno d’Italia, da quella che immediatamente fu bollata come una repubblica borghese. 25 6 CASTIGLIONCELLO: DA LUOGO DI DELIZIE ELLENISTICHE A TERRITORIO PER VIP (O PRESUNTI TALI) ***************************************************************************** olo pochi chilometri, ed ecco il piccolo promontorio di Castiglioncello, la frazione più no- S bile di Rosignano Marittimo, comune che, dopo l’unità d’Italia, era stato in provincia di Pisa, per poi passare dopo una specie di referendum, a quella di Livorno, istituita molto tempo dopo. A qualcuno Castiglioncello e le sue scogliere evocheranno senz’altro nomi di attori e di altri artisti romani che qui si insediarono negli anni sessanta, e che portarono a Castiglion- cello una ventata di dolce vita. Iniziò Marcello Mastroianni, seguito da Paolo Panelli e sua moglie (fiorentina) Bice Valori: anche Alberto Sordi vi ebbe residenza per qualche tempo. Ma, molto prima di loro, negli anni venti, aveva scelto come luogo di vacanza al mare - su queste scogliere profumate di salmastro e di ragia di pino - un’altra genìa di artisti: la famiglia degli Spadolini (il padre illustratore famoso di libri per ragazzi, ed i figli: lo scrittore e l’architetto) che si trasferiva qui ogni estate dalla sua Firenze. E prima ancora, alla metà del secolo scorso, vi aveva dimora Diego Martelli che ospitava nella sua grande fattoria tra il mare e le colline, quei pittori che avrebbero formato la Scuola di Castiglioncello: Loro capo riconosciuto era Giovanni Fattori e qui lo avevano seguito Telèmaco Signorini, Raffaello Sernesi e tanti altri che avevano battagliato a Firenze contro la banalità dell’accademismo postrisorgimentale e dipingevano a macchia. Se ne parlerà più diffusamente più oltre. Sul promontorio di Castiglioncello, proprio ove era il fulcro della fattoria di Diego Martelli, sorse alla fine del secolo scorso il Castello Pasquini. 26 Prende nome dalla famiglia che volle quella costruzione in stile neogotico, che, oggi, è un centro polivalente di spettacoli musicali e coreografici, mostre d’arte a volte anche di alto livello, convegni scientifici, rappresentazioni teatrali, e quant’altro può attirare un pubblico sempre più esigente e colto. Il Castello Pasquini è anche la sede del Premio Castiglioncello, uno dei più importati premi italiani per la saggistica, che ha - curiosamente - anche una sezione dedicata alla letteratura turistica. Fregiarsi del titolo di vincitore di una delle sezioni del Premio Castiglioncello è onore e vanto di pochi saggisti italiani e di pochi e rari editori. La maggior fortuna turistico-mondana di Castiglioncello avvenne, però, nell’epoca a cavallo delle due guerre mondiali, perché proprio su questo piccolo promontorio si erano dati via via appuntamento • Luigi Pirandello con Marta Abba, • le sorelle Gramatica, e tutta una serie di intellettuali, come • Massimo Bontempelli, • Ugo Ojetti ed • Emilio Cecchi, e con lui sua figlia • Suso e suo genero • Fedele d’Amico. A Castiglioncello ha resistito all’usura del tempo una Torre Medicea, fatta costruire dalla Signoria fiorentina nel XVI secolo sotto Cosimo I, a difesa della zona dalle incursioni piratesche saracene che, fino all’Ottocento, erano molto frequenti su tutto il litorale tirrenico. E’ gemella a quella di Calafuria che, però, è meno rimaneggiata. A fianco della Torre di Castiglioncello, esisteva anche una caserma per la guarnigione fiorentina, andata perduta a seguito ai vari rimaneggiamenti subìti dal promontorio durante i secoli. 27 Durante i lavori per queste difese costiere rinascimentali andarono perduti, per esempio, pa- recchi ruderi che agli ingegneri fiorentini ed alle loro manovalanze interessavano ben poco. Erano i resti delle ville romane che sovrastavano un porto di epoca ellenistica; il tutto sorto su antichi insediamenti etruschi, ed erano la dimostrazione che il promontorio già nell’antichità era un luogo di delizie. Altri resti delle antiche civiltà furono trovati durante gli scavi per la costruzione della linea fer- roviaria: ma eravamo già nell’Ottocento e la coscienza archeologica si stava già affacciando, seppur pittorescamente, sul panorama culturale dell’Italietta dell’epoca. Fino a che non si occuparono della cosa prima i già citati Diego Martelli e Luigi Adriano Milani. Scavi ancora più recenti hanno portato alla luce molte altre tracce di queste tre civiltà sovrappostesi (l’etrusca, l’ellenistica e la romana): si possono ammirare presso il già citato Museo Archeologico di Rosignano Marittimo. A Castiglioncello esiste, come a Capri, una piazzetta: non è celebre come quella dell’isola dell’amore, ma via via è frequentata, durante l’estate, da personaggi vip o che si considerano tali. 7 QUERCIANELLA: UN CASTELLO PER IL MINISTRO DEGLI ESTERI **************************************************************** ’Aurelia prosegue sbirciante, ma con un percorso affascinante quasi a picco sul mare, ver- L so Quercianella, ultima propaggine meridionale del comune di Livorno, del quale è una frazione a metà strada tra l’elegante ed il balneare. Ci sono bagni di scoglio, piccoli approdi per la nautica minore ed una pittoresca insenatura alla foce del torrente Chioma, un fiumaccio che proviene dall’entroterra. Tutta questa zona tranquilla e molto borghesemente godereccia entrò repentinamente nella dio pauroso e di cronaca (nera) italiana di qualche estate fa perché fu scenario di un incenproporzioni gigantesche; mandò in fumo e cenere, in giorni e giorni di fiam- me e colonne di fumo nerastro, intere pinete e buona parte della macchia mediterranea. 28 Furono impiegati, per lo spegnimento dell’incendio, quasi tutti i vigili del fuoco della Toscana e delle regioni circonvicine, un esercito di volontari di tutte le pubbliche assistenze e di tutte le Misericordie del circondario, nonché alcuni reparti di paracadutisti dellaFolgore di stanza a Livorno ed a Pisa. Per qualche anno fu desolazione e morte, ma chi passa oggi da queste parti per la prima volta non si accorge di nulla: ad eccezione dei pini dei quali sono rimasti i fusti scheletriti (il pino, come tutte le resinose non ricresce dopo che è bruciato) tutta la macchia mediterranea è risorta ed è oggi di nuovo verdeggiante con i suoi cespugli di corbézzolo, i suoi lecci, il suo lentisco e, a giugno, le improvvise esplosioni gialle della ginestra. Anche Quercianella ha il suo bel castello che è a picco sul mare. Fu, prima, un fortilizio fiorentino a difesa della costa, e, poi, residenza della famiglia Sonnino.. Faceva parte di questa famiglia di ricchi possidenti pisani di origine ebraica Sidney Sonnino, parlamentare ed uomo politico della belle-époque. E’ rimasto nella storia d’Italia per essere stato ministro degli esteri quando l’Italia dichiarò guerra, nel 1915, agli Imperi Centrali: quella Grande Guerra che il vecchio e mite papa genovese Benedetto XV definì un’inutile strage. La sua città natale, Pisa, ha dedicato a Sidney Sonnino un lungarno: quello dove c’è l’ex convento delle Benedettine, ora elegante centro convegni della locale Cassa di Risparmio. La stazioncina ferroviaria di Quercianella si chiamava fino a qualche anno fa QuercianellaSonnino: seguendo la moda imperante negli anni ‘20-30, era stato aggiunto il cognome della casata-genius-loci al toponimo originario che sembrava un po’ banale: un’operazione tipo Torre del Lago-Puccini o Castagneto-Carducci insomma. 8 SULLE RAMPE DEL ROMITO: INCONTRI RAVVICINATI ***************************************************** 29 a Quercianella in poi, l’Aurelia corre verso Livorno quasi a piombo sul mare: è la zo- D na meglio conosciuta come Il Romito. Nessuno, oggi, ricorda che il luogo si chiama così perché vi abitavano nei secoli bui alcuni eremiti; come accadde anche a Firenze ed a Pontedera ove due rioni si chiamano anch’essi Romito. Oggi Il Romito è subito Il Sorpasso, ed è vero. Proprio su queste curve Vittorio Gassmann e Jean-Louis Trintignant, giovani ed aitanti come due dèi greci, furono, nel celebre film bianco-e-nero degli anni ‘60, gli eroi spensierati di un’epoca che forse non tornerà mai più, col suo twist, le sue alfette, le sue ragazze con la coda di cavallo. E non solo: poco più oltre, c’è la Calafuria, località che ricorderà a qualche signore di mezz’età un altro film italiano degli anni ‘40, con Carlo Ninchi che faceva il camionista. Senz’altro la zona è estremamente pittoresca e ricorda di tanti altri cinematografari, pittori e letterati che vi si sono ispirati o che, livornesi di nascita o di adozione, al Romito almeno un bagno l’hanno fatto. Per esempio: • nella torre di Calafuria ha studio Alberto Fremura, vignettista, disegnatore umoristico ed illustratore fra i migliori d’Europa in questo momento. Ma nopn solo: il Romito è un nome che è caro a tutti gli sportivi italiani Era, ed è tuttora, il percorso di allenamento di quella miriade di corridori ciclisti toscani che hanno affollato, da quando esiste questo sport a livello professionsitico, le pagine dei quotidiani sportivi e non. • Gino Bartali, sopra tutti, poi • il povero Gastone Nencini, • Fiorenzo Magni, • i fratelli Maggini, e 30 • Franco Bitossi Cuorematto, tanto per citare i più famosi. Ma, prima di loro, anche • Bini, Bizzi e Di Paco (anni quaranta), e quel bravo passista di Sesto Fiorentino che risponde al nome di • Alfredo Martini (anni cinquanta): sì, proprio lui. E, cioè, colui che è stato il commisssario tecnico della nazionale dei professionisti per la bellezza di ventitré anni. Allora le citazioni si accavallano e ne viene fuori un affresco di personaggi illustri e non: Fra i pittori, • Giovanni Fattori, già citato come caposcuola dei Macchiaioli ottocenteschi, e • Amedeo Modigliani, il pittore maledetto del ‘900 morto a Parigi (abbreviato all’uso francese, il suo cognome suonava Modì, che si può scrivere anche Maudit: maledetto, appunto; se ne parlerà a lungo nel capitolo dedicato al Fosso Reale), • e tutta la serie infinita dei postmacchiaioli: Bartolena, Natali, i tre Tommasi, Benvenuti, Cappiello, Fanelli, Ghiglia, Kienerk, Liegi, Lloyd, Lori, Muller, Nomellini, Pagni, Puccini, Sforni, Torchi, che fu seguita dai pittori del Gruppo Labronico - esistente tuttora - di Romiti e Natali. E, poi ? Alla rinfusa: • Pietro Mascagni, musicista noto ai più solo per la Cavalleria Rusticana, ma invece anche autore di tante opere sperimentali come l’Iris, ed addirittura di operette come ‘Sì’ Recentemente ripescata dal dimenticatoio; • Francesco Domenico Guerrazzi, già citato, patriota e fecondo autore di romanzi storici e di drammoni che oggi nessuno recita più, come quello che aveva come sfondo un uxoricidio d’onore realmente avvenuto alla corte dei Medici, nella villa di Cerreto Guidi; 31 • Ranieri de’ Calzabigi , che fu il librettista nientemeno che dell’Orfeo ed Euridice di Willibald Christoph Gluck, l’iniziatore del melodramma moderno, e, per rimanere nel colto, quel • Giovanni De Gamerra, che firmò, per la ripresa di Dresda del 1794 (tre anni dopo la morte tuttora misteriosa del compositore), la traduzione italiana del libretto originale de Il Flauto Magico di W. A. Mozart. Per il Salisburghese aveva già scritto anche il libretto del Silla. E’ noto ai musicofili per alcune sue stramberie: scrisse i novantamila versi del poema satirico Corneide e, particolare macabro, conservò per più di vent’anni in casa sua la salma di sua moglie: si suppone che fosse mummificata. E, poi, • Galliano Masini, tenore lirico ed idolo delle folle degli anni Quaranta. Senza tenere in conto che al livornese Teatro Goldoni • Enrico Caruso conobbe quella che sarebbe divenuta sua moglie: la soprano fiorentina Ada Giachetti. Anche il Capo della Comunità Ebraica in Italia, • il Rabbino Elio Toaff, è livornese e fu, in gioventù, prima delle Leggi Razziali, l’ultimo allievo del Collegio Rabbinico Livornese, retto allora da suo padre Alfredo. Quest’ultimo, a sua volta, era uomo di grande cultura ed ebbe fra i suoi insegnanti Giovanni Pascoli e quel Rabbino Benamozegh al quale è intitolata l’attuale piazza della sinagoga. A Livorno, poi, è gloria cittadina uno dei due quotidiani toscani: nato da un’idea di un garibaldino, si chiamò per quasi un secolo “Il Telegrafo”. Oggi si chiama “Il Tirreno”, esce in formato tabloid ed è diretto da una signora bionda. Sia il vecchio Telegrafo che il nuovo Tirreno sono stati per anni palestra di penne divenute poi molto autorevoli, ed i giornalisti che vi hanno fatto gavetta non si contano più: molti, addirittura, sono assurti alla gloria televisiva, come 32 • Antonio Foresi, della Tivù di Stato, celebre per le sue corrispondenze da Bruxelles, • Gino Bacci di Tuttosport, ospite fisso fino a poco tempo fa dei vari processi di Aldo Biscardi, ed un altro famoso giornalista sportivo: • Ezio De Cesari, dalla voce tonante, che fu anche direttore del Corriere dello Sport-Stadio, scomparso nel ‘98 ed anche lui ospite per anni della popolare trasmissione televisiva; e, poi, • Vittorio Orefice, principe dei cronisti parlamentari e depositario di tutti i pettegolezzi della Roma dei Palazzi del Potere, che ci ha lasciato anche lui nel ‘98, e suo fratello • Gastone Ortona, indimenticato corrispondente RAI da Washington. Poi gli sportivi e, primo fra tutti, • Armando Picchi, il primo vero libero del calcio italiano, dell’Inter del Mago e la sua storica formazione:Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarnieri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez e Corso. Scomparso prematuramente, non fece a tempo a partecipare al campionato mondiale del ‘70 in Messico, ma è rimasto nel cuore di tutti gli italiani. Livorno gli ha intitolato il suo glorioso stadio comunale; poi • Federico Caprilli, che, nella belle-époque, fu il caposcuola a Pinerolo della monta all’italiana ed anticipò di molti decenni i fasti dei fratelli D’Inzeo. Anche a lui la sua città ha dedicato un famoso impianto sportivo: l’ippodromo cittadino che sorge, come l’impianto calcistico di cui sopra, nel rione dell’Ardenza in riva al Tirreno, • Nedo Nadi, il più grande fiorettista italiano di tutti i tempi, che, alle Olimpiadi degli anni venti, sbaragliò tutto il mondo schermistico allora conosciuto. E’ sepolto nel piccolo cimitero di Portofino a picco sul mare, e • i fratelli ed i cugini Montano, vera e propria dinastia di altri schermidori che sono ancora nella memoria collettiva degli italiani per le loro gesta alle Olimpiadi degli anni settanta. La finanza? 33 Livorno e dintorni non hanno mai avuto fra i loro abitanti gente ricca a palate né genii della borsa. Invece, c’è sempre stato molto popolino e molta piccola borghesia: tutti nati e cresciuti sulle banchine del porto o nelle migliaia di negozi che si affacciano sulle strade della città. Ma un’eccezione c’è: ed è • Carlo Azeglio Ciampi, che avrebbe potuto fare l’ottico come tanti suoi consanguinei se non avesse fatto carriera nella Banca d’Italia fino a diventarne Governatore: direttore generale, cioè. Poi, gli incarichi politici, con la poltrona di primo ministro, ma per poco tempo: quanto gli è bastato per portar l’Italia in Europa. E, infine, la presidenza della Repubblica. La sua prima visita ufficiale ad una città d’Italia l’ha voluta fare alla sua Livorno e, parlando a braccio ha detto di essere dispiaciuto di aver perduto l’accento livornese e il suo “caro e terribile dé’” Al che “Il vernacoliere”, mensile umoristico e beffardo, infarcito di battute da caserma ma unico superstite in Italia di questo genere di editoria, gli ribatteva: “Un bluffe. Perché non beve ponce, non dice parolacce, parla in punta di lingua. E quindi non è livornese.” C’è stato, però, un personaggio-simbolo di una certa Italia in via di sviluppo degli anni Trenta: quel • Guido Donegani, ingegnere e manager di portata europea che fece divenire la Montecatini da un’azienda mineraria qualunque (sfruttava le miniere di Montecatini Valdicècina, attuale provincia di Pisa, verso il Volterrano) a quel mostro di potenza chimica che,dopo essere passata fra molte mani e divenire Montedison dopo la fusione con la Edison, fu catapultata sulle pagine della cronaca nera con l’affaire-Gardini e relativo suicidio ai tempi di Mani Pulite. A lui si deve, nella sua città natale, la creazione dell’attuale raffineria di Stagno - già citata - nata ai tempi dell’autarchia per produrre benzina dal petrolio greggio di pessima qualità che sgorgava da alcuni pozzi perforati in Albania l’anno prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Fu un’operazione finanziaria che piacque molto al regime dell’epoca. 34 E la politica, allora ? Tanta, a parole, e forse troppa: ed un panorama popolato di personaggi neanche di alto livello, se si eccettuano: • Costanzo Ciano, piccolo armatore, fegataccio da siluratore durante il primo conflitto mondiale e poi capo storico del fascismo livornese. Assurse alla carica di ministro dei trasporti durante il primo periodo del Ventennio e fu un infaticabile tagliatore di nastri e di posatore di prime pietre di opere del Regime. Soprattutto tronchi ferroviari nuovi e stazioni gigantesche, come quella della sua città. A Pisa c’è ancora qualche sopravvissuto dell’antifascismo che gli rimprovera il fatto di aver fatto traslocare da quella città a Livorno le officine delle FF.SS.; e suo figlio • Galeazzo, che, sposato con la primogenita di Benito Mussolini, fu ministro degli affari esteri durante il periodo del Patto di Monaco. Fu fucilato a Verona nel freddo autunno del ‘43 perché condannato per alto tradimento: aveva avuto la colpa di aver sottoscritto, il 25 Luglio precedente, l’ordine del giorno Grandi che decretò la caduta di suo suocero e di tutto il suo regime. Questo per quanto riguarda la destra; ma la sinistra ? Anche le pietre sanno che a Livorno, nel 1921, in clima di guerra civile strisciante, fu fondato • il Partito Comunista d’Italia. Ne era stato promotore un gruppo di dissidenti socialisti - allora chiamati massimalisti - che si ispiravano, più che al socialismo umanitario dei Turati e dei Treves, al pragmatismo bolscevico dei Lenin e dei Trozkji. I loro capi erano Bordiga e Gramsci che, però, non erano affatto livornesi: uno era napoletano e l’altro sardo. Al secondo ogni città d’Italia ha dedicato una strada od una piazza: al primo, niente. Aveva avuto anche lui delle colpe: la più grave quella aver capito, una decina d’anni dopo il congresso di Livorno, cosa stava succedendo in Russia e nel nascente impero sovietico. E il centro? Non ha dato molto, nell’ultimo secolo; forse solo 35 • Gianfranco Merli, democristiano della Base e anonimo deputato per diverse legislature, che ha però legato il suo nome alla severa legge sullo smaltimento delle acque: la Legge Merli, appunto. 9 UN PASSO INDIETRO: LA SCUOLA DI CASTIGLIONCELLO ******************************************************** acciamo un passo indietro, proprio come nei romanzi d’appendice. F Torniamo quindi a Castiglioncello ed al suo Castello Pasquini. Qui, come già accennato più innanzi, esisteva nel secolo scorso, la villa di Diego Martelli, grande proprietario terriero, critico d’arte, collezionista, mercante d’arte e amico di alcuni Impressionisti francesi. Conosciuti nell’ambiente della scapigliatura fiorentina alcuni pittori che si battevano contro l’accademismo imperante, li aveva invitati più volte a soggiornare a Castiglioncelllo, ospitandoli presso la sua villa. I soggiorni erano abbastanza continuativi e lunghi. Il luogo era ameno, il clima più che favorevole, l’anfitrione sempre disponibile. Cosa di meglio, al posto delle fumose trattorie fiorentine e del clima non certo mediterraneo della città-capoluogo? Fu così che, capeggiata da Giovanni Fattori , si avvicendò nella villa Martelli gente che sarebbe presto passata alla storia dell’arte moderna italiana. Fattori era nato a Livorno e quindi conosceva bene le delizie della costa livornese: però era cresciuto artisticamente a Firenze nell’ambiente dell’Accademia di Belle Arti. Grande illustratore di battaglie risorgimentali - da poco si erano spente le èco della terza guerra d’Indipendenza - e grande acquafortista, entrò in forte polemica coi suoi colleghi perché cominciò a dipingere non solo in studio, ma anche all’aperto. 36 Dipinse scene di vita quotidiana dei dintorni di Firenze in quadri di non grandi dimensioni, ove però l’elemento di maggior spicco non era né il soggetto né il suo ambiente, ma la luce. E per raggiungere l’effetto che si prefiggeva, dipingeva sciabolate di luce con pennellate larghe: quasi macchie di colore disteso alla buona. Così nacque alla chetichella, in una Firenze che non era ancora salita al rango di capitale d’Italia ma che viveva come sempre di ricordi, la scuola della Macchia. I suoi adepti furono chiamati ironicamente Macchiaioli. Di Giovanni Fattori pittore sono noti anche al grande pubblico sia le grandi tele di taglie risorgimentali e le opere di ambiente militare, sia quelle ispirate alla vita dei bat- contadini e dei bùtteri della Maremma Toscana. Celebri nell’aneddotica fattoriana anche le sue tavolette ora veri e propri pezzi da museo trattate dalle aste internazionali a prezzi da capogiro - ri- cavate da coperchi delle scatole dei suoi inseparabili sigari. Come incisore ed acquafortista ha lasciato centinaia di opere, quasi tutte ispirate ai temi dominanti della sua pittura: la vita militare e quella delle campagne.. La sua città natale gli ha dedicato una strada anonima non lontana dalla stazione centrale ed il museo civico, ove si trovano molte opere sue e dei suoi seguaci. Il Museo Fattori è ospitato da pochi anni nella splendida Villa Mimbelli, non lontana dall’Accademia Navale, che fu di proprietà di un ammiraglio della Regia Marina discendente di una ricca famiglia di origine dalmata. Precedentemente, aveva sede nella Villa Fabbricotti, che fu fatta costruire nell’attuale cuore di Livorno dall’omonima famiglia carrarese di magnati ottocenteschi del marmo. Agiato e senza eredi, l’Ammiraglio Mimbelli lasciò la villa - un piccolo capolavoro dello stile eclettico - alla comunità. Dopo varie peripezie ed il rischio di venir distrutta dai bombardamenti alleati, dagli acquartieramenti dei vari eserciti di passaggio durante il secondo conflitto mondiale, prima, e dagli sfollati, poi, Villa Mimbelli è stata riportata da pochi anni al suo antico splendore dopo un sapiente e costosissimo restauro. 37 Reinaugurata nel 1994, ospita, oltre al Museo Fattori, mostre d’alto livello imperniate sulla rivalutazione della pittura italiana dell’Otto-Novecento. Giovanni Fattori ed i suoi seguaci, ospiti di Diego Martelli a Castiglioncello, crearono in quella villa sul mare un vero e proprio cenacolo ed il loro lavoro in comune fu un continuo fervore di scoperte e di iniziative. Era nata la Scuola di Castiglioncello. Qualche nome dei discepoli? Giuseppe Abbati, Vincenzo Cabianca, Giovanni Boldini, Nino Costa, Silvestro Lega, (già citato a proposito di Gabbro), Telèmaco Signorini, Federico Zandoméneghi, Raffaello Sernesi ed Odoardo Borrani. Questi ultimi due, poi, erano stati fino dal 1861 assidui frequentatori estivi dellaMontagna Pistoiese, ove dipinsero dal vero i pascoli e le campagne intorno a San Marcello. Di lì, trasmisero il fascino di quei monti e delle loro povere genti all’ambienteartistico fiorentino che viveva le sue battaglie verbali tra un ponce al Caffè Michelangelo ed una trippa da Gigi Porco, e non solo a quello. Insieme ad altri pittori macchiaioli, fra i quali * lo stesso Fattori la cui moglie era di quelle parti, * l’emiliano Giovanni Boldini che affrescò la villa di un inglese ed 38 * il pugliese Giuseppe De Nittis che entusiasmò Adriano Cecioni, che della Macchia fu il rico, diedero vita ad una corrente premacchiaiola che alcuni eruditi chiamarono poi teo- Scuola di San Marcello. I loro furono i primi paesaggi dipinti all’aperto e dal vero in Italia nel secolo scorso, e ne rife- rì, sei anni dopo, Telèmaco Signorini sul Gazzettino delle Arti del Disegno che si pubblicava a Firenze. Ne dissertò anche e a lungo il già citato Adriano Cecioni. Poi venne Diego Martelli, la sua munificenza, la sua villa sul mare e la Scuola di Castiglioncello. Alcuni pittori della congrega si recarono a Parigi, forse attratti dalle frequentazioni del Martelli con l’ambiente degli Impressionisti francesi. Parigi era allora, nel periodo della Terza Repubblica nata sulle ceneri del Secondo Impero dopo la disfatta di Sedan ed i tragici fatti della Comune - non solo il faro della civiltà per tutte le arti, ma anche il fulcro mondiale di tutte le mode e di tutte le tendenze. I suoi salons andavano per la maggiore ed accedervi era, se non impossibile, almeno ifficile se uno era straniero e per di più macaronì. Qualcuno, come Boldini, ebbe successo e si fermò a Parigi; altri mestamente tornarono in To- scana rifacendo la strada percorsa all’andata. Furono lunghi giorni di viaggio su treni fumiganti sulle linea Parigi-Modane-Torino, appena costruita dalla Société des Chemins-de-Fer de la Méditerranée che aveva avuto fra i fondatori quel Luigi De Ferrari Duca di Galliera, nobile finanziere genovese che fu grandioso protagonista della vita brillante della capitale durante la belle-époque insieme a ua bella moglie Maria, che, rimastane vedova, sarebbe divenuta, poi, nella natìa Genova, una contraltare italiana della regina Vittoria d’Inghilterra. . 39 10 MONTENERO: DUE DIVI DELL’OPERA ED UN SANTUARIO PER TUTTA LA REGIONE ************************************************************************** orniamo sull’Aurelia: a chi si dirige da Quercianella verso Livorno-città, T sulla sinistra appaiono due torri, distanziate tra di loro da qualche chilometro: sono rispettivamente: • la Torre di Calafuria della quale si è già accennato a proposito di Alberto Fremura, • la Torre del Boccale, che fa parte di un complesso privato. Erano due torri di guardia fatte costruire dai Fiorentini per la difesa della costa dalle solite incur-sioni piratesche. Tutt’intorno, ora, si estende la riserva biogenetica di Calafuria, gestita dall’ Am-ministrazione Provinciale di Livorno come quella analoga dei Tòmboli (o dune) di Cècina. Anche Castello Sonnino di Quercianella, del quale si è già detto, sorge sui ruderi di un’altra torre di guardia fiorentina, fatta costruire colà da Cosimo III Medici. • sulla destra, invece, trionfa la vegetazione mediterranea della riserva. Tutt’ad un tratto, però, delle frecce segnaletiche che indicano una strada in salita per Castellaccio e Montenero. La prima di queste due località interessa marginalmente perché • Castellaccio è soprattutto il sito di molti ripetitori della televisione: un posto, insomma, sul tipo del Monte Serra quello “...per cui i Pisan veder Lucca non ponno”. La località, anche se non molto alta sul livello del mare, è fresca perché immersa - per usare un’espressione banale da agenzia immobiliare - nel verde del Parco delle Colline Livornesi. La seconda, invece, è un mito perché • Montenero è conosciuta in tutta la Toscana - ed anche in altre regioni circonvicine - per la presenza di un famoso santuario mariano. Alla collina di Montenero ed al suo santuario si può accedere percorrendo due diverse vie: 40 • quella già citata e che si diparte dall’Aurelia, e • quella che sale fino al santuario dalla Piazza delle Carrozze, a Montenero Basso. La prima delle due strade si inerpica sulla collina attraversando una zona quasi del tutto disabitata ma verdeggiante di macchia mediterranea, ed arriva al complesso mariano da sud. Non presenta alcuna attrattiva se non alcuni squarci di panorama sulla costa sottostante e sul mare. A chi ha fretta, consigliamo senz’altro questa prima strada. Ma chi ha un po’ di pazienza e vuol godersi davvero l’atmosfera di Montenero e del suo santuario mariano, deve proseguire qualche chilometro e, giungere ad un bivio che ha al suo vertice una chiesa - detta dell’Apparizione - moderna quanto basta a renderla anonima se non fosse abbellita da un mosaico che ne adorna il frontone. Quivi giunto, deve svoltare a destra e proseguire fino alla Piazza delle Carrozze. Il rione si chiama Montenero Basso per distinguerlo, ovviamente, da quello Alto: è, comunque, una zona residenziale di qualche pretesa, soprattutto per la mancanza assoluta di grandi condomini e la presenza di ville, villini, palazzine e quelli che in Toscana si chiamano terratetti. Anzi; vi si respira un’atmosfera un po’ campagnola. A metà strada circa, tra il bivio con chiesa di cui sopra e la Piazza delle Carrozze, in un iccolo cimitero che è a destra di chi procede, sono sepolti Roberto Stagno e Gemma Bellincioni. Ci si può chiedere: chi erano costoro? Possono venire in soccorso amici (se uno li ha) che gravitano in ambienti tipo Amici della Lirica, che potranno dire che i due furono grandi cantanti d’opera del periodo a cavallo fra i due secoli. Aggiungiamo noi che Roberto Stagno e Gemma Bellincioni furono, soprattutto, due divi: erano una bella coppia, bell’uomo lui e bella donna lei, e lavoravano spesso assieme. Lei, fu addirittura la prima interprete di Santuzza nella Cavalleria Rusticana del suo concittadino Pietro Mascagni. 41 Dopo anni di successi in tutto il mondo, la coppia lirica si ritirò poco lontano da dove è sepolta: in quella Villa Morazzana che è stata trasformata da pochi anni in un bel centro convegni con annesso albergo della gioventù. Chi ha qualche capello bianco in più, ricorderà con nostalgia la canzoncina che fu uno dei cavalli di battaglia del Quartetto Cetra negli anni Cinquanta-Sessanta; quel “Palco della Scala” nella quale si accennava alla coppia livornese così: “Quanta, quanta gente nella sala, “c’è tutta Milano in gran toilette, “per ascoltar Tamagno, “la Bellincioni e Stagno...” La canzoncina, un vero capolavoro di garbo, aveva come autori dei versi Garinei e Giovannini: autore della musica non poteva non essere di Gorni Kramer. Era il momento più felice della commedia musicale italiana, che non si ripeterà mai più. La Piazza delle Carrozze è detta così perché qui si davano convegno i devoti della Madonna di Montenero che giungevano in pellegrinaggio dalla Piana di Pisa, dalla Lucchesia e dai vari paesotti della costa livornese che non si chiamava ancora Costa degli Etruschi. Arrivavano su barrocci ed altri mezzi ippotrainati ed, all’inizio della salita verso il santuario, si univano ai signorotti che qui arrivavano in carrozza. Delle due classi sociali, molti erano davvero dei devoti tant’è vero che facevano la salita al santuario con nelle scarpe dei fagioli o dei ceci in atto di penitenza. Con l’andar del tempo, il santuario dedicato a Nostra Signora delle Grazie - Madonna di Montenero tout-court, per i livornesi - divenne mèta di pellegrinaggi da tutta l’altra Toscana: dal Fiorentino, dal Valdarno, dalla Versilia, dalla zona delle Apuane, dal Casentino, dalla Maremma e dai lontani Mugello, Valtiberina e Lunigiana. Non c’è, oggi, una parrocchia della Toscana che non organizzi annualmente un pellegrinaggio fino a quella collina che si affaccia sulla città di Livorno e sulla sua costa meridionale. 42 Negli anni Quaranta, Pio XII dichiarò solennemente la Madonna di Montenero patrona della Toscana, e da allora ogni comune della regione ha fatto affiggere, in una galleria adiacente alla chiesa, .il suo stemma. Ce ne sono di tutti i tipi: da quelli in maiolica invetriata ad imitazione dei lavori dei Della Robbia e dei loro seguaci a quelli in marmo scolpito; da quelli più poverini a quelli ricchi di istoriazioni. Ma se per il popolo dei devoti il salire sul colle di Montenero è tuttora atto di fede e per taluni anche di penitenza, per altri, invece, era un’occasione di festa e di bisboccia. Ne è testimonianza una farsa in vernacolo livornese - autore Beppe Orlandi che fu un comico di varietà degli anni trenta - che è stata recuperata da poco come esempio di quel teatro tra il bècero ed il nazionalpopolare a base di qui-pro-quo, di doppisensi, battutacce da avanspettacolo e con attori en-travesti, che furoreggiò in Toscana - soprattutto a Firenze, a Livorno ed a Pisa - nel periodo a cavallo delle due guerre ed anche oltre. La farsa vernacolare è intitolata “La ribotta di Montinero”, ove ribotta sta per bisboccia e Montinero sta bene così, perché è la pronuncia livornese del topònimo Montenero. In Piazza delle Carrozze è situata la stazioncina di partenza della funicolare per il santuario: fu inaugurata nel 1908 ed è una delle tre esistenti in Toscana. Un’altra altra è quella che collega • Montecatini Terme con Montecatini Alto e che ha celebrato da poco il suo secolo di vita, metre la terza è stata attivata da pochissimo tempo a • Certaldo e collega la stazione ferroviaria di quella cittadina della Valdelsa al suo centro medioevale. Il santuario si presenta subito con una breve scalinata che porta sul sagrato, ed il visitatore ha di fronte a sé, • al centro, una foresteria o casa del pellegrino, • alla sua sinistra, la basilica preceduta da un porticato, ed, 43 • a destra, il Famedio Livornese. Quest’ultima costruzione ad arcate fu fortemente voluta e fatta realizzare dallo scrittore patriota Francesco Domenico Guerrazzi già più volte citato, che vi ebbe anche sepoltura in una cappella centrale. L’intendimento del Guerrazzi era non tanto di far seppellire sotto quei portici i suoi concittadini più illustri dell’epoca e far di quel luogo qualcosa di più di un cimitero, quanto far ricordare, davanti alla basilica della dedicata alla Vergine miracolosa e per mezzo dell’apposizione di lapidi, i livornesi che si sarebbero resi famosi nel tempo. E’ così che il visitatore può scoprire che ci sono le lapidi dedicate non solo a grandi letterati od illustri scienziati ottocenteschi ormai dimenticati, ma anche quelle che ricordano, ad esempio, * Dario Niccodemi, commediografo e grande uomo di teatro in voga negli anni Venti- Trenta. Fu autore di celebri lavori teatrali come “La Nemica” e “La maestrina” che fecero spargere fiumi di lacrime ad almeno due generazioni di italiane; * Giovanni Marradi, delicato poeta di ogni livornesità: le sue liriche erano nelle antologie Regi Ginnasi, ed al quale Livorno ha intitolato una delle sua strade più centrali ed dei eleganti, e * Giosuè Borsi, giovane e brillante giornalista e scrittore cattolico dei primi anni del secolo, destinato ad un grande avvenire se non fosse caduto sul Carso poco dopo l’inizio del primo conflitto mondiale al quale aveva voluto partecipare da volontario. Altre lapidi ricordano Giovanni Fattori, Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni, già citati in questo libello, ma anche Mario Puccini, tanti altri coloristi postmacchiaioli e Paolo Emilio Demi, scultore neoclassico ed autore del monumento livornese a Leopoldo II di Asburgo-Lorena, granduca di Toscana al quale la città deve molto. La basilica, preceduta come già detto da un portico, fu invece edificata nel 1710 da Giovanni Del Fantasia, architetto gradito agli ultimi Medici , che demolì la chiesetta antecedente. Quest’ultima era stata costruita nel 1390 sul luogo ove era avvenuta un’apparizione della Vergine, effigiata poi in un fondo-oro che appare tuttora sull’altare maggiore. 44 Il santuario mariano di Montenero è amorevolmente retto da secoli dall’Ordine dei Vallombrosani, uno dei tanti rami del monachesimo benedettino, così chiamato perché ha la casa-madre a Vallombrosa, altro celebre santuario e centro monastico nel cuore dell’Appennino, ma non lontano da Firenze. L’interno è tipico del periodo settecentesco con ricchezza di ornati e di dorature, affreschi e soffitti dipinti dal Galletti, autore anche di altrettante tele poste nelle sei cappelle laterali. Ai lati dell’altare maggiore, due statue raffigurano San Bernardo e San Giovanni Gualberto, fondatore dell’ordine vallombrosano. In alcune gallerie che conducono al chiostro, ed alle quali si accede da una porta laterale, sono affisse ed appese migliaia di ex-voto, tutti commoventi e pietosamente ingenui. I santuari mariani italiani ne sono pieni, ma quelli di Montenero sono un po’ particolari perché vi si riconosce una devozione popolare antica e profonda che contrasta con linguaggio attuale degli abitanti di Livorno, piuttosto inclini a sacramentare in ogni occasione. Alle spalle della collina di Montenero si estende, su di una superficie di 1.500 ettari a protezione integrale, il primo nucleo del Parco Provinciale delle Colline Livornesi. A questa considerevole estensione di terreni quasi totalmente boscosi, si devono aggiun- gere altri 2.000 ettari di Aree Naturali Protette facenti parte dei territori dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano, nelle quali sono presenti alcune attività artigianali e commerciali e dove è possibile, con molti limiti, anche la caccia. I confini della grande riserva naturale sono ancora in via di definizione e, solamente quando sa- ranno superate diverse pratiche burocratiche, il progetto di grande parco costiero sarà attuato. Sono previste fin da ora, agli ingressi del Parco, alcune porte attraversarlo le quali si potrebbe accedervi, e percorrerlo a piedi od in bici od a cavallo, seguendo alcuni percorsi quali: * un percorso religioso che, partendo dall’eremo della Sambuca, fino ad adesso quasi inaccessibile ma in fase di restauro, conduce al santuario di Montenero, od 45 * un percorso naturale, che prenda avvio dalla zona di Calafuria, sul mare, e si spinga all’interno, sempre verso Montenero, od * un percorso archeologico che valorizzi alcune importanti tracce del passato come l’acquedotto lorenese di Cològnole, od, infine, * un percorso di paesaggio che permetta la riscoperta dei mulini e delle altre costruzioni rurali che erano presenti in loco in abbondanza fino all’abbandono delle campagne. A questi percorsi dovrebbero aggiungersene degli altri che, nel quadro del programma “A cavallo (o più semplicemente in bici) nei parchi” da tempo allo studio della Regione To- scana, dovrebbero portare molto più a sud, fino all’oasi di Orti-Bottagone ed al Parco di Montioni, nelle Colline Metallifere. 11 A LIVORNO TUTTO E’ GRANDE: VIE, PIAZZE, PALAZZI, TEATRI E CINEMA ************************************************************************* 46 al santuario di Montenero si può riprendere la funicolare, tornare sulla Piazza delle D Carrozze e riprendere il cammino verso l’Aurelia ripassando, prima, davanti al cimitero ove sono sepolti i due cantanti-divi dei primi del secolo e, poi, sull’incrocio, davanti alla chiesa con mosaico sul frontone. Si riprende, quindi, la strada verso destra, e cioè verso Nord, ed in breve si soprattassa il rio Ardenza. Questo torrente - come tanti altri in Toscana (e non solo in questa regione) - è quasi sempre in secco, spesso è ridotto a discarica di ogni bendiddio materassi e frigoriferi compresi, non ha alcuna attrattiva dal punto di vista pittorico; non ha, insomma, nulla che lo contraddistingua da tutti i torrenti d’Italia. Però, come tutti i torrenti che si rispettino, basta che piova per una settimana consecutiva e diventa una vera furia della natura. Non sono passati molti anni da quando il rio Ardenza mandò a bagnomaria, dopo qualche giorno di pioggia, tutta la vasta zona che è alle falde della collina di Montenero, con scene consuete in Valdarno: immense distese d’acqua putrida sulle quali galleggiano tutti i reliquari del consumismo, gente in canotto a salvare il salvabile, e, poi, tutti insieme appassionatamente a ricostruire il ricostruibile tra un mòccolo e l’altro. Montenero fa già parte del comune di Livorno, che è abbastanza esteso. Infatti, il suo territorio parte dai confini con Pisa e si dipana lungo la costa oltre Quercianella fino quasi a Castiglioncello. Ed è proprio oltrepassato il rio Ardenza che inizia da sud l’agglomerato urbano della città di Livorno che inizia con i rioni di Antignano e di Ardenza, ambedue se non proprio sulle rive del mare, almeno non molto lontano dalla costa, in questo punto ancora tutta scogli e spiaggette di sabbia di grana grossa. Qui occorre, però, fare una piccola parentesi a base di sociologia a buon mercato. Bisogna partire da Lucca, perché in Toscana si dice che si va a Lucca per prendere il garbo: e questo è dovuto al fatto che sembra che la gente lucchese sia molto più gentile rispetto al modo di 47 fare - e di agire - del resto della popolazione della regione. Anche la parlata dei lucchesi è più dolce rispetto ai vari vernacoli della Toscana interna o di quella litoranea: i lucchesi non hanno al posto della c dura l'acca aspirata dei fiorentini (che dicono buha al posto di buca), né propendono alla g come i versiliesi ed i garfagnini (che dicono spesso buga), né tolgono del tutto la famosa c dura di cui sopra come i pisani ed i livornesi (che dicono bua e buonanotte). Accadeva allora che gente dei contadi pisani, pistoiesi e fiorentini che andavano a far le gite coi treni popolari a Lucca, vi prendessero, sì, il garbo, ma si accorgessero che era una città vecchiotta, tutta negozietti minuscoli: sul Fillungo non mancavano neanche vecchi empori con esposizione di caratelli di aringhe e salacche. Cosa che non accadde quando scoprirono Livorno. A Livorno, invece, la gente era ordinaria (non aveva il garbo dei lucchesi, insomma) ma tutto intorno era qualunque cosa era grande, se non addirittura gigantesca: * i negozi avevano tutti tre o quattro occhi e le loro vetrine erano stracolme di ogni tipo di merce, * le strade erano esageratamente larghe, i viali erano tutti dritti come fusi, * la stazione centrale era tanto grande che sembrava non finisse mai, * e di stazioni Livorno ne aveva anche altre tre, * i martelli pneumatici degli operai del cantiere navale facevano sulle lamiere delle navi in co- struzione un fracasso mai allora udito nelle campagne toscane, * il porto era tutto un formicolio di navi dalle ciminiere fumiganti e di barche di ogni genere, * i negozi rigurgitavano di ogni bendiddio (e non c’erano ancora i supermercati), e * persino le pareti delle botteghe dei barbieri erano tutte tappezzate di quadri. Ed, infatti, tutto è ancora così, tant’è vero che il piatto che più livornese non si può è il cacciucco: l’unica parola del vocabolario italiano che contenga cinque c. Livorno è città di provincia, ma grande. • Grande si chiama la sua via principale che conduce dalla grande Piazza della Repubblica - una volta detta più congruamente il Voltone - al porto, e vi si affaccia 48 • il politeama cittadino che si chiama, manco a farlo apposta, La Gran Guardia, • Grande si chiama anche la piazza del duomo che divide in due la Via Grande: ed è inutile aggiungere che vi si affaccia il Palazzo Grande che ospita il Cinema Grande La Via Grande, poi, secondo alcuni, si divide in * Prima Via Grande (quella che va dal duomo alla Piazza della Repubblica) e * Seconda Via Grande (quella che dal duomo conduce al Porto Mediceo). Poi, altre grandezze: • un grosso deposito d’acqua che, dal suo frontone a forma di conchiglia, è divenuto uno dei simboli della città, non è semplicemente una cisterna, ma Il Cisternone, • i prigionieri saraceni bronzei di Pietro Tacca (detti i Mori), incatenati alla base del monumento a Ferdinando I de’ Medici non possono essere che quattro; • il riconoscimento della città alla dinastia dei Lorena che tanto si adoperò per il suo sviluppo non potevano essere che due grandi statue e non una sola come a Pisa, in Piazza Santa Caterina,. Sono in bella vista nella • enorme piazza, che sembrerebbe concepita da Giorgio De Chirico, nata sulla copertura di uno dei canali che attraversano la città ed alla quale si è appena accennato, e, • dall’età rinascimentale in poi, infine, la difesa di Livorno, che era poco più che un borgo di poche catapecchie, era affidata non ad un solo, ma a due fortilizi tuttora esistenti: * la Fortezza Vecchia e * quella Nuova. Come città portuale, poi, Livorno ha una peculiarità che altre non possedevano: aveva lo spazio, tanto grande spazio che non hanno né la • Genova circondata da monti scoscesi, né la • Napoli so praffatta da una metropoli sovrappopolata e brulicante, né la • Venezia con il suo scrigno di bellezze. Commento [*1]: Pagina: 41 49 Infatti, malgrado che il suo porto vivacchiasse alla bell’e meglio tra una bega sindacale e l’altra, la città di Livorno continuò - fino agli anni Sessanta - la sua vita mercantile circondata da enormi spazi vuoti, campagne brulle che nessuno avrebbe mai coltivato perché erano i resti melmosi di paludi prosciugate appena qualche decennio prima, Se ne accorsero ben presto, all’inizio dell’èra dei contenitori, gli armatori estremorientali e quelli nordeuropei, le case di spedizioni svizzere e tedesche, le agenzie marittime del Nord Italia: tutta gente occhiuta ma affamata di spazio. Da allora fu tutta una frenesia da occupazione di spazi alla periferia nord, dove la città finisce col grande cimiteri suburbano dei Lupi ed iniziava la campagna. Ne trovò giovamento tutta la città perché il suo porto dovette adeguarsi investendo nelle nuove tecnologie di carico e scarico dei nuovi feticci; estesissimi depositi di containers sostituirono all’aperto docks che in porto stavano andando in malora dalla vecchiaia; centinaia se non migliaia di automobili di ogni provenienza europea furono stoccate nella pianura costiera pronte per l’imbarco verso l’Oltremare. Iniziò la conta di chi, fra i porti italiani movimentava più contenitori, perché di lì iniziava la nuova prosperità. Poi venne la frenesia da traghetto, perché nel vecchio Porto Mediceo, alle navi per le isole dell’Arcipelago Toscano ed ai loro tristi carichi di ergastolani in manette, si aggiunsero presto quelle per le isole maggiori cariche di vacanzieri vocianti e di autotreni stivati di ogni merce possibile. Gli italiani e gli europei avevano scoperto, infatti, che la Sardegna e la Sicilia si potevano raggiungere via nave non solo dalle lontana Civitavecchia e della ancora più lontana Napoli, ma anche da un porto meno sovraffollato di quello di Genova : gli armatori si adeguarono. Poi fu scoperta la Corsica, e ci s'accorse che non c’era bisogno di andare ad imbarcarsi a Nizza o a Marsiglia, quando l’isola è quasi davanti a Livorno. Di più: ai contenitori, alle petroliere ed ai traghetti che fanno la gioia degli amanti delle statistiche si aggiunsero le navi da crociera, sempre più belle, sempre più eleganti, sempre più grandi e sempre più cariche di gente danarosa. 50 L’armamento ed i tour-operators suoi clienti avevano capito che Livorno è la porta della Toscana delle città d’arte, e fu così che qualche nave elegante e gremita di stranieri grondanti dollari e marchi aveva attraccato ad una calata dove una stazione marittima così così aveva preso il posto di un capannone dove, cinquant’anni prima, ai tempi del Piano Marshall e dell’UNRRA, arrivavano dagli USA gli stracci destinati ai cardatori di Prato. Poi, quasi tutti i croceristi finivano caricati su pullman fiorentini per improbabili quanto bersaglieresche visite guidate: • di un giorno, della Firenze dei gelati e delle pizze al taglio, e • di un pomeriggio, della Pisa dei brigidini di Lamporecchio, col rischio di confondere Cimabue con Bonanno e Michelangelo con Galileo. Qualcuno di loro, che Firenze e Pisa le conosceva già bene e che rifiutava questo tipo di turismo usa-e-getta, preferì, invece, rimanere nella città d’attracco e partire alla scoperta di una città che d’arte ne aveva, sì, ma che non sapeva metterla in bella vista, e si accorse che Livorno non era poi proprio da scartare. 51 12 UN LUNGOMARE SIGNORILE CON BARACCH(IN)E, RICORDI DI PITTORI. CAVALIERI E CALCIATORI ***************************************************************************** hiusa la parentesi sociologica, non resta che ricordare ai lettori un illustre carneade, forse C un antesignano della letteratura turistica: quel Prospero Fantuzzi, reggiano, che nel 1833 si recò nel Granducato di Toscana per un viaggio di lavoro e ne trasse un diario manoscritto che oggi è divenuto un volumetto dal titolo “I.P.Fantuzzi, viaggi geografici”. Nel suo diario, quest'austero signore dell’epoca della Restaurazione fa un racconto dal quale si ar-guirebbe che, a quell’epoca, a Pisa abbondassero “ricchezza e nobiltà veden- dosi signori e signorine riccamente vestite, moderne e gaje carrozze con fini cavalli” Di Pisa il buon Fantuzzi aveva anche decantato la “veduta del Lung’Arno...vi scorre in mezzo l’Arno, fiume reale, navigabile, per cui si veggono barche dappertutto ed eleganti buccentori a divertimento dei cittadini. Il fiume è rinserrato tra muraglie e vi si scende per scalinate.”, e aveva notato che, mentre nelle campagne reggiane “si veggono da per tutto carra con buoi a tre e quattro paia, vacche grasse e pingui, qui (ed, in altre parole, nelle campagne pisane) rara volta s’incontra un barroccio o volantino con un paio di bovi bianchi.” A far da contraltare alle presunte ricchezze e nobiltà viste a Pisa, ecco invece un’osservazione lapidaria del Fantuzzi su Livorno: “..in Livorno, città mercantile, non m’incappai che in mercanzie e dappertutto spirano contratti e cambiali.” Tale doveva, infatti, apparire al viaggiatore una città apparentemente senza storia, popolata di tipi neanche tanto raccomandabili tenuti a bada senza tanti complimenti da sbirri e guardie varie dei governi codini fedeli ai Lorenesi. Ma se questo accadeva nella prima metà dell’Ottocento, una vera e propria rivoluzione urbanistica e dei costumi avvenne nella seconda metà successiva del secolo, ed in quello che è appena spirato. Ne fa fede l’ingresso sud della città, da dove riprende il nostro viaggio. 52 Oltrepassato, dunque, il piccolo ed elegante abitato del rione di Antignano, seguito immediatamente dalla nuova urbanizzazione della Banditella, si arriva all’altro elegante rione dell’Ardenza vera e propria che prende nome dal fiumaccio di cuisi è già parlato. Quest’ultimo rione si divide in due parti: Ardenza-Terra ed Ardenza-Mare. La prima parte (detta a terra, in altre parole interna) è quella ove ha sede • la grande caserma e relativi impianti della divisione Folgore del corpo dei Paracadutisti e da dove l’Aurelia transita per proseguire verso il cuore della città attraversando prima • un villaggio di case popolari che ha il poetico nome di La Rosa, forse dovuto alla presenza in altri tempi di una fattoria la cui proprietaria - o la consorte del signorotto padrone delle terre - aveva un tale nome floreale, ed, infine, • una zona ove sono i cimiteri gestiti dalla locale Misericordia. La seconda parte (quella a mare) è facilmente raggiungibile deviando dall’Aurelia verso sinistra ad un bivio e seguendo la segnaletica. E’ , con Antignano, la parte signorile di Livorno, quella delle ville in stile liberty dei ricchi borghesi spesso dai cognomi stranieri, dei bagni eleganti, dei porticcioli e dei circoli velici, delle scuole per subacquei, delle baracchine, che non sono delle capanne da terzo mondo, ma dei bei bar con tanti tavolini all’aperto. Di qui si snoda il lungomare della città che si chiama Viale Italia e che inizia da una zona che porta il nome di Rotonda dell’Ardenza. E’ un boschetto di pini e lecci a pianta circolare, ideale per prendere il fresco d’estate, che ospita di volta in volta manifestazioni di ogni genere, da quelle politiche a quelle di artigianato, dai mercatini d’antiquariato alle gare estemporanee di pittura. Proprio con una ex-tempore degli anni cinquanta, pensata e organizzata da Mario Bor giotti buon pittore, grande amico di Pietro Mascagni, collezionista e mercante d’arte sopraffino - si riu- 53 scì a coagulare una messe piuttosto eterogenea di pittori per una gara all’aperto che presto a- vrebbe decretato l’inizio della fama nazionale della Rotonda. Non tutti sanno che Livorno è, oltre che città portuale ed operaia, anche città di pittori: non tan- to perché sua stata la culla di tutte le correnti postmacchiaiole, quanto perché, pennelli in mano, i suoi abitanti realizzano sogni neanche pensabili quando c’è l’incubo dell’orologio e del cartellino. E siccome i pittori, come tutti gli artisti, sono individualisti, la lite e l’improperio sono pane quotidiano. Mario Borgiotti riuscì, invece, a mettere d’accordo la falange di pittori livornesi e li mise in gara fra di loro a chi dipingeva meglio all’aperto, e la cose fece notizia: ne parlarono tutti i giornali locali e ne parlò perfino la RAI nei suoi notiziari regionali, da sempre fiorentinodipendenti. Fu così che alla falange dei livornesi si aggiunsero ben presto molti pittori convenuti per dipingere alla Rotonda da ogni parte d’Italia, perché, nel frattempo, Via Margutta a Roma e Via Bagutta a Milano stavano perdendo colpi su colpi, e la fama del Premio Rotonda fu presto consolidata. Senza tener in conto che il Borgiotti riuscì a convincere tutti i dirigenti delle industrie livornesi anche i più refrattari alle cose belle - a devolvere in premi-acquisto qualche biglietto da mille dell’epoca. Ora, a distanza di più di quarant’anni, i quadri premiati con questo ingegnoso sistema sono ancora appesi alle pareti delle algide sale dei consigli d’amministrazione e degli uffici di managers spocchiosi, e sono additati agli ospiti di riguardo come conquiste aziendali. Ora la grande ex-tempore della Rotonda non c’è più: c’è, invece, d’agosto, un premio di arti visive che il comune di Livorno ha giustamente intitolato a Mario Borgiotti. Dalla Rotonda il Viale Italia prosegue, alberato sul lato mare e senza alberi sul lato monte, lasciando spazio libero davanti alle ville liberty ed ai piccoli, eleganti condomini della Livorno-bene. Proseguendo verso Nord, e cioè verso il cuore della città, l’attenzione è attirata dalla presenza di una serie di costruzioni non eleganti ma che hanno la loro peculiarità: sono disposte ad esedra, e cioè a ferro di cavallo. 54 Sono quelli che comunemente sono chiamati i Casini dell’Ardenza e sono tredici palazzine d’epoca lorenese progettate da quell’arch. Cappellini che fu autore di molte costruzioni preunitarie nella città. Il viale prosegue toccando, • sul lato mare, un porticciolo turistico, mentre, • sul lato monte, le abitazioni lasciano posto ad una folta vegetazione spontanea circondata da muri e muretti. E’ la parte retrostante dell’Ippodromo Federico Caprilli, che ha il suo ingresso principale sulla via parallela che ha il nome poetico di Via dei Pensieri. La città di Livorno ha voluto intitolare l’ippodromo cittadino a quel grande personaggio concittadino che fu, appunto, Federico Caprilli che, a Pinerolo, alla scuola di Cavalleria, fu l’inventore se così si può dire - della monta all’italiana che fece conquistare ai nostri cavalieri glorie a bizzeffe alle Olimpiadi ed a tutti i concorsi di equitazione dei primi decenni del Novecento. All’Ippodromo Federico Caprilli si tengono prevalentemente riunioni di galoppo: durante l’estate molte di esse avvengono in notturna. Un altro impianto sportivo è poco lontano: è lo stadio calcistico comunale ove ha giocato, fino dagli anni Trenta, il Livorno Calcio. Quello - ma pochi lo ricordano: forse gli annuari - che, in periodo bellico, giunse a contrastare, l’egemonia del Torino. I suoi giocatori più rappresentativi furono Raccis e Degano: * il secondo era un’aletta velocissima e niente male; * il primo, invece, era un centravanti molto mobile che ebbe una carriera breve. Morì ancor giovane nel dopoguerra, prima della calata in Italia delle varie legioni straniere e degli eserciti di oriundi. 55 In questo momento, il Livorno non è niente di eccezionale e naviga spesso fra le secche della serie C. Malgrado abbia un pubblico fedele ed entusiasta, è spesso attraversato da crisi societarie che hanno visto avvicendarsi cogli anni presidenti danarosissimi provenienti dal Nord Italia e, fra di essi, un grossista di lampadari, un importatore di auto di lusso ed un autotrasportatore proprietario di una flotta di TIR. 13 L’ACCADEMIA NAVALE, L’AMMIRAGLIO TESTARDO ED UN LAZZARETTO SCOMPARSO *************************************************************************** oche centinaia di passi, e, sul lato mare, appare il complesso degli edifici che ospitano P l’Accademia Navale Italiana. Non hanno un’unità stilistica perché alcuni sono di chiara impronta ottocentesca ed altri piuttosto moderni. L’ingresso principale non ha nulla di trionfale, ma l’osservatore attento può intravedere l’alberatura-scuola sulla quale si esercitano gli allievi dell’Accademia, salendo e discendendo fra scale e cordami proprio come accadeva ai marinai dei romanzi di Emilio Salgari. Qui si formano, dopo anni di studi severi e di altrettanto severa disciplina, gli ufficiali della Marina Militare Italiana, risorta in questi ultimi cinquant’anni di pace sulle ceneri della Regia Marina, delle sue sconfitte del secondo conflitto mondiale e delle storie ambigue di “Navi e Poltrone”.. E’ l’università della Marina ed iniziò a Livorno la propria attività nel 1881. Fino ad allora, di Accademie o Scuole per ufficiali della Regia Marina dello stato unitario ce n’erano la bellezza di due: • una a Genova ed era il proseguimento della Marina Militare Sarda, ed 56 • una a Napoli che proseguiva l’antica tradizione della marineria del Regno delle Due Sicilie. Fu l’ammiraglio Benedetto Brin che decise la fusione delle due scuole in un’unica Accademia Navale: e scelse come città ospitante la nuova scuola per ufficiali la pressoché sconosciuta Livorno. Non Venezia quindici anni prima ancora austriaca, né Genova o Napoli che avevano dato parecchie gatte da pelare al momento dello scioglimento delle loro due vecchie scuole, né La Spezia che per conto suo era già piazzaforte, ma una città toscana e per di più reduce da una crisi profonda determinatasi dall’abolizione, nel 1868, dei privilegi medicei del porto franco e dove il populismo la faceva da padrone. Dopo anni di diatribe, il testardo Benedetto Brin riuscì a spuntarla e fece nascere a Livorno la scuola per gli ufficiali della Regia Marina. All’ammiraglio fautore e realizzatore dell’Accademia Navale è dedicato un grande busto di bronzo che sovrasta dal suo basamento di marmo un giardino pubblico posto quasi di fronte all’ingresso della scuole per ufficiali. L’Accademia fu fatta costruire da Benedetto Brin sul luogo ove Pietro Leopoldo di AsburgoLorena aveva fatto costruire neanche un secolo prima un lazzaretto. Questo ospedale d’emergenza - che era intitolato a San Leopoldo in onore forse del lorenese - aveva sostituito un altro lazzaretto, chiamato di San Rocco, voluto da un Medici un paio di secoli prima e che era situato in una zona di fronte al mare, poco lontano dal porto. Il Lazzaretto di San Leopoldo serviva, come tutti i lazzaretti d’Italia e d’Europa, in caso non tanto di pestilenze di ormai manzoniana memoria, quanto di epidemie di tifo e colera, che nell’Ottocento erano sempre in agguato ovunque. Soprattutto nelle città portuali, dove l’igiene, sulle calate come nelle abitazioni, era ridotta ai minimi termini. Il Lazzaretto di San Leopoldo era sul mare e - oggi si direbbe così - immerso nel verde della macchia mediterranea. Forse per far prendere aria buona e salmastra ai ricoverati, dal momento che le nozioni della classe medica, in materia di malattie infettive, non andavano molto avanti. 57 Del Lazzaretto di San Leopoldo sappiamo che fosse composto da vari edifici dei quali non re- sta più nulla: è stata tramandato, invece, che c’era un palazzo, una elegante cappella, un porticciolo e numerosi locali ove venivano ospitati uomini, animali e merci in caso di quarantena. Oggi l’Accademia Navale, oltre ad essere il centro di formazione degli ufficiali della Marina, è anche una grande fucina sportiva. Ad ogni primavera, ad esempio, organizza le Giornate Veliche di Livorno che sono una serie di regate alle quali partecipano imbarcazioni appartenenti ad una ventina di classi di imbarcazioni a deriva ed a bulbo. E’ una grande festa del mare e della gioventù: nacque per caso qualche anno fa, ed è divenuta in breve tempo la più grande manifestazione velica dell’intero Mediterraneo. Uno spettacolo a parte, quando capita l’occasione, sono le uscite a mare delle due navi-scuola dell’Accademia: • la Vespucci, che tutti più o meno conoscono per averla vista in diverse occasioni televisive, e • l’Orsa Maggiore, più piccola ma per questo non meno bella. Sono due velieri di straordinaria eleganza che fanno la gioia dei fotografi, dilettanti e non. Sempre sul Viale Italia, all’altezza dell’Accademia Navale, due costruzioni ad arcate in uno stile floreal-monumentale di chiara origine ottocentesca - una a destra e l’altra a sinistra di chi viaggia sono tuttora chiamate Barriera Margherita. Erano l’entrata della città da sud, e facevano la funzione delle porte dell’antichità. Ma erano anche dei caselli di quel dazio - od imposta di consumo che fino all’entrata in vigore del regime IVA, era il maggior introito delle amministrazioni comunali italiane. La costruzione di destra porta tuttora la scritta lapidaria: Tramvie Elettriche Toscane, perché vi aveva sede il capolinea di quel tram Pisa-Livorno che tanti rimpianti ha lasciato nei vecchi pisani e nei vecchi livornesi che parlano ancora del loro trammino come di cosa ancora vivente. 58 14 ALTRI LAZZARETTI, UNA FONTE DI ACQUA VIVA E LA VILLA DELL’AMMIRAGLIO ************************************************************************* Che tutta questa parte sud della città attuale fosse non solo aperta campagna, ma tutto un lazzaretto lo dimostra il fatto che un altro terzo ospedale d’emergenza era situato anche a metà strada- ma leggermente più a monte - tra quello di San Rocco già citato e quello di San Leopoldo. Era il lazzaretto di San Jacopo: forse il primo ad essere stato costruito ed il primo ad essere stato demolito. Prendeva nome dall’Apostolo Giacomo (o Jacopo, o Iago secondo gli spagnoli) che è protettore da sempre dei malati e dei pellegrini e che, nei secoli scorsi, godeva di una particolare venerazione in tutta Europa. Leggenda vuole che nel Settecento, durante lo scavo di un canale di collegamento - forse un collettore di acque sporche - tra il lazzaretto di San Jacopo e quello di San Rocco, fosse scaturito di fronte al mare uno zampillo di acqua fresca e chiara: acqua viva, insomma. Ed, infatti, a pochi passi dall’Accademia, ecco sul mare la chiesa di San Jacopo in Acquaviva che vuole ricordare all’ignaro passante sia il lazzaretto sia la fonte scaturita durante lo scavo settecentesco. La chiesa confina con l’Accademia, tant’è vero che il suo lato sinistro rispetto alla facciata è circondato da una rete metallica che delimita la zona militare. Dietro a quella rete, un monumento marmoreo rappresenta Leopoldo I ed è opera del tardo Settecento di Angelo Pelliccia, scultore carrarese ormai dimenticato. Dall’acqua viva prese anche nome un piccolo borgo e, successivamente, la chiesa che fu ri- cavata modificando radicalmente dei piccoli edifici esistenti sulla battigia. La chiesa di San Jacopo in Acquaviva, dal momento che la città cominciava la sua espansione verso sud, divenne troppo angusta e, verso la fine del secolo scorso, fu ingrandita fino ad assumere le dimensioni attuali. 59 Le strutture portanti, però, sono quelle della vecchia chiesetta rurale dei primi del ‘700 e si possono osservare soprattutto nell’interno del tempio che è a croce latina. La facciata della chiesa - e lo ricorda una lapide - fu costruita a spese del mai tanto bene merito Ammiraglio Mimbelli. Dalla piazza antistante la chiesa - sulla quale sorge una delle baracchine di cui si è già detto - si diparte una strada che attraversava uno dei rioni più eleganti ed esclusivi della città. La via porta lo stesso nome della chiesa ed è importante perché, verso la sua metà, è situata la già citata Villa Mimbelli che ospita, dal 1994, il Museo Civico Giovanni Fattori. La villa - che è un vero e proprio palazzo di tre piani, circondato da un ampio parco con giardini ed alberi ad alto fusto - è un piccolo capolavoro di quello stile eclettico che era tanto di moda fra i ricchi dell’Ottocento. Vi si trovano, ad esempio, • un salotto in stile turchesco, • la ringhiera dello scalone, sorretta da putti di maiolica uno diverso dall’altro, • saloni con specchi e tante altre cose che servivano ai padroni di casa a dimostrare il proprio potere economico. L’Ammiraglio Mimbelli fu per parecchi anni direttore dell’Accademia Navale e, per questo motivo, è spesso citato per la sua munificenza nel corso delle cerimonie di inaugurazione delle varie mostre di alto livello che si tengono via via in quello che fu il suo piccolo regno dorato. 60 14 I BAGNI DIPINTI DA FATTORI E LA TERRAZZA DEL MUSICISTA CONTESTATO ******************************************************************************* Proseguendo sempre sul Viale Italia, sulla sinistra di chi viaggia, l’osservatore attento non può far a meno di notare: • il complesso dei Bagni Pancaldi, ed, immediatamente dopo, • la Terrazza Mascagni. Sono, ambedue, simboli della livornesità, e si sono aggiunti al primo tracciato di quella che è ora, contemporaneamente, strada di passeggio e via di scorrimento per un traffico anno dopo anno sempre più intenso. Non doveva essere stato così quando, con la crescita della borgata di San Jacopo, il gonfaloniere così si chiamavano i sindaci dell’èra mediceo-lorenese - Fabbri decise di collegare il cuore della vecchia città ai suoi neonati rioni meridionali. La zona, infatti, era solo campagna anche se ospitava quei lazzaretti di cui si è detto più innanzi, e qualche casermaggio. Ad unità d’Italia compiuta, nel 1866, uno di questi casermaggi fu demolito: era il Forte dei Cavalleggeri che, sul mare, aveva, dal 1595 in pieno Rinascimento e quindi poco dopo la fondazione di Livorno come città, ospitato un reggimento della cavalleria granducale. Rimase al suo posto un piazzale di terra battuta: il resto dei ricordi di questo fortilizio mediceo è affidato ad una strada che porta tale nome e che porta davanti alla Villa Mimbelli che è poco più a monte. Nel 1916 fu costruito, su quel piazzale, un Asilo Elioterapico che fu a sua volta smantellato per la costruzione dell’Acquario Comunale e del primo embrione della Terrazza. • I Bagni Pancaldi sono noti a molti per essere stati soggetto di alcuni famosi dipinti di Giovanni Fattori; ciò è la dimostrazione che, già nell’Ottocento, Livorno poteva vantarsi di aver degli stabilimento balneari. 61 Ora è un complesso di cabine e di altre strutture in muratura, ma nell’Ottocento I bagni Pancaldi erano un insieme di eleganti capanni di legno ove la ricca borghesia livornese ed i suoi ospiti estivi - fiorentini, pisani, romani e lucchesi - passava i pomeriggi assaporando i bagnidi sole e di acqua salsa che, fino ad allora, neanche il popolino si era degnato di pro vare. • La Terrazza Mascagni, invece, è opera molto più recente e databile degli anni Venti-Trenta; intitolata in un primo tempo a Costanzo Ciano, il genius-loci già citato, fu, dopo la caduta del regime fascista, dedicata a Pietro Mascagni, dopo roventi, lunghe e velenose polemiche. Ciò in quanto il musicista, malgrado non avesse mai abiurato la propria livornesità, era andato ad abitare - ed a morirvi nel 1945 - a Roma, fra i fasti e le feluche dell’Accademia d’Italia: cosa che aveva comportato la sua adesione entusiasta al regime di cui sopra e gli anatemi del CLN livornese. La Terrazza - come è chiamata tout-court dai livornesi - appare oggi nella sua bellezza, ma fino a pochi anni fa era caduta in un degrado indegno di una città civile: corrose dal salmastro le balaustrate, divelta in molti tratti la pavimentazione e ridotti a pubbliche discariche i giardini a prato, sembrava la rappresentazione di una città in coma. Qualcosa di bosniaco sul mare, insomma. Poi, finalmente, il restauro: o meglio, la ricostruzione. Al centro c’è * un gazebo che sarebbe più italiano chiamare palco per la musica, perché ospita concerti di bande musicali, e, davanti, * il mare: con vista delle isole dell’Arcipelago Toscano che spesso, nelle giornate invernali di tramontana, si svelano tutte: • di fronte alla Terrazza, la Gorgona, piccola ed inaccessibile fino ad ieri perché sede di un penitenziario, 62 • verso sud, la Capraia, con le sue due gobbe, poco popolata ma sempre di moda fra gli sportivi, poi • l’Elba, più lontana ancora, ma più voluminosa: fa capire di essere piuttosto grossa, e, infine, • la Corsica, della quale si intravede la punta settentrionale: Capo Corso, detto anche familiarmente il Dito della Corsica. Nel contesto della Terrazza Mascagni, al suo limite settentrionale, c’è un’altra istituzione livornese che sta per uscire dal limbo provinciale per divenire una realtà nazionale, e forse qualcosa di più. E’ • l’Acquario “Diacinto Cestoni” che, una volta restaurato, ampliato e restituito al pubblico, sarà uno dei poli scientifici più importanti d’Italia nel mondo della biologia marina. Farà coppia, per gli amanti del sapere, con • il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, da poco rinato a nuova vita e che ha sede poco più a monte, nel cuore dei rioni residenziali della città, nella neoclassica Villa Henderson ed ove era l’antica Porta Maremmana 15 LO SCOGLIO DELLA REGINA, I SOGNI TURISTICI E LA REALTA’ SUGLI SCALI DEL CANTIERE NAVALE ************************************************************************* pochi passi dalla Terrazza Mascagni e dall’Acquario, una zona quasi nascosta da pa- A lizzate e da altre baracchine porta il nome poetico di Scoglio della Regina. A dir il vero di poetico non c’è molto, perché si tratta di un piazzale di terra battuta che ospita, lato mare, una costruzione a più piani fortemente degradata, sulla quale si possono leggere con un po’ di buona volontà delle scritte. Sono la sua storia. 63 E’ la storia del primo stabilimento balneare dell’Italia turistica, nato nel periodo della Restaurazione per volontà di Maria Luisa di Borbone, vedova di quel Lodovico I, che fu, per un brevissimo periodo in epoca postnapoleonica, re d’Etruria e che si è fatto ricordare per aver fatto costruire nella media Valle del Serchio la strada che conduce in Garfagnana e che porta ancora il suo nome. Anche Maria Luisa si rese benemerita a Lucca: fece costruire da Lorenzo Nottolini - quello del Ponte delle Catene sul torrente Lima - l’acquedotto della città, e la cosa è ricordata da una lapide apposta sul fronte del basamento del monumento fattole erigere dalla comunità lucchese davanti al Palazzo Ducale di Piazza Napoleone. Maria Luisa era una spagnola che, durante la sua permanenza in Toscana, si era lasciata attrarre da una moda appena arrivata in Italia dall’Inghilterra: quella dei bagni naturali in acqua marina. Poiché, già alla fine del Settecento, a Livorno erano nati dei piccoli stabilimenti per la talassoterapia, la regina d’Etruria li potenziò facendo anche scavare un piccolo canale che li congiungesse ad un grappolo di scogli che emergevano dalla sabbia della spiaggia. Lo scavo proseguì ricavando dai macigni anche una piscinetta quadra - che è stata ritrovata nel corso di recenti lavori di restauro - dove la regina vedova poté bagnarsi in magnifico isolamento lontana dagli occhi della plebe La piscina aveva il particolare che, nel bel mezzo dei suoi quattro lati, una canaletta scavata nella roccia viva collegava la vasca al mare. In questa maniera, l’acqua fluiva nella piscina naturalmente, limpida e fresca, eternamente rinnovata per le regie bagnature, alla periferia della zona portuale odorante di pece greca. E’ stato così che, per seguire una moda inglese, una regina spagnola vedova di un francese si fece fautrice della nascita in Italia dei bagni di mare. Allo stabilimento iniziale si aggiunsero con gli anni altre sovrastrutture, e quel che resta del primo stabilimento balneare dell’Italia turistica è quell’edificio fatiscente di cui si è detto, che fu, per più 64 di un secolo, anche albergo di un certo tono; come il gigantesco Hotel Palazzo che è di fronte alla Terrazza, chiuso ormai da anni . Erano i simboli di una Livorno che aveva ambizioni di città di svaghi, allietata da luoghi di delizia. Negli anni Venti-Trenta, la città si era autodefinita Perla del Tirreno per la sua offerta di bagni di sabbia e di scoglio, ma ben presto fu detronizzata da Viareggio. Aveva anche delle terme con annesso albergo e si era illusa di essere la Montecatini-sulMare, ma nessuno ricorda più che a Livorno ci si andasse per passare le acque. L’albergo con stabilimento termale era nato su una fonte di acque oligominerali, ottime perché diuretiche quanto basta, ed aveva come annessi uno stabilimento per la bevuta mattutina al suono di un’orchestrina ed un altro per l’imbottigliamento di acqua da tavola, aranciate e gazzose con la biglia. Venduti alla Cocacola che chiuse tutto. Era evidente che le sorti della città erano non tanto nell’aleatorio futuro turistico, quanto in un più concreto presente industriale. Il presente industriale di Livorno è una zona vastissima a nord-ovest della città, sulla strada che conduce a Tirrenia, dove il porto commerciale coi suoi ricchi traffici di merci varie lascia posto ad un porto industriale. Vi attraccano soprattutto petroliere e portarinfuse che alimentano a loro volta grandi stabilimenti chimici e petrolchimici, centrali termoelettriche, cementifici ed altre installazioni che comportarono, al momento della loro installazione, grandi investimenti di capitali, ma che assorbirono peraltro poca manodopera. Ma una grande e bella realtà industriale manifatturiera, di quelle che sono fonte di occupazione, confina proprio con lo Scoglio della Regina. E’ il Cantiere Navale Fratelli Orlando. La sua è una storia che inizia con l’unità d’Italia, quando un’area derivata dallo smantellamento del Lazzaretto di San Rocco ed in seguito bonificata, fu affittata all’Ingegner Luigi Orlando ed ai suoi fratelli.. 65 In precedenza, lo spiazzo resosi libero dalle costruzioni del vecchio lazzaretto mediceo era stato occupato da alcuni piccoli cantieri di calafati che vi riparavano delle imbarcazioni e da alcuni maestri d’ascia che provvedevano alla costruzione di qualche barca da pesca e da carico. Orlando e i suoi fratelli venivano dalla Sicilia da poco annessa al Regno d’Italia, ed avevano già fatto un bel po’ di fortuna a Genova, dove avevano fondato uno stabilimento metallurgico e dato l’inizio all’attività cantieristica che avrebbe reso celebre nel mondo la Superba. Industriali e finanzieri di raro intuito, sarebbero divenuti in un secondo tempo - ai tempi della Triplice Alleanza - una specie di santi protettori dell’industria toscana. Avevano, infatti, iniziato anche la produzione metallurgica - leghe del rame, soprattutto - prima a Fornaci di Barga nella media valle del Serchio dove la Lucchesia diventa Garfagnana e, poi, sull’Appennino Pistoiese a Campotizzoro ed a Mammiano. Perché annidarsi fra quei monti per far dei laminati d’ottone è presto detto: i laminati in questione erano prodotti per la fabbricazione di bossoli per la fucileria e per l’artiglieria, ed era più saggio stare il più lontano possibile dalle coste e da ogni minaccia che venisse dal mare. Gli Orlando furono anche, a modo loro, dei benemeriti del turismo toscano perché finanziarono la costruzione del Ponte Sospeso di Mammiano e della FAP (Ferrovia Alto Pistoiese): di quest’ultima si è già parlato a proposito delle ferrovie toscane che non ci sono più. Il cantiere navale fondato e gestito da Luigi Orlando e dai suoi fratelli fu un esempio della prima industrializzazione italiana e, dai suoi scali, furono varate, nel corso dei decenni, non solo navi da passeggeri e da carico, ma anche molte navi da guerra. Vi fu costruito, negli anni Venti, anche il primo - ed ultimo - incrociatore leggero della Regia Marina. Era una nave armata ma non corazzata, che batté diversi primati di velocità ma che nulla poté fare durante lo strapotere nel Mediterraneo della Royal Navy britannica, che lo affondò ingloriosamente nel primo periodo della seconda guerra mondiale. 66 Poi venne la crisi del dopo ‘29, e, come quasi tutti i cantieri navali italiani, anche il glorioso cantiere livornese fu fagocitato dall’IRI e dal suo braccio secolare Fincantieri: lavorò a tutto ritmo per tutto il periodo anteguerra, poi fu distrutto dagli eventi bellici e ricostruito. Ricominciò a lavorare duro ed a varare navi di tutti i tipi fra una bega sindacale e l’altra, fra uno sciopero generale ed una carica della Celere, fino a che non si affacciarono all’orizzonte della marineria mondiale coreani e giapponesi che spiazzarono tutti i cantieri del mondo con le loro superpetroliere da 250mila e più che costavano una bazzecola al confronto di quelle europee ed americane. Fu l’inizio dell’obsolescenza, simpatica paroletta del sociologhese che significa invecchiamento degli impianti e costi di produzione da infarto. Gli ultimi decenni videro il cantiere livornese svuotarsi di tutta la sua manodopera dalle mani d’oro: cassa integrazione, mobilità ed altri meccanismi infernali detti ammortizzatori sociali fecero il resto. Nel frattempo, però, era caduto l’Impero e le sue ideologie dirigistiche. Un gruppo di dipendenti si accorse che, se il lavoro c’era, tanto valeva gestirselo da soli: ed il lavoro c’era davvero. In tutto il mondo, infatti, la cantieristica stava riprendendo il volo ma con altri obiettivi: non più superpetroliere e megaportacontenitori da coreani e giapponesi, ma navi specializzate. Ed anche il Cantiere Navale Fratelli Orlando ricominciò a lavorare. Oggi costruisce navi piccole ma tecnologicamente perfette: gasiere, chimichiere, traghetti superveloci. Ha anche una sezione che produce e ripara panfili ed altri battelli della cantieristica minore e c’è chi sogna di trasformare un grande specchio d’acqua da un secolo in concessione al cantiere in un porto turistico per gente col portafoglio a fisarmonica. Cosa, quest’ultima, nemmeno pensabile prima del fatidico Ottantanove; prima di allora il politburò livornese non avrebbe ammesso un’intrusione della plutocrazia nell’area portuale.. Luigi Orlando è ricordato da un monumento opera dello scultore siciliano Cangemi, posto sulla piazza che fronteggia l’ingresso principale del cantiere da lui fondato, e che da lui prende nome. 67 Con Piazza Luigi Orlando termina Viale Italia. 17 TRE EMBLEMI DELLA LIVORNESITA’: IL FOSSO REALE, I QUATTRO MORI E LE FONTANE DEL TACCA ******************************************************************************** erminato Viale Italia con Piazza Luigi Orlando, la strada, prima di tornare ad essere T lungomare, attraversa una grande piazza alberata, Piazza Mazzini, dalla quale si dipartono verso monte alcune vie che conducono al cuore elegante della città. Sono strade molto animate, piene di negozi di ogni genere e affiancate da condominii molto popolosi, abitati da gente chiassosa ma allegra: l’atmosfera è molto mediterranea. Proseguendo sempre a dritto ed oltrepassato il lungo edificio degli uffici del Cantiere Navale un tempo brulicante di disegnatori chini sui tecnigrafi fra un mare di matite, di bottiglini di inchiostro di china e lucidi, ritorna la passeggiata a mare. Chi ha un po’ di spirito d’osservazione, noterà che la toponomastica cambia: queste strade non si chiamano più vie o viali, ma scali: sono il contraltare livornese delle veneziane fondamenta. Si comincia, infatti, con gli Scali Novi Lena ove, a destra di chi viaggia, alcuni palazzi sono in parte destinati ad uffici ed, un po’ prima di un ponte su di un canale, anche a scuole: vi è infatti la sede dell’Istituto Nautico, ove si forma il personale di coperta e di macchina della Marina Mercantile. A sinistra, invece, la Darsena del Cantiere, che è lo specchio d’acqua già citato di cui si vagheggia la destinazione a porto turistico d’alto bordo, poi un piccolo bacino di carenaggio ed una specie di porto-canale affollato di pescherecci e, superato il ponte, si prosegue con gli Scali Cialdini che conducono alla radice della Via Grande già citata, e, di qui, in Piazza Micheli ove si trovano altri 68 simboli della livornesità. Infatti, tutta questa pur piccola area compendia molte cose che il visitatore accorto deve sapere per capire lo spirito di questa città: • il Fosso Reale, che è il canale che si sorpassa col ponte di cui sopra, • il monumento a Ferdinando I Medici, detto più comunemente dei Quattro Mori, in Piazza Micheli, e • le fontane di Pietro Tacca, in Piazza Colonnella, all’inizio di Via Grande. IL FOSSO REALE... Il Fosso Reale circondava le fortificazioni della prima Livorno che erano state volute verso la fine del ‘500 da Ferdinando I Medici, Granduca di Toscana. La costruzione di queste fortificazioni lunghe circa cinque chilometri con mura a bastione durò la bellezza di quindici anni. Due secoli dopo le mura medicee furono demolite per lasciar spazio alla città, ma il canale fu risparmiato e tuttora penetra nel cuore della città. Non è più un’opera difensiva, ma siccome i tempi cambiano, è da un secolo circa adibito a rifugio per le imbarcazioni da diporto che vi ormeggiano a migliaia. Il Fosso Reale era - ed è tuttora - attraversato da soli tre ponti, vale a dire: • il Ponte Nuovo, sul lungomare, • il Ponte di Piazza Cavour, ed, infine • il Voltone, che costituisce l’impiantito dell’attuale Piazza della Repubblica, quella coi due monumenti ai Lorena. All’altezza dell’elegante Piazza Cavour, il Fosso Reale è soprappassato il ponte omonimo, poi costeggia • la chiesa degli Olandesi in stile neogotico, che è sulla sua destra ed • il Mercato Centrale, che è alla sua sinistra. 69 Come su tutti i canali che circondano la vecchia Livorno, anche sul Fosso Reale si facciano a pelo d’acqua le cosiddette cantine: erano i magazzini dei mercanti d’altri af- tempi ai quali le barche, provenienti dal vicino porto, attraccavano per trasbordarvi le merci appena ar- rivate. Oggi, le cantine che sono tuttora sulle sponde dei canali (o fossi) di Livorno, sono a- dibite a ripostigli per associazioni del tempo libero che vanno dai circoli di vogatori agli immancabili pescatori dilettanti; altre, invece, sono di proprietà di pochi privilegiati privati come quella che fa parte di un palazzo moderno e che è l’uscita a pelo d’acqua di una gal- leria d’arte di buon livello. • La Chiesa degli Olandesi è da parecchi anni chiusa al culto ed ha una bella facciata in pietra serena che si specchia nel canale. Fu fatta costruire durante il secolo scorso, secondo il gusto imperante fra i luterani, dalla ricca colonia di sudditi del Regno dei Paesi Bassi riuniti nella Congregazione Olandese-Alemanna, che ha la sua origine nella presenza di quella Nazione a Livorno dal 1602.. Il tempio ha un interno severo ed al tempo stesso elegante, con scanni per i fedeli e vetrate molto colorate. Dicono che abbia un’acustica quasi perfetta, tanto che sarebbe ideale trasformarlo in sala da concerti, se si sapesse esattamente chi ne è il proprietario: tutti i discendenti dei suoi fondatori, infatti, sono da tempo scomparsi. Un comitato di cittadini formatosi anni fa vorrebbe tentarne il recupero con l’aiuto dell’Ambasciata d’Olanda, prima che tutto vada in perdizione. • Il Mercato Centrale, che è poco lontano ma sulla sinistra di chi guarda da Piazza Cavour, fu costruito su di uno spiazzo ricavato dalla demolizione delle vecchia mura medicee che correvano in quel punto. La sua erezione lasciò allibiti i campagnoli che venivano a Livorno a far compere, e ne fu artefice nel 1894 l’architetto Angiolo Badaloni che fece quasi una fotocopia di quello fiorentino di San 70 Lorenzo di poco anteriore. Il buon Badaloni non sapeva di aver progettato e fatto costruire un antesignano degli attuali centri commerciali. Seppur nel cuore di una città iperattiva ma piccola e provinciale, il Mercato Centrale di Livorno è sempre un polo di prim’ordine, perfettamente aerato e reso luminoso da grandi finestroni che occupano tutto il perimetro dell’edificio. E’ una grande costruzione in muratura con una copertura di ferro e ghisa che fu eseguita dalle Officine Fratelli Gambaro su disegno di E. Spagnoli: era, infatti, l’epoca degli architetti-ingegneri che costruivano in metallo opere ardite entrate nella storia dell’arte e del costume come la Tour Eiffel di Parigi e la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Il Mercato Centrale ha un grande salone centrale che ospita più di duecento banchi di vendita di generi vari, affiancati da oltre trenta banchi di generi alimentari; due saloni laterali, invece, sono adibiti alla vendita di pesce, l’uno, e frutta e verdura, l’altro. Nel sottosuolo, vi sono novantaquattro cantine con celle frigorifere, e ciò dà un’idea della maestosità e della funzionalità dell’edificio. A poche centinaia di metri in linea d’aria dal Mercato Centrale, in un rione che è oggi uno dei più signorili del centro, abitava una famiglia agiata di lontana origine ebraica come tantedella città. Uno dei suoi ragazzi era pervaso dal furore dell’arte: plasmava, nello studio che aveva affittato non lontano dal mercato, sculturine accademiche e dipingeva alla maniera dei Macchiaioli. Fece a tempo a conoscere Giovanni Fattori e fu allievo di Guglielmo Micheli insieme a Llewelyn Lloid, Gino Romiti e Manlio Martinelli. Ben presto capì che non era quella la strada da seguire, perché già allora la sua città era piena di pittori, più o meno dilettanti, tutti più o meno bravi. Le idee e le stranezze dei Futuristi, però, cominciavano a farsi largo non tanto fra i benpensanti, quanto fra gli artisti più intelligenti, ed il ragazzo livornese volle seguire la loro maniera. 71 Cominciò a ritrarre donne dal collo lungo come quelli dei cigni e a scolpire cose che sembravano venire dall’Africa. Poi emigrò a Parigi, e, fino al 1920 - era del 1884 - visse una vita di stenti e si autodistrusse nell’alcool, nell’oppio e nell’eros, travolgendo con la sua morte anche sua moglie che si uccise non si sa bene se dal dolore o dalla vergogna di aver amato un macaronì. E’ sepolto al cimitero di Père-Lechaise insieme a tanti altri artisti più o meno famosi della sua epoca, ed è tuttora considerato un genio dell’arte moderna. Si chiamava Amedeo Modigliani, e la sua città gli ha dedicato una strada anonima in un rione periferico di case operaie non lontano dalla stazione ferroviaria. Una lapide, però, lo ricorda nel Famedio dei Livornesi che è davanti al Santuario di Montenero. Si favoleggiò per tanto tempo che Amedeo Modigliani, nel primo periodo vissuto nella sua città, avesse creato nel suo studio alcune sculture ricavandole da cordoli di macigno trovati in un cantiere stradale: ma che, avendole giudicandole brutte ed approssimative, le avesse caricate una notte su una carriola e le avesse gettate senza tanti complimenti nel Fosso Reale che scorre poco lontano. Un’ottantina d’anni dopo, alcuni soloni dell’arte moderna ripescarono la vecchia diceria e fecero dragare - a spese del Comune, ovviamente - il canale, alla ricerca delle sculture di Modigliani. Fra la attonita meraviglia di tutti ed il fruscio di decine di telecamere, una draga tirò su dal limo del canale tre o quattro pezzi di pietra che potevano anche raffigurare delle teste di donna: non potevano che essere le sculture gettate via dal giovane Modigliani. Qualche mese dopo la scoperta, che mobilitò tutti i mass-media del mondo, due o tre giova- not- ti livornesi si presentarono a Panorama con un video amatoriale da loro confe- zionato nel quale avevano registrato quella che doveva divenire la beffa più atroce di una città che beffarda è sempre stata. 72 Erano loro, infatti, gli autori delle presunte sculture di Modigliani, fatte nel giardino della casa di uno dei burloni, con pezzi di macigno trovati chissà dove e scolpiti rozzamente con un trapano della Black & Decker, che forse aveva sponsorizzato l’operazione-beffa. Il filmato fu trasmesso anche in una puntata di Telemike e, poi, i burloni finirono nell’anonimato, ma i soloni dell’arte moderna continuarono a pontificare dalle loro cattedre universitarie. ..I QUATTRO MORI... Immediatamente dopo la zona semaforica situata davanti al Porto Mediceo, uno slargo con albergo e ristorante è Piazza Micheli, famosa ovunque perché ospita il monumento detto familiarmente dei Quattro Mori. Questo monumento è, in realtà, una statua eretta in epoca seicentesca per onorare Ferdinando I Medici: è tutta di marmo bianco come il suo basamento. Ne fu l’autore lo scultore fiorentino Giovanni Bandini che la portò a compimento tra il 1617 e l’anno successivo. Alla base del grosso piedistallo furono anche collocate quattro statue di bronzo raffiguranti quattro saraceni (i mori) incatenati.Le prime due statue - quelle che guardano il porto - furono realizzate nel 1623 e le altre due nel 1626. Modelli delle quattro sculture furono quattro prigionieri saraceni (tunisini, algerini, chissà) che erano stati rinchiusi nel non lontano Bagno delle Galere, ed ai quali fu concessa la grazie e la libertà per la pazienza dimostrata durante la posa. Poco lontano da questo monumento - ma un po’ a monte - in una piazza detta del Logo Pio in ricordo di antiche devozioni livornesi, una chiesa sei-settecentesca restaurata ed aperta al culto, è dedicata a San Ferdinando: il motivo di ciò sta nel fatto che il mai tanto celebrato Ferdinando I fra le varie cose di cui poté andar fiero fu di aver fatto arrivare a Livorno un primo drappello di Padri Trinitari. Erano gli appartenenti ad una congregazione fonda ta a Cerfroid,in Francia, nel 1098 da Giovanni De Mata, e che si distinse, già dal tempo delle Crociate, nel far liberare dalla schiavitù nella quale erano stati sottoposti dai Saraceni molti soldati delle milizie cristiane. In se- 73 guito, la missione umanitaria dei Padri Trinitari proseguì nel Mediterraneo con sempre più numerosi scambi di prigionieri: tanti saraceni contro altrettanti cristiani e viceversa. E, poiché Livorno aveva nel Bagno delle Galere molti prigionieri saraceni, il lavoro non mancò ai buoni Trinitari. Che, per ringraziamento a Ferdinando I, eressero una chiesa intitolata a San Ferdinando di Castiglia del quale il granduca portava il nome. Autore delle quattro sculture rappresentanti i quattro prigionieri saracesni fu il carrarese Pietro Tacca, molto attivo nel periodo della Maniera presso la corte dei Medici ed autore di opere che si possono ammirare a Firenze: suo il monumento equestre che è in Piazza della Santissima Annunziata. E’ luogo comune dire che c’è un punto di Piazza Micheli dal quale è possibile vedere tutti i quattro nasi dei mori (o saraceni, o magrebini) contemporaneamente: ed è vero. Per questo motivi non è difficile trovare sul luogo turisti che si fanno fotografare mentre guardano i quattro nasi. La città natale di Pietro Tacca, Carrara, ha eretto a questo grande scultore del periodo manieristico un monumento che lo raffigura mentre, con le mani dietro la schiena come se fosse incatenato, mima ad un moro la posizione che deve tenere per essere ritratto. Il monumento a Pietro Tacca è posto nei giardini difronte all’Accademia di Belle Arti, e la figura reclina altro non è che l’autoritratto dell’autore del monumento: quel Carlo Fontana, scultore carrarese della belle-époque che si rese famoso, ai suoi tempi, per aver modellato la quadriga di bronzo che sovrasta l’Altare della Patria a Roma. ...E LE FONTANE DEL TACCA Da Piazza Micheli basta far quattro passi all’indietro ed imboccare Via Grande: dopo qualche decina di metri una piazzetta, spaccata in due dall’arteria, ospita a sua volta altre due sculture di Pietro Tacca. Sono le sue famose Fontane, bizzarre sculture a forma di animali altrettanto bizzarri, che ornavano i lati del monumento detto dei Quattro Mori, 74 Non sono gli originali, ma copie e la loro storia è, a sua volta, alquanto bizzarra. Infatti, nel 1618 Cosimo II Medici fece erigere da Giovanni Bandini il monumento a suo padre Ferdinando I, vincitore dei saraceni. Qualche anno dopo, Pietro Tacca, che aveva aggiunto alla base del monumento al granduca le quattro sculture raffiguranti i saraceni vinti ed incatenati, ebbe l’incarico granducale di costruirvi ai lati due bizzarre fontanelle, che furono plasmate, fuse nel bronzo e collocate ove voleva Cosimo II, nel 1629. Sennonché, nel frattempo, Cosimo II era tornato alla casa del padre e suo figlio ed erede al trono, Ferdinando II si invaghì delle due opere del Tacca e, senza tanti complimenti, le fece smontare e rimontare a Firenze in Piazza della Santissima Annunziata ove chiunque può tuttora ammirarle. Toccava ai posteri stabilire se le due fontane fossero livornesi o fiorentine e fu trovato un compromesso fra le due maggiori città di quello che fu il granducato. Firenze avrebbe continuato a tenersi gli originali, mentre Livorno avrebbe avuto come risarcimento le copie identiche. Così fu, ma non subito: dovettero passare alcuni secoli perché i fiorentini consegnarono le copie nientemeno che negli anni ‘50 del ‘900, ai tempi delll’amministrazione di quel galantuomo che fu La Pira. Altro compromesso: delle copie delle due fontanelle, una sarebbe stata pagata dal Pantalone fiorentino ed una dal suo simile livornese. E così fu. 18 LA FORTEZZA VECCHIA: DA FORTE PISANO A PALCOSCENICO PER BALLETTI ******************************************************************************** 75 atti quattro passi di numero oltre i l monumento del Quattro Mori, ci si ritrova in Piazza F del Pamiglione: non c’è nulla di eccezionale, come il lettore può confermare, se, sulla sinistra di chi viaggia - o meglio passeggia - non si scorgesse la mole rosa-violetto della Fortezza Vecchia, che sorge dall’acqua di una vecchia darsena. . Si dice che questo colore a mezzatinta delle mura esterne dell’antica fortificazione ispiri certe tavolozze di certi pittori livornesi che la fanno da padroni, d’estate e nei luoghi più impensati di vacanze, nei concorsi ex-tempore di pittura: la loro caratteristica, infatti, è di aver in tavolozza un color rosa-violetto che pochi altri hanno. La Fortezza Vecchia ha questo colore tipico perché è tutta di laterizio, e rassomiglia così tante altre fortificazioni fiorentine che si trovano nella Toscana Interna. Come, per esempio, nel comprensorio delle Colline Pisane - lontano da Livorno una quarantina di chilometri in linea d’aria - a Lari, paesotto piuttosto famoso in Toscana non solo come produttore di ciliege, ma anche per un fortilizio fiorentino chiamato dai larigiani ‘Il Castello’. La funzione di questi fortilizi era, inizialmente, di difesa: quando Firenze era in guerra con Pisa, Pisa con Lucca, Lucca con Volterra, Volterra con Siena, Siena con Firenze e via elencando. Poi i tempi piano piano cambiarono, Firenze ebbe il sopravvento, e, proprio da Firenze , tirono altre disposizioni: i fortilizi divennero sede di magistrature chiamate vicariati par- che aveva- no come scopo non tanto il comminare pene varie a ladri di polli od avvinazzati turbatori della quiete pubblica, quanto di tassare il più possibile con ogni tipo di gabella i malcapitati abitanti della Signoria prima e del Granducato poi. Ma questo solo nella Toscana Interna, perché lungo la costa, dall’attuale Bocca di Magra - che era genovese - a Roma, si estendeva una lunga pianura ricca solo di paludi: la Maremma. Malaria, miseria, desolazione e, in riva al mare, incursioni di pirati. A difendere la costa ed a tentare di renderne fertile il retroterra c’era stata, invero, la Repubblica Marinara di Pisa; ma dopo la sconfitta subìta coi genovesi alla fine del Duecento alla Meloria, era 76 passata da un malgoverno all’altro, ed era caduta preda delle brame fio rentine che la fecero cadere e ne distrussero il potere costiero. Si presume che i fortilizi fiorentini di tal fatta fossero tutti di laterizio perché nati in zone dove non esistevano cave di macigno: o, perlomeno, dove il macigno col quale poter costruire doveva essere scavato in luoghi tanto distanti da non renderlo economico come materiale da costruzione. E, poiché tutt’intorno terraccia ed argilla abbondavano, ecco il nascere di fornaci fumiganti per la produzione di mattoni pieni, atti alla costruzione di qualunque edificio: anche di fortilizi. Quello che oggi si chiama Fortezza Vecchia fu fatto costruire nel Cinquecento da Giulio dei Medici, futuro Papa Clemente VII, che diede l’incarico del progetto ad Antonio da Sangallo il Vecchio. Il fortilizio fu finito di costruire verso la fine di quel secolo, e la sua edificazione comportò l’inglobamento di un vecchio edificio a pianta quadrata e di una torre. Ambedue questi edifici preesistenti erano di origine pisana, dal momento che proprio poco lontano esisteva quel Porto Pisano del quale tutt’oggi si favoleggia, e dove dovevano avere ricovero le navi della Repubblica Marinara prima del suo interramento naturale definitivo. Essi erano • quella che oggi si chiama la Quadratura dei Pisani, rimanenza di quello che doveva essere il nucleo del sistema difensivo del porto della Repubblica, e • la Torre (o Mastio) di Matilde, così chiamata perché fatta costruire, ancor prima, nel secolo XII, da quella Contessa Matilde di Toscana rimasta nella memoria collettiva per l’affaire di Canossa. Torre e forte quadrato furono teatro, nei secoli successivi, di diverse sanguinose battaglie; furono più volte distrutti e ricostruiti da parte dei regnanti che via via si succedevano in quel periodo tormentato e nebuloso della nostra storia remota. 77 Il fortilizio pisano era nato, oltre che a difesa di un improbabile porto militare e di un piccolo villaggio di pescatori, anche di un faro alto 51 metri che alcuni studiosi attribuiscono a Giovanni Pisano, scultore ed architetto del Trecento. Il faro, detto più comunemente Fanale, è ben visibile oltre le maestose mura della Fortezza Vecchia, ed è apparentemente costituito da due torri a tronco di cono che ne fanno una costruzione piuttosto curiosa. La curiosità della costruzione sta nel fatto che le torri che lo compongono non sono due sole, ma la bellezza di sette: tutte a cilindri soprapposti ed a diametri decrescenti. Il Fanale resistette nei secoli fino al 1944, quando fu fatto saltar in aria dalle truppe tedesche in ritirata. Fu, poi, ricostruito com’era e dov’era e reinaugurato il 16 Settembre 1956, in occasione delle celebrazioni del 350° anniversario della fondazione della città. Ma altre torri di guardia erano disseminate lungo la costa - in parte sabbiosa ed in parte tutta scogli affioranti dal mare - ed anche al largo. Ne sono rimasti due esempi, che sono citati nei libri di storia della navigazione e sono ambedue ben visibili da chi sosta nei pressi della Fortezza Vecchia. Esse sono: • la Torre del Marzocco, che è situata sulla diga omonima, e che è all’imboccatura del porto industriale. Al momento della sua costruzione, nel Quattrocento, quella zona era totalmente acquitrinosa e quindi difficilmente attaccabile da pirati o nemici: perciò la Signoria fiorentina la fece costruire ampia ed alta, degna di ospitare una guarnigione abbastanza numerosa rispetto ai pochi armati che occupavano, invece, le altre torri ora scomparse. La Torre del Marzocco - chiamata così in onore dell’insegna della Signoria, un leone che tie- ne fra le zampe lo scudo gigliato di Firenze - è alta 54 metri ed è interamente fasciata di marmo bianco. E’ di forma ottagonale ed ad ogni lato porta il nome del vento al quale il lato stesso è ri volto. 78 E, ben visibile al largo anche ad occhio nudo, meglio con un binocolo anche modesto, la Torre della Meloria, fatta ricostruire nel 1598 dal solito e benemerito Ferdinando I Medici, sui resti di un primitivo faro pisano, andato distrutto nel 1284 durante la battaglia navale che vide la sconfitta del Pisani contro i Genovesi e la fine del predominio della Repubblica Marinara toscana sul Tirreno. La torre era a quattro miglia marine dalla costa, ed al centro di una zona dove gli scogli affiorano dall’acqua: le famose Secche della Meloria, oggi paradiso di pescatori di canna e subacquei. La torre medicea non ebbe, però, gran fortuna: il mare se la mangiò ben presto e ci volle un secolo di vicissitudini varie per la sua ricostruzione. Ciò avvenne nel 1709: la Torre della Meloria fu fatta riedificare da uno degli ultimi Medici in forma di parallelepipedo con quattro archi alla base. Dopo la sconfitta della Meloria, Pisa e la sua Repubblica Marinara decaddero a tal punto che tutta la zona costiera fu venduta più volte. Prima al Duca di Milano e, successivamente, alla Repubblica di Genova. Quest’ultima si sbarazzò nel Cinquecento del luogo malarico ed insicuro, vendendo il tutto alla emergente Signoria di Firenze che non aveva sbocco al mare. Niente mare per i Fiorentini, ma molte ambizioni di potenza marittima antiturca perché, dopo due secoli di dominazione sulla affamata ed umiliata Pisa, si sentivano in dovere dì armare una flotta che eguagliasse quella dei loro odiati predecessori. Oggi la Fortezza Vecchia è visitabile solo su appuntamento da concordare con le guide turistiche della città, ma, durante l’estate, viene di volta in volta aperta al pubblico ed in quella che fu la Quadratura dei Pisani, si tengono anche degli spettacoli di balletto e concerti di musica colta. Il suo restauro è ancora in corso, ed è lungo e difficile perché, durante i secoli, il vec- chio fortilizio fiorentino fu adibito, come tutti i suoi confratelli, agli usi più diversi, carceri e bagni penali compresi. Furono anche costruite nel suo perimetro delle sovrastrutture non certo da enciclopedia dell’architettura e, quasi certamente, ebbe dei danni - piuttosto vi- stosi dalle crepe che si intravedono qua e là lungo i suoi bastioni - a causa di alcuni ma remoti che avvennero da- 79 vanti a Livorno e che coinvolsero anche la città: anche il non più recente secondo conflitto mondiale lasciò segni difficilmente cancellabili. Fu così che nacque la città di Livorno; ed il suo topònimo fu ricavato, dagli eruditi della fine del Cinquecento, da un Castrum Liburnii di origini alquanto incerte. Forse era il nome di un accampamento romano che poteva aver avuto sede nel luogo ove è la Fortezza Vecchia, e che costituì il primo nucleo di una città-porto fortificata. Fu chiamato, espressamente da Firenze, Bernardo Buontalenti. Egli si mise subito al lavoro, anche perché aveva già lavorato molto bene come architetto di corte dei Medici. Per esempio, aveva progettato - o comunque ispirato ad altri suoi colleghi meno famosi - quasi tutte le ville medicee che sono tuttora sparse in tutta la Toscana, dal Mugello alla Valdera Erano ville ai margini del Granducato, quasi tutte situate al centro di vasti possedimenti agricoli della famiglia Medici, ma ubicate in zone se non disagiate, in territori di confine ed in luoghi ove briganti a parte - la gente era sempre pronta a menar le mani. Ville che assomigliano a fortilizi, quasi sempre con quattro torri ai vertici, con mura spesse e feritoie ovunque. Arrivato sul posto, Bernardo Buontalenti si mise subito al lavoro e progettò una città ideale che ben presto prese la forma di un pentagono esatto: • il lato inferiore del pentagono era il mare e la Fortezza, • il vertice era un altro fortilizio da costruire al più presto, • i lati erano una potente cinta muraria circondata da due canali che convergevano verso il vertice. Uno dei due canali lo conosciamo già, perché è il Fosso Reale: l’altro sarebbe stato scavato qualche anno dopo la venuta del Buontalenti ed attualmente si chiama Fosso della Venezia. Regnava sul Granducato Ferdinando I Medici. 80 19 UNA SECONDA GRANDE FORTEZZA, LA NUOVA VENEZIA E LA CITTÀ’ MULTIETNICA ******************************************************************************* Davanti alla Fortezza Vecchia un canale che penetra nel cuore della città come il suo gemello detto Reale, porta il curioso nome di Fosso della Venezia: esso collega il fortilizio di cui sopra con un altro grande fortilizio. Il perché dell’affinità tra Livorno e Venezia non è dato solo da quei due canali e da altri che, con un po’ di pazienza e perseveranza, il lettore può mano a mano scoprire. Sono tutti navigabili, e, alla domenica, percorsi da battelli per brevi gite turistiche. Tutto ciò è dovuto al fatto che, regnando il benemerito Ferdinando I Medici vincitore dei pirati saraceni, oltre all’esperimento del Buontalenti di costruire una città fortificata, sì, ma ideale, fu anche sperimentata una copiatura di Venezia. Qualcuno di Firenze - se non il granduca stesso - era stato presso i Dogi ed era rimasto esterrefatto della bellezza magica della città tutta attraversata da canali. Si era chiesto: dato che qui noi ne stiamo costruendo sul mare una nuova, proviamo a dotare il granducato di una città simile a quella dei Dogi. E così fu fatto, perché Ferdinando I aveva dato incarico al Cogorano, un architetto della corte medicea meno famoso del Buontanlenti ma non per questo meno bravo in materia di fortificazioni, di realizzare una nuova cinta muraria che aveva come vertice a monte un’altra grande fortezza. Lo stesso Claudio Cucurrano (o Cogorano), insieme ad Antonio Cantagallina e Padre Giovanni Antonio Mezzenta fu anche il responsabile dei lavori dello scavo del canale che poi si sarebbe 81 chiamato popolarmente Fosso Reale: un lavoro immane compiuto in pochi mesi, all’inizio del 1600, da 6.200 forzati che scavarono ventiquattr’ore su ventiquattro sotto la minaccia dello staffile dei sorveglianti e degli sbirri granducali e tormentati di miliardi di zanzare, al pari di migliaia di cavalli, muli ed asini che trainavano carriaggi e barrocci. Quando il lavoro fu finit, il canale circondò una specie di isola - in pentagono ideato dal Bontalenti - lambendo la seconda fortezza E’ quella che attualmente è nota come Fortezza Nuova e che, nei primi tempi, era molto più am- pia di quanto è adesso: fu trasformata nell’Ottocento - una volta terminata la sua fun- zione militare - in un giardino pubblico e fa parte del sistema degli spazi verdi della città di Livorno. Vi si svolgono anche manifestazioni all’aperto ed al chiuso: queste ultime si svolgono nei cunicoli che una volta erano magazzini. stalle e casematte Nei frenetici anni di regno ferdinandeo, fu compiuto anche il progetto della nuova Venezia sul Tirreno o Nuova Venezia. Fu ridisegnaata la Fortezza Nuova appena costruita e, nella congiunzione fra le due fortezze che difendevano Livorno, una a mare e l’altra a monte, fu dato avvio ad un rione tutto intersecato da canali navigabili affiancati da ampi scali per il passaggio di carri e pedoni, sui quali potevano essere costruiti palazzi e chiese, edifici pubblici e privati. Non restava che popolare quella nuova città, ideale e nuova di zecca fin che si vuole ma ai li- miti di un territorio da sempre malarico e poco abitato. A Firenze ebbero un’intuizione che avrebbe meritato maggior considerazione da parte degli storici italiani e stranieri del tardo Rinascimento e de primi anni della Decadenza: fu decretato che la città fosse porto franco - e cioè senza barriere doganali: esentasse insomma - e che chi vi si fosse stabilito sarebbe stato il benvenuto. Occhiuti commercianti di tutta l’area del Mediterraneo seppero ben presto della decisione fiorentina e non si fecero dire due volte di traslocare nella neonata Livorno le loro attività, una volta avvertiti della faccenda dell’esentasse. A loro seguì gente di ogni razza e religione: balcanici, dàlma- 82 ti, turchi e libanesi, inglesi, armeni, fiamminghi, tedeschi e,soprattutto, ebrei sefarditi ancora in cerca di una patria dopo la loro cacciata da parte dei Re Cattolici dalla Spagna e dal Portogallo in seguito alla Reconquista del secolo pre- cedente. E, poi, i greci che ebbero addirittura, intorno alle fine del ‘600, un governatore della città: Immanuel Volterras che volle a Livorno la cerimonia bizantina della benedizione del mare. L’evento durò centootto anni fino alla disgregazione della comunità greco-livornese, ed il suo rito solenne quanto singolare è stato recentemente recuperato anche per volontà della diocesi cattolica locale, particolarmente sensibile all’ecumenismo. Ma c’è di più, perché fra il popolino livornese che scambiava la devozione con la superstizione era uso, in altri tempi, andar a chieder grazie alla Madonna farsi benedire a Montenero: ma, poi, se quanto chiesto alla Vergine Maria non veniva concesso, qualcuno passava dagli archimandriti greci per ripetere il rito propiziatorio. Le litanie e le suppliche in greco bizantino pare che avessero più effetto di quelle in latino della Chiesa cattolica, e da allora è rimasta nel vernacolo livornesela locuzione“Va’ a farti benedì da’ Greci” che significa “Vattene un po’ a quel paese”. Le leggi granducali che permisero tutto questo e che fecero di Livorno una città libera e senza ghetto, sono ricordate negli annali della storia minore d’Italia come Leggi Livornine, e, degli insediamenti che seguirono, restano tuttora tracce indelebili: sia nella toponomastica, sia nei casati, sia nelle tradizioni e nei culti. Malgrado fosse una città piccola, Livorno ospitava chiese e cimiteri di ogni rito cristiano più che ogni altra d’Italia: ci sono tuttora non solo chiese cattoliche governate dagli ordini maggiori, ma anche chiese • dei Greci Uniti (cattolici di rito greco) • dei Greci Ortodossi; poi, la già citata chiesa • degli Olandesi-Alemanni, una • dei Valdesi-luterani, ed una sinagoga moderna 83 • degli Ebrei-sefarditi. Quest’ultima, costruita negli anni Cinquanta sulle rovine della precedente distrutta dai bombardamenti alleati, ha la forma di una grande tenda del deserto: è situata in una piazza laterale rispetto a Via Grande, poco lontana dalle fontane del Tacca e che è intitolata al buon Rabbino Benamozegh che resse la comunità ebraica livornese nell’800. La puzza della pece greca, delle salacche, del baccalà e dei formaggi pecorini immagazzinati nelle cantine a fior d’acqua della Nuova Venezia, è ormai scomparsa da un bel pezzo, però rimangono vecchi palazzi signorili, ricordi di residenze di ricchi commercianti, ponti e strade strette come le calli della vera Venezia. E’ rimasto anche un edificio lungo e stretto che fu adibito per secoli a deposito dell’olio di oliva: ove le partite erano introdotte - e fatte poi uscire per l’imbarco per chissà dove, o per la distribuzione nel territorio granducale - più o meno come si fa adesso col vino nelle cantine sociali. L’edificio si chiama I Bottini dell’Olio, dove bottino era il nome di un orcio (o giara) da olio in terracotta, interrato nel magazzino come una cisterna di piccole proporzioni. Sul portale della costruzione una lapide del latino ampolloso del Settecento ricorda un regnante lorenese che volle questo magazzino, che è ora adibito a sede espositiva ed ove si svolgono mostre di ogni genere, da quelle d’arte a quelle legate al mondo dell’hobbismo. Altre manifestazioni si susseguono, proprio in questo piuttoresco rione, durante la prima settimana di ogni Agosto: la serie si chiama Effetto Venezia ed è un’orgia di cose goderecce organizzata dal Comune di Livorno, alla stregua di quanto si fa, qualche settimana prima, a Certaldo con Mercantia. Con le immancabili abbuffate a base di cacciucco negli antri della Fortezza Nuova e di concerti di musica colta in quella Vecchia, tutta la Nuova Venezia appare - in quelle serate d’estate in cui trionfa un’afa che neanche la brezza del mare che è lì a duecento metri riesce a sconfiggere - un girotondo di cose stravaganti e di cose belle. 84 Si va dal mercatino dell’antiquariato e del modernariato al teatro di strada, dai trampolieri agli indovini, dai fuochi artificiali finali allo spettacolo di luci al laser. Da non perdere a chi càpita ai primi d’agosto in Toscana; prima, cioè, che tutta la regione chiuda per ferie e diventi un cimitero di saracinesche chiuse. Nel rione della Nuova Venezia ci sono, però, anche alcuni importanti monumenti ed edifici di culto come • la chiesa di San Ferdinando, settecentesca, progettata da G.B.Foggini e con sontuosa decorazione interna opera del carraraese Giovanni Baratta; oggi è luogo di culto della Chiesa Avventista, • la chiesa ottagonale di Santa Caterina, con grandiosa cupola e, all’interno, un’Incoronazione di Maria di Giorgio Vasari e, sul suo retro, il tetro edificio che ospitò, fino a qualche decennio fa, • il carcere di San Domenico: una lapide apposta sul lato che fronteggia un canale dice che, fra gli altri, vi soggiornò anche Sandro Pertini. 20 TRE CHIESE PER TRE RITI, UNA REPUBBLICA DIMENTICATA , IL MERCATINO DEI SURPLUS ED UN MASCAGNI PRODUTTORE DI MOTOCICLETTE ************************************************************************** A pochi passi dai Bottini dell’Olio, Via della Madonna conduce, oltrepassato l’omonimo ponte su di un canale, nella Via Grande, già citata. Ci sarebbe anche in questo caso poco da dire, perché il tragitto si svolge nel secondo tratto tra condominii-scatolone costruiti nel secondo dopoguerra e che non appaiono in nessuna enciclopedia dell’architettura. 85 Anche la stessa Via Grande, nonostante i suoi portici che ne fanno uno dei rari esempi in To- scana di città un po’ alla bolognese, non ne è un compendio anche se si nota una certa influenza dell’architettura razionale: quella che i milanesi conoscono come architettura di San Babila e che molti intellettuali marxisti continuano ancor oggi a definire fascista. Tutta la Via Grande appartiene, invece, al periodo della ricostruzione dell’immediato secondo dopoguerra, dal momento che tutto il centro della città di Livorno, dal porto in poi, fu letteralmente raso al suolo da continui, terrificanti bombardamenti alleati fino al giorno dell’occupazione della città da parte delle truppe americane. Via della Madonna è importante per capire ulteriormente lo spirito della città e le sue origini multietniche: infatti, si affacciano sulla sinistra di chi prosegue verso Via Grande, tre chiese in rapida successione: • la Chiesa degli Armeni, con portale barocco, unica cosa rimasta dopo un bombardamento e che alle origini fu della comunità cattolico-armena che vi celebrava con i suoi riti; • la Chiesa della Madonna vera e propria, settecentesca e di rito cattolico romano, e • la Chiesa della Visitazione, che fu dei Greci Uniti, e cioè dei cattolici di rito greco. Queste ultime due chiese furoino progettatte da A. Pieroni, ma, due secoli dopo, tutte e tre furono distrutte dai bombardamenti alleati. Poi furono ricostruite; ma, mentre la prima è sconsacrata ed adibita a centro sociale, le altre due lasciano capire quale fosse la dovizia dei loro arredi, la profusione di marmi, i loro altari spesso opera di scultori carraresi ora dimenticati come il Baratta ed il Pelliccia. In quella greca, un grande pannello detto iconostasi è all’altezza dell’altare maggiore ed è dipinto alla maniera bizantina: emana un fascino discreto di cose orientali. Via Grande è la via dei grandi magazzini, dei negozi lussuosi e spaziosi, e del passeggio pomeridiano dei livornesi purosangue e di quelli del contado. Come si è già accennato, collega il lungoma- 86 re ed il porto mediceo con la Piazza della Repubblica o del Voltone sotto la quale passa il Fosso Reale. A dir il vero, e secondo i ricordi dei livornesi di una certa età, Via Grande, prima delle distruzioni della guerra e la successiva ricostruzione, non era granché. Anzitutto non aveva i portici se non nel tratto d’angolo con Piazza Grande: ne è rimasta memoria nel loggiato di un palazzotto d’angolo, chiamato Le Logge del Pieroni, e che prende nome da un architetto locale che edificò la zona nel Settecento. In secondo luogo, la strada era piuttosto stretta, perché limitata al traffico dell’epoca non certo intenso: qualche barroccio, alcune bici ed i tram. Era, come ora, divisa in due da Piazza Grande. Questo spazio cittadino era chiamato in origine Piazza d’Armi, perché vi si svolgevano tutte le attività connesse alla presenza di caserme e di militari: sfilate, alzabandiera, e parate. Vi fu piantato anche, nel 1849, l’Albero della Libertà durante l’effimera Repubblica di Livorno che ebbe poca fortuna: fu soffocata nel sangue e fece la fine della di quelle di Roma e di Vene- zia, ma solo pochi eruditi locali conoscono le vicende di questo che fu tra i primi esempi di governo democratico durante il Risorgimento. Nessun libro di storia delle scuole d’Italia, che pur è una repubblica, poi, cita la Repubblica di Livorno come fatto storicamente citabile. E dir che ne aveva parlato bene perfino Engels. La piazza era enorme e, fino al secondo conflitto mondiale, quando si chiamava Piazza Vittorio Emanuele II, andava dalla zona ove è il Palazzo Comunale a nord, fino al Duomo che è a sud. Rasa al suolo anch’essa, con tutti i suoi palazzotti ridotti a cumuli di macerie, si pensò bene, durante il periodo della ricostruzione, di dividere la Piazza Grande in due e, nel bel mezzo, vi fu costruito il Palazzo Grande, anch’esso secondo i cànoni dell’architettura sambabilina, che ospita il Cinema Grande ed un inevitabile McDonald’s. 87 Il tutto con le fermate di autobus cittadini, il capolinea di quelli che provengono da Pisa e, dietro l’abside della Cattedrale, quelli che vanno verso Cècina, una stazione di taxi ed altre cose che ne fanno il cuore della nuova città nata sulle rovine della guerra. Difronte al Palazzo Grande, la Cattedrale, che è intitolata a San Francesco: fu, anch’essa, ricostruita dopo la distruzione quasi totale e riconsacrata nel 1952. Dalle macerie si salvarono solamente cinque campane, che furono recuperate e dalla fusione delle quali furono ricavate le sei attuali, qualche pezzo di soffitto - peraltro ricostruito in muratura - ed una parte del pavimento. La Cattadrale di San Francesco era stata costruita nel 1595 su progetto di Antonio Cantagallina, un architetto della cerchia dei Medici, autore anche diella chiesetta di San Sebastiano, oltreché coautore del Fosso Reale, assieme al Cogorano ed a Padre Giovanni Antonio Mazzenta.. Divenne cattedrale solamente nel 1806, quando Livorno fu innalzata a dignità di diocesi. All’interno, prima della distruzione, era di settanta metri di lunghezza e presentava un ricco soffitto a cassettoni intagliati magistralmente secondo i dettami di quell’arte fiorentina. La facciata, da quanto si può arguire da alcune fotografie dell’anteguerra, era intonacata: e presentava un orologio al centro del timpano. Oggi, al posto dell’orologio, c’è uno stemma mediceo con tanto di palle; la facciata e le colonne del prònao sono in bardiglio, un marmo grigio spesso striato di nero che si scava nelle non lontane Alpi Apuane. All’interno, salvate in maniera rocambolesca dalla distruzione, alcune tele e pale di autori fiorentini del periodo della Maniera, come Jacopo Ligozzi, il Passignano e l’Empoli. Sul retro dell’edificio sacro, esisteva una fontana ora scomparsa. Sulla sinistra della Cattedrale, invece, d’angolo ad una strada che conduce in uno dei rioni che, benché centralissimo, è uno dei più popolani e che è quello che attornia Piazza Cavallotti, una pic- 88 cola chiesa dalla facciata anonima custodisce quanto è di più sacro ai livornesi: la devozione a Santa Giulia che è la patrona della città. Poco più oltre, dietro alla zona absidale della Cattedrale, si trova una piazza ad esedra con portici dal centro della quale si diparte una strada, • Via Cairoli, tutta di edifici austeri: è la massima concentrazione di banche della città. Poco più oltre ancora, • Piazza Cavour col suo ponte sul Fosso Reale già citato. Al suo centro, incombe il monumento al Grande Tessitore. Fu eretto per volotà della cittadinanza ad unità d’Italia compiuta ed è in marmo bianco di Carrara. Per la sua erezione furono indette tredici tombole pubbliche e, col loro ricavato, furono pagati sia il marmo di cui sopra sia due scultori un po’ accademici. Uno, scolpì la statua di Camillo Benso conte di Cavour, il secondo si occupò del pieditallo che è tuttora un grande parallelepipedo. Agli angoli del piedistallo sono raffigurate quattro aquile, ma Francesco Domenico Guerrazzi, non appena le vide, sentenziò: “Sono quattro tacchini”. Da Piazza Cavour si diparte a sua volta l’elegante • Via Ricàsoli (un negozio di ottica è della famiglia del Presidente della Repubblica) che termina nella moderna • Piazza Attias, luogo serale di raduno di ragazzi. Il tragitto continua, in parallelo al mare, con • Via Marradi (ove ha sede l’Istituto Musicale Pietro Mascagni, piccola fucina di musicisti), come, lato monte, • Corso Amedeo, animato e pieno di negozi di abbigliamento, di elettrodomestici, di ferramenta e di cornici ed articoli per belle arti; questi ultimi molto frequenti in tutta la città, data la propensione della gente alla pittura All’inizio di questa strada, una via che porta il nome dello scrittore ottocentesco Enrico Meyer, e che corre parallelamente a Via Ricasoli, conduce ad uno dei templi della lirica della Toscana. 89 E’ il Teatro Goldoni, ora da tempo in fase di restauro dopo che la proprietà lo aveva abbandonato a sé stesso e che l’Amministrazione Comunale lo aveva acquisito per tentarne il recupero. La costruzione è neoclassica ed è databile alla metà dell’Ottocento, quando il Teatro Gol- doni di Livorno divenne una delle mète fisse dei grandi cantanti d’opera ottocenteschi. La tradizione continuò anche agli inizi del Novecento ed al Goldoni si avvicendarono le più belle voci ed i grandi divi dell’opera. Ma non solo quelli. Infatti, il teatro, seguendo le mode dell’epoca, fu trasformato in politeama per spettacoli di operetta, di varietà, di rivista e di arte varia: anche in questo caso divi della canzone e celebri fantasisti si davano appuntamento al Goldoni per la gioia del loro pubblico. Poi, il decadimento fatale dopo la conversione in cinema; poi ancora le rovine della guerra, la ricostruzione affrettata e, qualche decennio dopo, l’abbandono definitivo. Il suorestauro sarà un’opera difficile e dispendiosa, ma si suppone che ne verrà fuori un piccolo capolavoro. Come è un piccolo capolavoro quanto, per il momento, è agibile: si tratta del ridotto del Goldoni che si chiama La Goldonetta e che è un teatrino-bomboniera nel quale si fanno già concerti di musica colta, in attesa che la grande sala sia recuperata. Corso Amedeo s’incrocia con • Via Magenta dai molti negozi di orefici, che, a sua volta, sfocia in • Piazza della Vittoria, una piazza alberata che ospita un monumento ai Caduti del primo conflitto mondiale. La scultura bronzea - dice un’iscrizione sul retro - fu il risultato della fusione di bronzo proveniente da armi austriache. Sulla piazza si erge uno degli edifici sacri più importanti della città: la chiesa della Madonna del Soccorso, ottocentesca e dalle dimensioni talmente grandiose da farla assomigliare ad una cattedrale. 90 Anche il suo interno è grandioso ed in varie cappelle laterali non mancano opere di pittori ottocenteschi locali di buona fama. Ma la cosa curiosa è che questa grande chiesa ospita, in una cappella detta dell’Addolorata a sinistra dell’altare maggiore - forse l’unico esemplare di arte rinascimentale di tutta la città. E’ un Volto del Cristo - un Gesù dolente e sanguinante - attribuito senza dubbi al Beato Angelico. Era di un ricco collezionista che ne fece dono a quel tempio. La chiesa del Soccorso era nata nel 1835 come ringraziamento alla Vergine dopo la fine di una grande epidemia di colera che. importata da una nave che proveniva da Marsiglia, aveva seminato per mesi morte e dolore in tutta la città. Dopo poche centinaia di metri da Via Magenta, ecco un’altra istituzione livornese: • Piazza XX Settembre, col suo il Mercatino Americano. La zona è pittoresca che di più non si può, e deve la sua fama al fatto che, nell’immediato dopoguerra, vi fioriva un ricco mercato di surplus (od eccedenze) degli eserciti alleati che fino qualche tempo prima erano stati gli occupanti della città. Gli americani, soprattutto, non si riportarono via niente di quanto avevano portato in Italia. Le apparecchiature belliche furono regalate alle esangui forze armate italiane; il resto fu venduto al miglior offerente. Gli offerenti migliori spuntarono come i funghi. Livorno, come Napoli, Genova ed altre città più o meno marittime divennero ben presto tutto un mercato di queste cose considerate dagli americani poco più che inutili e fuori moda. E se a Genova, per esempio, scoppiò il fenomeno di Via Pré, fino ad allora strada po- polana e niente più ma con qualche borsaro nero di troppo, a Livorno ci fu quello di Piazza XX Settembre, o meglio del Mercatino Americano dove le sigarette si vendevano sciolte-e-a-pacchetti insieme ad occhiali Ray-Ban ed ad impermeabili da trincea (i Trench). Ora Piazza XX Settembre ha perduto il suo fascino di zona un po’ contrabbandiera e vi si vende tutto quanto si può anche reperire anche nei grandi magazzini. 91 Da Piazza XX Settembre, ripercorrendo a ritroso la strada che conduce in Piazza Grande ed alla Cattedrale, si attraversa un rione densamente popolato ed fortemente commerciale che ha il suo cuore nella • Piazza Cavallotti già citata, ove ogni mattina si tiene, all’aperto, un pittoresco mercato della frutta e dalla verdura: per chi vuol sentire parlare il vero vernacolo livornese, è una tappa d’obbligo. Poco lontano, in • Via Buontalenti, che prende nome dall’architetto fiorentino Bernardo Buontalenti, già citato come il progettista del pentagono della città ideale che si chiamò poi Livorno, c’è un altro mercato all’aperto, ma composto di chioschi che vendono di tutto un po’, alla stregua di altri mercati ben noti ai vacanzieri italiani: • quello di Montecatini Terme, a ridosso della zona alberghiera più chic, e • quello di Viareggio, ove si affaccia la farmacia che fu della famiglia di Mario Tobino. Nel cuore di questo rione, nella piazza che allora si chiamava delle Erbe, e che porta in sé ancora vive le ferite delle distruzioni belliche, sulla facciata di una casa piuttosto modesta, una lapide ricorda che proprio lì nacque Pietro Mascagni. Di Pietro Mascagni si sa ormai quasi tutto, dal momento che la sua avventura musicale fu addirittura soggetto di alcuni film degli anni quaranta-cinquanta. E parecchi altri film ita lia- ni di quell’epoca furono tratti dalla sua opera più conosciuta. Quella Cavalleria Rusticana il cui librettista, Giuseppe Targioni-Tozzetti, ricavò da una delle più lette novelle di Giovanni Verga: quella, appunto, che termina in un duello a colpi di coltello, per motivi d’onore (o di corna, secondo i punti di vista) fra un barrocciaio ed un bulletto delle campagne siciliane di fine Ottocento in un assolato mezzogiorno di Pa squa. L’opera, in un atto, rispetta i tempi aristotelici del dramma ed è rappresentata quasi sempre in abbinamento con un’altra opera in un atto del periodo cosiddetto veristico e che tratta di un altret- 92 tanto truce fatto di sangue e di coltello che ha per teatro un paesotto della Calabria: Pagliacci, di Ruggiero Leoncavallo. Ci sono delle analogie fra i due compositori, almeno per quanto attiene la Toscana: * Pietro Mascagni era livornese, e più toscano di così non si può, anche se i livornesi dicono di essere a-toscani; * Ruggiero Leoncavallo era, invece, napoletano, ma amava tanto la Toscana da volervi morire, a Montecatini Terme, durante il primo conflitto mondiale. A partire dalle prime rappresentazioni - tutti dovrebbero sapere che Cavalleria partecipò e vin- se un concorso per un’opera nuova indetto da una casa musicale milanese, quando Mascagni, lui toscano, era solo il direttore della banda di Cerignola - l’opera ebbe una successo strepitoso e non ci fu cantante d’opera che non l’avesse nel proprio repertorio. Non solo; ma i brani più conosciuti di Cavalleria erano, come si suole dire nel gergo pittoresco dei melòmani, i cavalli di battaglia di tutti i cantanti più famosi del secolo, ad iniziare da Enrico Caruso e Beniamino Gigli, per finire, ai giorni nostri, a Luciano Pavarotti. Ma Pietro Mascagni non dormì sugli allori, e compose - al contrario del suo corregionale e contemporaneo, il lucchese Giacomo Puccini - una messe enorme di opere per lo più dimenticate perché di difficile esecuzione, come Iris, L’Amico Fritz, Lodoletta, Il piccolo Marat, I Rantzau, Silvano, Le Maschere ed Isabeau. Si avventurò anche nella sperimentazione postwagneriana con un’opera, * Guglielmo Ratcliff, tutta dialogata e senza una romanza per la platea, che è la trasposizione in musica della traduzione italiana di un poemetto di Heinrich Heine, ed in quella decadentistica con una * Parisina, nientemeno che su libretto dell’allora imperante Gabriele D’Annunzio. Se ben si gaurda, però, anche la sua opera più conosciuta, la Cavalleria, aveva in sé il seme della sperimentazione, con quella serenata in dialetto siciliano a sipario chiuso e con quel finale urlato, quasi bestemmiato. 93 Pietro Mascagni fu anche autore, durante il suo periodo creativo più intenso, di musiche religiose e di romanze da camera, dimenticate per quasi un secolo ma ora in corso di rivalutazione. Questa produzione vocale da camera di Pietro Mascagni echeggia melodie già sentite e che un buon orecchiante può accostare a quelle dei vari Francesco Cilea e Umberto Giordano suoi contemporanei. Non a quelle di Francesco Paolo Tosti che, in quel periodo della belle-époque fu il vero mattatore di questo particolare genere musicale, e le cui romanze sono tuttora in repertorio presso tenori e soprani di ogni risma. Coperto di gloria e di onori, cittadino onorario di mezza Italia e di buona parte delle città nord e sud-americane con forti colonie italiane, Mascagni fu fatto - cosa che non capitò a Puccini che era, nel frattempo, deceduto - Accademico d’Italia. Si trasferì dalla natìa Livorno a Roma, dove morì il 2 Agosto1945. Dieci anni prima aveva composto la sua ultimna opera, Nerone, e si era appena concluso il secondo conflitto mondiale. Non si erano spenti, però,nella sua Livorno i livori conseguenti alla sua adesione al PNF, e ci vollero altri undici anni perché Pietro Mascagni fosse sepolto con tutti gli onori in una grande tombamausoleo che la sua città natale gli fece costruire, nel 1956, nel cimitero della Misericor- dia, sul tratto di Aurelia che conduce alle falde della collina di Montenero. Al contrario di Giovanni Fattori ed Amedeo Modigliani, a Pietro Mascagni non è stata intitolata una strada anonima di periferia, ma la bella Terrazza sul mare della quale si è già parlato. Ed, oltre all’istituto musicale di Via Marradi, Livorno ha voluto intitolare al suo musicista anche un piccolo museo mascagnano che è ospitato, poco lontano, nella Villa Maria di Via Calzabigi. Il figlio secondogenito di Pietro Mascagni, Edoardo detto Dino, nato a Cerignola e morto in Etiopia durante la campagna d’Africa Orientale del ‘35-36, per non smentire la genialità della famiglia, fu un brillante ingegnere meccanico ed inventore. Fondò una casa motoci clistica che produsse per una decina d’anni la motocicletta Junior - in due versioni: una da 170 e l’altra da 350 cc. - che ebbe un buon successo commerciale. La sua officina era a Castiglioncello e la moto co- 94 stava 5.000 lire nella versione superiore. Ne esistono ancora cin que esemplari e sono oggetto di culto da parte di altrettanti collezionisti. Poi il marchio Junior passò ad una società genovese alla quale è attribuibile quella moto Veltro che fa parte della storia del motociclismo italiano dell’anteguerra. Una breve parentesi storico-gastronomica: l’opera Silvano contiene una barcarola che giace tuttora fra i dimenticati della produzione di Mascagni (la più celebre barcarola ed anche la più conosciuta nel mondo dei melòmani rimane comunque e sempre quella dai Racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach) e che diede nome ad una trattoria dell’angiporto. Distrutto il rione dalle bombe alleate, la trattoria si trasferì sul viale che conduce alla stazione ferroviaria centrale. Vi è tuttora ed è uno dei luoghi di ristoro più rinomati di tutta la costa tirrenica, perché è fra i depositari della ricetta del cacciucco livornese. 21 PIAZZA DECHIRICHIANA, TRE MONUMENTI PER DUE GRANDUCHI, UN CISTERNONE E DUE CISTERNINI ****************************************************************************** ornati su Via Grande e procedendo verso monte, un piccolo slargo accoglie quanto di T questa strada è rimasto non tanto di antico, quanto di vecchio in tutto quel nuovo dei portici: • un edificio settecentesco con portale baroccheggiante detto Palazzo del Picchetto, ove ha sede il Circolo Ufficiali della città, • un monumento a Francesco Domenico Guerrazzi, il politico-scrittore già più volte ci- 95 tato, e • il Cisternino, curiosa costruzione tutta in pietra serena ed eternamente in fase di restauro, fatto costruito ai primi dell’Ottocento su progetto del Poccianti per dare alla cittadinanza l’acqua per le necessità quotidiane. Vi ha sede la Casa della Cultura ove si organizzavano mostre di pittura ed altre cose dell’arte visiva. E’ stata molto attiva fino agli anni Ottanta: poi, forse perché è mancato lo spirito polemico di chi la governava, si è un po’ afflosciata. Qui termina Via Grande, che si immette nella altrettanto grande Piazza della Repubblica che ha l’aspetto di un luogo progettato da Giorgio De Chirico. E’, invece, di più di un secolo anteriore al padre della pittura metafisica italiana, perché fu terminata dall’Ingegner Bettarini in epoca lorenese, ma terminata nel 1874, ad unità d’Italia compiuta da qualche anno.. In precedenza, sotto il granducato degli Asburgo-Lorena, era avvenuto a Livorno l’ampliamento delle mura cittadine che erano rimaste, fino a metà dell’Ottocento, quelle secentesche: e ciò perché la città si allargava incontrollata a più non posso. Fu deciso, così, di coprire il tratto terminale del Fosso Reale (quello che si immette nel Fosso della Venezia all’altezza della Fortezza Nuova) con una piazza che avesse varie vie di uscita. Il tratto terminale del Fosso Reale non fu interrato, come sarebbe stato abbastanza facile a rea- lizzare, ma coperto, su progetto del Bettarini succitato, da una volta che costituì la struttura sulla quale nacque la piazza, che fu chiamata subito dal popolo Il Voltone: quel nome le è rimasto fino a che non è stata chiamata Piazza della Repubblica. La volta è lunga 240 metri ed il canale o fosso sottostante è perfettamente navigabile. All’inaugurazione ufficiale della piazza vi furono istallati dei lampioni a gas, delle panchine di marmo e paracarri di ghisa che la resero totalmente pedonale, impendendo il passaggio di carrozze e barrocci. 96 In onore della dinastia degli Asburgo-Lorena che avevano regnato sulla Toscana e dato impulso allo sviluppo di Livorno, furono eretti sulla piazza, alla distanza di circa130 l’uno dall’altro, due monumenti a due dei granduchi austro-fiorentini. Un primo monumento fu eretto in onore di Ferdinando III, ed era opera dell’elbano - di Portoferraio - Francesco Pozzi, mentre un secondo, opera del livornese Paolo Emilio Demi, era dedica- to a Leopoldo II. Ma i tempi erano cambiati, l’ultimo Lorena era fuggito da Firenze in seguito al plebiscito per l’annessione della Toscana al Regno d’Italia, ed il monumento di Piazza del Voltone fu rimosso. Gli eruditi amanti della storia minore della città dicono che rimase sepolto (ma non dicono dove) per più di una secolo, fino a che non fu piazzato non senza polemiche, al centro di Piazza XX Settembre, quella del Mercatino Americano. Il monumento che si vede ora far coppia in piazza con quello a Ferdinando III fu, invece scolpito da Emilio Santarelli e fu sistemato sul Voltone nel 1885, venticinque anni dopo la fuga dell’ultimo granduca. La piazza ha diversi sbocchi, ma quello principale, quasi di fronte a Via Grande, è la Via De Larderel, che prende il nome dalla famiglia francòfona già citata a proposito della Valdicècina, che ebbe nell’Ottocento un gran ruolo nella prima industrializzazione della Toscana. A metà di questa strada, molto trafficata perché congiunge il cuore della città all’Aurelia e viceversa, è situato un grande ed austero palazzo, che si presenta a destra di chi viaggia verso monte. E’ il Palazzo Larderel, che fu della famiglia già citata e poi sede della società che, fino agli anni sessanta e della nazionalizzazione dell’energia elettrica, gestiva l’erogazione di tal tipo d'energia in quasi tutta la Toscana. E’ ricco di volte affrescate e di grandi saloni come si addiceva alle dimore della gente molto facoltosa, ma attualmente non è visitabile neanche sporadicamente perché è sede di importanti uffici giudiziari. 97 La strada prosegue e, dopo un incrocio, si erge, con la sua mole di pietra serena, un altro simbolo della livornesità: il Cisternone. Inaugurato nel 1842 sotto Leopoldo II Asburgo-Lorena, il grande edificio si presenta con un prònao con otto colonne doriche che compone la facciata, che, a sua volta, sorregge una grande nicchia a volta che dà al monumento l’aspetto caratteristico che oggi tutti conoscono. All’interno del prònao, due lapidi nel latino ufficiale quanto ampolloso del Sette-Ottocento ricordano il perché ed il ed il percome della costruzione dell’edificio. Doveva averne tanta di sete la Livorno del Settecento, se si dovette interpellare Firenze. E da Firenxe arrivò nel 1772 un decreto di Ferdinando III che fece iniziare i lavori di un quedotto che portasse verso la città portuale e fortificata l’acqua che sgorgava abba ac- stanza ab- bondante da una polla sita in una località di prima collina detta Cològnole, lontana dalla città e dal mare parecchi degli attuali chilometri. Iniziati di buona lena, i lavori durarono una ventina d’anni ma, come spesso succede anche gi, (vedi proprio a Livorno un palazzo dello sport la cui costruzione sembra non aver og- mai fine) furono spesso sospesi. Era iniziata, intanto, l’èra napoleonica e Livorno era stata occupata dalle truppe francesi che avevano ben altro da pensare che non al rifornimento idricodi una città che non amavano. Occorse un’altra ventina d’anni per riprendere i lavori: in piena Restaurazione, Ferdinando III ordinò da Firenze la prosecuzione dei lavori iniziati prima della sua caduta e, finalmente, l’acqua arrivò a Livorno, fra il grande giubilo della popolazione, ad una fontana a quattro getti sormontata da una pigna dorata e situata più o meno ove attualmente c’è Via del Seminario. Poi, dato che i consumi crescevano a vista d’occhio, Leopoldo II che era succeduto a Ferdinando III ordinò all’architetto Pasquale Poccianti, lo stesso del Cisternino, di convo gliare sulla città tutte le altre acque sorgive della zona di Cològnole: il Poccianti le con vogliò in un edificiocisterna di sua progettazione, che sorse appena fuori le nuove mura della città. 98 L’edificio è quello che si vede oggi: mancano però due statue - allegoria delle due sorgenti di Cològnole, Morra e Camorra - che il Poccianti avrebbe voluto far installare all’interno della nicchia-conchiglia del suo piccolo capolavoro architettonico. Detto per inciso, nella bassa valle del Serchio, quasi ai confini tra le province di Lucca e Pisa, c’è un paesino che si chiama curiosamente anch’esso Cològnole; è famoso nel conta do pisano per la coltivazione delle pesche. Ma ancora più curioso è il fatto che,lì accanto , c’è un altro paesino, Filéttole, da dove viene pompata l’acqua che attualmente disseta Livorno. A quattro chilometri dalla città, fu fatto costruire dal Poccianti, in piena campagna in una località detta Pian di Rota, un altro Cisternino che aveva il compito di purgare le acque sorgive prossime al convogliamento nel Cisternone. Anche in questo caso i lavori durarono parecchio - quasi una dozzina d’anni - ma il piccolo e funzionale edificio assolse molto bene il proprio compito fino alla fine dell’Ottocento, quando fu abbandonato a sé stesso. Il complesso sistema del rifornimento idrico della città di Livorno è oggi oggetto di culto da parte degli appassionati di archeologia industriale, tant’è vero che vengono anche organizzate delle visite guidate ai vecchi impianti lorenesi. La facciata del Cisternone è stata restaurata ed illuminata scenograficamente qualche anno fa dopo quasi un secolo di degrado, mentre il Cisternino di Cològnole attende ancora qualcuno che si occupi di sé. 99 22 IL LEONE DI SAN MARCO IN DIFESA DELLA REPUBBLICA, UNA SCISSIONE STORICA ED UN CANALE (TEORICAMENTE) NAVIGABILE **************************************************************************** opo il Cisternone e la piazza omonima, la strada continua dritta come un fuso - se si D prosegue verso monte - verso l’Aurelia, prima, e, la Stazione Centrale, poi. Ma proprio davanti al Cisternone la segnaletica indica diverse località che si trovano nei rioni a nord della città. Svoltati a sinistra, dunque, ci si immette in alcune strade dritte ed anonime che conducono ad una piazza con un po’ di verde rachitico sulla quale incombe un tratto di mura ottocentesche ed una porta sormontata dal leone veneziano. E’ Porta San Marco, una delle due rimaste delle sei delle quali era dotata la città. Esse erano: • Porta Fiorentina, dalla quale si dipartiva la strada che conduceva a Pisa ed a Firenze; ma che ora si chiama Barriera Garibaldi, ed è sull’Aurelia, nei rioni a nord della città, • Porta a Mare, sul porto; • Porta Maremmana, nella zona ora residenziale di Via Roma; • Porta San Leopoldo, che era più o meno ove è il Cantiere Navale; • Porta della Dogana d’Acqua, ove aveva termine il Canale dei Navicelli, ed, appunto, • Porta San Marco, sita nei pressi di una stazione ferroviaria leopoldina, prima che la linea venisse deviata a monte della città. Tutte queste porte facevano parte del sistema difensivo della città voluto da Leopoldo II che fece costruire un nuovo cerchio di mura, allargandola fino a zone allora di campagna. Qualche tratto di quelle mura lorenesi è ancora visibile, ma altri tratti sono nascosti da co- struzioni varie; altri, poi, furono distrutti tra l’Otto ed il Novecento, per i motivi di traffico che decre- 100 tarono in ogni città della Toscana - meno che a Lucca ed, in parte, a Pisa - la scomparsa di mura e di bastioni. Porta San Marco è importante nella storia della città, non tanto perché alla sua sommità c’è un leone veneziano, quanto per il fatto che fu teatro, nel Maggio del 1849, dell’ultima resistenza della Repubblica di Livorno contro gli austriaci che cercavano di entrare nella città che si era permessa di andar contro i voleri di Leopoldo II. Ci furono episodi di eroismo sublime ed altri di crudeltà efferata; ma, poi, come da copione, le truppe austriache riuscirono a sfondare, dopo vari tentativi. Enrico Bartelloni detto Il Gatto, che comandava gli ultimi rivoltosi, fu fucilato sul posto ed iniziò il processo di normalizzazione secondo i voleri granducali. Dieci anni più tardi, sopraffatto dagli avvenimenti, Leopoldo II - non più bel giovane biondo ma dai capelli color stoppa tanto da meritarsi il nomignolo di Canapone - lasciò l’ingrata e bècera Firenze per stabilirsi nella più tranquilla Vienna ove non c’erano a corbellarlo gli stenterelli, ma si affacciava al successo la famiglia degli Strauss. Qualche centinaio di metri entro la cinta di Porta San Marco, lato mare, sulla facciata di quello che era il Teatro San Marco - distrutto anch’esso da un bombardamento e mai più ricostruito una lapide non nel latino ampolloso dei lacchè dei Lorena, ma in un italiano che sembra uscito dalle tetre cronache di antichi congressi sovietici degli anni Trenta, ricorda - citando Marx, Engels, Lenin e Stalin - che proprio qui avvenne, nel 1921, la famosa scissione dell’ala massimalista dal Partito Socialista Italiano e l’inizio della storia sessantennale del PCI finita con la caduta dell’impero sovietico. E di qui si ritorna nei pressi della Fortezza Nuova da dove la strada, attraversando un pezzo della Nuova Venezia, conduce al Porto Industriale ed ad una serie di grandi stabilimenti. Non ci sarebbe nulla da aggiungere, perché il viaggio si svolge in una zona piuttosto brulla e fra muri di cinta, depositi ferroviari e pile di containers. 101 Ma, proprio all’inizio di questa zona fortemente industrializzata ed all’uscita della città antica, al limite delle mura lorenesi, esistono i ruderi di un edificio chiamato Dogana d’Acqua, che aveva le funzioni di casello daziario e doganale per tutto quanto entrava dal mare nel granducato. L’edificio fu fatto costruire nel 1841, regnante Leopoldo II, contemporaneamente alla nuova cinta muraria, su progetto dell’architetto austriaco Reiskammer. Ebbe funzione di dogana e di luogo di riscossione di dazi e gabelle varie per più di un secolo: anche quando il granducato era finito da un pezzo. Oggi la zona è completamente sconvolta perché ai bombardamenti alleati che ridussero la Dogana d’Acqua ad un cumulo di macerie, si aggiunsero gli interramenti degli anni Cinquanta: anche questa volta, per motivi di traffico. E dire che la costruzione, tutta in stile con le mura ed edificata quindi con lo stesso pietra me, poggiava su tre archi sotto i quali passavano i natanti, ed era abbellita da dei delfini di metallo, attualmente istallati davanti al porticciolo turistico dell’Ardenza. La Dogana d’Acqua era anche il terminale livornese del Canale dei Navicelli che congiungeva l’Arno al porto di Livorno: e che, teoricamente, lo congiunge ancora se le parti terminali non fossero interrate.. Questo canale navigabile nasceva a Pisa nel rione di Porta a Mare, all’altezza della Cittadella ove esiste tuttora un rudere che incuriosisce il passante - e più spesso i clienti di un grande negozio di fotografia ed ottica - ma che nessun ente del turismo né alcuna sovrintendenza alle belle arti si sono mai degnati di segnalare con una targa gialla. Il rudere, analogamente alla Dogana d’Acqua di Livorno, aveva un arco sotto il quale passavano le barche, non dopo aver pagato tasse e balzelli sia in entrata che in uscita. Il Canale dei Navicelli fu iniziato nel 1573, in epoca medicea, e terminato pochi anni dopo. Occorsero migliaia di manovali e, quasi certamente, molti di essi erano galeotti o, comunque, gente che con il lavoro poco aveva a che fare. Tanto sudore per scavare quel canale che doveva collegare 102 il nascente porto di Livorno con l’Arno prendendo la pianura malarica in diagonale, ed evitando il mare aperto ed giro di Bocca d’Arno alle imbarcazioni da carico dette navicelli. Queste imbarcazioni, molto robuste e dal fondo piatto, assolvevano lungo l’Arno, il compito che avevano i leudi in Liguria. Avevano una vela latina, ma spesso venivano governate a remi se non addirittura trascinate da riva da squadre di uomini forzuti e. durante certi periodi non infrequenti di miseria, anche da donne. I navicelli trasportavano merci povere come legname, carbone, laterizi, sassi e quella pietra serena con la quale sono stai costruiti i monumenti più insigni di Firenze e delle altre città toscane che facevano parte della Signoria, prima e del Granducato, poi. I navicelli avevano anche la funzione di corriere; vale a dire, trasportavano piccole partite e là lungo il Valdarno Inferiore. Una fermata per uno scarico qui, poi ripartenza per qua un altro carico là, e così via per quattro secoli abbondanti. Tutto ciò accadeva fino a che l’Arno fu navigato dalla sua foce fino a Signa, ove esiste una località che si chiama tuttora Porto di Mezzo, perché si presume che ivi fosse il capolinea dei navicelli per il trasbordo su barrocci del carico diretto a Firenze. I navicelli non erano costruiti né a Livorno né menchemeno a Pisa, ma a Limite sull’Arno, allegro paesotto sito quasi davanti a Montelupo Fiorentino. Lì si era istallata, nel Seicento, una dinastia di maestri d’ascia di origine catalana: il suo cognome era impronunciabile per la gente del luogo, che li ribattezzò fiorentinamente Picchiotti. Uno di costoro, abilissimo e chiamato Becolino, brevettò - se così si può dire - un vascello che aveva tutte le caratteristiche per essere adibito al trasporto giù per l’Arno fino a Pisa e, di qui, via canale mediceo, al porto della nascente Livorno. Alcuni discendenti di Becolino Picchiotti, poi, aprirono un cantiere navale proprio a Livorno; forse per questioni di spazi portuali, detto cantiere, poi, si trasferì a Viareggio ove scrisse alcune pagine memorabili nella storia della nautica maggiore mediterranea. 103 Gli storici della navigazione hanno contato a seicento il numero dei navicelli varati durante i secoli dal cantiere di Limite. Molti di essi continuarono a solcare le acque infide dell’Arno e quelle piatte del Canale dei Navicelli fino all’arrivo del consumismo: non ne esiste più neanche uno. Neanche una carcassa da farne un paragone con quei tre o quattro leudi che sono ancora in vita nella Riviera di Levante. Il navicello ebbe, nei secoli scorsi, addirittura una buona parte nell’industrializzazione della montagna tosco-emiliana. Lassù, infatti, si istallò, verso il Cinquecento, la famiglia degli Appiani , signori di Piombino e padroni della Magona dell’Elba, cioè delle vena di ferro, che portò sulla Montagna Pistoiese l’arte della metallurgia. Per far arrivare il minerale di ferro dalle miniere dell’Elba all’Alta Valle del Reno (a cavaliere fra le attuali province di Pistoia e Bologna) fu escogitato un sistema di trasporto di questo tipo: • nave, per il trasporto dei corbelli (o coffe) di minerale dall’Elba fino a Livorno, poi • navicello, da Livorno a Pisa via Canale dei Navicelli, e proseguimento controcorrente fino a Signa, ove l’imbarcazione imboccava l’Ombrone Pistoiese per raggiungere Poggio a Caiano: quindi, trasbordo dei corbelli su • barrocci, fino a Pistoia ed, infine, • dorso di mulo, da Pistoia fino a Pracchia. I rari documenti ancora esistenti non parlano di termini di resa. Negli anni Cinquanta un gruppo di deputati della circoscrizione elettorale costiera, della quale Livorno faceva parte, fecero un’interpellanza al governo per sollecitare la costitu zione di una zona industriale fra Pisa e Livorno che sfruttasse il Canale dei Navicelli che, coi suoi sbocchi in mare ed in Arno, sarebbe stato la via di comunicazione ideale per il tra sporto di merci povere e materie prime. 104 Non si combinò niente, malgrado che fra i deputati sottoscrittori dell’interpellanza ci fossero personaggi del calibro del versiliese Leonetto Amadei che fu, poi, fra i primi presidenti della Corte Costituzionale, e Randolfo Pacciardi, grossetano, mazziniano e capo storico del Partito Repubblicano Italiano ante-La Malfa Padre. La strada che sinora si è percorsa prosegue ancora fra grandi stabilimenti, poi • attraversa ponti su canali di bonifica e sul Canale Scolmatore che proviene da Pontedera e serve a deviare le acque dell’Arno che, quando il padre dei fiumi toscani è in piena, sommergerebbero tutta Pisa e la sua Piana; quindi • giunge nella zona di Calambrone (ma siamo già in comune di Pisa) già citata per le ex-colonie marine, ed, infine, • approda a Tirrenia dalle grandi spiagge di finissima sabbia, frequentatissime dai livornesi che non se la sentono di far il bagno di scoglio, ed ove termina il nostro viaggio. 105 APPENDICE N°1 23 LA CITTÀ MULTIETNICA A TAVOLA: DA UNA ZUPPA TURCA A UN CAZZOTTO INGLESE ED AL PARMIGIANO SUL NERO DI SEPPIA ELOGIO DEL CACCIUCCO ELOGIO DEL PONCE ******************************************************************** ELOGIO DEL CACCIUCCO... e, alla Ruota della Fortuna, Mike Bongiorno chiedesse quale parola di italiano ha cinque S cì-come-Como, pochi saprebbero rispondere: infatti, l’unica parola italiana con cinque c è Cacciucco. Che è il piatto tradizionale della città di Livorno. Un po’ come il risotto a Milano, le trenette col pesto a Genova, la bagnacàuda a Torino, la ribollita a Firenze, e via elencando. Secondo gli estensori di alcuni vocabolari italiani, la parola dalle cinque cì significa poco più che una zuppa di pesce che si fa a Livorno ed a Viareggio. Provate a dire una cosa del genere a Livorno e rischiate il linciaggio: cacciucco è solo livornese. Al massimo viene accettata come viareggina solo una zuppa di pesce (e non cacciucco, sia chiaro) piuttosto insipida perché mancante di alcuni elementi - come il peperoncino, o zenzero - che fanno del cacciucco livornese un unicum fuori dal comune. Poi, a Viareggio quella zuppa è ormai da locali storici; è offerta come rarità gastronomica in locali un po’ su, ed è abbinata a vini bianchi di pregio. Il cacciucco livornese, invece, viene ancora fatto in casa dalla massaie non ancora estinte; nelle trattorie che non vantano ancora forchette e cappelli vari; in posti comuni, insomma. E è abbinato - se così si può dire - con vino rosso e neanche tanto d.o.c.. Unica cosa certa è che ci vuole una decina di pesci diversi tuffati in un intingolo ben tirato, con pane abbrustolito ed agliato generosamente e zenzero squillante. 106 Non devono mancare seppie, fette di palombo (o nocciòlo), cicale, gamberi, murene, gronghi, capponi, scòrfani, gallinelle, con l’aggiunta di altre specie di pesci proletari che è dif- ficile trovare sul mercato perché nessuno li vuole, tanto sono liscosi. Che altro dire di questo piatto? • che la parola pare provenga dal turco antico, ove katçùk aveva il significato di mescolanza; • che non abbia un inventore sicuro né una data precisa di riferimento, • che fosse il risultato della cottura casalinga di tutto ciò che i pescatori, a fine giornata, non erano riusciti ad esitare sul mercato e del pane raffermo; duro sì, ma da non gettare nella spazzatura come si fa oggi. • che, insomma, fosse lo specchio culinario della città multietnica e proletaria che si affacciava sulla ribalta della storia italiana. Il fatto è che, nel 1998, quando una delle varie multinazionali dell’alimentazione mandò in onda su tutte le emittenti uno spot pubblicitario nel quale Diego Abatantuono chiamava cacciucco una zuppa di pesce surgelata, ci fu, a Livorno, una specie di sollevazione popolare e si invocarono provvidenze comunitarie a difesa della livornesità del cacciucco. Ma c’è di più: un’associazione di cuochi livornesi si coalizzò ed offrì, ai colti ed agiati visitatori di una grande e raffinata mostra di opere di pittura dell’Ottocento che si teneva a alla Villa Mimbelli, un pranzo a base di cacciucco livornese a 25.000 lire, vini, minerale, coperto e - perché no? Iva - inclusi. Un’inezia, per gente abituata a locali con nouvelle-cuisine da 100mila in su, vini eccetera esclusi. Per rimanere nel frivolo, ci fu anche un locale della media valle del Serchio, molto famoso perché molto caro, che propose il cacciucco di pesci d’acqua dolce: non si sa bene dove pescati, perché nel fiume di Lucca non è che ci sia tanto da pescare. DEL PONCE,... 107 elle algide mattine d’inverno quando tutto è ancora sottozero e la brina non ce la fa a N sciogliersi, c’è ancora chi si scalda con un cicchetto, malgrado i divieti imposti dai medici e gli anatemi degli igienisti: ciò avviene soprattutto in montagna, ove il culto del cicchetto ha radici antiche ed alpine. Ma sul mare? Sul mare, ponce: almeno qui a Livorno. La parola è di chiara origine inglese, perché punch (che si pronuncia pànc’) vuol dire, sì, pugno o cazzotto, ma ha anche il significato di una bevanda bollente a base di acqua calda e rhum usata come un cazzotto liquido a bordo delle navi di Sua Maestà Britannica durante le traversate dei freddi mari del Nord. E’ anche chiaro che, come tante parole straniere, anche punch fu storpiato in ponce da qualche marinaio livornese che aveva contatti con suoi omologhi inglesi bevitori del cazzotto liquido. Ma il ponce livornese non ha nulla a che fare col punch inglese. Tanto per cominciare • il rhum non è più tale, ma è il rumme; non proviene dalla Giamaica ma da fabbrichette locali, è a base di spirito, ed il suo gusto è dato da additivi permessi dalla legge. E, insomma, quello che si chiama anche rumme-fantasia; • l’acqua calda degli inglesi è stata sostituita dal caffè espresso, altro ingrediente che più italiano non si può; • il tutto, poi, viene portato a bollore con un soffio di vapore acqueo come solo i baristi provetti sanno fare. Si può zuccherare e farvi anche aggiungere • la vela, che è una scorzetta di limone. Nel caso la cura-ponce non bastasse, si può aggiungere alla dose • una persiana, che è un intruglio di colore verde e composto di liquori di menta ed anice. 108 ...E DEGLI ALTRI PIATTI LIVORNESI e buone massaie che ci leggono, però, sanno che un altro piatto di ormai diffusione nazio- L nale è • la triglia alla livornese, ovvero in guazzetto, con prezzemolo, aglio ed appena un po’ di pomodoro. Di più difficile catalogazione è • il baccalà alla livornese, fatto in stufato e con abbondanza di pomodoro. Secondo Vincenzo Buonassisi, questo piatto regge bene il vino rosso, perché è piuttosto robusto e per palati forti. Sempre per stare in campo di piatti a base di prodotti del mare, una stranezza è, invece, • il riso al nero di seppia, che non avrebbe nulla di strano - perché è un piatto veneziano e non esotico - se a Livorno non lo cospargessero di formaggio parmigiano grattugiato. Un’altra stravaganza sono • i fichi sottolio, una vecchia ricetta casalinga che è stata resuscitata da poco ma che merita di essere citata. Si tratta, in poche parole, di fichi che, raccolti freschi e ben integri, si fanno cuocere e stracuocere per poi imbarattolarli nel vetro sterilizzato. Messi a riposare, dopo qualche tempo emettono un sughetto dolcissimo ma giallastro che sembra olio. Di qui la strana dizione. 109 APPENDICE N° 2 SOPPRESSATE GIGANTESCHE E LA EX-NUORA DELLA REGINA P.R.-WOMAN DEL SASSICAIA ELOGIO DEL CINGHIALE ELOGIO DEI VINI ELOGIO DELL’OLIO ***************************************************************************** ELOGIO DEL CINGHIALE... e la cucina di Livorno, intesa come città portuale e marinara, ha il sapore del pesce con S l’aggiunta di ingredienti non proprio da gente debole di stomaco, quella della costa che è a sud del capoluogo non ha una sua storia precisa. Il fatto - lo abbiano sottolineato più volte - è dovuto alle condizioni ambientali, pessime fino a qualche decennio fa quando tutto il territorio costiero non si chiamava Costa degli Etruschi, ma più semplicemente Maremma Settentrionale. E Maremma ha sempre significato vita grama e malaria. Si salvavano dalla disperazione solo alcuni paesini dell’entroterra che, alti qualche centinaio di metri sul mare, godevano di un clima leggermente migliore. Erano paesi di cacciatori incalliti di piuma e di pelo, ed il loro bersaglio preferito era il cinghiale. Questo strano animale selvatico e peloso della famiglia dei suini si è ora riprodotto in maniera esponenziale e rovina tutto quello che è possibile rovinare. Animalisti ed ambientalisti coalizzati ne hanno fatto vietare la caccia incontrollata; il suo abbattimento è addirittura regolato da leggi regionali. Ciononostante, il cinghiale è, all’inizio dell’inverno, oggetto di battute di cacciatori pro vetti e la sua fine è nelle casseruole delle case rurali e nelle macellerie dei paesi. Si uccidono ormai tanti cinghiali che ne è nata una specie di piccola industria; e la do manda è robusta, nei ristoranti di tutta la regione. 110 D’inverno, soprattutto, dato che la sua carne è di non facile digestione ed occorrono, per mandarla giù, frequenti libagioni. Una delle trasformazioni più singolari del cinghiale è la soppressata, detta in diverse parti d’Italia anche testa-in-cassetta. Sono i rimasugli delle teste dei cinghiali che sono confezionati da abili macellai in proporzioni a volte gigantesche. Chi ha l’occasione d'andare a Novembre a San Miniato - un gioiellino di cittadina a metà strada tra Firenze e Pisa, nel Valdarno Inferiore - durante lo svolgimento della Festa del Tartufo, ne può vedere di dimensioni da Guinness. Ma anche nel retroterra dell’attuale Costa degli Etruschi, non scherzano: ci sono diverse Sagre del Cinghiale e la più famosa è quella di Suvereto, paesino medioevale celebre solo per questo. Ancora più all’interno, a Volterra, città di vento e di macigno, un piatto che sarebbe degno di miglior fortuna presso gli studiosi della gastronomia, è il cinghiale alla volterrana: uno stufato che era presentato con una corona di castagne lessate. ...E DEI VINI on è molto - sì e no tre o quattro anni - che anche in Italia si sono create le Strade del N Vino, in analogia a quanto già succedeva in Francia da parecchio tempo. In Toscana, che di vini ne produce a bizzeffe e tutti sulla bocca di tutti, dai più comuni ai più pregiati, la prima provincia a dotarsi di una strada del vino è stata quella di Livorno. Forse perché non molto estesa, forse perché la produzione non raggiunge i volumi di quelle di Firenze e Siena, forse perché c’è stato maggior impegno, forse perché si è capito in anticipo il valore aggiunto del turismo enogastronomico. La Strada del Vino della Provincia di Livorno inizia alle spalle della città capoluogo, piega verso il territorio di Collesalvetti e prosegue verso sud seguendo grossomodo la direttrice dell’autostrada n° 111 12 che proviene da Pisa e Genova. Giunge all’altezza di Vada e prosegue, poi, verso Piombino ove termina. In tutto questo territorio, molte sono le zone vitate, ma solo tre i siti ove si producono vini che hanno una d.o.c.; essi sono: • il territorio di Montescudaio e di alcuni piccoli comuni che sono alle spalle di Cècina, e, più a sud, • il territorio di Bòlgheri, in comune di Castagneto Carducci, nonché • la Val di Cornia, alle spalle di Piombino. Per questi ultimi due territori si può parlare di d.o.c. piuttosto recenti e, conseguentemente di prodotti non ancora ben conosciuti dal mercato (otto tipologie a Bòlgheri e quattro nella Val di Cornia). Fanno eccezione due grandi vini delle tenute dei Della Gherardesca e degli Incisa Della Rocchetta di Bòlgheri, il Sassicaia e l’Ornellaia, che hanno riempito di sé pagine e pagine di riviste specializzate; hanno fatto prendere la laurea ad honorem in agronomia al loro in ventore (perché di invenzione in questo caso si tratta) hanno anche il fascino indiscreto delle cronache rosa per le frequentazioni in zona della ex-nuora della Regina d’Inghilterra. Sono considerati vini da collezione; valgono cifre imprecisate ed è difficile, se non impos- sibile, trovarli nelle enoteche qualunque. Il piccolo comune di Montescudaio (amministrativamente compreso nella provincia di Pisa) invece, è da sempre il fulcro della zona di produzione degli omonimi tre vini a d.o.c. che sono: • il Montescudaio Bianco, da uve Trebbiano, Malvasia e Vermentino; vino bianco secco e rinfrescante, adatto agli antipasti delicati, uova, crostacei e molluschi e preparazioni di pesce in bianco; • il Montescudaio Rosso, da uve Sangiovese, Malvasia Nera, Trebbiano, e (poca) CabernetSauvignon; vino rosso secco, adatto a primi piatti a base di selvaggina, carni rosse alla brace, cacciagione e formaggio pecorino; ed, infine, 112 • il Montescudaio Vin Santo, dalle stesse uve del Bianco ma invecchiato (o maturato come vuole Luigi Veronelli) nelle vinsantaie per almeno tre anni in caratelli di legno di.due ettolitri. Può essere secco, semisecco e dolce, è vino da fine-pasto (o da meditazione), e si accompagna bene con la pasticceria secca, crostate e cantuccini. Tutt’intorno, cresce e prospera l’olivo e da qualche anno anche la produzione oleicola è fra quelle emergenti della Costa degli Etruschi. Il suo Olio Extravergine d’Oliva ha ottenuto da poco la IGP (Indicazione Geografica Protetta) come Toscano e si produce coi suoi frutti, le olive, colti sulla pianta e spremuti a freddo nelle ventiquattr’ore successive alla raccolta. ELOGIO DELL’OLIVA E DEL SUO OLIO *************************************************************** 113 ’albero dell’olivo vive nelle regioni temperate come la Toscana ed, in condizioni climati- L che favorevoli, diviene una pianta di incredibile longevità; quando è anziana, può raggiungere anche decine di metri di altezza e molti di circonferenza. Nel mondo se ne conoscono duemila varietà, che si chiamano tecnicamente cultivar; solo in Italia se ne contano trecentonovantacinque. Spesso i suoi frutti, le olive che, con termine botanico, sono drupe, hanno nomi a dir poco poetici a seconda di queste varietà: e, così, ci sono le leccine, le moraiole, le frantoio, le caroleo, le caratine, le taggiasche, le agugge (aghi, in genovese), le manzanelle, le koroneiki, le chetoul, le lavagnine, le colombare, le pignole, le mortine e le razzole, solo per citare quelle più conosciute. I suoi rami dalle foglie grigio-argento, una volta potati, possono essere esitati durante la set- timana antecedente la Domenica delle Palme per essere venduti agli ingressi delle chie se per la loro benedizione: è una antica tradizione cattolica che ha radici nel Vangelo. Come fanno parte della tradizione cattolico-romana e di quella greco-ortodossa i sacra menti che hanno, come tramite tra la Divinità e l’uomo, l’olio che - date le origini mediter ranee della religione cristiana e le sue radici bibliche - non può essere che di olive. Lo stesso vocabolo Cristo è aggettivo greco che vuol dire unto: e da chi se non dal Signore Dio dell’Universo? D’altra parte, partendo dalla stessa radice, si ha il sostantivo Crisma (volgarizzato in Cresima) che, sempre in greco, vuole dire unzione. E sono olii della tradizione cristiana quelli del battesimo, della cresima, quello della ordi- na- zione sacerdotale e quello dei malati. Quest’ultimo si chiamava, in era preconciliare, olio santo o, che peggio, estrema unzione, moribondi. perché con esso veniva segnata con la croce la fronte dei 114 Oggi, si è tornati alla antica dizione di olio dei malati, ed infatti nelle vecchie chiese ci sono ancora piccoli tabernacoli ove tale olio veniva custodito, e che portano tuttora incisa nella pietra la scritta latina oleum infirmorum. E sempre in altra epoca preconciliare - ma in questo caso si parla non del Concilio Vaticano Secondo, ma addirittura di quello di Trento che si tenne in pieno Rinascimento - erano proibiti il mercoledì, il venerdì, il sabato, per tutta la Quaresima ed i giorni di vigilia delle feste liturgicamente importanti, il mangiare la carne e l’uso dei grassi di origine animale (burro, strutto, lardo, etc.). Nella fascia mediterranea si sopperiva alla bisogna con l’olio di oliva e con quello di noci - ricordate Fra Galdino nei primi capitoli dei Promessi Sposi? - in quella prealpina. Ciò avveniva, ovviamente, nelle case dei nobili e dei prelati, ove si facevano pranzi e cene per strabiliare di fronte agli ospiti e dar loro segno del proprio potere. Non si hanno, invece, notizie certe di quanto accadesse invece nelle case dei povericristi, ma è indubbio che dei pranzi e delle cene dei ricchi ci sono pervenuti addirittura i menù e gli ordini di servizio al personale di cucina e di dispensa. E così si è venuti a sapere che, per esempio, nella dispensa dei palazzi di Lodovico Maria Sforza, l’ ultimo duca di Milano meglio conosciuto come Lodovico il Moro e protettore di Leonardo da Vinci, c’era, oltre allo strutto ed al burro, l’olio di oliva (forse importato dalla Liguria) come unico condimento lecito nei giorni proibiti. Stessa cosa doveva accadere nella dispensa della corte dei Medici, tanto per rimanere in Toscana, ed in quelle di tante altre celebri casate dell’Italia delle Signorie. Nei paesi musulmani non mediterranei, come quelli della Penisola Arabica, poi, l’olio d’oliva aveva, invece, anche un significato medico se non taumaturgico: infatti, era venduto, fino a qualche anno fa, in ampolle o bottigliette nelle farmacie od in negozi similari.Oggi quasi certamente non più, perché anche paesi allora chiusi all’Occidente si sono omologati e sono entrati di forza anche loro nel mondo della globalizzazione. 115 Anticamente, da noi, le foglie degli olivi potati venivano anche usate in farmacia per ottenerne un infuso ipotensivo: se ne trova traccia nelle erboristerie dove questo ipotensivo all’olivo è stato rilanciato e fatto passare come un medicamento alla moda. Le stesse foglie, però, nelle campagne venivano più prosaicamente date come pastura a vacche, cavalli, asini e muli. I rami, invece, una volta seccati, erano bruciati ed il loro fuoco emanava un sottile profumo, ottimo per aromatizzare arrosti allo spiedo di carni e selvaggina di ogni tipo. La raccolta delle olive si chiamava brucatura ed aveva inizio a fine novembre per quelle maturate precocemente, comunque mai più tardi del 13 Dicembre, giorno di Santa Lucia: un proverbio di origine incerta diceva: “Per Santa Lucia lascia la ghianda e piglia l’ulìa”. Fino alla seconda guerra mondiale, la frangitura delle olive veniva fatta nei frantoi a macine annessi alle case coloniche od in quelli pubblici, ma la lavorazione era identica a quella dei tempi di Omero, prima, e di Gesù, poi.. Pare, infatti, che la coltivazione degli olivi più o meno selvatici fosse stata introdotta in Liguria nella notte dei tempi dai Fenici o Focesi, che provenivano dall’attuale Libano ma che avevano colonizzato la zona delle foci del Ropdano e fondato una città che poi prese il no Marsiglia. Nell’Italia del Sud, invece, pare che la me di tale coltivazione fosse stata introdotta dai Greci. Fenici e Greci avevano conosciuto l’olivo da popoli caucasici come gli àzeri - quelli dell’Azerbaijan di ora, insomma - coi quali erano entrati in contatto per motivi di scambi commerciali. Cose che facevano certamente anche gli Etruschi che abitavano quelle che sono oggi la Toscana centrorientale ed il Lazio settentrionale. Etruschi, Fenici e Greci tramandarono le loro esperienze in fatto di coltivazione dell’olivo ai Romani. Invece, la coltura razionale dell’olivo viene fatta risalire da alcuni storici ad epoche più recenti, e cioè alle Crociate, quando dei soldati portarono dalla Palestina delle piante d’olivo ai benedettini. 116 I buoni frati-lavoratori le disposero ordinatamente nel corso delle loro bonifiche dell’Italia malarica e delle sue campagne abbandonate dopo il passaggio dei barbari, fino alla creazione di quelli che oggi sono gli oliveti. Le olive vi venivano raccolte ed, immesse in sacchi di iuta od in ceste di vimini , erano trasportate nei frantoi: qui erano schiacciate da macine a mole cilindriche di pietra e ridotte in una pasta che veniva a sua volta ingabbiata con la pala in altre ceste di tessuto vegetale o animale (canapa, crine, giunco) per essere poi poste sotto lo strettoio (o strizzatoio) per sfruttarne per schiacciamento ogni goccia d’olio prodotto dalla frangitura. Le mole venivano mosse in un moto rotatorio continuo da un complicato sistema di viti senza fine (di legno, non essendo ancora conosciuta l’utilizzazione del ferro e dell’acciaio neanche nei macchinari più semplici) che veniva a sua volta messo in moto prima dagli schiavi, poi da animali pazienti quanto basta (asini o muli). Poi, scoperta la forza motrice, le mole vennero azionate prima con l’energia idraulica ed altrettanto complicati sistemi di gore, bottacci e ruote a pale; infine, con motori a vapore e, da ultimo, elettrici. Nel Carrarese, oltre il paese di cavatori di Torano, esistono tuttora i resti di una cava da ove venivano estratti i blocchi destinati ad essere ridotti, a colpi di scalpello, a macine o mole cilindriche per frantoi e mulini. La pietra, che è stata scavata fino ad un secolo e mezzo fa, non è marmo perché la cava delle macine è ai margini di quelli che i geometri chiamano agri marmiferi: è, invece, macigno, quella pietra grigiastra e dura da selciati, lonta na parente della pietra serena con la quale fu costruita Firenze. Con la lunga macinatura delle olive e dalla pasta ricavatane, si otteneva così • l’olio extravergine (o di prima spremitura a freddo), mentre la pasta rimasta, miscelata ad acqua tiepida, veniva rimacinata e ristrizzata fino ad ottenere 117 • l’olio di sansa, in genere di qualità a dir poco scadente ma di uso quasi quotidiano fra tutti i ceti sociali, sia per friggere che per condire. Quel che rimaneva dopo l’olio di sansa si chiamava morchia: era un impasto grasso, nero e piuttosto puzzolente che serviva per lubrificare i mozzi delle ruote dei carri e dei barrocci che, in campagna, abbondavano. Fra i sottoprodotti della frangitura delle olive non si deve dimenticare • l’olio da illuminazione (o lampante) per quelle fumiganti e non certo profumate lampade che sono state usate nelle campagne e nelle periferie delle città toscane fino all’arrivo della corrente elettrica, e • la carbonella di sansa, ottenuta facendo carbonizzare i nòccioli delle olive; questa carbonella veniva venduta nei neri negozi dei carbonai e veniva usata per farne la brace degli scaldini o caldani, unici mezzi di riscaldamento per le mani piene di geloni delle nostre nonne. Le olive, insomma, erano un po’ come Verdi ed il maiale: non si buttava via niente Tornando all’olio extravergine, appena spremuto dalle olive scorreva dallo strizzatoio in un gorello per finire in un recipiente di legno chiamato tinella od ad una conca di terracotta, insieme all’acqua di vegetazione sulla quale galleggiava. Veniva quindi raccolto per sfioramento col piatto (o nappo) ed introdotto in barili di legno; successivamente era messo a chiarire per un giorno in conche di terracotta pulite ed asciutte. Il giorno dopo, calate sul fondo tutte le impurità, l’olio veniva definitivamente messo negli orci; i locali dove maturava fino al consumo si chiamavano orciaie ed erano quello che, per il vino, sono le cantine. Gli olii extravergini o di prima spremitura a freddo appaiono per qualche mese verdognoli: è l’effetto della clorofilla ancora presente nelle olive un po’ più acerbe che, a volte, si sono confuse con quelle veramente mature. 118 Da più di cinquant’anni, comunque, la spremitura delle olive e, conseguentemente, la produzione dell’olio hanno raggiunto forme industriali considerevoli, sia come tempi di lavorazione sia come purezza del prodotto. Questo, solo parlando dell’extravergine. L‘olio di sansa, invece, dopo essere stato lavorato in raffinerie, assume la denominazione generica di olio d’oliva. Ne sono strapieni gli scaffali dei supermercati, e fa compagnia agli oli di semi, frutto di una moda importata, già nel primo dopoguerra, dai paesi del Nordeuropa. Il consumo di questi olii, prodotti a bassissimo costo dalla spremitura della copra (la polpa dei cocchi seccata al sole africano), prima, e di quella dei semi di girasole, di soia, di colza, di mais ed ora addirittura di riso, soppiantò, per un buon mezzo secolo, quello dell’olio di oliva ritenuto a torto troppo mediterraneo e quindi troppo terrone. E’ stata, però, un’altra moda, quella della dieta mediterranea, a far tornare in auge l’olio di oliva e soprattutto l’extravergine. Oggi esistono anche, alla stregua dei sommeliers degli assaggiatori di vini, gli assaggiatori di olii di oliva extravergini che sono in grado di dare un’aggettivazione diversa a seconda del- la provenienza (od origine) e delle cultivar: si hanno così olii fruttati, maturi, medi o leggeri, dolci, profumati, mandorlati, amari, piccanti, lisci ed intensi. Si sono adeguati a queste mode alcuni ristoranti dai vari cappelli e dalle varie forchette e dalle tariffe piuttosto robuste, che ora hanno - oltre alla carta dei vini - anche il carrello degli olii. Non solo: ma scopiazzando un po’ l’uso francese, introdussero qualche anno fa presso una loro clientela tutt’altro che raffinata ma danarosa, la citronette e la vinaigrette che non so no altro che due salsette ottenute sbattendo con una forchetta un po’ d’olio ed un po’ di succo di limone, per la prima, ed un po’ d’aceto per la seconda. Ambedue le salsette necessitano anche di un pizzico di sale fino, e servirono a certi ristoratori a far alzare i loro prezzi già poco abbordabili In Francia queste due salsette sono, però, poco più che un esotismo, perché l’olio prodotto dal- la spremitura delle olive non fa parte che della cultura della sua fascia mediterranea: dalla Costa 119 Azzurra che risente delle consuetudini alimentari liguri alla Linguadoca che guarda già oltre confine, verso la Catalogna. Il resto è mostarda. L’olio extravergine di oliva fa parte delle 103 denominazioni italiane protette dalla UE. Di queste, 72 con marchio DOP e 31 con IGP. 21 denominazioni italiane protette sono relative all’olio extravergine DOP , ma una sola ad olio extravergine IGP: e quest’unica IGP si riferisce a quello che, se prodotto nella nostra regione, ha il diritto di chiamarsi Toscano. A sua volta, sono in corso di approvazione, da parte delle autorità comunitarie, alcune piccole varianti; infatti, oltre a Toscano IGP gli olii extravergini prodotti nella nostra regione potranno vantarsi anche di alcune denominazioni locali. E, quindi, si sono avuti da poco tempo l’olio del Chianti Classico e quello delle Colline Senesi,mentre sono in lista d’attesa quello delle Colline Lucchesi, quello della Lunigiana ed, addirittura, l’olio di Bòlgheri, sulle ali del fenomeno Sassicaia. Sono tutte zone piutto sto limitate dal punto di vista dell’ampiezza del territorio, ma va detto che i microclimi della Regione sono parecchi e le cultivar degli olivi sono altrettante, come del resto lungo tutta la Penisola dalle Prealpi a più profondo Sud. Le denominazioni di fantasia, poi, sono state proibite dalla UE , mentre, al contrario, sono di rigore quelle protette, sia come denominazioni d’origine (le DOP) sia come indicazioni geografiche (le IGP). Le DOP degli olii italiani extravergini si riferiscono all’olio • Aprutino-Pescarese, a quello di • Brisighella, al • Canino, a quella del • Cilento, a quello delle • Colline di Brindisi, di quelle 120 • Salernitane e di quelle • Teatine, ed a quello • Dauno. Ci sono, poi, gli olii del • Garda e dei • Laghi Lombardi, dei • Monti Iblei e della • Penisola Sorrentina, quello della • Sabina, delle • Terre di Bari e di quelle di • Otranto, quello della • Umbria, quello delle • Valli Trapanesi, quello di • Lametia, ed, quello della • Riviera Ligure, quello - come riferito più innanzi - del • Chianti Classico ed, infine, quello delle • Colline Senesi. Quindi, se un olio è dichiarato, sì, extravergine, ma non vi sono nominate come protette né l’origine né l’indicazione geografica, vuol dire non solo che è prodotto da olive non raccolte in loco, ma che addirittura può essere risultato della raffinazione di olii grezzi provenienti da altre aree produttive del Mediterraneo comunitarie come Grecia e Spagna, od extracomunitarie come Turchia, Tunisia, Marocco e via elencando. Quindi, nessun olio che non sia interamente prodotto in Toscana in tutte le sue fasi potrà indebitamente accreditarsi come Toscano. E ciò anche a seguito di una decisione della Corte Europea Ad immagine e somiglianza di quelle associazioni civiche che favoriscono il turismo enogastronomico, sul tipo delle Città del Vino e di quelle del Tartufo, è nata e sta prosperando anche 121 l’Associazione delle Città dell’Olio che comprende circa 120 associati tra comuni che sono la maggioranza assoluta - camere di commercio ed altre istituzioni. La regione più rappresentata è, stranamente, la più piccola d’Italia, e cioè il Molise, mentre le meno rappresentate sono la Basilicata e, dati i climi non proprio mediterranei, il Friuli, la Lombardia (riva bresciana del Garda) ed il Veneto (riva veronese del medesimo lago). In Toscana sono Città dell’Olio (rigorosamente in ordine alfabetico): Arcidosso, Castagneto Carducci, Castiglione d’Orcia, Cetona, Cinigiano, Montalcino, Montepulciano, Montespèrtoli, Pienza, Radicòndoli, Rapolano Terme, Reggello, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Seggiano, Siena, Sinalunga, 122 Suvereto e Trequanda. Come si può notare, si tratta di località accentrate fra le province di Grosseto, Siena e Firenze, se si escludono Castagneto Carducci e Suvereto che fanno parte della provincia di Livorno. Le altre province, ad iniziare da quella di Lucca col suo olio bòno, quella di Pistoia con gli olii del Montalbano e quella di Pisa, con quelli del Monte Pisano e delle Colline Pisane, non hanno stranamente nessuna località citata nell’elenco di cui sopra. Sullo stile, poi, delle Strade del Vino (quella della Costa degli Etruschi è stata la prima in Toscana), stanno nascendo, forse un po’ laboriosamente, anche le Strade dell’Olio: la prima in assoluto più conosciuta del capoluogo. è nata nell’entroterra della provincia di Imperia, da dove proviene la cultivar detta taggiasca dal paese di Taggia che ha sulla costa un’appendice balneare, Arma, molto frequentata e, pertanto, più comnosciuta dal grande pubblico. Agli inizi del ‘900, quando sulle tavole dei ricchi borghesi cominciava ad apparire l’olio raffinato e leggero di Oneglia, nacque il primo - e, per quasi mezzo secolo, unico - esempio di patrocinio culturale (meglio del anglolatino sponsorizzazione: da sponsor, colui che celebra le nozze). La ditta Sasso, produttrice dell’Olio Sasso che esiste tuttora, fece nascere, come evoluzione letteraria di una pubblicazione legata alla promozione dei suoi prodotti, “La Riviera Ligure”, una rivista che divenne un veicolo assolutamente innovativo nella cultura del Novecento. Ne diede le direzione a Mario Novaro e, sia dal punto di vista grafico sia dal quello contenutistico, fu ambita lettura di chi di poesia e di prosa poetica a quell’epoca s’intendeva. Ospitò firme abbastanza note nel panorama del primo Novecento: da epigoni del Classicismo come Francesco Gerace, Giuseppe Lipparini, Giovanni Marradi (livornese) e Guido Mazzoni, fino a poeti che guardavano a Pascoli ed a D’Annunzio, come Luigi Orsini e Aurelio Ugolini. Senza aderire a particolari movimenti alla moda, Novaro fece pubblicare sulla propria rivista anche scritti di giovani disponibili a nuove esperienze, come Bino Binazzi, Filippo De Pisis, Lionello 123 Fiumi, Francesco Meriano, Giuseppe Ravegnani e Giovanni Titta Rosa. Altri collaboratori della rivista, invece, lasciarono un segno profondo nella cultura italiana del ‘900, ed erano: Dino Campana, Emilio Cecchi, Umberto Saba, Clemente Rebora, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Camillo Sbarbaro e Giuseppe Ungaretti. Esiste tuttora il Fondo Mario Novaro e della Riviera Ligure che, insieme a materiali stampati e fotografie relativi all’attività imprenditoriale dei Sasso, comprende quattromila lettere autografe e manoscritti dai collaboratori di quella antica rivista. Fra di essi, oltre i citati più sopra, Giovanni Pascoli, Guido Gozzano, Francesco Pastonchi, Corrado Govoni, Marino Moretti, Giovanni Boine, Massimo Bontempelli, Ardengo Soffici, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Giovanni Papini, Salvatore Di Giacomo, Luigi Capuana, Aldo Palazzeschi e Piero Jahier. Al Fondo Novaro si sono aggiunte nel tempo numerose donazioni fatte da letterati ed uomini di cultura; tutta gente che non voleva disperdere testimonianze essenziali di un passato prossimo o recente, onde consentire la prosecuzione e lo sviluppo di particolari esigenze settoriali. Ecco cosa significava allora una sponsorizzazione culturale: ma erano anche i tempi di quell’enciclopedia popolare che furono le figurine Liebig. Poi, vennero i concerti della Martini & Rossi. I nomi degli amici di Novaro se li ricordano solo i nostri nonni e qualche maestro elementare in pensione.
Scaricare