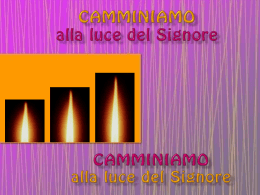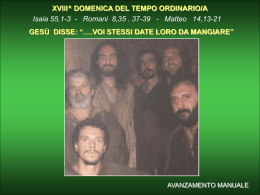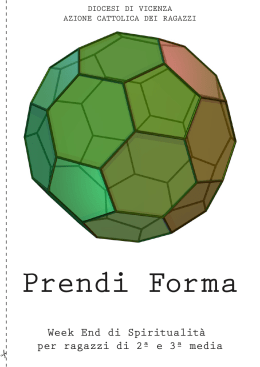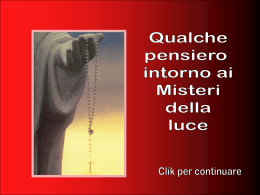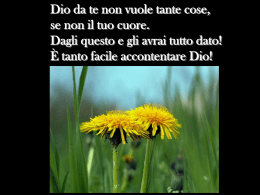523-527_art germania:Layout 2 30-09-2011 10:43 Pagina 523 Chiesa cattolica GERMANIA p otenza di Dio è la pazienza D al 22 al 25 settembre Benedetto XVI compie un viaggio apostolico in Germania a seguito dell’invito rivoltogli dal presidente federale Christian Wulff – oltre che a Berlino, il papa si reca a Erfurt, presso la piccola chiesa mariana di Etzelsbach e infine a Freiburg. Al di là del profilo politico ufficiale, il viaggio è caratterizzato anche da incontri di carattere interreligioso (con rappresentanti della Comunità ebraica in una sala del Bundestag e con quelli islamici presso la Nunziatura a Berlino) ed ecumenico (con il Consiglio della Chiesa evangelica tedesca a Erfurt e con i rappresentanti della Chiesa ortodossa nel seminario di Freiburg). Ma uno dei passaggi cruciali è anche il suo «attraversamento» del cattolicesimo tedesco: dalla Conferenza episcopale al presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, dall’incontro con i cattolici impegnati in ambiti ecclesiali e sociali fino a quello con l’ex cancelliere Helmut Kohl. A differenza del primo viaggio, quasi autobiografico, questo rappresenta una sorta di passaggio attraverso gli snodi maggiori dell’Europa post-bellica, colti nella loro sintesi rappresentativa, politica e culturale, della Germania odierna. Non c’è luogo della convivenza umana europea che non sia attraversato oggi da profonde tensioni, ma non sembra profilarsi all’orizzonte un’idealità, tanto politica quanto religiosa, che sappia portarle all’altezza dei compiti che si presentano oggi alle istituzioni che presiedono alla comune Appunti sulla Chiesa tedesca in occasione del viaggio di Benedetto XVI socialità umana e alla sua ispirazione spirituale di fondo. Più per valenza simbolica che per effettività delle cose, l’attesa è alta sui fronti sempre più frastagliati di una Chiesa cattolica che mantiene un’unità formale a prezzo del dissipamento di un fraterno riconoscimento reciproco delle diverse sensibilità che la abitano. Ben prima delle questioni di disciplina ecclesiastica, e a monte delle tematiche dottrinali, sembrerebbe essere proprio questo il nucleo che indebolisce dall’interno la qualità della rappresentanza ecclesiale e della testimonianza credente: l’aggressività comunicativa con cui si nega un diritto di cattolicità a chi pensa e vive la fede e la Chiesa in maniera diversa dalla propria. Una certa ingenuità rispetto agli ingranaggi mediatici ha sostanzialmente permesso di fare di qualsiasi questione dibattuta, all’interno o all’esterno della Chiesa, una sorta di referendum di fedeltà al papa. Salvo poi venire rapidamente risucchiate nel grande dimenticatoio dell’informazione contemporanea (basti pensare al fiume di inchiostro e di parole autorevoli spesi intorno ai cosiddetti «valori non negoziabili»). La stessa sorte sembrerebbe essere toccata al Memorandum del febbraio del 2011 sulla crisi della Chiesa cattolica (cf. Regno-att. 4,2011,82 e Regno-doc. 5,2011,181). Alla veemenza dei toni che, solo pochi mesi fa, ne ha accompagnato la pubblicazione corrisponde la sua apparente assenza dal dibattito pubblico ed ecclesiale – attratto, di volta in volta, da nuove «notizie» da of- frire all’ingordigia del mercato comunicativo. Da questa atmosfera complessiva che si è generata consegue una banalizzazione senza precedenti di termini cardine per l’ordinamento cattolico, come possono essere quelli di eresia e ortodossia. Essi sembrano essersi ridotti oggi a poco più che opinione, da ancorare in continuazione a un principio di autorità perché sostanzialmente incapaci di un’autorevolezza interna alla loro formulazione. La necessaria teologia Eppure tanto l’ortodossia quanto l’eresia sono esattamente il caso serio della fede; quello che non capita ogni giorno a uso e consumo della propria sensibilità ecclesiale, quanto piuttosto nel lento maturare di forme e strutture intorno alle quali, non certo senza confronto talvolta anche aspro, si costruisce la figura della Chiesa del Signore. Giovanni Moioli era solito ricordare che per ben comprendere un’asserzione dogmatica bisogna conoscere molto bene la posizione teologica rispetto alla quale essa si definisce vincolando autorevolmente la fede a venire della Chiesa. Se si legge con un po’ di spassionata obiettività la storia del cristianesimo, si potrebbe cogliere abbastanza facilmente quanto la qualità dell’ortodossia sia legata a un’eresia dal profilo teologico alto. La grande tradizione della Chiesa non ha mai avuto timore di una teologia seria e all’altezza del confronto culturale coi tempi in cui si attua la fede; essa ne è l’esercizio critico che può, e in certe situazioni deve, spingersi al limite IL REGNO - AT T UA L I T À 16/2011 523 523-527_art germania:Layout 2 30-09-2011 10:43 ed esplorare tutti gli spazi in cui la fides Ecclesiae può andare ad abitare per essere fedele al desiderio del Dio di Gesù: essere presente in presa diretta in ogni frangente della storia comune degli uomini. Abbassare il livello qualitativo del sapere teologico, pensando di potersi garantire così un’aderenza immediata all’ortodossia, significa spingere verso il basso lo stesso contenuto normativo del credere cristiano. E immaginarsi una Chiesa senza il pungiglione critico del sapere teologico vuol dire finire col cedere la rappresentanza culturale della fede a istanze e persone che non hanno interesse alcuno per le forme di attuazione della coscienza credente. Se guardiamo all’uso odierno che si fa di queste parole, sembrerebbe che esse da concetti teologici siano divenuti semplici (e banali) termini politici: duttili, a geometria variabile a seconda dell’occasione, senza più vincolo con la res del cristianesimo. Il dogma si indebolisce molto di più in questo modo che attraverso posizioni teologiche che lo mettono, o sembrerebbero metterlo, in questione. Ma di questo pare esserci poca avvedutezza nella Chiesa cattolica – senza distinzione tra le diverse posizioni ideologiche in cui essa è scomposta –. Su questo siamo tutti accomunati. In un’epoca in cui il rumore di fondo rischia di coprire ogni voce, passare sotto silenzio può essere cosa buona. Si potrebbe tentare di leggere anche sotto quest’ottica il destino cui il Memorandum è andato incontro ben prima di uscire dalla culla. L’arena della teologia è quella della fatica del concetto e non quella dell’inflazione delle prese di posizione e dei comunicati. Lontani dal fragore mediatico si può iniziare a dare struttura a ciò cui un Memorandum può fare al massimo cenno;1 ma soprattutto si creano spazi e atmosfere per poter argomentare (teologicamente) le ragioni della propria adesione come quelle del dissenso.2 Questo recupero di un luogo argomentativo del confronto teologico è un bene per tutta la comunità ecclesiale – anche per il magistero. Quando la teologia fa il suo mestiere, e le si lasciano i tempi e i luoghi atti a svolgerlo, essa sa generare il circolo virtuoso di un controllo critico interno attraverso il gioco di interazioni fra le diverse posizioni che sono disponibili a sottoporsi al- 524 IL REGNO - AT T UA L I T À 16/2011 Pagina 524 l’esercizio paziente del rendere conto delle proprie ragioni, senza ricorrere immediatamente all’appello a un’istanza regolativa superiore a essa. Sostenere questa possibile virtuosità del dibattito teologico è interesse stesso del magistero, perché gli consente di evitare un eccesso di esposizione e ne preserva l’autorevolezza della parola. Il fenomeno di un magistero che «produce» da sé la sua teologia è sostanzialmente recente; ed è potenzialmente superato dall’intenzione stessa dell’attuale pontefice: distinguere la portata della sua parola in quanto teologo da quella che lo vede impegnato nell’esercizio del ministero petrino a favore dell’unità della Chiesa. Valore e autonomia dell’argomento teologico È il papa in prima persona a distinguere dunque tra l’autorevolezza della posizione teologica in forza della sua portata argomentativa e della disponibilità con cui si sottopone al controllo del dibattito della comunità teologica, dal principio di autorità che presiede alla vita della Chiesa; nella convinzione che la prima sia funzione necessaria all’attuazione ecclesiale non meno del secondo. In questo risiede la sua persuasione che la teologia nel suo complesso sia luogo necessario alla maturazione del giudizio della Chiesa, cui essa contribuisce secondo i propri modi e tempi specifici. Un giudizio maturo e adeguato chiede, da parte del magistero, l’esercizio di quella pazienza che sola può affinare il discernimento autorevole della Chiesa: accettare i tempi lunghi del confronto teologico, sostare nelle ragioni che in esso si adducono, permettergli di attuarsi secondo l’autorevolezza dell’argomentazione senza schiacciarlo immediatamente sul principio di autorità, consente alla fede di penetrare e attestare le presenze del Dio di Gesù così come esse si danno nella contemporaneità di ogni tornante della storia. Al magistero compete certamente una parola, ma esso non esaurisce in sé tutte le parole di cui la fede è capace e a cui la fede è doverosamente chiamata. I fondamentali del cristianesimo non sono principi astratti, ma forme pratiche dell’esistenza cristiana e figure concrete dell’istituzione della fede, se vogliamo dare retta per una volta a Tommaso, per il quale l’articulus fidei (quello che noi oggi chiamiamo dogma) era un’istruzione alla vita beata: il come deve vivere il cristiano e come dovrebbe essere la Chiesa per poter testimoniare adeguatamente il Dio di Gesù ed essere pronti, nel qui della storia, all’incontro ultimo con lui. La destinazione dell’esistenza credente si decide nella qualità testimoniale del suo abitare la terra. Per questo il come si attua la Chiesa nella sua fides non è affatto irrilevante per la sua fedeltà alla missione che il Signore le ha affidato. La separazione voluta da Benedetto XVI tra autorevolezza argomentativa del sapere teologico e principio di autorità ecclesiale crea da sé lo spazio per una partecipazione critica della teologia all’edificazione della Chiesa; e chiede una teologia ancorata all’accademia dei saperi e l’altezza di un ragionamento della fede in grado di confrontarsi, con liberalità e acutezza evangelica, con la cultura contemporanea. Auspicandone così un esercizio che sia anche critica di civiltà interna alle forme attuali del dibattito pubblico – quello serio, per quanto ristretti ne siano gli spazi oggi, e non certo quello dei pamphlet informativi o dei talk-show televisivi –. Su queste misure si provano la bontà e la qualità delle posizioni «pro» o «contro» il Memorandum di febbraio. L’arcidiocesi di Freiburg, nella persona del vescovo ausiliare Paul Wehrle, ha accolto questa intenzionalità del papa rispetto alla teologia come momento integrante della sua visita: offrire un’interlocuzione teologica di alto profilo sui fondamentali del cristianesimo come uno dei momenti del suo passaggio in diocesi. Lo ha fatto affidando il compito a un teologo che di Ratzinger è stato uno dei primi dottorandi, Hansjürgen Verweyen (professore emerito di Teologia fondamentale dell’Università di Freiburg). Il testo che ne è venuto fuori è disponibile alla lettura dagli inizi di luglio con il titolo Domande dalla Chiesa alla Chiesa.3 A partire dagli anni Sessanta quello tra Ratzinger e Verweyen è un rapporto di conoscenza reciproca, confronto leale, schiettezza di parola, rispettoso proprio perché aperto anche alla critica e alla valorizzazione. Dopo il suo ritiro dall’attività accademica, Verweyen ha 523-527_art germania:Layout 2 30-09-2011 GERMANIA - CHIESA 10:43 Pagina 525 C AT TO L I C A Le cifre e i fatti I l contesto ecclesiale della terza visita di Benedetto XVI nella sua patria è agitato e in movimento, come dimostrano sia le cifre (secondo i dati aggiornati pubblicati dalla Conferenza episcopale tedesca alla fine di agosto, cf. Zahlen und Fakten 2010/2011. Arbeitshilfe 249, in www.dbk.de), sia le cronache degli ultimi mesi. Dati e cifre. Su 81 milioni di abitanti, 24,7 milioni sono cattolici: il 30,18% della popolazione (24,1 milioni gli evangelici, 1,2 milioni gli ortodossi, 4 milioni i musulmani, 100.000 gli ebrei). La Chiesa cattolica conta su 27 diocesi e 11.483 parrocchie, 70 vescovi, 17.274 sacerdoti (15.136 in servizio pastorale, contro i 19.707 del 1990), 3.032 diaconi permanenti, 28.651 religiosi, 1.657 membri laici di istituti secolari e 10.060 catechisti. I seminaristi minori sono 2.303 e i maggiori 1.151. La figura tipica del ministero laicale tedesco, l’assistente o referente pastorale e l’assistente o referente di comunità cristiana, è raddoppiata dal 1990: oggi sono rispettivamente 3.071 (di cui 1.264 donne) e 4.481 (di cui 3.450 donne). Nel 2010 ci sono stati 170.339 battesimi, il 90% dei quali negli stati dell’ex Germania federale. Un totale di 1.013.981 alunni frequenta i 9.439 centri di istruzione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi, dalle scuole materne all’università. I centri caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi contano: 444 ospedali; 1.368 ambulatori; 2.804 case per anziani, invalidi e minorati; 1.172 orfanotrofi e asili nido; 2.176 consultori familiari e altri centri per la protezione della vita; 2.204 centri speciali di educazione o rieducazione sociale e 468 istituzioni di altro tipo. Uno tra i numeri più impressionanti è quello delle uscite dalla Chiesa (tramite l’uscita dalla tassa ecclesiastica): nel 2010 181.193 cattolici, il 50% in più rispetto al 2009, principalmente a seguito della crisi legata alla pedofilia, ma anche a causa di un lento e progressivo distacco dei fedeli dalla Chiesa per sensibilità culturale e per stile di vita. acceso dibattito sulla necessità e l’urgenza di riforme nella Chiesa. Si tratta di una lettera di otto esponenti di spicco dell’Unione cristiano-democratica (CDU) a favore dell’ordinazione di «viri probati», diffusa il 21 gennaio, e di un Memorandum intitolato Chiesa 2011: mettersi in cammino è necessario, sottoscritto tra febbraio e marzo da molti docenti di teologia nei paesi di lingua tedesca (cf. Regno-att. 4,2011,82; Regno-doc. 5,2011,181). «Iniziativa di dialogo». La risposta dell’episcopato tedesco consiste nella messa in campo di un ampio e strutturato processo di dialogo (cf. Regno-att. 10,2011,301), che si svolgerà da subito fino al 2015 e che coinvolgerà tutte le componenti del corpo ecclesiale (non è un Sinodo, cioè un’assemblea chiamata a prendere decisioni, ma un forum di dialogo che mira al confronto e alla riflessione, ha detto il presidente della Conferenza episcopale ad Avvenire il 21 settembre). Sul primo appuntamento, che si è tenuto l’8 e 9 luglio a Mannheim, i vescovi Marx (Monaco), Overbeck (Essen) e Bode (Osnabrück) insieme al loro presidente hanno informato il papa a metà agosto. A Mannheim dei 27 vescovi ne era presente la metà. Davanti ai punti scottanti della piattaforma riformista è stato posto il limite della «non negoziabilità». Il presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, Alois Glück, ha messo in guardia dalla «cultura dell’inconcludenza». «Ci potranno essere dei passi avanti». In un’intervista al settimanale Die Zeit il 5 settembre il presidente della Conferenza episcopale tedesca mons. Robert Zollitsch si è detto convinto che «sul tema dei divorziati risposati ci potranno essere dei passi avanti». Il card. Meisner di Colonia e il nunzio apostolico in Germania, l’arcivescovo Jean-Claude Périsset, hanno preso le distanze da quanto l’arcivescovo di Freiburg avrebbe affermato come opinione personale e non in quanto presidente dei vescovi. Appelli e Memorandum per la riforma della Chiesa. Tra gennaio e febbraio due forti prese di posizione innescano un lungo e contribuito non poco a introdurre il cattolicesimo tedesco al pensiero di Ratzinger;4 facendolo teologicamente e non per compiacenza verso il ministero petrino esercitato ora dal suo antico maestro. In tal modo Verweyen ha onorato debitamente quella distinzione e separazione che Benedetto XVI desidera rispetto alle proprie parole. Anche questa sua ultima pubblicazione rientra in questo stile. Proprio perché i fondamentali del cristianesimo si decidono nell’attuazione pratica della fides Ecclesiae, Verweyen auspica che «Benedetto XVI, nonostante tutte le ambivalenze che si trovano in esso, non solo prenda nota del Memorandum, ma che lo prenda anche molto, molto sul serio» (p. 8). Perché uno dei compiti della teologia è quello di essere pronta a «rendere ragione della lieta notizia di Gesù davanti alla ragione mondana, che oggi percepisce ancora solo poca gioia in quell’annuncio» (p. 9). Due i cespiti fondamentali di questo agile libretto di Verweyen: da un lato il ruolo e la funzione della Scrittura rispetto all’attuazione della Chiesa e al lavoro teologico; dall’altro il senso dell’eucaristia e dell’immagine della presenza di Dio cui si accede nella sua celebrazione. Anche quando va a toccare questioni di disciplina ecclesiale, legate ai punti avanzati dal Memorandum, Verweyen ne cerca il raccordo con questi due luoghi originari del cristianesimo, D. S. e profila soluzioni possibili che non vadano a intaccare la costituzione teologica della Chiesa cattolica. Il concreto esistente, quello che la Chiesa già è, offre spazi per un dibattito, sereno e non polarizzato, e per soluzioni effettive dei problemi esistenti. Nessuna richiesta di adeguazione allo spirito del tempo, ma un’intelligenza del fatto che essendo quello che è la Chiesa può far fronte a questioni aperte che le si pongono nell’oggi della sua missione a favore degli uomini e delle donne del nostro tempo. Accessi alla Scrit tura Il cristianesimo non può fare a meno della storia, data la «materialità» IL REGNO - AT T UA L I T À 16/2011 525 523-527_art germania:Layout 2 30-09-2011 10:43 corporea dell’accadere di Dio nella carne del suo logos filiale; ma in quanto evento di una donazione ultimamente valida del senso, proprio quella «materialità» oppone una resistenza all’accesso della verità della sua donazione mediante il solo accumulo di informazioni, il più possibile accurate, sull’effettività del suo accadere. Non si accede dunque alla res delle Scritture cristiane senza un’adeguata conoscenza storica, ma non si entra nel loro senso teologico senza l’accertamento dell’impatto esistenziale che essa ha prodotto sulla testimonianza scritturistica del suo accadere: «Una testimonianza ecclesiale credibile non può sfuggire alla questione di come essa porti al linguaggio veramente Gesù di Nazaret, senza presentarlo in un rivestimento mitico (...). Il problema fondamentale, che non è stato scorto, è che gli esiti della critica storica, che sono in grado di avocare per sé al massimo la migliore probabilità possibile, svuotano l’incondizionatezza della confessione resa a Gesù, a meno che non venga inclusa la persuasione che regge tale confessione della fede» (p. 27). La percezione dell’evento (teologico) del senso che ha generato tale persuasione, che ne è parte integrante in quanto ne realizza la verità, si sottrae alla lente della «scienza storico-critica» in quanto presuppone una «musicalità» (p. 33) che si genera dall’accordare fiducia incondizionata al carattere promettente di quell’accadere: «Per cogliere la dinamica che prende le mosse da Gesù devono essere trovate, e diagnosticate nella maniera più precisa possibile, proprio quelle mura colpite e segnate dalla pietra gettata che è Gesù. Come “oggetto” di questa indagine all’indietro troviamo degli uomini che, mediante il loro incontro con Gesù, hanno messo radicalmente in questione la vita vissuta fino ad allora e i modi di vedere le cose a essa legata, divenendo così disponibili a una conseguente conversione» (p. 34). La qualità testimoniale della fides Ecclesiae è la disponibilità di far accadere nella propria carne la medesima forma dell’evento «materiale» di Dio che è il vissuto di Gesù di Nazaret. Tale disponibilità si realizza, nell’ordine scritto della parola, in forma «canonica» nella fase redazionale dei quattro 526 IL REGNO - AT T UA L I T À 16/2011 Pagina 526 Vangeli. L’analisi storico-critica è necessaria, in quanto ci permette una conoscenza del materiale sul quale ha lavorato la fede testimoniale degli evangelisti stessi, il loro «essere colpiti» dall’evento cristiano di Dio; su questa base, e solo su di essa, è possibile percepire e cogliere il lavorio che quel colpo ha prodotto su di loro stratificandosi testimonialmente nella redazione finale del testo: «L’importanza maggiore risiede piuttosto nelle “modifiche redazionali” che gli evangelisti hanno apportato alle fonti che erano giunte loro, ritenendo che così facendo avrebbero trasmesso esattamente ciò che avevano ricevuto. È proprio a partire da queste modifiche redazionali che si può accedere alla specifica teologia che è propria a ogni evangelista, ossia riconoscere quei luoghi in cui il messaggio partito da Gesù è penetrato in essi indirizzando il loro parlare e agire lungo nuove vie» (p. 35). L’originaria forma testimoniale della fede si diffrange canonicamente nel prisma quadriforme dell’attestazione scritturistica dell’identità teologica del vissuto di Gesù con la presenza reale di Dio nella storia umana. Gli «scarti» redazionali fra questa pluriforme testimonianza di Dio non possono essere fatti giocare l’uno contro l’altro, pena mancare la realtà di un evento che accende il plurale canonico della sua attestazione; ma non è possibile neanche selezionare esclusivamente una di queste diffrazioni testimoniali a scapito delle altre, perché così facendo la si sottrarrebbe alla funzione regolativa della pluriforme attestazione evangelica dell’evento cristiano di Dio che, solo in quanto tale, vale come regula di ogni fede a venire. Le ragioni redazionali interne, che sono alla base degli «scarti» caratterizzanti la policromia evangelica dell’attestazione del canone scritturistico cristiano, fanno parte della regola normativa stessa della fede. Esse nascono dalle esigenze di un’interlocuzione culturale con le diverse condizioni in cui il cristianesimo veniva chiamato a rendere testimonianza dell’evento di Dio che è il vissuto di Gesù. Tale gesto è costitutivo del carattere canonico delle Scritture, aprendo così spazi inaspettati per la rappresentazione istituzionale e le rappresentazioni testimoniali della fede davanti all’«inedito» incessante che nasce dal loro radicamento corporeo nella realtà della vita e della storia così come esse si danno. Spazi a cui la Chiesa può attingere per far fronte alle questioni che le si pongono nel suo essere segno evidente della contemporaneità di Dio a ogni passaggio ed epoca dell’esistenza umana, nella persuasione incondizionata che proprio così facendo essa rimane fedele al suo Signore. Memoria eucaristica di Gesù come dedizione di sé e at tesa degli altri La forma cristologica della dedizione incondizionata di sé quale rappresentanza definitiva della verità cristiana di Dio si condensa realisticamente nella memoria eucaristica del Signore: «Se non si vuole che il messaggio della Chiesa si esaurisca in aride parole, allora la reale e permanente presenza della vittoria di Gesù sulla morte deve essere riconoscibile per tutti anche nella forma di segni (...). Nella misura in cui in tali segni è realmente presente il nucleo incandescente della vita, morte e risurrezione di Gesù, allora la Chiesa non può fare altro che considerare questo essere presente memoriale come parte integrante dell’annuncio che le è affidato» (p. 38). Nel segno memoriale dell’eucaristia è presente anche quella tensione caratteristica dell’attestazione evangelica fra Dio, il Padre, e il Figlio, che giunge all’apice nella preghiera del Getsèmani e si concretizza drammaticamente nell’urlo crocifisso di Gesù, in cui egli fa esperienza del radicale abbandono di Dio proprio nel cuore dell’incondizionata fiducia che gli concede rivolgendogli questa sua ultima parola. È questo il punto attraverso il quale è possibile una ripresa del difficile concetto di espiazione. Verweyen distingue accuratamente due aspetti opposti e inconciliabili iscritti in esso: davanti alla consapevolezza delle ferite che ho provocato all’altro sorge il giusto sentimento di dover riparare a quanto fatto, poiché è in questo sentimento che vedo per la prima volta le ferite inferte agli altri, così che esso disàncora il mio essere centrato su me stesso; d’altro lato, abbiamo l’idea religiosa della nostra ingiustizia davanti a Dio accompagnata dalla paura per le conseguenze che dovremo scontare per essa 523-527_art germania:Layout 2 30-09-2011 e, quindi, il sorgere di un sentimento di espiazione che ci preservi da esse. Ma, in tal modo, sono di nuovo l’egoismo del proprio io e la preoccupazione per sé a muovere la dinamica di espiazione, cui corrisponde un’immagine di Dio ben lontana da quella realizzatasi nella dedizione incondizionata di sé che è Gesù: «Prima di ogni nostra decisione per la conversione, e al di là di ogni inutile tentativo di aggraziarci Dio, Gesù Cristo si è già messo al nostro posto, ed è soltanto così che possiamo riottenere accesso a Dio» (p. 45). Accanto a questa commercializzazione di scambio è importante evitare tanto una comprensione magica della partecipazione eucaristica alla dedizione di sé di Gesù Cristo, quanto una sacralizzazione mitica dell’eucaristia stessa. Verweyen sviluppa questi aspetti sul filo della tradizione paolina della cena del Signore. Che i molti siano un corpo in Cristo (cf. Rm 12,5) implica, da un lato, che le differenze sociali presenti nella comunità cristiana non vengano duplicate nello spazio dell’assemblea eucaristica che, nell’essere partecipazione al corpo di Cristo, deve essere partecipazione e condivisione effettiva dei vissuti di ciascuno; e, d’altro lato, implica che partecipare al Signore significa aver parte al realismo del suo vivere e morire: quando Paolo parla della Chiesa come corpo di Cristo (senza articolo) si tratta «di un’affermazione di ciò che essa deve essere, più che di ciò che essa è: nella sua vita la comunità deve trarre le conseguenze dall’unità con il corpo offerto, e che si offre sempre di nuovo, della dedizione di sé di Gesù Cristo – unità fondata nel battesimo e resa presente nell’eucaristia» (p. 63). A Corinto il vincolo fra l’atto cultuale eucaristico e il vissuto quotidiano dei cristiani era espresso dal legame che univa un pasto in comune tra i membri della comunità e la celebrazione cristiana: la presenza reale del Signore, per Paolo, si situa proprio nella qualità esistenziale di tale legame. È questo il luogo in cui si realizza l’essere-corpoper che è la dedizione incondizionata di Gesù, dove «la “sostanza-corpo” consiste solo nella relazione del “per”» (p. 66): l’essere-per della dedizione di sé fissa l’essenza stessa del corpo di Cristo cui si ha parte nella celebrazione eucaristica: essa è lieto «annuncio di questo 10:43 Pagina 527 vivificante essere per altri, anche e proprio al di là dello spazio interno della Chiesa, nell’attesa del ritorno del Signore, che non significa volgere impazientemente lo sguardo verso una gloria futura, ma che nell’imparare ad attendere gli altri è in grado di ottenere la necessaria perseveranza» (p. 68) per l’attesa del Signore di tutti. L’eucaristia non consiste nella fissazione su oggetti/elementi sacri, quanto piuttosto trova il suo «elemento integrante, se non addirittura essenziale» in questa attesa degli altri, dei poveri, di chi è nel bisogno e nella sofferenza: è solo così che si celebra la cena di colui «che è qui solo nella forma dell’esistenza per altri (...). In memoria della morte di Gesù dovremmo fare quello che egli ci dice con estrema chiarezza attraverso i suoi messaggeri: spezzare il pane in modo tale che anche altri possano trovare il coraggio di passare al vaglio le loro cattive abitudini. Insieme a loro potremmo utilizzare tutta la nostra immaginazione per trovare il modo in cui sia possibile trasporre questo nuovo inizio nel piccolo all’interno della realtà politica ed economica del nostro tempo – con un esercizio impegnato, e proprio per questo gratuito, delle nostre forze» (p. 71.75). La pazienza del contadino «Potenza di Dio è la pazienza», il suo voler essere attesa di un libero riconoscimento da parte di ogni uomo e ogni donna, tempo dato al lavorio spirituale e culturale di una conversione dalla concentrazione preoccupata solo di sé alla dedizione di sé in favore di chiunque. Pazienza che costituisce l’armonica dell’Alleanza, la cui passione per l’umano genera effetti inaspettati e sorprendenti di attaccamento di Dio proprio là dove ci sarebbero tutte le ragioni per un congedo definitivo (cf. Osea). La pluralità evangelica dell’attestazione dell’essere-corpo-per del vissuto di Gesù rappresenta la sedimentazione regolativa di questa pazienza divina, che la Chiesa, nel segno realistico della sua presenza, celebra come legame fra effettività della vita quotidiana e atto liturgico della memoria del Signore. Pazienza alla quale Gesù non cessa mai di istruire i suoi discepoli, nell’esercizio teologale di un’attesa sapienziale necessaria al discernimento delle multi- formi presenze di Dio. Dalla sua Chiesa Dio si aspetta quantomeno la pazienza del contadino, quella che sa dei tempi del seme e dei ritmi della terra, quella capace di attendere prima di mettere mano al campo in cui crescono insieme l’erba buona e la gramigna, quella che non teme che i segni sicuri della rivelazione nei gesti della liberazione dal male accadano anche al di fuori di quelli che sono con noi. La pazienza è la virtù seria dell’esercizio teologico, senza la quale la fatica del concetto diventa semplice slogan o banale asservimento a uso e consumo del mercato mediatico; è quel tempo lungo in cui, mediante il confronto critico e la dialettica delle diverse posizioni, essa genera un sano e fecondo controllo reciproco. L’unità della Scrittura non ha alcun timore della pluralità che ne costituisce l’attestazione normativa; anzi, vive proprio di essa come il Dio che testimonia a canone di ogni fede a venire. Quello di cui oggi abbiamo bisogno è esattamente una teologia di alto profilo che, nel suo essere dalla Scrittura,5 sia al tempo stesso generata dalla «materialità» corporea dell’evento cristiano di Dio e destinata alla pratica quotidiana del credere nella contemporaneità. Abbassare ulteriormente il livello del sapere teologico, quale che sia la ragione per cui si mira a questo, non fa bene alla Chiesa: la lascia più debole nell’esercizio della sua missione e più esposta alla strumentalizzazione dei fuochi fatui di un’«apologia» del cattolicesimo che non ha interesse alcuno per la cura della fede e la dedizione di sé a favore dell’umano chiunque. Marcello Neri 1 Cf. M. HEIMBACH-STEINS, G. KRUIP, S. WENDEL (a cura di), Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch. Argumente zum Memorandum, Herder, Freiburg 2011. 2 J. KÖNEMANN, T. SCHÜLLER (a cura di), Das Memorandum. Die Positionen im Für und Wider, Herder, Freiburg 2011. 3 H. VERWEYEN, Fragen aus der Kirche an die Kirche, Freiburger Texte 59 (Schriftenreihe des Erzbistums Freiburg), Freiburg 2011. 4 Cf. H. VERWEYEN, Ein unbekannter Ratzinger. Die Habilitationsschrift von 1955 als Schlüssel zu seiner Theologie, Pustet, Regensburg 2010; ID., Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. Die Entwicklung seines Denkens, WBG, Darmstadt 2007, cf. Regno-att. 12,2007,421. 5 Cf. ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Teologia dalla Scrittura. Attestazione e interpretazioni, Glossa, Milano 2011. IL REGNO - AT T UA L I T À 16/2011 527
Scarica