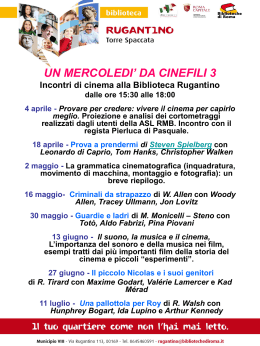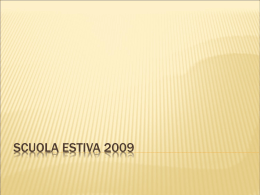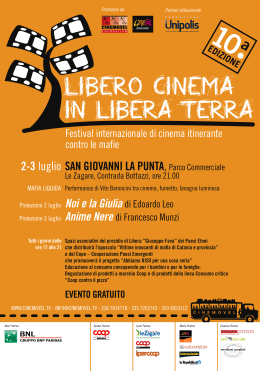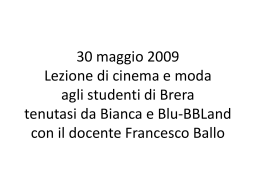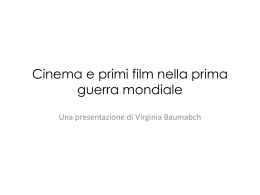Anteprima Estratta dall' Appunto di Storia e critica del cinema Università : Università degli studi di Milano Facoltà : LettereFilosofia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. Possibilità di guadagno vendendo appunti, tesine, lezioni private, tesi, svolgendo lavori stagionali o part time. www.ABCtribe.com ABCtribe.com - [Pagina 1] L' Appunto A partire dalla pagina successiva potete trovare l' Anteprima Estratta dall' Appunto. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. Il numero di pagina tra le parentesi tonde si riferisce a tutto il documento contenente l'appunto. Sull'appunto stesso in alcuni casi potrete trovare una altra numerazione delle pagine che si riferisce al solo appunto. Grafico dei voti medi per questo esame: Grafico dei giorni medi per la preparazione di questo esame: Grafico Copyright © ABCtribe.com. Vietata la riproduzione. Grafico Copyright © ABCtribe.com. Vietata la riproduzione. Clicca qui per i grafici aggionati su Storia e critica del cinema >> ABCtribe.com - [Pagina 2] Storia E Critica Del Cinema Storia E Critica Del Cinema AB Ct om VERTIGO .................................................................. 27 L’Uomo.................................................................. 27 L’arte...................................................................... 27 TRA NEOREALISMO E NOUVELLE VAGUE...... 28 À Bout De Souffle.................................................. 30 La Ricotta............................................................... 31 La Ricotta: Fasi Cronologiche ............................... 31 La Ricotta: Fasi Censorie ....................................... 33 La Ricotta: Approccio Interpretativo ..................... 35 III MODULO ............................................................. 39 ROBERTO ROSSELLINI ......................................... 39 Roma Città Aperta ................................................. 39 La Doppia Vita di “Francesco Giullare di Dio” ..... 41 Paisà ....................................................................... 41 Il Piano Morlion ..................................................... 43 Il Miracolo ............................................................. 46 Stromboli Terra di Dio........................................... 47 Francesco Giullare di Dio ...................................... 50 e.c rib I MODULO ................................................................. 2 CINEMA DELLE ORIGINI........................................ 2 Programmi ............................................................... 2 Periodi...................................................................... 3 Convegno di Brighton.............................................. 9 Scala dei Piani e Montaggio – The Great Train Robbery ................................................................. 11 CINEMA DELL’ISTITUZIONE .............................. 13 Griffith................................................................... 13 Le Avanguardie ..................................................... 15 Scuola del Montaggio Sovietico ............................ 18 Cinema Classico Americano.................................. 19 CITIZEN KANE........................................................ 21 STELLA DAGNA..................................................... 24 La Pellicola Cinematografica................................. 24 Formato.................................................................. 25 Aspect Ratio .......................................................... 26 Sonoro.................................................................... 26 Colore .................................................................... 26 II MODULO .............................................................. 27 1 ABCtribe.com - [Pagina 3] Storia E Critica Del Cinema I MODULO CINEMA DELLE ORIGINI Programmi e.c om Unità didattiche A e B: 1. Paolo Bertetto (a cura di), Introduzione alla storia del cinema. Autori, film, correnti, Utet, Torino 2008 (o edizione precedente del 2002) con l’esclusione dei capitoli 7, 8, 12, 14. 2. Due libri a scelta tra i seguenti: • André Gaudreault, Cinema delle origini o della «cinematografia-attrazione», Il Castoro, Milano 2004; • Mauro Giori, Tomaso Subini, Mother is here. La donna in “Vertigo” di Alfred Hitchcock, Cortina, Milano 2011 (disponibile presso la Libreria Cortina di Largo Richini, 1). • Michel Marie, La Nouvelle Vague, Lindau, Torino 2006; • Tomaso Subini, Pier Paolo Pasolini. “La ricotta”, Lindau, Torino 2009. Unità didattica C: 1. Tomaso Subini, La doppia vita di “Francesco giullare di Dio”. Giulio Andreotti, Félix Morlion e Roberto Rossellini, Libraccio, Milano 2011 (disponibile presso la libreria Libraccio di via Santa Tecla, 5) con il capitolo 2 facoltativo. AB Ct rib Unità didattiche A e B: 1. Antologia delle origini (da vedere nella sua interezza)* 2. Antologia del periodo Biograph di David W. Griffith (da vedere nella sua interezza)** 3. Das Kabinett des Dr. Caligari (Il gabinetto del dottor Caligari, 1920), Robert Wiene 4. Bronenosec Potëmkin (La corazzata Potëmkin, 1925), Sergej M. Ejzenštejn 5. Citizen Kane (Quarto potere, 1941), Orson Welles (nella versione originale sottotitolata in italiano) 6. Vertigo (La donna che visse due volte, 1958), Alfred Hitchcock (nella versione originale sottotitolata in italiano) 7. A bout de souffle (Fino all’ultimo respiro, 1960), Jean-Luc Godard (nella versione originale sottotitolata in italiano) 8. La ricotta (1963), Pier Paolo Pasolini (episodio di Ro.Go.Pa.G.) Unità didattica C: 1. Roma città aperta (1945), Roberto Rossellini 2. Paisà (1946), Roberto Rossellini 3. Il miracolo (1948), Roberto Rossellini (2° episodio di Amore) 4. Stromboli (Terra di Dio) (1950), Roberto Rossellini 5. Francesco giullare di Dio (1950), Roberto Rossellini * Sortie des usines; Repas de Bébé; Arrivée des congressistes; Le jardinier et le petit espiègle; Arrivée d'un train en gare; Pompiers à Lyon (Lumière) The Miller and the Sweep, George Albert Smith (1898) Ladies Skirts Nailed to a Fence, Bamforth (c1900) Let Me Dream Again, George Albert Smith (1900) Grandma’s Reading Glass, George Albert Smith (1900) The Big Swallow, James Williamson (1901) Le voyage dans la lune, Georges Méliès (1902) Mary Jane’s Mishap, George Albert Smith (1903) The Life of an American Fireman, Edison - Edwin Porter (1903) The Great Train Robbery, Edison - Edwin Porter (1903) ** The Adventures of Dollie (1908) The Lonely Villa (1909) 2 ABCtribe.com - [Pagina 4] Storia E Critica Del Cinema The Drunkard’s Reformation (1909) A Corner in Wheat (1909) The Painted Lady (1912) Death’s Marathon (1913) Periodi Tre grandi periodi Cinema delle origini: 1985-1918 Cinema classico: da metà anni ’10 agli anni ‘50 Cinema moderno: dagli anni ’50 in poi Ogni periodizzazione presenta dei problemi, dipende molto più da chi governa il discorso che dall’oggetto periodizzato, dipende più dallo storico che dalla storia, è un’operazione soggettiva necessaria, è lo schema che discerne il passato. Quello che articola la storia del cinema in tre macroperiodi, è uno schema generale che presenta piccole articolazioni interne. Il lungo periodo del cinema classico presenta una forte cesura interna: il sonoro. È una cesura forte, eppure non così forte da implicare una revisione dello schema generale. rib e.c om Ogni marcoperiodo ha al suo interne ulteriori periodizzazioni che spesso fanno discutere e litigare gli storici, ad esempio si è rivelato problematico circoscrivere il fenomeno più famoso della storia del cinema italiano: il Neorealismo. C’è chi lo considera un fenomeno esteso nel tempo, riconoscendolo in opere degli anni ’40, individuando una fase centrale negli anni ’50 e trovando alcuni episodi isolati negli anni ’60. Per questi signori il neorealismo interessa pochi film degli anni ’40 e ’60 e un gruppo più grosso negli anni ’50 (un fenomeno stretto e lungo). Alcuni storici contrappongono un fenomeno corto e largo (corto nel tempo e largo nel numero dei film), si può parlare di neorealismo solo per i film girati in Italia fra ’45 e ’49. I primi fanno una selezione, solo alcune opere fra ’40 e ’60, altri dicono che sono neorealisti tutti i film tra ’45 e ’49. A seconda che si adotti una o l’altra, ne esce una storia diversa. Importante è il criterio di periodizzazione, quando si va nello specifico non sempre non ci si mette d’accordo. AB Ct Anche l’ultimo periodo presenta cesure difficili da individuare: alla fine degli anni ’60 si presenta la svolta del postmoderno: si è in una dimensione successiva alla modernità, il termine non ci dice in cosa siamo entrati ma cosa è finito, ovvero che la modernità è terminata. È un passaggio cruciale per intendere alcuni film a lezione, in quanto anticipatori di sensibilità postmoderne. La storia delle arti del ‘900 segue una linea di progresso, esattamente come la storia della modernità. Dire che la modernità è finita significa dire che non siamo più in grado di pensare la storia dell’arte (la storia del cinema nello specifico) secondo una linea progressiva. L’impressionismo segue il realismo, il postimpressionismo segue l’impressionismo, ogni movimento rappresenta una novità rispetto al precedente contribuendo al progresso delle arti: la postmodernità coincide con la presa di coscienza che il progresso continuo non è più alimentabile. Un artista postmoderno ha la coscienza che non inventerà un nuovo stile che metterà in cantina il precedente, la storia è finita. C’è chi anticipa la data all’esplosione della bomba di Hiroshima, secondo alcuni storici sarebbe terminata lì la modernità, altri storici per l’Italia vedono la fine col boom economico a fine anni ’60, in America negli anni ’50 quella rivoluzione industriale è già avvenuta, il postmoderno è iniziato quindi in precedenza. Se tutti sono d’accordo che la modernità è finita, non c’è pur tuttavia affatto accordo sulla data che identifica il momento di passaggio. Per quanto riguarda il cinema in molti si sono accodati alla tesi Laurent Jullier che propone il 1977 con lo Star Wars di George Lucas. Il primo produce senso, domanda di essere compreso, il secondo genera sensazioni, chiede di essere percepito coi sensi. Il cinema postmoderno è una suite di sensazioni da essere godute singolarmente, il cinema moderno invece invita alla comprensione. Uno spettatore degli anni ’40 chiedeva all’immagine che si facesse credere vera, il piacere dell’esperienza cinematografica era legato allo statuto di verità di quell’immagine, oggi non chiediamo più all’immagine di essere vera, deve essere un’immagine in grado di colpirci, non chiediamo più che il cinema sembri vero, ma sia stimolante ed eccitante, una vera finzione da vivere intensamente. È scelto da Jullier proprio per la sua pista sonora: è il cinema d’esordio perché è il primo ad utilizzare il Dolby Stereo, inaugurando il film concerto, effetti sonori importanti tanto quanto immagini, producendo un effetto bagno. È come se lo spettatore venisse investito da un effetto bagno, lo spettatore sembra essere immerso dai suoni che toccano il corpo. Sensazioni non solo visive ma anche sonore, grazie al sistema del Dolby Stereo. Che al Dolby Stereo sia affiancato il 3d è completo, l’effetto bagno non appartiene solo alla pista sonora ma anche alla pista visiva. Non conta più credere che 3 ABCtribe.com - [Pagina 5] Storia E Critica Del Cinema l’immagine abbia uno statuto di verità, ciò che conta è sentire quell’immagine: primato del sensibile sul sensato, del gratuito sul motivato. Il discorso può spingersi oltre, facendo slittare e individuando non solo la fine della modernità, ma del cinema. I cambiamenti avviati da Star Wars sono tanti e tali che per alcuni il cinema, come inteso nel ‘900, non esiste più. In un libro “L’Occhio Del Novecento” Francesco Casetti propone di chiamare l’esperienza cinematografica odierna “cinema due”, per contrapporlo a quello che era il cinema precedente. Cosa distingue i due? Il primo grande scarto il cinema due lo compie nel modo stesso in cui produce le immagini, è un discorso di struttura: il cinema due produce le sue immagini senza passare per il dispositivo cinematografico, è la magia del digitale (effetti speciali, esibendo realtà che non esistono in natura), il digitale consente di fare a meno di una realtà previa. Nel cinema uno questa cosa accadeva sempre, per quanto fantasiose fossero le realtà mostrate, quelle realtà erano realtà con uno statuto di verità perché erano passate di fronte alla macchina da presa. Il cinema uno operava su base fotografica, il cinema due questa cosa non la fa più. Lo stesso Jabba the Hutt era un pupazzo, adesso è un algoritmo matematico, il cinema due è esonerato dal fare i conti con la realtà. È una differenza fondamentale: capacità del cinema di conservare le fattezze del reale, capacità discusse a lungo da uno dei più grandi teorici del cinema, “Ontologia Di Un’Immagine Cinematografica” (Antoine Basain), all’origine delle arti plastiche c’è il complesso della mummia: il bisogno di un uomo a cui hanno risposto per secolo le arti plastiche, bisogno che l’uomo ha di conservare le fattezze del reale (e vincere la morte, il tempo che investe tutto e non lascia nulla). om Il cinema a differenza della pittura ha una marcia in più rispetto a questo specifico problema, che risiede nella modalità in cui produce le sue immagini. È una macchina che ha prodotto l’immagine, attraverso un procedimento che funziona da calco del reale. In quello statuto di credibilità sta una delle grandi forze motrici del cinema, capaci di rispondere ad un antichissimo complesso, che cade sotto il complesso della mummia. Il cinema nel corso del ‘900 ha dato risposta al problema della morte. AB Ct rib e.c Fin dalle prime recensioni dei fratelli Lumiere, si parla di potere restituire la vita tramite la manovella. Fin da subito il cinema concorre a dare sfogo alla fantasia suprema, di sopprimere la morte. Se l’avvento del digitale cancella di un colpo questa prerogativa, perché non c’è più legame con quella realtà che il cinema uno si è sforzato di conservare alla faccia dello scorrere del tempo, se l’avvento del digitale conserva questa prerogativa del cinema, il cinema non è più lo stesso. Se sullo schermo vediamo cose che non sono passate sulla macchina da presa, l’immagine non risponde al radicale bisogno dell’uomo di conservare un calco del reale. Il secondo grande scarto rientra nell’esperienza quotidiana, sul versante dei modi di consumare il film, lo spettatore non necessariamente si reca in sala: video domestico, via etere, cavo, satellite, vhs, dvd, bluray, pc, telefonino, home theater. Negli anni ’50 si fruiva il film all’interno di una comunità, per essere discusso tutti insieme scambiandosi le impressioni; oggi il cinema non è più luogo sociale, ma come luogo all’interno di un luogo più ampio, un centro commerciale, un parco a tema, dove viene meno la socializzazione nel tempo. Per “cinema muto” si intende quel cinema compreso fra il 1895 (brevetto del cinematographe Lumiere, ovvero della macchina che si impone sul mercato e che per convenzione dà avvio alla storia del cinema) e 1927 (The Jazz Singer di Alan Crosland, primo film con sequenze parlate e cantate). È un concetto che taglia trasversalmente la periodizzazione di cui abbiamo parlato in precedenza. La pellicola è forata per scorrere all’interno di ganci, con la luce si impressiona: è piccola, leggera, consente di riprendere e anche di proiettare. Sono due date da cui partire per riflettere sul cinema muto, ma non possono essere prese in modo aproblematico. Le fotografie mostrate in rapida successione erano già note nel 1894, di fatto per risalire alle premesse tecnologie creative occorre spingersi più indietro negli anni, addirittura la lanterna magica, quindi secoli. È altrettanto problematica la data d’arrivo, il lungo crepuscolo del cinema muto: la morte del cinema muto avviene lungo un arco di tempo considerevole, inizia con gli esperimenti di registrazione diretta del suono su pellicola, i primi studi vennero pubblicati nel 1901; lì probabilmente inizia la fine del cinema muto. L’allineamento a una così radicale innovazione conobbe molti ritqardi, La Canzone dell’Amore è il primo film a sonoro italiano del ’30, l’URSS iniziò nel ’35. Cos’è che fa di un film un film muto? Non è l’assenza o meno della colonna sonora, perché ci sono film senza colonna sonora che non hanno nulla a che fare col cinema muto (cinema sperimentale underground anni ’60, privi di colonna sonora ma non di certo film muti). Viceversa ci sono film muti con la colonna sonora (The Wind di Sjöström, regista europeo con la più grande attrice americana, Lillian Gish), tuttavia esso appartiene all’estetica del cinema muto, ne costituisce una delle più compiute espressioni, siamo all’apogeo del cinema muto nonostante abbia una colonna sonora originale. Un film muto non lo fa la presenza o meno della colonna sonora, ma il modo in cui è montato, la modalità del linguaggio, le sequenze narrative. Il film è del 1928, è iniziato il declino del cinema muto e già impone la necessità di distribuire film già terminati quantomeno con una colonna sonora. Il cinema muto dimostra tutte le sue potenzialità, è in 4 ABCtribe.com - [Pagina 6] Storia E Critica Del Cinema grado di rappresentare una storia complessa ed eventi in cui si può trovare una cassa di risonanza, è la maturità del cinema: arrivato ad una tale maturità il cinema è destinato ad avere una svolta. Nemmeno il cinema compreso fra 1895 e 1927 era muto, spesso la proiezione dei film muti era integrata dalla produzione di rumori con meccanismi esterni alla pellicola, c’era una produzione sonora attraverso dispostivi esterni alla pellicola. L’immagine muta era integrata da rumori, musiche (musicisti e orchestre in sala con la presenza di cantanti), spesso anche dalle parole pronunciate da imbonitori incaricati di raccontare quanto stava accadendo. Nei primi tempi, prima dell’avvento delle didascalie, il cinema prevedeva la presenza di narratori che spiegavano quello che succedeva sullo schermo. Il cinema del primo Novecento si definiva tale in quanto questa era la componente essenziale di una nuova forma d’arte: si definiva muto, pur non essendo silenzioso, per emanciparsi dal teatro e dalla letteratura. “Muto” non indica uno spettacolo silenzioso, ma un’estetica in chiave antiteatrale e antiletteraria, per connotarsi come una forma d’arte nuova e diversa da tutte le altre presenti in quegli anni. L’assenza del suono non era percepita come un limite da colmare, era percepita da chi realizzava il cinema muto come un dato costituitvo su cui orgogliosamente fondare la propria identità. Supporto om La pellicola cinematografica era composta quasi esclusivamente da sostanze organiche particolarmente instabili. La pellicola era costituita da o Base di nitrato di cellulosa o Substrato adesivo in gelatina o Emulsione sensibile Colore rib e.c La pellicola era: o fino a metà anni ’20 ortocromatica (alcuni colori apparivano come macchie nere) o dopo metà anni ’20 pancromatica (consentiva di riprodurre una scala di grigi molto più vasta, ma era meno sensibile alla luce, le tecniche di ripresa quindi mutano. AB Ct I film erano colorati a mano tramite pennelli per far sì che il colore non occupasse un’area definita del fotogramma, la tecnica con cui veniva impresso il colore era approssimativa. Si poteva se no creare una copia matrice per applicare il colore in modo definito. Siamo comunque di fronti a casi in cui il colore veniva applicato dopo che il film era stato girato. Un altro metodo era quello di colorare l’intera pellicola con un colore uniforme, in questo modo si può separare una sequenza dall’altra (sequenza di notte colorata di blu, di giorno ha un altro colore): i segmenti di pellicola erano suddivisi secondo il colore di cui dovevano essere collaborati, un’equipe di operai faceva questo mestiere (il processo è quindi dipendente dalla capacità di montare). Un buon restauro filologico dovrebbe essere in grado di restituire al film il suo colore, questo accade di rado. Ma il colore non è solo un elemento decorativo, lungi solo dall’essere una decorazione spettacolare, funzionava a tutti gli effetti da segno e veicolava un significato in relazione al tempo e al luogo in cui l’azione si svolgeva; la colorazione contribuiva al senso del film. Vedere oggi film così pensati in bianco e nero, significa privarli di segni e significati. The Lonedale Operator di Griffith del 1911 sono quasi tutti in bianco e nero. In esso c’è una sequenza in cui la protagonista impugna la chiave inglese come fosse una pistola, i malviventi si spaventano e si calmano. Nella sequenza originale il colore è blu, i malviventi ci cascano perché la scena è ambientata di notte. Un altro significativo esempio è legato a Nosferatu di Murnau del ’22, nelle copie in bianco e nero sembrava che il conte Orlok vagasse di giorno contro la tradizione che figura i vampiri come creature notturne. L’unica sequenza in cui è immerso nella luce diurna è quella in cui muore, per essersi troppo attardato al letto dell’amato, alba segnalata per il passaggio ad un altro colore. L’uso della colorazione si diradò negli anni ’20, con la pellicola pancromatica, in quanto pur restituendo migliori colorazioni di grigio, si prestava molto meno ad essere colorata. Suono Oltre agli imbonitori, c’era la musica. Intolerance di Griffith nel ’16 fu accompagnata da 16 voci e un’orchestra, la presentazione al pubblico è accompagnata da un complesso orchestrale di tutto rispetto. I locali che non si potevano 5 ABCtribe.com - [Pagina 7] Storia E Critica Del Cinema permettere ciò, offrivano pianisti e piccoli gruppi con semplici fogli di brani famosi che si indicava ad associare a questa opera della scena. La Nascita di Una Nazione del ’15 di Griffith, l’arrivo dei cavalieri del KKK è accompagnata dalla cavalcata delle Valchirie. Distribuzione Il cinema nasce con la spiccata impronta internazionale, già nel 1910 le principali case di distribuzione avevano uffici in tutti i continenti. È un’immagine facilmente comprensibile in tutti i paesi del mondo: didascalie erano girate nei diversi paesi con le copie richieste, spesso capitava che di un film si girassero due negativi, perché da un negativo possono essere tratti solo un numero ristretto di positivi (copie). Capitava che di un film fossero approntate più versioni, per un determinato poteva essere prodotto un finale ad hoc (nel mercato russo si creavano finali negativi perché lì si amava piangere). Veniva poi approntata una versione colorata per le sale delle grandi città, e copie meno belle senza il colore per i cinema periferici. La versione italiana di Quarto Potere è scorciata di parecchi minuti per questioni di censura, occorre un approccio filologico che si risalga alla copia originale. Il film muto oggi e.c om Gli storici del cinema sostengono che l’80% della produzione mondiale sia andata persa, il che è un numero scoraggiante. Quello che ci è giunto ha passato una storia di degradazione e di degrado, il film ha vissuto traversie diverse. Traversie che lo hanno modificato profondamente, anzitutto perché la pellicola era altamente infiammabile, ma anche deperibile, ogni suo utilizzo la rovina e fa un passo verso la sua morte. La pellicola quando scorre a contatto con l’aria crea acidi che corrodono le immagini, facendola restringere. La pellicola non scorre più attraverso i ganci, il secondo effetto è che l’immagine comincia a svanire, la pizza diventa un blocco unico e non si riesce più a svolgere perché gli strati si appiccicano fra di loro. Ct rib Dopodiché compaiono sui rulli eruzioni di una macchie scuri, le pellicole si coprono di una patina marrone. Le sostanze chimiche con cui è stato realizzato il cinema muto sono deperibili, più va avanti lo stato di decomposizione a minor temperatura la pellicola prende fuoco (la pellicola genera ossigeno, aumentando la combustione). AB È già un miracolo che il 20% della produzione dei primi ‘900 sia giunta fino a noi. Meglio riprodurre un film a colori o cinque in bianco e nero? Stessi costi, salvo cinque film, e rinuncio al colore. Si è ritenuto che il trasferimento dell’originale su un supporto stabile. Il film potrebbe essere stato alterato da altri fattori, l’immagine potrebbe essere stata taglia a sinistra con lo scopo di inserire una colonna sonora per rendere più accattivane la proiezione, potrebbe presentare immagini fisse corrispondenti a lacune con più fotogrammi rovinati. Potrebbe avere subito lo stretching, proiezione di un film muto alla velocità di 24 fotogrammi al secondo. Un apparecchio scatta delle fotografie che vengono proiettate ad una certa velocità. Se vengono proiettate ad una velocità inferiore a 10 fotogrammi al secondo non si crea il movimento, le singoli immagini si fondono insieme se proiettate ad una data velocità. Il cinema muto proiettava a 16 fotogrammi al secondo, lo standard odierno è di 24. Il cinematographe Lumiere era in grado di scattare 16 fps, fondendoli e dando l’illusione del movimento. Il proiettore presente nei cinema oggi proietta a quella velocità, o ha una funzione che consente di variare la velocità di proiezione, oppure il film viene proiettato ad una velocità diversa da quella a cui era stato pensato, succede che i personaggi corrono, lo spettatore vede 24 fps e non più 16, il film finisce prima. Per ovviare a questo problema è stata predisposta la tecnica dello stretching, riproducendo a intervallo regolare più fotogrammi, per poter riprodurre la pellicola con una macchina che riproduce a 24 fps. Ricostruzione della vita di un film muto girato nel 1914: vengono ottenuti due negativi (A,B) ripresi con due macchine appaiate. È stato approntato il set, gli attori sono pronti per recitare la scena, e ci sono due macchine da presa affiancate che registrano quanto sta accadendo, da queste due macchine da presa provengono due negativi, uno viene usato nel mercato interno da cui sono tratte 19 stampe colorate, per l’altro vengono fatte 16 copie con didascalie tedesche, italiane, ecc. Con la prima guerra mondiale i due negativi originali A-B muoiono, nel 1925 da uno dei positivi viene ottenuto un negativo di cui si fanno 12 positivi, con un costo enorme dell’immagine (un negativo in positivo mantiene inalterata la qualità, ma da positivo e negativo si produce una perdita considerevole di qualità dell’immagine). Nel ’36 un collezionista intercetta uno dei 12 positivi e ne fa 3 copie, nel ’48 un imprenditore ottiene un altro dei 12 positivi e trasforma le lunghe e noiose inquadrature in inquadrature più 6 ABCtribe.com - [Pagina 8] Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. ABCtribe.com - [Pagina 9] Preparati con le domande di ABCtribe su Storia e critica del cinema. 1. Individuare i punti di connessione tra le Risposta: Pinter fu un uomo di spettacolo nel senso più completo del termine. Nacque come attore, ma ben presto si dedicò alla scrittura di testi teatrali e cinematografici. L'approdo al cinema però può dirsi completo solo nel momento in cui lo sceneggiatore incontra un regista, negli anni 60: Losey. In realtà l'incontro avviene per caso poichè Losey, volendo girare un film su 'the servant', scopre che il romanzo era stato già trasposto in sceneggiatura, proprio da Pinter. Tra i due c'è da subito un accordo, legato non tanto alle decisioni da prendere per la revisione dell [Clicca qui >> per continuare a leggere]. 2. Che si intende p Risposta: Pinteresque è un termine coniato dai critici per indicare il modo di 'usare' il linguaggio di Pinter, nelle sceneggiature. Basandosi sul concetto di economia del linguaggio (non inserire parole quando non servono), e conoscendo in maniera [Clicca qui >> per continuare a leggere]. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Storia e critica del cinema e guadagna punti >> * Lezioni Private per Storia e critica del cinema >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di ABCtribe.com è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. Il presente file può essere utilizzato in base alle tue necessità ma non deve essere modificato in alcuna sua parte, conservando in particolare tutti i riferimenti all’autore ed a ABCtribe.com; non potrà essere in alcun modo pubblicato tramite alcun mezzo, senza diverso accordo ABCtribe.com - [Pagina 10] scritto con l’autore ed i responsabili del progetto ABCtribe.com. Per eventuali informazioni, dubbi o controversie contattate la redazione all’indirizzo [email protected]. ABCtribe.com - [Pagina 11]
Scarica