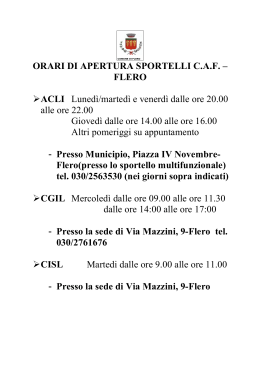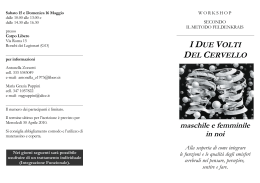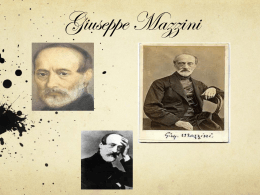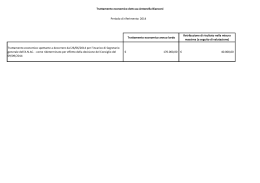Maurizio Mazzini Breslavia, agosto 1979 Ai giovani breslaviesi di oggi, polacchi e italiani, che non conoscono la Breslavia di allora. Era una tiepida giornata d’agosto, quando, sotto un cielo leggermente velato, Breslavia ci diede il benvenuto con un’infilata di palazzoni grigi, come disseminati a casaccio tra timidi spazi verdi. Eravamo in tre, Antonella, Paola e io, su una luccicante Autobianchi A112 blu, che pareva impaziente quanto noi di trovare un approdo dopo un viaggio iniziato la mattina stessa a Praga. Antonella ed io ci eravamo conosciuti un paio di anni prima, nell’aula di russo della Statale di Milano. Antonella era istruttrice di nuoto e studentessa di germanistica in trasferta, forse intrigata dal passato di suo padre, ex-ufficiale sul fronte russo, autore di un racconto che lei citava con ammiccante ironia e non senza un pizzico di malizia: La ragazza di Przemyśl. Dai banchi dell’università era scaturita una frequentazione tra amici, che si nutriva di studio in comune e qualche uscita serale al cinema o a teatro. Un’amicizia tenera, ma con scarse prospettive di divenire qualcos’altro. Paola, genovese nata in Brasile, era, al contrario, una perfetta sconosciuta per me, forse accodatasi su suggerimento della cugina, a scanso di equivoci. La terza lei, l’Autobianchi, gentilmente messa a disposizione dal padre di Antonella, avrebbe svolto un ruolo non secondario in quel viaggio che, nel giro di due settimane, ci avrebbe portato da Breslavia al Baltico, e di là alla foresta di Białowieża, al confine con l’Unione Sovietica, per poi con- 370 Maurizio Mazzini cludersi nei Tatra, a Zakopane. Compagna fedele e affidabile, avrebbe suscitato quasi ovunque l’interesse di tanti polacchi sedicenti meccanici nonché, a più riprese, dell’autorità costituita in veste di Milicja, a cui, con il suo fascino di utilitaria briosa, doveva apparire come una riuscita mutazione dell’onnipresente Fiat 126. Qualche mese prima, in una nebbiosa serata d’inverno meneghina, l’idea di intraprendere un viaggio insieme, alla scoperta della Polonia, aveva trovato consacrazione simbolica nel gesto con cui Antonella aveva dispiegato la cartina di quel paese sul pavimento della sua camera. Nel mio caso, accanto alla motivazione meramente turistica, c’era la volontà di esercitarmi in polacco, la lingua che avevo iniziato a studiare l’anno prima, non senza suscitare incredulità fra i compagni di studi (“Ma che te ne fai?” – mi aveva chiesto la mia amica Enrica) e disappunto tra i docenti di russo (“Finirà per fare confusione”). Effettivamente, con i primi polacchi in cui mi ero imbattuto – un gruppo di architetti conosciuti in un ostello, in Spagna – avevo sfoggiato un idioletto panslavo di dubbia utilità. Nel caso della mia amica, si trattava probabilmente di semplice spirito d’avventura: la Polonia all’epoca ci appariva, se non come “il nessun posto” dell’Ubu Re, almeno come “il paese lontano” da cui Karol Wojtyła aveva spiegato di provenire, affacciandosi l’anno prima al balcone di piazza San Pietro: uno dei più esotici e misteriosi paesi d’oltrecortina, come si soleva dire allora. Motivazione a cui si associava, probabilmente, quella del viaggio sentimentale sulle orme dell’impresa militare paterna. Arrivata l’estate e finiti gli esami, giunse il momento di dare forma alle fantasticherie che da mesi ci frullavano in testa. L’idea era in realtà quella ben più articolata di un viaggio interculturale, che avrebbe permesso ad Antonella di limare il suo tedesco a Vienna e ad entrambi di vedere insieme Praga e la Polonia, dove io sarei stato abbandonato in balia di me stesso e del mio incipiente polacco (sicuramente per darmi l’opportunità di conoscere la mia futura moglie), mentre le due ragazze avrebbero proseguito per vedere anche Budapest. Per questo, approfittando anche del fatto che io ero ancora impegnato con gli esami, Antonella e Paola erano partite per la capitale austriaca, dove avremmo dovuto incontrarci alla Hauptbahnhof una settimana dopo. In realtà, ai Breslavia, agosto 1979 371 tempi quando i cellulari non esistevano ancora, gli appuntamenti, specie se fissati con largo anticipo, appartenevano al mondo dell’effimero. Arrivato alla stazione il giorno convenuto, non ci trovai nessuno ad attendermi, e dovetti cercare scampo in un ostello, potendo confidare solo sul mio inglese scolastico. Fortunatamente, due giorni dopo Antonella riuscì a rintracciarmi, telefonando a tutti gli ostelli e lasciando l’indirizzo della camera che avevano affittato in centro. Lasciata Vienna, ci dirigemmo verso Praga, dove trascorremmo alcuni giorni in quella città che se Ripellino vedesse oggi, dubito definirebbe “magica”. All’epoca, nonostante il grigiore generale e la cupa cappa che la opprimeva, la capitale boema era molto più misteriosa ed affascinante di quanto non lo sia attualmente, in gran parte sfigurata dal turismo di massa. La scelta di fissare proprio a Breslavia la prima tappa del nostro itinerario polacco non era solo di natura geografica, bensì anche logistica. L’anno prima all’università era giunto, proprio dal capoluogo della Bassa Slesia, un polonista teatrologo in veste di lettore: Andrzej. Io e lui avevamo fatto amicizia e ci incontravamo anche al di fuori dei corsi, con indubbio beneficio per il mio polacco. Un giorno, all’Istituto di Lingue e Letterature Slave, in via Festa del Perdono, lui mi aveva mostrato una cartolina su cui appariva l’isola della cattedrale di Breslavia. Fu quella la prima immagine (internet, dov’eri?), comparsa davanti al mio sguardo, di quella che sarebbe diventata la mia città d’adozione. Quello che allora registrarono i miei occhi è esattamente ciò che di Breslavia continua a stupirmi e a cui, a mio parere, essa deve gran parte del suo fascino: il fatto che al centro di una città popolosa e di notevoli dimensioni, nel suo cuore storico, regni un senso di quiete, di non costretta spazialità e (concerti permettendo) di silenzio. A parte quella cartolina e la comparsa del toponimo sulla cartina di un manuale di storia delle secondarie che indicava le principali città sede di mercato dell’Europa medievale, alla voce Wrocław/Breslavia avrebbe corrisposto all’epoca una pagina bianca della mia “enciclopedia”, se in quegli anni – frequentando il Centro di Ricerca Teatrale del Comune di Milano – non avessi avuto modo di conoscere Jerzy Grotowski ed assistere al migliore dei suoi spettacoli: Apocalipsis cum figuris. Non solo Grotowski, ma anche Eugenio Bar- 372 Maurizio Mazzini ba, suo allievo italiano presso il Teatr Laboratorium e futuro fondatore dell’Odin Teatret, che durante un incontro, sempre a Milano, mi aveva incuriosito ed intrigato affermando: “La Polonia è l’unico paese che io conosca che vive ancora nell’Ottocento”. Del resto, la città meneghina era, nella seconda metà degli anni Settanta, una mecca per gli amanti della cultura, anche polacca: senza spostarmi ebbi la possibilità di assistere all’indimenticabile Classe morta di Tadeusz Kantor (a cui avrei dedicato la mia tesi di laurea) e alle pantomime di Henryk Tomaszewski, altro artista attivo a Breslavia, spettacoli che, al tempo, facevano il giro del mondo, per non parlare degli artisti attivi in loco: Dario Fo alla Palazzina Liberty, Giorgio Strehler al Piccolo Teatro, Giorgio Gaber, Roberto Vecchioni o Enzo Jannacci. Per questo, viaggiando verso la nostra prima tappa programmata del viaggio, sentivo di dirigermi verso la mecca dei teatrologi: un luogo in cui, chi ama il teatro, deve recarsi almeno una volta nella vita. Breslavia mi appariva come un terreno eccezionalmente fertile di figure ed iniziative teatrali e mi chiedevo quanto di “teatrale” recasse in sé la città stessa. Tuttavia, il primo evento in terra breslaviese mi avrebbe riportato ben presto con i piedi per terra. Volendo metterci in contatto telefonico con Andrzej, parcheggiammo il nostro minibolide in un quartiere-dormitorio della periferia, che non saprei identificare con certezza. Provenendo da sud, doveva trattarsi probabilmente dei dintorni di via Ślężna. Mi avviai così verso una cabina telefonica, ignaro dell’ardua prova che mi attendeva: dover affrontare le incognite tecnologiche del sistema telefonico della Polonia Popolare. Staccato il ricevitore che dondolava appeso ad un grigio apparecchio dall’aspetto alquanto primitivo, cercai di comporre il numero che il mio lettore mi aveva lasciato. Vittima della mia scarsa fantasia tecnica, sentendo un segnale continuo, pensai, erroneamente, che il telefono fosse guasto e rinunciai, anche perché incalzato dalla coda di utenti dall’aria impaziente che, in un baleno, si era materializzata all’esterno. Va aggiunto, per dovere di cronaca, che, in quegli anni, possedere in Polonia il telefono in casa era un privilegio di pochi e l’allacciamento – possibilità tecniche a parte – era uno dei piccoli-grandi ricatti (al pari del rilascio del passaporto, del buono ac- Breslavia, agosto 1979 373 quisto auto, delle vacanze in una casa-ferie sul Mar Nero ed amenità simili), usati dal sistema per accattivarsi la benevolenza, se non la complicità, dei cittadini. Mentre me ne tornavo, scornato, in direzione della macchina, vidi che Antonella cercava di comunicare in tedesco con una donna di mezz’età la quale, notata la targa estera, le si era avvicinata per chiederle se avevamo oro da vendere; evidentemente non ci voleva molto per far credere che provenissimo dal paese di re Mida... Una volta spiegatole che non disponevamo del prezioso metallo, ce ne liberammo facilmente. Dopo che ebbi comunicato il fallimento del mio tentativo, risalimmo sulla nostra vettura, decisi a proseguire a lume di naso verso il centro per chiedere a qualcuno dove fosse via Drukarska. Giungemmo così in breve nei dintorni di via Kołłątaja, dove, accostata la macchina, scesi per compiere, non senza patemi d’animo, la mia prima spedizione linguistica in terra polacca: chiedere la strada per arrivare a destinazione. Entrai in un locale che doveva essere un bar, sicuramente mleczny, ossia una specie (oggi in via di estinzione) di bar-latteria con consumazione a self-service di prodotti a base di latte (un’iniziativa che – a detta delle autorità – doveva combattere l’alcolismo...). Non ricordo esattamente che cosa mi rispose l’inserviente alla quale rivolsi la domanda; in ogni caso, alla fine, sinceratasi che fossi in macchina, mi consigliò di seguire il tram numero 17 in direzione sud, esattamente quella da cui eravamo arrivati. Risalito in auto, feci partecipi le mie amiche dell’informazione ricevuta, orgoglioso di essermi fatto capire dagli “indigeni” senza alcuna difficoltà. C’era però un piccolo problema: i tram hanno l’abitudine di sostare alle fermate e “pedinarne” uno non è cosa facile. Per fortuna, il traffico era allora tanto limitato che ci si poteva fermare quasi ovunque senza problemi. Addocchiata la nostra vittima, ci mettemmo dunque all’inseguimento. Giunti all’incrocio di via Świerczewskiego (oggi Piłsudskiego) e Powstańców Śląskich, non potendo fermarci al semaforo verde, decidemmo di girare a sinistra per imboccare quest’ultima ed accostammo a fianco della gelateria Ambrozja, situata dove oggi c’è il Kuchnia Marché, per aspettare la mossa successiva del nostro “cetriolo”, una volta ripartito dalla fermata, strategia che tuttavia si rivelò 374 Maurizio Mazzini inutile. Prima ancora che il tram ci superasse, fummo infatti raggiunti da una vettura che si fermò davanti alla nostra. Tra sorpresa e preoccupata, Antonella abbassò il finestrino per chiedere che cosa volesse il conducente che, nel frattempo, ci si era avvicinato. Questi ci chiese in inglese se poteva aiutarci e noi gli fornimmo il nome della via che cercavamo. Follow me!, ci disse e, risalito a bordo, ci guidò fino a piazza Powstańców Śląskich, dove ci indicò con un cenno della mano da che parte girare per prendere via Drukarska. Fu quella la prima di una serie di simili episodi in cui, durante la nostra odissea in terra polacca, saremmo stati oggetto di simpatia e attenzioni da parte dei polacchi, per il semplice fatto di essere stranieri, ma forse in modo particolare per il nostro essere italiani (o almeno “occidentali” ma non tedeschi). Un atteggiamento dettato sicuramente anche dal bisogno psicologico di avere contatti con persone dell’“Occidente” e di venire da essi ben giudicati, ma non per questo meno simpatico e apprezzabile. Parcheggiata la macchina sotto un lungo condominio che – come avrei saputo in seguito – era conosciuto col nome di “formicaio”, suonammo alla porta di casa. Fortunatamente, Andrzej era in casa, in compagnia della moglie. Il mio amico ci accolse con calore e senza alcuna sorpresa, malgrado non ci sentissimo da un paio di mesi e non ci fosse alcuna garanzia che sarei andato a trovarlo davvero. Dopo esserci riposati un po’, accettammo la proposta di farci accompagnare al margine del quartiere di Karłowice dove, in via Obornicka, il mio lettore aveva appena “ricevuto” un appartamento in uno dei condomini a dodici piani, che svettavano in un paesaggio lunare. Il meccanismo era ed è piuttosto noto: ai bambini ancora in fasce veniva intestato un libretto di risparmio per la casa che, con le quote accumulate in un arco di tempo che variava a seconda della situazione dell’edilizia popolare, e che poteva giungere fino al compimento dell’età matura, avrebbe permesso loro di “ritirare” la casa, costruita nel frattempo da una “cooperativa”. Una vera lotteria, dunque, quanto a tempi di attesa e ubicazione dell’immobile, ma pur sempre un evento agognato che permetteva a molte famiglie di assicurare, con uno sforzo relativamente esiguo, una casa ai propri figli (stato assistenziale, dove sei?). Evento celebrato con una festa, entrata forse per sem- Breslavia, agosto 1979 375 pre nei costumi dei polacchi, un’occasione per fare baldoria con amici e parenti, per la quale è stato coniato l’ameno termine di “davanzalata”, con scherzoso riferimento a ciò che solo poteva supplire alla mancanza di mobili. Dopo averci mostrato con orgoglio il vasto, ma ancor vuoto appartamento, Andrzej, non potendo ospitarci, ci chiese dove avremmo pernottato. Si tenga presente che allora era quasi impossibile prenotare un alloggio dall’Italia, se non negli alberghi di lusso, destinati soprattuto a stranieri “dollarosi” da spennare e comunque attraverso i canali della principale agenzia di viaggi, ovviamente statale, l’Orbis. Persino telefonare dal nostro paese era un’impresa: bisognava prenotare la chiamata attraverso il centralino internazionale e aspettare che (se andava bene) ti richiamassero; talvolta, quando dicevo di voler parlare con la Polonia, avvertivo dall’altro lato del cavo l’insofferenza di chi è chiamato a svolgere un compito alquanto arduo per mettermi in contatto con un lontano aldilà. L’unico punto di riferimento di cui noi tre disponevamo per trovare un alloggio era la guida agli ostelli della gioventù d’Europa che avevo ricevuto a Milano, iscrivendomi all’associazione turistica studentesca. Un libretto che, nel corso del viaggio, si sarebbe rivelato indispensabile e ci avrebbe condotti a pernottare su materassi in scuole di città, completamente vuote, o letti a castello di scuole rurali adagiate tra i laghi Masuri, dove l’unica indicazione era il nome della persona responsabile, affisso sulla porta sprangata, e dove una sera, captata per caso una stazione radiofonica italiana, sentimmo il brivido di un esploratore spaziale che riesce inaspettatamente a riconnettersi con il mondo lontano da cui proviene. Sì, sarebbe stata proprio la radio, durante quel viaggio polacco, a lenire la nostalgia di casa, sciorinandoci a più riprese, ovunque fossimo, le canzoni di Drupi e dell’effimero successo di quell’estate, dal titolo per noi emblematico: Tornerò, dei Santo California (qualcuno se lo ricorda?). Nel caso di Breslavia, l’indirizzo relativo, contenuto nel nostro libretto-bussola, era quello di via Na Grobli, dove Andrzej ci procurò una camera e volle assolutamente, malgrado le nostre insistenze, pagarci il pernottamento. Rientrati in via Drukarska, ci mettemmo a tavola per consumare il pasto che sua moglie ci aveva preparato. Sarebbe stato quello il mio 376 Maurizio Mazzini primo contatto con la cucina polacca, se, in precedenza, in occasione di una Festa dell’Unità, organizzata al Castello Sforzesco, non avessi avuto modo di assaggiare il leggendario bigos, presentato a Milano con la buffa dicitura di “piatto dei cacciatori”, forse come antidoto alla naturale ritrosia che il suo aspetto poteva suscitare ad un occhio italico. Rifocillatici e preso commiato dai nostri anfitrioni, risalimmo in macchina con la speranza di riuscire a ritornare in via Na Grobli, impresa portata a compimento senza grossi problemi, nonostante che – calate le tenebre – avessimo l’impressione di muoverci in una città sottoposta ad oscuramento. All’ostello ci attendeva una camerata tanto enorme quanto disadorna a nostra completa disposizione; una pacchia tuttavia, considerata l’età e il fatto che mi era capitato di dormire in stazioni, scantinati di case in costruzione o sui pavimenti di pietra di un convento. Così, stanco, dopo una giornata intrisa di impressioni e di emozioni, posi fine alla mia prima giornata breslaviese, addormentandomi mentre la luna si specchiava nelle calme acque dell’Oder. La mattina seguente avevamo in programma la visita ai luoghi più significativi della città slesiana: l’isola della cattedrale e la Piazza del Mercato. Svanita la Reisefieber del giorno precedente, potei dedicarmi ad assaporare quella città per me nuova e piuttosto esotica. Quello che mi colpì maggiormente fu la sensazione di ariosa spazialità e l’abbondanza di aree verdi, particolarmente inconsuete per un milanese cresciuto in un cortile di cemento stretto fra due condomini, che fungeva all’occorrenza da velodromo e da campo di calcio, nel quartiere periferico e popolare di Turro, cui si addicono perfettamente le parole di una canzone di Celentano: “continuano a costruire e non lasciano l’erba”. Un’altra cosa che mi balzò agli occhi erano i numerosi austeri edifici pubblici neogotici, scuole ed ospedali, in mattoni rossi, che parevano voler ostentare il loro splendore sfiorito sotto la patina di fuliggine, segnando la continuità architettonica con le chiese gotiche in cotto: in uno di questi – oggi abbandonato a sé stesso – introdotto da una stonata appendice moderna, in piazza Primo Maggio, sarebbero venuti al mondo i miei figli. Ma ciò che mi colpì di più fu il fatto che Breslavia fosse, e sia ancora in gran parte – dopo le distruzioni belliche e le demolizioni Breslavia, agosto 1979 377 postbelliche a chiave (ideologica: antigermanica) – una città che un architetto locale ha definito “intermittente”, che scompare per poi ricomparire quando, in pieno centro, ad un gruppo di palazzoni sparsi – tipici, in Italia, delle periferie-dormitorio – subentra inaspettatamente il frammento superstite di un quartiere d’anteguerra e la linea prospettica della via, prima lacerata, improvvisamente si ricompone. Quanto si trattasse di due città, quella tedesca e quella polacca, non solo intersecate ma anche sovrapposte, lo capii, cercando di decifrare le insegne semicancellate in tedesco che trasudavano a volta da muri scrostati, mentre un manifesto affisso alla fermata del tram strillava sguaiatamente che “Wrocław era, è e sarà sempre polacca”, facendomi riflettere su quanto si possa appiattire, rendere triviale e fuorviante il discorso sulla storia di una città posta al centro dell’Europa, per meschini fini di propaganda nazionalistica. Il paradosso, a tale proposito, risiede nel fatto che allora si negavano in toto i secoli precedenti, epoche di reale convivenza multietnica, mentre la propaganda di chi la governa oggi si è inventata di sana pianta il mito di una città che multietnica lo sarebbe ora. Di questa storia comune l’Isola della Cattedrale è una delle materializzazioni più alte. L’Ostrów Tumski è anche la zona che, non solo da allora ma in generale, è cambiata di meno. Se togliamo le sproporzionate guglie della cattedrale – definite da uno storico breslaviese dell’arte medievale “siringhe” – qualche facciata ridipinta o ristrutturata, le ripristinate lampade a gas e la demolizione di un grosso ambulatorio per studenti, avulso dal suo contesto architettonico, poco qui è mutato: il “piccolo Vaticano” resiste, per ora, agli attacchi di banche, negozi di telefonia, ambulatori privati, gabinetti dentistici, farmacie e luoghi di ritrovo – tutto ciò che, nel bene e nel male, ha dato un volto nuovo alla città. Per non parlare dei centri commerciali e di quello che una volta si chiamava “grandi magazzini”. Ancora a venire i primi, i secondi, in quell’agosto di trentacinque anni fa, si potevano contare sulle dita di una mano ed il dito pollice era il PDT Centrum, oggi Renoma, che al pianterreno vendeva generi alimentari, al tempo forse l’unico posto dove i piccoli breslaviesi potevano provare l’emozione di salire per la prima volta sulla scala mobile. 378 Maurizio Mazzini Arrivati sul Rynek, ci trovammo di fronte ad un’ampia piazza non abbracciabile con lo sguardo, impedito dall’insolita, per un occhio mediterraneo, soluzione mitteleuropea di avervi innalzato un intero isolato al suo centro. La Piazza del Mercato e quella del Sale con le vie adiacenti, oggi fulcro della vita mondana e dello svago di massa, era un luogo dove si poteva fare di tutto fuorché divertirsi e starsene tranquillamente seduti al tavolino di un locale (ad eccezione del ritrovo per giovani con annesso cinema operante sotto il municipio, al posto della soppressa, e oggi risorta, “Cantina di Świdnica” d’anteguerra); ai negozietti di alimentari seguivano quelli di abbigliamento, una banca, un negozio di parrucchiere, un museo, un altro di mobili, l’agenzia di pratiche automobilistiche e soprattutto diverse librerie, tra cui quella di “libri sovietici” e chi più ne ha più ne metta. Il selciato sconnesso, i lampioni da tangenziale e i resti delle rotaie del tram, soppresso qualche anno prima, non conferivano certo a quel luogo un clima particolare. In uno scantinato del municipio era stato ricavato il ristorante omonimo (Ratuszowa), tutt’altro che accogliente per uno straniero; l’attrattiva maggiore, l’unica cosa a dar colore a locali simili, erano le cosiddette “nonne closed”, vera e propria istituzione, vecchiette che governavano con mano ferrea le toilette pubbliche, esigendo senza indugio dai clienti il dovuto compenso, nonché il fatto di poter mangiare con l’equivalente di 1000 lire, ovviamente cambiando, a proprio rischio e pericolo, dai cambiavalute clandestini che, capito a cento metri di distanza che eri uno straniero, ti tiravano in un portone e ti mettevano sotto il naso un plico di banconote; il tutto una volta esaurito l’equivalente dei dollari che si era obbligati a cambiare al cambio ufficiale, a seconda della durata del visto di soggiorno. L’unico locale presentabile agli stranieri era la caffetteria Herbowa, dislocata su due piani, al posto – se non erro – dell’attuale ristorante CesarskoKrólewska, dove attraenti cameriere, in abiti vagamente tradizionali, servivano bevande calde e dessert vari. Ad essa si poteva aggiungere la gelateria Witaminka, miracolosamente sopravvissuta, ma il cliente in cerca di golosità avrebbe fatto meglio a dirigersi nella zona di piazza Kościuszki e via Świerczewskiego dove, stranamente, gli si prospettavano diverse possibilità, a cominciare dal bar-gelateria Hortex, per finire Breslavia, agosto 1979 379 con la gelateria cult U Kruty, considerata la migliore della città. L’intera area della Piazza del Mercato sarebbe stata rinnovata – pavimentazione ed illuminazione in testa – solo parecchi anni dopo, alla vigilia di una visita papale e di un altro evento religioso di portata internazionale, e poi eroicamente difesa dagli abitanti – come del resto tutto il centro storico – nel corso della tragica alluvione del 1997. Qui, il cittadino assetato o in cerca di refrigerio poteva in compenso imbattersi in una sorta di carretto da gelataio ambulante che offriva la cosiddetta “acqua di soda”, concedendosi magari lo sfizio di farsela colorare con qualche goccia di succo di lampone. Tracce di pseudoitalianità erano rinvenibili nei microlocali dove si vendevano dalla finestra “gelati italiani” nei coni (i contenitori di plastica non esistevano e nei bar imperavano le posate di alluminio, magari legate al tavolo con apposita catena...), prodotti con macchine firmate Carpignani nonché i gelati denominati Bambino (in italiano), made in Stargard Szczeciński. Quanto ai divertimenti, “casotti con birra” a parte, si poteva contare solo su un paio di club musicali frequentati soprattutto dagli studenti: il classico jazz club Rura, situato in un edificio prospiciente l’Oder ed oggi fatisciente, e il cosiddetto Pałacyk, che fa ancora bella mostra di sé in via Kościuszki, e poco più. I ritrovi giovanili più frequentati erano pertanto i club operanti presso le varie case dello studente, dove le portinaie avevano il loro ben da fare per non permettere l’ingresso agli estranei (che però sapevano come accattivarsele). In compenso, quasi ogni quartiere, anche il più periferico, aveva il proprio cinema: Przodownik, Lalka, Polonia, Światowid, Oko, Pioner, Dworcowe ed altri, una lunga lista di piccoli cinema fagocitati dalle odierne multisale, che suscitano teneri ricordi di gioventù tra i breslaviesi non più giovani, al pari dei tanti piccoli negozietti di periferia, regno di fascinazioni infantili fatte di piccole, modeste cose, ricordati ancora oggi con una lacrima di nostalgia su un sito come “La Breslavia che non c’è più”. Non posso dire di essere rimasto scosso dal senso di precarietà e di penuria che emanava in genere dalle vetrine e dagli scaffali dei negozi, dall’imperante mancanza di colore e di gusto; la crisi economica, che sarebbe esplosa l’anno seguente in crisi anche politica con Solidarność 380 Maurizio Mazzini era ancora latente: i negozi semivuoti, le code, anche notturne, davanti ai negozi (che erano tuttavia occasione di socializzazione oltre che fonte di controinformazione) ed il tesseramento dei generi di prima necessità ancora a venire. Del resto, ero già stato vaccinato contro certe vedute, avendo trascorso, tre anni prima, un paio di settimane tra Mosca e Sochi, per limare il mio russo. Che però sotto quella penuria ci covasse qualcosa, lo avvertii subito, confrontando quello che si poteva acquistare nei negozi di alimentari con quello che mi mettevano davanti al naso ogni volta che ero invitato. Solo che all’inizio non avevo coscienza di come funzionasse l’economia del “sottobanco”, la pratica generalizzata del baratto, che abbracciava parenti, amici e persino vicini di casa, la politica quotidiana dei favori e controfavori (io ti procuro mezzo maiale e tu mi metti da parte una lavatrice, quando arrivano) con cui ci si arrangiava a dispetto della cronica scarsità di merci e dei circuiti inaccessibili al comune cittadino i quali soli, ufficialmente, permettavano a certe categorie privilegiate (militari, poliziotti, minatori, uomini di partito) di accedere ai prodotti che scarseggiavano. A meno che non si disponesse di valuta pesante, nel qual caso, il sistema era disposto a farti accedere a negozi denominati Pewex (“Azienda di esportazione interna”, che già nell’ossimoro del nome mostrava il suo carattere contraddittorio), dove potevi assaggiare i frutti proibiti del tanto deprecato capitalismo. La mia attenzione era allora convogliata piuttosto su certi comportamenti che di tale situazione erano la conseguenza. Ricordo lo shock culturale provato nell’incrociare sui marciapiedi persone che si portavano a spasso sotto l’ascella, a mo’ d’ombrello, filoni di pane così come sfornati (mancava la carta e a volte ti impacchettavono la merce nel giornale), ed altre con dieci rotoli di carta igienica (prodotto particolarmente ed assiduamente ricercato) uniti da uno spago, portati al collo come una collana. Il tutto in uno scenario in cui mancava la pubblicità, tanto aggressiva quanto variopinta, ed i cestini dei rifiuti risultavano quasi inutili, visto che imballaggi e confezioni erano quasi inesistenti e le buste di plastica venivano vendute come rarità da trafficanti e “formiche” che facevano la spola con Berlino o altre città dell’Occidente. Questi avevano come punto di riferimento principale il Mercato Coperto, situato ancor oggi Breslavia, agosto 1979 381 sulle sponde del fiume, di fronte all’edificio della Facoltà di lettere. Qui i breslaviesi si erano creati un proprio surrogato d’Occidente, al di fuori del circuito sancito delle autorità. Una volta entrati, sotto l’avveniristica costruzione dei primi del Novecento, si era assaliti da un turbine di colori e profumi, da un vocio e un viavai quasi mediterraneo, in stridente contrasto con l’atmosfera amorfa e compassata che regnava al suo esterno. Qui, il sistema permetteva al senso d’imprenditoria latente nei molti di sfogarsi, purché si autoghettizzasse e rimanesse sotto controllo. Un luogo, questo, dove ritrovai al meglio quella teatralità di cui ero alla ricerca e che ancora oggi, malgrado il contrasto di allora sia svanito, costituisce per me uno degli angoli magici della città. Spiccatamente teatrali erano le vetrine dei negozi, specie di quelli che vendevano prodotti particolarmente ricercati. Non di rado in vetrina faceva mostra di sé la scritta “Esposizione permanente”, che suggeriva di non chiedere i prodotti esposti, i quali avevano il solo scopo di far credere che il negozio servisse per vendere. Un’altra osservazione sullo stile e le condizioni di vita degli abitanti, che solo in parte ha perso d’attualità, riguarda la discrepanza fra il buon gusto e la relativa eleganza con cui, in genere, si vestivano le donne e l’imperante sciatteria e provincialismo che emanavano gli abiti dei loro compagni, i quali, quando cercavano di sembrare eleganti, sembravano usciti da una sagra di paese; a dispetto della qualità scadente degli abiti reperibili sul mercato interno (il meglio veniva esportato), le donne riuscivano miracolosamente, per lo più con mezzi artigianali, a tenersi aggiornate su quello che si portava in “Occidente”, scopiazzando, ad esempio, i modelli della rivista tedesca Burda, una delle poche pubblicazioni d’oltre cortina che riusciva a filtrare fra le maglie della censura. Donne nei confronti delle quali – udite, udite! – era d’obbligo il baciamano, usanza, di dubbia igenicità, a cui mi piegai non senza provare, almeno agli inizi, un senso di ridicolo e di imbarazzo e che fortunatamente oggi appartiene al passato. Prima di proseguire il nostro viaggio, che il giorno dopo ci avrebbe portato a fare tappa a Gniezno, non poteva mancare una visita alla “Grande Isola”, la zona del “Padiglione del centenario” (all’epoca de- 382 Maurizio Mazzini nominato “del popolo”) e del parco Szczytnicki dove zampillava una delle rare fontane di allora e – come in attesa del giardino giapponese che un giorno vi avrebbero allestito – una pseudopagoda se ne stava solitaria al centro di un laghetto. Lungo la strada notai un altro di quegli elementi che concorrono, per me, a creare l’atmosfera di questa città: i ponti d’acciaio, verniciati a colori sgargianti, sopravvissuti all’assedio di Breslau, che scavalcano i tanti rami dell’Oder, un fiume che quando credi di averlo lasciato alle spalle, quasi d’incanto ti ricompare davanti, per ricordarti che è proprio esso, con i suoi affluenti, i suoi tanti ponti e passerelle, a determinare la specificità di questa metropoli. Una cittàfiume fatta d’acqua di cielo e di rosso mattone, da cui presi commiato con la mente già rivolta a tutto quello che ci attendeva lungo il percorso ancora da compiere, ignaro di quanto essa avrebbe inciso nella mia vita futura.
Scarica