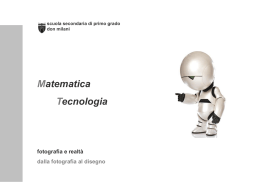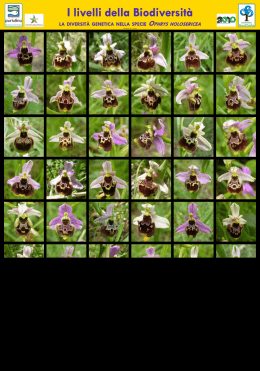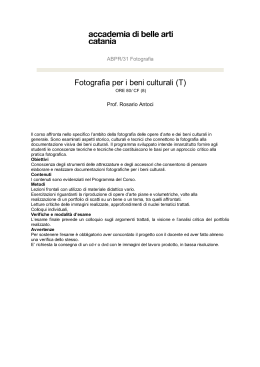mousse 42 ~ Talking About mousse 42 ~ Talking About The Man Without Photographs by Jennifer Allen Photography, at this point, has become the intrinsic and organic container of our lives and our identity. With each new shot our deepest essence inevitably drifts towards the image of our selfies. The psycho-bio-political repercussions are there for all to see. It wasn’t always this way, though. On the way to these and other considerations, Jennifer Allen analyzes the work of Christoph Westermeier, a young artist who concentrates, understandably enough, on the photographic medium. After all, his childhood family album doesn’t exist, since his parents, followers of Heinz Buddemeier—who believed that photographs alter and falsify the memory of our experiences—never took any pictures of their child. Christoph Westermeier, I want to hold your hand, 2013. Courtesy: the artist and Galerie Max Mayer, Düsseldorf He doesn’t look so strange. I play a game in my head: what if I knew all that before I had met him? And what if I had never found out? Yet once you know, it’s an impossible tidbit of information to erase from your memory, from your experience of him. What do I feel? Pity? Envy? He has a curious little breathless aura around him: not so much the golden halo of angels and saints but a floating question mark, moving by and then stopping on the spot. A dead end. “It’s impossible to go beyond that,” I tell myself, and get used to knowing the man without photographs. The artist without a past of pictures. Christoph Westermeier was born 1984 in Cologne. Yet there is no photographic record of his birth, or of any other key moment from his childhood. No first day at school or day after that, no first haircut, no blowing out one to eighteen candles on so many birthday cakes. No mud fights, no sandcastles, no family dinners or the craziness that so often accompanies them. Westermeier’s parents decided never to photograph their children, once they had read Heinz Buddemeier’s now-obscure manifesto Opposite - Christoph Westermeier, “Ways of Seeing, Ways of Aging”, 2013. Courtesy: the artist and Galerie Max Mayer, Düsseldorf Das Foto. Geschichte und Theorie der Fotografie als Grundlage eines neuen Urteils (The Photograph. History and Theory of Photography as the Basis for a New Judgment, 1981). Buddemeier’s new judgment included the radical decision that photographs not only replaced but also altered and falsified our memories of our own experiences. And Westermeier’s parents agreed. Only his grandmother was allowed to take an occasional snapshot of her grandchildren. “I still have my father in my ear, saying, ‘You shouldn’t remember the photographs—you should remember the moments,’” adds Westermeier. It should come as no surprise that the artist later chose photography as his main artistic medium. First came projects with found photographs and reproductions—from postcards to art history books—and then Westermeier moved behind the lens to take his own photographs. These are quite remarkable: not so much photographs as doubles of physical spaces, flattened and thinned out. Yet it’s as if the photograph were like a pop-up children’s 132 book, offering the illusion of a larger three-dimensional space that might be lived in, only to take away the invitation to enter it. However realistic in terms of perception, his photographs offer “distorted” images that evoke the imaginary—perhaps as the illustrations in children’s books hover between realism and imagination. His series “Ways of Seeing, Ways of Aging” (2013)—photographic portraits of plaster copies of classical sculptures from the Zurich University collection—seems to have been inspired by the title of John Berger’s illustrated Marxist-feminist critique of images Ways of Seeing (1972). Berger shows how women have been quite literally captured by artists, photographers, advertisers and art historians, while Westermeier offers up images of sculptures of men only. The artist’s choice perhaps suggests that the sculptures and their copies have allowed the men to persist across centuries with an unabashed vanity of eternal youth. No wrinkles, just a bit of plaster dust. Westermeier adds another palpable sense of time and space, beyond the ancient history evoked by the sculptures themselves and beyond the immediacy of the camera shutter’s rapid blink. This extra time-space lies in the photograph’s materiality, reproduction and framing. While the photographs are digital, they have not been manipulated. Using an inkjet printer, the artist reproduced each likeness many times over on the same paper, albeit slightly displaced, which leads to distortions in our perception of the photograph’s depth. The ink cartridge happened to be almost empty, leading to a random tonal range for each print. The pale whiteness of the sculptures seems to be stained with translucent colors, which illuminate the images in the chaotic way that the Aurora Borealis can redraw a Nordic night sky without shifting a single star in the universe: another depth, shimmering, alive. Westermeier chose to display the series in two continuous groups, each set inside a large, free-standing frame, which allows viewers to see the images as if they were sculptures, moving all around them. Instead giving us the frozen instant, the artist gives the printing process a memory, a durational blur of time whizzing by, if not the cinematic feel of a flipbook, albeit printed on a single page. And instead of offering a perfect copy of a past that would deny the passage of time, he makes each copy tremble, slightly yet oh-so-visibly and shadily, as if the sculptures were trying to remember what they looked like. As if they were indeed centuriesold men, searching in their mental archives, going back and forth between black-and-white and living color. Between remembering photographs and remembering moments. Westermeier’s “Studioline” series (2013) shows his studio at De Ateliers in Amsterdam, where he completed a two-year residency last spring. These pictures are equally remarkable for their give-andtake of a sense of space—real and illusive—but they have not been distorted in the printing process and are simple analog camera shots—no digital manipulation. The artist used the sun itself, almost as a hapless lighting assistant, to light the various surfaces: couches, tables, papers, many books, both opened and closed, a lone lip balm, a piece of clear cellophane with a thin golden edge, perhaps from a cigarette package or an eraser, some thin marble slabs. The photographs look overexposed, somehow blinding. Most of the words on the books have been blanched out, except for largely-printed titles, like the telling “Kunstliteratur und Reproduktion” (Art Literature and Reproduction) in Studioline-Research. The sun creates not only stark shadows around the objects but also dazzling reflections on the surfaces, between blank sun spots and crystalline sun flares. If one sees the images from afar, they look akin to collages of cut-out, oddly geometric shapes; as one moves closer, they seem to morph into photographic documents of some bygone Minimalist sculptures. The shadows are not empty, unoccupied, airy shapes, but appear to have volume, like heavy, square black blocks. In Studioline-Marble etc.—a table and the corner of a fat couch with a blanket—the shadows cast by the table legs are so dark, so dense and voluminous that they seem to leap forward, ahead of the legs. The shadowy backgrounds and the sunny surfaces start to swap places, more optical illusion than photograph. Again in Studioline-Research, the surface of a marble slab reflects the sun, mirror-like, while showing rings from what might have been a coffee mug, and outlines of other liquid stains. A plasticized book cover bears a long, rounded line of sunlight, revealing tiny dents in the cover and the sticky, less reflective outline left by a removed price tag. The same sunlight hitting a page in the distance picks up the creases in the paper, half-hearted folds and traces of being handled and read, the beginning of a dog-eared edge. These photographs— despite bordering on overexposure—maintain a high degree of detail: a nail in the floor, a scratch on table, weird gunk, clumps and stains, here and there. The objects, blanched out yet carrying all the little surface faults that come from sheer living in the world, remind us of sunbathers from a cold country hitting a beach on a winter vacation: blindingly white bodies, yet visibly marked with Westermeier’s choice of the medium of photography forbidden by his parents could well be laden with the Oedipal baggage that weighs most of us down with neurosis. The late French writerphotographer Hervé Guibert comes to mind, in particular the account of making his mother’s portrait in his fantastical autobiography L’image fantôme (The Ghost Image, 1981), published the same year as Buddemeier’s tract but with a different set of perversions pertaining to photography and memory. Guibert begins after sabotaging the look his mother constructs to please his father, who does not allow his wife to dye her hair, nor to wear make-up. Guibert puts her head under the tap, combs her permed hair straight, leaves it wet, adds a touch of face powder and decides on her clothes: a white suit, a business virgin. In a strange twist, the film turns out blank. Guibert first suspects that his father, who developed the roll of analog film, has in turn sabotaged his son’s voyeuristic drive to capture his mother the way the young man wants to see her. It’s an Oedipal father-son battle about how the mother should look and whom her look should please. Yet it turns out that Guibert himself did not correctly spool the film roll into the camera sprockets, so the film never moved out of its tight metal casing. In this technical psychopathology of everyday life, the camera spurs incest while reinforcing its taboo. Guibert poses his mother according to his own visual desire, but there is no lasting document of this exchange of gazes. The story reminds us that photography has long been a family affair, if not a full-fledged relative. Why wouldn’t the camera and the pictures become charged with family psychodynamics? In contrast to Guibert, Westermeier seems to be at ease with his own choices and those of his parents, which included a Waldorf education for their children, grounded in Rudolf Steiner’s anthroposophy and its intense notions of perception. “My parents tried to live life differently from their own childhoods,” says the artist. “It was the time after the 1968 revolutions when people had lost faith in changing society as a whole but believed in changing their own world. My father took my mum’s surname at their wedding, and she went to work while he stayed at home. The ‘ban’ was not a puritanical decision. Especially my father had a deep love for art history, and my parents had prints and artworks all over the house. We put up postcards— reproductions of works by Fra Angelico, Raphael, the entire Italian Renaissance, Impressionists, Expressionists—for every festivity, and changed them with the seasons. It was not a house without images but a house without photos.” tiny wrinkles, scars, a touch of holiday fat. Despite such details, the series seems to document not the objects but their contact with the sun. Perhaps the work is a portrait of the sun’s relationship to the studio, not the studio itself, nor its various contents: what the sun alone can produce, make visible, at particular times of the day. Of course for a camera lens the sun is a bit like Medusa; a direct gaze does not turn the camera into stone, but it blinds the film, leaves the pictures blank, erases the photographic memory. 133 Of course, through digital sharing, we not only live in houses with photos but also live in photography in a way like no society before us. Even recent history pales by comparison. Carsten Höller and Miriam Bäckström’s work for the Nordic Pavilion at the 51st Venice Biennale in 2005—All Images of an Anonymous Person (2005), a project that collected all of the photographs taken of a relatively young woman in one single book—would surely require endless volumes today, a short decade later. While Westermeier is an anomaly among his Facebook peers, he would have been at home in any era before the 1830s, when photography started shifting from scientific experiment into a technique with a potential mass calling. As Buddemeier notes, after the French government purchased the patent from the inventor Louis Daguerre for general use, the public presentation of his new technique in Paris in August 1839 was attended by crowds, later dubbed mousse 42 ~ Talking About the “Daguerreotype Mania.” Westermeier must recall his childhood in a way similar to Daguerre himself, if not Fra Angelico, Raphael, even Jesus, although their histories are vastly different. “I am not angry with my parents,” says the artist. “I am actually happy. We live in a photo society. Everyone is taking pictures of everything at any time. We don’t think about it, we just press the button and put it into the cloud. I do it too, but I don’t take it for granted. It’s still something special, and if I am honest with myself, I would rather trust my own mind than a photograph.” Still, a man without photographs is a man without qualities. It’s hard to imagine existing without a family album to share, online or otherwise. It’s as if Westermeier’s hard-drives had been erased, his cloud emptied or his password hacked. a similar biopolitical dimension—a connection to our lives and to politics—precisely because no one can imagine a life without pictures, because the idea of Westermeier’s childhood is as disturbing as the idea of losing your digital archive in a poof of a cloud. In a sudden digital downpour that accidently scatters pictures and pixels, like so many raindrops, disappearing down the drain or drying up on the sidewalk. Despite the omnipotence of photography, it is a medium that has become harder to grasp with every passing day. Literally. “It no longer exists as a physical object,” says Westermeier, “it’s all in the cloud!” Since the digital image can never be isolated as an object, the print has become but a temporary stop on a journey that can be endless and What’s more fascinating than his parents’ decision to ban photography is the political nature of this decision. Paradoxically, they were inspired by the failures of ‘68, which for many people radically shifted political activism from the public collective realm to the privately shared realm of the family and the limited realm of one ’s own life. In France, the rise of psychoanalysis in the 1970s had a similar origin, as intellectuals did analysis or became analysts. But what must have looked back then like a retreat from politics, if not an admission of failure, has a renewed political urgency today, because the border between the public sphere and the private sphere has all but disappeared with digital technologies. Consider how private lives are intentionally shared in public on Instagram. Or the secret intrusions of the NSA and other government spies into our daily digital lives. It no longer makes sense to talk about “the private” and “the public.” Where would that border exist? How would one draw it, maintain it and legislate it? Old slogans like “the personal is political” from feminism have also gained a renewed urgency, yet this slogan assumes a separation that has been both willfully eroded and secretly abused. After Edward Snowden’s revelations, we now realize that we had no idea just how fully political our personal lives had become, right under our fingertips, pecking away at our touch screens. In a way, by banning photographs from their children’s lives, Westermeier’s parents were anticipating a politics of the future, of our present. Their decision has a certain political currency, especially for younger people. Consider globalized child porn or online bullying and its fatal effects among teens that have committed suicide over a compromising photograph. Can one imagine another future, when digital conglomerates are sued for creating a dangerous technology—as cigarette companies were eventually sued for misleading the public about the dangers of nicotine, privately eating away at each smoker’s lungs? Will smartphones some day be outfitted with the kind of warning that ended up on cigarette packages: photography kills? That seems too extreme. Yet in a society of shared digital spectacles, photographs have gained travel the world in seconds, at any moment. For that reason, some professional photographers who have seen their work leaked on the web have begun to require everyone attending a shoot to cover up their smartphones: not with a warning “photography kills,” but with a blue sticker covering the back and the lens. This ban recalls not only Westermeier’s childhood but also Hito Steyerl’s video from the last Venice Biennale with tips on How Not to be Seen (2013). And the medium is harder to grasp figuratively, in legislation or critical theory. The term “cloud” naturalizes data clusters while raising them high above national borders and laws, just like the weather. As for theory, the classics from the analog era by Berger, Roland Barthes or Susan Sontag assume that photographs could stay relatively put, whether as prints, postcards 134 or magazine spreads, despite their circulation and recombination. But again, that was a mere trickle compared to today’s flood. Ariella Azoulay’s book The Civil Contract of Photography (2008) and Steyerl’s essay “In Defense of the Poor Image” (2009), though vastly different, have placed a refreshingly new political-ethical focus on the photograph’s life in circulation, not just on the fixed content of any one photograph, either alone or alongside others. I have attempted to make a contribution in various essays: about the death of analog; how circulating photographs produce narratives in their wake with each person who sees them; and how photographs are no longer likenesses, linked to a past origin, but actions, to be instantly clicked away into endless future itineraries. Yet I still return to the analog Guibert, who examined aspects of photography beyond the actual image and who gave photography an organic existence, linked not just to Oedipal desire but also to every element of life. His theory often fell somewhere between psychoanalysis and technology, perhaps a psychobiopolitics or a psycho-biotechnology. Whatever writer one prefers, it’s clear that all of these theoretical approaches are simply not interdisciplinary enough to grasp the current omnipresence of the medium. As the term “selfie” implies, our selves are inseparable from our selfportraits. Photography has come to envelop us and our lives, precisely like a cloud, perhaps like a cloud descended to become fog: something we see but cannot grasp, something we breathe. As for Westermeier, his shift from collecting photographs to taking his own seems to be a permanent one. “With the series taken in my studio, I rediscovered what it means to take your own image. I think in a time of Tumblr and reblogging, it is important to make your own images again. There are millions of images around us, but what does it mean? It’s very easy to become an (image) archivist, but that’s not the job of an artist.” While Westermeier has no plans to do self-portraits, it comes as no surprise that he has moved from Amsterdam to Istanbul, whose history has also known image bans. “Yet photography is very present and has always been used to document the metamorphoses of the city. I am more interested in the old history, like the Islamic floral ornaments in the mosques from the time of iconoclasm. And it seems to be very popular to take selfies in front of them today.” Above - Christoph Westermeier, Research from the series “Studioline”, 2013. Courtesy: the artist and Galerie Max Mayer, Düsseldorf Opposite - Christoph Westermeier, Marble etc. from the series “Studioline”, 2013. Courtesy: the artist and Galerie Max Mayer, Düsseldorf 135 The Man Without Photographs di Jennifer Allen La fotografia è diventata ormai un contenitore delle nostre vite e della nostra identità – connaturata e organica. A ogni nuovo scatto la nostra essenza più profonda si dirige inesorabilmente verso l’immagine dei nostri selfies. Le ricadute psico-bio-politiche sono evidenti. Ma non è stato sempre così. Nel pervenire a queste ed altre considerazioni, Jennifer Allen analizza l’opera di Christoph Westermeier, un giovane artista che lavora, abbastanza comprensibilmente, con la fotografia, e il cui album d’infanzia è vuoto: i genitori, seguaci di Heinz Buddemeier – per il quale le fotografie alterano e falsificano il ricordo delle nostre esperienze – non hanno mai scattato un’immagine del loro figlio. Quest’uomo non sembra poi così strano. Mentalmente faccio un gioco: e se avessi saputo tutto questo prima di incontrarlo? E se non l’avessi mai scoperto? Certo, una volta che l’hai saputo, diventa praticamente impossibile cancellare questo gustoso aneddoto dalla memoria, dalla tua esperienza di lui. Che cosa provo? Pietà? Invidia? È circondato da un’aura che toglie il fiato: più che l’aureola degli angeli e dei santi, un punto interrogativo che fluttua e a un tratto si ferma. Un vicolo cieco. “Impossibile proseguire…” mi dico mentre cerco di abituarmi all’idea di conoscere l’uomo senza fotografie. L’artista privo di un passato d’immagini. Christoph Westermeier è nato nel 1984 a Colonia. Eppure né la sua nascita, né gli altri momenti chiave della sua infanzia sono documentati da fotografie. Nessun primo o secondo giorno di scuola, nessun primo taglio di capelli, nessuna candelina numerata da uno a diciotto, spente su altrettante torte di compleanno. Nessuna lotta nel fango, nessun castello di sabbia, nessuna cena con il parentado al completo, nessuna di quelle scenette folli che spesso accompagnano le riunioni di famiglia. I genitori di Westermeier, dopo aver letto il manifesto di Heinz Buddemeier Das Foto. Geschichte und Theorie der Fotografie als Grundlage eines neuen Urteils (La fotografia. Storia e teoria della fotografia come base di un nuovo giudizio, inedito in Italia N.d.T.) decisero che non avrebbero mai fotografato i loro bambini. Il nuovo, lapidario giudizio a cui perveniva Buddemeier nel suo saggio, oggi non più in auge, era che le fotografie non solo sostituivano, ma addirittura alteravano e falsificavano il ricordo delle nostre esperienze. I genitori di Westermeier la pensavano esattamente allo stesso modo. Solo la nonna era autorizzata a scattare di tanto in tanto una fotografia ai nipotini. “Ho ancora nelle orecchie la voce di mio padre che dice ‘non devi ricordare le fotografie – devi ricordare il momento’” chiosa Westermeier. Non è poi così sorprendente che la scelta dell’artista, in seguito, sia caduta proprio sulla fotografia come medium artistico prediletto. I primi progetti combinavano fotografie e riproduzioni di varia natura, dalle cartoline ai libri di storia dell’arte; infine Westermeier si è messo dietro l’obiettivo per scattare le sue fotografie. Sono davvero notevoli: più che fotografie sono doppi di spazi fisici, appiattiti e assottigliati. È come se la fotografia fosse un libro pop-up per bambini: crea l’illusione di un ampio spazio tridimensionale abitabile, per poi rimangiarsi l’invito a entrare. Per quanto apparentemente realistiche, le immagini “distorte” che popolano le sue fotografie evocano una dimensione fantastica simile a quella delle illustrazioni dei libri per l’infanzia che oscillano spesso tra realismo e invenzione. La sua serie “Ways of Seeing, Ways of Aging” (2013) – ritratti fotografici di copie in gesso di sculture dell’antichità classica custodite presso la collezione dell’Università di Zurigo – pare ispirarsi, almeno nel titolo, alla trasmissione televisiva di John Berger Ways of Seeing, trasmessa dalla BBC nel 1972, che ospitava una lettura critica delle immagini di stampo marxista-femminista. Berger si proponeva di sensibilizzare lo spettatore nei confronti delle strategie messe in atto da artisti, fotografi, pubblicitari e storici dell’arte al fine di intrappolare, nel vero senso della parola, la donna. Dal canto suo, Westermeier sceglie di fotografare esclusivamente sculture maschili. Ritengo che qui l’artista voglia far riflettere su come il mito spudorato e vanesio dell’eterna giovinezza sia stato perpetrato per secoli dagli uomini mediante queste sculture e le loro copie. Nessuna ruga, tutt’al più un pizzico di polvere di gesso. Westermeier riesce a rendere tangibile una dimensione del tempo e dello spazio che trascende la storia antica evocata dalle stesse sculture e l’immediatezza del rapido ammiccamento dell’otturatore. Uno spazio-tempo alternativo che risiede nella materialità, nella riproduzione e nella composizione della fotografia. Pur essendo digitali, le fotografie non sono state alterate con Photoshop. Con l’ausilio di una stampante a getto d’inchiostro, l’artista ha riprodotto più volte il medesimo soggetto su uno stesso foglio di carta, in maniera leggermente sfasata, alterando la nostra percezione della profondità nella fotografia. Il fatto che, per un caso, la cartuccia d’inchiostro fosse quasi esaurita, fa sì che ogni stampa abbia una propria palette di colori assolutamente arbitraria. Il pallido biancore delle sculture si macchia di colori traslucidi che illuminano le immagini nella maniera caotica in cui l’aurora boreale ridisegna il cielo della notte nordica senza alterare la posizione di una singola stella nell’universo: un’altra profondità, un bagliore cangiante, vivo. Westermeier ha scelto di esporre la serie in due gruppi contigui, ognuno dei quali inserito in un’ampia cornice sospesa che consente allo spettatore di contemplare le immagini come se fossero sculture, muovendosi attorno a esse. Invece di restituirci un istante raggelato, l’artista conferisce al processo di stampa una memoria, una visione confusa e sfocata del tempo nel suo divenire, e la suggestione cinematografica di un “flip book”, un libretto a disegni animati stampato però su di una singola pagina. Ecco che, invece di offrire la copia perfetta di un passato negando il trascorrere del tempo, l’artista pervade ogni copia di un tremito, di un ambiguo vedo-non vedo, come se le sculture stessero cercando di ricordare quale fosse il loro aspetto originario. Come se quei soggetti fossero davvero uomini centenari che scandagliano l’archivio della loro memoria in un continuo oscillare tra bianco e nero e il vivo colore, incerti tra il ricordo di fotografie e il ricordo di momenti vissuti. La serie di Westermeier “Studioline” (2013) ha per oggetto lo spazio in cui ha lavorato al De Ateliers di Amsterdam: la scorsa primavera si è concluso un periodo di residenza di due anni in questa struttura. Queste fotografie sono sempre notevoli per il senso di spazio che riescono a cogliere e a restituire – uno spazio reale e illusorio al tempo stesso – ma non vengono distorte nel processo di stampa. Si tratta di semplici scatti realizzati con una macchina fotografica analogica – non è stato fatto alcun ricorso a Photoshop. L’artista ha impiegato il sole come una sorta di maldestro addetto luci per illuminare svariate superfici: divani, tavoli, giornali, molti libri, sia aperti che chiusi, un solitario balsamo per labbra, un pezzo di cellophane trasparente bordato da un sottile filo dorato, forse un frammento dell’involucro di un pacchetto di sigarette o di una gomma da cancellare, alcune sottili lastre di marmo. Le fotografie paiono sovraesposte, risultano in un certo senso accecanti. Le parole stampate sui libri sono slavate, quasi indistinguibili, a eccezione dei titoli a caratteri cubitali come il significativo “Kunstliteratur und Reproduktion” in Studioline-Research. Oltre a creare profonde ombre intorno agli oggetti, il sole proietta riflessi abbacinanti sulle superfici, chiazze di luce dal biancore accecante e baluginii cristallini. Osservate da lontano, queste immagini somigliano a collage di strani ritagli di forma geometrica; avvicinandosi, paiono trasformarsi in documentazioni fotografiche di qualche scultura minimalista d’altri tempi. Lungi dall’essere forme aeree e vacanti, le ombre sembrano possedere un volume, simili a pesanti, squadrati blocchi neri. In Studioline-Marble etc. – un tavolo e l’angolo di un divano imbottito con una coperta – le ombre proiettate dalle gambe del tavolo sono così scure, così dense e voluminose che sembrano prendere il sopravvento sulle gambe stesse. Gli sfondi in ombra e le superfici inondate di sole sembrano quasi scambiarsi di posto; più che una fotografia, un’illusione ottica. Ancora in Studioline-Research: la superficie di una lastra di marmo, macchiata da caffè (sono visibili gli anelli di ciò che potrebbe essere la base di una tazza) e da altri liquidi, riflette il sole come uno specchio. La copertina plastificata di un libro è attraversata da una lunga linea di luce che descrive un arco mentre rivela piccole intaccature nella copertina e l’alone appiccicoso, opaco, di un’etichetta del prezzo precedentemente rimossa. La stessa luce del sole che colpisce un giornale a distanza, rivela le increspature della carta, le pieghe e tracce d’uso che indicano che è stato maneggiato e letto, l’accenno di un’orecchia all’angolo del foglio. Queste fotografie, pur essendo al limite della sovraesposizione, mantengono un alto grado di definizione: un’unghia sul pavimento, un 136 graffio sul tavolo, una strana sostanza appiccicosa, pezzi informi, macchie, qua e là. Gli oggetti, slavati dalla luce abbacinante, recano comunque ben in evidenza sulla loro superficie, i piccoli difetti che ne attestano lo stare al mondo – ricordano le persone che prendono il sole sulla spiaggia, d’inverno, nei paesi nordici: corpi di un biancore accecante, eppure ben visibili alla luce cruda: le piccole grinze della pelle, le cicatrici, la pancetta, retaggio del periodo vacanziero. A dispetto di questi dettagli, la serie sembra documentare non tanto gli oggetti, ma il loro contatto col sole. L’opera descrive la relazione tra il sole e lo studio, non lo studio stesso, e nemmeno gli oggetti eterogenei che lo popolano: descrive ciò che solamente il sole può creare, rivelare all’occhio attento, in determinate ore del giorno. Per l’obiettivo di una macchina fotografica, effettivamente, il sole è un po’ come la testa di Medusa; uno sguardo diretto, se non pietrifica la macchina fotografica, comunque acceca la pellicola, sbianca e dilava le immagini, cancella la memoria fotografica. La scelta di Westermeier del medium della fotografia – proibito dai suoi genitori – potrebbe essere appesantito dal bagaglio edipico che affligge la maggior parte di noi con il suo carico di nevrosi. Viene da pensare a Hervé Guibert, compianto scrittore-fotografo, e al suo ritratto della madre descritto nella sua immaginifica autobiografia L’Image fantôme (1981), che condivide l’anno di pubblicazione del trattato di Buddemeier, ma affronta tutt’altro genere di perversioni inerenti alla fotografia e alla memoria. Guibert ha appena finito di sabotare il look creato da sua madre per compiacere il padre che non consente alla moglie di tingersi i capelli, e nemmeno di truccarsi. Guibert le mette la testa sotto il rubinetto, le liscia i capelli permanentati, li lascia bagnati, aggiunge un tocco di cipria e sceglie i vestiti che deve indossare: un tailleur bianco, una vergine del business. Colpo di scena: la pellicola non contiene immagini. All’inizio Guibert sospetta che suo padre, incaricato di sviluppare il rullino analogico, abbia a sua volta sabotato la determinazione del figlio di catturare la madre nel modo in cui il giovane vuole vederla. Una battaglia edipica tra padre e figlio per decidere quale aspetto fisico dovrebbe avere la madre e chi dovrebbe compiacere. Si scopre invece che è stato lo stesso Guibert a non agganciare correttamente il rullino ai denti del rocchetto della macchina fotografica: la pellicola, dunque, è rimasta incapsulata nel suo astuccio metallico. In questa psicopatologia tecnologica della vita quotidiana, la macchina fotografica incita all’incesto rafforzando al tempo stesso il tabù che lo circonda. Guibert impone alla madre di posare assecondando il suo desiderio estetico, ma non permane alcun documento di questo scambio di sguardi. La storia ci ricorda che la fotografia, da molto tempo ormai, è divenuta un affare di famiglia, se non un parente prossimo a tutti gli effetti. Perché mai la macchina fotografica e le fotografie non avrebbero dovuto farsi carico delle psicodinamiche familiari? A differenza di Guibert, Westermeier sembra a proprio agio con le sue scelte e con quelle dei suoi genitori, che includevano una educazione esclusiva per i figli, fondata sull’antroposofia di Rudolf Steiner e sulle sue pregnanti teorie sulla percezione. “I miei genitori cercavano di vivere una vita diversa da quella della loro infanzia”, afferma l’artista. “Era il periodo immediatamente successivo alle rivoluzioni del 1968; la gente aveva perso la fede nella possibilità di cambiare la società, ma credeva ancora fermamente nella possibilità di cambiare il proprio mondo. Dopo il matrimonio, mio padre adottò il cognome di mia madre. Lei lavorava, lui stava a casa. Il ‘divieto’ non era il frutto di una convinzione bigotta. Mio padre, soprattutto, nutriva un profondo amore per la storia dell’arte, e la casa dei miei genitori era piena di stampe e di opere d’arte. Nei giorni di festa esponevamo cartoline – riproduzioni delle opere del Beato Angelico, di Raffaello, del Rinascimento italiano, impressionisti, espressionisti – e le cambiavamo a ogni stagione. Non era una casa senza immagini, era una casa senza fotografie”. Ovviamente, con la nostra abitudine di condividere fotografie digitali, non solo viviamo in case piene di fotografie, ma in un certo senso viviamo nella fotografia come nessun’altra compagine sociale prima di noi. Persino la storia recente impallidisce al confronto. Basti pensare all’opera di Carsten Höller e di Miriam Bäckström per il Padiglione dei paesi nordici alla Cinquantunesima Biennale di Venezia nel 2005, All Images of an Anonymous Person (2005): un progetto che raccoglieva in un singolo libro tutte le fotografie scattate a una donna relativamente giovane. Fare la stessa cosa ai giorni nostri richiederebbe una serie infinita di volumi, e sono passati meno di dieci anni. Westermeier è una mosca bianca tra i suoi coetanei muniti di account facebook. Si sarebbe sentito a proprio agio in qualsiasi epoca antecedente il 1830, anno in cui la fotografia cominciò a mutare da esperimento scientifico a tecnica dall’enorme potenziale di fenomeno di massa. Come osserva Buddemeier, dopo che il governo francese acquistò il brevetto dall’inventore Louis Daguerre per mettere a frutto la nuova tecnica in diversi ambiti, la prima dimostrazione pubblica a Parigi nell’agosto del 1839 richiamò folle di spettatori, dando vita a un fenomeno ribattezzato in seguito “La Dageurrotypomanie” (dagherrotipomania). Westermeier ha la facoltà di rievocare la sua infanzia come facevano Daguerre, il Beato Angelico, Raffaello e persino Gesù, anche se con retroterra diversi. “Non sono arrabbiato con i miei genitori”, dice l’artista, “in realtà sono felice. Viviamo in una società che si nutre di fotografia. Tutti fotografano tutto in qualunque momento. Non ci fermiamo a pensare – ci limitiamo a premere il pulsante e a mettere le foto nel cloud. Anche io lo faccio, ma non lo do per scontato. È ancora qualcosa di speciale e, a voler essere onesti fino in fondo, continuo a fidarmi più della mia memoria, che non di una fotografia”. Eppure, un uomo senza fotografie è un uomo senza qualità. È difficile immaginare di esistere senza avere un album di famiglia da condividere, online o in altro modo. È come se il disco fisso di Westermeier fosse stato formattato, il suo cloud svuotato o la sua password violata. Più intrigante della decisione di vietare la fotografia, è la natura politica della scelta dei suoi genitori. Paradossalmente furono ispirati dai fallimenti sessantottini che portarono molte persone a riversare il proprio attivismo politico, invece che nella sfera pubblica e collettiva, in un ambito privato, tutt’al più condiviso dai membri della propria famiglia. In Francia, l’ascesa che la psicoanalisi conobbe negli anni ’70 ebbe una simile matrice: gli intellettuali si misero in analisi o diventarono analisti. Ma ciò che ai tempi deve essere sembrato come un ritiro dalla vita politica, la proclamazione di una sconfitta, oggi ritrova una rinnovata urgenza politica – il confine tra sfera pubblica e sfera privata è tutto tranne che scomparso con l’avvento delle tecnologie digitali. Basti pensare al modo in cui la vita privata è volontariamente condivisa in pubblico su Instagram. Oppure alle segrete intrusioni dell’NSA e di altri organismi di controllo governativi nella nostra quotidianità digitale. Ormai non ha più alcun senso parlare di “pubblico” e “privato”. Dov’è il confine? Come tracciare un limite, farlo rispettare, e regolamentarlo sul piano legislativo? Vecchi slogan come “Il personale è politico” dai tempi del femminismo hanno acquisito una rinnovata urgenza. Eppure questo slogan dà per scontata una distinzione che viene costantemente, volontariamente o segretamente che sia, cancellata e violata. Le rivelazioni di Edward Snowden ci fanno finalmente comprendere quanto incommensurabilmente e imprevedibilmente politiche siano diventate le nostre vite private sotto i nostri polpastrelli, al tocco dei nostri touch screen. In un certo senso, bandendo le fotografie dalla vita dei figli, i genitori di Westermeier stavano anticipando un provvedimento futuro, che ora, nel nostro presente, appare quanto mai necessario, soprattutto in un’ottica di salvaguardia dei giovanissimi. Basti pensare alla diffusione virale della pedo-pornografia o del bullismo online e i suoi effetti fatali su quegli adolescenti che sono stati indotti al suicido dalla pubblicazione in rete di una fotografia compromettente. È possibile immaginare un futuro alternativo, quando i colossi del digitale saranno messi sotto accusa per avere creato una tecnologia pericolosa, proprio come le aziende produttrici di sigarette sono state, alla fine, accusate di avere nascosto ai consumatori i rischi derivanti dal consumo di nicotina, lucrando a spese della loro salute? Forse un giorno sugli smartphone andrà stampato l’avviso che ha finito per essere apposto sui pacchetti di sigarette: “la fotografia uccide”? Ora come ora parrebbe un’esagerazione. Eppure in una società di spettacoli digitali condivisi, le fotografie hanno acquisito un’analoga dimensione “biopolitica” – una connessione alle nostre vite e alla politica: perché nessuno può immaginare una vita senza immagini, perché l’idea di un’infanzia come quella di Westermeier ci turba tanto quanto l’idea di perdere il nostro archivio digitale a causa di un’improvvisa “perturbazione” nel cloud che accidentalmente disperda immagini e pixel come le gocce di pioggia che si dileguano nei canali di scolo o evaporano sul marciapiede. A dispetto della sua onnipotenza, la fotografia è un medium che diventa sempre più inafferrabile, giorno dopo giorno. Letteralmente. “Non esiste più come oggetto fisico,” dice Westermeier, “è tutto nel cloud!” Dato che l’immagine digitale non può mai essere isolata come un oggetto, la stampa non è diventata altro che una fermata temporanea in un viaggio che può essere infinito e si propaga nel mondo in pochi secondi, continuamente. Per questa ragione, alcuni fotografi professionisti che hanno visto il proprio lavoro diffuso indebitamente sul web hanno iniziato a richiedere alle persone presenti, quando scattano le loro fotografie, di coprire i propri smartphone: non con l’avvertimento “La fotografia uccide” ma con un adesivo azzurro che copre il retro del telefonino e oscura l’obiettivo. Questo divieto ricorda non solo l’infanzia di Westermeier, ma anche il video di Hito Steyerl dall’ultima Biennale di Venezia e i suoi suggerimenti su come rendersi invisibili raccolti sotto il titolo How Not to Be Seen (2013). Ed è ancora più difficile inquadrare metaforicamente la fotografia in una griglia legislativa o teorica. Il termine “cloud”, la nuvola, naturalizza cluster di dati innalzandoli ben al di sopra dei confini e delle leggi nazionali, proprio come ora accade per le perturbazioni meteorologiche. Sotto il profilo teorico, i classici dell’era analogica firmati da Berger, Roland Barthes e Susan Sontag muovono dall’assunto che le fotografie siano entità statiche, come stampe, cartoline o riproduzioni sulle riviste, a dispetto della loro circolazione e ubiquità. Solo che quello non era che uno stillicidio, a confronto del diluvio a cui assistiamo adesso. Il libro di Ariella Azoulay The Civil Contract of Photography (2008) e il saggio di Steyerl “In Defense of the Poor Image” (2009) – pur con sfumature diverse – hanno portato alla rivitalizzazione dell’attenzione etico-politica sulla circolazione di ciascuna foto, e non solo sul suo contenuto statico, individuale o in quanto parte di un gruppo. Io stessa ho contribuito al dibattito in molti saggi, scrivendo della morte dell’analogico, del modo in cui le fotografie, circolando, risveglino narrazioni inedite entrando in risonanza con le persone che le vedono, di come le fotografie non siano più copie o ritratti legati a un’origine passata, ma azioni, istantaneamente avviate con un “click” verso infinite rotte future. Ma torniamo alla dimensione analogica di Guibert e alla sua analisi di aspetti della fotografia che esulano dall’immagine vera e propria e che ha conferito alla fotografia un’esistenza organica, connessa non solo al desiderio edipico, ma a ogni elemento vitale. Questa teoria ha avuto ricadute sia nel campo della psicoanalisi sia in quello tecnologico: a metà tra “psico-biopolitica” e “psico-biotecnologia”. A prescindere da quale sia il proprio scrittore preferito, è chiaro che nessuno di questi approcci teorici è abbastanza interdisciplinare da contenere l’attuale onnipresenza del medium in tutta la sua complessità. Come implica il termine “selfie” (autoscatto), noi stessi (ourselves) siamo inscindibili dai nostri autoritratti (self portraits). La fotografia è si è fatta contenitore delle nostre vite e della nostra identità, proprio come una nuvola bassa si trasforma in una sorta di nebbia: qualcosa che vediamo ma che non possiamo afferrare, in cui inspiriamo ed espiriamo. Come per Westermeier, questo passaggio dal collezionare fotografie altrui allo scattare da sé le proprie fotografie sembra essere permanente. “Con le fotografie scattate nel mio studio ho scoperto ciò che significa catturare la nostra immagine. Credo che al tempo di Tumblr e dei blog sia importante tornare a scattare le proprie immagini. Ci sono milioni di immagini intorno a noi, ma che vuol dire? È molto facile trasformarsi in archivisti (di immagini), ma non è questo il compito dell’artista”. Anche se Westermeier non ha in programma di realizzare autoritratti, non sorprende che si sia trasferito da Amsterdam a Istanbul, una metropoli la cui storia ha conosciuto anche episodi di iconoclastia. “Eppure la fotografia è molto presente ed è sempre stata usata per documentare le metamorfosi della città. Sono più interessato alla storia antica, come gli ornamenti floreali islamici nelle moschee al tempo dell’iconoclastia. E sembra proprio che sia di moda realizzare autoscatti di fronte a essi.” 137
Scaricare