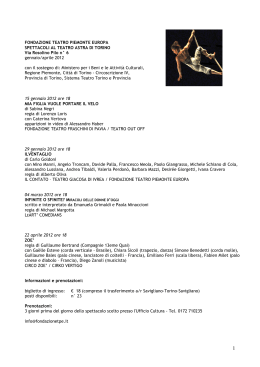42 — cantiere regia Cantiere Regia: un’appendice d’eccezione P ubblichiamo ora tre nuovi importanti interventi sul tema della regia nel teatro musicale, per mantenere vivo il dibattito con la speranza che molti altri protagonisti vogliano, nel futuro, dare la propria opinione su uno dei temi più rilevanti per la scena musicale contemporanea. Guido Barbieri cantiere regia Leggo e rileggo la domanda, una, due, dieci volte. E non riesco a formulare nessuna riposta coerente, argomentata, precisa. Provo uno strano disagio e non capisco perché. Mi dico che nessuno ha il diritto di fare i conti in tasca a un regista, di teatro, di cinema, d’opera o di cortometraggi che sia. Sarebbe come dire a un poeta, a un pittore, a un architetto: «Questi sono gli “elementi essenziali e irrinunciabili” che devi mettere dentro le tue poesie, dentro tuoi quadri, dentro i tuoi progetti». Ma saranno fatti nostri, risponderebbe, e con qualche ragione, il coro degli artisti. Mi ripeto nella testa l’osservazione sin troppo banale e scontata secondo la quale l’esercizio della critica o (ad essere ancora più ambiziosi) della riflessione estetica non può mai essere prescrittivo. Non puoi certo stilare tu (io…) le «norme per la corretta regia d’opera»: neanche uno fosse Zdanov, Galeazzo Ciano, Goebbels o un membro della Commissione McCarthy… Allora mi viene il sospetto che ci sia qualche cosa che non va, qualche cosa di poco chiaro, non tanto nella definizione di «lavoro registico», E qui si apre un vero baratro: chiunque possieda un minimo di consuetudine con i teatri di casa nostra (fondazioni liriche o teatri di tradizione, cambia poco) non può non notare alcuni ricorrenti «orrori»: cantanti privi della benché minima consapevolezza del rapporto con lo spazio scenico, gesti individuali ovvi, ripetitivi e convenzionali, movimenti di massa (cori, figuranti, danzatori) consegnati alle più ovvie regole «fisiche» dello spostamento dei corpi: il coro entra e canta, il coro finisce di cantare ed esce (di solito metà a destra e metà a sinistra…). È il segno più evidente che, nella grande maggioranza dei casi (le eccezioni ovviamente esistono…) i registi d’opera non compiono (non vogliono, non possono compiere…) alcun autentico lavoro di regia, ma si limitano a rappresentare, in modo più o meno «fedele», le indicazioni scenografiche e ambientali suggerite dal libretto. Trascurando il più delle volte il più elementare «uovo di colombo»: nell’opera (cosiddetta) lirica il testo non è un testo scritto bensì un testo cantato (ovvio no?) e dunque il gesto, il movimento, l’uso della voce sono continuamente suggeriti, se non imposti, non tanto dalla scrittura poetica, quanto dalla scrittura vocale. Se non si cerca nel canto la sorgente del movimento scenico, individuale o collettivo che sia, non si compie un autentico lavoro di regia, ma tuttalpiù un onesto lavoro di decorazione teatrale. Se dovessi dunque azzardare una risposta alla domanda iniziale potrei dire che il teatro d’opera, oggi, ha il bisogno vitale di affidarsi, come mai è accaduto nell’ultimo secolo, ad un lavoro di regia che sappia analizzare il testo musicale in tutte le sue componenti drammaturgiche, imprimere sulla sostanza testuale la rete di una interpretazione testuale rigorosa e coltivare con consapevolezza e sistematicità le risorse attoriali degli interpreti. Il metodo vale indifferentemente, come è ovvio, per il teatro d’opera classico come per il teatro d’opera contemporaneo, al di là delle evidenti difficoltà di definire, oggi, quanto nella definizione stessa di «regista». Siamo proprio sicuri di sapere perfettamente chi sia un (o il) regista? Quale sia il suo mestiere, quali siano i suoi strumenti di lavoro e che cosa ci si debba aspettare da lui? Tra gli spettatori abituali dei teatri d’opera, ma anche tra molti «addetti ai lavori», circolano spesso alcune espressioni totalmente prive di senso come «regia d’epoca» o «regia di avanguardia» o, peggio ancora, «regia attuale». Di solito l’etichetta «regia d’epoca» la si appiccica addosso ai registi che ambientano l’opera nei tempi e nei luoghi prescritti dal libretto, mentre i registi di avanguardia o «attuali» sarebbero quelli che trasportano nel presente o nel futuro prossimo i personaggi e le loro (più o meno tragiche) vicende. Si tratta, con tutta evidenza, di un equivoco madornale, che richiama irresistibilmente la faccenda proverbiale dei fischi e dei fiaschi: si dice «regia», ma in realtà si ha in mente, o negli occhi, una cosa, o un insieme di cose, del tutto differenti: vale a dire la scenografia, i costumi, le luci, tutti gli elementi teatrali cioè che costituiscono la cornice dentro la quale si svolge il lavoro di regia. Nessuna malafede, per carità, nel malinteso. Il fatto è che nell’universo del teatro d’opera italiano, sia dalla parte di chi lo fa che dalla parte di chi lo giudica, il legame con la tradizione del teatro europeo (da Mejerchol’d a Peter Brook, tanto per disegnare due stelle polari) si è spezzato, se mai è esistito, da tempo immemorabile. E poi molti dei cosiddetti «registi d’opera» più accreditati e scritturati (fuori i nomi? Pizzi e Zeffirelli, tanto per dirne due) sono in realtà scenografi che svolgono «anche», più o meno impropriamente, le funzioni del regista. Il lavoro di regia, forse è bene richiamarlo alla mente, riguarda essenzialmente due elementi distinti della drammaturgia: il testo e l’attore. Al regista, nella prassi teatrale condivisa del Novecento, spetta innanzitutto il compito di interpretare il testo attraverso gli strumenti della tecnica attoriale: la voce, il gesto, il movimento. Il carattere della scena (che è costituito dalla scenografia, dalla scenotecnica. dalla illuminotecnica…) è progettato, generalmente, in funzione dell’interpretazione del testo. che cosa sia e che cosa non sia «opera», o teatro musicale, nelle infinite galassie delle forme musicali di carattere rappresentativo. Il «corpo» dell’attore e le sue formidabili potenzialità simboliche non conosce la differenza tra l’opera del passato e l’opera del presente, tra il melodramma dell’Ottocento e l’azione scenica del Novecento, per la semplice ragione che il lavoro di regia, applicato all’hic et nunc della rappresentazione, non può essere né d’epoca, né attuale, ma solo necessariamente, inevitabilmente «contemporaneo». Quirino Principe Qualcosa di ragionevole, ovvero della regìa Non voglio coprirmi di ridicolo dettando precetti o comandamenti sulla regìa nel teatro d’opera, ma nessuno può impedirmi di suggerire qualcosa di ragionevole. Di solito, gli enunciati ragionevoli mantengono un basso profilo, corrono lungo un’aurea via di mezzo, danno un colpo al cerchio e un altro alla botte. In definitiva, si notano poco, si confondono con altri, non suscitano contrasti. Temo che queste circostanze non coincidano con le mie (intenzionalmente) ragionevolissime considerazioni, che smentiscono l’assoluta ritualità di un tabu oggi radicato. Ecco la prima riflessione. L’epoca in cui nacque il teatro d’opera, il tardo secolo XVI, non è la stessa in cui si era sviluppato il dramma ellenico (che pure dal nascente teatro d’opera e dalla fiorentina Camerata de’ Bardi fu assunto a modello), partendo dall’Atene dei tempi di Pisistrato e dagli esordi leggendari con l’Alkestis di Tespi, e culminando con la celeberrima triade unica sopravvissuta nelle scritture (Eschilo, Sofocle, Euripide). Nell’antico dramma attico, l’indicazione dell’arredo scenico è assente dal testo vero e proprio delle tragedie e commedie e farse satiresche, e può essere ricostruita da segnali fuggevo- cantiere regia — 43 na da Iliona, la musica cupa e suggestiva di cui parla Cicerone era evidentemente più un’aggiunta registica (appunto!) che non un elemento organico e stabile e addirittura primario di un determinato genere teatrale, ciò che la musica è, invece, nel teatro d’opera. In quest’ultimo, a partire dalla Camerata de’ Bardi e dal fatale 1599, la regìa ci si presenta con caratteri del tutto diversi: tra l’opera barocca e il tardo romanticismo o post-romanticismo o «impressionismo», ossia tra Dafne di Giulio Caccini e Jacopo Peri e Capriccio di Richard Strauss, la regìa si sposa organicamente alla scenografia, alla scenotecnica, all’illuminotecnica e ai costumi. Motivo fondamentale per cui noi non sopportiamo né più dovremmo sopportare le regìe ipocritamente «povere» ed «essenziali» (si abbia il coraggio di dirlo finalmente, lo si confessi ad alta voce, che tali scelte non sono dettate da ragioni artistiche e stilistiche, bensì da penuria di mezzi finanziari e dal terrore che incute la Corte dei Conti, oggi vero Direttore-Artistico-Leviathan dei teatri d’opera!!!), è un ineliminabile fattore culturale: la regìa di tipo «simbolico» (nei rari casi in cui essa sia scelta senza ipocrisia ma per velleità “artistica”) o «povero» (nella maggioranza dei casi in cui essa è il prodotto di servilismo e rassegnata resa a chi vuole umiliare e cancellare il teatro d’opera!) è a priori smentita dal testo e dalla musica stessa del grande lascito operistico occidentale (si guardi alla Cina d’oggi, a quanto quello Stato – per altri versi, sgradevolissimo – spende per il teatro d’opera, e con quanta cura, con quanta passione!), dalle esplicite didascalie dei libretti, ma, lo ripeto e ribadisco, dai contorni e dalla fisionomia della musica d’opera. L’uso che Verdi fa delle scale orientali in Aida e Saint-Saëns in Samson et Dalila esige una scenografia intelligentemente faraonica e monumentale… purché non sia proprio quella in stile «Baci Perugina» di Zeffirelli! Parsifal deve tassa- sodio di vita teatrale, a noi riferito dalla preziosissima notizia di Porfirione ripresa da Orazio, l’attore Fufio, interprete di Iliona, era giunto all’ora dello spettacolo dopo avere bevuto vino in abbondanza. Sdraiatosi sul giaciglio, come da prescrizione scenica implicita nel testo, si era addormentato, essendo ubriaco, e non si era destato neppure al richiamo dell’attore Catieno, che copriva il ruolo dello spettro di Deifilo. Invano Catieno reiterò il richiamo. Allora, i circa 1200 spettatori, sghignazzando, cominciarono a gridare (con la «voce di 1200 Catieni», scrive Orazio): «Mater, te appello!» Ancora Orazio riferisce (Sermones, I, 5, 53-68) una finta o improvvisata «baruffa» tra Messio Cicirro e Sarmento: la scena da una fabula atellana, e anche qui non mancano allusioni a un preventivo lavoro di regìa. Quel tanto di lavoro registico che riusciamo a indovinare a proposito di una tragedia antica come Iliona di Pacuvio suggerisce indubbiamente un sistema di segni puramente simbolici (com’è proprio dell’antico teatro ellenico, ellenistico e romano): spazi, dimensioni geometriche, collocazioni prossemiche. Quel sistema, talora, può essere arricchito e per così dire «violato» da essenziali elementi di «realismo»: per esempio, il giaciglio su cui dorme Iliona, oppure un’oggettistica teatrale costituita da spade, torce, rotoli di pergamena, clave come quella di Eracle in Alkestis di Euripide. La musica lugubre descritta da Cicerone a proposito della tragedia di Pacuvio ci offre un’indicazione da brivido: sembra davvero che la tragedia antica sia presaga di ciò che, duemila anni dopo, a partire da Caccini, Peri, Monteverdi, la assumerà a modello e, quasi, a immagine sacra…, anche perché conosciamo l’esistenza di musiche in altri drammi ellenici e romani, come il famoso Terzo Stasimo dell’Orestes di Euripide di cui possediamo la notazione musicale. Tuttavia, se ritorniamo alla citata scena pacuvia- tivamente svolgersi in un riconoscibile tempio-monastero medievale immerso in una riconoscibile foresta, o in un riconoscibile giardino di delizie racchiuso in un riconoscibile Château-Merveille e popolato di riconoscibili maliarde e «jeunes filles en fleur». La vera croce e la vera spina della regìa operistica d’oggi è la sesquipedale ignoranza (letteraria, filosofica, pittorica, matematica, astronomica, antropologica…) della stragrande maggioranza dei registi, tanto più sprezzantemente ruspanti e analfabeti e «rustica progenies» quanto più esigenti e pretenziosi e quanto meglio pagati. Un esempio: un regista che metta in scena Tannhäuser di Wagner deve conoscere la biografia e la poesia di Wolfram von Eschenbach e di Biterolf e di Reinmar von Zweter e di Heinrich der Schreiber, deve saper leggere e capire i testi in «mittelhochdeutsch», percorrere a menadito la storia e la geografia della Turingia, ed avere visitato la Wartburg. Altrimenti, è meglio che cambi mestiere, e si volga a professioni ugualmente onorevoli come il cancelliere di tribunale, l’idraulico, la guardia di finanza, l’impiegato dell’Agenzia delle Entrate. Il mondo è grande, avanti c’è posto. Gli altri, infiniti esempi, li lascio ai lettori: se ne trovano a bizzeffe, anche procedendo a moscacieca. cantiere regia li, impliciti nelle battute del dialogo o, più raramente, negli interventi del coro: talvolta, da annotazioni descrittive di scoliasti e commentatori (Aristotele, l’anonimo del Sublime, la Suda…). Quanto alla regia, riusciamo a fare una miglior figura dichiarando, senza mezzi termini, che non sappiamo di quale natura fosse. Ma certamente, esisteva. Era, con ogni probabilità, un sistema di accorgimenti relativi alla gestualità e al movimento, fondamentalmente orale o oralmente trasmesso per eredità professionale. Talvolta, otteniamo dalle letterature antiche e pre-cristiane tracce fulminee che balzano da testi illustri, oppure da quelli piatti e noiosi ma utilissimi dei soliti biografi, commentatori e scoliasti. Orazio (Sermones, II, 3, 59-62), attingendo a uno scolio di Porfirione, narra un episodio avvenuto durante una rappresentazione della tragedia «coturnata» Iliona di Marco Pacuvio: la scena in cui il morto Deifilo, figlio di Iliona a sua volta figlia di Priamo e moglie di Polimèstore re di Tracia, appare in sogno, di notte, alla madre, per chiedere sepoltura. Iliona si sveglia dal sonno, scossa e atterrita dal tremendo richiamo del fantasma di Deifilo, «Mater, te appello, tu, quae curam somno suspensam levas, neque te mei miseret: surge et sepeli natum!». Poi il fantasma scompare lentamente. Con disperata angoscia, la madre grida all’ombra che svanisce: «Age, adsta, mane, audi…». Cicerone (Tusculanae, I, 44, 106) riferisce che l’apparizione di Deifilo era accompagnata da una musica cupa e lamentosa che diffondeva grande tristezza in tutto il teatro («…cum pressis et flebilibus modis, qui totis theatris maestitiam inferant…»). Com’è noto, nel teatro antico – fatta eccezione per il mimo nella Roma repubblicana – come in quello medievale e in quello moderno sino a dopo Shakespeare, le donne ubbidivano al divieto di recitare in teatro. I ruoli femminili erano assunti da uomini giovani o adolescenti en travesti. Nell’epi- Fabio Vacchi Musica e regia oggi Difficile sintetizzare il problema del rapporto, oggi, tra musica e regia, nell’ambito del teatro e del cinema. Sono stato interpellato per raccontare la mia esperienza personale, e così farò, cercando di trarne peraltro riflessioni di carattere più generale. ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DE CALZA «I ANTICHI» FONDATA DA ZANE COPE VENEZIA TRADIZIONE e TRASGRESSIONE La più antica, libera e originale organizzazione veneziana del divertimento. Sei un veneziano de garbo o un foresto de sesto? Iscriviti e Partecipa! Il Circolo de I Antichi in Campo San Maurizio è aperto per feste cene mostre concerti convegni conferenze presentazioni affabulazioni e deliri abbonati a «Il Ridotto» mensile via mail: è gratuito, divertente e anche intelligente Campo San Maurizio 2674 – San Marco - Venezia – 30124 ITALIA telefono 041 5234567 – e-mail: [email protected] www.iantichi.org cantiere regia — 45 rire nuove forme: lì per lì, funzionali al prodotto televisivo, ma in effetti rivelatrici di inedite potenzialità costruttive. E arrivo così a parlare del teatro musicale propriamente detto, nel quale, almeno io, personalmente, e finora, mi sono sentito in relazione piuttosto stretta e paritaria con la regia. La quale, però, nelle opere che ho composto finora, mi giungeva a sua volta filtrata e in qualche modo «deviata» dalle esigenze del libretto. Le implicazioni tra intenti musicali, registici, scenografici e testuali dà vita a una texture complessa, che ogni volta, nel momento dell’allestimento, sfugge almeno in parte alla mia determinazione. Il che, se da un lato mi disorienta, dall’altro mi costringe a una rimessa in gioco di quanto sembrava scritto in modo definito, scatenando un feed back di interazioni che spesso esula dalla composizione della singola opera, rifrangendosi sugli altri brani cui sto lavorando e addirittura sul destino delle opere successive. Forse era proprio questo che intendeva Wagner. Solo che oggi la rivoluzione tecnologica, modificando sostanzialmente sia le tecniche di stampa, riproduzione e diffusione delle musiche sia lo spettacolo dal vivo, con un evidente accrescimento del grado di interdisciplinarietà linguistica, ha portato al formarsi di una platea più vasta e diversificata rispetto al passato. Se il pubblico della musica contemporanea è infatti ancora elitario, è pur vero che, essendo sempre più socialmente differenziato – grazie ovviamente anche ad internet – si sta ponendo come filtro di eterogenee e complesse stratificazioni interculturali ed estetiche. Si tratta infatti di una platea varia, interraziale, interculturale, intergenerazionale. Ed ecco perché ritengo utile, in questo momento storico, continuare a mantenere in vita il teatro d’opera. Pur innervandolo di nuove esperienze, pur ravvivandolo attraverso ricerche linguistiche che sfrutti- altre esperienze positive in tal senso: con l’attrice Giovanna Bozzolo nell’operina radiofonica La burla universale, sempre su testo di Marcoaldi, oppure con Federica Fracassi e Annina Pedrini in Mi chiamo Roberta e in Persefone, su testi di Aldo Nove – laddove mi sono confrontato anche con la forza evocativa delle sculture di Arnaldo Pomodoro. In questi contesti, la musica, come già teorizzava Mozart, che avrebbe desiderato scrivere melologhi ma non gli venivano richiesti, deve mettersi in relazione col senso e col suono della parola. Quindi, inevitabilmente, ne deriva un’implicita regia, che viene però affidata esclusivamente al modo in cui l’attore o gli attori interpretano ciò che la musica usa della trama letteraria. È ovviamente la forma musicale a dettare le regole di questa regia, proprio all’opposto di quanto avviene nel cinema. Altra situazione in cui l’incontro-scontro tra musica e altro avviene in uno stadio intermedio di reciproca indipendenza e convergenza, è l’installazione. In questo caso – ad esempio quando una mostra di Giulio Paolini a S. Cecilia, a Roma, è stata concepita in relazione all’ascolto simultaneo di mie musiche – deve esistere, a priori, un terreno comune, un’empatia estetica, ma anche tecnica. Lo stesso dicasi per il documentario su Jannis Kounellis girato da Ermanno Olmi, nel quale la «risonanza interiore» coinvolgeva quattro dimensioni: lo spazio di Arnaldo Pomodoro (nella sua Fondazione), le sculture di Kounellis, la regia di Olmi, la partitura. Ancora, mi è capitato di «prestare» la mia musica per eventi culturali, come una regia televisiva per Rai Due sul restauro della Leggenda della vera Croce di Piero della Francesca. Anche in una circostanza come questa, che apparentemente richiede alla musica un grado di incidenza minima, in realtà, sei costretto a esplorare nei dettagli la tua produzione, scandagliandola in modo tale da scoprirne entità primarie, fondanti, dalle quali possono scatu- no i risultati ottenuti tanto dalla tradizione quanto dalle avanguardie, entrambi ormai storicizzati, il teatro musicale deve fare i conti con le proprie radici e lottare per mantenere la sua specificità contro i facili ipnotismi di una comunicazione superficiale. E per fare questo deve porsi in relazione con la regia, in un rapporto creativo ed egualitario. Ed è quanto ho tentato di fare, nell’ambito dell’opera vera e propria, con Myriam Tanant (La station thérmale, rappresentata a Lione, Parigi e alla Scala), Daniele Abbado (che ha ripreso, dopo Lione, a Bologna, Les oiseaux de passage), Giorgio Barberio Corsetti (Il letto della storia, Maggio Fiorentino), Denis Krief (La madre del mostro, Siena) Ermanno Olmi e, su un piano scenografico che si è fatto altamente strutturale, anche Arnaldo Pomodoro (Teneke, alla Scala di Milano). Da tutto ciò che ho detto in questo brevissimo excursus sulla mia produzione musicale, che ha implicato, in modi diversi, la regia, credo si deduca un principio generale, per me fondante anche sul piano estetico: non è mai il materiale, il modo, l’approccio, a legittimare un risultato artistico, ma la sua qualità. Non potrei dunque dire se preferisco una regia astratta o descrittiva, con un’ambientazione tradizionale o modernizzata, che utilizzi l’essenziale o che sfrutti tecnologie varie, anche video. È un falso problema. Ho visto regie di un tipo e dell’altro, convincenti o astruse. Dipende dal rigore, dalla coerenza, dalla consapevolezza, dalla sensibilità, dalla sapienza con cui testo e partitura vengono affrontati. Penso che si debba uscire definitivamente da questo equivoco che ha per tanti anni condizionato il risultato del teatro musicale, attraverso la ricerca continua di un dinamico punto d’incontro e di equilibrio tra arti, concezioni, posizioni estetiche differenti, con uno sguardo rivolto a ciò che avviene nelle altre discipline, ma anche fuori dalla tradizione colta occidentale. ◼ cantiere regia Intanto, ritengo che per me siano state importantissime le collaborazioni con registi e attori-registi del cinema, come Ermanno Olmi, Patrice Chéreau, Toni Servillo, poiché mi hanno permesso uno sguardo allargato sul rapporto gesto-suono-immagine: la musica non era più completamente autonoma o comunque fulcro del processo artistico, come avviene nell’opera. Al contrario, i registi hanno usato le mie partiture (già esistenti o scritte appositamente in base alle loro esigenze) per i loro obiettivi specifici. Il che, a dispetto di quanto un certo moralismo dogmatico ha talvolta teorizzato, non sminuisce affatto la forza espressiva della musica. Anzi, costringe il compositore (almeno per me così è stato) a indagare con maggiore umiltà le reali possibilità comunicative del mestiere, affinando ulteriormente l’aspetto, per me tutt’altro che trascurabile, della sapienza tecnica, dell’artigianato, della capacità di piegare la materia e gli stessi confini della propria estetica, a un risultato altro. E il confronto è divenuto quindi, per me, non solo intrinseco alla sfera musicale (con la tradizione colta occidentale, con le tecniche d’avanguardia, con altri generi, con le culture extraeuropee), ma anche estrinseco, volto cioè alla mediazione con il diverso da sé. Il che, da un punto di vista filosofico ed etico, ma potrei tranquillamente dire anche politico, è per me, oggi, imprescindibile. Lo stesso vale per quanto concerne altre forme musicali rappresentative, come il melologo, che indirettamente si plasma sul talento di attori, registi, e attori-registi. Così è stato con Ferdinando Bruni in Prospero o dell’armonia diretto da Riccardo Chailly in Scala, con Peter Simonischek nei panni del narratore nella Giusta armonia diretta da Riccardo Muti a Salisburgo, ma anche quando Toni Servillo è stato attore-regista dei Canti di Benjaminovo su testi di Franco Maorcaldi e Moni Ovadia attore-cantore in Irini, Esselam, Shalom. Devo ricordare
Scarica