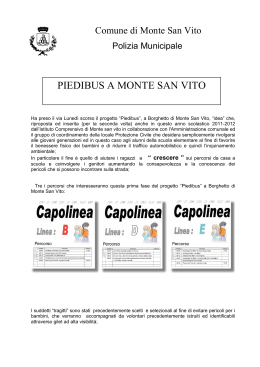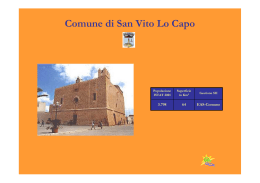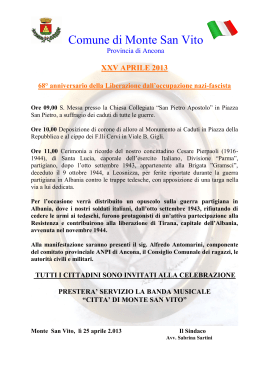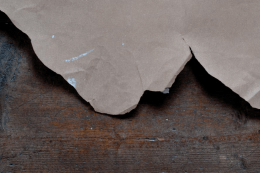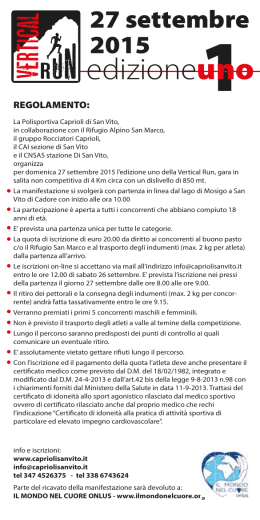1 Vito Riviello (1933-2009) UN POETA FUNAMBOLO DELLA PAROLA ‘ASSURDA E FAMILIARE’ Se ne è andato l’autore lucano che nell’arco di oltre mezzo secolo ha prodotto una vasta, estrosa e assai godibile opera in versi comico-giocosa che lo apparenta alla linea burlesco-satirica e antilirica dei Cenne de la Chitarra e Cecco Angiolieri, Berni e il Burchiello, Folengo e il Ruzante, Tassoni e il Basile e Redi. Una linea in sostanza espunta dal ‘canone’ letterario ufficiale, ma invero vitalissima e che ha fiancheggiato le avanguardie novecentesche. Da non dimenticare anche i suoi stralunati, bizzarri, extravaganti libri in prosa da “Premaman” (1968) a “Qui abitava Pitagora” (1993), a “E arrivò il giorno della prassi” (1999), in cui si rinvenivano pungenti ritratti della società provinciale, nonché sardoniche schegge memoriali della natia Potenza. ____________________________________________________________________ di Plinio Perilli … I bicchieri caddero s’infransero E imparammo a ridere Ci avviammo allora pellegrini della perdizione Attraverso le vie attraverso le contrade attraverso la ragione … - Guillaume Apollinaire: Alcools - Trasgressivo e trasversale; tagliente e impertinente… Se ne potrebbero usare tanti, di aggettivi, per raccontare la parabola espressiva, il guizzo intellettuale, la satirica flânerie di un poeta come Vito Riviello… Ma nessuna coppia antitetica e dirompentemente grottesca supera l’effetto madornale, la clownerie filosofica di due attribuzioni (e sentenze) al contempo privatissime ed epocali come Assurdo e Familiare – che infatti ben volentieri adottò come titolo (nella raccolta omonima dell’86, per Empirìa) e poi come titolo dei titoli (nella densa, spassosa antologia riepilogativa, prefata da Giulio Ferroni e certo minuziosamente ragionata, annotata d’irrazionale… che gli curai da Manni nel 1997). Cosa altra cosa se no è la stessa cosa, che sia la cosa stessa a essere più se stessa sino ad essere fuori cosa e cosa in se stessa. Da una cosa all’altra la cosa non rinunzia alla sostanza stessa della cosa, una cosa è una cosa e una cosa cosa che sia sempre nata dalla stessa cosa ma diversa pur essendo la cosa stessa. 2 Cosa cosae cosae cosam cosa cosa quale cosa? il nome della cosa… è sempre nella cosa. “Riviello ha saputo entrare, insieme con viva partecipazione e con ironico distacco,” – rilevava già allora Ferroni, acuto e amabilissimo – “entro le pieghe più intime di quel tessuto provinciale e piccolo borghese, ne ha estratto la colorata materia (fatta di esibizioni e di pudori, di incongrue aspirazioni, di piccoli oggetti familiari, di voci di retrobottega e di dopopartita, di un brulicare di commercianti sull’orlo del fallimento, di accaniti ascoltatori della radio, di cascamorti e di dongiovanni senza donne da conquistare, di bizzarri viveurs frequentatori del teatro di varietà e pronti a rovinarsi per soubrettes di passaggio) insieme ad un senso di insufficienza, di sproporzione, che appunto spinge sempre a volgere lo sguardo altrove, a cercare altri universi. (…) Si ritrovano qui le modalità in cui lo spirito comico di Riviello emerge proprio da questo fondo meridionale, lucano, cittadino, piccolo-borghese, nello squilibrio di potenze scatenato a Potenza e da Potenza: un fondo dietro cui si affacciano le tracce appena visibili di arcaiche maschere grecoitaliche congelate in rictus indecifrabili, l’eco lontana dell’enigmatico sorriso apulo del venosino Orazio, l’humour nero e celeste, cosmopolita e parigino del surrealismo novecentesco, l’ammiccare verbale e corporeo dell’avanspettacolo meridionale (fino alla smorfia slogata e metafisica della moderna maschera del grande Totò), e ancora le varie coniugazioni dell’assurdo post-bellico.” Uno dei più bei “kukù” di Vito Riviello (cfr. Kukulatria, del 1991, sorta di haiku parodiati e nostrani, velenosi quanto veloci d’ironia – sberleffi in versi, li plaude Paolo Mauri – tutti giocati a lapidaria equazione sorniona, epigrammatico mortaretto/calembour), è appunto dedicato alla neapolitana marionetta vivente di Fifa e arena o 47 morto che parla, I pompieri di Viggiù ma anche del pasoliniano, candido e polemico Uccellacci e uccellini: Nascono nel qui pro quo le ragioni di Totò. Sfottò, posa, critica dall’interno, transfert emotivo o archetipo immaginifico, e per soluzione finale, diciamo pure: mimata, loica parodia di fervorose, moralità del Moderno (contro-minima moralia?!), la dolente risata etica, il contrappasso stilistico, il grimaldello autocritico del Motto di Spirito come aguzzo, postfreudiano frammento d’autocoscienza collettiva… Epitaffio Se un giorno io trovassi in un vecchio cimitero d’Europa la tomba d’un uomo col seguente epitaffio: “Qui riposa Adolf Hitler imbianchino n… m…” Nel 1907 nasce mio padre che con le demoiselles d’Avignon mette in crisi la vecchia figuration. E se è già accaduto tanto perfino ch’io nascessi nel 1933 anno dell’avvento. Per anni, interminabili decenni, anzi brevissimi secoli… l’Italia non ha mai avuto il coraggio di concedere eguale dignità agli scrittori, ai poeti eminentemente lirici così come a quelli, sapientemente, sacrosantemente comici… Solo da poco, le nostre stesse antologie e storie letterarie predispongono una corsia vera e propria, un sito equivalente ed equipollente – a partire dal più 3 canonico e glorioso Dugento fecondatore – ad autori in realtà essenziali, e finora accantonati, occultati, pressoché rimossi, quali Cenne de la Chitarra e Cecco Angiolieri, Berni e il Burchiello, Folengo e il Ruzante, Tassoni e il Basile, Redi coi suoi bacchici ditirambi, eccetera eccetera. L’equivoco, il peccato originale anche del ’900 è stato più o meno, ahinoi, lo stesso… Una linea vincente, in luce, ufficiale, accademica, canonica (quasi sempre verticale), e un’altra secondaria, serbata scioccamente e maldestramente in ombra (guarda caso, quasi sempre orizzontale)… Alla cosiddetta poesia giocosa non viene insomma preparato il regolare posto a tavola, ma al massimo si tollera che ci diletti mentre mangiamo, confinata e recepita a mo’ di giullarata conviviale, di pur nobile, ameno e sapido passatempo… L’ufficialità finanche poetica ha da sempre cieca e immensa paura dell’agudeza, della salacità, della tirata ironica, del motteggio irridente e irriverente… Pessima forma mentis e sterile risultanza… Come se il Leopardi dei Canti, tanto per dire, non avesse perfettamente convissuto con le prove giovanili, la satira abilissima dei Paralipomeni della Batracomiomachia, e soprattutto con le inesauribili illuminazioni antropologico-culturali, le supreme, necessarie e adorabili forzature, sprezzature insomma delle Operette morali!… Finissimo conoscitore oltretutto dell’arte visiva, nonché inesauribile e inesausto Critico del Costume, Vito sapeva bene – nella ridda felice delle avanguardie che si sono succedute per impadronirsi, commentare, ripudiare o fors’anche epurare, ristrutturare e rinsanguare il nostro ’900 – che orizzontale e verticale, nei casi migliori convivono come dentro un gigantesco, immortale Calligramma di Apollinaire… Vito Riviello se ne fregava altamente della scrittura rubricata, elogiata alta, così come di quella denigrata, subordinata come bassa: entrambe in lui perfettamente convivevano, si rintuzzavano e sfruculiavano con esiti tra i più esilaranti e dunque sintomatici dei nostri ultimi lustri. Un tempo era casuale il tempo il male abitudine fissa il sole o la luna nella celeste calata prefissa. L’orientamento era sgomento un quartiere uno sciame, il vento bloccava l’aria più della sventura. Ci sono voluti milioni di affanni, di morti da una morte atomica fermati per vedere atomi di pace sciogliersi dolci nei cuori. … Partito da regolare, paziente adepto della vulgata realista (neo o meno, che dir si voglia), con raccolte anche memorabili quali L’astuzia della realtà (non a caso prefata – era il 1975 – da un lucido e fervoroso Paolo Volponi: “Riviello illumina le sue giornate come queste poesie, a strappi, con indolenza, e con una vecchia sapienza per il risparmio di ogni cosa, del quale già si conosce l’inutile virtù. Le sue poesie sono certe collane di luci colorate nelle feste meridionali intorno alle giostre o tra i muri della piazza e la facciata della chiesa: talvolta un vento indolente le dondola, le spegne e le riaccende, altre volte uno più aspro si diverte a dileggiarle, fulminando alcune lampade, creando nuovi spazi che senza raggiungere quelli siderali gravano sull’anima degli ultimi spettatori.”), Vito ha proseguito libro dopo libro, spesso opere smilze e volutamente episodiche, circoscritte), una poderosa, avvolgente ricognizione organica della realtà mentale, psicologica, stilistica, comportamentistica del nostro essere, volerci, illuderci assolutamente contemporanei… Ne è derivata un’opera insieme frammentaria e omogenea, bizzosa e rigorosa, giocosa e invece 4 drammatica, ludica e disperata, ma sempre perfettamente risolta, affilata in termini ed esiti linguistici. “Riviello cerca di tenersi lontano dalle tecniche sperimentali della Neoavanguardia, adoperando soprattutto i suoi felici calembours, e confidando apertamente nel tripudio delle sue metafore, dei suoi giochi verbali, con un linguaggio insieme dissodato e fluido.” – segnalava Giacinto Spagnoletti, ben collegandolo alla succosa, implosiva e adorabile tradizione satirica dei Delfini e dei Wilcock, dei Flaiano e dei Balestra, dei Vòllaro e dei Fratini, per non dire del “più grande” di tutti, il geniale e per fortuna anarchico Emilio Villa – “Il suo modo di sconsacrare non ha alle spalle altra pretesa che il gioco letterario; ma questo che per altri potrebbe significare una difficile avventura, in lui si attua con un’autentica qualità espressiva. Della sua migliore raccolta, Dagherrotipo, citiamo questo ‘1943’: «Chi siamo sgolava il filosofo. / Dove andiamo? Si batteva la testa / nella villa mesta. Da dove veniamo? ‘Da Foggia, signor tenente!’». Se il gran malato è comunque l’Homo Erectus Contemporaneus, facciamo parlare la sua poesia con le sue stesse pause, vizi e vezzi, cadute e illusioni, categorie e decentramenti, tic e pulsioni, poesia sliricata e prosa nutrice del verso… Se poi invece del paziente sul lettino ci mettiamo il medesimo letterato-psicotereapetuta, anzi ancor più l’entità Linguaggio, l’impresa sarà perfetta, e la cura (l’acquisizione, l’autocoscienza, la medicina-antidoto) garantita: assurda e familiare. Ricordo della cena Junghianamente parlando mi ricordo d’una sala da pranzo in cui sedevano i micenei e poi mia madre l’altare della patria pieno di candele all’infinito. Dopo un ballo alle Terme gli Egizi chiusero il canale e chi scese in apnea e chi ebbe l’adenoide. Al dolce il desiderio passivo di assistere alla caduta della monarchia. Ricorderemo di Vito Riviello, in egual modo, l’amicizia e l’ironia, l’attenzione e il sarcasmo, la noia e la dedizione; insomma il malessere goloso, quella sentenziosità affabile da perditempo esemplare, da pantomimo-profeta di ogni astuta Realtà. I conti non tornano, i torni non contano… si sa, ma questo lo sapevamo – voleva dirci – fin dall’inizio. L’importante che la gara, l’astratta e muscolare contesa col Futuro sempre ci trovi, ci trovasse pronti, egualmente creduli e interdetti, scettici e appassionati… La questione meridionale Nella mia terra adombrata d’ombre d’uomini hombres, si sposavano gli alberi le bianche cerre coi cerri dalle chiome dominanti, le acacie provocanti in tulle bianco e i telemoni acaci, forti ed elastici, fecondi idilli senza potature, cedre con cedri 5 dalle radici cedrate. Amore boschivo sorgivo che stupiva gli uomini anch’essi scossi dal vento anzi percossi. Le quercie erano nonne e i nonni querci, immobili, grandi creatori d’ombre per digiunar sull’erba. Questi alberi hanno camminato molti hanno fatto gli alberi nelle lontane Americhe, altri sono stati abbattuti disboscati da celebri coiffeurs pour arbres. La poesia è lì – né verticale né orizzontale, o entrambe le cose insieme, come l’orografia, l’altimetria sportiva di una tappa ciclistica… Perché la Fantasia che si rispetti è sempre all’avanguardia, e la tachicardia del cuore sublima il muscolo, incorona lo stile, il vero portamento regale della scrittura… I lapsus quotidiani fanno il resto, e “l’anello che non tiene” (Montale docet), per paradosso salvifico e propedeutico, rinsalda tutto, collega non solo i progetti, le idealità, ma perfino gli stili… Personal Anche l’Italia è computer. Torna la nostalgia del mare il latte della razza bovina sociologica bruno-alpina, la neve del postiglione e l’eco del suo corno dalla Cornovaglia. Torna il tango nella festa la finta sciatalgia. E quel Mazzin di fiori sulle vesti di Maria. Tornano amari, cedrate di zie che sognavano l’harem torna ferito Garibaldi, torna il tuono torna il vento torna il monaco nel convento. Le ultime raccolte insieme disperdevano certezze, idealità, abitudini e medesime radici novecentesche – ma tanto più e meglio s’immergevano invece in quest’immenso, pletorico, fastidioso e risibile Paradosso, assurdo e familiare, che è dunque, e ormai temo, temiamo, inesorabilmente, la nostra definitiva, ineludibile e maldestra Contemporaneità. Definirla o no postmoderna, diciamolo, è oramai solo un alibi e un luogo comune: poco più che un’etichetta di comodo, colta e insieme prolungatamente sbarazzina… Vito lo sapeva e ci si tuffò, ci giocò molto…Basta ritornare, ritrovare via via il cursus, la posizione pozione postazione omeopatica delle nuove opere… A un primo periodo di nobile sarcasmo intimista, di critica d’autoritratto antropologico culturale, da gruppo di famiglia in un interno (L’astuzia della realtà, 1975; Dagherròtipo, 1978; Sindrome dei ritratti austeri, 1980; Tabarin, 1985; Assurdo e familiare, 1986; Apparizioni, 1989) seppiata in un bianco e nero che più che quello dei vecchi televisori è quello delle antiche stampe o litografie 6 velenose e fiorite insieme dei Longanesi e dei Maccari (il Ci salveranno le vecchie zie?, il Parliamo dell’elefante o L’antipatico – per intenderci: o ancora la vecchia rispolverata e trastullante polemica anni ’30 su Strapaese o Stracittà), Riviello prende il telecomando e un bel 29 pollici a colori, per concedersi un vorticoso zapping sulla nostra vertiginosa, vellutata o urticante (è lo stesso) Irrealtà quotidiana… Ma senza accelerazioni o impaludamenti teorico-psicotici alla Ottiero Ottieri (il titolo è suo, e fu un capolavoro di rara giustezza), bensì un’eterna, sorniona vena postdadaista (ha ragione Mario Lunetta) da iperironico Surrealista Gnoseologico… Tutto ci è consentito please il peccato è stato reso trasparente da una pronta scienza e le virtù si sono appianate nell’ordine di perseguirle. Ma della divinità che se ne va? Parlo dell’onniscienza dell’eternità. Siamo lontani dalla notizia almeno di trenta giorni, solito tramestìo di vettovaglie accampamenti elettronici che han fatto a meno degli elefanti ma gli odori i suoni i frastuoni sono riducibili a segnali convenuti infatti i convenevoli i convitati si dispongono come da secoli. Sarebbe veramente l’ora che i morti spiattellassero. Erano gli anni in cui lo attraeva, ricordo bene, non tanto la patafisica storica di Alfred Jarry, ma quella reinventata, codificata con un vago, fumettistico sentore e strascico di pop-art, dunque quasi “illustrata”, alla maniera – che so – di un grottesco, polimaterico Enrico Baj, frammentato tra collages, medaglie, conchiglie e specchietti infranti… O magari perpetuando, e se possibile accelerando, l’affollata, gustosa tecnica dei decollages del caro vecchio Mimmo Rotella… Gemmano infatti i nuovi titoli: Kukulatrìa, 1991; Monumentànee, 1992; Il passaggio della televisione, 1993 (su progetto grafico di Gianfranco Baruchello e con disegni del vecio amico potentino Giuseppe Pedota); Plurime scissioni, 2001… Ed ecco dunque la smodata e snudata accensione delle metafore, “La parola di pietra”, parafrasiamo Montale, che mondi possa aprirci: Aspro il monte, il contrafforte, le allegorie sono loquaci una tale asprezza non s’era mai vista prima, anche le tue parole d’uso sono violente, hanno perso lo smalto chimerico che le poteva aleggiare, conoscono l’abuso. … E il reoconfesso, viscerale abuso di “Sogni barocchi”: Il brivido dell’incostanza quando la brezza lucidava 7 i falchi rossi del tramonto, i pullover alla rovescia e s’andava dall’altra parte del mondo. ma quale parte, non v’era stata la neve a dire che il silenzio è un passo d’uomo? … Ma ecco soprattutto l’eccezionale esito di una critica della Modernità che passa dal Museo, ahinoi, dell’Orrore a quello, sic!, delle Cere, e in fondo li apparenta – magari dentro il baratro catodico (oggi rinnovato, categorizzato come digitale terrestre…) di un monitor televisivo: Futura Vi ricordate i futuri campi di sterminio? A prima vista sembravano simili a quelli del passato ma a vederli più da vicino si discostavano per tecnologia avanzata, anche il dolore anche l’angoscia senza più psicanalisi. Spettacolarizzata la visione animata degli eccidi dei massacri e delle tecniche efferate. Intervalli pubblicitari degli strumenti usati da quelli medievali ai giorni nostri perfino tipi di corda in casa degli impiccati, spregiudicate correlazioni con vittime autostradali e morti d’etnie obliterate, naufragi esodali e scontri a fuoco nell’urbano a quest’ora in altre ore di questo tempo. Plurime scissioni, sentenzia, ripetiamo, il titolo, deflagrantemente già sintomatico… “È la divisione, l’andare in pezzi, la frammentarietà dell’io da cui tutti siamo pervasi in questo torno di tempi.” – argomenta con molta finezza e specchiata perentorietà sociologica, un maieuta fra Logos ed Epokè quale Francesco Muzzioli (e la sua prefazione gioca un titolo che accarezza, titilla il thrilling psicodinamico: “La poesia comica nel puzzle dell’io”) – “È una pluralità psichica (ma anche corporea: non dimentichiamo le polemiche sulla donazione di organi, gli espianti, ecc.) che ha un lato intrinseco e uno estrinseco. Da un lato, la pluralità emerge da dentro ed è positiva, perché l’io che noi siamo è fatto di tante parti che è riduttivo poi restringere all’uno, all’unico ‘io sono’ imposto dal ruolo sociale; ma dall’altro lato, la pluralità è imposta dall’esterno (dai messaggi dei media, che fanno appello in noi a tante persone diverse, per vendere al medesimo consumatore tutta la gamma dei prodotti; dalla tecnologia, che pretende attenzioni e saperi specialistici e differenziati; dall’economia, che vuole flessibilità e adesione al continuo cambiamento) e quindi è subita negativamente, con conseguenze patologiche, che producono, alle somme, come compensazione all’insicurezza, il rigurgito dei vecchi fantasmi.” Né va comunque dimenticata l’intrigante vena antropologico-culturale, da storico del costume, da exragazzo, o eterno monello colto del sud che era infatti cresciuto con le mitiche inchieste liriconarrative o saggistiche o etnografiche di Carlo Levi, Rocco Scotellaro, Ernesto De Martino… E si era fatto l’orecchio con grandissimi poeti e, per dir meglio, artisti totali, della pagina, dei quadri, del cuore, nella Storia, quali – soprattutto – Alfonso Gatto e Leonardo Sinisgalli… Quest’ultimo anzi, lucano nume tutelare, esimio e assiso Ingegnere (un po’ come “il Gran Lombardo” Carolus Aemilius Gadda) nonché struggente, ungarettiano aedo ermetico, amico di artisti, e vigoroso eclettico artifex, a Milano, di una vera sapiente collaborazione tra i trovatori del ’900 e la “Civiltà delle Macchine”, stampò a Vito il primo, decisivo libretto, Città fra paesi 8 (Schwartz, 1955), che l’autore di Vidi le Muse (e ormai illustre nativo di Montemurro) non esitò a battezzare e incoronare come “il primo ritratto letterario di Potenza”… Frutto nobile di quest’attitudine saranno svariate prose, racconti, inchiestine, sempre in bilico – lunatico e rarefatto – fra il romanzesco e lo scanzonato, l’esigesi affilata, e la divagazione elevata al cubo (o forse sfaccettata, arrischiata e rigiocata al “cubismo” – come ben asserisce Francesco Muzzioli)… Una piccola, strampalata, stralunata messe di titoli che riconsiderati tutti assieme, coniugano una sorta di bizzarra, extravagante analisi sociologica, e una lirica, inveterata diagnosi italiota, con le buffe, aspre pulsioni e i misteriosi, alienati rituali dell’Io: Premaman (1968), La neve all’occhiello (1986), Manualetto del calcio sognato (1992), Qui abitava Pitagora (1993), E arrivò il giorno della prassi (1999)… Fideiussore prezioso di Premaman, Gilberto Finzi disvela procedimenti stilistici e aggregazioni psichiche come perfettamente correlati, trasfusi, annodati: “La comunione con la realtà-irrealtà è ormai l’assenza di nessi visibili, la solidità di cerniere tenute nascoste: mentre tra gli interlocutori (uomo-donna) del dialogo-racconto ancora resiste una pur tenuissima, labile distinzione, gli irreali (ma sacri, come rituali) modi di trapasso, gli stacchi impercettibili eppure (controsenso?) vischiosi e densi, il taglio morbido, con modulazioni prevalentemente affettive, di scene o pseudoscene, i lapsus o i calembours, tensione razionale o memoria caritativa e meridionalmente ipersensiva, sono già ‘forme’ di organizzazione etica (sic) e strutturale.” Rispolveriamo dunque una scheggia narrativa, un residuo tenero e feroce di questo mancato, aggirato stream of consciousness: Nei nostri paesi si conserva ancora la paura per l’inconscio, sono tutti rassegnati a subirlo nelle incredibili conseguenze né credono che la scienza possa guarirli, il colloquio e il monologo avvengono al buio con l’alibi dell’istinto, della natura prorompente, ed è proprio in questi paesi che la psicanalisi potrebbe essere la fiat degli animi comunali e la guarigione per lo meno della fissità con cui gli uomini guardano lo specchio, il non-essere mattutino e l’ombra di se stessi nel corpo della sera. Si rimane per sempre neonati, con gli occhi sbarrati sul viso della madre come su di un cielo compatto ed elementare dove piove o si accende la luna. Bisogna scarmigliare questo cielo, entrare nelle nuvole del sacro, turbinare agli orizzonti e precipitare in sonno, per ripetere la propria esistenza con una donna. Ti conobbi così, spostato un poco dal vento di una ricerca sacrilega, tuttavia situato nel solco consueto, tra sogno e realtà nell’itinerario difficile e fiabesco. E flusso di coscienza (parodiato, mimato al contempo: come la smorfia con cui un pittore si specchia, si valuta e forse si giudica nel mentre s’autoritrae!) scorre, aleggia anche nella plastica, vocata prosa memoriale, saga d’autocoscienza di E arrivò il giorno della prassi, di cui un critico come Giorgio Patrizi non esita a sottolineare l’originalità e l’importanza: “La perizia che Riviello dimostra in questo racconto-lungo è tutta legata alla capacità di ritrarre uno spaccato sociale che è insieme autobiografico e storico, con microeventi – i rituali della vita scolastica, il contrasto tra studenti e professori, le ‘maschere’ dei ragazzi protagonisti di piccole epopee quotidiane – che divengono emblematici di un mondo non ancora in trasformazione ma certo non statico, mosso da inquietudini e fermenti, da malesseri, entusiasmi, minimi e grandi eroismi.” La ronzante macchina da presa della scrittura, gira e rievoca come un baldo film tardoneorealista anni ’50, affidato più che alle parole alle occhiate in tralice, alle ombreggiature interiori, al forte gioco in bianco e nero dei contrasti sia cromatici che emotivi: Nino, il pittore del gruppo, con Fedora, culagna e signorosa. Pepè con Aida, mulagna. Con me Lilli cinciallegra. Il tango venne sollevato e al suo posto calò l’aria di “Cincillà” e fummo cavalieri evanescenti di cuori e quadri, picche e fiori. Un critico bilioso direbbe che faccio i soliti giochi di parole. Ma le parole si intrecciano da sole e si amano sui sedili di pietra con i colori spremuti delle foglie di mirto. Le parole finiscono col somigliarsi, le analogie scoprono complicità clandestine che il linguaggio ufficiale interrompe bruscamente. Pertanto tra zia e psicologia c’è veramente una parentela, oltre che, marciando insieme, una riacquisita funzionalità demistificatoria. 9 Anche i racconti, i veri e propri scenari di costume, vien fatto di dire, de La neve all’occhiello, ritualizzano giovinezza borbottante e radici antique, staticità adulta e brulichìo sensuale, in una ridda d’esperienze che di ogni sguardo, o attesa, o golosità, o débâcle eroicomica, riescono a fare romanzo, opera buffa seppur tachicardica… Il babà la cui invenzione qualche Popov ha accreditato ai cosacchi è invece un dolce napoletano, anzi è il dolce più dolce, morbido, tenerissimo. È il simbolo della dolcezza meridionale in opposizione alla durezza della vita. L’originaria forma di spillo ingrandito, amuleto portafortuna, è stata in seguito modificata da un “designer” che ha disegnato una valvola elettronica, una valvola che genera felicità. Più che assorbire rhum se ne inzuppa, se ne ubriaca con estasi. Il babà è un uomo quando vuol essere maschio e femmina quando vuol essere donna, un ermafrodito sui generis. Ecco perché il grande pasticciere di S. Lucia non si rizelò quando uno straniero gli chiese: “Per favore, signore, una babà!”. “Riviello esercita contemporaneamente, come spetta ai poeti,” – arguisce e proclama uno storico e ancor più noto osservatore quale Giovannino Russo, squisito amico d’antan e devoto prosecutore della laica schiatta flaianense ovverosia maccariana: pungente e amena, tenera e fustigante – “il diritto alla trasformazione della realtà senza travisarla; usa la figura retorica dell’iperbole o fa balenare l’ironia che spesso è feroce, ma è sempre stemperata nel gioco, ogni volta che si sofferma sulla descrizione della limitatezza dei borghesi, sulle ambizioni sbagliate tra l’aspirazione (o la pretesa) a vivere come cittadini e la mancanza di autocritica, di lucidità nel riconoscere i limiti fra sogno e realtà.” Restano poi fuori una miriade di articoli, presentazioni, interviste, testimonianze in cui talora spesso si annida la sua parte onnivora e migliore, visionaria e astutissima: come quella Realtà che egli sempre nascondeva e lo nascondeva, per tragicomiche vie di fuga perfino più concrete dei ricordi ameni, nostalgici, dunque mitici e indelebili… Considero ad esempio le Memorie d’avanspettacolo che Vito pubblicò nel ’94 sul mensile “Il Grifo”, un piccolo capolavoro, sorta di felliniana, crepuscolare e bislacca Caricatura d’Immaginario; melanconica e carnascialesca, laida e solitaria; elegantissima come un abito rétro, birichina come la rossa estatica giarrettiera donataci da una cocotte gozzaniana che ha confuso secolo (’800, ’900 o 2000?!) ed eccitato – bravissima! – tutte le nostre mascule … virtù: … La storia del “mio” avanspettacolo si svolge tra zio Michelino e zio Michelone. Zio Michelino era un play boy degli anni ’30, imbrillantinato, azzimato, vestito con abito scuro d’inverno e di gabardin beige d’estate. In autunno-primavera sciorinava un Principe di Galles da “gita al lago”. Michelino, deluso da un matrimonio commissionatogli giocoforza, intravvedeva nelle ballerinette del tempo le ideali compagne ahimè svanite. Per esse si era trasformato in una specie di impresario teatrale, un manager occasionale che camuffava raptus d’amore. Michelino lavorava in proprio, quando gli piaceva una soubrettina alle prime armi la ingaggiava nella sua scuderia provvisoria. La svezzava con una corte furiosa e l’accudiva con bigné e brillantini d’orafi specializzati nel cingere colli e polsi di bellezze campesine. La mia adolescenza coincise con l’avvento di Dudù ventenne primadonna nata tra i pomodori di Scafati e Pompei. Dudù era gentile e bella, di una bellezza ancora non alterata da trucchi eversivi. Seguace di Anna Fougez non disdegnava dopo lo spettacolo di cenare con trippa paesana e baccalà su cui beveva qualche bicchiere di rosso mediterraneo nelle cantine che allora erano luoghi trasgressivi di intrattenimento. Tra i convitati v’era spesso il gruppo “intellettuale” della provincia. … E non è un caso che Vito abbia in fondo sublimato, esorcizzato al massimo tutto questo percorso, pellegrinaggio, forse, nel post-camusiano, post-ioneschiano Assurdo familiare, con un’operina allampanata e inesorabile quale Fumoir (2003): un fiducioso, sacramentato omaggio al suo adorato mondo dei “fumetti” (quello da cui in fondo vennero anche Zavattini e Fellini, Flaiano e Alberto Sordi…), capace davvero e finalmente di “trattare gli eroi di carta come se fossero persone,” – annota Vincenzo Mollica – “liberandoli dai confini psicolabili del mondo delle nuvole parlanti. È la 10 prima volta che un poeta con i suoi versi dà corpo ad un universo sconsacrato da tutte le culture ufficiali, fa circolare il sangue della poesia in esseri in cui normalmente il diritto di esistenza in vita equivale a quello di un paradosso.” Un paradosso, per l’appunto, assurdo e familiare, come magari i tratti e le gesta elastiche, effigiate, di “Tiramolla”: Si stende si tende si scolla, Tiramolla a tutte l’estensioni, le propensioni, richieste dalla vita. Per vivere fa salti mortali e spesso anche immortali, mai che i suoi slanci, i prolungamenti siano immorali. Anzi del suo destino può esser fiero. Per vivere sul serio s’accorcia, s’allunga caracolla ritorna al primo punto, Tiramolla. Da L’astuzia della realtà a “Minnie” o al “Sor Pampurio”, a “Mandrake” ed “Eta Beta”, “Tex Willer” o “L’Uomo ragno”, il passo è breve e l’approdo infinito… È come se il Cervantes avesse riscritto oggi un Don Chisciotte da sceneggiare con Almodóvar, ma dove il vero protagonista è Sancho Panza, lui il panciuto, obeso e satollo cavaliere di ogni saggezza, insomma il Familiare –, e il prode, goffissimo Hidalgo solo l’emaciato, lungagnone, iracondo e perciò scompisciante Assurdo da cui veniamo… Assurdo e Familiare… Rileggiamo per esempio e a caso l’affabulante, secentesco Cervantes del capitolo trentasettesimo: “ – Si calmi Vossignoria, signor mio, – rispose Sancio; – potrebbe anche darsi che io mi sia ingannato, per quanto riguarda il cambiamento della signora principessa Miccomiccona. Ma quanto alla testa del gigante o, meglio, degli otri sforacchiati, e per il sangue ch’era vino rosso, non m’inganno vivaddio, perché gli otri stanno là sbudellati dietro di Vossignoria, e il vino rosso ha allagato la stanza. E se non ci crede, lo vedrà alla frittura delle uova, cioè lo vedrà quando sua signoria il signor oste le domanderà il risarcimento di tutto. Per il resto, se la signora regina è ancora tale, me ne rallegro, perché anch’io avrò la mia parte, come ogni altro figlio di mamma. ” Ecco, Vito avrebbe invece concesso, spinto Sancho a interloquire con don Chisciotte in un ribaltato, reboante barocco da inizio terzomillennio: Parata di stelle Donde vas, estrella? Se lo sapessi, amigo, non te lo direi perché certamente ti inquieterebbe sapere che in fondo non lo so. E qui sabe? Quien sabe? Qualche verso di Saba. E voi sapete? Sbottonatevi è tempo che chi sa dica di non sapere niente, lo dica e non lo tenga in mente. Se no ferma per sempre 11 la nescioscienza! Il niente si trastulla col nulla ma ha bisogno di credere di non sapere niente che è poco più di nulla. … Sì, la raggelante nescioscienza come unica bussola – e in cielo, l’estrella smarrita ed eterna, pallida e assorta… dell’inseguita, concupita, trasognata, pomiciata, arrapata poesia… La venusta venustà della lirica Beltà, avrebbe sorriso e motteggiato Vito, ieri, oggi, domani, ma sempre e solo Come la vidi da ragazzo – una donna, forse, ma molto di più un’isola, mitica eppure ironica: una Capri del mattino che la sera rima Caprera… Vedendola da ragazzo la vidi desnuda d’incomparabile bellezza giovinezza senza vecchiaia, vi zufolava il mito ebbro e giocondo quasi nordico biondo che mi chiamava Vito e le capre capresi capricciose col Capricorno, i Faraglioni fratelli mormoni pel mormorìo del mare e la gotta azzurra che fa sognare le fossili zitelle di Podagra e i seguaci del Kaiser, Rilke che gronda rime plenilunio ed effluvio, Gorki alla pescatora che sciogliendo l’inverno russo ballava il tango in una stanza bassa Goethe a cui l’isola apparve dagli scogli delle Sirene una bonaccia serena e completa e tutti i celebri che giunsero a celebrarla in solitudine meno che Garibaldi desìoso al mattino di rifugiarsi a Capri, per colpa della sera finì i suoi giorni a Caprera. Dalla pascoliana Digitale purpurea, evocante d’arcano, sino al fantasmagorico, attualissimo Digitale terrestre, è un’unica immensa, secolare orbita, parabola nell’ètere, non meno lirica che tecnologica… Una nuova, allucinata, inopinata Metamorfosi occidentale, ci aspetta al varco!: quella che Zio Franz praghese non fece in tempo a scrivere, ma solo magari abbozzò, in una lettera a Milena in versi che certo mai e poi mai le spedì... Vito, chissà?, la divinò, la immaginò forse come capace di livellare, omologare perfettamente il Comico nel Tragico, e viceversa, in linea del resto con la migliore tradizione del Witz da teatro ebraico: Kafkiana Uscire dai labirinti è stato per secoli un progetto tenace mostrare il buio alla luce i tormenti i tanghi della mente 12 e le contorte forme del pudore smarritesi nelle pieghe retoriche di burocrazie austere, ridarle in immagini salde e vere, così ballerine severe vestite di sola oscenità escono da un uomo solo dalle sue congrue profondità. “… Per Mauron (che qui legge Freud attraverso le precisazioni e gli aggiornamenti di Kris)” – Giulio Ferroni indaga e richiama la sua scandagliante Psychocritique du genre comique – “il riso nasce dall’avvertimento di una differenza tra una rappresentazione ricalcata sull’esperienza adulta normale e un’altra dotata di caratteri infantili, che ‘suggerisce una regressione verso stati superati’ (p. 22): la scarica derivante, secondo il noto meccanismo ‘economico’, da questa differenza, si configura sotto l’aspetto di un ‘trionfo’, di una ‘vittoria sull’angoscia’. L’affacciarsi sullo spazio della regressione si rivela dunque innocuo, la liberazione dalle costrizioni adulte, lungi dal dissolvere l’integrità dell’io, arriva ad offrirgli un gratificante ‘sentimento di trionfo’.” È in questo vertice e vortice (che possiamo ben chiamare spazio della regressione, certo, ma anche e insieme fantasia di trionfo, vittoria sull’angoscia), che il Nostro colloca quella che nella sua ultima raccolta, Livelli di coincidenza (2006), battezza come “Psicanalisi asciutta”: tutta, si capisce, all’insegna – rileva Gabriele Perretta – di un vivissimo “Senso dell’autoversione comica”… De senectute Vennero le pie donne, chiesero d’accompagnarmi, discrete, fino alla morte. Non avevano più paura del comico ridevano perché sapevano che il pianto è infinito. Mi chiamavano con dolci nomi come amanti di teatro sincere fino all’ossimoro. Facendosi sempre donne mimavano la fragilità del maschio accarezzando la mia mano che sembrava un cane che iniziasse a dormire. L’importante, per Riviello (e credo per noi tutti) è che la trappola della retorica fosse sempre acutamente evitata; che l’avanguardia che conti e che resti sia sempre la prossima; che il vulnus d’esistenza o d’amore, l’eterna prorogata ferita romantica si chiuda e si cicatrizzi da sé… E che la morte – la morte nella vita e quella della vita, dopo la vita – come intonava, ammoniva Cardarelli (un altro e ancor più supremo poeta moralista, esimio “cinico che ha fede in quel che fa”), la morte, dicevamo, ci rispetti, ci sospetti, ci sorrida, ci arrida, e che soprattutto… ci trovi vivi: “… E in quell’ultimo istante essere allegri / come quando si contano i minuti / dell’orologio della stazione / e ognuno vale un secolo. / Poi che la morte è la sposa fedele / che subentra all’amante traditrice, / non vogliamo riceverla da intrusa, / né fuggire con lei. / Troppe volte partimmo / senza commiato!”… La sua estrema, esaustiva agnizione, si prospetta insomma – perifrasiamola così – più plautina che plotiniana, meno rapita che divertita… Ma forse anche questo è un riviellesco punto d’arrivo, perfino filosofico: “Non c’è rosa senza Spinoza”. 13 … Il niente si trastulla col nulla ma ha bisogno di credere di non sapere niente che è poco più di nulla. È immensa l’ignoranza che porta alla stelle si esplora l’infinito nel nulla. Un infinito fatto di infiniti niente quantificati al nulla. Sempre più prospettive d’essere infiniti perché finiti nel nulla. … So per certo che in quell’ultimo istante effimero ed eternante, nullifico di noir, Vito avrà chiamato la Madama con un nome o lapsus, sì, da baiadera, da venerea sciantosa d’avanspettacolo (Cocò?… Dudù?…), o da donchisciottesca – anch’Essa – “signora principessa Miccomiccona”, recitandole infine il più assurdo e familiare dei suoi mitici, smitizzanti “Neokukù”: Sulla mia tomba: sono momentaneamente assente.
Scarica