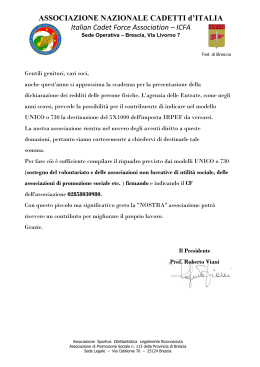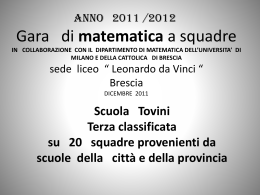Confronti Grafo / Pubblicazione finanziata dall’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Studi Sociali © febbraio Grafo | gestione IGB Group Giancarlo Provasi Tra desideri e paure Sguardi su Brescia e sul presente Confronti Grafo Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure (Italo Calvino, Le città invisibili) Prefazione Il titolo di questo libro può suonare strano, anche se il sottotitolo aiuta – mi auguro – a comprenderne i contenuti. Nasce da una citazione dalle Città invisibili di Italo Calvino che ho voluto porre ad epigrafe dell’intero volume, dopo averla utilizzata in conclusione di uno degli interventi in esso raccolti. Tra le principali ragioni di inquietudine per i tempi difficili che stiamo vivendo (nel Paese e anche in questa nostra realtà locale) c’è in me la percezione di un ripiegamento della nostra società sulle proprie paure (la paura di aprirsi al mondo, la paura del diverso e dei diversi, la paura di cambiare, la paura di un futuro peggiore del passato) e del venir meno – anche per gravi responsabilità della politica – dei desideri, delle aspirazioni e degli ideali che ognuno coltiva in cuor suo, e che soli possono dare forza vitale e motivazioni per pensare positivo, per guardare avanti con fiducia e speranza, per sormontare le paure appunto e impegnarci singolarmente e collettivamente nella costruzione di un futuro migliore. Abbiamo purtroppo sempre più paura delle nostre paure. Stiamo diventando una società sempre più vecchia, non solo anagraficamente ma esistenzialmente e culturalmente. Non solo facciamo sempre meno figli ma non investiamo su di loro; preferiamo difendere sicurezze e privilegi conquistati nel passato che guardare avanti e assicurare ai nostri discendenti un futuro più ricco e più giusto. Ci arrocchiamo nella difesa dell’esistente, chiusi nel nostro particolare, timorosi di perdere il benessere di cui godiamo. E rinunciamo così a rischiare, a metterci in gioco, a fidarci degli altri per costruire insieme una concreta speranza. Le città, come luoghi emblematici della convivenza civile, sono fatte – ci suggerisce Calvino – di desideri e paure: sta a noi coltivare i desideri e sormontare le paure per costruire un domani migliore. È dunque, quello scelto per questo libro, un titolo che intende evocare insieme l’amara costatazione della perdita di vitalità del nostro presente ma anche la volontà di non arrendersi ad essa, di essere positivi e propositivi, di coltivare i desideri e di scommettere ancora sul futuro. In fondo questo mi è parso il messaggio che – pur nello specifico dei vari temi trattati – sottostà a tutti gli interventi qui raccolti. Si tratta di riflessioni occasionali, originate dall’invito a partecipare a momenti di dibattito (convegni, incontri, presentazione di libri) tenuti a Brescia nell’arco di un quindicennio e per la maggior parte mai pubblicati (dei pochi già apparsi si dà conto del luogo nelle note a piè di titolo). Come studioso innanzitutto, ma anche come preside della Facoltà di Economia prima e come prorettore dell’Università degli studi cittadina poi, ho avuto il privilegio in questi anni di essere invitato a eventi culturali tenutesi in città su svariati temi. Di molti la mancanza di tempo mi ha impedito di stenderne una versione scritta; di altri ho avuto modo invece di predisporre un testo. Tra gli oltre settanta conservati nelle memorie del mio computer ho scelto i quattordici presentati in questa raccolta. La scelta è non tanto caduta su quelli stilisticamente meglio riusciti, quanto piuttosto è stata dettata da tre criteri: l’attualità dei contenuti, nonostante il tempo trascorso dalla originaria stesura del testo pubblicato; la centralità del tema nel percorso della mia riflessione personale; l’interesse (almeno presunto) dell’argomento affrontato. Quanto al primo e secondo criterio ho poco da aggiungere. Alcuni interventi, letti a distanza di qualche anno, suonano inevitabilmente superati, vuoi per il tema vuoi per il punto di vista con cui sono stati trattati. Conservano invece più spesso una loro attualità quelli che mi appartengono più da vicino, che non rispondevano (al momento della loro stesura) solo a motivazioni occasionali ma ad una convergenza (voluta o fortunata) tra un percorso intellettuale di più lunga lena e l’oggetto proposto al dibattito. Mi sia consentito invece – anche per utilità del lettore – ripercorrere brevemente il “filo rosso” che lega insieme gli interventi inseriti in questa raccolta e ne giustifica, ai miei occhi almeno, l’interesse. Vorrei partire dalla seconda parte del libro: quella dedicata a Brescia. Perché tutti gli interventi raccolti sono frutto di dibattiti tenutisi in città e perché anche questo libro che li raccoglie è destinato innanzitutto ad un pubblico locale. Sono le riflessioni di un non bresciano che da più di trent’anni (dal lontano ) lavora a Brescia e che ha scelto a un certo punto di venirci anche a vivere. Credo che questa mia storia personale spieghi in larga misura l’empatia con cui ho sempre guardato a questa realtà. Un’empatia che mi ha permesso di sviluppare un punto di vista esterno ma non distante né tanto meno distaccato, un punto di vista “critico”, non offuscato cioè dal (comprensibile) orgoglio di appartenenza degli abitanti di questa terra, ma partecipe e coinvolto sino in fondo nei suoi destini. Quale è il giudizio che emerge da questo sguardo? Quello di una realtà viva, determinata e caparbia, che possiede ancora grandi potenzialità, ma che soffre di una crescente discrasia tra la vitalità spontanea e individualistica degli uomini e delle donne che la abitano e un progetto comune che sappia dare senso e direzione a tale volontà vitalistica. Una ragione (forse la principale) dell’empatia che mi lega a questa terra è appunto il suo non essere mai doma, il non ripiegarsi neppure nei momenti più difficili nel compatimento o nella nostalgia. E tuttavia la mancanza di una prospettiva condivisa, di un obiettivo comune da raggiungere e a cui destinare questo enorme potenziale motivazionale, fa sì che esso si chiuda su se stesso, che – non trovando uno sbocco concreto positivo – finisca con l’alimentare appunto incubi e paure anziché desideri e speranze. Questa situazione, che si è andata rivelando con sempre maggiore evidenza negli ultimi dieci-quindici anni, è il risultato di due linee di tendenza che gli interventi della seconda parte del volume cercano di mettere a tema da punti di vista e con accenti diversi. La prima di queste tendenze ha a che fare con le trasformazioni economiche e sociali della provincia. Forse in nessun altra parte d’Italia si sono dati i cambiamenti strutturali che hanno segnato Brescia. Questa infatti è passata da una prima fase di industrializzazione (fine ’ - anni ’- del ’) che ha visto l’affermarsi di alcune grandi imprese nei settori metallurgico e tessile, a una seconda fase (dal secondo dopoguerra agli anni ’-) caratterizzata da medio-grandi imprese soprattutto siderurgiche e meccaniche legate al grande ciclo post-bellico delle costruzioni prima e dell’auto poi, a una terza (dagli anni ’ alla fine dei ’) che ha visto il progressivo venir meno del modello di sub-fornitura fordista (insieme alle medio-grandi imprese che lo avevano caratterizzato) e l’affermarsi della piccola e piccolissima impresa post-fordista, per finire con la crisi crescente di questo modello a fronte dei processi di globalizza- zione dei mercati e con il difficile riaffermarsi di alcune medie imprese di filiera. Brescia dunque, a differenza del nord-est, ha conosciuto una fase fordista che ha improntato la società e ha lasciato eredità importanti (nelle relazioni sindacali, nelle forme di rappresentanza degli interessi e di mediazione politica, nella stessa configurazione spaziale e nei rapporti tra città capoluogo e provincia); ma, a differenza di alcune grandi città fordiste (come Torino), pur conservando una spiccata vocazione manifatturiera, ha sperimentato il frammentarsi del tessuto economico-produttivo senza poter contare sulla continuità di leadership di alcune grandi imprese. In uno dei momenti più difficili della storia economica e sociale del Paese si è trovata così priva di riferimenti forti interni alla classe economica e nell’attesa (per ora vana) che emergano personalità imprenditoriali in grado di indicare una via. A questa insufficienza di leadership a livello economico, a cui non ha saputo sopperire neppure il sistema finanziario locale che ha scelto piuttosto la via degli investimenti e delle alleanze per vie esterne (con i risultati ben noti), si aggiunge una seconda caratteristica, che è andata anch’ essa progressivamente evidenziandosi negli ultimi anni. Si tratta della mancanza di un confronto (culturale e politico) serio sui grandi temi della società locale e della conseguente intrinseca debolezza della società civile. Questa ha conosciuto il suo momento forse più alto tra la fine dell’ e gli inizi del ’, con la felice dialettica tra le forze laiche post-risorgimentali, insediate soprattutto a livello politico-istituzionale, e il cattolicesimo sociale che fece della società civile (delle parrocchie, del credito cooperativo, delle prime precorritrici forme di welfare society) il suo luogo d’elezione e che finì con affermare la propria incontrastata egemonia, resistendo con successo allo stesso tentativo fascista di scalzarlo. Non altrettanto successo ebbe nel secondo dopoguerra, quando venne progressivamente “colonizzato” dalla società politica (innanzitutto democristiana) che seppe assimilare e fare proprie le migliori forze espressione di quella realtà, ma così depauperandola e imponendo una mediazione tutta politica sopra le dinamiche della società civile. Una ulteriore fase di depotenziamento si ebbe tra la fine degli anni ’ e i primi anni ’, quando la forte dialettica sociale di quegli anni – particolarmente sentita in una realtà ad alta intensità industriale quale quella bresciana – produsse, se possibile, una ulteriore e più grave disarticolazione della società civile. Da una parte la componente laica dei grandi imprenditori, che non si sentì più tutelata dalla mediazione politica e cercò vie autonome di rappresentanza; dall’altra il movimento operaio che vide ricompattarsi su posizioni radicali la componente comunista e quella cattolico-sindacale. Del tutto spiazzata ne uscì così la componente storica del cattolicesimo sociale bresciano, non solo nelle sue espressioni politiche, ma anche in quelle culturali. Una grande tradizione di cultura cattolico progressista perse così il suo radicamento popolare e, pur mantenendo una grande qualità intellettuale e morale, non fu più in grado di esprimere una propria egemonia e una mediazione sociale all’altezza dei nuovi problemi. Il terrorismo, la caduta del muro, tangentopoli, la fine del sistema politico della prima repubblica e con esso il collasso dei partiti di massa e l’avvento della democrazia plebiscitaria faranno il resto. È interessante notare come, dopo tangentopoli, la lunga esperienza di governo della città capoluogo da parte della coalizione di centro-sinistra sia riuscita solo in parte a riarticolare i rapporti tra le varie componenti di una società civile ormai frammentata, priva di leadership economica e (soprattutto) sempre più spaccata tra una città capoluogo in perdita di velocità e in crisi di identità e una provincia sempre più in disordinata ebollizione ma priva di riferimenti culturali e sociali. Al di là delle oggettive difficoltà legate al contesto nazionale, quella che più è mancata a livello locale è stata la capacità di alimentare un confronto vero e partecipato sul futuro della città e della provincia. Alcuni degli interventi pubblicati riflettono sul rapporto tra economia e cultura e identificano nella frattura (mai davvero ricomposta) tra la cultura alta, di stampo storico-umanistico, e la cultura popolare, tutta interna invece a un orizzonte tecnologico-materiale, una delle ragioni di questa incapacità di far dialogare le diverse componenti della società e di trovare una prospettiva condivisa. L’idea di una città capoluogo che ritrovi l’identità (e l’economia) perduta in una vocazione culturale, artistica e turistica – città universitaria, città di S. Giulia, città dello “splendore dell’arte” – pecca a mio giudizio della incapacità di “dare un’anima” ad una cultura materiale che ha bisogno di restituire un senso al proprio agire, ma che necessita di una proposta diversa per poter essere davvero indirizzata. Purtroppo, nel momento in cui scrivo queste note, si sta affossando forse definitivamente uno degli strumenti più efficaci che la società bresciana si stava dando per cercare di compiere questa operazione di sintesi: il Museo dell’Industria e del Lavoro, concepito da quello straordinario personaggio che fu Gino Micheletti, personalità emblematica e forse unica nel suo genere di questo compendio tra cultura alta e popolare, tra cultura umanistica e tecnologica. Più di S. Giulia, il MusIL potrebbe rappresentare il luogo emblematico della nuova città, il luogo di una identità ritrovata e capace di proporsi alla guida dell’intera provincia. Luogo di incontro tra la cultura umanistica e quella tecnologica, nel segno di una neo-industria che sappia innestare sul tronco ancora vitale e fortemente sentito della vocazione manifatturiera quel di più di conoscenza, design e cultura che soli possono garantire il futuro in un’era globalizzata. Oltre a questa idea della necessità prioritaria di una nuova sintesi culturale che sappia riarticolare le diverse componenti della società civile bresciana – i luoghi della cultura con quelli dell’industria e del lavoro, i ceti alti con quelli popolari, la città con la provincia – la riflessione di questi anni mi ha portato a porre attenzione ad altri elementi, non specifici della realtà locale e tuttavia anch’essi essenziali ai fini di una sua rivitalizzazione. La prima parte del volume è così dedicata a sette interventi su temi più generali, “sguardi sul presente” appunto, che hanno a che fare con l’economia nei suoi rapporti con la politica e l’etica. L’occasionalità già ricordata mi ha impedito di sviluppare un discorso compiuto su temi che meriterebbero ben altro respiro. Tuttavia alcuni spunti in essi contenuti mi auguro possano risultare utili per avviare una riflessione oggi quanto mai necessaria. Tre in particolare si rincorrono in queste pagine: quello del rapporto tra mercato, società e politica; quello dell’etica; quello della economia civile e del terzo settore. Sono temi tra loro fortemente intrecciati, che cercano di esplorare quello spazio “di mezzo” tra mercato e stato che è appunto lo spazio della società civile. Il nostro Paese, come del resto tutti i paesi occidentali più sviluppati, ha sperimentato dal secondo dopoguerra agli anni ’ del secolo scorso, la crescita pervasiva di uno stato interventista che ha cercato di regolare e di porre rimedio alle esternalità sociali negative del mercato. Questa tendenza (inizialmente positiva e progressiva) si è accompagnata tuttavia alla colonizzazione della società da parte dello stato e al decadimento della sfera di espressione dell’au- tonomia civile. La successiva fase neo-liberista ha fatto il resto, portando infine al collasso il sistema per il vuoto sociale che si è venuto a determinare, prima ancora che per la pressione esterna esercitata della globalizzazione. Rivitalizzare la capacità della società di pensare e agire per il bene comune, senza attendersi né che esso possa essere realizzato spontaneamente dalla “mano invisibile” del mercato né che possa essere affidato allo stato, esonerando i singoli dalle responsabilità conseguenti, è il compito più urgente che le difficoltà dell’oggi ci impongono. Ora a me sembra che questo compito possa avere (e stia avendo) due diverse declinazioni. Una – perseguita con determinazione e successo da destra – cerca di sopperire alle spinte centrifughe e alla delegittimazione di qualsiasi azione collettiva mediante l’esaltazione dei legami comunitari e la riaffermazione di principi etico-religiosi tradizionali. La paura (di ciò che sta “fuori”) serve a ricostituire comunità chiuse, spesso in contraddizione con le politiche neo-liberiste che si continuano a seguire a livello economico, ma in grado (nel breve almeno) di portare consenso a una qualsivoglia azione politica. L’altra consiste piuttosto nel tentativo – che chi abbia a cuore una prospettiva riformista dovrebbe perseguire con maggiore convinzione – di rivalorizzare lo spazio del confronto, il luogo di una opinione pubblica informata e critica che sappia rispettare le individualità e i punti di vista differenti, ma li sappia anche orientare ad azioni socialmente responsabili. È questo il luogo che la filosofia politica e la politologia hanno individuato con il termine appunto di “società civile”, spazio di connessione e mediazione tra l’espressione degli interessi immediati di ciascuno e la “società politica” quale manifestazione dell’interesse generale della polis. Ma perché questo processo possa dispiegarsi con successo è necessario che le forze riformiste riscoprano la dimensione “sociale” (e non solo statuale) della politica, evitando di cadere sia nel “comunitarismo” di ritorno coltivato dalla destra che nel rischio di una qualche riedizione (seppure in tono minore) di “stato etico”. Per questo è importante ripercorrere – come si fa in alcuni degli interventi presentati – i fondamenti di un’etica della responsabilità e del confronto, al di là degli schemi e delle scorciatoie del politically correct (pure presenti in alcune proposte che vanno per la maggiore di etica economica e di corporate social responsibility), ma anche in dissenso critico con un’etica fondamentalista, tanto chiusa al confronto quanto astratta e disincarnata rispetto ai dilemmi morali del presente. Così come è vitale cercare di valorizzare le esperienze di economia civile che stanno seppure con fatica venendo avanti e che costituiscono un terreno prezioso per sperimentare alternative sociali concrete ai fallimenti del mercato e dello stato. In chiusura mi si conceda un’ultima considerazione. Nessuno degli interventi qui raccolti ha come tema specifico il ruolo dell’università, anche se di questo ruolo (soprattutto nel contesto locale bresciano) si fa cenno in diversi di essi. E ciò non è conseguenza di una scelta operata nella selezione dei pezzi da pubblicare. Che ricordi, infatti, non mi è mai stato chiesto in tutti questi anni di partecipare ad un dibattito pubblico sull’università. Lascio al lettore giudicare se ciò sia la conseguenza di quella mancanza (prima lamentata) di disussione sui temi di interesse per le sorti della città o piuttosto del fatto che la presenza universitaria sia ormai completamente metabolizzata nella vita locale e vissuta come un tutt’uno inscindibile con i problemi del presente. Economia, etica, società La città tra comunità e mercato Il libro che discutiamo questa sera è una raccolta di saggi vari, potremmo dire occasionali (dettati cioè da occasioni diverse). Ma – forse proprio per questo – rivela in modo ancora più evidente un pensiero sottostante fortemente unitario. Paolo Corsini è, in questo, un intellettuale, che non rinuncia a riflettere criticamente sulla realtà che – come sindaco – rappresenta e amministra. In un momento in cui la politica diventa sempre più “arte del possibile” in senso deteriore, in cui le crescenti difficoltà di una società sempre più frantumata e ondivaga, posta di fronte a sfide globali forse senza precedenti, fanno da alibi per una politica che “naviga a vista”, questa è – almeno per chi vi parla – una qualità assolutamente preziosa. Come ci ricordava Max Weber, in un saggio che resta uno dei punti più alti della riflessione occidentale: La politica come professione, “etica della responsabilità ed etica della convinzione non sono assolutamente antitetiche, ma si completano a vicenda e solo congiunte formano il vero uomo, quello che può avere la ‘vocazione della politica’”. Altrimenti, anziché trovare la forza morale per resistere ad un mondo – per usare sempre le parole di Weber – “sempre più stupido e volgare”, l’uomo politico finisce per farsi fagocitare da quel mondo e per appiatPresentazione del libro di Paolo Corsini, La città tra comunità e mercato, Ridotto del Teatro Grande, gennaio . tirsi su di esso – che è quello che in buona misura mi pare stia succedendo oggi alla politica. Ora, questa unitarietà di fondo del pensiero di Corsini traspare da buona parte dei saggi raccolti, che trattino di problemi istituzionali e costituzionali, di welfare o di virtù pubbliche. La compatta e lucida Presentazione dà conto di questa unitarietà di pensiero e di riflessione. Il titolo – La città tra comunità e mercato – ne fornisce la chiave di lettura forse più pertinente. Ed è proprio su questo punto che voglio intrattenermi questa sera, richiamando l’attenzione dei presenti sulla problematicità evocata da questo titolo – problematicità di certo feconda perché ci permette di riflettere su una questione centrale della società e della politica d’oggi, su cui forse non si è ancora riflettuto abbastanza. Si potrebbe sintetizzare tale problematicità nella domanda: che significa “tra comunità e mercato”? È chiara – e per me assolutamente condivisibile – la pars destruens del discorso. La città, la convivenza civile non può essere lasciata totalmente al mercato, al prevalere incontrastato – per usare le parole di Corsini, che si rifà qui ad un bel articolo di Giuseppe Onofri dell’agosto scorso sul Giornale di Brescia, che non ha avuto forse l’attenzione che meritava – di “un individualismo appropriativo ed anomico al quale oggi si fa sempre più riferimento come unica espressione delle ‘potenzialità’ di ciascuno”; una città dunque “dei singoli, basata sulla competitività, sull’economia dei beni e dei consumi … una città del benessere materiale individuale che rischia di scivolare in una involuzione tecnico-quantitativa e di diventare povera di significati”. Una città e una società che vanno per questo frammentandosi e perdendo qualsiasi capacità di orientamento “forte”, qualsiasi capacità di risolvere quei dilemmi di azione sociale che impediscono di far fronte comune alle sfide che sempre più, e forse proprio per questo, ci sovrastano. E però se si passa dalla pars destruens alla pars costruens, l’alternativa al mercato non mi è del tutto chiara. È la comunità tout court? E dunque il tra è disgiuntivo e la scelta cade a favore della comunità o è piuttosto un tra che indica una via di mezzo, un qualche compromesso tra mercato e comunità? O, ancora, si presume esistere una terza modalità di organizzazione e regolazione sociale che non appartenga né al mercato né alla comunità? Si badi, il problema non è capzioso, né puramente nominalistico. Possiamo anche usare il termine “comunità” se ci aggrada, basta essere chiari su cosa contraddistingue questa modalità di convivenza e di regolazione dei rapporti sociali. Per altro il termine “comunità” occupa non solo un posto preciso nei linguaggi specialistici della sociologia e della antropologia, ma ha profonde valenze (anche emotive) nel linguaggio comune e un suo uso politico non è indifferente. Non può dunque sfuggire che un approfondimento sul punto abbia non solo un valore teorico e filosofico, ma anche importanti implicazioni politiche. Veniamo infatti, come è noto ai presenti, da una lunga fase in cui il dibattito e il confronto politico si è incentrato intorno al rapporto problematico tra mercato e stato, tra il principio di libertà e quello di uguaglianza e giustizia. Ora porre al centro della riflessione la “comunità” significa avviare un ripensamento profondo (e credo fecondo) della tradizione politica novecentesca (perseguito anche da altri importanti pensatori europei e nord americani, quali Giddens, Beck ed Etzioni), ma questo ripensamento richiede chiarezza dei punti di partenza, per evitare due rischi altrimenti incombenti: quello di un eclettismo generico e inconcludente o, ancora peggio, almeno per un pensiero che si voglia progressista, quello di una confusione con le posizioni di una certa destra culturale. In un interessante e stimolante libretto di qualche anno fa – pubblicato con coraggio e tra i mugugni dei benpensanti di sinistra da Laterza – uno dei pochi intellettuali seri della destra italiana, Marcello Veneziani, metteva a tema questo stesso punto. Il suo tentativo – insieme culturale e politico – era quello di accreditare tutta la tradizione di sinistra dentro la categoria dei liberal – coloro che si riconoscono nell’idea di emancipazione dai legami, nel progetto di una umanità liberata dai vincoli delle tradizioni, in nome di un ideale individualista di stampo illuminista e universalista – così da conquistare ad un discorso di destra la categoria dei comunitari – coloro che si radicano invece in un orizzonte sociale e culturale avvertito come orizzonte comune e significativo; coloro che (cito testualmente da Veneziani) “assegnano valore alla identità, alla provenienza, all’origine e alle vie che conducono alle radici, come le tradizioni”. È una operazione, quella di Veneziani, certo intelligente, che potrebbe evitare – da destra – per usare una efficace espressione di Alain Touraine “quel conflitto cieco tra mercati aperti e comunità chiuse” che sembra invece profilarsi minaccioso all’orizzonte della società tardo-moderna (e che sfida anche la destra italiana). Ma – proprio per questo – un pensiero riformista che voglia riconquistare centralità politica non può farsi schiacciare tout court su una posizione liberal, che – anche se la ricostruzione di Veneziani risulta un po’ riduttiva – non è più comunque capace di interpretare le nuove esigenze della tardo-modernità o, per usare un termine caro a Giddens, della “modernità riflessiva”. In questo senso un discorso sulla “comunità” importa ed è centrale anche per il pensiero progressista e lo stimolo che deriva dalla riflessione di Corsini diviene allora un punto di partenza prezioso. Non mi è possibile qui sviluppare un ragionamento compiuto sul tema, e anche se ne avessi tempo non ne sarei all’altezza. Mi limiterò a due brevi considerazioni che mi portano a ritenere che in questo importante ripensamento sia preferibile abbandonare la categoria di “comunità” e lavorare su un concetto certo non nuovo ma troppo trascurato e divenuto nel tempo del tutto marginale nella riflessione di una sinistra tutta presa nella mediazione illuministica tra stato e mercato: il concetto di società civile. L’interpretazione del “tra comunità e mercato” di Corsini che personalmente suggerirei e su cui penso si possa più proficuamente lavorare non è dunque né quella che attribuisce la convivenza civile alla forma comunitaria tout court, né quella che cerca una “terza via” eclettica e mediatoria tra comunità e mercato, bensì quella che ritrova una centralità culturale e politica nella valorizzazione della società civile appunto. Due brevi considerazioni dunque per cogliere seppure in via del tutto preliminare questa importante differenza. La prima: l’idea di comunità – in tutta la tradizione filosofica e politica occidentale – viene prima dell’idea di individuo. Sia nella sua versione più tradizionale che in quella etico-politica moderna che fonda lo stato totalitario (da Hegel a Schmitt), la comunità nega l’autonomia dell’individuo, lo subordina ad un universo di significati che lo precedono o lo trascendono e ne limitano la libertà di pensiero (prima che di azione), la sua “autenticità”. Questo non è più il sentire della tardo-modernità, che è innanzitutto e soprattutto caratterizzata da una “società degli individui”. La destra economica lo ha capito ed è stata premiata, anche se l’egoismo possessivo e la frammentazione anomica, che derivano da un individualismo fondato esclusivamente sugli interessi economici, portano poi a riesumare sempre più forme “chiuse” quando non paranoiche di comunità (si pensi ai fondamentalismi religiosi o alle forme di razzismo etnico o etico). Una sinistra che voglia riconquistare il centro della scena deve allora riconoscere l’autonomia sostanziale degli individui, ma deve spostarla da un ambito esclusivamente economico ad un ambito più ampio, culturale e dialogico. Charles Taylor, forse più di altri, ha indicato la via di un individualismo etico, il fondamento possibile di un individuo che persegue la propria autenticità nel dialogo e nel confronto con gli altri. Ma indicazioni altrettanto preziose si possono ritrovare anche in quel filone di filosofia politica personalista, a cui Corsini (e anche Onofri) sembrano guardare con interesse. Forse più che nel personalismo comunitario di Emmanuel Mounier nella riflessione di un autore come Paul Ricouer. Nella affermazione che il “tu viene prima dell’io” Ricouer riconosce infatti che è il rapporto dialogico con l’altro e non l’appartenenza ad una comunità già costituita ad essere fondativo dell’autenticità della persona umana (il “tu” infatti, non il “noi”, viene prima dell’“io”). E in questa affermazione mi pare essere contenuta la possibilità di una società civile che non viene prima dell’individuo, ma è rispettosa dei suoi interessi e punti di vista particolari, convinta che solo il dialogo e il confronto anche serrato (e talvolta conflittuale) tra esseri autentici e responsabili è fonte di significato e rende possibile il superamento di quei dilemmi dell’azione sociale che si frappongono tra la razionalità individuale e il bene comune. La seconda: in questa ricerca di un fondamento etico all’individualismo tardo-moderno, il tema della solidarietà assume un ruolo politico centrale, e fa bene Corsini toccarlo nella sua riflessione in diversi dei contributi del volume. Ma ci sono almeno tre concezioni diverse di solidarietà su cui un pensiero politico rinnovato deve misurarsi: () la solidarietà “face to face” tra persone socialmente omogenee, che condividono cioè la stessa Lebenswelt, la stessa “forma di vita”, l’universo di significati di una comunità tradizionale chiusa; () la solidarietà politica tra eguali, tra persone che si riconoscono in un discorso etico-politico comune e che perciò stesso tendono spesso ad opporsi a chi in tale discorso non si riconosce (quella solidarietà illuminista e a parole universalista che è stata però spesso alla radice di conflitti politici dirompenti tra stati e classi sociali nel secolo che si è appena concluso); e () la solidarietà inclusiva, che non disconosce ma valorizza in positivo le differenze e cerca di costruire un rapporto di fratellanza, una solidarietà aperta e responsabile in nome di una reciprocità fondamentalmente umana. (Tra parentesi: ci si dovrà prima o poi chiedere perché delle tre parole d’ordine uscite dalla rivoluzione francese due, liberté ed égalité, abbiano calamitato il centro del dibattito politico e una, fraternité, sia stata sin qui emarginata.) Credo che all’indebolimento della seconda forma di solidarietà (cara alla sinistra) si debba rispondere con la terza, se non si vuole tornare alla prima (cara alla destra). Corsini mi pare possa concordare con questa prospettiva, perché molte delle virtù civiche che tratteggia nella terza parte del libro cercano appunto di declinare concretamente questa nuova sensibilità (si veda tra tutti il bel pezzo, niente affatto di circostanza, sulle virtù degli alpini), ma una riflessione sistematica e approfondita si impone per un pensiero politico progressista all’altezza delle nuove sfide della “società degli individui”. Un pensiero politico che deve ritrovare il gusto del “volare alto”, il coraggio di un “pensiero forte” che sappia ridare alla “società civile” la prospettiva di nuove capabilities (per usare la grande lezione di Amartya Sen), di nuove potenzialità e speranze. Corsini apre il suo bel libro con una lunga epigrafe tratta da Le città invisibili di Italo Calvino. Voglio anch’io concludere con una citazione dallo stesso libro: “Le città come i sogni sono costruiti di desideri e di paure”. Bene, a me pare che la nostra società e questa nostra città sia sempre più governata dalla paura (dalla paura dei diversi, dalla paura della precarietà e dell’incertezza economica, dalla paura della guerra, dalla paura di essere sorpassati da una innovazione tecnica continua… e via dicendo, di paura in paura). Alla politica spetta innanzitutto il compito di ridare fiducia, di rinnovare i desideri, perché solo i desideri ci permettono di passare sopra ed oltre le nostre paure. Etica civile, politica, cittadinanza È un onore ma anche una grande responsabilità discutere un contributo così impegnato, coraggioso e insieme equilibrato quale quello consegnatoci dal presidente Casavola. Una riflessione, su temi così delicati e attuali, che è difficile commentare rimanendo all’altezza della sua qualità intellettuale e morale. Ma tant’è, dal compito del discussant non ci si può sottrarre, e allora mi proverò a chiosare alcuni passaggi del testo che mi paiono particolarmente illuminanti, cercando di spiegare perché. Da sociologo parto dalla “coda” della riflessione di Casavola, che è però anche l’inizio del tema che ci è stato affidato: la città “plurale”. La città di oggi, la città dentro la quale siamo chiamati ad esercitare la nostra responsabilità di cittadini democratici, non è più né la città tradizionale, la civitas pre-moderna, primo luogo di incontro e confronto di ceti sociali che cominciavano a diversificarsi professionalmente ma comunque ancora tutti appartenenti ad una cultura che rimane nella sostanza comune ed omogenea (comunità); né è la città “pluralista” della modernità industriale occidentale: luogo di confronto (e anche di scontro) tra due culture: la cultura borghese liberale (che valoDiscussione dell’intervento di Francesco Paolo Casavola, Nella città “plurale”: cammini e impegni per una cittadinanza democratica, Università Cattolica – sede di Brescia, marzo ; già apparso in Luciano Caimi (a cura di), Cittadini in crescita, Vita e Pensiero, . rizza l’individuo e il merito) e quella socialista (che valorizza la eguaglianza e la giustizia), due culture – entrambe appartenenti alla tradizione storico-filosofica e morale dell’occidente – che hanno trovato, attraverso un percorso storico difficile ma ricco di fertilizzazioni incrociate, un modus vivendi positivo dentro appunto la città “pluralista” del secondo Novecento. La città “plurale” tardo-moderna – come nota lucidamente Casavola – è invece caratterizzata da due tensioni in un certo senso opposte che spezzano la dialettica pluralista della modernità occidentale. Da un lato, il processo di ”individualizzazione”: “non classi o ceti, ma individui che transitano da una attività professionale ad un’altra senza lasciare che essa si irrigidisca in uno statuto identitario” – per citare Casavola; e dall’altro l’ingresso, attraverso la globalizzazione e l’immigrazione, di culture appartenenti a civiltà diverse da quella occidentale. La nozione moderna di cittadinanza viene così ad essere messa in discussione, soprattutto perché occorre tenere insieme due dinamiche profondamente diverse tra loro: quella degli individui che non si riconoscono più in alcuna definizione condivisa di città e quella di civiltà diverse che rivendicano identità collettive forti e che “sottraggono gli individui ad una uguale cittadinanza”. È questa duplice sfida che impone un ripensamento radicale della nostra responsabilità di “cittadini”, che chiede una rinnovata “educazione alla cittadinanza”. Ed è qui che la lezione intellettuale e morale di Casavola risulta fondamentale. Egli parte innanzitutto da una concezione “sostanzialistica” e non meramente formale o procedurale di cittadinanza: “sono i fini che si intendono perseguire a dare significato alla cittadinanza”. E soprattutto introduce una distinzione che reputo essenziale anche perché purtroppo mi pare sia oggi spesso cancellata da , , chi vorrebbe trovare “scorciatoie” a buon mercato ai problemi epocali che ci stanno di fronte: i fini sono “il bene della persona e il bene della comunità. Il primo è nel cerchio della coscienza, il secondo nello spazio della politica”. La distinzione tra etica e politica è dunque essenziale ma non può essere astratta e nominalistica. E infatti Casavola prosegue: “ma se occorresse dover scegliere tra la persona e la comunità? Etica e politica uscirebbero dalla tranquillità dei loro alvei. E le decisioni sarebbero affidate agli uomini, riformatori o rivoluzionari, governanti o giudici, ultimi o primi tra i cittadini. In quel giorno si rivelerà la forza o la fragilità dell’educazione alla cittadinanza”. E allora se vogliamo essere pronti a questa evenienza che mi pare sia alle porte, se non già ben dentro le nostre città, dobbiamo chiarire quale etica e quale politica possano aiutarci in questo difficile compito, senza cortocircuitare l’una sull’altra ma anche senza pensare che ci possa essere una distinzione facile e scontata tra le due. Quale etica allora? Per una rinnovata cittadinanza un’etica civile è essenziale, ha ragione Casavola. Ma ha soprattutto ragione quando ci ricorda che se si cortocircuita etica e politica si apre la strada allo “Stato etico”, quanto di più nefasto per la dignità della persona umana la storia abbia sperimentato. A me pare però che i prodromi dello “Stato etico” – come reazione insieme alla amoralità montante e alle difficoltà crescenti della politica – siano tuttora ben presenti e non solo in altre civiltà politiche, più o meno fondamentaliste e integraliste, ma anche qui da noi, in quella – per citare ancora Casavola – “pretesa dominante di trarre dall’etica regole tecniche, accompagnate preferibilmente da sanzioni giuridiche, per governare senza dilemmi tutti gli aspetti della vita umana, personale e collettiva”. Mettere un’“etica della convinzione” (nella definizione weberia- na: “fa quel che devi, accada quel che può”) al servizio dell’economia, della politica, dell’ecologia, della biologia, del diritto è una “scorciatoia” comoda per pensare di risolvere i problemi epocali della città “plurale”, ma una scorciatoia che non porta da nessuna parte. Un’etica civile deve essere invece un’“etica della responsabilità” (“fa tutto ciò che puoi perché accada quel che deve”). Un’etica cioè che impegni ad azioni concrete nella contingenza. Un’etica basata sul rispetto e sulla testimonianza. Sul rispetto dei principi altrui: dove “rispetto” non vuol dire tolleranza a buon mercato di qualsiasi principio morale quando non indifferenza relativistica ai valori morali, ma confronto aperto e autentico (mi piace ricordare a questo proposito l’alta lezione che al riguardo potremmo trovare nel ripercorrere lo spirito della Summa contra gentiles di S. Tommaso). E sulla testimonianza dei propri principi, perché i valori non si proclamano, si vivono e si testimoniano. Anche qui Casavola ci dà una lezione morale importante quando ci ricorda il monito evangelico della pagliuzza nell’occhio del fratello e della trave nel nostro. Non già dunque una morale “debole” ma “forte”: non però nella proclamazione astratta di principi quanto nella ricerca di autenticità e di assunzione di responsabilità. E veniamo alla seconda questione: quale politica per l’esercizio di una cittadinanza democratica? Anche la politica deve infatti adeguarsi alle nuove sfide. Il rischio in proposito è speculare a quello appena visto nel fondamento di un’etica civile. Per usare categorie ben note al pensiero politico occidentale, se quello di cui abbiamo bisogno oggi è ridefinire, accanto al bene della persona, anche il “bene della comunità” e a tale scopo il principio liberale della “libertà negativa”, perorato da Isaiah Berlin, non è più oggi sufficiente, bisogna comunque essere , , molto cauti nei confronti delle tendenze comunitariste oggi in gran voga ma che finiscono, a mio giudizio, inevitabilmente per mettere una morale al servizio della politica. Se si vuole evitare il cortocircuito tra etica e politica, accanto ad una educazione all’etica civile è necessaria allora anche una educazione alla “virtù civica”. Una virtù che si sostanzia (nella tradizione di quel repubblicanesimo politico che meriterebbe di essere oggi più che mai riscoperto) nel rispetto di tre principi: () il principio deliberativo: la politica non si fa né a colpi di maggioranza né dando spazio alla negoziazione corporativa tra interessi costituiti, bensì attraverso il dibattito informato e l’argomentazione basata su una ragione dialogica; () il principio inclusivo: tutti i punti di vista e gli interessi presenti nella città devono poter essere fatti valere e avere uguali chance di voce nel processo deliberativo; () il principio ricettivo: gli atti di governo della città devono essere sottoponibili a contestazione, anche se la contestazione non deve necessariamente pretendere di essere accolta ma solo di essere sottoposta al vaglio della ragione deliberativa. Sono questi principi che non solo permettono di raggiungere una definizione sostantiva ancorché contingente di “bene comune”, ma anche e soprattutto di tutelare l’autonomia e la responsabilità etica dei cittadini. Solo così – con buoni figli, padri, fratelli e amici ma anche con buoni cittadini – potremo sperare di fare nostra la lezione tramandataci da Joseph Schumpeter e quanto mai attuale nella città “plurale” tardo moderna: “Rendersi conto della validità relativa delle proprie convinzioni eppure difenderle senza indietreggiare è ciò che divide un uomo civile da un barbaro”. E nella barbarie incipiente è un monito da non scordare. Etica e mercato in una società globale Il tema affidatomi è di tale complessità e delicatezza che il poco tempo che ho potuto dedicare ad esso sconsiglia una trattazione sistematica. Mi limiterò piuttosto ad una traccia per punti, nella speranza che la loro forma aperta (e anche un po’ grezza) trasmetta al lettore, più che tesi confezionate, stimoli e possibili percorsi di approfondimento. La globalizzazione: una sfida con ancora poche risposte Quella della globalizzazione è una grande sfida che gli attuali strumenti concettuali e analitici che possediamo non sono ancora in grado di controllare pienamente. Di qui la tendenza ad una forte radicalizzazione e ideologizzazione delle posizioni. Così la globalizzazione è, per alcuni, vittoria del mercato sulle società nazionali, sui vincoli imposti dai sistemi politici welfaristi, e preludio di una nuova era di “magnifiche sorti e progressive” del capitalismo mondiale; per altri – di contro – ritorno al darwinismo sociale, all’ideologia della sopravvivenza del più forte, con un regresso etico-politico senza precedenti e soprattutto con il rischio di consegnare l’economia alla volatilità dei mercati finanziari e i sistemi sociali a possibili contraccolpi politici di stampo autoritario. Intervento alla conferenza organizzata dal Centro Universitario Diocesano, Facoltà di Economia, maggio . Le due posizioni estreme, in verità, rischiano di non cogliere la sostanza dei processi in atto e possono portare a politiche fuorvianti. Un bilancio più preciso e meno pregiudicato ideologicamente, anche se non facile, si impone. I pro e i contro della globalizzazione I benefici dei processi economici di mondializzazione dell’economia sono difficilmente negabili. Essi attengono: . allo sviluppo del commercio mondiale e alle conseguenze economiche positive sulla ricchezza delle nazioni; . alla crescita degli investimenti internazionali, alla delocalizzazione produttiva e alla fine della vecchia divisione internazionale del lavoro con effetti positivi sul sottosviluppo e sulla povertà di alcune aree del mondo (Asia e America latina); . alla “apertura” delle società e all’indebolimento degli assolutismi politici con conseguenze che non potranno nel lungo periodo che essere positive sui diritti civili e politici dei popoli. Ci sono per altro anche molti effetti negativi o che comunque chiedono di essere gestiti in modo più efficace di quanto sia stato sin qui fatto: . crescono le differenze e le ineguaglianze economiche e sociali tra paesi e tra gruppi sociali. Cresce soprattutto la percezione soggettiva di queste differenze con inevitabili e spesso accentuati effetti di delegittimazione sociale e politica; . alcune aree del mondo (Africa in primis) sembrano essere incapaci di entrare nel gioco della nuova divisione internazionale del lavoro con conseguenti forme sempre più acute di povertà e disagio sociale che delegittimano i sistemi politici e provocano tensioni e conflitti sia interni che tra paesi ed etnie vicine; . anche se in una prospettiva di medio-lungo periodo – come sopra affermato – la globalizzazione potrà avere effetti positivi sulla democrazia e sui diritti civili dei popoli, nel breve la crisi di legittimazione politica, di cui al punto precedente, può produrre (e ha in effetti già prodotto in diverse occasioni) reazioni autoritarie; . la forbice divaricante tra paesi ricchi e paesi poveri (meno poveri in assoluto ma non in termini relativi) e la possibilità di confronto tra le diverse condizioni di vita permessa dalla diffusione dei mezzi di comunicazione alimenta flussi immigratori sempre più consistenti e drammatici per le conseguenze umane e sociali che essi comportano; . la concorrenza dei paesi emergenti, la delocalizzazione produttiva, le conseguenze sui mercati del lavoro interni dei flussi migratori generano tensioni e reazioni anche da parte dei gruppi sociali più deboli dei paesi sviluppati, preoccupati per la disoccupazione, la riduzione dei salari e il peggioramento delle condizioni di vita. L’ideologia neoliberista del mercato come “mano invisibile” – come sistema automatico e irresponsabile di allocazione delle risorse e di governo della società – sembra in verità nascondere piuttosto l’impotenza di fronte a processi sempre più complessi e difficili da controllare (salvo ovviamente ricredersi nevroticamente appena qualche cosa non va per il verso giusto, come accade sistematicamente dopo ogni perdita un po’ consistente delle borse mondiali). Mercato e politica nella globalizzazione Eppure la riflessione teorica (delle scienze economico-sociali e politologiche) è andata parecchio avanti negli ultimi anni nel fare luce sulle logiche di fondo di coordinamento e governo dei fenomeni sociali complessi e ha colto sia i limiti del mercato che quelli della politica. In condizioni di complessità crescente e di incertezza il mercato resta un insostituibile meccanismo di allocazione delle risorse e di coordinamento sociale. È l’unico meccanismo infatti in grado di garantire: () un coordinamento decentrato; () la varietà interna e dunque la tempestività nel far fronte all’incertezza; () delle adeguate motivazioni individuali, necessarie per promuovere innovazione e sviluppo economico e sociale. Per altro i limiti o, come è stato detto, i “fallimenti del mercato” sono ormai universalmente riconosciuti dalla letteratura specialistica. Tali limiti sono da ricondursi principalmente: () alla presenza di esternalità; () ai comportamenti opportunistici consentiti dal mercato e che impediscono la produzione ottimale di beni pubblici; () alla “miopia” delle decisioni che conduce spesso ad equilibri stabili ma inefficienti. La risposta “classica” a tali fallimenti del mercato attraverso le istituzioni e la politica, ancorché sembri necessaria, non garantisce di per sé la soluzione di tutti i problemi, anzi (dopo l’esperienza degli stati sociali di stampo keynesiano) è accertato che può a sua volta produrre effetti negativi. Anche su quelli che vengono chiamati i “fallimenti dello stato” la letteratura specialistica ha raggiunto notevoli punti di convergenza. I meccanismi di allocazione e di governo per via di autorità finiscono infatti: () con l’imporre finalità e prospettive che riducono la varietà interna; () con il portare ad “abusi della ragione” e ad esiti catastrofici di fronte alle sfide dell’incertezza; () al meglio, con il determinare la “burocratizzazione” della società e il venir meno delle motivazioni individuali al cambiamento e allo sviluppo. Pare sempre più evidente che il sentiero di uscita da questi fallimenti congiunti è la ricerca di un mix ottimale di meccanismi sia di mercato che politici e normativi. In questo senso alle istituzioni politiche compete il compito non già di sostituirsi ai meccanismi di mercato quanto di: () stabilire delle regole che impediscano i più evidenti fallimenti del mercato e () assicurare un livello (minimo) di solidarietà sociale che garantisca a tutti gli individui alcuni diritti di base – la sicurezza minima necessaria – senza interferire sull’autonomia individuale e sulla libertà di definire i propri bisogni. Come ricordava Keynes: “l’azione dello stato deve essere tale da lasciare i mercati con più speranze che paure”. Ma è proprio questa la grande sfida posta dalla globalizzazione: l’indebolimento degli stati nazionali nelle loro capacità di intervenire sulle dinamiche economiche nonché il disfacimento del tessuto normativo e fiduciario delle comunità locali sembra rendere sempre più difficile la definizione di regole e la costruzione di istituzioni efficaci. In particolare la dinamica spontanea degli interessi all’interno delle arene politiche costituite non sembra più in grado di raggiungere risultati istituzionali efficaci e stabili. Di qui l’enfasi crescente su possibili riferimenti etici condivisi che possano legittimare e dare efficacia a nuovi obiettivi politici e istituzionali all’altezza delle sfide che ci attendono. Un’etica per una società globale L’etica è rientrata così negli ultimi tempi fortemente in gioco come strumento per fondare nuovi discorsi politici e istituzionali adeguati alle nuove esigenze poste dalla globalizzazione. Ma quale etica può efficacemente legittimare istituzioni e quadri normativi in una dimensione globale? È questo un terreno in verità pieno di trappole e dunque di grande delicatezza. Propongo due sole riflessioni che mi sembra però colgano alcuni dei problemi più urgenti sottesi ad una nuova etica per una società globale. . Etica della responsabilità vs. etica della convinzione. Troppo spesso i discorsi etici che circolano oggi sono ispirati ad una etica della convinzione, vale a dire a principi universalistici astratti, secondo la regola “fa quel che devi, accada quel che può”. È un’etica alta, che sembra bene adattarsi alla dimensione globale dei problemi sul tappeto, ma che a mio giudizio rischia di depotenziare ulteriormente le possibilità di una azione politica responsabile e di divenire niente altro che un alibi per coscienze sensibili ma distratte e disimpegnate. Quello di cui si ha davvero bisogno è invece un’etica della responsabilità, che pretende si risponda delle conseguenze prevedibili delle proprie azioni (e omissioni), secondo la regola “fa tutto ciò che puoi perché accada quel che deve”. Un’etica che impegni cioè ad azioni concrete, possibili e responsabili delle loro conseguenze. Non si va molto avanti proclamando, ad esempio, un astratto (e di per sé sacrosanto, sia ben inteso) diritto alla vita, se non ci si “sporca poi le mani” prendendo parte a favore o contro un’azione militare (che provocherà inevitabilmente delle vittime) in difesa dei più deboli o per difendere un equilibrio internazionale la cui rottura rischierebbe altrimenti di provocare la perdita di migliaia di vite umane. . Etica del riconoscimento vs. etica universalistica. Un’altra alternativa importante è tra un’etica che cerchi di fondare principi universali di equità e giustizia in grado di legittimare le istituzioni politiche internazionali (e locali) e una etica che sia invece rispettosa delle diverse specificità culturali e fondi le istituzioni e la politica sul riconoscimento e il rispetto delle diversità. Mi pare di poter dire che nei discorsi odierni sull’etica economica e sociale tenda a prevalere la prima impostazione, quella cioè di una “globalizzazione della giustizia sociale”, con il rischio di imporre ad altre culture una concezione occidentale ed etnocentrica di giustizia. A mio parere invece un’etica per una società globale non può che essere fondamentalmente un’etica del riconoscimento interetnico, secondo il principio di “non fare agli altri quello che vorresti facessero a te: potrebbero avere gusti diversi”. L’etica nelle relazioni d’impresa Quello dell’etica degli affari è un tema che negli ultimi anni ha suscitato crescenti interessi. Dico subito che il mio approccio sarà piuttosto critico rispetto a questa recente tendenza, che ha fatto dell’etica una parola alla moda dopo essere stata a lungo confinata nei dizionari. Da un lato capisco l’importanza del recente movimento etico in campo economico: è il segno di una ripresa importante della dimensione civile e sociale che per troppo tempo era stata schiacciata dal mercato e dallo stato. Dall’altro però diffido dall’“ideologia” etica, dal consensualismo a buon mercato che intorno all’etica si vorrebbe costruire, liberandosi così dai problemi “duri”, concreti e spesso fonte di conflitto, che l’economia delle società industriali e post-industriali si porta dietro. Dunque, come afferma Platone per la giustizia, bisognerà prima o poi strappare il nome dell’etica a quanti lo prostituiscono. Qui mi limiterò ad alcune linee di riflessione (certo non complete e sistematicamente argomentate) al riguardo. Un fondamento “razionale” all’etica di impresa Uno dei principali filoni di etica di impresa cerca di fondarla a partire dall’utilitarismo laico e razionale proprio della teoria Intervento alla conferenza organizzata dal Centro Universitario Diocesano, Facoltà di Economia, aprile . economica. È un filone importante perché cerca di fondare un discorso etico a partire dal funzionamento economico di mercato. Il ragionamento è rigoroso e di per sé interessante (anche se, come cercherò di sostenere, non esaustivo per un discorso autenticamente etico). Tale filone trae origine dalla riflessione sui limiti del mercato come “mano invisibile” e sui costi di transazione che – derivati dalla carenza di informazioni – impediscono al mercato di essere un allocatore efficiente di risorse (“vizi privati, pubbliche virtù”). È dunque Williamson (e il filone neo-istituzionalista) ad essere alla base di questa riflessione. Williamson, come è noto, ritiene che a questi problemi si sia risposto attraverso l’autorità delle organizzazioni (e in particolare l’autorità dei manager dell’impresa). Ma da più parti (a partire da Ouchi) si è obiettato che l’autorità non è risolutiva in quanto può funzionare solo quando è percepita come legittima da parte di coloro che vi sono sottoposti. Viceversa comportamenti opportunisti sono sempre possibili sia da parte di coloro che detengono l’autorità (che useranno a loro esclusivo interesse il potere che deriva loro dalla carica che ricoprono), sia da parte di coloro che a tale autorità dovrebbero essere in via di principio sottoposti. Le varie teorie della “produzione di squadra” (dove l’opportunismo è tra i lavoratori stessi), della “agenzia” (opportunismo dei manager verso i proprietari del capitale), e delle “coalizioni” (tra manager e lavoratori contro altri lavoratori e/o proprietari) sottolineano come sia possibile adottare comportamenti opportunisti anche in presenza di una organizzazione gerarchica (con costi organizzativi di implementazione e controllo che, in assenza di consenso, possono far fallire l’organizzazione così come il mercato). È Ouchi che – a partire dall’esperienza giapponese fortemente intrisa di comunitarismo aziendale – ha sottolineato il rilievo di una condivisione sostanziale di valori comuni per rendere le organizzazioni efficienti (clan). Altri hanno pensato che codici etici di impresa potessero introdurre anche nelle imprese occidentali i benefici del sistema giapponese. In questa visione i codici etici – proposti innanzitutto dai manager come auto-contenimento del loro potere discrezionale – dovrebbero funzionare come sistema di vincoli preventivi in grado di innescare un “gioco” non distruttivo (non opportunista e defezionista bensì cooperativo) tra le varie componenti dell’impresa. Problemi e limiti di questa impostazione Questa impostazione dell’etica di impresa è certamente interessante sotto molti profili: () sottolinea l’insufficienza del mercato e dei comportamenti orientati esclusivamente all’interesse individuale; () nondimeno salvaguardia l’autonomia dell’individuo come base di qualsiasi discorso di progresso (economico ed etico); () richiama infine la necessità di una discussione razionale tra portatori di interessi diversi per raggiungere una base di cooperazione possibile. Ma che cosa non (mi) convince in questa impostazione? Tre punti paiono particolarmente deboli. Innanzitutto l’ottimismo a priori di questa impostazione che ritiene si possano eliminare i problemi e i conflitti di interessi sulla base di un codice etico “buono per tutti”. L’etica è invece principio di giudizio e il carattere intricato e imprevedibile delle esigenze sociali rende la capacità di giudizio un elemento essenziale al fine di una valutazione etica. Ne conseguono – ed è il secondo elemento di debolezza – dei principi il più delle volte astratti, privi di impatto reale sui problemi di impresa, che necessitano di una “interpretazione” che costituisce la vera sostanza etica del problema. L’etica – quella vera – è sempre soluzione dei problemi “nella situazione” e non affermazione di principi generali astratti. Infine il fatto di porsi come alternativa ad altri sistemi di soluzione dei problemi dell’impresa, quali la contrattazione sindacale, la democrazia di impresa o l’intervento legislativo, mentre l’etica – quella vera – ritengo debba essere rispettosa di questi momenti e situarsi semmai su di un piano più elevato, come discorso sui principi guida dei processi sociali di discussione e soluzione dei problemi. In sintesi, l’etica delle relazioni di impresa così come è attualmente praticata nei codici d’impresa e nei movimenti manageriali e imprenditoriali al riguardo è un etica del consenso (e del senso comune), che fa leva sulla tolleranza e il pluralismo degli interessi già costituiti, per attuare una conservazione “democratica” e a buon mercato dell’esistente. Per un’etica della verità Personalmente credo che l’etica debba aspirare ad altro che alla semplice garanzia a priori della cooperazione sociale a partire da interessi dati. L’etica – e dunque anche l’etica delle relazioni di impresa – ha la sua radice più profonda nella sostanza umana, dall’essere l’uomo un vivente non meramente adattivo (come tutti gli altri animali) ma pro-attivo, capace cioè di modificare creativamente l’ambiente in cui è inserito e se stesso. In questo suo essere non adattivo (non meramente governa- to dal principio di conservazione) l’uomo è capace di intenzionalità e progettualità, di rotture dell’esistente, alla ricerca di verità che trascendono le soluzioni presenti (e dunque gli interessi costituiti). Ma questa ricerca non è – e non può essere – condotta sulla base di una verità terrena assoluta (qui sarebbe interessante rileggere la teologia cristiana dell’incarnazione come momento del rapporto tra Verità trascendente e verità terrena): la verità (con la v minuscola) è sempre ricerca rischiosa (non scontata a priori nella sua valenza di bene o di male) di una soluzione “nella situazione” contingente dei problemi. Se ciò che contraddistingue l’uomo è dunque la ricerca continua della verità nel contingente e l’etica è il discorso su questa azione, allora l’etica si compone di pochi principi generali che riguardano tale azione (una sorta di meta-discorso sul processo di giudizio umano) – azione che avviene concretamente dentro e attraverso le istituzioni e le relazioni sociali pratiche (la contrattazione sindacale, le istituzioni partecipative di impresa, i consigli di amministrazione, la legislazione d’impresa, ecc.). Quali sono questi principi di un’etica della responsabilità umana? Senza pretesa di completezza enuncio quelli che paiono a me i principali: () il riconoscimento della pluralità dei fini individuali: quale pre-condizione di una ricerca di verità che è il frutto della pluralità di esperienze e diverse sensibilità degli uomini; () la responsabilità personale della propria verità: il coraggio di affermare pubblicamente le proprie posizioni, di non tramare in segreto per la loro affermazione, in una parola la trasparenza dei propri giudizi e delle proprie azioni; () l’essere fedele alla propria verità: il coraggio di non cedere ai propri interessi immediati e tradire la propria ricerca di una soluzione universale. Come dicono gli Angeli quando strappa- no l’anima di Faust morente al Diavolo: “Quegli che costantemente si sforza di avanzare, quegli è colui che poi possiamo salvare”; () non adorare simulacri: non pretendere che la propria verità sia la Verità in nome della quale si possa applicare anche il terrore per imporla e “redimere” gli altri. Essere come dice Rorty ironici, sfuggire il senso comune per sostenere con forza la propria verità ed essere al contempo capaci di non prendersi mai fino in fondo sul serio; () infine riconoscere che vi sono aspetti innominabili, che la Verità (con la V maiuscola) ci sfugge comunque, che la nostra è una eterna, asintotica ricerca, mai paga e conchiusa. Questi pochi principi etici ci garantiscono sia contro l’integralismo che contro il conformismo. Dobbiamo avere il coraggio delle nostre verità, pur scomode esse siano, pur conflittuali esse siano (la verità produce sempre conflitto); senza per altro mai prevaricare sugli altri e su noi stessi. Abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di combattere le opinioni che riteniamo sbagliate. L’etica è sempre in questo senso etica militante. Ma dobbiamo nondimeno rispettare la persona del nostro nemico, perché anch’egli è alla ricerca di una verità e a lui comunque si indirizza la “nostra” verità. Ma cosa c’entra quest’etica con le relazioni di impresa? C’entra nella misura in cui ci impone di essere coraggiosi, leali e responsabili nei luoghi istituzionali e organizzativi, nella ricerca di soluzioni concrete ai grandi problemi che interessano le imprese e i lavoratori. Ha poca importanza affermare un principio generico di rispetto del lavoro, se poi di fronte a gravi problemi di impresa lo si viola licenziando. E, sia detto per chiarezza, sarebbe altrettanto poco etico mantenere l’occupazione in una situazione tale da produrre il fallimento dell’impresa (con conseguenze gravi anche per gli altri lavoratori). È etico invece cercare la soluzione contingente al problema, responsabilmente (non delegando ad altri l’incarico spiacevole!) e senza sotterfugi, ben sapendo quali sono i costi che si distribuiscono e valutando tale distribuzione in termini di equità. Non sottraendosi cioè dai luoghi di dibattito e di conflitto sul problema. Sono molti i temi che le relazioni di impresa pongono agli uomini “di buona volontà” che sono alla ricerca autentica di soluzioni non preconfezionate: il problema dell’occupazione in sistemi sempre più labour intensive; il problema dell’alienazione e del coinvolgimento dei dipendenti nella gestione “intellettuale” dell’impresa; i problemi ecologici e di macro-riequilibrio (tra nord e sud del mondo, ecc.). Ma non sarà l’etica del consenso e del senso comune a risolverli bensì le istituzioni e i conflitti tra punti di vista diversi, portati avanti da uomini che si riconoscono in un’etica della verità. La responsabilità sociale dell’impresa: utopia o progetto perseguibile? Ho sempre avuto un’opinione per così dire “disincantata” nei confronti dei bilanci sociali, dell’etica economica o, per usare un termine più generale e comprensivo, della cosiddetta “responsabilità sociale dell’impresa” (RSI). Il più delle volte infatti, la mia impressione è che si tratti di un’abile operazione di cosmesi con la quale si cerca di ottenere consenso (relativamente a buon mercato) in presenza di una crisi di legittimità etico-sociale delle imprese e del loro management. Il caso Enron insegna; o, per dirla con Piercarlo Maggiolini, la RSI come sintomo del disagio esistenziale dell’economia post-industriale. E i sintomi – come è noto – sono rivelatori. La RSI, se presa seriamente (in modo critico ma non prevenuto), può costituire un punto di partenza interessante e proficuo per comprendere alcuni problemi di fondo dell’economia e più in generale delle società tardo-moderne. Non è vero che non ci siano dei cambiamenti epocali in atto, è vero piuttosto che la cultura e la politica sono afasiche rispetto a questi cambiamenti: c’è una sorta di “coazione a ripetere” gli stessi modelli e le stesse soluzioni di un tempo quando molto sta cambiando nelle profondità dell’economia e della società post-industriale. La RSI è un varco utile per riflettere su questi cambiamenti, a patto però che venga presa appunto sul serio. Presentazione del Bilancio sociale della Camera del lavoro di Brescia, Facoltà di Economia, dicembre . Non so se risponderò alla domanda posta dai promotori di questo incontro. Il problema non mi sembra infatti tanto quello se si tratti di un’utopia irrealizzabile (ancorché desiderabile) o di un progetto perseguibile, quanto piuttosto cosa significhi davvero e semmai a quali condizioni possa divenire l’innesco di un reale processo di cambiamento – l’avvio di un processo dagli esiti tutti da scoprire, non l’esito ideale forse irraggiungibile ma chiaro e desiderato. La logica del bilancio sociale, in cui la RSI si è sin qui estrinsecata, è quella di “render conto” dei risultati dell’impresa non soltanto ai proprietari/azionisti ma a tutti i cosiddetti “portatori di interessi” (i cosiddetti stakeholder nell’accezione anglosassone), ovvero a tutti coloro che sono direttamente o indirettamente toccati dall’azione dell’impresa stessa: oltre ai proprietari/azionisti dunque, i dipendenti, i consumatori, i fornitori, i concorrenti e la collettività tutta. Dal punto di vista dell’economia classica e del liberismo economico, una tale preoccupazione è senza senso. La missione dell’impresa è infatti quella di creare valore (economico) e la responsabilità dei manager è di generare tale valore e di renderne conto ai proprietari/azionisti (che beneficiano di tale valore sotto forma di profitto). Il perseguimento del bene sociale non è nella responsabilità dell’impresa (e dei manager) ma consegue spontaneamente alla creazione del valore da parte di quest’ultima attraverso la “mano invisibile” del mercato. Nel dibattito fondativo si pone dunque una contrapposizione tra l’approccio della responsabilità sociale dell’impresa (RSI) e quello del valore per gli azionisti (VA). E da qui conviene partire. Che cosa non convince (o almeno non mi convince) in questa posizione liberista? Principalmente l’ottimismo acritico sull’efficienza del mercato nel garantire il bene sociale. La stessa teoria economica riconosce infatti l’esistenza delle cosiddette esternalità: i prezzi non sempre riflettono i costi e i benefici sociali e di conseguenza questi ultimi possono divergere da quelli economici privati. Possiamo dunque affermare che il valore economico diverge dal valore sociale a causa delle esternalità. È una proposizione accettabile questa? Io credo di sì, credo che sia un modo serio per impostare il rapporto sempre problematico tra economia e società e quindi dare un fondamento serio alla RSI. Se vale questa non coincidenza tra valore economico e valore sociale in presenza di esternalità, allora si può rispondere ad alcune domande che gli economisti critici (ma non prevenuti) spesso pongono ai sostenitori della RSI: l’impresa è in grado di generare spontaneamente le azioni suggerite dalla responsabilità sociale? E i benefici generati da tali azioni superano i costi della loro produzione? L’impresa non è in grado di generare spontaneamente le azioni suggerite dalla responsabilità sociale perché sono appunto esternalità, ancorché i benefici generati da tali azioni possano superare i costi per la loro produzione. Siamo cioè in presenza di un classico dilemma dell’azione sociale: non si generano spontaneamente benefici perché questi vanno a tutti mentre i costi della loro produzione debbono essere sostenuti da ciascuno. È compito delle istituzioni internalizzare costi e benefici così che si possa generare un maggiore valore sociale. Questo dilemma si presenta ai manager dell’impresa sotto forma del ben noto problema della massimizzazione intertemporale del valore. Conviene massimizzare a breve, garantendo ritorni elevati immediati ai proprietari/azionisti anche a scapito dei rendimenti medi su un arco temporale più lungo (ma quanto lungo?), oppure appunto a medio-lungo termine, pun- tando cioè a creare un valore maggiore dell’impresa grazie ad una più equa e condivisa distribuzione dello stesso? Chi ragiona in questo secondo modo è portato a tener conto del valore sociale e non solo di quello economico, del valore cioè per l’impresa della coesione sociale e/o della qualità della vita dei propri stakeholder. Ora – sia chiaro – anche i liberisti non negano l’esistenza delle esternalità. Ritengono però che queste possano essere facilmente identificate e ad esse si possa porre rimedio attraverso opportuni interventi legislativi (come ad esempio nel caso dell’inquinamento o della formazione dei lavoratori). E così è stato infatti per una lunga fase storica, quella della modernità industriale: alle esternalità – grazie anche all’impegno sindacale e al ruolo dei partiti socialdemocratici o pro-labour – si è data una risposta politico-istituzionale di carattere generale. In una parola il welfare state, con i suoi diritti sociali riconosciuti e sanciti dalle legislazioni nazionali e con le sue istituzioni chiamate a implementarli. Considerare dunque oggi “seriamente” la RSI significa (e di questo bisogna pur essere consapevoli) mettere in discussione quella soluzione politico-istituzionale generale che ha retto per una lunga e importante fase storica. La RSI è il segno del superamento e del venir meno di quella risposta fornita dal welfare state. Sarebbe interessante – ma troppo lungo qui – chiedersi il perché. Una risposta, del tutto insufficiente per la verità alla complessità della questione, è che il problema delle esternalità è assai più complesso e di difficile soluzione di quanto ritenga non solo l’ottimismo liberista ma anche la soluzione welfarista (almeno in società dai bisogni sempre più diversificati e sofisticati). Nella tardo-modernità emergono cioè esternalità “sottili” che solo una attenta valutazione, frutto di un dibattito pubbli- co informato, è in grado di rilevare e misurare: si pensi – come esempio rilevante – al concetto sfuggente e tuttavia sempre più avvertito nelle società tardo-moderne di “qualità della vita”. Quanto siamo disposti davvero a pagare per una qualità di vita migliore? E come è possibile tener conto di questo valore nel determinare i costi sociali di una impresa? È a domande come questa che l’approccio della RSI ambirebbe dare risposta. Ma a domande siffatte non si possono dare risposte semplici. Non basta infatti affermare astrattamente (come molti bilanci sociali fanno) che la qualità della vita (dei propri dipendenti, dei consumatori, della collettività) costituisce un valore da tutelare; se si vuole dar seguito efficace all’impegno bisogna quantificare in termini economici tale valore e cercare di internalizzarlo nei costi dell’azienda. E qui viene il difficile, perché si tratta concretamente di bilanciare un valore sociale con un valore economico. Se il bilancio sociale si ferma alla declamazione di un vuoto “buonismo” etico-sociale è pura cosmesi. Se entra nel merito, deve invece “sporcarsi le mani” e accettare di misurarsi concretamente con il bilanciamento di interessi diversi e con il difficile compito di valutare quanto del profitto distribuito ai proprietari/azionisti derivi dal valore effettivamente generato dall’impresa al netto delle esternalità (positive o negative) da questa stessa prodotte. E non può essere, si badi, un bilanciamento a senso unico (a favore del valore economico dell’impresa). L’obbiettivo – come si è detto – deve essere quello di favorire una più ampia creazione di valore da parte dell’impresa grazie appunto ad una più equa e condivisa distribuzione dello stesso. Ai fini non solo di una efficace gestione dell’impresa ma anche dello stesso bene sociale di lungo periodo, sono negative infatti sia la situazione in cui si accresca il profitto dei proprietari/azionisti oltre il valore generato, e dunque a scapito del benessere sociale, che quella opposta in cui si riduca il profitto (al di sotto del valore prodotto) per “finanziare” il benessere sociale degli stakeholder, al di là delle esternalità effettivamente generate e a scapito dunque dello sviluppo di lungo periodo. Ma perché questo possa realizzarsi concretamente non basta lo strumento del bilancio sociale, ancorché preso seriamente e non come pura operazione di cosmesi sociale dell’impresa. Il bilancio sociale deve allora innanzitutto integrarsi con il bilancio economico, ma soprattutto deve essere una occasione reale di avvio di una diversa governance delle imprese. E qui tocchiamo il punto più delicato e aperto per una RSI davvero capace di dare risposte nuove all’esaurimento del patto sociale welfarista. La RSI, per poter essere presa seriamente e non come una foglia di fico sulle vere o presunte vergogne del capitalismo, deve tradursi in una diversa governance: una governance che metta nei fatti in discussione e superi l’approccio cosiddetto dell’esclusività del principale (i manager rispondono unicamente ai soci proprietari/azionisti) verso un approccio realmente multipolare, in cui tutti gli stakeholder trovino davvero uno spazio legittimo di espressione. Problema che se posto in questi termini risulta – come ben si comprende – per la verità alquanto complesso, perché si tratta di disegnare un assetto istituzionale nuovo che risponda ad almeno tre requisiti: () sappia non solo dare spazio all’inevitabile conflitto tra gli interessi diversi di cui sono portatori gli stakeholder, ma sappia anche generare le regole per una composizione efficace dello stesso; () sappia – in quest’ottica di fornire uno spazio di confronto costruttivo e non distruttivo – fissare le giuste priorità e il giusto peso che i diversi stakeholder debbono avere a seconda dell’ambito funzionale interessa- to (la finalità di creare valore economico da parte dell’impresa pone oggettivamente una gerarchia negli stakeholder dentro la singola impresa); () sappia – ed è forse il compito più difficile e delicato – raccordare il livello micro degli interessi coinvolti nella singola impresa con il livello macro dell’equilibrio generale che deve essere comunque prodotto. Detto in termini più concreti, già si avvertono qua e là i rischi potenziali di una RSI non di pura cosmesi: che gli interessi forti prevalgano a scapito di quelli più deboli e che gli interessi locali prevalgano su quelli generali. Ma se si porta il dibattito su questo terreno, siamo sulla strada giusta per dare contenuti veri a un processo di innovazione istituzionale quanto mai urgente e necessario. Dare credito al bene comune Dare credito al bene comune: confesso che da qualche tempo sono molto sensibile al tema del “bene comune” e sulle ragioni di questo mio interesse vorrei intrattenere brevemente i presenti perché mi pare di poter ritenere che esse non rispondano solo ad una sensibilità personale, che come tale può interessare fino ad un certo punto, ma abbiano un qualche motivo di interesse più generale. Sono convinto infatti che il futuro prossimo delle democrazie occidentali sarà segnato da tre importanti fenomeni, veri e propri driver storici: () i drammatici problemi geopolitici posti dalle crescenti disuguaglianze a livello mondiale (che la globalizzazione è destinata, se possibile, a drammatizzare ancor di più, non già perché non diminuisca le differenze oggettive bensì perché aumenta le possibilità di confronto e dunque la percezione delle disuguaglianze); () la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che hanno appena incominciato a cambiare le nostre vite e che continueranno a cambiarle nel nuovo secolo appena iniziato, così come l’auto ha cambiato in profondità la vita del Novecento; () la necessità di ripensare a fondo i meccanismi di allocazione e regolazione socio-economica. I due meccanismi che hanno segnato Presentazione del Bilancio sociale delle Banche di credito cooperativo della Provincia di Brescia, Centro convegni Paolo VI, luglio . la storia del Novecento – il mercato e lo stato – risultano infatti ormai insufficienti non solo da soli (come il grande scontro della prima parte del Novecento tra liberismo e socialismo ha mostrato) ma anche nella combinazione/compromesso sperimentata dagli assetti di welfare state propri della seconda parte del secolo appena trascorso. La mia impressione è che (soprattutto nel nostro paese) la consapevolezza della partita che si sta giocando su questo ultimo tema sia del tutto inadeguata. Tutta giocata come è in negativo: crisi fiscale dello stato e ricorso al privato come risposta al problema, sulla base di una ideologia neoliberista (spesso assai più grezza anche rispetto alla originale matrice liberista, senz’altro più articolata e sofisticata rispetto ai surrogati odierni). La mia opinione è che se si vogliono risolvere i problemi posti dalla crisi dello stato sociale e anche quelli che stanno oggi alla base della crescente gracilità e debolezza della nostra economia (si veda il recente dibattito sul declino industriale del nostro Paese) si debba riconquistare il senso e dare seguito concreto a quella dimensione che gli anglosassoni chiamano dei commons – i beni comuni appunto che non sono semplicemente e immediatamente i beni pubblici (prodotti cioè dallo stato) ma sono i beni necessari al vivere civile, prodotti dall’azione sociale consapevole e responsabile di una comunità di cittadini. Se l’equivoco tra “pubblico” e “comune” è alla base di molte disgrazie passate e presenti della nostra vita sociale, sarebbe però altrettanto deleterio pensare che si possa dare risposta ai bisogni comuni con soluzioni private, come se ai bisogni di una comunità si potesse rispondere semplicemente con beni prodotti secondo logiche private e acquistabili sul mercato. I beni comuni presentano due peculiarità che rendono difficile la produzione e l’allocazione ottima delle risorse attraverso il mercato: () si prestano a comportamenti opportunisti e () sono di difficile misurazione. È cioè innanzitutto difficile evitare comportamenti (totali o parziali) di free riding: vale a dire impedire che i singoli si sottraggano ai costi di produzione collettiva del bene comune (la tragedia dei commons, nell’efficace espressione di Garrett Hardin, divenuta ormai un riferimento classico di un’ampia riflessione teorica), dalla sottrazione totale per mancanza di fiducia nella cooperazione altrui ai comportamenti di moral hazard e di sovra- o sotto-esposizione dei bisogni reali. Questi beni – ed è la seconda caratteristica – sono inoltre difficilmente misurabili. Esiste cioè una doppia asimmetria informativa che pone gravi problemi di agenzia (rapporti principale-agente). Solo chi li produce e non anche chi li consuma dispone delle informazioni necessarie per valutarne la qualità (esempio la formazione). Per altro chi li produce spesso non è in grado di misurare il reale bisogno di quel bene da parte di chi lo domanda (esempio le prestazioni sanitarie o assicurative). La teoria economica ortodossa ha dimostrato in modo incontrovertibile che in presenza di costi di misurazione elevati il mercato va incontro a fallimenti nell’allocazione efficiente delle risorse. Una prima risposta a queste peculiarità, è quasi inutile ricordarlo, è stata appunto quella dello stato sociale: una offerta di beni pubblici standard per la totalità dei cittadini – una offerta finanziata attraverso l’imposizione fiscale e i cui standard di qualità erano fissati “politicamente” e uguali per tutti. Il sistema ha funzionato sin tanto che lo stato ha goduto di legittimità nell’effettuare i prelievi fiscali necessari all’offerta di beni pubblici, perché un’ampia maggioranza di cittadini esprimeva una domanda relativamente omogenea e si riteneva sod- disfatta delle prestazioni standard offerte. Quando le esigenze sono cresciute e, soprattutto, la società si è andata differenziando nella domanda di servizi, il sistema di offerta pubblica standard è entrato in crisi. Ma se valgono – come credo valgano – le due peculiarità dei beni comuni qui richiamate, non basta purtroppo creare un “quasi mercato” (fatto di concorrenza tra soggetti erogatori diversi e da una domanda alimentata dalla ridistribuzione pubblica e in parte da risorse aggiuntive private) perché si risolvano i problemi al cuore dei beni comuni. È in questo spazio – che non può più essere coperto dal pubblico ma che non può neanche essere semplicemente rimesso al mercato né al “quasi mercato” – che può e deve inserirsi la terza forma di allocazione e di regolazione socio-economica: quella delle organizzazioni non profit o con un termine che preferisco del “privato-sociale”. Le loro peculiarità sono note ai presenti e mi limito quindi ad accennare solo alle caratteristiche che le rendono adeguate a rispondere ai problemi sin qui evidenziati: () da un lato sono organizzazioni in grado di mobilitare risorse collettive importanti (attraverso donazioni e contributi in denaro e/o prestazioni lavorative gratuite o semi-gratuite) per la produzione di beni percepiti come utili alla comunità: possono quindi funzionare come equilibratori (non di mercato) tra intensità delle esigenze percepite e quantità delle risorse destinate a rispondervi ed esercitare un controllo di tipo sociale sui comportamenti di free riding o di moral hazard; () dall’altro sono organizzazioni private libere di muoversi rispetto alle esigenze percepite. L’essere senza fini di lucro (sottoposte cioè al vincolo di non poter distribuire gli utili ai propri amministratori) e/o sottoposte a una governance democratica (di cui tra l’altro la presentazione di un bilancio sociale costituisce uno degli atti più importan- ti), le mette al riparo dallo sfruttamento opportunista che gli amministratori possono fare delle asimmetrie informative e le candida a svolgere una funzione essenziale di razionalizzazione della qualità dell’offerta e di intermediazione fiduciaria con la domanda. Nel nostro Paese (e qui nel Bresciano in particolare) le imprese non profit o l’economia privato-sociale è ben presente. Ma a mio giudizio continua a soffrire di un bias culturale che ne limita di molto l’estensione e le funzioni. Se in altre culture infatti il non profit può coprire per intero lo spazio dell’azione comune, indipendentemente dagli obiettivi che questa si dà, da noi l’implicito senso di colpa che accompagna l’azione utilitaristicamente orientata, e che deriva dalla matrice cattolica della nostra cultura, porta a sviluppare anziché forme di condivisione e cooperazione che ne superino i limiti individualistici, soluzioni compensative di tipo altruistico sociale. Queste soluzioni, per altro, non solo possono coesistere senza problemi con l’individualismo dell’azione economica ma, proprio perché ne compensano su un altro piano i presunti vizi, non stimolano l’emergere di norme etiche che ne disciplinino l’esercizio e contemperino l’individualismo con la necessità ai fini di sviluppo di una produzione cooperativa di beni comuni. Il non profit per parte sua resta principalmente associato all’idea del volontariato solidale nei confronti dei più deboli e bisognosi e, anche quando si incomincia ad accettare che vi possano essere forme più sofisticate e professionali di organizzazioni nonprofit (le “imprese sociali” appunto), queste – e la loro natura “aziendalistica” che comporta rapporti di lavoro anche non volontari, gestione manageriale e attenzione alla dimensione dell’efficienza – si giustificano solo in nome della loro capacità di perseguire in modo più efficace gli obiet- tivi di solidarietà sociale che ne costituiscono la vera e unica ragion d’essere. Senza nulla togliere al valore sociale (oltre che etico) di questa concezione, credo che il settore dell’economia sociale possa e debba coprire uno spazio assai più ampio di quello in cui è stato sin qui confinato nella cultura italiana: ad esempio, quello delle potenzialità che una forma particolare di organizzazione e di regolazione dei rapporti sociali, quella non profit appunto, può dispiegare sul piano della cooperazione tra soggetti economici (for profit) ai fini dello sviluppo. La letteratura economica sullo sviluppo è infatti ormai pressoché unanime nel riconoscere l’importanza del contesto sociale e istituzionale nel condizionare in senso positivo o negativo le performance economiche di un’area-sistema locale e nell’affermare la necessità di una più stretta sinergia tra istituzioni economiche e istituzioni sociali, ovvero l’urgenza di riappropriarsi di “un uso economico delle istituzioni non economiche e di un uso sociale delle istituzioni economiche”. Il ruolo del privato sociale è allora fondamentale, e l’idea che le fondazioni finanziarie o alcuni tipi di banche come quelle di credito cooperativo possano divenire una sorta di venture capitalist del privato sociale mi sembra di grande suggestione. E tuttavia mi sembra che il privato-sociale debba anche essere qualificato e specializzato. Vedo qualche rischio nella diffusione crescente e non qualificata delle organizzazioni non profit. Da un lato esse non si possono né si devono sostituire a quelle private o a quelle pubbliche nell’erogazione di alcuni servizi. Bisogna cioè essere “parsimoniosi” nell’utilizzare il non profit, nel senso che deve essere usato solo quando serve davvero, per evitare – tra l’altro – che il non profit divenga un “for profit mascherato”. In questa ottica tutto il privato sociale abbisogna di una nuova legislazione e di nuove regole ripensate alla luce della sua crescente e cruciale importanza. L’essere imprese senza fini di lucro resta un requisito necessario ma forse non più sufficiente per un settore in grande espansione sia quantitativa che qualitativa. È urgente porre mano ai problemi di governance, per evitare che “il non profit cattivo scacci quello buono” e distrugga uno strumento essenziale per uscire in positivo dalla crisi dello stato sociale novecentesco. In questo, il contributo appassionato e la riflessione che mi pare sottenda questa giornata nonché l’impegno del sistema delle banche di credito cooperativo a presentare il loro bilancio sociale può essere senz’altro un passo nella giusta direzione. Dal welfare state alla welfare society L’invito a discutere il libro di Vittadini mi ha costretto a riflettere e a mettere ordine in alcune idee che disordinatamente mi sono fatto intorno ad un tema che reputo comunque cruciale per il futuro. Sono convinto infatti che il futuro prossimo delle democrazie occidentali sarà segnato dalla necessità di ripensare a fondo i meccanismi di allocazione e di regolazione socio-economica. I due meccanismi che hanno segnato la storia del Novecento – il mercato e lo stato – risultano infatti ormai insufficienti sia da soli che nella combinazione di compromesso sperimentata dagli assetti di welfare state propri della seconda parte del secolo appena trascorso. La mia impressione è che (soprattutto nel nostro Paese) la consapevolezza della partita che si sta giocando su quest’ultimo tema sia del tutto inadeguata. Ben venga allora un libro come quello curato da Giorgio Vittadini che andiamo a commentare questa sera. Libro che ha due pregi rispetto al dibattito corrente: () tratta in modo completo delle sfide allocative del futuro non limitandosi (come spesso avviene invece) agli aspetti più tradizionali della crisi del welfare state (sanità, assistenza, previdenza), ma estendendo l’analisi ad ambiti di solito trascuraPresentazione del libro a cura di G. Vittadini, Liberi di scegliere, Auditorium S. Barnaba, giugno . ti e in realtà cruciali per il futuro quali: l’istruzione, le public utilities, i servizi alle imprese, la stessa finanza; () pur partendo da un “punto di vista” – da una scelta politico-culturale ben precisa (colta efficacemente dal titolo: “Liberi di scegliere”) – è un libro “aperto”, che non nasconde i problemi e che tratta in modo non pregiudiziale le obiezioni e i dubbi che sorgono lungo la via perseguita. Un libro che per questo può divenire un terreno costruttivo di confronto anche con chi – come chi vi parla – ha sensibilità in parte diverse, ma condivide la necessità di un ripensamento in positivo e non in negativo e ideologicamente pregiudicato del welfare state. Dico subito che della scelta di Vittadini e dei suoi coautori condivido alcuni assunti di fondo. Innanzitutto che la crisi del welfare state non è principalmente una crisi fiscale. Di fronte ai costi crescenti dovuti ai cambiamenti demografici e alle aspettative circa i diritti acquisiti, può sembrare provocatoria questa affermazione – di cui mi assumo la responsabilità, ma che mi pare sottostare anche all’analisi del libro. Credo tuttavia che se non fossero venuti meno i presupposti sociali di fondo che hanno retto la soluzione dello stato sociale, nulla impedirebbe di continuare ad alimentare i processi ridistributivi dello stato sociale in modo adeguato alle nuove esigenze. Quello che ha decretato la crisi irreversibile del welfare state è invece la crescente esigenza di poter essere appunto “liberi di scegliere”: esigenza che va ormai ben oltre i ceti borghesi e di classe media e investe l’intera società. È cioè la crescente differenziazione della domanda anche di beni collettivi che sta alla radice della crisi di legittimazione del welfare state e, conseguentemente, della sua crisi fiscale. Per questo non posso non condividere anche l’opzione di una differenziazione nei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità di cui il libro si fa promotore (welfare mix) e la necessità conseguente di trovare meccanismi ridistributivi più articolati ed efficaci (sussidiarietà fiscale). Non ho purtroppo le competenze per svolgere un ragionamento compiuto su questo secondo tema, per altro cruciale per impedire un degrado dei diritti di cittadinanza fondamentali, che restano una delle conquiste più importanti della grande stagione dello stato sociale. Voglio invece nel breve tempo a disposizione fare qualche osservazione sul primo tema. La proposta che mi sembra emerga in generale dal libro è che i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter scegliere liberamente l’erogatore del servizio di cui necessitano e, pertanto, il “quasi mercato” dei servizi sociali deve vedere presenti tre tipi di soggetti erogatori: () agenzie pubbliche; () imprese private for profit e () organizzazioni private non profit. Ora a me sembra che questa visione necessiti di un approfondimento in due direzioni. La prima: i tre tipi di soggetti erogatori citati non sono tra loro interscambiabili e il problema, purtroppo per noi, non è – come spesso si pensa – semplicemente quello di “aprire alla concorrenza” il settore dei servizi sociali, affiancando allo stato, l’offerta privata e quella non profit. I tre tipi di soggetti si prestano in maniera differente a rispondere a bisogni e, dunque, ad erogare beni differenti. E tale specificità va salvaguardata. In verità Vittadini e i suoi coautori dimostrano di essere consapevoli del problema, anche se a mio parere non sciolgono radicalmente e con la dovuta chiarezza l’equivoco. La seconda: impostare il problema nei termini di un welfare mix, che permetta ai cittadini di scegliere su un “quasi mercato” il soggetto erogatore preferito, rischia di far passare in secondo piano la specificità delle organizzazioni non profit – a cui per altro Vittadini e la Compagnia delle opere che ci ospita questa sera sono particolarmente sensibili – e il ruolo fondamentale che da tale specificità deriva per una compiuta welfare society. Detto diversamente: la mia opinione è che se si vogliono risolvere i problemi posti dalla crisi dello stato sociale senza peggiorare la qualità del benessere sociale (ed è questa l’opzione forte della welfare society propugnata nel libro) si debba riconquistare il senso e dare seguito concreto a quella dimensione che gli anglosassoni chiamano dei commons – i beni/servizi comuni, che non sono i beni pubblici (prodotti dallo stato e perciò percepiti dalla gente come lontani ed estranei) bensì i beni prodotti dall’azione civile e sociale di una comunità di cittadini. Se la confusione tra pubblico e comune è alla base di molti problemi del nostro Paese, sarebbe altrettanto deleterio confondere comune con “privato di quasi mercato”, come se ai bisogni comuni si potesse rispondere semplicemente con beni prodotti secondo logiche private e acquistabili sul mercato – sebbene un mercato particolare: quello alimentato dal potere di acquisto ridistribuito dallo stato sotto forma di sussidi, voucher, buoni servizi e quant’altro. Un modo per entrare un po’ più nel merito del problema che intendo sollevare è quello di partire dalla peculiarità dei beni che contraddistinguono la welfare society. Scusandomi con gli addetti ai lavori presenti, ma cercando di farmi capire dai più, i beni di welfare presentano due peculiarità: () si prestano a comportamenti di consumo opportunisti e () sono di difficile misurazione. La realizzazione di un sistema sanitario efficace comporta uno sforzo necessariamente collettivo. Una volta però apprestato – grazie all’azione pubblica o attraverso forme “comuni” di tipo assicurativo o mutualistico – tutti (i cittadini o i sottoscrittori della formula assicurativa o mutualistica) ne possono beneficiare. È cioè difficile impedire comportamenti (totali o parziali) di free riding: vale a dire impedire che i singoli si sottraggano ai costi di produzione collettiva del bene, sia tale sottrazione intesa come “evasione fiscale” (nel caso di bene pubblico), ma anche – si noti – nel caso di comportamenti opportunisti nel ricorso alle prestazioni (livello di prestazioni domandate a fronte del contributo assicurativo o mutualistico corrisposto, comportamenti di moral hazard, ecc.). Inoltre – ed è la seconda caratteristica – le prestazioni sanitarie sono difficilmente misurabili nella loro qualità da parte di chi le consuma. Esiste cioè una fondamentale asimmetria informativa tra chi produce e vende il servizio (che ha le competenze per valutare la qualità dello stesso) e chi lo acquista (che, al più, solo ex post può misurarne la qualità e l’efficacia). La teoria economica ortodossa ha dimostrato che in presenza di costi di transazione e di misurazione elevati il mercato va incontro a fallimenti nell’allocazione efficiente delle risorse. Una prima risposta è stata appunto quella dello stato sociale. Il sistema ha funzionato sin tanto che lo stato ha goduto di legittimità nell’effettuare i prelievi fiscali necessari all’offerta di welfare, perché un’ampia maggioranza di cittadini esprimeva una domanda relativamente omogenea e si riteneva soddisfatta delle prestazioni standard offerte. Quando le esigenze sono cresciute e, soprattutto, la società si è andata differenziando nella domanda di servizi, il sistema di offerta pubblica standard è entrato in crisi. Ma se valgono – come credo valgano – le due peculiarità dei beni di welfare richiamate, non basta purtroppo creare un “quasi mercato” (fatto di concorrenza tra soggetti erogatori diversi e di una domanda mista, in parte alimentata dalla ridistribuzione pubblica e in parte da risorse aggiuntive private) perché tutto possa riprendere a funzionare al meglio. Il “quasi mercato” da solo non risolve i due problemi sopra segnalati: () l’asimmetria informativa impedisce ai consumatori di scegliere razionalmente l’erogatore più efficiente. Dunque – nonostante molti lo pensino – la concorrenza da sola non è un incentivo sufficiente per aumentare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di pubblica utilità; () l’ineliminabile contributo pubblico necessario per produrre servizi altrimenti troppo costosi per le capacità di reddito dei singoli, combinato con un meccanismo di “quasi mercato”, genera in realtà comportamenti opportunisti (free riding, moral hazard). È in questo spazio – che non può più essere coperto dal pubblico ma che non può neanche essere semplicemente rimesso al “quasi mercato” – che può e deve inserirsi la terza forma di allocazione e di regolazione socio-economica: quella delle organizzazioni non profit (ma dovremmo trovare una denominazione più adatta all’importanza che esse vanno ad assumere: organizzazioni “comuni” o di “privato-sociale”). Le loro peculiarità sono note ai presenti e mi limito quindi ad accennare solo alle caratteristiche che le rendono adeguate a rispondere ai problemi sin qui evidenziati: () da un lato sono organizzazioni in grado di mobilitare risorse collettive importanti (attraverso donazioni e contributi in denaro e/o prestazioni lavorative gratuite o semi-gratuite) per la produzione di beni percepiti come utili alla comunità: possono quindi funzionare come equilibratori (non di mercato) tra intensità delle esigenze percepite e quantità delle risorse destinate a rispondervi ed esercitare un controllo di tipo sociale sui comportamenti di free riding o di moral hazard; () dall’altro sono organizzazioni private libere di muoversi rispetto alle esigenze percepite, ma l’essere senza fini di lucro e sottoposte al vincolo di non poter distribuire gli utili ai propri amministratori, le mette al riparo dallo sfruttamento opportunista che questi ultimi possono fare delle asimmetrie informative e le candida a svolgere una funzione essenziale di razionalizzazione della qualità dell’offerta e di intermediazione fiduciaria con la domanda. Ma se questo è il ruolo centrale del privato-sociale nella ricostruzione sempre più urgente e necessaria di una welfare society, allora ne derivano alcune conseguenze importanti che enumererò sinteticamente avviandomi alla conclusione: a) i problemi del welfare state non si risolvono semplicemente con meccanismi di “quasi mercato” (come da alcune parti sembra si pensi e si intenda fare); b) ben venga una pluralità di soggetti (welfare mix), ma non nel senso generico di una molteplicità di erogatori che facciano crescere l’offerta di mercato dei servizi e dunque la concorrenza, bensì nel senso di specializzare i vari tipi di soggetti in funzione dei beni erogati. In questa direzione esistono beni o servizi che possono essere erogati al meglio da imprese for profit, perché sono beni di facile misurazione e per i quali la concorrenza di mercato non può che produrre vantaggi per tutti (le public utilities ad esempio); altri che continuano a richiedere necessariamente una produzione ed una offerta di tipo pubblico e se questa venisse meno si andrebbe incontro ineludibilmente a un peggioramento dei diritti di cittadinanza e della qualità della vita complessiva (si pensi alla sanità d’urgenza o alla ricerca scientifica di base); altri infine che possono essere erogati al meglio solo da (una pluralità) di organizzazioni di privato sociale (tutti quei servizi che eccedono l’offerta standard pubblica e che possono essere alla portata di una azione comune ma con forti asimmetrie informative e rischi di comportamenti opportunisti: buona parte della sanità e dell’assistenza, l’istruzione post-obbligo ed universitaria, ma anche, in un’ottica moderna meno scontata e giustamente fatta propria da Vittadini, i servizi alle piccole e medie imprese, soprattutto se di tipo innovativo); c) il ruolo del privato sociale è allora fondamentale, e l’idea proposta dal libro che le fondazioni finanziarie possano divenire una sorta di venture capitalist del privato sociale mi sembra di grande suggestione. E però mi sembra che il privato-sociale debba anche essere qualificato e specializzato. Vedo qualche rischio nella diffusione crescente e non qualificata delle organizzazioni non profit. Esse non si possono né si devono sostituire a quelle private o a quelle pubbliche nell’erogazione di alcuni servizi. Bisogna cioè essere “parsimoniosi” nell’utilizzare il non profit, nel senso che deve essere usato solo quando serve davvero; d) in questa ottica tutto il non profit abbisogna di una nuova legislazione e di nuove regole ripensate alla luce della sua crescente e cruciale importanza. L’essere imprese senza fini di lucro resta un requisito necessario ma forse non più sufficiente per un settore in grande espansione sia quantitativa che qualitativa. È urgente porre mano ai problemi di governance, per evitare che “il non profit cattivo scacci quello buono” e distrugga uno strumento essenziale per uscire in positivo dalla crisi dello stato sociale novecentesco. Brescia: la storia, l’economia, la città La storia economica di Brescia attraverso una famiglia esemplare Quello che viene presentato questa sera è non solo un bel libro, interessante, rigoroso nella ricostruzione storiografica (nonostante sia un’opera a più mani). Un libro che assai opportunamente rende onore ad una famiglia che tanto ha dato alla comunità bresciana, senza però cadere nella agiografia bensì con serietà e rigore nel valutarne i meriti ma anche gli inevitabili errori e responsabilità. È anche e soprattutto un libro importante che attraverso la storia di questa famiglia e della sua impresa ci obbliga e ci aiuta a riflettere sull’oggi di questa nostra società e della sua economia. Lascio al prof. Castronovo il compito di un esame storiografico del libro e il commento ad alcuni spunti interpretativi sulle origini dell’industrializzazione bresciana che mi sono parsi originali. Per parte mia e secondo le mie sensibilità vorrei intrattenervi brevemente su qualche spunto di attualità che si può ricavare dal libro. Sono quasi certo che i signori Glisenti non me ne vorranno, anzi credo comprenderanno che cercare di trarre delle “lezioni” per l’oggi dalla storia della loro impresa è il riconoscimento più sentito e profondo che si possa tributare loro. Dal punto di vista che qui mi interessa, quella che abbiamo Presentazione del libro di AA.VV., I Glisenti. Cinquecento anni di storia, Palazzo Loggia, ottobre davanti è la storia di una grande ascesa ma anche (bisogna pur dirlo) di una sconfitta. È la storia – non unica in provincia e proprio per questo assume un interesse che trascende lo specifico particolare – dell’incapacità del capitalismo bresciano a divenire e a rimanere (anche quando grande lo è stato) “grande”. I fattori che stanno dietro all’ascesa che porta appunto la Glisenti tra la prima e la seconda industrializzazione italiana alle dimensioni di grande impresa di rilievo nazionale sono ben individuati nel libro e meritano di essere ricordati. Essi sono: () una grande e articolata famiglia che (nonostante alcune divisioni interne) apporta energie, competenze e risorse finanziarie all’azienda; () un background culturale costruitosi nel tempo con percorsi di vita assai diversi tra loro (di tipo professionale, ma anche religioso e rivoluzionario giacobino), che porta la famiglia a porre grande attenzione alla formazione delle nuove generazioni, attraverso una istruzione rigorosa di stampo europeo (prevalentemente svizzero-tedesca), attenta anche ad una educazione più generale della personalità, con tirocini in imprese non della famiglia; () un’ampia rete di relazioni economiche e politiche (Zanardelli su tutti); () la capacità di far crescere e selezionare una classe manageriale di valore (si veda Egidio Garuffa); () un “modello di business” – direbbero gli economisti aziendali – assai originale, che sfrutta il Verlagssystem (il sistema di piccole e piccolissime realtà produttive artigiane e familiari esistenti sul territorio) per acquisire flessibilità e competenze di mestiere, ma che fornisce allo stesso un’impresa leader che lo organizza e soprattutto le fornisce un di più di “intelligenza” sul piano dell’innovazione tecnologica e di mercato. Formazione, relazioni che contano, manager di valore, imprese leader che sappiano organizzare il tessuto delle piccole imprese sono oggi i quattro ingredienti di cui forse il capitalismo familiare bresciano ha più bisogno. Ma ne ha più bisogno proprio perché le grandi imprese del passato non ci sono più, si sono perse nel passaggio dalla prima alla seconda industrializzazione. Perché? Che cosa ci può insegnare la storia della Glisenti al riguardo? Un elemento che ha certo giocato (e che gioca per altro sempre nella storia non solo delle imprese) è stato senz’altro il destino. Innanzitutto la morte tragica e prematura di Franco Glisenti che, se trova un validissimo sostituto in Piera Carpani Glisenti, indebolisce comunque le forze familiari investite nell’impresa in un momento difficile e critico di passaggio. Ma quello che mi intriga di più (per una storia fatta con i se) è la cagionevole salute e la morte in giovane età di Alfredo Glisenti nel . Che cosa sarebbe potuta diventare la Glisenti se l’intuizione di Alfredo di una “vettura automobile” da lui prodotta nel (un anno prima di quel fatidico che Castronovo conosce bene perché è l’anno di nascita della Fiat) avesse potuto contare sulla sua determinazione di imprenditore propenso alle innovazioni discontinue (di prodotto e non solo di processo) per altri dieci o quindici anni? Dico questo perché tra i fattori della crisi della “grande industria” Glisenti (e forse di buona parte del grande capitalismo bresciano della prima industrializzazione) credo si debba annoverare innanzitutto un modello di business che non riesce a cogliere l’occasione dei nascenti mercati di massa dei beni durevoli di consumo. Si situa qui credo una biforcazione fondamentale della storia della Glisenti. Guido Glisenti, che porterà avanti l’impresa segnandola per tutto l’arco successivo ben oltre la prima industrializzazione, ha in mente un modello più tradizionale che si regge (come molte altre imprese bresciane del periodo) su due mercati complementari: quello delle commesse pubbliche (armi) e quello locale (delle “ferrarezze” come si diceva allora). Quando il mercato delle commesse pubbliche finisce e quello locale con la seconda industrializzazione e la modernizzazione del paese viene soffocato e non basta più, l’unico sbocco diventa quello di allearsi in qualità di subfornitori con la ormai affermata industria dell’auto (cresciuta però fuori dalla provincia). E in questo ulteriore passaggio si annidano forse altri punti di debolezza dello sviluppo più recente dell’industria bresciana. In breve, dalla storia della Glisenti emergono tre punti che sembrano determinarne nel corso del secondo dopoguerra il ridimensionamento definitivo come “grande industria”. Innanzitutto la debolezza finanziaria di una impresa familiare che ricorre a forme di credito ordinario ma non al mercato aperto dei capitali per finanziare la propria ristrutturazione. Questo non è solo un dato bresciano per la verità, ma di buona parte del capitalismo familiare italiano, e dunque attiene a caratteristiche che, soprattutto a partire dagli anni ’ del Novecento – quando la crisi morde di più sulla Glisenti e la ristrutturazione diventa ineludibile – non potevano non condizionarne in negativo le scelte finanziarie. In secondo luogo, se le relazioni e le alleanze strategiche sono il cuore di una imprenditorialità dinamica, non devono diventare troppo esclusive e creare eccessiva dipendenza, come invece è forse stato per la Glisenti quando, sempre a metà degli anni ’, ha riposto tutta la sua strategia industriale nella subfornitura privilegiata del gruppo Fiat. Infine il tentativo di rompere con il modello del passato (impresa leader di un tessuto di piccola impresa di mestiere) e di andare più decisamente nella direzione della grande impresa fordista (standardizzata, ad elevata intensità di capitali e bassa qualità del capitale umano), paradossalmente proprio nel momento stesso in cui la crisi della metà degli anni ’ avrebbe segnato l’inizio della fine di quel modello e l’avvento di un modello alternativo (post-fordista a specializzazione flessibile) di cui forse una diversa scelta strategica (certo difficile da intuire allora) avrebbe potuto fare della Glisenti una antesignana. In questo senso la nuova Glisenti (di Guido Carpani Glisenti e Giovanni Dalla Bona) è la risposta giusta ma solo parziale a questo nuovo modello. Giusta a livello di impresa, perché ha saputo inserirsi come subfornitrice di qualità non esclusiva in un processo di specializzazione flessibile che ha ridato respiro e garantito lo sviluppo del capitalismo bresciano degli anni ’ e ’. Parziale a livello di sistema, perché sempre più mancano oggi all’economia bresciana delle imprese leader che sappiano indirizzarla non solo sul terreno dell’innovazione tecnica ma anche su quella di nuovi prodotti e modelli di business. Il venir meno delle grandi imprese del passato (a cui si è aggiunta la crisi anche di quelle cresciute con la seconda industrializzazione) è certamente un limite che oggi si avverte in questa provincia. La partita non è però già persa in partenza. Le nuove dimensioni di una economia basata più sulla conoscenza e sulle economie di scopo che sui grandi investimenti strutturali e sulle economie di scala, permettono anche a imprese medie e medio-piccole di affermarsi come imprese leader. Ma perché questo possa avvenire non bisogna dimenticare le “lezioni” ancora valide che possiamo ricavare dal successo come dagli errori della Glisenti, così come dalla storia di molte altre imprese di questa nostra terra ricca di spiriti imprenditoriali di valore. Proprio per questo il libro mi è sembrato importante e tale da meritare una attenta considerazione, non solo per l’occasione celebrativa di una grande famiglia bresciana. Ed è anche per questo che spero che altre opere siffatte possano essere promosse dall’Ateneo e dal futuro Museo dell’Industria e del Lavoro. Mi ha colpito nella lettura del libro – lo dico in conclusione – come l’Ateneo abbia svolto un tempo un ruolo importante nell’affermarsi di una moderna cultura tecnico-industriale nella nostra provincia. Fatte le debite differenze, tocca oggi all’Università offrire un momento altrettanto alto di aggregazione e di promozione di una rinnovata cultura dell’innovazione (fatta di tecnologia ma anche di cultura organizzativa e di cultura tout court). È un impegno non da poco, su cui per altro l’ancora giovane Università bresciana sta lavorando già con qualche risultato. Dove va il sistema Brescia? L’economia: caratteristiche strutturali e fattori competitivi La composizione percentuale del valore aggiunto per macro settori conferma la tuttora forte vocazione industriale della provincia. Più di un terzo risulta infatti prodotto dal settore industriale, che risulta di oltre dieci punti percentuali superiore alla media nazionale. Un dato questo superato in Lombardia solo dalle province di Lecco, Bergamo, Varese e Como, che però si caratterizzano tutte per una agricoltura quasi inesistente e che lascia maggiore spazio all’industria. Brescia presenta invece anche un settore agricolo significativo, che concorre con oltre il % al valore aggiunto provinciale, mentre il settore dei servizi, pur avendo visto crescere negli ultimi anni significativamente il suo peso, resta al di sotto della media nazionale e regionale. L’economia della provincia rivela inoltre una notevole varietà interna che ne costituisce senz’altro uno dei punti di maggiore forza. Accanto al settore agricolo, concentrato soprattutto intorno alla zootecnia, può contare infatti su un’ampia gamma di comparti manifatturieri (siderurgia, tessile e abbigliamento, metalli non ferrosi, meccanica, mezzi di trasporto, lavorazioni del legno, chimica, gomma e plastica, alimentari, carta e editoria) e delle costruzioni, nonché su importanti comparti del Relazione al seminario organizzato dalle Acli di Brescia, giugno . terziario, quali quelli del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese. Oltre alla varietà interna, l’altro dato strutturale che connota la specificità provinciale anche rispetto alle altre province lombarde è la tuttora forte propensione ad intraprendere. Nonostante la difficile congiuntura degli ultimi anni, il tasso di crescita del numero di imprese si è mantenuto su valori nettamente superiori a quelli regionali e vicini a quelli medi nazionali, in una provincia per altro che (con oltre mila imprese registrate) si colloca di già in una delle prime posizioni a livello nazionale per densità di imprese esistenti. L’elevato tasso di crescita del numero delle imprese si accompagna per altro ad una ridotta dimensione media delle stesse. Nel settore primario e dei servizi prevalgono infatti le microimprese sino a addetti, mentre nell’industria sono le imprese da - addetti a predominare. Anche in termini di fatturato la struttura produttiva della provincia mostra la sua forte vocazione alla piccola dimensione (o la sua incapacità strutturale a crescere). Con riferimento alle società di capitali, è possibile rilevare infatti come il % di esse presenti un fatturato nella fascia dai ai milioni di Euro e un altro % circa si colloca addirittura al di sotto dei milioni. Si tratta di una caratteristica tipica del modello economico che ha finito con il prevalere a livello provinciale a partire dalla fine degli anni ’ e che, se garantisce senz’altro grande flessibilità e capacità reattiva alle difficoltà congiunturali, rischia di rilevarsi inadeguato per far fronte alle crescenti sfide competitive che attendono l’economia bresciana (globalizzazione dei mercati, concorrenza crescente dei paesi asiatici, necessità di passare a produzioni a più alto contenuto tecnologico e valore aggiunto). Flessibilità e reattività hanno comunque permesso all’economia provinciale di contrastare efficacemente la difficile congiuntura degli ultimi anni. Lo dimostrano l’andamento del mercato del lavoro e delle esportazioni provinciali. Il primo ha sostanzialmente tenuto, nonostante la crisi di alcune importanti aziende. Le seconde, dopo la forte contrazione del , hanno segnato un recupero importante (+,%), in presenza di un dato regionale che ha continuato invece a presentare un marcato andamento negativo. Hanno favorito la ripresa, oltre al debole riavvio dell’economia tedesca (che pesa per quasi il % delle esportazioni provinciali), anche e soprattutto la capacità di penetrazione in mercati meno evoluti, quali quelli dell’est europeo, della Turchia e della Cina. La notevole dinamica delle esportazioni verso mercati più poveri sconta inevitabilmente un valore delle esportazioni relativamente contenuto. L’export bresciano, anche nel confronto con quello lombardo, è relativamente poco pregiato e riguarda principalmente i settori manifatturieri più tradizionali. Conferma questa valutazione la percentuale di export classificabile tra i prodotti specializzati e high tech (secondo le ben note categorie di Pavitt) che risulta inferiore di oltre punti alla media regionale e a quella di sei su dieci delle altre province lombarde. Si delinea dunque un modello economico basato sulla piccola impresa operante in settori a basso valore aggiunto, che manifesta nel breve periodo una forte capacità di reazione e una positiva capacità di impegnare manodopera ma che si mantiene su sentieri tradizionali e poco innovativi di sviluppo. Il giudizio sul modello – e gli effetti che ne conseguono – è confermato anche dai dati relativi alla capacità di generare reddito. Nel periodo - la provincia di Brescia ha perduto parte del suo dinamismo: il tasso di crescita cumulata del pe- riodo risulta infatti pari al % contro una media regionale per lo stesso periodo del ,%, con una performance inferiore a ben otto su dieci delle altre province lombarde e che l’ha portata a perdere posizioni nella graduatoria nazionale, collocandola al º posto. Tale perdita di velocità nel generare reddito è senz’altro in gran parte imputabile allo scarso valore aggiunto per addetto che l’economia provinciale riesce a garantire. Il dato disponibile (fonte Unioncamere) si riferisce alle sole società di capitali al e risulta pari a . Euro per addetto, rispetto ad una media lombarda di . Euro. Tale dato consegue ad un basso valore aggiunto per addetto sia del settore manifatturiero che di quello dei servizi, dove pure Brescia ha visto una crescita significativa di produttività negli ultimi anni. In entrambi i settori, il relativamente basso costo del lavoro (rispetto alla media regionale) non risulta sufficiente a compensare il ridotto valore aggiunto prodotto per unità di lavoro e determina un margine operativo lordo (MOL) tra i più bassi a livello regionale. Si conferma dunque, anche attraverso questi ulteriori riscontri, l’ampio spazio di miglioramento tuttora presente nell’ambito dell’economia bresciana, che deve nel prossimo futuro saper finalizzare i propri indubbi punti di forza (varietà interna, flessibilità, buona propensione ad intraprendere) ad un miglioramento del valore aggiunto per addetto, attraverso lo spostamento verso comparti manifatturieri a più alto contenuto innovativo e la crescita di un terziario di servizio più moderno e dinamico. Se si classificano (secondo un’utile suggerimento di M. Lazzeroni) i principali comparti produttivi presenti in provincia rispetto al loro peso occupazionale e alla loro dinamica di crescita, distinguendo così quattro categorie: () le vocazioni debo- li, ovvero i comparti a basso peso occupazionale e a crescita stabile; () le vocazioni mature, che contribuiscono in modo rilevante all’occupazione provinciale ma presentano una dinamica di crescita stabile o negativa; () le vocazioni trainanti, con alto peso occupazionale e buona dinamica di crescita e () le vocazioni emergenti, con ancora basso peso occupazionale ma forte dinamica di crescita, si può costatare come l’economia bresciana sia carente proprio di vocazioni emergenti, di comparti cioè nuovi, in grado di fare da traino qualitativo allo sviluppo provinciale e di sostituirsi potenzialmente ai settori trainanti nel momento in cui questi stessi abbiano esaurito la fase espansiva del loro ciclo di vita. Ma per innescare un processo evolutivo in tale direzione è necessario aumentare la propensione all’innovazione del sistema economico provinciale che sconta, sotto questo profilo, due importanti limiti: le dimensioni aziendali ridotte, che si accompagnano all’assenza di imprese leader in grado di trainare il tessuto di piccola impresa, e la bassa qualità del capitale umano. A questi due temi cruciali per il futuro della provincia è perciò necessario dedicare qualche considerazione ulteriore. Capitale umano, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico Qualità professionale e grado di istruzione della forza lavoro segnano senza ombra di dubbio uno dei punti di maggiore debolezza della realtà economica bresciana. I tassi di entrata per gruppi professionali ricavabili dall’indagine annuale Excelsior di Unioncamere presentano, se confrontati con quelli regionali, uno scarto negativo per quanto concerne l’insieme di dirigenti e personale di elevata professionalità di oltre punti percentua- li, mentre la quota di personale non qualificato risulta essere di quasi punti percentuali superiore alla media lombarda. A tale relativa povertà di competenze professionali richieste dal sistema si accompagna un basso livello medio di istruzione. Anche in questo caso, rispetto ai dati della Lombardia, la percentuale di assunti con la sola scuola dell’obbligo è superiore di oltre punti, mentre risulta inferiore del ,% per i diplomati della scuola superiore e del ,% per i laureati. Né a tali carenze può sopperire una formazione aziendale che, pur vedendo Brescia significativamente impegnata sia in termini di numero di formati che di costi sostenuti, non presenta differenze tali rispetto al resto della regione da compensare il modesto background di partenza. Ciò che va soprattutto evidenziato di questa situazione è il circolo vizioso che si è innescato con il modello di sviluppo affermatosi in provincia a partire dagli anni ’: le imprese generano una sostenuta domanda di lavoro scarsamente qualificato e non incentivano i giovani (e le loro famiglie) a investire in formazione, quanto piuttosto a entrare prematuramente in un mercato del lavoro dinamico ma di bassa qualità. Una forza lavoro di bassa qualificazione costituisce d’altro canto un fattore negativo per un sistema che voglia innovarsi e lo costringe a riprodurre un modello low skill e a basso valore aggiunto per addetto. La presenza di un sistema “bloccato” in un equilibrio sotto-ottimale viene altresì confermata dai comportamenti di coloro che incominciano ad investire in formazione, grazie anche alla presenza – come si è detto – di una offerta universitaria locale ormai consolidata e di buon livello qualitativo. Costoro – pur provenendo in buona parte anche da famiglie di piccola imprenditorialità – preferiscono alla fine degli studi occuparsi nelle professioni liberali oppure in grandi imprese fuori pro- vincia, non contribuendo così al rinnovamento del tessuto manageriale e imprenditoriale locale e ponendo in prospettiva seri problemi per la stessa successione delle imprese di famiglia. Nella misura in cui tali comportamenti si diffonderanno (non essendo più disposti i giovani a rinunciare a livelli di istruzione più elevata e a prospettive professionali qualitativamente migliori), il modello sarà destinato ad andare incontro non solo ad una crescente concorrenzialità da parte dei paesi emergenti a basso costo del lavoro ma anche ad una crisi endogena, quale conseguenza della scarsità tendenziale di una offerta di lavoro di bassa qualità (a meno di continuare ad alimentarla – come è del resto già avvenuto negli ultimi anni – con massicce immissioni di lavoratori immigrati). Rompere tale circolo vizioso è dunque una delle sfide decisive per il futuro della economia provinciale. La consapevolezza del problema è ormai ben presente nel dibattito locale, ma la frammentazione del tessuto economico rende particolarmente difficile invertire la tendenza in atto. Al riguardo non basta infatti lo sforzo del sistema formativo locale, che pure è chiamato a svolgere un compito critico. Richiede necessariamente che si inneschi anche un processo evolutivo del sistema delle imprese. In questo senso le linee di azione da intraprendere sono almeno tre: () accompagnare l’evoluzione verso un modello a più alta qualificazione con una formazione che sappia rispondere alle esigenze delle imprese senza però appiattirsi sul presente ma guardando avanti e puntando alla qualità e all’eccellenza; () sostenere l’evoluzione delle imprese esistenti e l’emergere di nuovi comparti a più alto valore aggiunto attraverso un più incisivo impegno nella ricerca industriale e nel trasferimento di nuove tecnologie; () promuovere una nuova cultura imprenditoriale e forme più efficaci di finanza innovativa e di progetto in grado di favorire l’affermarsi di una giovane leva di imprenditori innovativi. Quanto alla prima linea di azione, l’impegno del sistema scolastico e universitario provinciale nell’instaurare un dialogo costruttivo con il mondo delle imprese è stato negli ultimi anni notevole e incomincia a produrre qualche risultato concreto. Ne sono testimonianza: il Comitato permanente scuola industria, promosso da AIB per meglio raccordare il sistema di formazione superiore con le esigenze delle imprese; la società consortile Università & Impresa, avviata dall’Università degli studi, da Isfor, dalla Camera di commercio e da tutte le associazioni di categoria dell’industria e dell’artigianato per organizzare iniziative formative di eccellenza utili al tessuto economico provinciale; le numerose convenzioni stipulate dalle associazioni di categoria con le scuole e le due università per gli stages. Se una formazione secondaria superiore e universitaria di primo livello più vicina al mondo delle imprese, ma altresì capace di fornire una preparazione polivalente di qualità, costituisce la leva di più ampio impatto con cui intervenire nel prossimo futuro, bisogna per altro essere consapevoli che la scommessa si gioca anche sulla capacità di accrescere la dotazione di sistema di manager e ricercatori industriali di più alta specializzazione (laureati di secondo livello e dottori di ricerca) in grado di intermediare il mondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica con quello dell’industria. Perché questa sfida possa essere vinta è necessario che, accanto ad una offerta di competenze specifiche e qualificate da parte del sistema formativo, cresca anche da parte delle imprese una domanda in tale senso: è questo l’obiettivo della seconda linea di azione prima indicata. A risultati positivi in tal senso sarà possibile pervenire per altro solo se il tessuto delle piccole e medie imprese locali potrà contare su istituzioni o agenzie in grado di attrarre fondi pubblici destinati alla ricerca industriale e di aggregare le imprese perché raggiungano una massa critica anche di risorse proprie (finanziarie e umane) sufficiente a far decollare attività significative di ricerca e sviluppo e a favorire l’interazione con i centri di ricerca universitari. Sotto questo profilo risulterà determinante a livello provinciale la capacità di gestire con efficacia il Centro di servizi multisettoriali per il trasferimento tecnologico che l’Università degli studi, la Camera di commercio, il Comune capoluogo, la Provincia e l’Eulo stanno predisponendo (grazie anche ad un cospicuo contributo della Regione Lombardia) per sostenere la ricerca finalizzata e il trasferimento di tecnologia. Oltre agli interventi formativi e di accompagnamento delle imprese esistenti sul terreno della ricerca e del trasferimento tecnologico, per far evolvere il sistema verso nuovi settori a più alto tasso di innovazione e di valore aggiunto è indispensabile infine che cresca e si affermi una nuova generazione di imprenditori innovativi. Capitalismo familiare, nuovi imprenditori, ruolo del credito e della finanza Si è già avuto modo di dire della elevata propensione imprenditoriale del capitalismo familiare bresciano. All’origine vi è stata una congiuntura particolarmente fortunata – tra gli anni ’ e ’ – che ha potuto contare su caratteristiche antropologiche confacenti (laboriosità, determinazione, coraggio nell’assumersi rischi) e su condizioni economiche e sociali favorevoli (forte spinta ad uscire dalla povertà del dopoguerra, famiglie numerose capaci di fornire una rete protettiva e di socializzazione dei rischi d’impresa, una domanda nazionale e internazionale di beni durevoli in rapida crescita, la progressiva terziarizzazione delle lavorazioni a più basso valore aggiunto da parte delle grandi imprese del triangolo industriale). Un tessuto ricco di esempi positivi ha poi fatto il resto attraverso meccanismi imitativi e di diffusione “per contagio” di una cultura imprenditoriale dai forti connotati specifici. Ora, questo modello mostra segni di esaurimento. Da un lato per le difficoltà a crescere da parte di imprenditori con un forte senso patrimoniale dell’impresa e perciò scarsamente disposti a cogliere le opportunità offerte dal mercato dei capitali, e dall’altro per la scarsa attrattività che è in grado di esercitare nei confronti delle nuove generazioni, che quando possono cercano – a differenza del passato – strade diverse di realizzazione professionale. La via per ovviare a questi limiti (destinati a pesare sempre più negativamente nel futuro dell’economia provinciale) passa attraverso una nuova cultura imprenditoriale e forme di finanza più innovative. Sul primo punto è certamente importante promuovere – come da più parti si sta già da qualche tempo facendo – una maggiore consapevolezza della necessità di innovare le forme di proprietà e di governance delle imprese. La crescita delle società di capitali e, soprattutto, delle holding di gruppo è un segno confortante del fatto che, pur con l’inerzia caratteristica dei mutamenti profondi, dei passi nella giusta direzione si sono incominciati a fare. Resta invece la necessità di assicurare un ricambio generazionale adeguato alla classe imprenditoriale, fornendo ragioni convincenti ai giovani migliori perché investano i loro talenti (di conoscenza, creatività e capacità di mettersi in gioco) nel sistema locale delle imprese. Il modo forse più efficace per ottenere questo risultato è quello di promuovere spin off (innanzitutto universitari ma anche da imprese esistenti) che vedano a capo dei giovani. Ciò comporta, da un lato, che il contesto di partenza non solo accompagni la fase iniziale di start up con strumenti adeguati di sostegno, ma soprattutto che sappia farsi promotore di una cultura d’impresa nuova che torni a interessare e coinvolgere i giovani con elevati livelli di scolarità e di aspettative professionali; dall’altro che la finanza sostenga adeguatamente la crescita di queste nuove imprese. A questo proposito, il sistema finanziario bresciano costituisce senza dubbio un punto di forza dell’economia provinciale per quantità di risorse disponibili, per consistenza e solidità delle imprese che lo compongono, per capacità di impiego. Pur avendo espresso in passato alcune iniziative innovative soprattutto nel campo parabancario, la struttura creditizia e finanziaria provinciale resta tuttora largamente connotata in senso tradizionale e le poche realtà dinamiche presenti tendono a investire le loro risorse al di fuori del sistema locale, rispondendo più ad esigenze di diversificazione di portafoglio che di finanza innovativa. È invece prioritario, per favorire una evoluzione positiva del sistema, favorire la nascita di nuovi canali finanziari operanti in logica di venture capital, disposti cioè ad accettare i rischi connessi a iniziative imprenditoriali innovative in settori high tech, a fronte di ritorni del capitale in tempi più brevi e con rendimenti più elevati. È questa una funzione di cui il sistema economico provinciale è allo stato carente e che risulta invece fondamentale per sostenere il decollo di una nuova generazione di giovani imprenditori innovativi, in stretta sinergia con le iniziative di promozione di spin off di ricerca e di sostegno a nuovi settori emergenti che sappiano dare rinnovati stimoli al sistema produttivo locale. Brescia Scusandomi con gli altri autori della ricerca e visto il tempo a disposizione, preferisco concentrarmi sul solo contributo del prof. Matteo Caroli. Si tratta di un contributo assai apprezzabile per l’equilibrio e la lucidità dell’analisi. Credo davvero che questo punto di vista “esterno” possa essere un aiuto importante al dibattito aperto tra le forze economiche ed istituzionali della provincia. Intendo dunque soffermarmi su quattro punti, non già per discuterli o approfondirli ulteriormente, ma solo per richiamarli all’attenzione di tutti, perché li reputo tra i fondamentali problemi che abbiamo davanti in questa che forse, alla luce anche del saggio di Caroli, potremmo chiamare la “crisi di crescenza del sistema Brescia”. Il primo punto è relativo alla dimensione delle imprese. Caroli conferma i limiti strutturali del nanismo industriale bresciano ma qualifica la sua analisi in tre direzioni che meritano di essere richiamate all’attenzione. Innanzitutto nella direzione di identificare la “ottimalità relativa”, ovvero la dimensione aziendale migliore in funzione delle caratteristiche del settore e dei modelli di business. Personalmente credo ci sia spazio per piccole imprese innovative (e questo contribuisce al mio ottimismo sul futuro), ma queste debbono poi voler e poter crescere e, soprattutto, bisogna essere consapevoli che quelle esistenti sono troppo piccole. Intervento predisposto per la presentazione del volume a cura della Fondazione ASM, Brescia , chiesa di Cristo Re, ottobre . In secondo luogo, la necessità di individuare modelli aziendali per crescere e le opportunità che al riguardo possono offrire anche gli insediamenti di realtà produttive esterne. Il tema dell’incremento degli Investimenti Diretti Esteri e del marketing territoriale al riguardo è un tema cruciale, troppo a lungo accantonato perché tocca un nervo scoperto: si pensi alle reazioni all’ingresso dei russi nel capitale Lucchini. Infine la necessità di valutare le dimensioni anche alla luce della capacità delle imprese di “fare sistema”, di mettere in atto relazioni cooperative per accedere “collettivamente” ai fattori di sviluppo. E anche qui scontiamo – secondo Caroli, e concordo con lui – un limite dovuto alla scarsa leadership delle medie imprese (pure eccellenti che possiamo annoverare in provincia) e alla carenza di un sistema istituzionale in grado di favorire la relazione tra le imprese e tra queste e i portatori di risorse di sviluppo. Il secondo punto riguarda la bassa qualità del capitale umano. Si leggano le pagine - del libro per avere una descrizione precisa di quello che ho chiamato altrove un modello low skill e la prognosi chiara che non si resta competitivi nel XXI secolo con un modello siffatto. Si leggano queste pagine alla luce anche dei dati recenti della ricerca Unioncamere sulla domanda di lavoro delle imprese per il , dove si evince che ancora il , delle assunzioni previste è di lavoratori con il solo diploma di scuola media, il , di istruzione professionale, il , di scuola superiore e solo il , universitario. Del resto Caroli dice bene quale sia il circolo vizioso che si è innescato e la necessità di operare su imprese, famiglie e istituzioni formative per romperlo. Ma questa è la prima emergenza di questo territorio e non basta più nascondersi dietro all’elevato contenuto professionale acquisito on the job in imprese caratterizzate da un processo di “generazione endogena della conoscenza”. Il terzo punto riguarda appunto la generazione della conoscen- za e la sua applicazione nell’innovazione delle imprese. Anche su questo punto le molte osservazioni di Caroli sono preziose: () dalla necessità di fare innovazione non tanto di processo (in cui le imprese bresciane sono imbattibili) quanto di prodotto e soprattutto di modelli di business (dunque non solo un problema tecnologico ma anche di marketing e di cultura strategica delle imprese); () al realismo di sottolineare che quello che si chiede alle agenzie di ricerca e trasferimento è non già di fare ricerca di punta quanto di essere tempestivi ad adottare tecnologie abilitanti anche se messe a punto altrove; () alla grande scommessa di dotare la provincia di centri di ricerca applicata e trasferimento tecnologico, intesa come uno dei principali e più urgenti compiti del sistema delle rappresentanze e delle istituzioni locali (con il Csmt la provincia non può permettersi di fallire, causa l’individualismo e l’orgoglio di parte dei soggetti in gioco); () infine all’interrogativo su quali piattaforme tecnologiche puntare, con la risposta saggia ed equilibrata di rivitalizzare alcuni dei settori esistenti (meccanica e gomma-plastica in primis) ma anche avviare nuovi settori (che però non dice e mi piacerebbe sapere cosa pensa al riguardo). E vengo infine al quarto e cruciale punto che costituisce giustamente il “filo rosso” della riflessione di Caroli: quello della classe imprenditoriale bresciana. Mi spiace di non avere il tempo di leggere ai presenti alcuni passaggi del lavoro di Caroli al riguardo. Farò solo due considerazioni che mi paiono però fondamentali per il dibattito in corso. La prima: fa bene il presidente Pasotti a far leva sull’orgoglio di una classe imprenditoriale che non ha forse eguali, perché è a questo gruppo sociale che dobbiamo la ricchezza e la qualità della vita invidiabile di questa provincia e perché non si riparte in avanti senza la convinzione di “potercela fare”. In questo senso il dato che mi preoccupa di più è proprio quel certo “smarrimento” tra gli im- prenditori che Caroli registra. Ma se è così, non si dà un messaggio politico convincente e positivo negando lo smarrimento e soprattutto i problemi (di debolezza culturale e motivazionale) che attraversano l’attuale classe imprenditoriale. Il realismo pragmatico (un po’ luterano) dei bresciani non chiede l’assoluzione dai peccati ma una diagnosi anche impietosa che costituisca però la premessa per porvi rimedio. E proprio in questo trovo oltremodo stimolanti due intuizioni di Caroli. Quella di porre al centro dell’azione un rafforzamento dei valori (dunque un ripensamento rivolto a tutti, ma soprattutto alle giovani generazioni, sulle basi etiche e motivazionali dell’intraprendere) e di partire per fare ciò dalle medie imprese di eccellenza e da nuove imprese anche estere che possano fare da “nave scuola” per una rigenerazione e rivitalizzazione degli spiriti imprenditivi della provincia. La seconda: lo “smarrimento” attuale è figlio anche dell’individualismo che isola e estranea il singolo imprenditore dal contesto, della mancanza di leader che traccino la via, della mancanza di “catalizzatori” istituzionali in grado di coagulare volontà e risorse per progetti collettivi che ridiano fiducia. Per questo lo sforzo principale e più urgente è quello di riuscire a “fare squadra” tra tutti gli attori da cui dipende il futuro economico e sociale di questa provincia. Non credo sia una buona politica allora assolversi e attribuire le colpe principali agli altri (si tratti degli imprenditori, come dei politici o degli uomini di cultura e di scienza). La responsabilità di questa classe dirigente è innanzitutto quella di prendere coscienza di essere sulla stessa barca: nessuno è esente da debolezze e limiti, ma tutti insieme possiamo emendarli e uscire in avanti dai problemi che ci assillano, di cui stiamo prendendo consapevolezza e per i quali (a livello di sistema) abbiamo le risorse (economiche, sociali e culturali) per uscirne. Brescia: l’identità perduta La predisposizione e la gestione di un Piano regolatore è un momento molto importante per la vita di una città. Se si vuole, come recita la Presentazione del libro, “armonizzare le grandi libertà civili – i diritti di cittadinanza dei singoli e la legittima aspirazione alla crescita e alla espansione personale – con uno sviluppo comunitario non dissipativo”, è necessario trovare un equilibrio tra istanze opposte, un equilibrio che faccia cadere l’accento più che sul “piano” (strumento dirigistico, ancora prima che inaccettabile sul piano dei principi, ingestibile su quello dei fatti in una società aperta e matura come la nostra), sulle “regole”, su criteri e prospettive di sviluppo condivise e che possano costituire catalizzatori e linee guida di volontà individuali. Una gestione urbanistica efficace è e richiede anche necessariamente “cucina politica”, mediazione minuta di interessi, ma rischia di vanificarsi in mediazioni dissipative se non ha una prospettiva, una stella polare a cui guardare. Una prospettiva che non può che nascere da una “riflessione comune sulla città”, sulla sua identità che – come ci insegnano i filosofi e i sociologi contemporanei – si costruisce sempre più in una progettualità dinamica condivisa. Io non sono un urbanista e quindi mi è difficile entrare nel Presentazione del libro di M. Matteotti e M. Tedeschi, Brescia. Il Piano e i progetti, Salone Vanvitelliano, febbraio . merito di molte questioni “tecniche” (sia di metodo che di merito) che il libro con un linguaggio piano ma rigoroso e puntuale (grazie alla bravura degli autori ma anche alla sempre ottima cura editoriale di Grafo) ricostruisce. Mi proverò dunque a svolgere qualche riflessione sull’identità di questa nostra città, così come emerge dalla sua attuale connotazione urbanistica ma anche e soprattutto dalle dinamiche economiche e sociali sottostanti che la riguardano. Alcuni punti forti del Piano e dei progetti documentati dal libro mi sembrano assolutamente e generalmente condivisibili: la riqualificazione di alcune aree urbane, la soluzione dei problemi legati alla mobilità, l’uso parsimonioso e non dissipativo del territorio e l’attenzione ai “vuoti”, cioè al verde, e non solo ai “volumi”, per una diversa e più alta qualità della vita. Mi piacerebbe però che occasioni come questa diventassero anche momenti di riflessione su aspetti e prospettive “meno neutrali”: che città vogliamo? quali dinamiche spontanee sono in atto e come intendiamo accompagnarle? Senza – si badi – voler imporre un progetto dirigistico, ma pur ammettendo e anzi valorizzando la varietà e l’autonomia del sociale, cercando di innervare linee di forza, di dare ad esse consapevolezza culturale e strumenti per affermarsi al meglio entro un quadro equilibrato e coordinato di sviluppo complessivo. E allora riprenderò – per aggiornarla – una riflessione che ricordo abbiamo incominciato a fare ormai diversi anni fa con Mario Venturini. L’occasione era – se non ricordo male – uno dei Laboratori voluti da Bernardo Secchi per il preliminare del Piano, al Museo di Scienze naturali nel ’ o ’. La città – è quasi inutile dirlo – è profondamente cambiata a partire dagli anni ’. Basta leggere il capitolo del libro sul recupero e riqualificazione delle aree industriali dismesse per : raccogliere le prove di dettaglio di questo cambiamento. La Brescia del Novecento e del miracolo industriale, fatta da un tessuto di medio-grandi imprese localizzate prevalentemente in città e in grado di “governare”, secondo un modello sociale fordista e gerarchico, un tessuto di piccole imprese di subfornitura dislocate nella provincia, è venuta meno. Gli anni ’ e ’ sono stati anni di profonde dislocazioni economiche e sociali. È progressivamente prevalso un modello economico diverso, fatto di piccole e piccolissime imprese, organizzate per distretti, secondo logiche più orizzontali di “specializzazione flessibile”, in parte organizzate in filiere autonome (i casalinghi, la rubinetteria, le armi) in parte ancora vocate alla subfornitura (automotive, meccanica), ma capaci di fare a meno delle medio-grandi imprese locali. Ciò ha determinato sul piano strutturale (e anche urbanistico) la fine della grande impresa urbana, ma soprattutto ha provocato un progressivo decentramento di funzioni anche sociali e istituzionali. Da un sistema gerarchico – caratterizzato sì da una pluralità di sottosistemi tutti però bisognosi di una intermediazione istituzionale centrale che si realizzava attraverso la capacità di leadership del blocco sociale urbano (si pensi al ruolo di mediazione sociale svolto da Bruno Boni) – si è passati ad un sistema policentrico e reticolare che ridefinisce inevitabilmente la funzione sociale della città rispetto alle aree distrettuali della provincia, economicamente sempre più indipendenti. La consapevolezza di questi cambiamenti profondi è abbastanza recente. Si può dire che sia proprio maturata in questi ultimi anni, con la crisi definitiva delle ultime medio-grandi imprese, con i mutamenti di equilibri interni alle associazioni di rappresentanza degli interessi economici, con un ripensamento ormai avviato anche nelle forme di rappresentanza del mondo del lavoro. Ma questa nuova e recente consapevolezza – nel momento stesso in cui arriva a maturazione – sconta e deve misurarsi con una crisi economica profonda (qui sta la differenza rispetto alla fine degli anni ’), che impone una presa di coscienza circa il fatto che anche il modello di piccola impresa flessibile è destinato ad essere superato, in una fase di globalizzazione sempre più spinta che porta alla ribalta paesi più flessibili e a più basso costo del lavoro e che ci obbliga a muoverci rapidamente verso produzioni a più elevato valore aggiunto e quindi più alta intensità di capitali e di conoscenza. In sintesi, si è passati da un modello fordista classico (che in termini urbanistici ha retto il Piano Morini del – “la città per lavorare” – e in buona misura credo anche quello Benevolo – “la città per abitare” –, che ha cercato di garantire una migliore qualità di vita ma sempre all’interno di una ipotesi che vedeva l’area urbana come centro di funzioni economicoproduttive importanti e destinata a richiamare in termini di residenzialità ceti prevalentemente operai) al modello di piccola impresa post-fordista basata sulla flessibilità e decentrata in provincia, che mette in crisi il modello urbanistico tradizionale (e che è del tutto presente invece nelle riflessioni “aperte” del Piano Secchi). Ora questa dinamica fa un ulteriore passo avanti e la riflessione in corso su quale modello economico-sociale possa garantire un futuro alla provincia ci interroga, ma forse ci fornisce anche qualche spunto di maggiore certezza sul ruolo sociale e culturale che la città capoluogo e destinata a giocare nel prossimo futuro. Credo infatti che sia difficile pensare che Brescia possa nel futuro svolgere ancora il ruolo di capoluogo, di centro di governo “tradizionale” del territorio provinciale. Ma se non reg- : ge più il modello della città capoluogo (su cui tutti qui saranno credo d’accordo), non regge forse nemmeno più il modello della “città diffusa”, della città allargata al territorio circostante e in esso sempre più integrata con funzioni comunque sempre centralizzate di servizio. Occorre forse cominciare a ragionare in termini di “città rete”: di Brescia come “nodo di una rete”. Un nodo che deve ricercare la propria funzione e identità nella relazione con altri nodi, sia locali (le altre città, ma anche nodi funzionali decentrati sul territorio come le fiere, i centri commerciali e i luoghi dell’intrattenimento culturale, le nuove “trame” di un sistema sociale sempre più policentrico e diffuso), che nazionali e internazionali (Verona, Bergamo, Milano, ma anche New York o Pechino) a cui la società locale guarda ormai sempre di più e verso i quali “va accompagnata”. La consapevolezza che mi sembra stia maturando in una classe economica che avverte l’esigenza di un salto di qualità deve essere supportata da nuove funzioni di alta qualificazione cognitiva e culturale. La città allora può divenire il luogo/nodo di questa funzione – promuovendo le competenze e i servizi ad alta qualificazione che sono necessari per far crescere l’intero sistema, con un’ottica però non di centralizzazione ma di promozione e di successiva diffusione sul territorio, non di sviluppo autarchico ma di tramite verso le reti lunghe della conoscenza e dell’economia globale. Se questa è la possibile vocazione identitaria della Brescia del futuro, accanto ai progetti di intervento urbanistico “manutentivo” – che garantiscano cioè l’aggiustamento virtuoso dell’ esistente – occorre cominciare a pensare ad interventi evolutivi, con una progettualità che guarda avanti al futuro delle funzioni urbane richiesta dal nuovo ruolo. E allora mi chiedo e chiedo: quali dovranno essere queste funzioni? Quali ceti e gruppi sociali dovranno “vivere” la città del futuro e quali caratteristiche residenziali e di qualità non solo ambientale ma anche sociale saranno per loro attraenti? Quale mobilità sarà necessaria per permettere alla Brescia del futuro di svolgere la sua funzione di nodo cognitario dell’area? Città in rete Questo incontro, che succede a quello di Verona del giugno scorso, testimonia della volontà dei comuni capoluogo qui convenuti a stipulare una alleanza strategica che possa dare luogo ad una “geocomunità di opportunità” (Bonomi), una “marca territoriale” di mezzo (Corsini) che possa fungere da cerniera consapevole tra nord-est e nord-ovest, tra Lombardia e Veneto, e tra il Mediterraneo e il nord Europa lungo l’asse dell’Adige. Cade poi in un momento particolarmente significativo per Brescia, alla vigilia dell’avvio delle audizioni che porteranno alla Conferenza degli Stati generali prevista per fine anno. Per Brescia è l’avvio di un processo di “pianificazione strategica” che altre città qui presenti hanno già avviato con successo. Questo incontro assume dunque per noi bresciani un senso particolare: non solo quello di poterci confrontare con esperienze già fatte dalle quali trarre insegnamenti preziosi di metodo, ma soprattutto quello di dare contenuti non localistici alla riflessione che questa provincia sta avviando sul suo futuro. Le alleanze strategiche di rete costituiscono infatti – a mio giudizio – la modalità oggi più efficace (in termini sia di metodo che di merito) per collegare locale a globale, per far interagire al meglio le specificità e le radici dei territori (i luoghi) Intervento al convegno Città in rete, Salone Vanvitelliano, ottobre . con la comunicazione, la circolazione dei capitali (finanziari e di conoscenza), la mobilità (in una parola i flussi) di una economia sempre più globalizzata. C’è un legame stretto (quasi perfettamente simmetrico) tra le relazioni interne alla città e le relazioni tra città, come la polisemia del titolo di questo convegno bene segnala: città in rete, nel senso sia di “reti di città”, cioè relazioni e alleanze tra città, ma anche di “città delle reti”, città fatta di relazioni orizzontali tra soggetti diversi (istituzioni, agenzie privato-pubbliche, rappresentanze della società civile, non profit, imprese private). Le reti sono a geometria variabile e dai confini non definiti, mettono in relazione soggetti a livelli di complessità e di constituency diversi e mutevoli nel tempo, obbligano a un metodo di lavoro e di costruzione delle policy (per discussione informata e negoziazione integrativa) nuovo e tutto da sperimentare, con confini (amministrativi e geografici) sempre più labili e non definiti una volta per tutte. Ma proprio questa novità pone serie questioni di metodo e di merito. Nel metodo innanzitutto. Le alleanze strategiche debbono trovare un fondamento in una “pianificazione strategica” che Perulli ben descrive nel suo libro Piani strategici. Governare le città europee (Franco Angeli). Per usare una efficace citazione contenuta nel libro (e ripresa da Bagnasco), l’azione strategica “consiste fondamentalmente nel convincere molti liberi attori diversi … a comportamenti che si orientano reciprocamente, ovvero a investimenti complementari lungo un sentiero di crescita definito dalle scelte sulle quali si raggiunge un ragionevole consenso e sui cui esiti si possono fare ragionevoli previsioni”. Ora una pianificazione siffatta, deliberativa e negoziale, comporta, da un lato, la consapevolezza che i metodi di governo amministrativo del passato (nazionale come locale) sono sempre meno efficaci per governare territori e società in rapida evoluzione (troppo lungo sarebbe qui analizzare le cause di questi cambiamenti); dall’altro, l’emergere di molti problemi che le esperienze di governo strategico delle città europee stanno mostrando con chiarezza. Senza pretesa di essere esaustivo o sistematico ne elenco alcuni. La necessità di attivare un processo capace di costruire una meta collettiva, di orientare al futuro, di definire mediante scelte concrete una idea condivisa di città: è questo un processo che implica una leadership ma anche una partecipazione ampia e soprattutto una dialettica matura tra i due momenti (e non la tendenza prevalente oggi al rapporto diretto e mediatico tra una persona più o meno carismatica e una massa di individui disinteressati). Ma anche la necessità di dare seguito agli orientamenti con strumenti non di government ma di governance (come ci ricorda Perulli), quindi attraverso condivisione deliberata o negoziata di scelte tra soggetti diversi e non attraverso command and control da parte di una autorità costituita e legittima. Ma questo comporta un diverso modo di governare da parte degli enti locali, con sperimentazioni innovative nel rapporto tra gli strumenti amministrativi tradizionali e quelli della pianificazione strategica e, soprattutto, la gestione di livelli multipli non gerarchici di governo (fuori squadra come dice Bagnasco): tema particolarmente impegnativo nel caso specifico di oggi di una alleanza tra soggetti che appartengono a regioni diverse. Nel merito, poi, ci sono alcune questioni su cui un confronto vero e più serrato si impone tra le sei città qui convenute. Mi limito ad elencarle di seguito, con poche osservazioni: () le infrastrutture e il coordinamento tra le utilities sono quelle che possono trarre i maggiori benefici da una intesa stra- tegica tra le città. Ma ci sono temi “duri” che vanno affrontati per quello che comportano: aeroporto e strutture espositive; () il tema di una alleanza sui temi del turismo e della cultura è un altro tema assolutamente unificante e di grande interesse, ma non può essere l’unico perché il futuro di tutte queste città non potrà essere solo nel turismo e nell’economia dell’arte; () una certa ridondanza di funzioni è, oltre che politicamente opportuna, anche economicamente utile, ma una qualche idea di divisione dei compiti (secondo vocazioni anche storiche ma con scelte precise sul futuro) dovrà pure essere fatta; () soprattutto su due questioni importanti: quella della finanza e quella dell’industria. Sull’industria in particolare, soprattutto per fornire orientamenti forti su quali indirizzi prendere per sviluppare una economia neo-industriale: vale a dire ancora industriale ma in una fase dove i beni anche materiali hanno un crescente valore che deriva dai contenuti immateriali di conoscenza che li contraddistinguono. Per fare ciò è necessario coinvolgere i soggetti economici, quelli finanziari e le università in un processo di convergenza verso vocazioni diverse e utilmente complementari (e non verso duplicati o peggio scelte contrastanti); () infine, per Brescia e Bergamo, quali rapporti con Milano? si guarda ad est o ad ovest? si può essere strabici? È importante comunque trovare alcune idee forti e concrete su cui sperimentare con successo una alleanza, che potrà crescere e ampliarsi grazie anche al successo dei primi esperimenti. Da questo punto di vista è indispensabile dare seguito a questi incontri dotandoli di un qualche organismo che sappia concretizzarli sul piano operativo. Economia e cultura a Brescia. Il caso del MusIL Economia e cultura a Brescia: l’uso della congiunzione “e” è alquanto frequente nei titoli. Ho sempre ritenuto che ciò accada perché suggerisce l’esistenza di una relazione tra i termini dell’endiadi senza necessariamente stabilirne la natura o il verso. Nel caso specifico di questo intervento, il titolo mi è stato assegnato dagli organizzatori di questo importante momento di riflessione per il Museo dell’Industria e del Lavoro. Mi sono chiesto per altro quali fossero le loro intenzioni: volevano, nell’affidarmi il compito, che io parlassi di cosa possa fare l’economia per la cultura o, viceversa, di cosa possa fare la cultura per l’economia? O forse, più verosimilmente, di entrambe le cose? In mancanza di indicazioni precise circa l’intendimento dei committenti, proverò inizialmente a interrogarmi proprio sulla natura della relazione tra economia e cultura. Un primo ordine di riflessioni, alquanto frequentato di recente anche da noi, insiste soprattutto sulla opportunità che l’economia (privata) si faccia carico della cultura. Le difficoltà finanziarie crescenti del sistema pubblico, che in passato è stato se non l’unico certo il principale promotore di cultura, obbligano a cercare altrove le risorse necessarie per sostenere un settore – quello culturale apRelazione al convegno organizzato dal MusIL, Economia e cultura: il Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti, Ridotto Camera di Commercio, dicembre , già apparso nel Quaderno n. del MusIL. punto – che, come ci ha insegnato William Baumol, è sottoposto a forte pressione sui costi, dato che per comporre e suonare un quartetto di Mozart continua ad essere necessario oggi lo stesso impegno del ’, mentre la produttività del resto dell’economia ha sperimentato nel frattempo incrementi di alcuni ordini di grandezza. I problemi sottesi al finanziamento privato della cultura sono per altro assai complessi, mettendo in gioco la natura stessa della cultura e la sua funzione sociale. Senza addentrarsi troppo in tecnicismi, si deve ricordare infatti come i “beni culturali” presentino caratteristiche tali da rendere difficoltoso se non impossibile il ricorso al mercato come efficiente strumento di allocazione delle risorse. Si tratta infatti di beni: () relazionali, () a consumo non rivale, e () almeno in parte escludibili. I beni culturali sono beni la cui utilità per il singolo individuo non può prescindere dalla relazione che tramite essi egli stabilisce con altri: ciò è immediatamente evidente nel caso del bene culturale per eccellenza di una comunità, il suo linguaggio, ma a ben vedere vale, seppure in misura diversa, per tutti i beni culturali. Anche l’utilità che si può ricavare da un libro o da un’opera d’arte dipende dalla sua condivisione: cioè dalla relazione (morale, estetica o talvolta anche di mero prestigio) che per il tramite di tale opera il consumatore stabilisce con altri. La produzione inoltre di cultura è funzione della sua diffusione e libera circolazione: quanto più si crea un tessuto denso di relazioni tra consumatori e produttori di cultura, tanto più crescerà il tasso di creatività di una comunità. In secondo luogo i beni culturali – come tutti i beni immateriali – sono beni a consumo non rivale: vale a dire che il consumo da parte di un soggetto non sottrae valore al bene, che può essere consumato anche da altri senza che sperimentino una ri- . duzione della sua utilità. Per altro, anche se le due caratteristiche anzidette porterebbero a favorire la massima circolazione e fruizione dei beni culturali, il fatto che la loro produzione sia costosa impone secondo una logica di mercato di ricorrere alla terza caratteristica, quella dell’escludibilità, alla possibilità cioè di non ammettere al beneficio del bene coloro che non partecipino ai suoi costi di produzione. Ma il ricorso alla pura logica di mercato (per cui può beneficiare appunto solo chi paga) escluderebbe dalla fruizione della cultura tutti coloro che non possono pagare e che trarrebbero comunque una utilità dal suo consumo, con effetti negativi non solo sull’ottimizzazione paretiana del benessere sociale, vista la natura non rivale del consumo culturale, ma sulla stessa diffusione e circolazione della cultura e dunque sulla creatività del sistema, che è una esternalità da proteggere e promuovere. A queste condizioni è dunque pressoché impossibile definire una struttura di prezzi che permetta di rientrare dai costi di produzione dei beni culturali: i musei, ad esempio, per limitarci ad un caso che riguarda da vicino il Museo dell’Industria e del Lavoro che andremo ad aprire, con difficoltà riescono con la sola bigliettazione a coprire non più del -% dei costi medi per visitatore. Ne consegue che chi frequenta con più assiduità questo ordine di ragionamenti su cosa possa fare l’economia privata per la cultura, si rivolge soprattutto ad altre forme di contribuzione, quale quelle derivanti dalla filantropia (più o meno istituzionale o incentivata fiscalmente) o dalle sponsorizzazioni private, dettate per lo più da finalità di promozione di brand commerciali. Non mi addentrerò sugli effetti (non sempre positivi o quanto meno neutri) di queste forme di contribuzione privata alla cultura. Noto per altro che spesso per giustificare gli sgravi fiscali a favore dei filantropi o per convincere gli sponsor privati, si ricorra al secondo tipo di riflessioni che voglio brevemente commentare. Vale a dire a ciò che la cultura può fare per l’economia. La via maestra di questo ragionamento, almeno in Italia in questi ultimi anni, è quella del cosiddetto “turismo culturale”. Assunto che vi è una crescente e diffusa domanda culturale e che esistono nel nostro Paese importanti lasciti del passato che possono essere adeguatamente valorizzati, si sottolinea come da tale valorizzazione possano derivare non solo risorse dirette per il settore culturale ma anche e soprattutto benefici indiretti o indotti per l’intera economia, quali i flussi di reddito generati dalla domanda di servizi alberghieri, di ristorazione o di prodotti dell’artigianato locale, la valorizzazione della rendita urbana, la promozione di settori produttivi collegati (quali case editrici, produttori di merchandising, allestitori di esposizioni temporanee, botteghe di restauro, ecc.). E sulla base di questo ragionamento si studiano formule o “modelli di business” culturale. Credo che la consapevolezza di queste potenzialità economiche degli asset culturali che un territorio si trova a possedere sia un importante passo avanti rispetto allo stato spesso di incuria e di dispersione dell’enorme patrimonio culturale che abbiamo ereditato dal passato. Avverto e segnalo però tre limiti di una impostazione siffatta. Il primo riguarda la concezione ristretta e l’uso potremmo dire “strumentale” che viene fatto della cultura. Ciò che si immagina valorizzabile in questa prospettiva è (quasi) esclusivamente il patrimonio architettonico e artistico posseduto, trascurando gran parte della varietà e ricchezza delle forme culturali di una comunità (al più con qualche concessione . marginale all’artigianato e alle tradizioni gastronomiche locali). Inoltre la valorizzazione risponde ad una logica strettamente mercatistica: si investe solo dove si abbia un ritorno di mercato turistico a breve. Da questo primo limite derivano come corollari gli altri due. La valorizzazione del patrimonio culturale sub specie turistica vede coinvolti come beneficiari “culturali” principalmente se non esclusivamente persone provenienti da fuori, che con la loro domanda generano reddito per i residenti. Questi ultimi beneficiano solo “economicamente” dei beni culturali posseduti dalla comunità. Ne consegue – terzo aspetto problematico che intendo richiamare all’attenzione – che il più delle volte questa forma di valorizzazione del patrimonio culturale non genera “capitale culturale”, vale a dire risorse culturali (si badi: culturali non economiche!) che possano essere reinvestite per produrre nuova cultura e quindi accrescere o accumulare capitale culturale. La valorizzazione a fini turistici di un patrimonio esistente è a ben vedere non produzione e accumulazione di capitale ma semplice sfruttamento di una rendita di posizione culturale. C’è forse da chiedersi quale potrebbe essere il patrimonio culturale di molte città d’arte italiane se i nostri predecessori si fossero comportati in ugual maniera! Per fortuna da qualche tempo anche da noi, seppure mi pare di poter dire ancora in modo marginale, sta prendendo piede un terzo e diverso modo di concepire il rapporto tra cultura e economia. Un approccio certamente più complesso sotto il profilo teorico e più difficile da realizzare praticamente, ma che, senza trascurare o contrastare la dimensione turistica, anzi ponendo le condizioni per una sua migliore valorizzazione, la ricomprende entro una visione più ampia e, almeno a mio giudizio, molto più proficua del contributo che la cultura può apportare all’economia di un territorio. Questo approccio si è andato delineando a partire dall’idea dei cosiddetti “distretti culturali urbani” e ha trovato in anni recenti robusti riferimenti teorici nei modelli di Michael Porter per il recupero dei centri urbani sulla base di una competitività auto-sostenuta, di Richard Florida sul ruolo e l’importanza della “classe creativa” per lo sviluppo economico, e infine di Amartya Sen sulla necessità di sviluppare quelle che egli chiama le capabilities, ovvero le capacità di azione che la società deve promuovere perché gli individui possano divenire soggetti attivi di sviluppo. Per rimanere nei limiti di tempo che mi sono concessi, credo si possa riassumere questo approccio nella necessità di un superamento del rapporto strumentale vuoi dell’economia verso la cultura che della cultura verso l’economia e nella affermazione piuttosto della opportunità di sperimentare sinergie che potenzino reciprocamente l’una con l’altra. In altri termini, il capitale culturale opportunamente investito nella produzione di nuova cultura (e non “consumato” a fini di immediato sfruttamento economico) può generare capitale umano e capitale sociale, due ingredienti fondamentali per lo sviluppo economico di un territorio e capaci altresì di generare ritorni positivi per la stessa cultura. Una offerta ampia di cultura, rivolta certo anche ai potenziali turisti ma innanzitutto e soprattutto ai residenti, contribuisce in modo determinante alla produzione di conoscenze originali dentro una comunità; alla creazione di un ambiente favorevole alla incubazione di una classe creativa autoctona e all’attrattività di talenti esterni; allo sviluppo di capabilities e alla crescita del capitale umano; ad una maggiore coesione sociale pur nella valorizzazione delle differenze esistenti; all’apertura e allo scambio con altri paesi e comunità. Tutto ciò ha effetti benefici diretti sull’economia di un territorio. Genera un tessuto ricco . di imprenditori e lavoratori consapevoli e aperti al nuovo – che sono, nell’era dell’economia della conoscenza, i veri e unici asset distintivi per la competitività – attraendo così investimenti esterni e mobilitando quelli interni. In una parola, genera sviluppo economico e crea pure le condizioni per ulteriori investimenti in cultura. Non c’è bisogno di andare lontano (se non nel tempo) per trovare l’esempio forse in assoluto più luminoso di questa sinergia e dei risultati che essa può produrre: basti por mente infatti a cosa sia stato per lo sviluppo culturale ma anche economico il Rinascimento italiano! Ora, sono fermamente convinto che di input culturali siffatti sia oltremodo bisognosa la società e l’economia della nostra provincia. Gli Stati generali dell’economia e della società bresciana hanno registrato una convergenza pressoché unanime sullo stato dell’economia locale. Accanto ad alcuni indubbi punti di forza – che ne hanno fatto una delle economie più dinamiche del Paese e dell’Europa intera – non si possono però sottacere né sottovalutare alcuni elementi di debolezza, tanto più preoccupanti quanto più si affermano paesi che vanno a coprire con grande determinazione e maggiori possibilità le stesse posizioni dell’economia provinciale nella divisione internazionale del lavoro, costringendola per rimanere competitiva a spostarsi su produzioni a maggiore valore aggiunto. Risultato che potrà essere perseguito con successo solo se si riuscirà a rivitalizzare e valorizzare con nuove conoscenze d’origine scientifica e con un di più di creatività il grande patrimonio di saperi pratici e contestuali accumulati giorno per giorno sui posti di lavoro dentro le fabbriche. Ma ciò richiede che si coltivi una nuova generazione di imprenditori e lavoratori “creativi”, capaci cioè di far tesoro del passato ma anche di proiettarlo in un futuro necessariamen- te diverso. Purtroppo uno dei limiti maggiori di questa nostra realtà provinciale, per tanti altri versi straordinaria, è la frammentazione, che è innanzitutto scarsa conoscenza reciproca, mancanza di comunicazione e dialogo tra le varie parti della società e tra i soggetti che la compongono. Negli ultimi anni la classe creativa (come definita dal sopra citato Richard Florida) è cresciuta a Brescia (anche se resta al di sotto di quella presente in altre città simili), e soprattutto si vanno affermando in alcune nicchie esperienze imprenditive e innovative di notevole interesse che rimangono però sconosciute al resto dell’economia e della società bresciana. Ha ragione Roberto Verganti quando auspica per Brescia dei “mercanti d’arte”, ovvero – nel senso traslato che egli attribuisce al termine – dei soggetti capaci di far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti e di importarne da fuori, proponendo modelli di riferimento forti alle nuove generazioni, che altrimenti – come già hanno purtroppo incominciato a fare – emigreranno alla ricerca di ambienti più stimolanti e promettenti. È in questo contesto e a fronte di queste sfide che deve definirsi il ruolo del Museo dell’Industria e del Lavoro. Dico subito quello che a mio parere il Museo non deve essere se vuole esercitare appieno una funzione positiva e dinamica nel rapporto tra economia e cultura in questa nostra realtà. Innanzitutto non deve essere solo un mero luogo della memoria o, peggio ancora, dell’orgoglio industrialista della Brescia passata. Non deve poi limitarsi ad offrire a visitatori distratti e poco coinvolti beni pseudo-culturali – pseudo-culturali, perché non c’è cultura vera senza una partecipazione attiva e consapevole. Deve mirare piuttosto ad essere un luogo vivo, una “fabbrica di cultura” appunto, capace di attrarre e mobilitare nuove risorse, di coinvolgere in primo luogo gli abitanti della provincia e divenire . così il crocevia di esperienze diverse che oggi tendono invece ad ignorarsi. Il Museo ha in sé le potenzialità per poter divenire un punto di incontro, un ponte gettato su tre cleavages, o fratture culturali, che costituiscono, almeno a giudizio di chi vi parla, le principali ragioni della relativa staticità culturale (e dunque, se valgono le considerazioni precedenti, anche economica) della realtà locale: quella già ricordata tra passato e futuro; quella tra cultura storico-umanistica e cultura tecnologica, quella tra cultura alta e cultura materiale. Per fare del Museo un centro attivo di cultura e uno stimolo per l’economia e la società bresciana è necessario agire su più fronti (come le più riuscite esperienze soprattutto estere dimostrano). Mi limiterò qui ad accennare brevemente ad alcuni. Innanzitutto attraverso il progetto delle esposizioni permanenti. Il concept museale – che verrà presentato subito dopo questa introduzione – mi pare del tutto coerente con la prospettiva che vengo delineando. Accanto infatti ad alcuni significativi luoghi della memoria tecnologica e industriale (la Galleria delle macchine e Brescia: un territorio dell’industria), prevede occasioni di incontro tra storia e tecnologia (la Galleria del Novecento) e soprattutto uno sguardo aperto sul futuro (la Vetrina dell’innovazione). Tuttavia non basta solo un progetto museale originale e coerente, occorre alimentare un interesse ed una partecipazione che sole possono rendere vivo il Museo ed efficace la sua azione. In questa direzione risulteranno essenziali soprattutto le mostre temporanee, che avranno il compito non solo di attrarre turisti ma anche e soprattutto di tener viva l’attenzione dei residenti, per i quali altrimenti il Museo rischia di divenire nel giro di poco tempo un arredo urbano accanto al quale si passa senza più prestare attenzione. In particolare potranno suggerire temi e prospettive che sappiano fare del passato una chiave utile a interpretare il presente e aprirlo al futuro. Si pensi – per non fare che qualche esempio – quale contributo “culturale” forte potrebbe apportare una esposizione tematica sull’energia o sui rifiuti urbani che metta a confronto i modelli del passato con quelli del presente suggerendo (magari con il coinvolgimento di centri di ricerca o imprese specializzate) nuove prospettive tecnologiche ed economiche; oppure una esposizione di best practices nel campo dell’architettura industriale che possa suggerire a imprenditori e progettisti soluzioni (ambientali ed architettoniche) utili a migliorare il “paesaggio” delle numerose (e ahimè spesso tutto fuorché gradevoli) aree industriali del nostro territorio. Un terzo elemento qualificante è il coinvolgimento attivo dei residenti nelle attività del Museo. In un contesto quale quello bresciano, ricco di cultura industriale e propenso a forme di partecipazione volontaria, non dovrebbe risultare difficile reclutare operai e quadri dell’industria in pensione come manutentori e guide, o coinvolgere giovani studenti delle superiori o universitari in attività di ricerca e di animazione. Il coinvolgimento attivo risulterà poi tanto più efficace culturalmente quanto più il Museo riuscirà a stabilire relazioni proficue non solo con altri musei scientifici e tecnologici o con altri potenziali poli museali del territorio (oltre alle tre “antenne” già previste a Rodengo, Cedegolo e S. Bartolomeo) ma anche con altri centri di cultura e di innovazione tecnologica. Mi riferisco, oltre alle scuole e alle università, ad AQM, al Centro servizi multisettoriale per il trasferimento tecnologico, alle accademie d’arte e di design, agli altri musei cittadini, alle stesse imprese. Infine andrà valorizzata al meglio la stessa localizzazione del . Museo, creando sinergie che sappiano durare e rinnovarsi nel tempo. Il progetto di recupero del Comparto Milano – dove è prevista la sede centrale del Museo – offre di per sé una straordinaria occasione simbolica per un museo che intenda stabilire un legame di continuità e insieme di rinnovamento tra il passato manifatturiero e il futuro neo-industriale della città. Sarebbe per altro auspicabile che le opzioni ancora aperte sulla parte residenziale e su quella destinata ad attività economiche possano favorire offerte residenziali private e di housing sociale tali da attrarre giovani studenti, ricercatori e professionisti della conoscenza con redditi contenuti ma di elevato potenziale, e l’agglomerazione di attività economiche innovative, sinergiche con la presenza del Museo e con le caratteristiche dei residenti. Perseguire gli obiettivi qui seppur sommariamente suggeriti richiede una concertazione convinta di diversi soggetti e, con riferimento specifico al Museo, la disponibilità di risorse adeguate a garantirne il funzionamento come centro attivo di cultura e non semplicemente come contenitore di reperti storici seppure di straordinario significato. E così, nel chiudere, mi sia concesso tornare brevemente al punto di partenza di questa riflessione. La Fondazione di partecipazione che ha la responsabilità di gestire il Museo dovrà interrogarsi seriamente sulle formule anche economiche più adeguate per assicurare efficacemente la sua attività. Una valutazione rigorosa delle esternalità generate dal Museo (mediante l’applicazione di metodi oggi disponibili e internazionalmente condivisi) potrebbe innanzi tutto determinare e giustificare l’entità del contributo che dovrà essere destinato annualmente dagli enti locali che beneficiano delle sue ricadute positive. Per altro reputo essenziale che ci si adoperi per mobilitare altre risorse di natura privata, e non solo per ragioni economiche bensì anche come stimolo e indicatore concreto di efficacia dei servizi offerti dal Museo alla realtà del territorio. Formule già altrove sperimentate con risultati apprezzabili, quali la promozione di associazioni di amici del Museo, che possano prestare la loro opera volontaria, la costituzione di club di sostenitori (ad esempio di imprese disponibili a destinare annualmente una percentuale anche molto modesta dei loro utili ad un fondo a sostegno del Museo), l’adozione di modelli innovativi di bigliettazione, come il pay what you wish, praticato ormai da molti musei come strumento per permettere l’accesso a soggetti con capacità di pagare differenti, possono favorire la partecipazione diffusa alle sorti non solo economiche ma culturali del Museo. Nell’acronimo concepito recentemente ma già contenuto sin dalle origini nel nome del Museo sta forse il suo destino e la sua missione. Il MusIL potrà infatti contribuire forse solo un poco ma concretamente a gettare un ponte tra scienza e spirito, tra tecnologia e arte, tra economia e cultura, nella consapevolezza – che apparteneva anche al grande romanziere e intellettuale austriaco di cui ricorda il nome – che si tratta di momenti tra loro inconciliabili e pur tuttavia che il tentativo della loro riconciliazione è ciò che contraddistingue e dà sapore alla nostra vita di uomini moderni. Dal tondino a S. Giulia? Cultura ed economia nella Brescia del XXI secolo Brescia e la cultura Quello della cultura a Brescia è un argomento difficile, perché ricco di aspetti dissonanti. Da un lato infatti è dura a morire – nonostante i tentativi fatti soprattutto negli ultimi anni per smentirla e su cui tornerò tra breve – l’immagine di una città “ricca ma ignorante”, dedita all’industria e refrattaria (per scelta voluta) alle astrattezze delle dissertazioni culturali, considerate dai più inconcludenti. Dall’altro, a chi conosca Brescia solo un poco più da vicino non possono sfuggire i tanti tratti contrastanti rispetto a quella immagine. Al grande patrimonio archeologico e artistico della città, ben conservato e che ha cominciato ad essere adeguatamente valorizzato – che testimonia di una tradizione culturale niente affatto minore o marginale – si devono aggiungere alcuni musei (tra cui spicca ovviamente quello di S. Giulia), una delle più raffinate biblioteche civiche della Lombardia se non d’Italia, alcune case editrici piccole ma di ampio respiro, diverse fondazioni e centri culturali, due quotidiani, diverse riviste di cultura e politica, un teatro stabile di prosa e un festival musicale, per non dire delle due università e di un tessuto di buone scuole superiori che resistono nonostante le difficoltà nazionali. Intervento al convegno Cultura e territorio, Ateneo di Brescia, aprile . Eppure l’immagine della Brescia “ricca ma ignorante” è dura ad essere smentita. Il tentativo forse più ambizioso e insieme discusso e criticato di rompere questa immagine della città è stata senza dubbio l’iniziativa delle grandi mostre nell’ambito del progetto “Brescia lo splendore dell’arte”. Ora su questa iniziativa bisogna pure discutere (cosa che non è mai stata fatta seriamente né durante né tanto meno dopo); e riflettere sul perché abbia provocato giudizi positivi all’esterno e invece spesso negativi all’interno. Personalmente resto convinto che l’operazione abbia costituito un passaggio fondamentale per il rinnovamento della identità culturale della città e per questo mi auguro che non venga dimenticata, o ancor peggio rimossa, disperdendo così una esperienza essenziale per il futuro culturale della città e della provincia. Credo infatti che – come ci hanno insegnato filosofi come Paul Ricoeur e Emmanuel Levinas – l’identità di un soggetto, ancor più se si tratta di un soggetto collettivo come una città o un territorio, si costruisca attraverso un complesso gioco di rimandi. L’immagine che gli altri ci riconoscono è fondamentale per la percezione che ci facciamo di noi stessi e condiziona la costruzione della nostra identità. L’operazione grandi mostre ha avuto questo merito: di rompere lo schema della “città del tondino”, l’immagine di una città tutta dedita al fare quotidiano e insensibile, se non ostile, alla cultura. Ma possono bastare le grandi mostre per rinnovare l’identità della città e per avviare un nuovo ciclo culturale? Certo che no. Le grandi mostre hanno permesso di portare una nuova immagine di Brescia fuori da Brescia, di modificarne la percezione, il riconoscimento che gli altri hanno sempre proiettato su di noi. Ha così provocato uno “squilibrio” nel gioco dei ri- . mandi attraverso cui si costruisce una identità. Ha provocato sorpresa, una felice sorpresa negli altri; ma ha messo in crisi noi, ci costringe a fare i conti con un passato che non c’è più (per ragioni innanzitutto oggettive ma anche perché gli altri ci rimandano ora l’immagine di una città diversa dal passato), e a ragionare su un futuro che non riusciamo ancora a definire con precisione. La politica della cultura del prossimo decennio deve dunque ripartire da questo problema, da questa identità in trasformazione; partire dal salutare spiazzamento che le grandi mostre hanno creato nella percezione collettiva della città, per fornire alla città una nuova identità al passo coi tempi e con le aspettative spesso non ben delineate dei suoi abitanti. Lasciatemi allora fare alcune brevi considerazioni per un percorso tutto da costruire. Tre fratture Innanzitutto una identità collettiva la si costruisce nel dibattito e nel confronto. Ora la cultura della nostra città ha – a mio parere – il suo principale limite nell’essere “frammentata”, di peccare cioè del medesimo (e non poteva essere diversamente) peccato di tutta la società bresciana, quella che ad un osservatore esterno, Gian Battista Sgritta, nella ricerca Brescia promossa dalla Fondazione ASM, appare essere il “difetto congenito” della realtà locale e della mentalità dei bresciani: la difficoltà a sciogliere i nodi dell’individualismo e dell’orgoglio di appartenenza ad un gruppo, ad una associazione, ad una categoria, di superare la logica della tolleranza distratta o del gossip (questo sì) inconcludente. Anche il grande sforzo culturale prodotto tra la fine degli an- ni ’ e questo scorcio di anni dalle amministrazioni Corsini non mi pare sia riuscito a superare tale frammentazione. Se questa interpretazione corrisponde al vero, allora su questo innanzitutto bisogna lavorare. E bisogna lavorare cercando di risolvere tre “fratture” che mi pare continuino tutt’oggi a segnare negativamente i processi culturali della città. Innanzitutto la frattura tra cultura alta e cultura materiale. La cultura alta, quasi per definizione e dunque non solo a Brescia, presenta tratti elitari. Ma in alcune realtà ha saputo comunque inseminare positivamente la cultura materiale, anche a costo di qualche imbarbarimento o imbastardimento. E ha saputo spesso rinnovarsi e misurarsi con problemi nuovi grazie proprio a questi imbarbarimenti o imbastardimenti, grazie cioè al contributo di concretezza e agli stimoli di cambiamento provenienti dalla cultura materiale. Sarebbe troppo lungo ricostruire qui le diverse ragioni storiche e sociali che hanno impedito che ciò avvenisse nella realtà bresciana, dove la cultura alta ha invece troppo spesso peccato di endogamia, nonostante alcuni pregevoli tentativi (tra cui quello dell’istituzione che questa sera ci ospita) che nel tempo hanno cercato di aprirla alla realtà dell’economia e delle professioni. Una delle ragioni – non l’unica ma, a mio parere, una delle più importanti di questa prima frattura – va ricercata in una seconda frattura, che chiede di essere ricomposta perché anche la prima possa sciogliersi positivamente, ed è la frattura tra cultura umanistica e cultura tecnologica. Al riguardo avanzo una ipotesi. Che il rifiuto dei grandi eventi culturali prima ricordati sia stato dettato principalmente dal fatto che molti bresciani li hanno interpretati sotto una luce sbagliata. Ovvero come un tentativo di cambiare il DNA della città, trasformandola da una città industriale manifattu- . riera (la “città del tondino”) in una città d’arte e del turismo culturale (la “città di Santa Giulia” appunto). Credo che questa visione, se pure sia mai appartenuta o appartenga a qualcuno in questa città, non possa comunque costituire realisticamente il punto di arrivo di una identità ricostruita. Per intenderci, la risposta alla domanda contenuta nel titolo un po’ ad effetto di questo mio intervento non può essere, almeno nella mia opinione, che negativa: S. Giulia non sostituirà mai il tondino, anzi se vorremo fare un salto di qualità sia sotto il profilo economico (visto tra l’altro che di tondino non se ne fa quasi più in questa provincia) che culturale dovremo trovare una diversa immagine, che sappia fare sintesi tra S. Giulia e il tondino e che oggi, non a caso, manca nell’immaginario collettivo della città. Detto fuor di metafora: la rinnovata identità di Brescia credo possa essere trovata nell’idea di una città che potremmo dire neo-industriale, di una città cioè che trovi la sua ragion d’essere e nuove potenzialità di crescita in una industria rivitalizzata dalla conoscenza, rispettosa dell’ambiente, innovativa, capace di mettere le grandi competenze manifatturiere ed artigianali della sua storia al servizio di nuovi prodotti frutto della ricerca tecnologica e di uno “stile” di vita culturalmente consapevole. Una offerta di cultura, che abbia respiro e qualità, che sappia interessare e appassionare anche visitatori esterni, ma che sia rivolta innanzitutto e soprattutto ai residenti, può contribuire all’apertura e allo scambio con altre culture, alla creazione di un ambiente favorevole all’attrattività di talenti esterni e alla incubazione di una classe creativa autoctona, alla produzione di conoscenze e prodotti originali. Ciò produrrà effetti benefici diretti sulla società e sull’economia locale. Contribuirà significativamente alla incubazione di un tessuto ricco di imprendi- tori e lavoratori innovativi – che, nell’era dell’economia della conoscenza, sono i veri asset distintivi da cui dipende la competitività di un territorio. La valorizzazione dell’arte e della grande cultura, i momenti culturali che in questi anni si sono succeduti in misura crescente in città (e che mi auguro possano continuare) hanno ora bisogno di trovare un rapporto più stretto e fecondo con la tradizione tecnologica e del fare che è e continuerà ad essere (vorrei dire per fortuna continuerà ad essere) l’anima della città e del suo territorio. Brescia ha disperatamente bisogno di soggetti e luoghi capaci di far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti e di importarne da fuori, proponendo modelli di riferimento forti alle nuove generazioni, che altrimenti – come già hanno purtroppo incominciato a fare – emigreranno alla ricerca di ambienti più stimolanti e promettenti. E vengo così all’ultima frattura culturale che merita attenzione. Quella tra cultura del passato e cultura del futuro. E qui i protagonisti, o meglio i mancati protagonisti, sono appunto i giovani. Mi sembra che i grandi assenti delle iniziative culturali della città siano proprio loro. Lo avverto quando mi capita di partecipare a qualche iniziativa culturale che si tiene in città o ancor di più quando si tiene qualche dibattito o evento culturale in università che non sia direttamente strumentale “agli esami”. Il problema di come coinvolgere culturalmente i giovani di una città che invecchia sempre più, ma anche quelli della provincia (più numerosi ma con meno opportunità culturali) per non dire delle seconde generazioni di immigrati, è il terreno principale su cui nei prossimi anni si dovranno misurare le politiche per una davvero rinnovata identità culturale di Brescia e del suo territorio. . Che fare? Lasciatemi allora concludere con una breve notazione su chi debba operare nella direzione qui auspicata o – detto altrimenti – dove la ricomposizione tra le tre fratture indicate possa trovare dei momenti e dei soggetti attivi di sintesi. Premesso che il superamento dell’assetto “frattale” della società e della cultura bresciane richiede innanzitutto il confronto costruttivo tra tutte le sedi culturali, sociali ed economiche, vi sono alcune realtà che più di altre potrebbero assumersi il ruolo di tessitori di questa rete, di cucitori delle fratture segnalate. Una di queste è senz’altro l’università. In questa direzione l’università potrebbe contribuire con una maggior presenza di iniziative culturali aperte alla città, che sappiano (anche attraverso una collaborazione tra la vocazione umanistica propria della Cattolica e quella più tecnologico-professionale della Statale) collegare la cultura alta a quella materiale, la cultura storico-umanistica a quella tecnologica e sappiano soprattutto offrire ai giovani occasioni forti di crescita culturale e civile. In questo senso l’idea di residenze universitarie modernamente concepite e dotate di luoghi di socializzazione e animazione culturale (il Collegio di merito che Università degli studi e Fondazione Lucchini stanno realizzando ma anche il campus, a cui l’attuale amministrazione cittadina si è dichiarata interessata per la riqualificazione di alcune aree dismesse) potrebbe costituire una opportunità storica per la città e per il suo ripensamento. Un’altra è il Museo dell’Industria e del Lavoro (con in primis le due Fondazioni che l’hanno voluto: Civiltà bresciana e Micheletti): se la frattura tra cultura storico-umanistica e tecnologica è il punto da cui partire, il Musil è una straordina- ria intuizione che andrebbe sostenuta e valorizzata. Purtroppo dobbiamo constatare che la sua realizzazione sta incontrando crescenti difficoltà che, se non impediranno la realizzazione del contenitore principale ad esso destinato, rischiano di rimandarne l’apertura e soprattutto di condizionarne pesantemente le iniziative future. Un ruolo importante potrebbe poi essere svolto da alcune delle molte fondazioni che arricchiscono il patrimonio civile e culturale di questa città. Alcune di esse sono alla ricerca di nuove idee che possano vivificarne l’operato. Il sostegno da parte loro di iniziative culturali che vadano nella direzione qui auspicata potrebbe risultare determinante. Si pensi, solo per fare un esempio da cui trarre suggestioni e suggerimenti, al Festival delle città impresa del Nord-est, che ha recentemente concluso la sua terza edizione dedicata al tema assai evocativo di “La cultura ci fa ricchi” e che ha messo in gioco tutti gli ingredienti necessari per un dialogo innovativo e stimolante tra economia e cultura e, in particolare, tra cultura umanistica e artistica da un lato e cultura tecnologica ed economica dall’altro. Non posso concludere senza rivolgere, last but not least, un invito anche all’Ateneo, che oggi ci ospita, e che potrebbe svolgere un ruolo importante in questa rifondazione culturale proprio a partire dalla sua vocazione storica originale. Ma su questo mi rimetto alla discussione che seguirà questa mia introduzione e alla riflessione che questo incontro – se avrà una qualche eco – potrà suscitare. Indice Prefazione Economia, etica, società La città tra comunità e mercato Etica civile, politica, cittadinanza Etica e mercato in una società globale L’etica nelle relazioni d’impresa La responsabilità sociale dell’impresa: utopia o progetto perseguibile? Dare credito al bene comune Dal welfare state alla welfare society Brescia: la storia, l’economia, la città La storia economica di Brescia attraverso una famiglia esemplare Dove va il sistema Brescia? Brescia Brescia: l’identità perduta Città in rete Economia e cultura a Brescia. Il caso del MusIL Dal tondino a S. Giulia? Cultura ed economia nella Brescia del XXI secolo Finito di stampare nel febbraio da Officine Grafiche Staged, San Zeno Naviglio (Bs)
Scarica