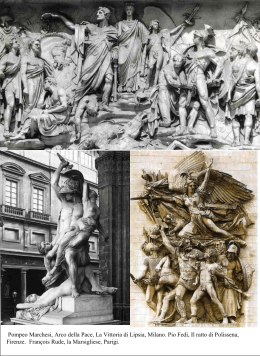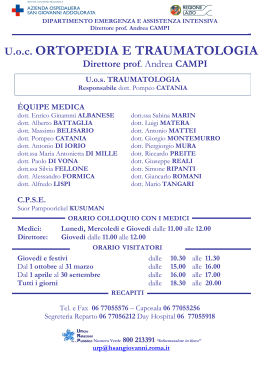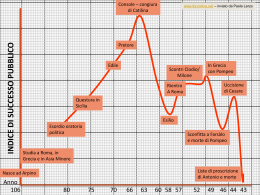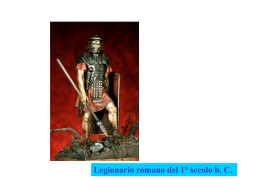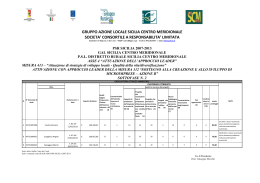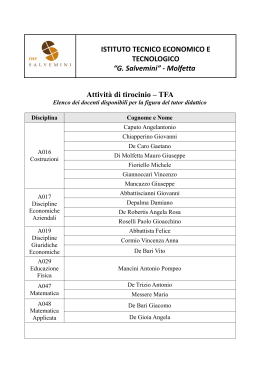lumie di sicilla numero 37 ottobre 1999 la parola al Presidente: Ricominciare... A fatica, dopo tanto silenzio, riprendo a scrivere per il “Lumie”; affrontiamo un nuovo corso di attività associativa, gravati da un altro anno di senescenza, logorati da mille difficoltà vissute in quasi totale solitudine, disillusi da eventi e comportamenti che ci hanno ferito spesso. Arriviamo però all’inizio del nuovo anno associativo, purtroppo, addolorati dai lutti che hanno colpito molti di noi. Di tali lutti, alcuni sono stati “fisiologici”; e pertanto, se hanno ferito i parenti e gli amici più vicini, sono stati peraltro accolti come normale evoluzione della grande vicenda della VITA. Altri lutti, altre morti, invece, ci hanno straziati tutti, per l’inaccettabile violenza con cui la grande falce ha colpito, alla cieca, con crudeltà estrema, VITE giovani, più giovani, e giovanissime, nel momento del loro riposarsi con il raggiungimento degli obbiettivi che ogni essere umano persegue, o quando la pedana del lavoro e della preparazione ti sta spingendo in alto, dove stanno i migliori. Ricordo qui Bernadette, moglie al consocio e fraterno amico notaio Nino Poma, morta, direi accidentalmente caduta dalla vita, per l’insipienza, la trascuratezza e, pensiamo, la scarsa professionalità, forse, di chi della sua vita di donna ammirevole, moglie e madre perfetta, coinvolta nella vita sociale come è di chi molto ha da dare, avrebbe dovuto avere cura. In ordine di tempo, poi, è venuta la morte di Alfredo De Rosa, figlio della consociata signora Franca; pochi di voi Lo conoscevano. Io Lo ebbi paziente sin dalla nascita; ricordo l’uomo, per la Sua riservatezza e affettuosità, ma soprattutto per la Sua tenace volontà di essere “bravo”. Nel momento in cui gli uomini e la vita lo chiamavano in alto (nominato, poco più che trentenne, alla vice direzione amministrativa di un grande istituto assicurativo), il mare di Cefalù, nell’ultimo meriggio di una breve vacanza, Lo uccise inspiegabilmente, a pochi metri dalla nostra amata terra di Sicilia. A conclusione di questa trilogia di infmito dolore, ricordo la morte accidentale di Alessio Passalacqua, figlio dei consoci Giuseppe e Francesca Camilleri. A questa madre, cui mi lega fraterno affetto nutrito dalle zolle della stessa terra che ci ha generato, laggiù nell’Agrigentino, non ho parole nè messaggi di solidarietà da trasmettere, se non dire: il dolore per la perdita di quel tuo unico figlio, meraviglioso per bontà, per la Sua generosità di capoguida degli scouts, per la Sua serietà di studente, per la Sua immensa fede di cristiano attivamente praticante, questo immenso dolore, tuo e di Giuseppe, sia un po’ rimpicciolito, concedimelo, di quel poco che noi vogliamo toglierti, per farlo nostro. Chiudo la relazione di questo lungo periodo di sconforto per ricordarmi a voi tutti, associati, simpatizzanti, lettori, con un lungo affettuoso abbraccio augurale per le imminenti ricorrenze natalizie e di fine anno. Dell’Associazione e della sua vita parleremo in altra occasione. All’ultima ora apprendiamo che il nostro associato, prof ANSELMO PRADO, cultore di cose d’arte e archeologia della Valle dei Templi, sulla quale ha pubblicato un bellissimo volume, èstato insignito del “Telamone”, premio che va ai migliori.Congratulazioni da noi tutti. Ennio Motta ritratti Lessico sozziano una suggestiva caleidoscopica carrellata di personaggi e di ricordi presentata ai nostri lettori dal Prof Antonio Pagano Lauretano Illi Magistro Vincentio Sozzi memoriam recolentes Eius Trasandatissimo, padre Vincenzo Sozzi si distingueva per la tonaca stinta e lisa, il cappello da prete più marrone che nero per il sole, l’acqua e la polvere e le larghe scarpe allacciate in modo strampalato, o mancanti, qualche volta, addirittura di stringhe, sicché i piedi erano costretti a guazzarvi dentro. Era rettore del Santuario Mariano di Loreto, la ridente borgata a poca distanza da Acireale, e docente di filosofia e storia nel Liceo di Stato “Gulli e Pennisi”, uno degli istituti più prestigiosi della provincia etnea. Rara avis per quei tempi un prete professore ordinario (per di più di filosofia e storia) nelle scuole governative. Michele Federico Sciacca, che fu alunno vivace e genialissimo di don Vincenzo negli anni venti, parla del Maestro con stima c rispetto in alcune pagine de “La clessidra”, stupende, il libro del “nostos”, del ritornò, ad un passato pieno di inquietudini, tumulti e fermenti. Il caro padre Sozzi soleva chiamare l’irrequieto ragazzo “‘u filosufu di Giarri”, apprezzandone la vivacità intellettuale e dialettica. Si trattava di un vero e proprio presagio! Chi scrive questa noterella fu allievo del Sozzi nella seconda parte degli anni quaranta: anni difficili, ma tanto ricchi di grandi speranze. Quell’Uomo inflessibile, duro, intransigente formò tantissime generazioni. Parlare dell’originalissimo prete-filosofo comporterebbe ripercorrerne non solo le vicende della lunga vita, ma anche illustrarne il pensiero e l’azione. Chissà se un giorno - qualcuno, mosso da intelletto d’amore, non si decida a farlo! Tra le tante cose, padre Sozzi ne merita due in modo particolare: un libro tutto “sozziano”, non oleografico (del resto, l’oleografia non piaceva al vecchio Maestro) e la traslazione dei suoi resti mortali dal cimitero di Acireale al Santuario di Loreto, dove riposa il primo Vescovo della Diocesi, monsignor Gerlando Maria Genuardi dei Baroni di Mulinazzo e Consolida. E davvero paradossale che la suggestiva chiesetta dedicata alla Madonna nera non accolga il “genius” di quel luogo, dove l’ombra del Filosofo sembra aggirarsi, nelle placide sere d’estate, tra i pioppi svettanti e i vialetti delle bellissime aiuole fonte di gerani color rosso fuoco. Paternese di nascita, ma acese di adozione, padre Sozzi aveva un gergo tutto particolare, del quale faceva uso in determinate circostanze, alternandolo con un italiano solenne, ortodosso in fatto di scelta di termini e di costrutti. Il “transfert” repentino dall’italiano al dialetto e dal dialetto all’italiano segnava i prodromi di un’arrabbiatura con relativa impennata, di un improvviso cambiamento di umore, di una più che ferma presa di posizione, di un “lisciabus” fatto di parole ora roventi come fuoco ora accompagnato da un sorrisetto ironico, sferzante. Con l’arma dell’ironia e del sarcasmo don Vincenzo si difendeva dai saccenti e dai presuntuosi, che si mettevano rigidamente in posa, ostentando quello che in effetti non erano. Di fronte a tipi del genere diventava giovenaliano: le sue frecciate lasciavano i lividi dovunque arrivassero. Di un politicante, che in un pubblico comizio s era lasciato andare ad una logorrea estenuante a base di parole sesqu4oedali, d’un piede e mezzo, destinate, più che altro, a fare effetto, a sbalordire, ma inutili, il Filosofo ebbe a dire sornionamente: “Mi pentu ca a chistu ‘na vota a scola ci desi ‘n pezzu di sei.Astura non avissi spunticatu tantu comu va facennu ora...” Quando incontrava un professionista abbastanza colto, non privo di humour, gli chiedeva: “Chi dici ‘a spirltera addumata?”, con evidente allusione al simbolo di un movimento di destra. Queste battute in dialetto, molto più efficaci di qualsiasi altro discorso, erano destinate a rimanere indelebili nel ricordo. Venne coniato, addirittura, il termine “sozzeggiare”, atteggiarsi alla Sozzi, cercare di imitarne lo stile, il modus agendi, il modo di fare. A “sozzeggiare” erano in tanti. Sozzi rimaneva, però, un esemplare unico. Più unico che raro. I riproduttori, più o meno maldestri, ci rimettevano le penne. A volere imitare Tindaro Tebano si cade giù con le ali spezzate. Questo insegna Orazio di Venosa. I ragionamenti campati in aria, tipici di chiunque non si fosse preoccupato gran ché di studiare con il dovuto impegno cercasse disperatamente di evadere aggiungendo parole a parole con il supporto di se, di ma, di cioè, di stavo per dire, dunque, e di perciò (oggi, si fa uso abuso di nella misura in cui, di a monte a valle, di al limite, di praticamente, portare avanti un certo discorso ecc) irritavano il Professore, che, dopo avere ascoltato per un po’ con un sorrisetto maliziosamente sardonico sulle labbra serrate ermeticamente, frenava di colpo valanga con .l’immancabile: “Sti cosi a 1ei ci sguazzariunu, chi mi sta cuntannu nummira o filosofia?”, lasciando interdetto l’incauto dispensatore di aria fritta. C’era, poi, il caso inverso: quello di chi, corto di argomenti, non era in grado mettere insieme un “gruzzoletto” di parole: “Sintissi, ci addumassi ‘’n turciuni San Tummasu”, esclamava Sozzi, devotissimo a San Tommaso d’Aquino, Doctor Angelicus, un gigante del pensiero. Riferendosi a Platone, dalle “larghe spalle”, Sozzi soleva dire che “è comu ‘u porcu”. Una asserzione del genere potrebbe correre il rischio di apparire quanto mai irriguardosa, se venisse estrapolata dal contesto: “non ci si jetta nenti’ intendendo, con ciò, dire -e giustamente che il pensiero del grande autore di dialoghi bisogna conoscerlo integralmente, senza trascurarne proprio nulla, se si vuole intenderlo a fondo. Non penso proprio di mancare di rispetto a quell’Uomo sui generis, vera mente geniale, se oso parlare di “baccagghiu” sozziano. Con questo catanesissimo termine si suole indicare un linguaggio, che, pur esprimendosi mediante geniali metafore e traslati, più o meno arditi, a trasi e nesci, dice e non dice, nondimeno viene recepito seduta stante dall’interlocutore addentro alle segrete cose. Intellegentì pauca... “Tavula niura”, un autentico francesismo da “tableau noir”, era la lavagna sicché la domanda: “Da quantu tempu non ni videmu a tavula niura?” era l’equivalente del rituale: “Da quanti tempo non siamo interrogati? “, espressi dal docente all’interrogato. Anche il confessore chiedeva all’inizio: “Da quanto tempo non si confessa?”. Oggi, l’interrogazione si chiama “verifica”. Chiamala come vuoi.... Mutato nomine fabula de te narratur, dice Orazio. Lo stesso concetto veniva, talora, presentato mediante un termine del gergo dei contadini, “trippaturi”, il posto del coniglio, per cui vinissi a trippaturi” significava “si accosti, per favore, alla cattedra per farsi interrogare”. Con un infallibile sesto senso egli intuiva immediatamente il grado di cottura del chiamato (dall’espressione del viso? dall’incedere lento e dinoccolato?), sicché cominciava a storcere il muso per esprimere perplessità. Novantanove volte su cento le cose stavano proprio come pensava don Vincenzo, che borbottava alcune frasi allusive all’imminente fiasco del poveretto o della poveretta destinati alla più meschina delle “malacumparsi”, di centorbiana memoria. “‘U trugghiu da malacumparsa”. Quando un ragazzo rispondeva disinvoltamente, prima di mandarlo a posto, Sozzi, soddisfattissimo, gli rivolgeva una domanda “di geniu” per avere un’ulteriore conferma delle capacità intellettive dell’ interpellato per il “redde rationem” Per chi non ne “masticasse” granché il rinvio a settembre, in seconda sessione, era più che inevitabile. Nel colorito linguaggio di don Vincenzo il preavviso della bocciatura, l’avviso di garanzia, era notificato con questa formula significativa: “Ni videmu a tempu di vinnigni”. Il termine “bocciatura”, odioso, terribile, veniva sostituito da una perifrasi che chiamava in causa il periodo della raccolta dell’uva, coincidente con quello della seconda sessione di esami, che ormai non esiste più. Mutantur tempora et nos mutamur cum illis... Per rintuzzare un ragionamento capzioso, bizantineggiante, capace soltanto di sollevare un gran polverone, padre Sozzi diceva che si trattava, senza alcun dubbio, di “un buttanisimu di raggiunamentu”, di cui suole fruire chiunque cocottescamente voglia tirare acqua al proprio mulino, facendo discorsi anodini, poco o niente lineari, equivoci. Nella parlata del Filosofo di Loreto ricorrevano abbastanza frequentemente la sineddoche o metonimia, il traslato, la icasticità delle immagini e l’ironia, che, qualche volta, nei momenti di amarezza, si faceva sarcasmo. L’automobile era “‘u ferru”, la carrozza “‘u lignu”, “scanneddu” la cattedra, “scola di Giannettinu” o “casinu di cumøagnia” la scuola presa con allegria, fin troppo alla leggera, senza il dovuto impegno, “‘u parrinu” l’insegnante di Religione (in cattedra lui, prete, era solo il docente di filosofia), “nuddu ‘mmiscatu ccu nenti” la nullità in senso assoluto, “non ti scippa” l’elemento mancante di versatilità e di predisposizione naturale, “sciabbacotu” il fannullone, che ama bighellonare, “non cunfanfura” il dubbio e la perplessità su certi presunti geni che “pigghiunu ‘u munnu a pugna”, troppo rumor per nulla. Di un professore, fin troppo buono, ebbe a dire: “Non sacciu cu’ di dui, iddu o ‘u carusu ca sta facennu esami di maturità, si spagna di chhiu’...” Una delle sue frasi più tipiche suonava proprio cosi: “Sti cosi lei mi li va dicennu caddozza caddozza”. Si trattava della condanna, in chiave popolareggiante, del frammentarismo di certe idee, che, per mancanza di un fulcro sostenitore, vengono fuori a spezzoni, come rocchi di salsiccia, senza un benché minimo tessuto connettivo, supporto essenziale di ogni discorso, che intenda procedere con un filo di logica. Nella trattazione degli argomenti padre Sozzi era limpido, cristallino. Michele Federico Sciacca ricorda che la filosofia don Vincenzo la porgeva “col cucchiaino”, con estrema chiarezza, non venendo così meno al dovere di ogni buon pensatore, che è quello di farsi capire da tutti. Diffidava dei discorsi ermetici, cavillosi. Indimenticabili, fra le tante, le lezioni sui rapporti del Conte di Cavour, il Tessitore”, con Re Vittorio Emanuele II, il Padre della Patria, su Vittorio Emanuele Orlando, il Presidente della Vittoria, al tavolo della pace alla fine del primo conflitto mondiale, che ci regalò solo le briciole di una vittoria mutilata, sulla Marcia su Roma delle camicie nere di Benito Mussolini. Certi aspetti dello staracismo non sfuggivano al suo giudizio penetrante, severo, dissacratore di tanti e tanti miti intoccabili. Famosa la battuta venuta fuori estemporaneamente durante una concione tenuta da un alto esponente del Partito Nazionale Fascista ai docenti della provincia di Catania, chiamati a rapporto nella federazione del capoluogo etneo di Palazzo dei Chierici. “È fissa e vulissi ca macari nuautri facissimu i fissa, non sapi ca si a iddu ‘a cammisa niura ci arriva finu o viddicu, a mia parrinu m’arriva longa finu e pedi non ci l’agguanta... Ammatula ca si duna versu... Prete della “bassa forza” del clero, ma intellettuale finissimo, non sempre tanto corrivo verso il fascismo, faceva capire, con una battuta del genere, che non intendeva sottomettersi alla gerarchia. Con chi non amava lo studio era implacabile, sfoderando una grinta assai minacciosa: infatti considerava l’impreparazione come un gravissimo atto di indisciplina bello e buono, una mancanza di riguardo verso la scuola, sicché rimandava a posto gli impreparati per infingardaggine bruscamente, o, addirittura, li espelleva dall’aula per l’intera durata della sua lezione. “Cacciassi ppi lu so’ postu, anzi ‘u sapi chi ci dicu? Addizzassi ppi fora...” Era un ordine categorico da eseguire immediatamente, senza discutere. “Cacciassi” era usato anche per invitare a dare inizio, tout court, alla trattazione di un argomento, o a riprendere il discorso dopo un suo necessario intervento per rispondere alle domande degli alunni interpellanti. Era per la sostanza più che per la forma. Allorché una persona antipatica e “fumogena” non riusciva affatto a convincerlo, don Vincenzo, storcendo il muso, e allargando e riunendo le dita della destra, ‘a manu ritta, con un movimento sincronico, quasi volesse incapsulare l’aria, se ne usciva con un sorrisetto sarcastico accompagnato da un commento abbastanza significativo: “Chi ci pigghi?”. Taglienti i suoi giudizi. Certe sue caricature tratteggiate con abilissima icasticità, tutta archilochea, sono rimaste impresse nella nostra mente. Di un trittico di ecclesiastici così sentenziava, categorico come Suprema Corte di Cassazione: “Il primo è buono, pio, zelante, ma ha una cultura da seminario; il secondo, gagliardo, pugnace, pieno di ardore, sembra che abbia intenzione di prendere il mondo a pugni, ma non conclude nulla, o quasi; il terzo, alto, prestante, mitrato, poveretto, è troppo basso di altare maggiore...”. Per altare maggiore intendeva la testa, sede del comprendonio. A proposito del gruppo bronzeo dello scultore acese don Michele La Spina in onore dei caduti, eseguito su commissione della municipalità, ebbe a dire con sicumera: “‘U mortu è troppu mortu, ‘u vivu è troppu vivu.. Per il monumento funebre a Monsignor Salvatore Bella, Vescovo di Foggia, poi di Acireale, storico e pubblicista di chiara fama, eretto nella Matrice di Nostra Signora della Catena, soleva rinfacciare, senza mezzi termini, ai catenoti, concittadini dell’illustre Presule, questa volta in italiano e con piglio solenne: “Ad un grande Vescovo voi di Aci Catena, Città nobile e civilissima, si badi, avete innalzato un brutto monumento, orirpilante, ‘horribile visu’, tremendamente in guardabile.”. “, non risparmiando loro la fortissima stoccata finale, agghiacciante: “La testa non è quella di un Vescovo, colto, mite, competentissimo, ma di un cane. Se lo ricordino loro, cittadini di Aci Catena...”. Taluni termini filosofici venivano resi con rara efficacia. ‘U tuttu, il tutto; ‘u cchi, il “quid”; ‘u nenti, il nulla; ddi cosi senza porti e senza finestri, le monadi di Leibniz; l’omeomerii di tutti i mmischigghi, le omeomerie di Anassagora di Abdera. Celeberrima la definizione di concetto di metafisica. Ad una candidata agli esami di maturità che non riusciva ad afferrare il concetto di metafisica, rivolse questa domanda: “Lit signurina, ‘u vidi chiddu ca cc’è ‘nta ddu muru?”. L’interlocutrice, confusa, rispose che scorgeva tante cose, compreso il quadro del Duce Fondatore dell’impero accanto a quello del Re Vittorio Emanuele. “E arreri a lu stissu identicu muru lei ‘u vidi chiddu ca cc’è??”. Naturalmente, la studentessa disse che non era in grado di scorgere alcunché, nulla, proprio nulla... “Bene, propriu chistu è ‘a metafisica”, concluse il Filosofo di Loreto, non senza aver dato prima un serio avvertimento: “Si arricurdassi lei, signurina, ca vuautri fimmini non siti cosa per la quali in quantu a filosofia, aviti i capiddi longhi e u giudiziu curtu; ha sintutu forsi diri ca ‘nta storia da filosofia ci ha statu ‘nfilosufu fimmina?”. In tempi di acceso femminismo, chissà come sarebbe stato contestato il povero don Vincenza, antifemminista più per posa che per effettiva convinzione... Padre Sozzi, un Uomo che ho amato. Un prete semplice, trasandato, intelligente, mordace, ma anche profondamente umano... Non riesco a dimenticare la sua battuta nei confronti di mio nonno Sebastiano Pulvirenti, un misto di humour e di grande affetto per l’amico: “Si ricordi che suo nonno è stato n’omu catolicu, non si lu scurdassi mai...”. E appunto per questo ho inserito questa espressione in questo florilegio lessicale sozziano ognora vivo e palpitante nel mio cuore. Manet alta mente repostum, vergilianamente. Eius meminisse juvat. Di Lui è bello ricordarsi. Un personaggio autentico che fa parte della mia vita... In scrinio pectoris. Nello scrigno del petto. Come un piccolo tesoro da non perdere. A Monsignor Ignazio Cannavò, Arcivescovo Emerito di Messina e dell Eolie, ho detto, l’altra sera, in occasione dell’incontro nel Seminario Vescovile per ricordare il primo anniversario della scomparsa di don Giuseppe Cristaldi, che non c’è occasione in cui non mi sovvenga di don Vincenzo, Maestro di vita e di dottrina. Antonio Pagano storia di sicilia Giubileo calatino – Aere perennius È il titolo dell’ultimo libro (uscirà fra qualche mese) di Calcedonio DONATO, nato a Vittoria, insegnante liceale di storia e filosofia, appassionato studioso e autore di ricerche storiche e di articoli d’interesse storico-filosofico. Un’approfondita ricerca su fatti di notevole valenza conoscitiva, non registrati o ignorati dalla storiografia ufficiale, relativi all’importante ruolo storico svolto dal popolo e dal clero siciliani agli inizi di questo secolo al fine di evitare, per il Sud, la subalternità economica, politica e religiosa verso cui lo sospingevano la scienza e la politica del tempo. In Sicilia, popolo e clero, stretti dalla morsa della miseria e dal malgoverno, al grido di” La terra ai contadini” e “Fuori dalle sacrestie”, alla fine del secolo scorso, misero in atto un programma di rinnovamento sociale e politico i cui risultati soltanto ora cominciano a delinearsi nella loro unitaria portata e che sono ravvisabili, per un verso nella definizione di una compiuta democrazia, e per l’altro nella difesa dei valori della cristianità. La ricerca è riferita soprattutto alla cittadina di Caltagirone, per l’irripetibile ruolo svolto in virtù di scelte operate, nel primo quarto di questo secolo, durante la sindacatura Sturzo e durante l’attività pastorale (1899-1925) di mons. Damaso Pio De Bono, per merito del quale don Sturzo esercitò l’attività di prosindaco. Di mons. De Bono, dei suoi rapporti con don Sturzo e della sua prestigiosa attività episcopale, conclusasi nel 1925 con dimissioni, non sì sapeva assolutamente nulla. E’ merito dell’autore averla segnalata sin dal 1994 nel libro “La primavera di Caltagirone”, con presentazione di padre Ennio Pintacuda. Il presente lavoro analizza quel periodo di storia siciliana, e in particolare di Caltagirone, quando popolo e clero, guidati rispettivamente dal Prosindaco e dal Vescovo, inaugurarono una politica e una pastorale, delineandone anche le rispettive sfere di competenza, volte a sconfiggere, nel caso specifico, corruzione e malaffare coniugando semplicemente i valori della Giustizia con quelli della Carità. Quel felice esperimento, reso possibile per la perfetta intesa fra Vescovo e Prosindaco, pur entro un sistema di difficili rapporti fra Stato e Chiesa, sorse e si irrobustì durante l’era giolittiana. Ciò rendeva ancor più pericoloso quell’operato politico religioso in conseguenza dell’ammorbidimento del non expedit, che di fatto tendeva a sostenere quella liberaItrasformistica politica. In conseguenza dello scioglimento dell’ Opera dei Congressi e del ripiegamento moderato che la S. Sede andava attuando in Sicilia, con dimissioni di vescovi locali e con conseguenti insediamenti di vescovi preferibilmente lombardi, sarebbe stato temerario il solo pensare di poter esercitare l’attività di prosindaco, come anche più temerario sarebbe stato pensare ad un incondizionato appoggio, in tal senso, da parte della cittadinanza e del proprio vescovo. Il capolavoro di mons. De Bono consistette appunto nel sollecitare la 5. Sede ad acconsentire alla prosindacatura di don Luigi Sturzo in conseguenza di una effettiva legale possibilità. Non solo, ma ad un deciso primo rifiuto, il Vescovo non si perse d’animo, insistette sino ad ottenere uno stentato “sì”. Da allora a Caltagirone, per quindici anni la necessità della giustizia si coniugò con la libertà della carità, per il bene della città dell’uomo. Fu un’esperienza importante, irripetibile e forse l’unica “utopia” a materializzarsi nel presente dai tempi di Empedocle, nella popolosa Agrigento, o di Platone, nella grande Siracusa, o di Federico, nella raffinata Palermo, e dalla quale trassero vantaggio lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Quando infatti questa si rese conto dell’ isolamento storico nel quale si ritrovava in seguito alla conclusione della Grande Guerra, per lo smantellamento dei tradizionali Imperi, sostegni terreni di metafisiche attese, ricorse a don Luigi Sturzo. il quale estese quelle esperienze alla Nazione, lacerata e priva di guida per una crisi economica e politica, che lasciava presagire lo spettro della sconfitta entro la vittoria. L’avvento del fascismo spazzò via tutto. Nel 1924, don Sturzo andava in esilio; nel 1925, mons. De Bono, mentre preparava grandiosi festeggiamenti per la celebrazione del Giubileo della Chiesa mariano per Caltagirone, rassegnava le dimissioni da vescovo. Queste, subito accolte, indussero la S. Sede ad attuare anche a Caltagirone quella “rimoralizzazione” già avviata in altre diocesi della Sicilia agli inizi del secolo durante la polemica modernista con l’invio e l’insediamento di episcopi lombardi. Erano anni particolarmente difficili e delicati per la politica e per la fede: il fascismo governava e si tessevano i preliminari per i Patti Lateranensi, che reclamavano l’esilio di don Sturzo e le dimissioni di mons. De Bono. Una pagina di storia, che non doveva fare storia, viene in parte riproposta grazie alla passione per la ricerca del nostro autore, volta a rievocare i fatti per una migliore e più completa conoscenza di questo difficile secolo che va a morire. homo ridens Il buco nell’ozono (E’ ITALIANO) Giallo catanese in tre puntate, di Giuseppe C. Pappalardo Prima puntata Una sera, quando il signor Pompeo si vide comparire davanti la moglie Alfonsa in body nero e tacchi a spillo, in tutte le sue gt Ì...tine tremolanti, capì che c’era da preoccuparsi. Per questo non la mandò subito ad affogarsi. Da un po’ di tempo la donna accusava disturbi strani. Invece di dire “parlare” o “fare”, diceva “portare avanti un discorso”; citava “i per7orsi di genere al femminile” e “il recupero della sessualità al femminile”; farciva le frasi di “voglio dire” e di “diciamo”. Era diventata, improvvisamente, “un attimino” bionda; e invece di usare come al solito, le lamette di Pompeo, comprava a giorni alterni e a costi stratosferici un minuscolo tubetto del depilatorio inglese “The Kojack’s wife”. Ma il fenomeno più inquietante era l’emissione di comunicazioni telegrafiche, simili a uno spot televisivo, con cui a tratti interrompeva il suo eloquio quotidiano: - Restàrè o tornare giovani? Si può. Anzi si deve! — esclamava. Mattina e sera si spalmava con una quantità di strani, nauseabondi intrugli misteriosi. L’edonismo, con tutti i suoi imperativi categorici bussava con prepotenza alla porta di quella casa. Pompeo cadde in ambascia. Divenne distratto: un giorno scambiò per l’Alka Seltzer le pastiglie effervescenti per la pulizia della dentiera della vecchia. Eh sì, egli aveva ricevuto in dote una suocera. Che abitava sulla sedia a dondolo con servizi annessi. Telecomando appeso al collo e cuffia ha fai per timpani d’epoca, la vegliarda stava davanti al video 24 ore al giorno. Sembrava un comandante di Boeing che, in collegamento con la torre di con.. )llo dell’aldilà, seguiva sul monitor la rotta per l’atterraggio definitivo. Per fortuna taceva; incrementava il fatturato Enel, ma taceva. Nello scenario geriatrico della casa c’era anche la serva Cammilina. La sua origine risaliva ai nonni di Pompeo, i quali l’avevano lasciata in eredità alla madre di Pompeo. Quest’ultima a sua volta, mantenendone l’usufrutto in vita, aveva passato la nuda proprietà di Cammilina al figlio per risparmiare sulle tasse di successione. Dentiere, busti, calze elastiche, lassativi e cinti erniari facevano dunque del loro meglio in quella casa: allo stesso tempo, TV e giornali ne bombardavano, con i loro sorridenti e freschi prodotti in scatola, gli indifesi abitanti. Irresistibili, potentissime, le armate televisive riportavano, falsificandoli, i giornalieri bollettini di guerra della quotidiana, estrema battaglia: quella contro il tempo. La sera, per non guardare la puntata di “Più sani più belli”, Pompeo immergeva gli occhi nella minestra e, di nascosto, la diluiva con qualche lacrima. Alfonsa, assidua lettrice di rotocalchi di moda e di attualità, ne studiava minuziosamente gli articoli e gli inserti scientifici. Un giorno, sventolando sul muso di Pompeo l’inserto della settimana, un manuale di cosmesi, « Le mille e una po(si)zioni », lo apostrofò dicendo: Pompeuccio caro... ma ti rendi un attimino conto che da molti anni a questa parte i soli rapporti fisici fra noi sono i pediluvi caldi di saltrati che facciamo in coppia nelle sere d’inverno? A questo punto bisogna sapere che il fascino meraviglioso di quest’uomo consisteva nella sua coscienza: la sua coscienza di cretino. Era un cretino cosciente. Oggi quasi tutti i cretini della vita quotidiana, che s’incontrano ovunque, sul teleschermo, nelle università, nelle cene di lavoro, al caffè e via discorrendo, i cretini usuali insomma, si credono di essere persone assolutamente intelligenti e non hanno la coscienza esatta della propria idiozia. Pompeo, invece, l’aveva. Ebbene, fu proprio in quel momento che a Pompeo mancò la sua coscienza di cretino. Si credette intelligente. E decise. Con occhialoni scurissimi, e finti baffoni neri appiccicati sotto il naso, egli si presentò al banco della farmacia di piazza Duomo. Dall’insegna, che a chiare lettere diceva: «Farmacia dott. Vieni» (testuale, venire a Catania per credere, ndr), quella farmacia gli sembrava la più specializzata nella vendita del farmaco che cercava. Con fare circospetto cavò di tasca un foglietto dove c’era scarabocchiato un nome e lo allungò alla laureata che svolgeva il semestre di tirocinio. La giovane afferrò il foglio e cominciò a leggere con difficoltà lo scarabocchio de medico: - Via..., viaaa... - e si fermò, per mandare uno sguardo al monumento al liotru. Pompeo fremeva e sudava freddo per paura che entrassero altri clienti. Po la ragazza riprese a sillabare: - . . . aa...grrr..., ah, Viagrande! Non è da questi parti. Chieda un attimino al vigile davanti al municipio qui accanto. Pompeo, indignato per essere stato scambiato per un turista, le strappò i foglio di mano e uscì con l’intenzione di affogarsi nella vasca zampillante ai piedi dell’elefante. Ma in città le cose eran cambiate. C’erano i pub, e perciò la città diventava internazionale. Europea, a di poco. Per rilanciare le grandi opere pubbliche dal “Palazzo degli elefanti” era partito l’ordine di restaurare il monumento. Per questo la fontana con gli zampilli che circondava il liotru non c’era più: era stata tolta per riportare il monumento all’antico-nuovo splendore. Pompeo rimase lì, a sbavare, appallottolando in tasca il foglietto con lo scarabocchio, e ammirando estatico dal basso in alto il pancione con accessori del possente liotru. Altro che Viagrande, pensò Pompei Lui, d’estate, villeggiava a Trois Marrons (vulgo: Trecastagni, ridente paesino del Etna. Ma chissà perché tutti i paesini sono ridenti. Anche Viagrande, tutto sommato è ridente). Prima di allontanarsi mestamente, comprò all’edicola un giornale specializzato. Lesse alcuni annunci più o meno economici. Fu sorpreso leggendone un “Giovane ottima famiglia, distinto elegante, piacente, dirigente, incontrerebbe giovane donna (eventualmente coppia) di ottima qualità, ma soprattutto autoritaria. Abiti di cuoio. Gradita foto”. Non faceva per lui. Quella sera Pompeo, durante la cena invece di seguire come al solito la puntata di « La malattia in diretta », densa di sintomi e di particolari nauseabondi, cambiò canale. E si immerse nella contemplazione del programma che era un attimino secsi, intitolato “Colpo grossissimo”.Egli seguì attento tutte le puntate di quel varietà: con gli occhi strabuzzati, mentre dalla sua dentiera sfuggiva un suono agghiacciante, simile a quello di una carrucola metallica arrugginita che sale e scende. Cammilina tremava di spavento. Alfonsa dava segni di nervosismo. Pompeo, che di solito a casa circolava con addosso i pantaloni del pigiama, in un telefilm vide uno che portava, del pigiama, soltanto la giacca. Pensò all’eventualità che inesattezze simili accadessero a lui, uscendo di casa. E decise finalmente che era il momento di chiedere aiuto alla scienza ufficiale. Passarono mesi. E un giorno, Pompeo esaurito vociferò ad Alfonsa: - Medici? Sessuologi? Mi hanno imbottito di stimolanti e di rilassanti, e di pozioni spaventose; mi hanno ecografato, radiografato, fotografato in ogni parte e in tutte le pose; mi hanno prelevato e analizzato tutto ciò che secerno. Mi hanno messo cataplasmi, protesi, e perette fabbricate a Hong Kong; mi hanno fatto spalmare con pomate pestilenziali. Risultati, zero. Ma Alfonsa, prevedendo gesti di disperazione del marito, era attrezzata per l’emergenza: gli sventolò sul muso un rotocalco patinato, e — Pompeuccio, - gli disse prendendogli la mano e sorridendo, ovvero storcendo la bocca quel tanto che le consentiva il chirurgo plastico svizzero che le aveva riparato labbra, mento, sotto-mento e sottopancia qualche anno prima,- -non avere dubbi, anche noi saremo presto biutiful. Guarda, leggi! IL SEGUITO ALLA PROSSIMA PUNTATA PIENA DI AVVENIMENTI MISTERIOSI! QUALI SCONVOLGENTI CI ATTENDONO IN QUELLA CASA? AVVINCENTI COLPI DI SCENA VI ATTENDONO. NON PERDETE IL PROSSIMO NUMERO CON LA SECONDA PUNTATA DI QUESTO AVVINCENTE SECSI-THRILLER MOZZAFIATO E MOZZATUTTO.. Seconda puntata Pompeo afferrò il rotocalco e lesse. L’articolo raccontava di un eminente scienziato che aveva scoperto l’elisir di giovinezza. C’erano sempre gare di solidarietà con raccolta di miliardi attraverso la no-stop televisiva “Teletiè”. Occorrevano fondi per la lotta contro i malanni del secolo: la bassa statura, la calvizie, l’adipe, la morte subitanea e quella al rallentatore, la vecchiezza, i calli, la sterilità, la fecondità, e il cortocircuito della natura morta. Nel paese fiorivano geni compresi come quel grande scienziato che una volta al mese comunicava su quotidiani e rubriche televisive la scoperta contro la malattia più contagiosa di tutte: la vecchiaia. L’articolo sul settimanale diceva: “Con questo medico si può”. E raccontava pure che quel generoso luminare, chiamato “professore” già quand’era nella culla, emetteva il suo sapere anche in molti talchi-sciò e varietà televisivi. - Pompeuccio, — squittì Alfonsa a bocca stretta per non scucirsela - è difficile avere un consulto, ma ci riuscirò. Poi andrai anche tu a farti prescrivere la terapia, e così saremo sempre più biutiful, caro -. E gli indicò la foto del luminare che poteva: il professor Kenarc Ison, un arzillo vecchietto di quarant’anni che diceva di averne, biologicamente, trenta. Alfonsa, dopo aver pagato il consulto in anticipo, fu ricevuta. Le presentarono un televisore. Tutto per lei. E la cornetta di un telefono. Abituato com’era allo studio — allo studio televisivo, beninteso - quel taumaturgo visitava i suoi clienti soltanto in diretta. Lo schermo si accese e, preceduto dalle note di un pianoforte e da 6baiadere-6 in camice bianco che dimenavano l’osso sacro, il taumaturgo apparve sullo schermo. Superbo! Proprio lui, l’inventore del sesso a batteria, del colpo della siringa nella penna stilografica, della pompetta spruzzaprofumo, del resuscitatore della natura morta! Scientifico! Incommensurabile! L’ambiente era lo stesso della trasmissione “Teledò”, durante la quale egli dava risposte definitive ai seguenti insondabili misteri: la piramide di Cheope, la metafisica del non-essere, l’autocombustione delle cosine durante la presa dell’abbronzatura, il segreto della pila al Kronprinz, la depilazione del monte calvo, e il farmaco per vincere la traversata del Sahara in bicicletta. Telecamere mobili lo inquadravano da tutte le parti. Un infermiere vestito da conduttore televisivo (o viceversa, un presentatore travestito da infermiere) gli passò la comunicazione con la paziente Alfonsa di anni ... anta e passa, sdraiata al di là del video. Parlò. — Comprendo, signora — disse marcando un sopracciglio e guardando la telecamera con occhio ispirato come un veggente — il suo problema. Sì, dall’età di 2 anni, per sfuggire ad oltre 270 cameriere e balie bionde innamorate di me fino alla follia, ho dovuto frequentare da allora tutte le università del mondo, dove sono stato amato in tutti gli idiomi, beninteso, e dove ho messo a punto le mie sensazionali scoperte che mi hanno portato al premio Snobel... Tre lunghi e simmetrici oh uscirono dalla trachea di Alfonsa: - Oh oh oh. -Dalla sintomatologia che lei riferisce —proseguì il telescienziato — mi accorgo che lei soffre di endocrinobioetaosi del cervello medio, con sindrome del superpiano flocculotrasmettitore e conseguente shock che le manda onde alla centrale termica. Meraviglioso! Emolliente! Il pubblico in sala applaudì. Alfonsa fiatava forte. E lui proseguì: Tutti sanno della mia età biologica trent’anni. Ebbene, la possiedo da quando ero un bambino di sei anni. Invece adesso eseguirò su di lei l’esperimento di e biologica reverse. Ah se sapesse! Dulbecco, Modigliani, Montalcini, Fo li ho inventati io. Con la pila... - Ma... - scandì Alfonsa, e precisò: glu gglu glu. - Le spiego. Con la mia terapia le farò raggiungere immediatamente un’età biologica di centovent’anni, che potrò mantenerle inalterata per altri cinquant’anni. Nel frattempo si presentò una segreta con la scollatura fin sotto ai ginocchi che annunciò: - C’è altro consulto in linea. - Ho visto tutte le sue trasmissioni all’ora di cena, “La colite ci chiama”! strepitò estatica Alfonsa. Ma lui imperterrito tagliò corto: Troverà all’uscita i farmabra- cadabranti che le prescrivo per ripristino dell’accensione a iniezione variante e conseguente fluidificazione dell’indotto presfinteroippoassirofrenico dell’endocauterio di primo-talamo del cervello medio. Li pagherà alla cassa. E le mostrò la mano destra, messa a taglio, un po’ pendente verso il basso. Poi la scosse colpendola da sopra, con palmo piatto della sinistra, all’altezza dell’articolazione del polso. Ad ogni colpetto, la destra si levava e si metteva tesa, a bandiera, funzionando anche da freccia indicatrice di direzione. Scientifico ed anatomico segnale, bulbo-regolato dal cervello medio, per dire che ilconsulto era chiuso. La linea fu passata alla nuova paziente. La quale iniziò a parlare alitando sulla cornetta: - Prontooo..., sono Cittina, da dove chia... ah aah aah? Frattanto Alfonsa aveva già perduto l’audio, il video, e il rimasuglio del bulbo del cervello medio. L’elettroencefalo-gramma della sua zona di primotalamo era divenuto extra-piatto. Rientrò a casa in ambulanza e barella Cammilina, in segno di inossidabile fedeltà, cominciò a strapparsi quei capelli che di solito riservava per condire il brodo dei padroni. Pompeo fece finta di niente; fece finta di leggere il giornale e di guardare la tivvù; fece finta di aver capito. Il rimasuglio del suo cervello medio era un attimino fermo. Pensava che Alfonsa si sarebbe presto ripresa e che anche quella sera, all’ora di andare a nanna, essa - al solito avrebbe indossato l’abbigliamento consigliato dalla rubrica della rivista femminile preferita: un paio di stivaloni neri a mezza coscia, un braccialetto da gladiatore, e nient’altro; e che lui — al solito avrebbe detto le sue preghiere e si sarebbe addormentato. Al solito. Preso da questi pensieri non notò lo strano ticchettio; non si avvide dell’aumentare della frequenza di oscillazione della sedia a dondolo con vegliarda, indicante che a bordo la comandante Campana era innervosita dall’agitazione dei passeggeri del suo jumbo. Ebbene, fasten seat belts. Allacciatevi le cinture. Anche le scarpe, le fibbie, tutto. Le mutande chi le ha. L’indomani mattina, dopo una notte piena di sogni su pozioni miracolose ed unguenti rivitalizzanti, Alfonsa e Pompeo trovarono la sedia a dondolo vuota. Ancora oscillante. Sì, vuota! La vecchia non c’era più. Volatilizzata. La confezione di pannoloni fu trovata intatta al suo posto. Il cornetto acustico giaceva abbandonato a terra, in un angolo, come pure la cuffia ahi fai e il telecomando. Malgrado le ricerche della polizia scientifica, l’Interpol, le trasmissioni di “Chi l’ha visto?”, i paragnosti e i chiromanti, un consulto del mago Silvan, della vecchia con le cerniere arrugginite non si ebbe più notizia. Scomparsa. Dissolta nel nulla. Terza e ultima puntata Passarono alcuni anni da quando la vecchia si era volatilizzata. La sua sedia a dondolo con servizi fu messa all’asta nella gara di solidarietà televisiva < Teledò >, e il suo cornetto acustico fu destinato alla raccolta di offerte per la missione umanitaria “Fregabaleno” abbinata alla trasmissione < Teletiè >. I nostri due eroi avevano abbandonato ogni speranza di ritrovarla, ma non demordevano sul fronte del restauro del secsappill. Quando imperversava la calu-ra estiva, rigagnoli grigiastri, nerastri, bluastri, rossastri, giallastri si spargevano sul loro volto decorandolo come quello di un Maori. Il sudore scendeva da fronte, tempie, occhi, naso, labbra, attaccando e sciogliendo tinture, maskara, rimmel e unguenti vari; e creando, con deodoranti e dopobarba, una sinfonia di odori estivi. Sedute di fittness, di bodibbudding e, a casa, di aerobbica, non si contavano. Alfonsa si era fatta i polpacci di Maradona e i bicipiti di Tyson, mentre nelle parti restanti mostrava il proprio scheletro all’atterrito Pompeo. Questi portava ogni mattina la sua pancia montata su due gambette corte a fare futingh; e la sera tornava stanco dal quotidiano massaggio che prometteva: “Nudo sarai bello!”. Pompeo aspirava il brodo dalla punta del cucchiaio per non fare scolorire i baffetti tinti. Alfonsa, invece, il brodo lo beveva con la cannuccia, a causa delle labbra che, per le cuciture del chirurgo svizzero, si aprivano soltanto a fischietto. E così ogni sera, a tavola, essi comunicavano in un loro codice segreto, fatto di grugniti, gorgoglii, suono di masticazione di sedano crudo. Ormai colloquiavano col televisore soltanto. Un giorno telefonarono in diretta a Giucas Casella per fargli ipnotizzare il gatto di casa. Ma una sera, mentre essi erano intenti a trasmettersi i loro messaggi cifrati, si udì il trillo del campanello di casa. – Chi è mai a quest’ora? – si domandarono. La fedele Cammilina andò ad aprire. Poi si udì un guaìto, come quello di un cane al quale pestino la coda. E per annunciare la visita, nella sala da pranzo, anziché l’intera Cammilina, rientrarono per primi i suoi occhi, tanto erano strabuzzati. Poi la serva arrivò, completa. Disse: Hauiiiooohhhuuuiii!!-. Gesticolò freneti-camente emettendo fischi, suoni rauchi, qualche singulto seguito da sibili, mentre a gambe aperte e piegate, ella si batteva le mani sulle cosce. Sembrava un giocattolo di latta caricato a molla. Poi eseguì due danze tirolesi, si sventolò con le vesti, squittì, sbavò, e finalmente, dopo avere salmodiato una serie di – Uh ih ah ah ! - stramazzò a terra, stecchita. A questo punto si consiglia ai signori lettori, ansiosi di conoscere la sorprendente piega che hanno preso gli eventi, una pausa dall’estetista. Oppure alle ‘ascine, per fare futingh. Si udì la voce dell’ospite inatteso dire: - Conosco, hum hum, la strada, hum hum . Ed entrò. Con tutto il corpo di profilo. E la criniera rossa. E la traccia di vestito, il perfido, che, casualmente aperto su un fianco, dall’ascella all’inguine, copriva la rimanente mercanzia del melodioso corpo di girl. Ella aveva labbra che sembravano il bordo di un canotto rosso fuoco. Per questo quando parlava sembrava ciucciasse una enorme caramella, e faceva uhm uhm. Alfonsa e Pompeo rimasero con cannuccia e cucchiaio a mezz’aria, a bocca aperta, e con gli occhi spiritati. La fatale dimenò il duodeno, scosse la criniera, mostrò la faccia di tre quarti verso la platea dei due esterrefatti telespettatori, adoperò il sorriso numero ventuno bis ammortizzato, e si sedette. In maniera, bisogna precisare, tecnicamente perfetta. Accavallò le gambe! Pompeo si riprese dalla paralisi. E divenne un diluvio di cachinni; un vero delirio. Respirava come se soffocasse. Sgocciolava. Alfonsa assunse l’aria del barbagianni. Fece pressappoco così: Hau u u u, - poi sventolò col tovagliolo Cammilina. La quale aprì un occhio, poi l’altro, scattò in piedi e applaudì. Sì, per chi non lo avesse capito era “lei”, seduta sullo sgabello e con le gambe accavallate. La quale, avendo accavallato le gambe, poteva attaccare a parlare. E lo fece. - Sì, miei cari, sono io, Alba, hum hum, l’autentica, esclusiva Alba italica, “la Parietti”, uhm uhm, chiocciò, accatti-vante, mentre con il silicone a forma di labbra imbronciate cominciava a degustare l’inesistente caramella. Espettorante, declamatoria. E proseguì: - Ma su, andiamo, non mi avete ancora riconosciuta? Pompeo la scrutò e cominciò a emettere il suo caratteristico gemito agghiacciante di carrucola arrugginita. Sbavava. - Sì, sono Alba ma ero… ero… indovinate… - disse lei capovolgendo la criniera e scoprendo un lembo di pelle sulla nuca che, premuto un pulsante segreto, si aprì come il coperchio di una scatoletta a molla. Apparve una pelle raggrinzita e una voglia di cozze. La sola che l’avesse era… - La nonnaaa a a a ! – echeggiò Alfonsa, diventata bluastra. Pompeo si dimenava come un ballerino di tango. E poi voleva sapere. Era chiaro che il segreto della nonnetta costituiva la sua ragione di vita. Scoprirlo era il solo scopo della sua esistenza. – Ero la nonna, sei anni fa, proseguì la fulgida, - ma adesso sono io, l’autentica, esclusiva Alba italica. Una trasforma-zione? Macché. Ho ritrovato il mio self, il mio essere donna, il mio “genere”; ho compiuto un percorso “di genere” al femminile. - Tu? La rossa che fa smaniare gli italiani? Ma se sembri un viado! Ah, la vecchiaccia! – vociferò invidiosa Alfonsa che non aveva ancora recuperato un minimo controllo del self. - Eh sì, - replicò la fatale, facendo un assolo di labbrone imbronciate: Hum hum. - Ma ci dica, - disse Pompeo, trascurando l’occhiataccia torva della moglie, - ci dica, quale nuova opera prepara? - Non posso parlare, per ora. - Segreto? - No, mi cadono le labbra, - disse. Fece una pausa per iniettarsi una siringa di silicone nel fiammeggiante bordo di gommone sotto il naso, e aggiunse: - Hum, hum, è la necessaria manutenzione giornaliera. Ma sono ancora in garanzia. Essa aveva compreso l’ansia di conoscenza di Pompeo. Gli lanciò lo sguardo numero 43 bis rinforzato, con inclusa sistemazione di un pendulo boccolo rosso della chioma. E continuò a dire: - Sono stata nella famosa clinica di Noom Màda Kaskar, dove opera il professor Guardhomar Q’uantebel, il quale, scuci di qui, taglia di là, ricuci di lì, tira per qua, mi ha restituito il mio fascination. Poi prese un’altra siringa, la conficcò, si siliconò la scollatura, e riprese a dire: - Dopo altri lavori di restauro a Noom Màdak Askar, tornata in Italia, appena compiuti trentuno anni, che ho da novantadue anni, ho iniziato la carriera in TV. Lo studio fatto sulla sedia a rotelle mi è servito a capire tutti i segreti del mestiere. Pompeo, ormai preda della più scatenata frenesia, ansimò: - Cosa fanno a Nooomm… come si chiama quel paese? - Noom Màdak Askar, appresso Hong Kong e lo stretto dei Sargassi… - essa rispose. E sfoderò per lui, con l’intento di liquefarlo, il sorriso con sguardo in-corporato numero due turbo-modificato: il grande slam per cretino che ha perso la coscienza di cretino. - Nella clinica – essa continuò a dire – sfornano almeno tre Alba come me e fino a due coppie di sorelle Carlucci ogni anno, per l’esportazione nei paesi sottosviluppati. Fabbricano anche tanti Mino Damato che vendono nell’isola di Pasqua, dove li usano come totem al posto dei veri totem di pietra, tutelati dall’ente turistico nazionale. Gli indigeni li sottopongono alla prova del fuoco nelle notti di luna piena trasformati in Mino Damianto; oppure, spacciandoli come totem autentici, li riservano ai turisti imbecilli e cesellatori, i quali possono liberamente inciderli sulle chiappe, a pun-ta di temperino, col loro nome, cognome, indirizzo, data di nascita e data della visita, o con cuoricino trafitto da freccia. Fabbricano pochi Biscardi biondi, ormai poco richiesti anche dal Ghana, ma molto adoperati nella stessa clinica per il controllo di qualità dei prodotti. Infatti servono per collaudare la tenuta delle suture del lifting di viso e labbra: basta mostrare e far parlare un Biscardi, e nemmeno una mummia egizia può esimersi dallo sganasciarsi dalle risate. Per questo ogni esemplare di segnorina uscito dalle magiche mani del professor dottor commendator Guardhomar Q’uantebel è sottoposto alla “prova Biscardi”: se tiene e non si rompono le cuciture è buono e si consegna. Che tecnica, che organizzazione… hum hum. Pompeo voleva sapere qualcosa sul luminare che con ago e crine di cavallo aveva trapunto una parrucca naturale sulla teca del noto ancor-man e sciò-man televisivo Peep Bawoodd. Ma per mostrarsi spettatore televisivo disinteres-sato, balbettò: - E Raff raff… - Uffa, la Carrà? - essa rispose con aria di sufficienza - Da quando fuggì dalla casa di riposo, trent’anni fa, e si è rifatta l’ombelico, è fuori produzione. I fondi di magazzino rimasti servono a qualche paese socialista. Mancano perfino i pezzi di ricambio,. Alfonsa tremava in tutte le sue gelatine. Indignata. – Mamà! La diroccata delle meningi, la vecchiaccia, ah!, con la cuffia. Eccola qua, eccola là sul video, tutta rossa fuoco, che parla, parla, che dà le sue opinioni, opinionista dei miei stivaliii! – sbraitò. Essa aggiunse altre vituperie prima di essere interrotta dalla fatale che sussiegosa disse: - Ma Alfonsa, che ti prende? E’ questo il ringraziamento per la mia visita? Oggi riposo la mia intelligenza, come da libretto di manutenzione. Come avete ben appreso io sono molto, molto intelligente. Hum hum. Spargo opinioni. Opinionizzo su tutto. Pompeo intanto faceva tremare la sedia con la sua prostata. Disse: - Sì, sì, intelligente, intelligente sei! Sai tutto, parli di tutto, opinionizzi su tutto. Sei esperta su tutto. Il tuo è pensiero allo stato puro, inguinale; distilli dal tuo collant verità universali; sei una scuola d’Atene, una corrente di pensiero, un abbeccedario dello scibile. Come fai? La sua calza sinistra ebbe un singulto. Rispose: - Semplice. Nel trattamento del professor Guardhomar Q’uantebel è com-preso un cervello a svitamento centrifugo, con inserimento di grammofono miniaturizzato. Tutta questione di micro-chips. Infatti sono programmata. Vuoi che dica la mia opinione sull’aborto? Attivo il commutatore x2zy del circuito nascosto nella palpebra sinistra, e appena accavallo le gambe – sinistrdestr – il disco comincia a trasmettere fesserie sull’aborto. Vuoi che io divenga esperta di calcio? Subito: basta che io inverta l’accavallamento – destrsinistr – e tiri fuori la lingua di quanto ha millimetricamente stabilito il bisturi a Noom Màda Kaskar, uhm uhm, e io parlo di calcio… Pompeo già batteva freneticamente i piedi. Era passato al tango. E al “tu”: con occhi sognanti, muovendo appena le labbra sussurrò alla fatale: - Dimmi cose di sinistraaa… Alfonsa, inviperita, prima di piombare in deliquio nelle braccia della fedele Cammilina, parlò: Bella, sì, opionionista, eeeee secsi, e, voglio dire, io lo eeeee sono ancora, diciamo, anzi eeeee di più voglio dire adesso. Tu ricorderai quanto, eeeee, da ragazzina, bella voglio dire io fossi (Alfonsa sfoggiò la sua preparazione televisiva, e mostrò come anche lei fosse capace di parlare allo stessa maniera delle attuali ministre della repubblica nelle interviste e nei talchisciò tv). Diciamo che scompariresti. Eeee vi farò vedere le mie fotografie di allora! - Menti! - chiocciò la vegliarda madre che a colpi di tinture, massaggi, tagli, cuciture e materiale plastico era stata trasformata in segnorina nella clinica del celebre Guardhomar. Finse di essere crucciata sotto la maschera astringente. - Sì, menti. Perché, quando tu eri bella, onorevole Alfonsa, la fotografia non era stata ancora inventata, – ribadì Pompeo alla maniera di Bruno Vespa. E, ormai sbavante, guardò con un sorriso ruffiano da primo ebete della classe la pupa suocera per riceverne una sventolata di ciglia di approvazione. La pupa dalla solita, inesistente caramella in bocca gli sussurrò a labbra chiuse come se masticasse purea: - Dimmi cose di destraaa… Poi mostrò la dentiera e proclamò: Un uomo così intelligente, fra tanti intelligenti che circolano, non l’avevo mai incontrato. Ed io, come ho detto nella mia recente intervista opinionistica, conosco soltanto la passione, non l’amore. Infine gli lanciò un’occhiata a 220 volts che per poco non le scaricò le batterie installate a Noom Màdak Askar. Alfonsa gemeva. Aveva perduto ogni controllo del self. Cammilina la cullava fra le sue braccia. Nel frattempo la rossa, essendo di casa, andò in cucina e riapparve a cavallo della scopa. Afferrò Pompeo, lo mise a cavalluccio dietro e s’alzò; volò via per la finestra aperta. Traversò l’aria, le nuvole. Il comandante Campana era decollato col suo jumbo. Responsabile dei servizi a bordo: Pompeo. Pompeo e la rossa divennero piccini piccini e poi scomparvero. Andarono lontano lontano. Per biodegradarsi nell’in-finito, oltre le antenne e i ripetitori tv, al di là delle frequenze e dei canali. Spray planetario. Che bucò l’ozono. Epilogo. Alfonsa ritrovò presto il suo self. Dopo aver partecipato ai viaggi oriental-esotici della Fesstours a prezzi stracciati, con borsetta a tracolla in finta pelle con logo “Fesstours” in omaggio, e dissenteria artisti di sicilia DIECI ANNI? OLTRE. Dieci anni. Un’infinità. Oppure un lampo, un battito di ciglia. Sufficienti per ricordare, per dimenticare, significativamente. Così è stato per Renzo Collura: dimenticato, ricordato artista. Nella partita a scacchi col tempo, ora, nel decimo anniversario della morte, l’occasione di una nuova “scossa”. Mentre Grotte, suo paese natale, con il concorso di altre istituzioni, estimatori e studiosi, è pronto con orgoglio a rilanciare il gioco e a riappropriarsi del suo illustre figlio, tentando di dare scacco matto agli avversari di sempre, all’oblio e al disinteresse, incominciano a riaffiorare i ricordi. L’ho conosciuto tardi, a Palermo, ma per un tempo sufficiente perché nascessero amicizia e intesa. Le radici ci accomunavano, originari entrambi di due paesi vicini, opposti e intersecantisi. Nell’infanzia aveva frequentato le terre avite ricadenti in territorio racalmutese presso un mulino ad acqua che non esiste più. Rimase a suo modo legato al paese detto per antonomasia “del sale e della Madonna del Monte”. Con gioia perciò, alla vigilia inconsapevole del suo epilogo terreno, subito dopo la presaga mostra palermitana “Processione delle ombre”, espresse con il candore di un bambino il desiderio di esporre i suoi quadri a Racalmuto. Nell’auditorium “Santa Chiara” venne a scandire con passo della sala per commisurare alla cadenzato profondità e larghezza superficie delle pareti un numero consono di tele. Per l’occasione, dipinse festosamente, in particolare “Memorie di zolfo” e “Il vecchio mulino”, dove sembrano cadere le cateratte plumbee della pittura precedente e che rappresentano nella vividezza giallo-sulfurea di giovanili colori, nella serena distensione di bianchi ricordi, l’inizio di una fase pittorica che malauguratamente non avrà seguito.. Quell’evento, fortemente voluto, organizzato con meticolosità e sfarzo, sfiorò, toccò la storia di un paese indaffarato nella nostra quotidianità di sempre e non ricadde nella condizione ipotizzata da Paul Valery: “...saremo approvvigionati di immagini e di sequenze di suoni, che si manifestano a un piccolo gesto, quasi un segno, e poi subito ci lasciano”. Nella temperie di mostre e di pittori che hanno fatto tappa a Racalmuto, patria tra l’altro di Pietro D’Asaro, il secentesco dipintore serioso di scene sacre e di scene profane dall’alterna fortuna critica misurata sulla lunghezza dei secoli, il ricordo della mostra colluriana, dei suoi quadri, delle “sue” immagini, non ci ha lasciato Ancora resistono echi di quel concerto visivo. Nella sua pittura, abbiamo riconosciuto luoghi noti, cari emblemi; rispecchiati, ci siamo ritrovati, ci siamo guardati, come non sempre avviene, con altri occhi, con sguardo rinnovato. È stata un’esperienza indimenticata. E quanto più, penso, lo sarà a Grotte, dove Renzo Collura approda conclusivamente da artista compiuto, per ricongiungersi alle sue origini e inalvearsi, per la seconda volta, in un destino, questa volta eminentemente pubblico. Il destino, si vuole intendere, che avranno il ricordo di un uomo nella coscienza dei posteri e la considerazione del suo valore di artista. Racalmuto, 30 settembre 1999 Piero Carbone Dopo un periodo di non infecondo silenzio, il Comune di Grotte si appresta a celebrare il decimo anniversario della morte di Renzo Collura, pittore e studioso. Il prossimo 19 dicembre verrà inaugurata una mostra retrospettiva, il cui catalogo-album conterrà contributi critici e testimonianze di Giorgio Segato, Cosimo Scordato, Aldo Gerbìno, Piero Carbone. È prevista anche l’istituzione di una Fondazione da intitolarsi all’artista grottese. una pervicace speranza Pirandello aveva scritto "La favola del figlio cambiato"; Melo Freni, scrittore cattolico di lunga militanza, propone "La favola del paese cambiato" (SEI, Torino 1995, pp.155). E se nel dramma pirandelliano un figlio buono e bello viene cambiato, con inganno e sortilegio, da malefiche, fantomatiche "Donne", in uno malformato e brutto, nel romanzo breve o lunga parabola di Freni il protagonista, Giovanni, viene a predire e a sancire il cambiamento inverso: il paese del dolore, della sopraffazione, della violenza, si riscatta in un altro aperto all'amore, alla pacificazione, alla speranza. Ma quando? e dove? Le parabole non hanno tempo. O forse no. E' la scheggiata e bruciante realtà dei nostri giorni, la violenta cronaca dei morti ammazzati, dei Falcone e dei Livatino ad essere assunta, manipolata, trasfigurata, resa romanzesca e duttile ad un messaggio: il paese (cioè la Sicilia, ma non solo) è, finalmente, cambiato, speriamo che cambi davvero, sicuramente sarà cambiato. "Il paese si è scrollata la paura e dice quello che ha visto, che sa, che ha sopportato in silenzio, in questi lunghi anni" (p.140). "Adesso basta. Ora è il tempo dei frutti" (p.149). Come dire: è sempre tempo per la rivolta morale. In ogni caso c'è sempre spazio per la testimonianza solitaria, anche a costo di divenire eroi o santi. E pertanto: nè mafia nè sfruttamento nè altro. Una bella utopia! Infatti è solo una favola. Quello che emerge è un pervicace ottimismo cristiano quando con la stessa forza dell'utopia si rivendica il diritto a cambiare, a riscattare un vittoriniano mondo offeso, a riscrivere nuove regole di convivenza civile. "Ma proprio questa volta falliremo", dice Basilio alla fine. Gli risponde Giovanni, artefice e interprete della nuova anima di un paese ormai cambiato, almeno nel suo sentire: "Può anche darsi, Basilio. Ma io ti dico: le vedi quelle montagne lassù? Sembrano scoscese, inaccessibili, ma se ci arrivi sotto, neppure ti accorgi di averle incominciate a salire, vi trovi sbocchi, sentieri. La distanza non confonde solo la vista, ma anche le idee. Bisogna avvicinarsi alle cose, affrontarle per quelle che sono, non per quello che sembrano. Gli inganni, il più delle volte, sono dentro noi stessi" (p. 148). Ma sia chiaro, è su un orizzonte teologico da "già e non ancora" che si schiude la realtà di questo libro. Tobia, il vegliardo che rimane, "il più vecchio dei vecchi", così congeda il pellegrino Giovanni: "I paesi cambiano, lentamente, è vero, ma ancora hai tanto cammino da fare" (p.151). Eppure è lo stesso Tobia a scorgere sopra la montagna un'alba che attende, "un filo di bava rosa nel cielo" (p. 152). Una conclusione che interpella il lettore. Irromperà la luce o non basteranno gli occhi per vederla? E', si diceva, una parabola, una favola bella. A fronte di tanta letteratura siciliana che si compiace di stanche pose ideologiche o di rumorose sonorità verbali, quella di Melo Freni è un'ansia quieta, il tentativo personale di indicare narrativamente un altro sentiero, il suo, per dare nuova rappresentazione della Sicilia, oltre i malinconismi bufaliniani, gli sciascismi ad ogni costo o le archeologie linguistiche poco consolanti di Consolo, oltre la perpetuazione, passata e futura, di una Sicilia "gialla" o macchiettistica" E' un segnale. La via è additata. Quest'opera di Freni potrebbe essere l'inizio di un cammino. E non solo per lui. Piero Carbone dialetto e poesia Il sogno della “koinè” Il Professor Salvatore Di Marco, fecondo saggista, studioso, scrittore e poeta palermitano, ci ha inviato un suo vivace pregevole saggio, “La questione della ‘koinè’ e la poesia dialettale siciliana”, tema al quale ha dedicato numerosi appassionati, spesso polemici, interventi sul Giornale di poesia siciliana, da lui fondato e diretto. Lo scritto qui di seguito riportato, tratto dal saggio, ne costituisce una chiara ed incisiva sintesi, ponendo all’attenzione del lettore i termini della vexata quaestio. C’è una questione che -sia pure situata ai margini rispetto ai temi che in questi editoriali sono stati trattati e poi dibattuti dai lettori, perché forse in gran parte fuori dagli interessi più pressanti- mi pare invece giunto il momento di riguardare un attimo, soprattutto per una esigenza di dare piena chiarezza alla posizione di questo giornale. Ed è la questione della koinè. Infatti, il problema del dialetto così come lo abbiamo posto comprende anche una precisa idea sul tema di una possibile koinè siciliana, della quale di tanto in tanto si discute. Ed è appunto su questa idea che oggi ci pare utile dare alcune informazioni esplicite e trarre qualche considerazione, con l’avvertenza naturalmente- che da queste colonne non si pronunciano verità, non si proclamano dogmi, si tiene invece conto di ogni possibile opinione diversa e si sollecitano sempre la discussione e il confronto. Partiremo da alcuni dati di fatto, perché a questi vogliamo massicciamente attenerci piuttosto che alle idee che dei fatti succede di tenersi in testa. Il primo è che stiamo vivendo in Sicilia una stagione estremamente ricca e felice della poesia in dialetto. Nel senso che c’è una presenza numerosa di poeti i quali, invece di abbandonare l’uso letterario del dialetto -come del resto, ci si aspetterebbe in tempi nei quali i nostri maggiori studiosi dei fenomeni sociali della lingua scommettono sulla graduale scomparsa dei dialetti dal panorama dei linguaggi italiani- lo preferiscono piuttosto come strumento efficacissimo di creazione artistica. Un fatto del genere può essere spiegato in tanti modi, e c’è chi se ne è già occupato: ma in questo momento non ci interessa affatto di studiare il fenomeno. Naturalmente, è all’interno ditale grande quantità di poeti dialettali che si registrano le opere di quegli autori nuovi, impegnati fortemente sul terreno del rinnovamento della nostra poesia sici- liana, dai quali è lecito trarre il convincimento che la grande tradizione letteraria della poesia siciliana in dialetto continui anche ai nostri giorni. Ma nemmeno questo fatto ci preme qui di commentare. Il dato che invece constatiamo è che la stragrande maggioranza dei poeti siciliani scrive le proprie opere nel proprio dialetto. C’è chi lo fa con quella piena coerenza dal punto di vista lessicale, ortografico e grammaticale che i nostri dialettologi tanto apprezzano, c è invece chi lo fa con più o meno rimarcata approssimazione, usando arbitrarie ortografie, oppure introducendo consapevoli trasgressioni alle norme. Ma ciò che predomina è la tendenza pressoché generale a non usare un dialetto siciliano standard, non una lingua siciliana comune in tutta quanta l’isola, ma il dialetto della propria città, del proprid paese quando non addirittura un lessico di settore. Potremmo qui citare a decine i casi di poeti del ragusano, dell’area catanese, delI’agrigentino, del messinese e così via. D’altronde, si tratta di un fenomeno che è abbondantemente presente in tutte le regioni italiane. E sia sufficiente citare il caso del dialetto di Pasolini, di Albino Pierro, di Mario dell’ Arco, di Scataglini, di Franco Loi, per ricordare alcuni dei più grandi poeti dialettali di oggi in Italia. Può non piacere questo fatto a qualcuno, ma oggi in Sicilia la realtà è questa. Succede però che -e torniamo alla Sicilia- ci siano dei poeti, qualche studioso delle nostre parti, i quali si mostrano preoccupati, ostili, polemici nei riguardi di questo fenomeno. Essi propongono invece che i poeti dialettali siciliani debbano abbandonare i dialetti locali che hanno scelto come lingua di poesia per adoperare una lingua comune per tutti i siciliani, una sorta di koinè alimentata dai dialetti di tutte le province siciliane e fusi insieme in un nuovo e coerente sistema linguistico. La koinè -sentita in questo caso come lingua che accomuna, che unisce, che elimina le differenze lessicali, morfosintattiche, soprattutto ortografiche, facilitando così la comprensibilità del dialetto in tutta l’Isola- comporterebbe da parte dei poeti l’osservanza di ben precisi principi linguistici. E si è perfino proposto un modello ortografico. Ma quale sarebbe il modello linguistico suggerito? I passaggi della proposta sono questi. Storicamente parlando, e prescindendo dal modello letterario che si può fare risalire al Duecento, una prima indicazione -però dagli esiti infelici- viene rintracciata nelle Observantii di la lingua siciliana di Claudio Maria Arezzo (Messina 1543) e successivamente nei cinque volumi dell’antologia poetica Muse SiciLiane di Giuseppe Galeano, dove si dice che sarebbe consacrato il modello di koinè tradizionale E si afferma che oggi un modello di koinè siciliana potrebbe essere individuato nel dialetto palermitano; non il palermitano così com’è oggi, ma quello che risulterebbe dall’arricchimento e dagli apporti di tutti i dialetti siciliani. Ci sono in Sicilia dei poeti che questa idea condividono e ad essa si attengono -più o meno coerentemente- per scrivere loro versi. E un loro diritto, e se poi fanno anche della buona poesia tanto meglio Un po’ meno convincente è l’atteggiamento di chi diffonde l’idea che fuori dalla koinè ci sarebbero confusione rozzezza e caos. Anche se siamo convinti che la koinè di cui si parla è solo -rispetto al presenteuna immaginazione, un sogno, una chimera che esiste nell’idea d chi se la progetta in mente, perché, come si può constatare, sono in tanti i poeti siciliani che preferiscono scrivere nel dialetto vero e concreto che hanno imparato a parlare venendo al mondo; anche se siamo convinti che una koinè non si crea nel laboratorio letterario di poche anime elette; anche se ragioni di carattere scientifico ci fanno perplessi al cospetto di quella idea, ci pare assolutamente inopportuno tuttavia sostenere, alimentare una polemica sulle idee che abbiamo circa la impraticabilità della koinè e delle sue incongruenze proprio da un punto di vista linguistico e dialettologico. Ci sono molte cose che il compianto Giorgio Piccino scrisse nei suoi Elementi di ortografia siciliana (Crisafulli Editore, Catania 1947) e che ci sembrano ancora di grande attualità per l’argomento che stiamo trattando. Sarà però il caso di ritornarci con più comodo, con più spazio disponibile. Qui ricordiamo soltanto che per l’illustre dialettologo siciliano “il dialetto non ha né può avere un carattere di uniformità... Il dialetto non è qualcosa di astratto che si distilli da scrittori che passino per classici ma è una cosa ben concreta, in quanto si individualizza nella parlata di ciascun individuo, di ogni città e paese. Alla relativa uniformità della lingua letteraria esso contrappone una molteplicità senza limiti; e per quanto ci sia uno speciale linguaggio a fondo palermitano e a tendenza arcaicizzante che passa per siciliano comune o letterario, esso non ha che una vita artifìciale e direi quasi fittizia, né può imporre una sua forma, tacciando come scorrette quella delle altre parlate locali. Nella letteratura dialettale hanno uguale diritto di cittadinanza la lingua letteraria del Meli il catanese di Tempio e Martoglio, il chiaramontano di Guastella, come l’agrigentino del Di Giovanni E il Piccitto non è certo l’ultimo arrivato nella dialettologia siciliana.Ma il discorso è ormai aperto. Continueremo a parlarne. Salvatore Di Marco dialetto e poesia  tarbunira (All’imbrunire) è il titolo dell’ultima raccolta di poesie di Benedetto Di Pietro, il “fondatore” del sistema ortografico del dialetto gallo-italico  tarbunira All’imbrunire Na vauta s’arcaunta e si disg, ô tamp d’u re d’i bàia ghj’era a Maunt Sar na màndra di vàcchi bleanchi.Gusci accurnunziva u zzu Arfian u caunt di la mändra tramurära ng’ar. Una volta si racconta e si dice, al tempo del re dei boia c’era a Monte Soro una mandria di vacche bianche.Così cominciava lo zio Alfio il racconto della mandria tramutata in oro. - Nièucc carusgì assitei, â tarbunira, ô scalan di la parta sprämu chi n giuorn m’avàia acapter di vrar na bièstia cun tänt di mulogn ô cadd, scampanijer ntô buscott di Gudura. Noi bambini seduti, all’imbrunire, sul gradino della porta speravamo che un giorno ci doveva capitare di vedere una bestia con tanto di campanaccio al collo, scampanellare nel boschetto di Collura. -Lavai a pighjer pi li carni e tinarla fierma, masenanqua sprisc. Ma se ghj la fai, acumanzu a passerv davänt, una, daui, ciant väcchi, li ciarvedi, i chiei, li scioschi d’u dät, i quadirì d’u rräm, tutta la rrantidarìa e a mèan a mèan si chiéngiu ng’ar fìan. Dovete pigliarla per le corna e tenerla ferma, sennò sparisce. Ma se ce la fate, cominceranno a passarvi davanti, una, due, cento vacche, le caprette, i cani le fiasche del latte, le caldaie di rame, tutta la mandria e mano a mano si tramuteranno in oro fino.- - Mi suntimu giea rricch, ma ogni sara si rrumpiva u ncantiesim quànn mestr Antunìan turnàva di la campegna a caveu di n scecch cilàrb cu n fesc d’aiàna. Anämu a rruberghjla pi ferm li sampogni e tutt li vauti eru santiuòi e giastomi, chi m’avàiu a cascher ghj’uogg pircà ermu fighjuoi di gràan baiesci. Ci sentivamo già ricchi ma ogni sera si spezzava l’incantesimo quando mastr’Antonio tornava dalla campagna in sella ad un asino guercio con un fascio d’erba. Andavamo a rubargliela per farci le zampogne e tutte le vo/te erano bestemmie e imprecazionj, che dovevano cascarci gli occhi perché eravamo figli di gran bagasce. U rritràtt Il ritratto La fraunt ièuta, u neas a cracch, u barbaratt spartì a n duoi, i mustäzz a carni di tar partiraur. La mièuzza di vilut n testa avarära saura di n’arògia da parar n balarìan di grèan talant. U cuder c’u ptureu di camìsgia cun nant darrier, suota d’u giacot nar, e n’espressian da patran di tucc i stäbu di la cunträra. Cuscì avoss a èssir u rriträt di mi catanänu: n cristijen pavr di saccota, ma rricch di rrispiet. Benedetto Di Pietro La fronte alta, il naso adunco, il mento diviso in due i mustacchi a corna di toro partitore. La “mièuza “ di velluto in testa girata sull’orecchio da sembrare un ballerino di gran talento. Il colletto col pettorale di camicia con nulla dietro, sotto il gilet nero, e un ‘espressione da padrone di tutti i terreni della contrada. Così dovrebbe essere il ritratto di mio bisnonno: un uomo Povero di tasca, ma ricco di rispetto. intermezzo di lu nicu sinu a lu chiù granni. ‘Sti paiseddi ca ti stanu attomu ca guardanu lu mari e la muntagna, ccu tantu ‘ngegnu fòru fatti ‘n jornu ‘ntra li ricchizzi di ‘sta costa magna. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dio, Patria, Famiglia = i valori “bollati”, ovverosia “non c’è più religione!” Il vino del Conte va consumato a temperatura abbiente Il caro-taxi = fermate il conto, voglio scendere! Hai mai vinto al lotto? = io? Nemmeno per... sogno! Còmpito in casa = l’assegno integrativo In molti cimiteri = si scopron le tombe, si levano i morti Fecondazione artificiale = la corsa all’ovo Proposta da un’associazione animalista la mattanza di Favignana con finti tonni di plastica = non avranno scambiato la mattanza con l’opera dei pupi?! Contraddizione in termini = fare bella (!) mostra di sè 11 “tocco” di una volta all’osteria = la secondazione in litro Da un quotidiano nazionale: “Nella fotina (sta per “foto piccola” n.d.r) l’on. pinco pallino” = a quando “motina” per motoretta?! Si racconta che ad un parlamentare siciliano, noto per la sua scarsa dimestichezza con grammatica e sintassi, nel corso di un comizio sia scappato detto: “.. .quando abbiamo stato a Roma...”. Al suo portaborse che, con una furtiva gomitata, gli suggerisce “siamo stati”, dubbioso borbotta: Jddu tu ccu mia eri? La zootecnia in Italia = è in una fase di stalla La scuola di oggi (e di ieri) = l’ufficio promozioni La grammatica a scuola = si studia per (il) modo di dire Il concorso per primario ospedaliero = la corsia di sorpasso La riforma della pubblica amministrazione = stato freschi! Per entrare alle Poste = occorre la laurea in... lettere! A piedi, con le scarpe strette = si cammina obtorto callo L’orologiaio = un commerciante al... minuto La merceria = la stanza dei... bottoni Scommesse all’ippodromo = il dado è trotto! La giuria al Giro d’Italia = ci vediamo doping! Quando il caffè riesce “lento” = il barista si è espresso male Il dietologo = soddisfatto se riesce a fare una magra figura! Lo spuntino del dopoteatro = il cacio della buonanotte Ferrovie sotto accusa = processo per direttissima Il semaforo segna verde = l’autorizzazione a procedere Per strada Un uomo nero, non più giovane, un vu’ cumpra’, mi viene incontro offrendomi la sua povera mercanzia. - No, non insistere, non mi serve niente... -Nessuno compra... -lamenta guardandomi negli occhi- dammi qualcosa, per mangiare...! Tirando fuori della tasca un fascio di biglietti da mille, gli ho dato “qualcosa”. E mi sono vergognato. Io Paesi di Sicilia Iu si’ lu granni di tutti li Jaci (Aciriali) Si’ comu ‘na lumera a novi micci e di lu centru lo to luci spanni, a tutti lu cugnomu to ci dasti, C’è Lucia, Catina, Fulippu e ‘nNtoni ccu Platani ca è lu nicareddu, Bonaccursi ‘n testa a lu balcuni e a la marina Trizza e Casteddu. Mittennu ‘nsemi Isula e Ciclopi -ca spicchiulìunu ‘ntra l’acqui purifanu di curnici a ‘ssu gran quatru ca pingiri ‘un lu sa nuddu pitturi. Peppino Marano ---------------------- “A Graniti”” di Aristide Casucci Nta Sicilia c’è na vaddhi chi tutt’u munnu fa ‘ncantari, ci curri un ciumi friddulinu cu so scrusciu sauta e canta di la sira a lu matinu e scava i petri da tant’anni. Filagnati di biddizzi su’ i paisi ch’iddu vagna acqui duci di muntagna genti bboni e gimrusi. Ciuri di maiu e cirasi ’i l’acquavini fannu iazzu fessiri e cucugghiati; nta jnestra spalassara su mmucciati merri, strunedda e beccaccini. Nta sta vaddhi c’è ‘npaisi chi fu fattu di Sicani, vecchiu, natu di na funti com’u ciumi: GRANITI, patre di burdunari e stagnatari. cu si ferma un minuteddu nta calura ‘i menzujonnu supra u bordu du Pitrolu senti a buci di Stinchinu e li zzocculi du so mulu: -tuc toc, tuc toc, tuc toc.Me cumpari, unne annate? -Vaiu a Finaita e dopu a Muscianò, ma, stasira stissa ‘cchianu pila festa ‘i San Bastianu, comu voli Diu e Maria. Jurnata rutta pirdila tutta. ...E antrasattu nu scrusciu ‘i luntanu fa vulari na picca ‘i spunsunedda; su i carusi cu la troccula nta la manu, vannu puttanu, praneta nto ventu, la so felicità, vanedda vanedda, sutta u suli caudu di l’austu sicilianu. Curiosità prestai un libru, bench’io me ne pento, ad unu: et quandu e’ lu appi assay tenutu, et illu mi dissi mi lu avia rendutu, undi cunvenni a mi essiri cuntenti. Però nixunu mi cherki in presenza azochì non m’avegna, comu soli k’io perda un libru et anco l’amistanza... (sonetto cantato dai musici del ‘400: come si può notare, nulla di nuovo sotto il sole) radici “Al centro della loro gloria” (I Normanni in Sicilia) Al centro della loro gloria i Normanni furono in Sicilia. Scorriamo le pagine del bellissimo libro di Allen Brown, “NORMANNI”, -Edizioni Piemme- e vi troviamo l’origine vichinga e la storia oltremodo interessante dei guerrieri del Nord. Allen Brown è stato professore di Storia al King’s College dell’Università di Londra ed ha scritto vari saggi su questo popolo dell’Europa settentrionale. Desidero subito precisare che trovo in lui una vibrante partecipazione alle vicende complesse e pur semplici di una straordinaria classe di uomini-guerrieri che hanno enormemente influito sulla storia dell’intera Europa, a partire dal X secolo. Parafrasando le parole di Allen Brown possiamo dire che i Normanni furono fortunati a espandersi nell’XI secolo, periodo di esuberante sviluppo in ogni campo: essi, audaci per natura, pronti all’avventura, ardentemente desiderosi di possedere terre e con estrema voglia di viaggiare, colsero ogni opportunità nel coraggioso nuovo mondo dell’Europa feudale e portarono la loro “Normanitas” dal nord al sud del continente europeo, spingendosi nel Mediterraneo sino alla Terra Santa al tempo delle prime Crociate. Possiamo anche dire che la conquista dell’Europa meridionale e della Sicilia fu l’impresa più romantica della storia del vecchio continente, la più densa di affascinanti leggende e di vicende di incredibile coraggio. La cristianità normanna si ispirò sempre più a quella latina e questo forte spirito religioso è in fondo l’essenza più vera della sopraddetta “Normanitas”. I Normanni incarnarono con facilità il sentimento del loro tempo radicato in una religione sentita e proclamata, ed oltre ad una fede davvero ammirevole ebbero abilità tecnica e, in generosa dose, magnificenza e orgoglio combattivo. Essi fecero della Normandia la loro terra promessa, fondandovi il principato feudale più importante della Francia, invasero con la benedizione papale l’Inghilterra e, come alleati del Papato, costruirono i loro principati in Italia e in Sicilia sino ad ergersi campioni della nuova concezione della guerra santa, in virtù della quale giunsero ad assalire le città di Antiochia e di Gerusalemme. Così dominarono i loro tempi. Allen Brown, riferendosi alla conquista dell’Italia meridionale e della Sicilia, scri- ve che essa fu .... . completamente conseguenza di un ‘impresa privata, quando singoli cavalieri e le loro relative compagnie uscirono dalla Normandia per cercare fortuna al sud”. Per mettere in rilievo il valore dei campioni Normanni, lo storico inglese precisa: “Le fonti ditale periodo diedero molto risalto ai cavalieri a cavallo e giustamente, poiché fu grazie ai cavalieri che la vittoria fu possibile. - - e che l’immigrazione normanna in Italia... soprattutto un afflusso di cavalieri e una ‘esportazione’ di cavalleria. “. Per sottolineare il forte senso della fede normanna, Allen Brown scrive ancora: i Normanni divennero presto i difensori della Chiesa latina, come alleati del Papato e alleati e patroni dei grandi monasteri longobardi e latini esistenti...”. E poi, sulla detta conquista, precisa che essa “... fu accompagnata in modo singolare da una grande serie di costruzioni e ricostruzioni, paragonabili ai programmi appunto, di costruzioni eseguite in Inghilterra dopo il 1066 e, appunto, nella stessa Normandia durante l’XI secolo.” E poi: si suppone che il numero dei castelli fondati durante la lunga conquista sia stato in ‘competizione’ col prodigioso numero costruito in Inghilterra e nel Galles nei decenni successivi al 1066. Comunque le chiese e le costruzioni di palazzi secolari in modo particolare a Palermo e intorno alla città hanno attratto le entusiastiche attenzioni degli storici dell’ architettura e dell’arte in questo paese come altrove... In merito al successo di questi guerrieri del nord, Allen Brown evidenzia, con l’acume di cui è dotato, la sua vera radice, scrivendo che: “... i Normanni erano il popolo più eclettico e poche furono le caratteristiche più importanti della ‘Normanitas ‘se non l’eclettismo.”. Questi intrepidi guerrieri, peraltro, erano capaci di grandi slanci architettonici. Scrive ancora Allen Brown: “Lo splendore interno della Cappella Palatina nel palazzo di Palermo è stato recentemente definito ‘un capolavoro di felice eclettismo’ trattandosi infatti di una forte mescolanza di antico cristiano, dilatino, di bizantino e di arabo. Tali costruziont in Sicilia in modo particolare, rievocano la splendida frase di Jean Decarreaux,che ha evidenziato la loro capacità di dare espressione a ‘uno spirito di sintesi spinto alla genialità ‘... e impressioni di Vittorio Morello riflettono direttamente non solo l’eclettismo normanno, ma anche, come tutta l’arte e l’architettura, la società che li generò,. emozionante, polìglotta e multipla, una società che fu creata dai signori normannt i quali la ‘modellarono’ poi secondo il loro volere. Coloro che compirono la conquista normanna dellIitalia e della Sicilia erano certamente Normanni in modo predominante e consapevoli di ciò... Normanni quanto coloro che conquistarono l’inghilterra... Sulla scia delle parole entusiaste di Allen Brown, ci sembra giusto concludere affermando che i Normanni furono dei magnifici cavalieri, nel fisico e nell’ anima, i quali in piccole compagnie seppero affrontare e sgominare grandi eserciti, con la loro innata abilità marziale. Essi, con il loro genio e soprattutto con la loro peculiare capacità eclettica, capacissima di assorbire e dominare le più varie culture, conquistarono il mondo medioevale, riuscendo a creare -fra l’altro- quella che fu definita la brillante e straordinaria cultura e civiltà” del regno siciliano del XII secolo, con la mirabile fusione di tre mondi grandissimi: il latino, il greco e il musulmano. E in ciò si avvalsero indubbiamente della loro eletta “Normanitas”. Si rivelarono una grande aristocrazia guerriera, che seppe dare ai propri tempi l’impronta dei valori più alti concessi all’ uomo. È così che, al centro della loro gloria intramontabile, i Normanni furono in Sicilia! ‘3 vetrina L’aquilone triste di Eugenio Giannone Un tuffo nel passato alla riscoperta delle proprie radici, lasciate ma non dimenticate per le nebbie di Lombardia, sulle orme del grande Quasimodo. È quanto è avvenuto quest’estate nei paesi della Montagna Agrigentina (Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, S. Biagio Platani), dove ha esposto Lorenzo Maria BOTTARI. “So di avere avuto coraggio ad esporre in questi minuscoli centri; altrove -e gli inviti non sono mancati- avrei guadagnato parecchio. Ma questo è un omaggio, un atto d’amore verso la mia gente”. Un’opportunità, la mostra, per ricongiungersi a quei quattro elementi, così evidenti in questo lembo della Sicania, che sono la sua linfa pittorica, -qui hanno avuto il loro più grande e antico mentore, Empedocle-, e che, con le combinazioni di acqua, aria, terra e fuoco, perpetuamente agitati da odio e amore, originano la vita e che, modernamente intrecciandosi e fondendosi sulla tela (o sulla ceramica), danno corpo alla mitopittura del Maestro Bottari. La Sicilia che vi traspare è la terra solare, patria del mito e di antiche e forti passioni, intense, in una simbiosi perfetta di realtà e sogno. “La realtà che diventa sogno ti lascia volare sulle ali della fantasia”, mi dice Lorenzo. Forse in un mondo meno ipocrita o meschino, onirico appunto, che non conosce i compromessi e riacquista tutto il suo candore, la sua innocenza. Traspirano infatti dalle opere del Maestro Bottari, oltre che un’accentuata sensualità, tanta 4elicatezza, espressa nelle composizioni floreali (fiore = effimero?), e tanta voglia di dare e ricevere amore; ma si ha l’impressione che qualcosa sia andato stono, che non funzioni. C’è irrequietezza, inquietudine come di chi vorrebbe abbandonarsi alla gioia di vivere ma è rimasto scottato da profonde delusioni, avendone vuotato il calice amaro, ricavandone un’indicibile tristezza che traspare dall’ “Aquilone” e talvolta anche dal viso del burattino che diventerà uomo. È una sensazione passeggera che ben presto svanisce per dare spazio alla levità degli angeli, ai cuori timidi d’amore, al potente Cristo che, risono, viene librato in aria da celesti spiriti. “I suoi colori sono vivi -ha scritto sul registro dei visitatori, in inglese, una donna-, un vero piacere della vista”. Artista di livello internazionale ha saputo fomire un’immagine positiva della nostra Isola. Una tematica, uno stile, quello di L.M.Bottari, che può non piacere, interessare un pubblico poco attento al suo tipo di pittura, oscillante tra An Deco e Surrealismo e che fonde in eclettismo esemplare la lezione della vita e dei grandi Maestri che ne hanno influenzato l’espressione (Guttuso, Cagli, Lam, Kodra etc.); ma che non può lasciare indifferenti. Una pittura originale, unica, che ‘~a di Lorenzo Maria Bottari con la sua accesa e lussureggiante tavolozza”, che “insegue ed accarezza i sogni dell’anima e i desideri del corpo” (A. Miredi) l’inimitabile Aedo del millennio che chiude. “ “ROSI DI VENTU” di Marco Scalabrino (Pietro Tamburello – Siculgrafica, Agrigento 1998) Il nome di Pietro Tamburello naturalmente evoca la stagione della Poesia Siciliana dell’immediato dopoguerra e l’esperienza d quel gruppo di giovani, sorto a Palermo attorno a Federico De Maria, che, in un primo tempo appellato “Società Scrittori Artisti”, venne in seguito denominato “Gruppo Alessio E Giovanni”. Stagione ed esperienza che -pure assieme a quelle contestuali del gruppo catanese chiamato “Trinacrismo”- stanno alle fondamenta del rinnovamento della Poesia Siciliana. Rinnovamento che inerisce alla forma e al contenuto e ch altresì definisce un’attenzione nuova, responsabile, della Poesi verso la realtà. Rinnovamento del quale Pietro Tamburello stato uno degli artefici principali e di cui, peraltro, si è res testimone validissimo nel suo volume del 1982: “LI MI PALORI”. E nondimeno l’uomo (Pietro Tamburello è nato a Palermo ne 1910) e il poeta -la cui impronta comunque avrebbe figurato ne boulevard universale dei Poeti- sanno trovare, ancora oggi, motivi, l’animo, il gusto di riproporsi, di calarsi nella tenzone, c rischiare: “Lassatimi vulari / nzinu a quannu... l’ali... nun ti regginu cchiù.” (LU SONNU DI CHUANG TSE). Con la puntuale prefazione di Antonino Cremona, ha visto luce, infatti, lo scorso gennaio -a distanza di sedici anni dalla prima precedente opera- la nuova silloge di Pietro Tamburelk “Rosi di Ventu”. Fragili boccioli in apparenza -il gambo mediamente non super i venti versi- esse, invero, sono ben radicate nel più fecondo de terreni: “la ninna duci di lu me’ dialettu” (AMARA E DUCI), e penetrano e permeano “...casuzzi bianchi.., porti abbutatì (PAISI DI SICILIA), per raggiungere e scuotere “chi ddi / cu la test ‘nfasciata di pacenza... ca supportanu zotta e puntaloru (DICITIMI MASSARU). In questo humus -scevro da qualsiasi “mirabilia” fonografiche insistono le varietà più pregiate dell’arbusto: la pace “... s’arrampicava ... pi disiu di la paci” (LII ROMITORIU DI SAN FRANCISCU AD ASSISI); (LA LIBIRTA’) “... ‘na canzuna fatta / pi cantalla 1u ventu”; l’amore “... ‘na gnuni di sta terra... avi sarvati l’occhi c mé matri” (AMARA E DUCI); e dispiegano i petali nelle tonalità della malinconia, de crepuscolo, dello struggimento: lu gruppu / di li me’ jorna persi” (ROSI D VENTU); la malincunia / di li finesiri ‘nchiusi (SIRA DI ‘NVERNU); ‘na curdedda di pena / casi va spidugghiannu” (OGNI VOTA) Ognuna di esse, peraltro, riceve le premure sollecite, attente meticolose dell’Autore: appassionato, espertissimo cultori “...vaju ‘ncerca di palori antichi”, “...ogni palora persa ‘n’anticchia di Sicilia si nni va” (L’ORGANU DI LU TEMPU). Alcuni esemplari addirittura vantano l’attribuzione di un. identità ben precisa: Chuang Tzu (filosofo cinese del IV secolo a.C.), Jorge Manrique (poeta spagnolo del XV secolo), Federico Garcia Lorca, Omar Khayyam (poeta persiano del XII secolo) e ancora quelle, a noi più vicine e meglio note, di Giuseppe Mazzola, San Francesco e Carmelo Lauretta. Ma tutte, parimenti degne, sfilano nella rassegna disciplinatamente: -Ma tu ventu tu ventu chi nnifici di li pampini sicch i? Nun tu dumannari; ‘nzinu a quannu lu tempu è un firriu di jorna e di nuttati pila pampina nova è ancora t’arba e pi l’avutri è sonnu senza finiI (LI PAMPINI SICCHI) .... dintra mura di ventu. ... ‘Na coppula senza risettu supra tanti pinsera. ... pari c’addumannassiru pirdunu d’essiri puvireddi (LI PUVIREDDI) Un’unica, suadente fragranza ammanta questo delicatissimo bouquet con traduzione in calce: la fragranza della Morte: ora pacata attesa “... aspettu cuetu... l’urtimu cucù” (LU ROGGIU ‘NTESTA), ora sospirato capolinea “l’appuntamentu cu la tibirtà” (LU SANGU DI GARCIA LORCA), ora ultraterreno spiraglio “Poi... attrova n‘autra vita” (LU CIUMI). Rosi di ventu. Rose.., senza spine. L’Avvocato Paese che vai.., avvocato che trovi. Le facoltà di legge e di lettere erano le più affollate perché non comportavano una frequenza assidua; si potevano studiare le materie a casa, frequentare il minimo indispensabile per la “firma” e poi sostenere l’esame. Per i non abbienti una vera manna. In paese i dottori in legge erano tantissimi: qualcuno era diventato manager di importanti industrie o magistrato o era rimasto in ambito accademico; altri si erano impiegati in vari uffici pubblici, qualcuno insegnava francese; altri ancora esercitavano la professione libera; ma l’avvocato per antonomasia era lui, che non era riuscito a prendere la laurea. A sentirlo, gli mancavano solo una materia e la tesi, da cui lo distraevano altri impegni. I più maligni, che lo conoscevano bene, avevano indagato e scoperto che in dieci anni aveva sostenuto solo pochi esami complementari. Le sue compagnie erano rappresentate da contadini e operai poco acculturati che, con la sua favella, in qualche modo, riusciva ad irretire utilizzando l’avvocatese delle frasi apprese a memoria su quei pochi testi che avevano avuto la fortuna d’essere da lui sfogliati. E parlava loro di consorzi, cooperative, contributi CEE, governativi e regionali. Il presidente della società sarebbe stato naturalmente lui, che avrebbe pensato ad arricchire tutti. Indispensabile che avessero piena fiducia e gli affidassero i loro beni per amministrarli. I paesani, come d’altronde tutti i contadini meridionali, anarchici e diffidenti per natura, lo ascoltavano pazientemente, annuivano con la testa e continuavano ad operare com’erano abituati. Quel “grosso affare” che aveva per le mani non incantava proprio nessuno. A raccontar frottole aveva iniziato già ai tempi della scuola superiore, quando aveva smesso i pantaloni corti e illustrava a compagni e amici le sue mirabilie di dongiovanni e cacciatore. Un giorno con una pallottola aveva preso una cuturnice, che stava appollaiata su un ramo, e il coniglio che era sotto. “Perché racconti panzane”? -lo rimproverò un giorno Peppe. -Credi che gli altri siano scemi”? “Tutti hanno qualcosa da dire” -si giustificò. -“Io non ho nulla e invento”. Era sempre più isolato e inutili erano le strane pose di viveur che assumeva. Vivacchiò per anni sollecitando il disbrigo di pratiche varie e con la pensione di uno zio; alla fine si ridusse a campare del poco che gli rendeva il fazzoletto di terra ereditato dal parente, della generosità dei vicini e divenne maestro nell’arte del “leccare la sarda”, pur continuando a fantasticare e a costruire castelli in aria, inventati forse per ingannare se stesso. Ora il tiro dei discorsi si era spostato sulle virtù taumaturgiche del lavoro.., degli altri. Agli amici, pochi, che lo invitavano a cercare un’occupazione, rispondeva sempre di attendere l’esito dell’ultimo concorso sostenuto, che non arrivava mai non avendovi partecipato! Sprecò così l’esistenza senza mai avere lavorato un giorno, crogiolandosi con quel titolo di “avvocato” che i paesani gli avevano affibiato e che per lui volava dire essere tenuto in grande considerazione, al di là del significato che gli attribuivano i concittadini, sicuramente non positivo. Lo svitamento del cervello e forse i morsi della fame lo indussero, negli ultimi anni di vita, allo sproloquio, per cui, oltre a ritenersi il corrispondente di un noto quotidiano, cominciò a vestire in modo inusuale, eccentrico, con occhiali scuri e ad intrattenere davanti al bar, spesso su una sedia, il pubblico che gli rinfrescava la gola offrendo in continuazione birra’e alcoolici, che lo stordivano. Divenne l’avvocato “Corvo” e chiuse i suoi giorni in un ospizio. Eugenio Giannone schede Musici trapanesi del XVI e XVII secolo di Ignazio Navarra L’Occidente deve all’Islam molti strumenti musicali, tra i primi il liuto, la ribeca, la lira da braccio e, di conseguenza, tutta la famiglia delle viole. Una civiltà così “prepotente e magnifica” non poteva •non influire sulla cultura della Spagna e della Sicilia. Sugli strumenti musicali, il teorico Muhammad Ibn ‘Ebdal-Hamid alLadhigi, che nel XV secolo compilò un trattato dedicandolo al sultano Bayzid 11(1481 -1512), così scrive: “Gli strumenti musicali sono in tutto di due specie: a corda e a Jìato. Tra questi ultimi, alle volte, si comprende anche la gota umana”. Il Tintori dice che il liuto è onnipossente nella nostra civiltà dai Medioevo in poi; il Guiraut de Calauson lo considera, nei “Conseil aux jongler”, strumento indispensabile; il Guiliaume de Machault lo cita ne “La prisa d’ Alessandrie” e “Ramede de Fortuna”; il Boccaccio, in “chiusura” della giornata prima. Il liuto, dopo il passaggio in Francia, Italia e Sicilia -dove la dominazione catalano-aragonese dura a lungo- diviene uno strumento conosciuto a tutte le classi sociali. Un passo dell’arciprete di Hita, che enumera una trentina di strumenti musicali, cita tra i primi il liuto, poi l’arpa, la guitara morisca e la guitara latina. Il Trasselli riferisce su un menestrello errante, Bonanàda Énglada, d’origine catalana, morto a Trapani nel 1427, il quale cantava accompagnandosi col liuto catalano, col liuto veneziano e con l’arpa. Palermo poco prima aveva avuto due suonatori, Paolo Mantasi e Giovanni de la Padula “magistri ministerù”, che avevano fatto società fra di loro per andare insieme a “pulsare de eorum artre ad nuptias” e ovunque chiamati in Sicilia; s’erano anche impegnati a non insegnare l’arte ad alcuno se non previo accordo. Gli esempi raccolti presso il Trasselli autorizzano ad affermare che i menestrelli continuarono a girare per l’isola, in tutt’ altra epoca, prestando la loro arte di suonatori ove richiesta. Il Trasselli afferma “dette musiche non saper dire, ma che di canzoni di quel periodo vagheggerebbe il sonicium de matrimonio del 1443, inzeppato di memorie profetiche”. I musici divertivano gli uditori con canti giocosi, come mostra un sonetto per un libro non restituito, dai versi assai significativi. I musici cantavano anche canzoni carnascialesche che ricordavano vecchi canti di scuola italiana, o lirica popolareggiante, o forse canzoni più licenziose. Un documento dell’Archivio di Stato di Trapani, dell’ultimo quarto del secolo XVI, dà notizia del suonatore di piffero Agostino Gallo, “de Urbe Panormi”, trasferitosi a Trapani, dove si pose al servizio dei giurati e dove istituì una scuola di musica. Congedatosi dall’incarico di suonatore di piffero, nella sua città il trapanese Giulio Oristagno assunse quello d’organista nella cappella palatina, sostituendo il musico Giuseppe Testaverde. Dell’ericino Nicolò Toscano poco si conosce circa la sua educazione musicale. Il Tiby dei musico Toscano dice di non saper “con chi.., abbia compiuto gli studi musicali”. Nella città di Trapani esistevano degli ottimi organi, quindi dovevano esserci anche dei buoni maestri organisti. I loro cognomi non li conosciamo; però sappiamo che nel 1559 “ali 27 di augusto a Maestro Vincenzo organista, per ripararsi l’organo et accordarlo” erano state pagate once 15 e, nel successivo 1577, erano state versate “al maestro Raphaeli organista, fra pagamento do onsi 36, quali resto.., a complimento di onse 66, per lo organo novo”, oncia una. Giulio Oristagno era nato a Trapani nel 1543. Di lui scrive il biografo G.M. Ferro: “Nel 1543, venne alla luce Giulio Oristagno. Egli era di un ‘aria assai pensierosa, e parlava assai poco. Il suo genio lo trascinava alla musica, ed i suoi genitori non vollero urtare la sua natura. Quindi assicuratosi il padre di questa sua disposizione, lo inviò in Palermo, per apprenderne i canoni Sorpassando egli~ ben presto i suoi compagni. divenne emulo perfino dello stesso suo maestro”. Se avesse fatto studi a Trapani, potremmo ritenere suo maestro lo stesso rnusico alla cui scuola si era formato Toscano; ma trattandosi di musico palermitano, non possiamo pensare ad altri ci ad Antonio Lo Duca di Cefalù, il sacerdote siciliano musico, notato nel novero degli amici di Michelangelo Buonarroti. Antonio Lo Duca era nato Cefalù nel 1491. Dopo aver studiato Roma, era passato a Palermo, e per “sua specifica competenza” era stai chiamato a insegnare musica e canto. Oppure bisogna pensare a un musico spagnolo, di cui non si conoscono né m me né attività musicali. Dobbiamo concludere che il biografo dell’Oristagno, circa gli insegnamenti musicali ricevuti e gli insegnanti avuti non per niente chiaro, anzi mette in sospetto sua mancata sincerità, dovuta sicuramente alla mancanza di documentazione. Da qui l’omissione del Di Ferro del nome di maestro del quale era stato allievo giovane Oristagno. Giulio Oristagno nel XVI secolo e nei primi del XVII, fu nel novero dei mush siciliani più stimati. Nei primi anni del XVII secolo, in Sicilia, Nicolò Toscano di Erice era considerato un’autorità in fatto di musica. Di lui possediamo un primo libro di canzonette a quattro voci, stampato a Venezia dall’editore Gordano nel 1594, che oggi si trova conservato nella Stadtstbibliothek di Danzica, in Polonia. Il Toscano, nel 1600, fu tra i giudici che valutarono le prove musicali dei compositori Sebastiano Raval e Achille Falcone. Come si siano svolti realmente i fatti della sfida musicale, con precisione non sappiamo dire. E’ noto soltanto che le composizioni musicali furono affidate al vicario della città, “acciò giudicare 1e facesse da quei signori compositori” dall’allora viceré di Sicilia, duca d Maqueda. Sulle conclusioni della gara musicale, il Tiby scrive: “...Vicario generale di Palermo era il Pretore della città, specie di Sindaco che nell’anno 1600 era don Francesco del Bosco Conte di Vicari ma questo nome non dice nulla Non risulta che a quell’epoca a Palermo vi fosse una corporatione di musici che potesse legittimamente rappresentare il sapere e li interessi della classe. E allora? E allora è da supporre che il Pretore abbia chiamato i più noti musicisti di Palermo, abbia loro mostrato.., i sei pezzi e li abbia invitati ad esprimere il loro giudizio. Chi erano questi musicisti? Anzitutto il Verso, il Toscano, il Formica, il Giglio...; poi fra’ Vincenzo Gallo maestro di cappella alla Cattedrale, Giulio Oristagno organista alta Cappella Reale e quindi dipendente dal Raval, ed altri minori (Francesco Tomeo, Barbarino Costanzo, il gesuita Vincenzo Branci forte). Se non era passato ancora a miglior vita (morì appunto nel 1660), non sarà mancato il parere del benedettino Fra’ Mauro Chiaula...; né bisogna dimenticare il Conte di Cammarata e Duca di S. Giovanni, il protettore del Raval. “. Ora è facile comprendere come, per la posizione ufficiale di quest’ultimo e la protezione del Viceré di cui godeva, dato il predominio della Spagna e degli spagnoli, gli animi fossero più propensi a favorire il Raval e non un giovane musicista e poco conosciuto maestro di cappella d’una lontana città di provincia. Certo è che i giudici, quali che siano stati, diedero una misera prova di carattere, di coraggio civile, di integrità; sola eccezione il Toscano, che fino all’ultimo sostenne il Falcone, a voce, di persona, e per iscritto. Giulio Oristagno di Trapani, organista alla Cappella Reale, stando al Tiby, morì in Palermo, nel dicembre del 1623, all’età di ottant’anni. Altro compositore trapanese “degno di onorevole menzione” è Francesco Maria Bello, maestro di cappella e autore di un componimento sacro-drammatico, che reca il titolo di Adamo. Altre individualità di spicco ebbe Trapani: quella che l’avrebbe resa famosa nel mondo nacque il 17 di maggio 1850: Antonio Scontrino. Un teatro dell’opera bello ed acusticamente perfetto: noterelle sul “Bellini” di Catania Il celebre tenore Beniamino Gigli, che di teatri s’intendeva certamente, e che non può essere tacciato di parzialità, ha fatto questa affermazione: “Il teatro Massimo Bellini di Catania è a mio giudizio il teatro d’opera più bello e più acusticamente perfetto del mondo, acusticamente ancora più perfetto del San Carlo di Napoli e persino più bello della Fenice, I suoi colori e le sue proporzioni si fondono in una armonia che non mi stanco mai di contemplare.Ogni volta che raggiungevo quel teatro era invariabilmente per me un purissimo piacere’. Quanto ha dichiarato questo grande artista può essere da chiunque verificato: basta entrare nella platea o in un palco, e subito l’occhio spazia gradevolmente dappertutto, e lo sguardo attraversa ammirato tutto il vasto ed armonioso ambiente. Costruttore di questo pregevole monumento fu l’architetto milanese Carlo Bada (1549-1924), allievo e collaboratore di Andrea Scala, anch’egli eccellentissimo costruttore di numerosi teatri in Alta Italia. Il Bada studiò dapprima nella città natia, proseguì gli studi per qualche tempo a Firenze, e frequentò poi a Roma l’Accademia di San Luca. Ricevette l’incarico di realizzare il “Bellini” nel 1550 e nel decennio successivo ebbe modo di mostrare il suo grande talento, portando a compimento l’opera nello spazio dl sette anni. Egli stesso ne diresse i lavori, ed il teatro riuscì magnifico, elegante ed armonioso sotto ogni riguardo. Le decorazioni della sala e del foyer, e quelle scultoree del prospetto, attestano la sua arte squisita, che si giudica improntata ad eclettismo, perché in essa coesistono stilemi neoclassici e rinascimentali, nonché rivisitazioni dell’architettura antica. Prese naturalmente esempio da altri celebrati architetti, come il Piermarini, il Carpeaux, il Garnier, ed il lavoro ultimato lasciò completamente soddisfatta la pubblica aspettazione. Si avvalse di bravissimi artisti, e per il gruppo centrale del prospetto, una splendida “Gloria alata”, realizzata in travertino, il compito fu assegnato al leccese Eugenio Maccagnani, il cui nome è legato alle sculture dell’Altare della Patria a Roma. Il “Bellini” fu Inaugurato il 31 maggio 1590, con la Norma, un’opera che nello stesso teatro fu poi cantata da famosi soprano come Gina Cigna, Maria Caniglia, Elena Suliotis e Maria Callas, che la interpretò in due stagioni consecutive. Costruito inizialmente per ospitare 2200 spettatori, dopo una ristrutturazione dei posti, ne contiene ora circa 1300, e soddisfa appieno le esigenze della città. Per quanto riguarda l’acustica, il Bada forse neppure immaginò che avrebbe avuto tanta fortuna, ed è forse il sottosuolo, fatto di durissima pietra lavica, che impedisce in parte la dispersione del suono, convogliandolo verso la sala. Ma questa è solo un’ipotesi. Sta di fatto che il Bada era assillato dal problema dell’acustica, ed aveva fatto delle ricerche per non incorrere in errori. Nella relazione presentata nel 1880, allorquando il suo progetto fu approvato, dedicò alcune righe al problema dell’ udibilità nella sala, così scrivendo: “La più forte ragione poi che non crediamo utile fare i sottoscena troppo profondi, si è che, come più si aumenta il volume dell’aria del palcoscenico in proporzione di quello della sala teatrale, l’onda sonora viene assorbita più facilmente da questa gran massa che da quella della sala teatrale e quindi concentrandosi le onde sonore nel palcoscenico, aiutate anche per effetto della differenza di temperatura e di atmosfera, ne risulta dl conseguenza che la sala teatrale diventi sorda. Esempio siano parecchi teatri esteri, e fra questi i più recentemente e sfarzosamente costruiti, quali sono l’Opera dl Parigi eVienna, che mentre in ogni angolo del palcoscenico si sente perfettamente, la sala è affatto sorda, e notare che queste sale sono più piccole di quella del Teatro alla Scala dl Milano, Il quale, sotto molti rapporti, abbenche’ vecchio e criticato per avere il palcoscenico poco profondo, è ancora fino ad oggi, il meglio rluscito riguardo all’acustica.”. Questo bel teatro, dl cui tutti hanno potuto ammirare uno scorcio nel 2 .1 “Johnny Btecchino” di Benigni, purtroppo non è affatto sfruttato come punto di attrazione turistica, benché sia tale da poter suscitare nei visitatori grande interesse e curiosità. Carmelo Neri artifices Scultori siciliani del 500 Don Mariano Manno, priore di 5. Nicolò la Latina e di San Calogero di Sciacca, nel 1530 diede inizio alla costruzione dell’attuale Santuario di San Calogero esistente sul Monte Cronio. Lo stesso priore volle anche che fosse sostituito nella chiesa il vecchio quadro di San Calogero con un ‘imponente statua. Così, nel 1535, commissionò la statua, per mezzo del cappellano don Antonio Bruno, ad Antonello Gagini. La monumentale statua, ispirata alle “Lezioni del Breviario” del tempo dei Normanni, con abito da eremita, e da egumeno (abate) basiliano, Bibbia e cerva, con sfarzose decorazioni in oro zecchino, iniziata da Antonello Gagini, fu completata dal figlio Giacomo. L’improvvisa morte, avvenuta nel 1536, aveva impedito al maestro Antonello di consegnare la statua e di collocarla sull’altare maggiore della Chiesa. L’opera che, per contratto, doveva comprendere anche la figura dell’arciere, rimase incompleta. La statua di San Calogero presenta una figura dal forte carattere e dallo sguardo toccante le profondità dell’anima. E’ ritenuta dal Sanfilippo lavoro di Nicolò Milante; il Di Marzo la considera invece eseguita dai maestri Gagini e consegnata nel 1536, e non nel 1538 come invece asserisce il Sanfilippo. Le due date, il 1536 e il 1538, non possono che indicare la consegna di due statue di San Calogero : una lignea consegnata nel 1536 dallo scultore Nicolò Milanti all’arciprete della Chiesa di S. Maria Maddalena, l’altra marmorea -nel 1538- dallo scultore Giacomo Gagini al priore Mariano Manno. La statua lignea policrorna di San Calogero scolpita dal Milanti è provvista della figura dell’ Arcano in posizione genuflessa. Secondo le asserzioni del Sanfilippo, ma anche di Mario Serraino, il Milanti (o Milante) avrebbe origine marsalese. Va detto però che da tempo si era trasferito a Trapani, e per tale motivo era stato indicato forse trapanese. Da Nicolò Milanti discenderebbe dunque quell’Antonio Milante trapanese, erroneamente considerato il capostipite della famiglia. Figli di Antonio sono Vincenzo e Leonardo; i due ultimi prendono moglie rispettivamente nel 1643 e nel 1655. Figli del primo sono Diego e Francesco, del secondo Cristoforo e Giuseppe. Diego e Francesco Milanti facevano parte della “Corporazione dei professori di scultura di ogni materia”. Dei loro cugini, pure scultori, sappiamo che lavorarono il marmo e il legno e che tennero bottega sia a Trapani sia a Palermo. Giuseppe Milanti è ritenuto dagli storici dell’arte J~utore di due Crocifissi lignei policromi, di commovente religiosità: unitamente a quello realizzato per la Chiesa di San Pietro a Trapani, gli viene assegnato il Crocifisso della chiesa del Collegio dei Gesuiti, oltre ad un altro nella Chiesa di S. Maria dell’Itria. Il suo biografo Di Ferro ne ricorda poi altri due, rispettivamente nella Chiesa degli Agostiniani e nel Monastero della Trinità, in aggiunta a una statua a grandezza naturale raffigurante 5. lsidoro Agricola, nella sagrestia dell’oratorio di San Filippo Neri intitolato a S. Giovanni Battista, sempre a Trapani.. Sono pure opera di Giuseppe Malanti la statua in legno, tela e colla dell’Addolorata e dell’Ecce Homo, che fanno parte della collezione dei sacri gruppi dei Misteri. Anche Cristoforo Milanti, detto Ottavio, fratello del citato Giuseppe, si rese illustre come scultore tanto nella sua città, quanto a Palermo, dove lasciò un bel Crocifisso ligneo nell’Oratorio di S.Anna. A Trapani lasciò invece il gruppo della Deposizione dalla Croce dei Misteri della Passione, che ogni anno sono portati in processione durante la Settimana Santa; eseguì inoltre la statua della Madonna del Soccorso per la Cappella omonima (progettata dall’architetto trapanese Giovanni Biagio Amico) della chiesa della Badia Nuova. Con probabilità realizzò i due Crocifissi in legno sistemati rispettivamente nelle Chiese di S. Francesco e dell’Addolorata. Uno dei due gli storici lo vorrebbero eseguito insieme al fratello Giuseppe. Nei Crocifissi di maestro Cristoforo, ma anche in quelli scolpiti dal fratello di questi, grande è il trasporto spirituale, che traspare dai volti sofferenti del Nazareno, nei quali manifesto appare il richiamo all’arte, formale oltre che pietosa, di frate Umile da Petralia (al secolo, Giovanni Francesco Pontorno), la cui influenza avrebbe toccato tutta la produzione dei Crocifissi del secolo XVII, ma anche quella del secolo successivo. Vincent Navarra le rime in copertina NUVOLE E PENSIERI S’addensano soffici strati su trasparenze ilari d’azzurro e spargono riflessi d’oro sulla schiuma ribollente del mare S’addensano vaghi pensieri dietro lo specchio dell’ iride assorta in colori e rumori Le narici catturano aromi di sabbia e d’acqua Ricreano profumi di lontani gelsomini e misteriose voci d’una segreta grotta ricolma di lumache e millepiedi su scivolio di verde umido muschio e porosi buchi di pietra PAROLE COME FUOCHI Con una rivistina intelligente ventilo l’afa dal mio viso e dal collo imperlato di sudore nell’ ipotesi gagliarda che dalle pagine ricche di parole soffi alla mente stanca una nuova ispirazione e vinca la pigra voglia che sbarra la voglia di accendere parole Enrica Di Giorgi Lombardo LA FUNTANEDDA Sunu ricordi di la carusanza chiddi ca m’affuddanu la menti: ccu ‘na gran pena sentu la mancanza di tanti amici e vecchi canuscenti. Dda funtanedda accostu a la me casa dava ristoru a tutti l’assitati: sinu a la Virmaria vinia invasa di na gran fitdda ‘nta la fitta ‘stati. Fimmini,carusi e vicchiareddi, -a ddi tempi chista era l’usanzajevanu ccu quartari e ‘nchitureddi all’acqua a la flintana ccu custanza... Ora sta funtana è sicca e muta, di nuddu idda chiù veni guardata; è comu ‘na lumia già munciuta Sta sorti attocca atutti’ntra’sta terra, chistu è bonu si ci teni a menti: doppu chi cummattemu ‘sta gran guerra, turnamu a’ ‘ssiri ‘autra vota... nenti Peppino Marano LU CUNTU C’era ‘na vota, c era... e pari un cuntu C’era ‘a famigghia cu patri, matri e figghi, e, nta lu spissu, li nanni e li ziàni. C’era lu patri, veru patri di famigghia; c’era la matri, vinirata a tipu Santa; c’eranu ‘i figghi, chi facianu ... ‘i figghi. Nun c’eranu portafogghi chini ‘i rana; nun c’eranu fistini cu l’amici; nun c’era lu ragazzu e la ragazza; nun c’era l’abbrazzata strati-strati; nun c’eranu màchini mpurtanti...: Si ja all’apperi,... s’allustravanu bbalati. C’era ‘na vota, c’era... e pari un cuntu!: pulizzia di rintra e pulizzia di fora; c’era ‘u rispettu pi li pirsuni ranni; c’era scarsizza... ma nun c’era droga. C’era... e pari un cuntu Alberto D’Angelo Mia isola Lontano da te mia isola ho amato la tua essenza le tue accese rocce le tue ruggenti eruzioni io donna del sud invoco il mio passato l’arabesco sui vetri dell’infanzia profumo intenso diventa l’aria nel sogno di notti complici di pazze fragranti estati. Arrivo nella terra delle inodori camelie con il cuore trasparente ho provato il dolore vero resto presa come in una rete io donna del nord al ritmo di lontane epifanie. Cerco il sentiero fra venti gelidi fra lacrime di neve che mi porti alla luce ai caldi tramonti che portano a tacere i monti e il mare. Il passato si dissolve mi avvolge solo il silenzio. Tita Paternostro PUNTUALITA’ P~~nninn Canusciu ‘n omu ca non è puntuali si dici a l’ottu veni e novi e menza e si u ritardu ci lu fai nutari dici c’aveva cosi di sbricari. Quannu pi casu duna appuntamento ti dici: “U tempu di la strata e sugnu ‘ndocu” e tu ci criri poviru mischinu! Ma pi iddu lu riloggio è ferru vecchiu, l’avi a lu pusu ma mancu lu talia, quieto grigio si ferma a leggiri i giurnali davanti a l’ediculi fistanti, si gira, si rivota, perdi tempu, ‘ncontra n amicu e... parra... parra...parra... poi finammenti arriva cunfunnutu e dici: “Sapissi li cosi caiu sbricatu!” N’avota ci crideva a sta sunata ma, a stissa musica, presta o taddu, annoia e ora ca canusciu a sta suggettu a l’ura stabilita si non veni... mi ni vaiu avanti e non l’aspettu. Rosetta Di Bella SI CAMPA PURU Dl CHISSU Si campa puru di chissu, quannu alèntanu li forzi e nte mumenti bbisitùsi; si campa puru di chissu, quannu lu specchiu t’arrifretti tuttu bbiancu e li rutati di lu tempu assùrcanu la facci. Si campa puru di chissu: di li riòrdi di la picciuttanza. L’assùmmanu ‘i ritratti, ‘na crirènza trabballanti o ‘na gghìcara canniàta, ‘na strata, un paisi, ‘na palora... ‘a vita d’ogni jomu ch’i so’ cuntrasti c’u passatu Si campa puru di chissu: di ‘sta miricàta antica a li cutiddati di lu tempu. Alberto D’Angelo (2° premio “Barunissa di Carini”)
Scaricare