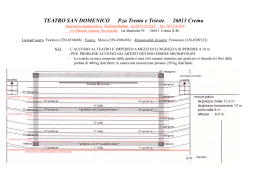1 In palcoscenico UNA GIOVENTÙ CONDANNATA IN PARTENZA A VIVERE ALL’ULTIMO (CORTO) RESPIRO Con “X(ics) Racconti crudeli della giovinezza >> X.04 Napoli” i riminesi Motus ripropongono una convincente linea scenica ‘analitico-concettuale’ aggiornata alle oggidiane crudeltà metropolitane. I romani Santasangre con l’installazionespettacolo “framerate0_primo esperimento”, producono mero, energetico teatro post-human. Il Nederlands Dans Theater guidato da Jiří Kylián ha presentato nella capitale lo sfizioso film video “Car-Men” e la elaborata partitura coreografica “Last Touch First”. La più recente commedia di Luca Archibugi “Immobildream” esplora un bislacco côté borghese pariolino in bilico tra Ionesco e Campanile. ___________________________________________________________________________ di Marco Palladini 1 - In questo tempo di turn-over teatrale frenetico, quasi neuro-ossessivo, un gruppo come i riminesi Motus che esordirono nel 1991 con Stato d’assedio, appare già un ‘classico’ della scena italica sperimentale, un effettuale padre delle più recenti waves generazionali già promosse (vedi Muta Imago, Dewey Dell, Pathosformel etc.) a rappresentanti del nuovo teatro tricolore in esimie rassegne internazionali. Dunque, a rigore, tornare a vedere la compagnia diretta da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò – incaricati, tra l’altro, di dirigere il Festival di Santarcangelo 2010 – non dovrebbe costituire un test probante circa le ultime sensibilità del teatro di ricerca nostrano. Io ho però da ‘lunga pezza’ maturato la convinzione che ben poco di nuovo compaia ormai sui palcoscenici della penisola. Più che altro si rimasticano, si rimodulano, si riarticolano forme e linguaggi e visioni che stanno ben dentro il solco di una “tradizione del nuovo” che in questo paese ha ormai una storia che dura da mezzo secolo (giusto 50 anni fa, ricordo, debuttò Carmelo Bene con il Caligola di Camus al romano Teatro delle Arti). Questo per dire che X(ics) Racconti crudeli della giovinezza >> X.04 Napoli, visto al Teatro India per la rassegna “Le vie dei festival”, mi ha una volta di più confermato che i Motus sono oggi i più fulgidi esponenti di una linea ‘analitico-concettuale’ (battezzata da Beppe Bartolucci e Achille Mango oltre 30 anni fa) che partendo da Simone Carella e dai primi Magazzini Criminali degli anni ’70, si conferma tuttora la più solida barriera artistica contro il patetismo e il lirismo sentimental-ricattatorio di tanta scena contemporanea. E tanto per non fare nomi, dichiaro senza mezzi termini che per me i Motus sono gli anti-Pippo Delbono del ‘côté’ teatrico italiota. L’attore-autore genovese ipersoggettivizza in modo vampiresco qualsiasi tema, iperbolizza il proprio ego (ego-corpo) sofferente proiettandosi, ma pure sovrapponendosi alle diversità umane che convoca in scena o agli spunti che accendono i suoi ammorbati, manierati spettacoli. Così, quando Delbono spalma se stesso, retoricamente e narcisisticamente, pure su una tragedia come quella dei sette operai bruciati alla Thyssen Krupp di Torino (vedi La menzogna), è difficile non parlare di mera ‘pornografia del dolore’ e di un lavoro, in sostanza, eticamente indecente. 1 2 Così, tanto più si apprezzano i Motus che si calano in un progetto geo-teatrale in progress, che qui mira a esplorare la deriva neobarbarica, alienata, anaffettiva, sociopatica della periferia metropolitana napoletana (la medesima di Gomorra) con fredda distanza, desoggettivando al massimo, in una chiave espressiva eidetico-concettuale che nulla concede al sociologismo volgare, come alla rappresentazione oleografica. Il titolo dello spettacolo è letteralmente ‘scippato’ a un magnifico film del 1960 di Nagisa Oshima, ma va bene così: qui la cruauté si dà per sottrazione, per allusione, per dinamiche tangenti che né demonizzano né epicizzano o visceralizzano la materia. Dopo avere a lungo e un po’ troppo acriticamente istruito rutilanti allestimenti innervati di compiaciuto glamour, di seduttive superfici suoni&luci e discotechno, di mercificazione-reificazione del mondo accettata tout-court, i Motus sembrano (a partire da L’ospite, 2004, ispirato a “Teorema” di Pasolini) essersi dislocati in una frontiera critica (anche critico-politica) che si dispone per composizione semantica e non per invettiva contenutistica o esercitazione didascalica. La loro forza è che fanno teatro pensando ad altro: al cinema, per esempio, al video, alle installazioni artistiche, alla performance situazionistica. In X (ics) il plateale point de repére, notato da molti, è la bellissima pellicola di Gus Van Sant Paranoid Park. Anche qui uno sguardo quasi neutro, sottomisura, attonito o documentaristico su uno scorcio periferico emblematizzato da un marciapiede, una panchina e un muretto, dove figure senza volto incappucciate nelle felpe d’ordinanza sfidano la morte saltando da un lato all’altro della strada, mentre sfrecciano i fari delle auto lanciate ‘a tavoletta’. Oppure volteggiano sui pattini distribuendo i flyers di qualche evento ‘alternativo’, o si incontrano muti, scambiandosi cicche ed enigmatici segnali, ovvero ascoltando pezzi tra rock e rap schitarrati e scanditi dai musicisti di “Roca Luce”. Sul fondo scena c’è uno scuro schermo grigliato sopra cui scorre un flusso di immagini video in bianco&nero che partendo dal quartiere partenopeo di Scampia, mostra algidi e squallidi panorami suburbani dei ghetti di varie città europee, incrociati con visioni astratte o optotroniche, siglate dalla ricorrente figurazione di un teschio, banale, ma veridico simbolo principe di desolanti territori, dove si accumulano indefinitamente spazzatura e morte fisica e spirituale. A dispetto del titolo, qui non c’è invero alcun reale racconto, ma soltanto l’esibizione iterativa di ectoplasmi scenici impegnati a tentare di sopravvivere fino alla prossima chiamata letale. Nessun compiacimento, ma anche nessun ammicco consolatorio: archiviata l’euforia scintillante e piaciona della postmodernità, i Motus si calano nella disforia dell’ipermoderno con sobria arte neocrudele, la giovinezza che ritraggono è quella di un’età stordita, anomica e anonima, condannata in partenza a vivere all’ultimo (corto) respiro. 2 - Alla (di già) penultima generazione teatrica appartiene l’ensemble capitolino Santasangre (Diana Arbib, Luca Brinchi, Maria Carmela Milano, Dario Salvagnini, Pasquale Tricoci, Roberta Zanardo) che dopo l’ottimo risultato conseguito con Seigradi, punto di approdo di una trilogia simil-apocalittica imperniata sull’acqua come elemento basico della vita, adesso cambia direzione di ricerca e annuncia una nuova trilogia, stavolta sul tema dell’energia. Tappa iniziale di questo progetto è l’installazione-spettacolo framerate0_primo esperimento, presentata al Romaeuropa Festival 2009, negli spazi di Fonderia 900. In un bianco, penitenziale camerone l’esperimento si avvale del gioco dei fari motorizzati che sventagliano lame di luce, ora radenti ora abbacinanti ora puntilisticamente esatte. Si susseguono proiezioni di esplosioni cosmiche o primordiali. Mini big-bang assistiti da correnti sonore elettroniche continue. Si formano clusters di linee lucibonde irregolari. Un rotante squarcio luminoso sembra un tanto immaginifico quanto minimale taglio di Lucio Fontana, una nivea ferita incisa sul muro. 2 3 Poi il punto di attenzione si sposta su una grande vasca quadrangolare dai bordi bassi, ai cui angoli penzolano quattro grosse, ferrigne catene, sormontate da un massiccio gancio da argano di cantiere. Una grande ombra circolare oscilla minacciosa sulla parete, come la palla nera gigante del film di Fellini Prova d’orchestra, quella che buttava giù il muro e preannunciava la restaurazione dell’ordine dopo la stagione di follia ed anarchia. Qui più sottilmente dà l’avvio al movimento delle catene che prendono a sollevare il massiccio blocco di ghiaccio contenuto nella vasca frigorifera, che levandosi in aria prende copiosamente a sgocciolare, di tra varie smitragliate di luminosità pulsanti e tourbillon policromi. Il blocco di ghiaccio viene manovrato fino a posizionarlo verticalmente, così che diventa una cortina gelida semitrasparente e trafitta da altri plurimi giochi di luci e ombre, mentre prosegue a scolare nella vasca, infine forse simboleggiando il fatale disfacimento di qualsiasi ‘Wall’ divisorio o di separazione. Anche i Santasangre si disoccupano di teatro, per fare altro, ossia nella fattispecie per confezionare con sicura e lodevole perizia tecnico-tecnologica una performance visivasinestetica che molto mi ha ricordato le prime suggestive prove dei Krypton di Giancarlo Cauteruccio (penso a Corpo, ambient-video-laser del 1982 o Angeli di luce del 1985). Se questo è teatro è mero teatro post-human. Per certi versi, forse, persino preferibile a quello ‘human’. 3 - Il 62enne praghese Jiří Kylián è da tempo uno dei maestri del teatrodanza europeo, trapiantato ad Amsterdam da oltre tre decenni guida il Nederlands Dans Theater, una delle compagnie di punta della coreografia contemporanea. Lo scorso ottobre al Valle di Roma, Kylián è stato ospitato e omaggiato presentando in serata unica un suo singolare dittico creativo. La prima parte del programma prevedeva la proiezione del film video Car-Men (2006) diretto da Kylián assieme a Boris Pavel Cohen. Uno sfizioso lavoro di rilettura e decostruzione della Carmen di Bizet in guisa di filmica ‘comica finale’ girata in un b/n d’antan. Vincente è, innanzitutto, il set del film in una landa mineraria desertica della Cekia, che mi fatto subito pensare alle desolate locations dei ‘nude trash-movies’ di Russ Meyer o di Un paese per vecchi dei fratelli Coen. E poi sempre irresistibile è la tecnica delle gags accelerate, in puro stile ‘slapstick comedy’. Car-Men ovvero macchina e uomini o uomini-macchina, gettati in un paesaggio allucinato, post-atomico, dove gli eponimi personaggi dell’opera – la femme fatale Carmen, il sergente spasimante Don José, il toreador sciupafemmine Escamillo e la provvida contadina Micaela – diventano quattro balzane figurette da cinema muto, un quartetto di spiritati burattini, di scavallanti misirizzi, non di rado impegnati in miseri dispettucci e giochetti scimuniti tra brulle collinette di terra e cimiteri di rottami d’auto. Si susseguono inseguimenti e siparietti demenziali come pura parodia del libretto di Meilhac e Halévy, nonché manipolazioni digitali ambientate in frenetiche gare automobilistiche anni ’20-’30. Scena o scenetta madre è una sorta di notturna corrida che si svolge tra una lugubre macchina nera con i fari minacciosamente puntati (macroscopica citazione di Christine, la macchina infernale, l’horror-movie del 1983 di John Carpenter, derivato dal romanzo di Stephen King) e che muggisce come un grande scalpitante toro di metallo e una Carmenmatador (o matadora) che fa volteggiare lo scialle-muleta in un’arena lunare da puro ‘nightmare in Sevilla’, riuscendo infine a placare-sedurre la lucida bestia a quattroruote. Interessante è che questa Carmen (Sabine Kupferberg, danzatrice topica di Kylián) è una donna matura e, più che avvenente, direi sconveniente e indisponente, una mezza arpia ingenerosa e malignazza, talora volgarotta e sguaiata come una drag-queen. Del pari, assai depassé e snervato o sgualcito è Don José, mentre Escamillo e Micaela sembrano trafelate sagome sortite o sgorbiate fuori da un circo di mostri-freaks alla Tod Browning. Insomma, 3 4 Kylián qui si diverte e ci diverte a sputtanare la Carmen con le sue habanere e seguidille, trapassando il teatrodanza in comicità clownesca tra Ridolini e Charlot. Di tutt’altro segno la seconda parte della serata che prevedeva lo spettacolo, in prima nazionale italiana, Last Touch First. Si alza il sipario e ci troviamo in un essenziale, elegante salone da maison di campagna ottocentesca in cui si potrebbe svolgere un dramma di Cechov o di Ibsen ovvero un racconto di Tolstoj o di Gogol. Qui si dispone un tableau vivant di sei figure (tre donne e tre uomini) come figés, glassati in un ambiente segnato da poltrone, sedie da soggiorno e sedie a dondolo, un tavolo con tovaglia e candeliere acceso, una porta, una finestra, una grande specchiera e un candido telo-tappeto increspato. Le tre coppie stanno sospese nell’assoluta immobilità, poi si muovono impercettibilmente. Gesti lentissimi: chi legge, chi si versa del vino in un bicchiere, chi gioca a carte, chi attende al lavoro domestico. Sei bradipi umani investiti acusticamente dalla colonna sonora di Dirk Haubrich che ha un andamento insinuante, avvolgente, con picchi e strappi rumoristici da ‘musica concreta’ che rompono l’atmosfera idilliaca, paciosa, ma forse anche mortuaria che si respira nel villone agreste. È evidente che Kylián ha assegnato alla partitura musicale una precisa e determinante funzione di drammaturgia scenica. Forse è questo “l’ultimo primo tocco” che induce nel sestetto dei danzattori degli scatti improvvisi, dei movimenti isolati, delle ratte torsioni cinetiche. L’esasperato ‘ralenti’ iniziale via via che scorrono i 55 minuti complessivi della messinscena, dà luogo a una calibratissima progressione dinamica in cui si sviluppano tangenti trame di vita quotidiana, di relazioni interpersonali, e poi anche traiettorie sentimentali e cripto-sessuali plurime per input successivi che accelerano e tengono in tensione i corpi dei protagonisti. Mano mano è chiaro che l’ordine casalingo e della facciata social-borghese va a farsi benedire: irrompe il disordine delle pulsioni emotive, dei sensi e poi, pure, delle menti: un uomo in bilico sul vano della finestra sembra proprio voler fare un salto suicida; la specchiera delle ‘loro brame’ si tramuta in un’arma riflettente che rimbalza le luci accecanti dei proiettori, sventagliandole sul palco e pure in platea; il telo al suolo viene rigonfiato o stirato secondo un mortifero sudario. Come nell’operazione filmica, anche qui Kylián, in tutt’altri stile e maniera, sembra voler decostruire e parodizzare tutta una drammaturgia ottocentesca (ai già citati Cechov e Ibsen, potremmo aggiungere Strindberg) che mirava a disvelare quali abissi e inferni psico-comportamentali e coniugali e familiari si celassero dietro le forme composte e i paludati modi di autorappresentanza e le ipocrite ritualità della classe borghese dominante. Ma se il disegno è chiaro, la confezione teatrale impeccabile e l’esecuzione degli interpreti in tutto lodevole, nondimeno l’impressione terminale è, appunto, quella di un esercizio di stile fin troppo compiuto (e magari autocompiaciuto). Kylián sembra correre sul crinale di un ipermanierismo coreografico ‘alto’ e nobile, ma privo di reali prospettive sceniche, se non quelle di replicarsi secondo un mero tautologismo accademico. Allora, tutto sommato, molto meglio buttarla nella maniera comico-parodica alla Stanlio e Ollio, dove il riso risulta sempre liberatorio. 4 - Da parecchi anni le tivù e le radio locali della capitale sono martellate da un immobiliarista indigeno che ha tramutato il nome della sua impresa in un tormentone pubblicitario: “Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà”. Immobildream, la più recente pièce di Luca Archibugi (vista all’Atelier Meta-Teatro), sembra invece voler vendere, ossia darci a vedere, la solida irrealtà ovvero pure il ‘sogno immobile’ di quattro personaggi che sono, probabilmente, l’uno il doppio dell’altro. Autore da un quarto di secolo di commedie socio-sentimentali, lievi e ironiche, anche leggermente svitate e sversate sul côté borghese pariolino-romano che conosce come le sue tasche, Archibugi arriva 4 5 oggi a 50 anni a un’ulteriore dislocazione drammaturgica, pur in assoluta coerenza con la sua visione teatrale. Immobildream è un copione ameno e piacevole, perfettamente in bilico tra Ionesco e Achille Campanile, ossia tra una poetica dell’“Assurdo” particolarmente imperniata su bisticci e qui pro quo e lapsus semio-linguistici, e una situazione farsesca, para-demenziale, ma giocata in punta di dialogo da un quartetto di figurette psichicamente derealizzanti (quanto irrealizzate). Da una parte, c’è una coppia ‘uscente’. Vale a dire i coniugi Carlo e Sara (Almerica Schiavo e Antonio Mastellone) che, caduti in disgrazia economica, vengono sfrattati dal proprio signorile appartamento. Dall’altro, c’è una coppia ‘entrante’. Ossia Giulio e Irene (Mariano Aprea e Elisa Veronica Zucchi) che hanno acquistato la casa a prezzo vantaggioso e ci vanno sollecitamente ad abitare. Ma non hanno fatto i conti con i precedenti, irriducibili, tignosi proprietari che sono rimasti nei paraggi e provano (e trovano) tutti i modi per rientrare nella agognata maison. Si crea, così, un forzato connubio in cui si scopre che i mariti fanno la stessa professione, che le rispettive nonne avevano il medesimo nome, che le due mogli hanno in comune persino il medico che le tiene in cura – Sara ha disturbi, come dire, psico-motori e vagola senza costrutto; Irene confonde parole, pensieri e cose a un dipresso come L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks. Il medico, peraltro, si chiama Scardanelli e qui Archibugi si permette la citazione raffinata: essendo Scardanelli il nome con cui Friedrich Hölderlin, ammattito, invecchiato e rinchiuso nella ‘torre’ sul fiume Neckar, prese a firmare le sue ultime poesie. La citazione eteronimica non è solo uno sfoggio di cultura, ma mi pare il preciso indizio che in questa abitazione da tipico generone borghese capitolino avviene che, per slittamenti progressivi del disessere, le due bislacche coppie si riconoscano in sostanza intercambiabili, complementari, finendo per instaurare una sorta di implausibile, ma in fondo funzionale e speculare ménage à quatre in cui, in modi traslati e ‘abbassati’, si riproduce la convivenza schizo-poetica di Hölderlin con l’ombra del suo nominale doppio. Bisogna dire che di questo non c’è traccia nella regia, pure incisiva, di Alberto Di Stasio, il quale ha premuto invece il pedale del mero divertissement, della comedy ridevole, preferendo ornare lo spettacolo con citazioni para-cinefile. Almerica Schiavo drappeggiata in attillatissimo abito rossofiamma con spacco sexy non può non richiamare Marilyn Monroe in Niagara. Mastellone si sbrodola nelle sue stesse, lagnose chiacchiere e quindi si mostra in candida canotta, ma più che a un Marlon Brando dei poveri (do you remember Un tram che si chiama desiderio?), fa pensare a Umberto Bossi in tenuta burina in Costa Smeralda. La debuttante Veronica Zucchi, bionda e diafana come la Eva Marie Saint di North by Northwest di Hitchcock, ora in malizioso déshabillé domestico, ora in tenuta da fitness, appare sciroccata e mentalmente svampita come Sydne Rome in Che? di Polanski o Evan Rachel Wood nel più recente Woody Allen (Basta che funzioni). Il più concreto o meno svanito appare il niveocrinito Mariano Aprea che, secondo un Peter Falk d’antan e d’annata, cerca di tenere i piedi piantati per terra, di opporre ragionamenti razionali o, appena, di buon senso ai comportamenti e alle situazioni paradossali e derealizzanti che gli si propongono, finendo, regolarmente, per capitolare. Di Stasio, come detto, sostiene e sorveglia con cura la recitazione degli attori e gli dà un ritmo svelto e gradevole, soltanto il finale dello spettacolo, soffuso e sibillino, appare un po’ debole. Archibugi conferma la sua tempra di autore umorista borghese, con lampi surreali, che ne fanno un po’ un tardo epigono di Ennio Flaiano. Il quale, però, sinceramente, graffiava di più. Talora a sangue. novembre 2009 5
Scarica