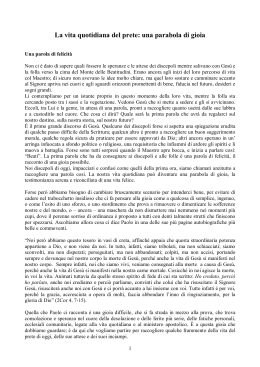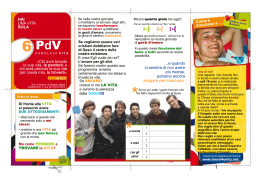La vita quotidiana del prete: una parabola di gioia Una parola di felicità Non ci è dato di sapere quali fossero le speranze e le attese dei discepoli mentre salivano con Gesù e la folla verso la cima del Monte delle Beatitudini. Erano ancora agli inizi del loro percorso di vita col Maestro; di sicuro non avevano le idee molto chiare, ma quel loro sostare e camminare accanto al Signore apriva nei cuori e agli sguardi orizzonti promettenti di bene, fiducia nel futuro, desideri e sogni grandi. Li contempliamo per un istante proprio in questo momento della loro vita, mentre la folla sta cercando posto tra i sassi e la vegetazione. Vedono Gesù che si mette a sedere e gli si avvicinano. Eccoli, tra Lui e la gente, in attesa di una parola, pronti a raccogliere quanto uscirà dalle sue labbra e a custodirlo nel cuore. Che cosa ci dirà? Quale sarà la prima parola che avrà da regalarci sul nostro destino, sulla nostra storia, sul nostro futuro? È il primo grande discorso di Gesù. Qualcuno dei discepoli forse si aspetta una spiegazione erudita di qualche passo difficile della Scrittura; qualcun altro è pronto a raccogliere un buon suggerimento morale, qualche regola sicura da praticare per essere approvati da Dio; altri ancora sperano in un’ arringa infuocata a sfondo politico o religioso, una requisitoria che infiammi di ardore gli spiriti e li muova a battaglia. Forse sono tutti sorpresi quando il Maestro apre bocca, e inizia a parlare così: “Beati”. La prima parola che ha da consegnare ai discepoli e alle folle è una parola di felicità, il racconto di una gioia possibile. Noi discepoli di oggi, impacciati e confusi come quelli della prima ora, siamo chiamati anzitutto a raccogliere una parola così. La nostra vita quotidiana può diventare una parabola di gioia, la testimonianza serena e riconciliata di una vita felice. Forse però abbiamo bisogno di cambiare bruscamente scenario per intenderci bene, per evitare di cadere nel trabocchetto insidioso che ci fa pensare alla gioia come a qualcosa di semplice, ingenuo, o come l’esito di uno sforzo, o uno stordimento che prova a rimuovere o dimenticare le sofferenze nostre e del mondo, o – ancora – una maschera da non dismettere mai nemmeno nei momenti più cupi, dove il perenne sorriso di ordinanza è proposto a tutti con denti talmente stretti che finiscono per spezzarsi. Ascoltiamo allora cosa ci dice Paolo in una delle sue più pagine autobiografiche più belle e commoventi. “Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l’inno di ringraziamento, per la gloria di Dio” (2Cor 4, 7-15). Quella che Paolo ci racconta è una gioia difficile, che si fa strada in mezzo alla prova, che trova consolazione e speranza nel cuore della desolazione e delle ferite più serie, delle fatiche personali, ecclesiali comunitarie, legate alla vita quotidiana e al ministero apostolico. È a questa gioia che dobbiamo guardare; è da qui che vogliamo partire per raccogliere qualche frammento della vita del prete di oggi, delle sue attese e dei suoi inciampi. 1 L’ipotesi da cui ci muoviamo, alla fine, è molto semplice. La diciamo nella maniera più diretta possibile: uno dei grandi problemi della chiesa di oggi è quello di avere ministri scontenti. Di che natura è questo disagio, questa linea sottile di infelicità? Non si tratta dell’inquietudine evangelica, che conduce, al contrario, ad operare generosamente pur portandosi addosso ogni giorno un diffuso senso di sproporzione; e neppure facciamo riferimento al triste bilancio che ci tocca tirare alla fine delle nostre giornate, e che ci porta a constatare quanto esili e fragili siano i risultati raggiunti dalla nostra azione proprio là dove avevamo profuso le energie migliori. Stiamo parlando di altro: di quel senso diffuso di infelicità, difficile da descrivere eppure quasi tangibile, nel quale si mescolano senza sosta tristezza, stanchezza, rabbia, paura, depressione, e che sovente attraversa la vita quotidiana del prete. Ricordo ancora con emozione un colloquio avuto ormai molti anni fa con un mio compagnio di ordinazione che aveva deciso di lasciare il ministero. All’inevitabile domanda che gli ponevo: “Perché?”, rispose semplicemente: “Perché non sono felice”. Tutte le spiegazioni che mi diede in seguito non furono che la declinazione di questo incontrovertibile assunto iniziale. Non poteva continuare ad essere prete perché nella vita e nel ministero non c’erano più tracce di gioia. Ne vediamo spesso di preti infelici. Non dico sofferenti, o malati, o in difficoltà, o in un momento di faticoso discernimento, o stanchi, o spossati. Dico proprio “infelici”. Figure rattrappite, irrisolte, scontente. Fanno tristezza, non sono più credibili, non esercitano nessun attrattiva. Ci si chiede come possano annunciare il vangelo, che per definizione è “buona notizia”, lieto messaggio per la vita. Li vedi rifugiarsi nel passato, o nascondersi nei loro “pallini” fatti passare per carismi, o crearsi un mondo a parte nel quale c’è posto soltanto per loro stessi, per qualche rarissimo amico, per due o tre interessi coltivati in maniera maniacale, in una sostanziale estraneazione dalla vita della gente. Quando non ci tocca assistere – come purtroppo capita – ad inspiegabili parabole di defigurazione… Tutti, credo, passiamo momenti così; tutti attraversiamo periodi di difficoltà nei quali sembrano prevalere stanchezze e delusioni, ed avvertiamo forte la tentazione di lasciar perdere e di andare lontano. E ci chiediamo: come ritrovare la gioia? Non l’entusiasmo un po’ ingenuo degli inizi, ma una gioia profonda, che sa fiorire in mezzo all’aridità dei deserti metropolitani o alla solitudine dei luoghi “dimenticati da Dio”, o nelle corse e rincorse tra una parrocchia e l’altra, inseguiti dalla gente che si lamenta perché “non ci siamo mai”. In questa “comunicazione nella fede” mi piacerebbe ritrovare e raccontare passaggi (o parabole) di felicità nel quotidiano della vita del prete. Un prete felice è un buon prete. La gente ci domanda anzitutto questo: un tratto di bellezza e di serenità, l’espressione naturale, non costruita, di una vita buona, che sa trovare la gioia senza per questo ignorare la fatica e la sofferenza dell’esistenza, che sa comunicare il vangelo con lo stile, il tratto, il modo di essere e di porsi, ancor prima che con la parola e l’azione, che rende credibile la buona notizia di Dio attraverso i segni inconfondibili della tranquillità interiore, della quiete, della fiducia. Rileggiamo in quest’ottica anche tutti gli ostacoli alla felicità del prete, che non sono soltanto legati al contesto in cui vive ed opera, ma anche allo stile con cui si pone e rimane nella vita quotidiana. Certo: a volte siamo sovrastati dall’eccesso di richieste, vittime di fraintendimenti, poco considerati o addirittura mal giudicati dalle persone che ci stanno a fianco. Facciamo fatica – non è un mistero – a vivere un buon rapporto con l’autorità, e ci può anche capitare di sentirci un po’ a disagio nella compagine ecclesiale; viviamo con un velato senso di sofferenza il rapporto con la chiesa “madre ed amica” quando ci mostra un volto non sempre affidabile e credibile, e ci sentiamo in conflitto con un mondo che ci capita di non riuscire a capire. Ma tutto questo può stare, sta, insieme ad una gioia profonda. La fatica del prete non è e non può essere il tutto della sua vita, la cifra attraverso cui rileggere la sua esperienza umana e cristiana. C’è dell’altro, c’è molto di più. 2 Proviamo allora a delineare qualche percorso di gioia possibile nella nostra esperienza di ministri ordinati. Possiamo indicare qualche pensiero semplice a partire dal basso, dall’esperienza quotidiana, dalla vita di tutti i giorni, nella quale si innestano e crescono la forza del vangelo e la grazia della salvezza che Dio ci vuole regalare. La gioia della riscoperta Una prima parabola che vorrei raccontare è quella della gioia della riscoperta. Vorrei proporvela a partire da un’esperienza molto semplice che ho condiviso lo scorso anno con la mia comunità cristiana. Non vivo in un quartiere tranquillo. C’è la confusione delle grandi città, un grande afflusso di stranieri e di irregolari, il disordine tipico delle cose lasciate un po’ andare. Spesso la gente si chiede “dove andremo a finire”, è tentata di cadere nella tristezza, nel disfattismo, di cedere alla tentazione del “si salvi chi può” o del “è tutto uno schifo”. Siamo partiti proprio da questo clima e da queste fatiche per giocare una scommessa con noi stessi. “Scommettiamo – ci siamo detti – che proprio in queste case e in queste strade ci sono molti segni di fede, di amore e di speranza che chiedono semplicemente di essere scoperti, accolti, raccolti?”. In molti hanno risposto ad un appello del Consiglio pastorale che si intitolava “Regaliamoci buone notizie”, ovvero: facciamo circolare il bene che già c’è, rendiamolo pubblico, raccontiamolo. Abbiamo collezionato più di 150 storie e un numero indefinibile di incoraggiamenti e di racconti orali. Li abbiamo ordinati e cuciti insieme, e li abbiamo restituiti alla comunità, a fine anno, nella forma di un semplice libretto da leggere e da regalare a tutti. Non crediamo di avere risolto i problemi della parrocchia, ma di sicuro è cambiato il clima, il modo di essere, di guardare fatti, avvenimenti, persone…. E non è poco. Mi pare di poter dire che è mutato anche l’approccio alle situazioni. A volte ci accostiamo agli “altri” al “mondo”, ai “lontani” (i termini vanno rigorosamente virgolettati: altri da chi? lontani da dove? non siamo anche noi “nel” mondo anche se non “del” mondo?) quasi animati dall’ansia della riconquista. Partiamo come per una guerra, una crociata per il bene del vangelo. E non riconquistiamo un bel niente. Alla fine restano soltanto i morti e i feriti, e le piaghe da leccare e da fasciare. E se provassimo a sostituire la sete della riconquista con la gioia della riscoperta? Se lasciassimo cadere una volta per tutte la preoccupazione di riportare il mondo intero nei nostri cammini ordinati e preordinati per scoprire con maggiore libertà i sentieri che lo Spirito ha già percorso nel cuore delle persone, e gioirne, e renderne grazie? Il Discorso della Montagna ci regala alcune parole di Gesù che non vanno disattese. Non dice prima di tutto “annunciate” o “fate”. Dirà anche questo, è chiaro, ma prima di ogni altra cosa ci suggerisce di mettere in pratica altri due verbi: “ascoltate” e “guardate”. È significativo che Gesù inviti a contemplare gli uccelli del cielo e i gigli del campo. Guardare gli uccelli significa far vagare i nostri occhi nello spazio per seguirne le traiettorie, gli spostamenti, i voli apparentemente senza direzione e senza meta. Chi segue le parabole disegnate dalle rondini in cielo impara a guardare largo, a vedere ampio, a rincorrerle nelle loro migrazioni da un paese all’altro, senza problemi di confini. Forse le nostre comunità sempre più aperte, sempre più “mondiali”, hanno bisogno di una contemplazione larga, non troppo incentrata sui propri problemi, attenta alle grandi aperture e ai grandi spazi del mondo. L’invito a guardare i gigli che crescono rappresenta la necessità di seguire le cose nello scorrere del tempo. Un fiore non sboccia dal nulla, in una frazione di secondo. C’è voluta tutta la pazienza di chi l’ha seminato, piantato, irrigato, esposto al sole, prima che appaia in tutta la sua grazia e la sua bellezza. Abbiamo bisogno di recuperare il senso della storia e della distanza del tempo. Nell’epoca del “tutto e subito” questo rappresenta uno sforzo ascetico non da poco. Tendenzialmente bruciamo le nostre iniziative con fretta inopportuna, non abbiamo né la pazienza di attendere né la saggezza di contemplare i cambiamenti della chiesa, del mondo, delle nostre comunità sui tempi lunghi. Viviamo tra inutili nostalgie del passato e frenetiche corse verso il futuro, e non ci rendiamo mai 3 conto dell’importanza della storia e del suo scorrere naturale, del suo progredire anche tra contraddizioni e battute di arresto. Non siamo i primi, e forse non saremo gli ultimi a vivere nella chiesa, questa istituzione “non vecchia ma antica” (Paolo VI), sempre bisognosa di essere riformata e cambiata. Della sua storia di fede e peccato noi siamo un segmento soltanto: sarebbe un errore colossale pensare (e vivere) come se fossimo i primi, gli ultimi, gli unici… e di conseguenza i migliori! Davvero il Signore ci insegna la gioia della riscoperta attraverso la guarigione dello sguardo; ci propone un nuovo modo di vedere le cose che è autenticamente evangelico, e ci rende felici. Ho ritrovato qualche tempo fa una notizia che all’epoca mi aveva molto colpito. Al primo scudetto del Napoli, la città intera esplose in una festa memorabile, attesa da decenni. Impossibile descrivere il clima di euforia, quasi di estasi, che attraversò tutte le vie, le piazze, le strade. Alcuni tifosi partenopei, con un grandioso colpo di genio, affissero fuori del camposanto generale della città uno striscione: “Guagliò, che vi siete persi!”. Il momento di gioia era così forte che anche i cari ormai defunti dovevano in qualche modo esserne partecipi. Con quella scritta i tifosi misero il sigillo ad un amore mai dimenticato per coloro che non c'erano più, coinvolgendoli nel tripudio generale. Questo episodio, a suo modo, è una piccola parabola evangelica. Forse la parola di Dio va annunciata così, sulla scorta di una gioia ritrovata, ritenuta quasi impossibile, che ti fa dire alla fine “guagliò, che ti sei perso!” a chi non ha potuto esultare con te, a chi non c’è alla nostra festa, a chi se n’è andato troppo presto. Niente di più distante – a guardar bene – dall’affanno nervoso che segna le opere di una riconquista impossibile. Cosa ci siamo persi anche noi? Perché abbiamo dimenticato la gioia? Il senso del gratuito Parto ancora dal basso, da due episodi concreti, per introdurre un secondo tema, quello legato al senso del gratuito. Il primo. È l’ultima sera del corso per i fidanzati, in preparazione al matrimonio. Il clima è quello giusto. Abbiamo discusso e pregato insieme; l’ascolto del testo delle nozze di Cana e la lettura delle parole del consenso hanno commosso i cuori più sensibili; la cena autogestita è ricca, quasi sontuosa, e il vino abbondante contribuisce non poco a sciogliere gli spiriti. Poi tutto finisce. Con le coppie guida del corso riordiniamo la sala, ci dividiamo le tonnellate di cibo avanzato, raccogliamo le schede di valutazione del corso, sulle quali i fidanzati hanno espresso il loro parere sull’andamento delle serate. Grazie a Dio anche quest’anno le cose sembrano essere andate bene. Spegniamo le luci, chiudiamo le porte. “E adesso?”, ci chiediamo, un pochino smarriti. Ogni anno è così. Si sposano e vanno ad abitare chissà dove. Quelli che rimangono li vedi per lo più due o tre mesi poi spariscono, risucchiati dalle preoccupazioni per il lavoro, il mutuo da pagare, i preparativi per le nozze, il figlio in arrivo… Ti salutano con grande affetto, ti invitano a cena… e ripiombano nell’anonimato, lontani di nuovo dalla comunità cristiana e apparentemente anche da quei percorsi di fede che avevano riaperto con grande entusiasmo. Ne vale la pena? Seconda cena. Messa vespertina di un giorno feriale. Sta celebrando un prete molto anziano che legge a fatica il testo del vangelo. Nella navata semibuia conto non più di dodici persone, tutte sopra gli ottant’anni. La signora che sale a proclamare la preghiera dei fedeli inciampa nella dizione perfino sulle virgole, e non si capisce se balbetti o se stia leggendo traducendo in diretta da una lingua straniera. Allo scambio della pace i fedeli percorrono chilometri, perché il fratello o la sorella più vicina si trovano cinque panche avanti o due indietro. Il canto alla comunione si interrompe a metà, quando l’unica signora che prova a sostenere l’assemblea va all’altare a ricevere la particola e smette di salmodiare. Un senso di sconfitta, di fallimento, di qualcosa che va a morire. Ne vale la pena? 4 Due esempi. Ma quanti ce ne sarebbero ancora? Quante volte al termine di un’eucaristia, di un’assemblea, di un incontro, ci siamo sentiti travolgere da un’ondata cupa di sfiducia, da un opprimente senso di inutilità o di sconfitta? Certo, in tutto questo gioca dentro di noi una parte umana, troppo umana. È normale gioire per una buona partecipazione o per la riuscita di un’iniziativa o di un incontro. È altrettanto logico patire una delusione se le cose non sono andate secondo le aspettative. Ma forse c’è dell’altro. Forse siamo fin troppo divorati dall’ansia del risultato. I vecchi e saggi padri spirituali non mancavano di ricordarci che perfino Gesù ne ha convertiti pochi, e quei pochi alla fine sono scappati o hanno tradito. Ma nonostante questo dato, che dovrebbe farci riflettere e un pochino rasserenare, non ce la facciamo a non ragionare in termini di efficienza, riuscita, crescita, risultati. Per ogni iniziativa le domande fatidiche sono sempre: “quanta gente c’era?”, “cosa abbiamo portato a casa?”, “quanto abbiamo guadagnato?”. Forse dietro questa angoscia da prestazione non ci sta tanto la passione evangelica quanto il nostro orgoglio di uomini. E allora non siamo più tanto disposti a credere (come suggeriva Giuseppe Dossetti) che anche l’eucaristia più scalcinata salva la città; allora non ci viene da pensare che i germi di bene seminati in un percorso di preparazione al matrimonio hanno bisogno di anni per crescere e dar frutto. Non riconosciamo volentieri che vale la pena lavorare senza risparmio anche per chi - lo sappiamo - non entrerà mai nella nostra orbita perché già in fase di trasloco, o di passaggio, o perché interessato soltanto a quale breve momento in cui lo intercettiamo: un lutto, una nascita, un problema da risolvere… Mi chiedo spesso: in che cosa faccio consistere la buona riuscita di un incontro, di un convegno, di una proposta? E la risposta che mi viene più spesso è questa. È venuto bene se è passata un po’ della grazia di Dio. Della grazia, cioè della gratuità di Dio, del suo lavorare in perdita, del suo spendersi senza chiedere nulla in cambio. Saremmo, io credo, preti più felici se imparassimo a lavorare gratis. Non parlo della dovuta retribuzione, visto che bisogna pur mangiare e che “l’operaio ha diritto alla sua mercede”, quanto di uno stile che di per se stesso racconta il vangelo. Tornano alla mente, ancora una volta, le parole del discorso della montagna: quando digiunate, pregate, fate l’elemosina, fatelo senza farvi vedere, nel segreto. O ancora: non invitare a cena chi ti può invitare a sua volta, e a chi ti chiede il mantello dà anche la tunica. Se fate del bene solo perché sperate di riceverne che merito ne avrete? Su questo versante avremmo bisogno di una maggiore libertà. Siamo tentati spesso di valutare il nostro operato a partire dai risultati (così difficili da decifrare!) e ci preoccupiamo troppo poco della nostra vita di fede, della nostra crescita umana, del tratto amabile con cui ci possiamo porre in relazione con l’altro. Badiamo a non scontentare la gente, anche a costo di compromessi meschini e di contraddizioni inquietanti nel nostro agire (“perché se no se ne vanno”); difendiamo ad ogni costo (soprattutto nei confronti dell’autorità) un profilo che intende essere vincente, magari nascondendo qualche magagna di troppo. Poi, quando scopriamo che si può essere un po’ più liberi, che non è necessario sentirci sempre sotto esame, che è possibile lavorare in perdita lasciando a Dio il compito di portare a termine le nostre opere generosamente imperfette, troviamo un equilibrio diverso, ci rilassiamo, siamo più felici. Il prete che se la prende coi pochi fedeli rimasti perché in tanti disertano gli appuntamenti parrocchiali, ottiene come effetto immediato quello di perdere ulteriori consensi. Il prete che lavora sereno, magari tenendo presente anche chi non verrà mai in parrocchia, sembra altrettanto inefficace, ma in realtà agisce secondo il vangelo, e può dormire sonni tranquilli anche se “non ha portato a casa niente”, anche se qualcuno lo considera un fallito. Dio probabilmente ha un'altra maniera di fare i conti e di considerare l’efficacia dell’agire dell’uomo. 5 La libertà dell’essenziale Saverio Xeres, storico della chiesa, in un suo testo emblematicamente intitolato “Manca il respiro”, analizza con spietata lucidità i cammini (e le possibili involuzioni) della chiesa italiana del postconcilio. Due passaggi in particolare, meritano di essere ripresi in questa sede: il primo riguarda i “piani pastorali”, il secondo il moltiplicarsi delle strutture. “[Spesso in una diocesi] il piano pastorale assorbe in sé e supplisce qualunque altra iniziativa. Anzi, tali documenti diventano una sorta di “feticcio” per cui nessun discorso potrà più prescinderne, anzi si redigeranno sussidi per la loro interpretazione e “traduzione”, si svilupperanno trattazioni più o meno complesse per definire il collegamento tra questi piani e altri precedenti o contemporanei; infine, di lì a qualche anno se ne pubblicheranno antologie o raccolte più o meno encomiastiche… Ancora, mentre la comunità locale (ossia praticamente i laici con il clero “inferiore”) è intenta all’ “attuazione” del piano pastorale, il vescovo e i suoi collaboratori – responsabili di uffici diocesani, professori del seminario, forse anche qualche laico “scelto” (ossia attentamente selezionato, spesso secondo criteri di malleabilità) – sono già alle prese con la stesura del piano dell’anno successivo, e così sarà l’anno (o il triennio) che verrà… Nessuno si aspetta di vedere se e come abbia “funzionato” il piano precedente: si sa, le scadenze, i tempi redazionali e tipografici non lasciano molta tregua…”. “La moltiplicazione delle strutture burocratiche locali dipende direttamente dall’ingrandimento della “macchina” centrale, dal momento che ogni ufficio nazionale esige di avere un corrispettivo in ambito diocesano che recepisca e traduca localmente le linee assunte in sede romana. Le sedi periferiche devono fornirsi di strutture almeno minimali per poter recepire e attuare in loco le iniziative nazionali: un impegno questo non sempre realizzabile per diocesi sempre più carenti di clero e non sufficientemente provviste di risorse economiche. Particolarmente a rischio, in questo senso, è la pastorale giovanile, quella che ci si aspetterebbe come la più aperta e fantasiosa. Quanto più calano i giovani raggiunti dall’azione ecclesiale, tanto più aumentano gli uffici, le organizzazioni, le commissioni: esse, peraltro, assorbono buona parte degli stessi giovani disponibili. Pertanto, le diverse attività formative, caritative ecc. rischiano di ridursi alla pura organizzazione di iniziative che non raggiungono se non gli stessi che le hanno organizzate. Avviene così spesso anche nelle associazioni: ci si ritrova talmente in pochi che si riesce, con quei pochi, giusto a coprire i “quadri” associativi”. Sicuramente molto dura, questa requisitoria; ha il merito, ad ogni buon conto, di mettere il dito nella piaga. Siamo di fronte ad un’azione pastorale che tende ad irrigidire l’aspetto strutturale e corre il rischio di perdere l’essenziale. A furia di programmi e progetti pastorali, di organigrammi e strutturazioni, di strategie e pianificazioni, stiamo perdendo di vista ciò che conta davvero. Come ritrovarne la bellezza? Siamo soffocati da un’infinità di urgenze: tutto sembra diventato indifferenziatamente decisivo, centrale, irrinunciabile.. Qualche anno fa a Milano il Cardinal Tettamanzi propose in una sua lettera di sospendere qualche iniziativa e di “fare meno” per imparare a “fare meglio e insieme”. Un’ottima idea, smentita (non me ne voglia il mio vescovo emerito) da un piano pastorale gonfio di adempimenti del tutto sproporzionati anche rispetto alla forza delle comunità parrocchiali più vive e in salute. Eppure gran parte dell’arte e della cura pastorale consiste proprio in questo: nel saper distinguere l’accessorio dall’essenziale. Anche Gesù nel vangelo non ci appare come uno che fa tutto, che dà risposte a tutto. Qualche volta elude le domande; in altre circostanze non guarisce tutti ma solo alcuni dei malati che gli vengono presentati… Perfino lui che deve salvare il mondo “lascia indietro” del lavoro da fare. 6 Come venire incontro – allora – a questa esigenza di essenzialità? Quali scelte operare? Dobbiamo ammettere di non avere tante risposte a disposizione. Certo c’è un discernimento feriale, puntuale, da attuare volta per volta, possibilmente non da soli. Però credo che almeno tre criteri li possiamo identificare. Il primo è quello di imparare a dire dei no. Che significa anche sopportare di essere deludenti, di non corrispondere alle aspettative della gente, e quindi di non avere sempre soltanto ritorni positivi rispetto alle nostre azioni e alle nostre scelte. Mi raccontava un amico prete, da poco parroco in una grossa comunità: “Il mio predecessore era un uomo buonissimo, spontaneo, quasi disarmato. Non ce la faceva a dire di no a nessuno. La gente gli voleva molto bene, ma poco alla volta la situazione in parrocchia era diventata ingestibile, e si viveva in una confusione totale. Io ora sto deludendo le attese di molti: alcune sono decisamente fuorviate, quasi incomprensibili, altre sensate e profonde. Dire di no alle prime mi costa fatica, ma è questione di pochi minuti, perché so di fare una buona opera di bonifica. Quando invece mi tocca rimandare o rinviare al mittente una richiesta di cui percepisco la bontà, ma che non posso sostenere, vivo il mio rifiuto come un dramma, un fallimento, anche se so di non poter fare diversamente”. In altre parole: non tutto ciò che è buono è opportuno, o lo è sempre, in ogni circostanza. Alla fine è più sensato entrare nella logica di chi riconosce a malincuore i limiti propri e della comunità e lascia che non tutto sia a posto o ben definito, piuttosto che cadere sotto il peso insostenibile di troppe richieste e di infiniti adempimenti che costringono sacerdoti e laici a sforzi titanici, e quindi di loro stessa natura fallimentari. La seconda scelta è quella di scommettere su mezzi poveri, di credere nell’efficacia della povertà dei mezzi. Spesso ci capita di pensare che dobbiamo ad ogni costo essere rilevanti, e iniziamo ad agire di conseguenza cercando di accaparrarci privilegi, di avere a disposizione mezzi sofisticati, o strutture ultramoderne, o portafogli sempre più gonfi, o amicizie potenti. Di fatto non è raro vedere in quanto poco tempo declinino le nostre proprietà faraoniche, e la storia ha dimostrato che non serve a nulla mettersi in competizione con “altri” per avere le cose “nostre”, cioè buone, benedette, sicure, sante, garantite (almeno così pensiamo…). Non è un’idea particolarmente geniale, né tantomeno evangelica, quella di agire per soppiantare la concorrenza anzichè per maturare una collaborazione. E può rivelarsi rischioso – o addirittura rovinoso – scommettere sulla forza dei nostro apparati anziché su quella della parola. Rileggo spesso con gusto questo brano tratto dal Primo libro di Samuele. “Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d’animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo Filisteo». Saul rispose a Davide: «Tu non puoi andare contro questo Filisteo a combattere con lui: tu sei un ragazzo e costui è uomo d’armi fin dalla sua adolescenza». Ma Davide disse a Saul: […] «Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell’orso, mi libererà anche dalle mani di questo Filisteo». Saul rispose a Davide: «Ebbene va’ e il Signore sia con te». Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e lo rivestì della corazza. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l’armatura e cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con tutto questo, perché non sono abituato». E Davide se ne liberò. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella bisaccia; prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo”. Sappiamo tutti come va a finire la storia. Davide abbatte il gigante Golia con la fionda e un sasso. Cinque sassi erano addirittura troppi; ne bastava uno, poteva fare a meno di prendere gli altri quattro. Mi chiedo se è proprio vero l’assunto che recita: “con meno cose a disposizione si è meno efficaci”. Magari è vero il contrario: si diventa più essenziali e più felici. 7 Terza e ultima scelta. Ciò che chiamiamo “l’essenziale”, non riguarda soltanto la vita nella e della chiesa. Non si tratta solo di custodire la centralità dell’eucaristia, il primato della parola, l’esercizio generoso della carità; si tratta di scegliere ciò che conta anche nella propria personale esistenza. O – detto in altri termini – è importante che un prete impari a prendersi cura di sé. La cura spirituale, anzitutto. Mi sorprende – ad esempio – e mi rattrista rilevare il fatto che molti sacerdoti non abbiano una guida spirituale. Non credo sia possibile la custodia dell’essenziale senza un buon accompagnatore, un compagno di strada maturo e paziente che accetti di percorrere insieme un tratto di cammino suggerendo, consigliando, incoraggiando, rimproverando se è il caso. Ma fa parte della cura spirituale anche la difesa dei tempi di preghiera, di aggiornamento, di studio. Questa necessità ce la sentiamo ribadire spesso, in contesti diversi: forse perché non è ancora entrata nella prassi e nel cuore. Non esiste però soltanto una cura spirituale in senso stretto. C’è uno stile di vita che va custodito anche riguardo agli aspetti fondamentali dell’esistenza quotidiana: il cibo, il riposo, il tempo libero. Arriviamo da una tradizione nella quale la cura di sé veniva frettolosamente archiviata come “tempo sottratto all’apostolato”. Io credo invece che col dovuto senso della misura, badando che la cura non diventi preoccupazione o addirittura ossessione riguardo alle proprie esigenze, occorra riaprire questo capitolo della vita del prete. I tempi vuoti dell’agenda, a volte, sono i più preziosi, i più necessari. Mi è sempre rimasta impressa la lettera che ci consegnò l’allora vicario generale della diocesi di Milano Mons. Renato Corti nel giorno in cui – da preti novelli – ricevemmo la prima destinazione. Si intitolava “Abbi cura di te stesso”. Letta e spiegata da un uomo tanto austero, dal marcato tratto spirituale e oserei dire ascetico, proprio nel momento in cui ci saremmo aspettati un discorso sull’importanza del buttarsi nella mischia e dello spendersi nell’apostolato, mi provoco un’emozione straordinaria. Sono tornato spesso, nel corso degli anni, ai suggerimenti che conteneva, senza riuscire quasi mai a metterli in pratica, segno che non è così facile convertirsi alla lezione della quiete e del riposo. La grazia della fraternità Un quarto passaggio per ritrovare la gioia nel ministero: riscoprire la grazia della fraternità. Anche in questo caso vorrei partire da un’esperienza buona, positiva, che mi è stata data di vivere ormai da più di un decennio: la vita comune con altri preti. Non ne voglio parlare a lungo, magari scadendo nel retorico o nel celebrativo. Mi basta accennarlo: mi fa bene condividere ogni giorno spazi di preghiera, di confronto, di programmazione pastorale, di vita domestica con altri preti. Quanto più la vita diviene dispersiva, tanto più servono luoghi di raccolta. Proprio su questo termine, “raccolta”, mi vorrei fermare. La vita fraterna può divenire spazio di raccolta nel senso più ovvio del “raccoglimento”. Non è per nulla banale, ad esempio, poter condividere la preghiera del mattino con un altro sacerdote, o leggere e meditare con lui la parola di Dio della domenica successiva, o decidere lo spazio di una mezza giornata di ritiro da vivere insieme. Questi momenti, magari anche molto compressi nel tempo, hanno in sé la forza di rigenerare, di ridare un po’ di freschezza ad un ministero esposto all’usura e alla fatica. “Raccolta” anche nel senso di raccattare, di rimettere insieme i pezzi. Ci sarà capitato, credo, di cercare un fratello per uno sfogo, una telefonata serale, una confessione… quando si sprofonda in baratri di tristezza e di malcontento, la vita fraterna si rivela una risorsa di valore inestimabile. Anche se il fratello non può far molto per te, comunque “c’è”, è presente. Ti raccoglie, ti tiene insieme. 8 Ma c’è un altro senso di “raccolta” che non ci deve sfuggire. Il tempo della raccolta è il tempo della pienezza, della mietitura, dell’abbondanza. La vita fraterna può diventare anche questo: un tempo in cui si sperimentano il centuplo, la ricchezza dell’esistenza, la bellezza e la gioia. Lo si scopre magari anche attraverso piccole cose, come la condivisione di qualche spazio di vita domestica, la gratuità di un po’ di tempo “perso” insieme, la scioltezza del genere medio del discorso che prende le distanze con leggerezza sia dalla vacuità delle conversazioni inutili sia dalla rigidità dei discorsi “impegnati”. Quella del comunicare, d’altra parte, è una delle grandi risorse che ci viene messa a disposizione dal ministero. I tempi sempre più esigenti del lavoro pastorale e una certa ansia del fare che caratterizza la nostra azione ci portano a dimenticare che non possiamo mantenere un profilo strettamente funzionale nelle nostre relazioni, tanto meno nelle relazioni fraterne. Non ci sono solo le scadenze del calendario o le questioni pratiche da mettere in comune nel dialogo tra preti, come se la cura pastorale fosse una gigantesca scatola piena di avvisi, ordini del giorno, verbali, scadenziari e locandine da esporre in bacheca. Si può anche parlare d’altro. C’è tutto un mondo di fede, di vita, di affetti che chiede di essere fatto circolare, che rende ricco chi lo racconta e chi lo accoglie come regalo. Amo ricordare spesso - quando ne ho l’occasione - che l’ascolto condiviso della parola di Dio con altri preti è stata una delle grazie più feconde del mio ministero. Così come, più di una volta, mi è capitato di sperimentare in profondità la forza misteriosa di fragilità che si sostengono a vicenda, di percorrere tratti di strada a stretto contatto con un fratello debole come me, povero come me e di scoprire che le nostre fragilità erano in grado di sorreggersi una con l’altra. Come, non riuscivamo a capirlo, ma sentivamo che era vero così. E se questa grazia della fraternità è così importante, perché praticarla solo tra preti? Con tutta la delicatezza e l’attenzione necessaria occorre che lo diventi anche nei rapporti con i laici, le famiglie, quel mondo affascinante e spesso sconosciuto che è legato alla presenza di figure femminili a nostro fianco. Forse abbiamo ancora un po’ paura a parlarne; forse siamo ancora ancorati ad un timore che non è segno di una saggia prudenza ma di uno stagnante e sterile distacco. Abbiamo bisogno di sciogliere il sospetto che spesso fa pensare che prete ed affetti debbano andare in direzioni opposte, che la freddezza – vera o ostentata che sia – possa essere annoverata tra le virtù che rendono il prete sicuro, fedele, irreprensibile. Si sente spesso dire, e a ragione, che non abbiamo bisogno di mezze figure di preti, ma di figure solide, di uomini “tutti di un pezzo”. Verissimo. Talmente vero che mi viene da aggiungere subito: se a un prete mancano gli affetti, manca un pezzo, e un pezzo importante della sua vita. Allora sarà anche “tutto di un pezzo”, ma senza affetti non sarà “tutto”, perché avrà eliminato e cancellato una parte di sé, rimarrà una persona dall’umanità incompiuta. E al proposito non abbiamo la necessità di scomodare il magistero conciliare e le encicliche papali per comprendere quanto poco possa parlare del Regno di Dio e possa viverne l’attesa un uomo incompleto, insicuro, che si trincera dietro freddezze e durezze incomprensibili, che sa soltanto praticare la pur nobile arte della fuga tutte le volte in cui viene chiamato in causa il mondo degli affetti. In realtà se andiamo all’inizio, meglio sarebbe dire alla Genesi, alla creazione, incontriamo un Dio agli occhi del quale tutto è buono, tutto è bello. Ad un certo punto qualcosa – però – lo fa dissentire, gli fa dire che “non è bene”. Ciò che non va non è qualcosa creato da lui, che gli è uscito male dalle mani. Ciò che non va è una condizione di vita, un modo di stare nel mondo: “Non è bene che l’uomo sia solo”. Ciò che non va è la solitudine, la mancanza di relazioni profonde, di affetti significativi, di legami. Vivere così è tradire l’opera della creazione. La vita in questo senso è piena di tentativi buoni ma insufficienti. L’uomo cerca qualcosa di più rispetto alla bellezza del creato, 9 della natura, degli animali. Ha bisogno di un aiuto che gli sia simile, di qualcosa che deve ferirlo nella carne (così avviene la creazione della donna), che deve essere “suo”, non nel senso del possesso, ma di qualcosa che esce da lui. “Non è bene che l’uomo sia solo” è parola che riguarda Adamo, l’uomo così com’è. Qualche volta abbiamo dimenticato che una parola così è rivolta anche a chi – pur pensandosi e desiderandosi celibe per il Regno – non può pensare di vivere solo, di fare del distacco e della freddezza una virtù. Un ultimo accenno, all’interno di questo lungo capitolo sulla fraternità lo vorrei riservare alla necessità di trovare qualche luogo di elaborazione di idee, di confronto e di pensiero comune. Spesso iniziamo i nostri incontri del clero con la preoccupazione di essere immediatamente operativi; questo ci porta a compiere scelte frettolose, non ragionate a sufficienza, e di conseguenza inefficaci. Sembra che ci faccia paura il ragionare libero, leggero, senza un’immediata finalità produttiva. E sbagliamo. Ricordo ancora oggi, al proposito, due lezioni di vita che ho ricevuto nei primi anni di ordinazione. La prima mi venne dal mio rettore di seminario. In uno dei nostri ultimi colloqui gli avevo manifestato un po’ di timore riguardo alla scelta delle mie letture. Niente di scandaloso, intendiamoci, ma percepivo che l’attrazione per la letteratura e la poesia spesso mi portava a mettere in secondo piano lo studio della liturgia e del diritto canonico. Il mio rettore mi disse chiaro e netto che avrei fatto malissimo a scegliermi le letture soltanto in un’ottica funzionale allo studio, al superamento degli esami, alla preparazione di qualche omelia o di un incontro di preghiera o di un cammino catechistico degli adolescenti. E mi invitò - col senso della misura - a lasciarmi attrarre e ferire spesso dalla bellezza del linguaggio, dalla forza evocativa delle immagini, dalla libertà delle letture “inutili”. Mi sono accorto con il passare del tempo di quanto bene abbia fatto a me e ai miei fratelli avere ascoltato il suo consiglio. E mi accorgo ancora oggi quanto bene mi fa ascoltare di gusto il racconto degli amici che mi spiegano un quadro, mi regalano l’ascolto di una buona musica, mi stupiscono per la loro capacità di rendere piene di poesia anche le cose più pratiche cui si dedicano con passione: le piante sul terrazzo, l’oggetto di legno intagliato con pazienza, il pezzo meccanico lavorato con cura al tornio. L’altra lezione mi venne dal mio primo vicario episcopale di zona. Un giorno mi convocò insieme ad altri cinque o sei giovani preti, e ci disse: “trovatevi tra di voi una volta al mese. Ma non trovatevi per fare altre iniziative, che ne tirate in piedi già troppe. Trovatevi a pensare. Mettete insieme i problemi che avete, raccontatevi qualcosa di bello, provate a sognare qualche itinerario per i vostri giovani anche se sapete che non avrete mai né le forze né le persone per condurlo a buon fine. Immaginate e pensate. E invitate anche me, così almeno imparo qualcosa”. Poche altre persone mi hanno parlato con questa libertà e con questa franchezza. E a proposito di franchezza, credo che ce ne voglia molta perché la fraternità possa dirsi vera. Una franchezza che passa attraverso la grazia difficile della correzione fraterna e che sa ribadire il diritto al dissenso, che non mi risulta sia stato ancora cancellato dallo stato italiano né dalla chiesa cattolica. Siamo davvero fratelli se impariamo anche a dissentire, ad esprimere senza paura disponibili comunque all’obbedienza - il nostro parere anche di fronte al vescovo, a segnalare quanto non comprendiamo o non condividiamo nelle scelte della nostra chiesa e dei nostri pastori. Non vogliamo essere i “bastian contrari”, e men che meno cavalcare la polemica facile, magari per ritagliarci qualche angolo di notorietà. Ma non vogliamo nemmeno rinunciare alla possibilità del contraddittorio, alla messa in comune delle idee, che è sempre ricchezza anche se spesso scomoda. Alla nostra chiesa non può far male un po’ di coraggio e di franchezza, la capacità di dire quello che si pensa senza parlare alle spalle, la rinuncia ai toni esageratamente encomiastici o celebrativi, la 10 volontà di confronto che qualche volta può diventare scontro acceso, anche se sempre in termini civili. Tutto perchè la parola corra, e non resti incatenata. La forza del Vangelo Ecco: perché la parola corra. Vorrei concludere parlando della forza del vangelo. Se c’è qualcosa che fa davvero bene alla vita del prete, e che gli fa bene sempre, è tornare alla bellezza e alla ricchezza della parola. E’ parola da raccontare e da accogliere, da regalare nei momenti di felicità e a cui aggrapparsi nella desolazione. C’è una pagina, tra le tante, che mi sembra opportuno rileggere in questo contesto: poche righe che ci ridanno fiducia, capaci di spazzare in un istante le nostre ansie e le nostre paure. “Così è il regno di Dio: come un uomo che abbia gettato il seme in terra, e poi dorme e veglia, di notte e di giorno, mentre il seme germina e si sviluppa, senza che egli sappia come. La terra da sé produce prima l’erba, poi la spiga e poi nella spiga il grano pieno. Quando, infine, il frutto lo permette, subito si mette mano alla falce perché è giunta la mietitura”. (Mc 4, 26-29) Come vivere la logica del seme oggi? Innanzitutto fiduciosi perché il Regno viene e noi possiamo soltanto accoglierlo. C’è una frase che ci viene spesso da ripetere, in diverse circostanze: “non c’è niente da fare!”. La dovremmo ripetere spesso, dandole però un duplice significato. Da una parte per riconoscere che ci sono situazioni non rimediabili, che non hanno soluzioni, rispetto alle quali non si può far nulla se non restare solidali nel dolore e nella fatica; dall’altra per ritrovare la pazienza del contadino che dice “ora attendo”, e frena l’impeto di uno zelo malposto che lo porta ad affrettare inutilmente le cose, a non fidarsi della forza del seme che cresce sottoterra, nell’inevidenza e nel silenzio. Possiamo imparare a stare accanto alle persone senza pensare di avere la soluzione dei loro problemi (e dei nostri) e a farlo con dolcezza e rispetto, senza forzare nulla, senza cadere nella frustrazione di chi non trova vie d’uscita e senza affrettare decisioni avventate, anche se spesso facciamo più fatica ad attendere che a lavorare. Ricordiamoci che non siamo noi ad operare il miracolo della crescita del seme, ma che dobbiamo soltanto farci trovare pronti al momento della mietitura, quando il frutto chiama per essere raccolto. Questa stessa parola, che cresce da sola, la possiamo rileggere e ricomprendere ogni giorno per e con la nostra gente. Scrive Gregorio Magno: “So [...] che per lo più molte cose nella sacra Scrittura, che da solo non sono riuscito a capire, le ho capite mettendomi di fronte ai miei fratelli [...] per voi imparo ciò che in mezzo a voi insegno; perché - è la verità - per lo più ascolto con voi ciò che dico”. Un prete felice - forse - è proprio così: un uomo che di continuo assiste alla gioiosa rincorsa tra la parola e la vita, e mentre si immerge nei fantasmi e nelle paure dell’esistenza della gente riscopre i propri, e impara a non temerli più perché si fida della forza di Dio e si sente in buona compagnia. Tutto questo nell’eucaristia si fa gesto e gratitudine, e diventa lode. Alla fine vale per il prete ciò che vale per ogni uomo: la fede è una questione di gratitudine e la vita ci è data per imparare a dire grazie col cuore. Possono togliere tutto alla chiesa ma non possono toglierle il suo Signore, la sua presenza, la sua parola, il suo corpo. Da lì ricomincia il prete: dalla parola che sta al principio, dall’eucaristia che sta al centro, dalla gente da incontrare e servire. Fino a quando sarò in grado di accogliere con gratitudine il dono della parola e di rendere grazie al signore nell’eucaristia, fino a quando nella chiesa qualcuno lo farà per me e con me non sarò perduto. C’è un bellissimo racconto della sapienza chassidica che dice così. “Rabbi Sussja non aveva mai ascoltato fino in fondo un discorso del suo maestro. Perché al principio del discorso, quando il maestro leggeva il passo della Scrittura ‘E Dio disse’. Rabbi Sussja era subito rapito fuori di sé, e 11 gridava, e si muoveva così selvaggiamente che disturbava la tavolata e bisognava condurlo fuori. Allora stava nell’ingresso o nella legnaia, batteva contro le pareti e gridava: ‘E Dio disse!’. Si calmava soltanto quando il maestro cessava di spiegare la scrittura. Così è avvenuto che egli non conoscesse i discorsi del maestro. Ma la verità è questa: quando uno parla in spirito di verità e un altro accoglie in spirito di verità, allora basta una sola parola, con una sola parola si può sollevare il mondo, con una sola parola si può riscattare il mondo”. Ci può far sorridere l’immagine di questo rabbi che impazzisce all’idea che “Dio disse”. Ma vorrei che potessimo ricominciare da qui. Da questa parola che diamo forse troppo per scontata, che non ci meraviglia più e non ci sorprende più come vorremmo ma che non ha perso nulla col passare dei secoli della sua forza originaria. Dio dice, Dio parla ancora. Non è forse un miracolo? Non è forse ciò che di più prezioso stringiamo tra le mani? Ogni giorno nell’eucaristia celebriamo il mistero della nostra salvezza, della salvezza della nostra vita e di tante vite abbruttite, disperate, alla deriva. E poco prima di ricevere il corpo del Signore, ci facciamo prestare le parole da un pagano, che insegna la fede e ci suggerisce di dire così. “signore, non sono degno… ma di’ solo una parola e io sarò salvato”. Ecco: quando la nostra vita ci sembra spenta, o ci pare perduta, il Signore ci regala una parola e un segno a cui aggrapparci. E a questo segno, a questa parola, si attaccano tutti gli uomini e le donne in mezzo ai quali Dio ci fa vivere. Nelle temperie dell’esistenza, nei suoi possibili approdi e nei temuti naufragi, nella rabbia di giornate in tempesta, nello smarrimento di navigazioni senza direzione, sappiamo di poter dire almeno questo: “di’ solo un parola, e io sarò salvato”. 12
Scaricare