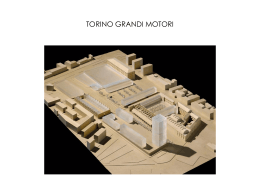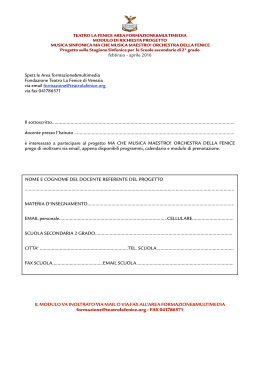VENEZIAMUSICA e dintorni Edizioni La Fenice VeneziaMusica e dintorni n. 53 – novembre 2013 Testata in corso di registrazione Direttore responsabile Giampiero Beltotto a cura di Leonardo Mello VeneziaMusica e dintorni è stata fondata da Luciano Pasotto Editore Fondazione Teatro La Fenice Realizzato da Dali Studio S.r.l. VENEZIAMUSICA e dintorni Edizioni La Fenice Sommario 3 4 Editoriale La Fenice 2013-2014 4 La nuova stagione lirica della Fenice di Cristiano Chiarot 6 Una stagione sinfonica novecentesca di Fortunato Ortombina 8 8 Dossier «Africaine» Le radici dell’«Africaine» L’esotismo in letteratura, pittura e musica nella Francia di primo Ottocento di Adriana Guarnieri 39 «Altra voce, altro spazio» La seconda Biennale di Ivan Fedele, direttore artistico della rassegna fino al 2015 40 Sulla Biennale 2013 Dai capisaldi della Nuova Musica agli autori emergenti di Mario Messinis 42 La LVII Biennale Musica Un racconto e qualche riflessione a margine di Paolo Petazzi 44 Verdi/Wagner (1813-2013) 44 10 Giacomo Meyerbeer I 150 anni di un grande compositore che torna alla Fenice di Francesco Bertini Verdi versus Wagner: alla pari? Un confronto tra due mostri sacri di Quirino Principe 47 12 La «prima» alla Fenice (1868) Il racconto del debutto veneziano in un documento storico straordinario I «Quattro pezzi sacri» Un saggio inedito illustra i componimenti verdiani di Chiara Facis 50 16 Sull’«Africaine» Meyerbeer, il «grand-opéra» e il successo dell’opera postuma di Massimo Contiero «Verdi è universale» A colloquio con Myung-Whun Chung 18 Le voci dell’«Africana» Grandi interpreti tra Otto e Novecento di Giorgio Gualerzi 20 «Accompagnare lo spettatore dentro la vicenda» La lettura del regista Leo Muscato 22 Le nuove stagioni – Una panoramica italiana 22 Su il sipario! I cartelloni dei Teatri nazionali 26 Bepi Morassi e il belcanto 28 Contemporanea – «Aspern» 28 «Aspern» al Malibran L’analisi di Salvatore Sciarrino a cura di Leonardo Mello 31 Salvatore Sciarrino Una biografia artistica del compositore palermitano di Gianfranco Vinay 35 Sciarrino fra Britten e James Giochi di specchi e rimandi colti in una Venezia dai contorni foschi di Michele Girardi 37 2 39 Contemporanea – La LVII Biennale Musica «Aspern» 1978-2013 Due recensioni | VENEZIAMUSICA e dintorni 52 RIP 52 Lou Reed, il Veneto e le rughe profonde della poesia rock di Giò Alajmo 54 Altre musiche 54 «Tre amici» La cronaca di un concerto di Keith Jarrett secondo Costanza, cinque anni 56 Dintorni 56 Ottavia Piccolo parla d’arte e di donne maltrattate a cura di Leonardo Mello 59 Polemiche 59 I nemici della musica Un testo corrosivo che i burocrati di ogni specie dovrebbero mandare a memoria di Quirino Principe 63 Carta canta 63 Le recensioni di Giuseppina La Face Bianconi EDITORIALE D opo il numero d’esordio nella nuova veste di periodico del Teatro La Fenice, torniamo ora a parlare di musica e d’arte in occasione della riapertura delle stagioni autunnali. L’assunzione, da parte della Fondazione lirico-sinfonica veneziana, di un periodico come questo, si inserisce in un più ampio spettro d’azione che la Fenice, negli ultimi anni, si propone come prioritario. La volontà, da parte del nuovo editore, di proseguire nel cammino intrapreso si collega a una urgente, necessaria riattualizzazione di questo strumento culturale. Sono ormai alcuni mesi, infatti, che VeneziaMusica e dintorni trova la sua collocazione privilegiata nella rete, aggiornando quasi quotidianamente i propri spazi. Questo ha permesso, com’era naturale, di sviluppare un continuativo monitoraggio sull’attività culturale nazionale e internazionale. L’osmosi tra lo spazio concesso dal web e la dimensione cartacea ci ha permesso di formulare un mezzo di approfondimento dinamico e accessibile. Il frutto di questa osmosi si può apprezzare in queste pagine: se da un lato il posto d’onore è riservato all’evento di punta dell’autunno musicale, quell’Africaine di Giacomo Meyerbeer che da più di un secolo non ritorna a Venezia, la gamma degli argomenti trattati dalla rivista è molto vasta: affronta realtà future nel loro progressivo divenire, come le nuove stagioni operistiche, ma fa anche i conti con manifestazioni di grande impatto che si sono appena concluse (una fra tutte la Biennale Musica). Riporta i dettagli di un’operazione difficile e riuscita come la riproposizione di Aspern di Salvatore Sciarrino, ma si occupa anche d’altre musiche, di tematiche che coinvolgono (e opprimono) i nostri giorni, come l’orrore spesso dimenticato del femminicidio, a partire – ovviamente – dal doloroso archetipo incarnato da Carmen, che di recente è tornata a dilettare e turbare gli spettatori. In questo mescolare passato e presente, tradizione e contemporaneità, VeneziaMusica e dintorni si inserisce a pieno titolo nel progetto complessivo portato avanti dalla Fenice, di cui si accennava all’inizio, che a fronte della riconosciuta qualità della sua offerta intende sempre più essere il teatro della città, della regione e di tutti coloro che qui approdano in cerca di bellezza. Il compito che ci siamo prefissi è quello, forse anche arduo, di sviluppare dibattito e – oltre a raccontare quello che accade qui – funzionare anche da cassa di risonanza per idee, progetti, riflessioni e anche critiche, convinti che l’apertura sia l’unica formula per leggere, almeno un po’, le ansie, le attese e le speranze di domani. VENEZIAMUSICA e dintorni | 3 La Fenice 2013-2014 LA NUOVA STAGIONE LIRICA DELLA FENICE Q di Cristiano Chiarot* uella che parte il 23 novembre è per la Fenice una stagione importante, di cui abbiamo tracciato la rotta con largo anticipo, «aggiustandola» poi in base alle situazioni che si sono venute creando. Come ogni anno l’inaugurazione è caratterizzata da un’opera di grande rilievo, in questo caso L’africaine di Giacomo Meyerbeer, che manca da Venezia dal 1892 e che viene ora riproposta in occasione dei centocinquat’anni dalla morte dell’autore. Un’impresa molto impegnativa, che abbiamo potuto realizzare soltanto grazie alla partecipazione fattiva di tutti i lavoratori del Teatro. Tanti sarebbero i titoli da menzionare, ma tra i molti citerei almeno la mozartiana Clemenza di Tito con la regia di Ursel Herrmann e The Rake’s Progress di Stravinsky, opera che debuttò alla Fenice l’11 settembre 1951, e che sarà proposta in un inedito allestimento di Damiano Michieletto. Poi il trittico di Puccini, composto da Bohème, Madama Butterfly e la nuovissima Tosca: dopo la trilogia mozartiana, firmata da Michieletto e riproposta in sequenza in questa stagione, sarà dunque la volta delle tre donne-simbolo del maestro di Torre del Lago. Tre storie di dolore, sopraffazione, diritti negati e sentimenti traditi: tutti argomenti estremamente attuali. Ecco allora che, nell’accostare al lavoro di Francesco Micheli e Mariko Mori la regia di un’esponente di spicco del teatro di ricerca come Serena Sinigaglia, impegnata in Tosca, si esprime al massimo livello l’operazione da noi intrapresa nel corso degli ultimi anni, che consiste nell’evidenziare, attraverso messinscene innovative – pur nell’assoluto rispetto della drammaturgia musicale originaria – la valenza estremamente con- 4 | VENEZIAMUSICA e dintorni temporanea della lirica. Un Puccini nuovo, insomma, anche dal punto di vista musicale, affidando la direzione d’orchestra ad artisti giovani e dinamici come Jader Bignamini e Daniele Callegari. Sarebbe impossibile ricordare in poche righe la totalità degli appuntamenti operistici. Mi limito dunque a questi brevi cenni, senza dimenticare la seconda edizione del festival Lo spirito della musica di Venezia, che – oltre al citato Rake’s Progress – vedrà altri eventi spettacolari di matrice prettamente veneziana, come Il combattimento di Tancredi e Clorinda, perla della produzione monteverdiana che debuttò in laguna nel 1624 e che Pier Luigi Pizzi allestirà a Palazzo Mocenigo. Inoltre abbiamo voluto aprire le porte ai teatri di tradizione del nostro territorio, creando un progetto ad hoc, «I teatri del Veneto alla Fenice», e ospitando a febbraio, al Malibran, Il campiello di Ermanno Wolf-Ferrari, una produzione del Teatro Sociale di Rovigo. Si tratta dunque di una stagione che privilegia, in modo trasversale, le priorità che ci siamo dati qualche tempo fa, e che poi insieme al direttore artistico Fortunato Ortombina abbiamo tradotto in scelte concrete. Da una parte sta, ovviamente, la valorizzazione della nostra grande tradizione operistica, resa contemporanea e fruibile al pubblico del XXI secolo. Dall’altra la riproposizione di spettacoli di successo delle nostre passate stagioni, che rientra in una strategia di contenimento dei costi e che assicura d’altro canto la qualità dell’offerta. A queste due esigenze si somma un’attenzione * Sovrintendente Fondazione Teatro La Fenice La Fenice 2013-2014 sempre più forte per le eccellenze che operano sul nostro territorio, e che vengono coinvolte in un processo di collaborazione proficua e continua (collaborazione di cui il festival estivo è esempio paradigmatico). Infine, la volontà di proseguire nel processo di rivitalizzazione della musica contemporanea: dopo la fortunata esperienza di Aspern sarà ancora Salvatore Sciarrino il protagonista, con La porta della legge, opera di recente creazione e mai rappresentata prima in Italia. Questa chiusu- ra, in novembre del’’14, si inserisce in un organico progetto di diversificazione e ampliamento del cartellone dei nostri due teatri, la Fenice e il Malibran: da Mozart all’Elegy for Young Lovers di Hans Werner Henze, dal Trovatore verdiano alla Porta della legge, passando per il belcanto rossiniano e per l’ormai storica Traviata, l’obiettivo è presentare al nostro pubblico una serie di spettacoli di qualità, che lo possano interessare e appassionare al di là dei generi e delle tassonomie da addetti ai lavori. VENEZIAMUSICA e dintorni | 5 La Fenice 2013-2014 UNA STAGIONE SINFONICA NOVECENTESCA I di Fortunato Ortombina* l titolo della nuova stagione sinfonica della Fenice sarà «Novecento», proprio come il film di Bertolucci. E questo poiché è interamente dedicata al secolo scorso, con due sole eccezioni. La prima è il concerto diretto da Sir John Eliot Gardiner, che a dicembre conclude le celebrazioni verdiane con l’ouverture di Aida e il Te Deum dei Quattro pezzi sacri, cui vengono unite musiche di Berlioz – l’ouverture da Le corsaire e brani sinfonici dalla grande cantata Roméo et Juliette – sonorità molto vicine alla sensibilità verdiana nella sua tensione verso la modernità. Anche se questi titoli si collocano nell’Ottocento, li consideriamo comunque «novecenteschi», in particolare il Te Deum, che risale agli anni novanta, ed è tra le ultime sue opere: siamo dunque davvero a ridosso, non solo cronologicamente parlando, del periodo che abbiamo scelto di indagare quest’anno. La seconda eccezione riguarda la Sinfonia n.4 in do minore di Schubert, la Tragica, che segue la Passacaglia op. 1 di Anton Webern: questa successione risulta la più logica e coerente, quindi non abbiamo voluto fare forzature: dopo quella Passacaglia ci vuole quella Sinfonia. Per tutto il resto il cartellone è composto esclusivamente da autori novecenteschi. Questa decisione parte dalla constatazione che, quasi senza accorgercene, ci siamo già inoltrati per ben tredici anni nel XXI secolo, perciò Donnerstag aus Licht di Karlheinz Stockhausen oggi va considerata un’opera del secolo passato, così come solo quattordici anni fa veniva percepita La traviata. Il tempo passa, e bisogna storicizzare: dobbiamo cominciare ad assumere il Novecento come un’epoca trascorsa, anche se vi apparteniamo 6 | VENEZIAMUSICA e dintorni per motivi anagrafici. Non è possibile continuare a considerare il secolo XX il nostro tempo, il nostro presente, come mi sembra che invece da più parti si continui a fare. Prese dunque le mosse da queste riflessioni, ci siamo poi chiesti a quale Novecento attingere. E ci siamo orientati verso l’esclusione della seconda Scuola di Vienna. Non è ovviamente una presa di posizione pregiudiziale, le sue motivazioni anzi partono da una considerazione: escludendo la dodecafonia si apre un altro mondo di musica. E questo perché la dodecafonia, anche se profondamente, peculiarmente «tedesca», è l’eredità più universale, quella che cancella tutte le scuole nazionali coeve. Quando si costruisce un programma incentrato sugli autori dodecafonici inevitabilmente le scelte prendono degli indirizzi molto precisi, che nella maggior parte dei casi rimangono all’interno dell’area tedesca, come testimonia la diade più ovvia e scontata, Beethoven-Schoenberg. Per quanto ci si sforzi di fare diversamente, poi la direzione che si imbocca è più o meno sempre la stessa. E dato che negli ultimi anni abbiamo dedicato ben due cicli a Beethoven, uno a Brahms, uno a Schumann, uno a Mendelssohn, uno a Bach, abbiamo preferito affrontare il Novecento al di fuori della fortissima polarità Vienna-mondo germanico. L’unica maniera per riuscire ad avere una panoramica più ampia ci è parsa quella di eliminare questi colossi, consentendo alla scuola russa, francese, americana, inglese di sprigionarsi con tutta la loro forza, anche in virtù degli accostamenti che abbiamo cercato di inventare. Accostare dei brani * Direttore artistico Teatro La Fenice La Fenice 2013-2014 musicali è come mescolare degli ingredienti in un piatto: ogni composizione ha una propria identità, ma quando due vengono messe insieme diventano una terza cosa, ciascuna delle due si arricchisce o si impoverisce, appare più o meno grande, oppure semplicemente determina un’entità terza. Questo procedimento si moltiplica ulteriormente nel Novecento, periodo nel quale le composizioni lunghe sono meno rispetto al passato: la grande sinfonia, eccettuato Shostakovich, non è più una forma così diffusa e frequentata. Questo vuol dire che i brani, all’interno di ciascuna parte della serata, diventano due, tre, quattro... Venendo al cartellone, ed essendo impossibile qui dare conto di tutti gli appuntamenti, mi limito ad alcune notazioni generali. All’interno del mondo variopinto che ci si è affacciato dinnanzi, per esempio, molto interessanti sono state le suggestioni nate dall’allargamento del nostro sguardo alla musica americana, e a Elliot Carter in particolare. Naturalmente non abbiamo tralasciato la tradizione italiana, presente in forze, da Ottorino Respighi a Goffredo Petrassi, di cui abbiamo scelto l’ultima composizione per orchestra. E cito soltanto due nomi, cui aggiungo il Quinto concerto per pianoforte e orchestra di Luca Mosca, che sarà eseguito dallo stesso compositore. Questa impostazione non «viennocentrica» purtroppo ci ha costretto a escludere anche Luigi Nono, che però tornerà presto protagonista alla Fenice, essendo una delle punte di diamante della musica contemporanea veneziana. Va da sé che non si tratta di un’operazione contro Nono, ma rappresentando lui una colonna portante del filone che abbiamo volutamente tralasciato, era inevitabile che venisse escluso, e con lui autori come Xenakis e Boulez. Ci sono due poli che sono indubbiamente «pesanti», quello russo e quello francese. Ma la nostra ricognizione si è estesa in ogni direzione, non solo da est a ovest ma anche da sud a nord, fino alla Finlandia, con la Settima sinfonia di Jean Sibelius. La parte del leone la fa ovviamente Stravinsky, presente con i due grandi balletti Petruska e L’uccello di fuoco, che dirige Diego Matheuz, e anche con brani poco frequentati, come le Variazioni che lui scrisse negli anni sessanta per la morte di Aldous Huxley, lo scrittore di cui era caro amico. E questa volta sono previsti anche due concerti interamente corali, diretti da Claudio Marino Moretti: il primo dedicato al solo Alvo Pärt; il secondo più variegato, con musiche di John Cage, Morton Feldman e Wolfgang Rihm. Ma voglio sottolineare che la Scuola di Vienna, lungi dallo scomparire, ritornerà in altra forma: è stata infatti da noi indicata come tema di riferimento per i tre compositori – Mauro Lanza, Vittorio Montalti e Luigi Sammarchi – che, come ormai è consuetudine, presenteranno ciascuno una propria opera inedita su commissione del Teatro, nell’ambito del progetto «Nuova musica alla Fenice», quest’anno dedicato a Giovanni Morelli: quello sarà l’argomento assegnato loro come fonte di riflessione e ispirazione allo stesso tempo. Aggiungo, in chiusura, un’ultima considerazione. È senz’altro vero che le stagioni devono avere una logica e ruotare intorno a un tema generale, e questo vale certamente anche per quelle liriche. Bisogna guidare il proprio pubblico attraverso una serie di percorsi che messi insieme formano un unico grande progetto. D’altro canto, nel confezionarlo, questo macroprogetto, bisogna pensare a fare sì cultura, ma anche e soprattutto spettacolo. Alcuni programmi sulla carta meravigliosi e profondamente significativi, che riuniscono proposte che magari non si ascolteranno mai più, lasciano spesso indifferenti gli spettatori. Invece il pubblico va coinvolto. Questo non significa replicare sempre la Nona di Beethoven e La sagra della primavera: le proposte più note devono mescolarsi ad altre che lo sono meno. In questo modo ricerca, cultura e spettacolo si compenetrano, emozionano e divengono efficaci. VENEZIAMUSICA e dintorni | 7 Dossier «Africaine» LE RADICI DELL’«AFRICAINE» L’esotismo in letteratura, pittura e musica nella Francia di primo Ottocento L di Adriana Guarnieri* ’ambito semantico del termine «esotismo» è decisamente articolato: nei dizionari francesi alla voce «exotisme» si trovano aggettivi, sostantivi e avverbi quali – in italiano – «straniero», «lontano», «altrove», «evasione», «pittoresco», «spaesamento» e così via. Sul fronte storico-linguistico il lemma risulta attestato in Francia al più tardi nel 1845, a registrare un fenomeno che nelle arti si affaccia, con caratteri di centralità se non di prepotenza, a seguito di eventi bellici di natura prevalentemente espansiva. La politica coloniale di Francia, Germania e Inghilterra, che distinguerà l’intero secolo (con prolungamento nel successivo), accende evidentemente da subito interessi e curiosità che coinvolgono nell’ordine, con frequenza crescente, letteratura, pittura e musica in viaggi – reali o immaginari – di esperienza del diverso. Per la Francia della prima e seconda generazione romantica si tratta in esordio della campagna d’Egitto di Napoleone, seguita dall’occupazione della Spagna; l’impegno nella guerra contro i Turchi coinvolge successivamente la Grecia e i Balcani, mentre la presa di Algeri e poi dell’intera Algeria rileva il Magreb. A partire dagli anni cinquanta questa politica di espansione si estende all’Indocina e – in termini commerciali – al Giappone. La geografia dell’esotico si precisa così, a partire dall’inizio del secolo, come un arco continuo che va dalla Spagna (già araba) all’Estremo Oriente e comprende Africa Settentrionale, Italia, Grecia, Medio Oriente, India: in sostanza tutto ciò che esce dai confini dell’Europa occidentale intesa come Francia, Germania e Inghilterra (nella prefazione alle Orientales del 1829 Victor Hugo scrive: 8 | VENEZIAMUSICA e dintorni «La Spagna è ancora Oriente; la Spagna è per metà africana e l’Africa per metà asiatica»). E l’altrove geografico si configura innegabilmente, agli occhi dell’uomo occidentale, come un insieme culturale alternativo caratterizzato da caratteri costanti e almeno in parte comuni. Su queste basi, dalla metà del secolo il fenomeno di espansione conosce anche la direzione inversa. Le Esposizioni Universali di Londra e Parigi ufficializzano e completano questa vicenda di penetrazioni e contatti: esibiscono realtà altre, artistiche o commerciali, che raggiungano e stupiscano l’intera popolazione occidentale. La curiosità del diverso si soddisfa però, ben prima che nelle Esposizioni, nell’esperienza diretta: molti scrittori, pittori e musicisti romantici della prima e seconda generazione viaggiano, con conseguenze palpabili sulla loro produzione. Chateaubriand visita nel 1806 Grecia, Terra Santa, Egitto, Tunisia e Spagna; Hugo negli anni venti Spagna e Vicino Oriente; Mérimée percorre negli anni trenta Spagna, Italia, Grecia e Vicino Oriente; Gautier visita negli anni quaranta Spagna, Algeria e Italia, in seguito Medio Oriente e Russia; Flaubert, a cavallo degli anni cinquanta, si reca in Egitto e Africa Settentrionale. Si consolida così, nella prima metà del secolo, una letteratura di viaggio (o di evasione ispirata a conoscenza diretta) che fonda e declina le parole dell’esotismo nelle due direzioni considerate classiche: quella di un realismo fondato sull’osservazione (che si traduce in couleur locale geografica) e quella di una fantasia sollecitata dal ricordo (che si rivela spesso * Ordinario di Storia della Musica all’Università Ca’ Foscari di Venezia Dossier «Africaine» la proiezione di un inconscio svelato dall’impatto col diverso). Chateaubriand, Gautier, Nerval e Flaubert praticano perciò sia il genere descrittivo del diario di viaggio sia quello lirico o narrativo di poesie e racconti investiti della dimensione di una fantasticheria orientale. In questa scia nasce anche una letteratura tutta d’invenzione, che ritrae viaggi immaginari quali rivelazioni del sé (i «voyages autour de ma chambre»). Dal canto loro i pittori contribuiscono alla visione romantica dell’altrove con altrettante escursioni e successive elaborazioni personali del materiale raccolto, in veste sia di pittori di cavalletto sia di scenografi. Le tele orientali di Ingres e soprattutto di Delacroix (che visita la Spagna e l’Africa Settentrionale negli anni trenta) fondano un repertorio di soggetti, di luci e di colori che accoglie interni algerini, animali del deserto, scene di caccia, guerrieri e si condensa nella figura dell’odalisca. Mentre Chassériau, in Oriente negli anni quaranta, restituisce sulla tela il senso dell’avventura, l’idea di un nuovo pittorico legato all’esperienza dell’altrove. E tutti scoprono la luce mediterranea quale nuovo mezzo di espressione del pittoresco. Nelle sue due formulazioni (la registrazione del caratteristico, il sogno «orientale») la produzione letteraria coinvolge anche i musicisti, che com- pongono, su questi testi o con la mediazione di un libretto, nelle forme della mélodie, della tragédielyrique, dell’opéra-comique, del grand-opéra, creando via via tutto un vocabolario di espressioni musicali del lontano che si organizzano anche sulla base dell’esperienza diretta, soprattutto con il viaggio dell’esiliato sansimoniano Félicien David nel Vicino Oriente e in Africa Settentrionale. A partire dall’Ode sinfonica Le Désert di quest’ultimo, il lessico «orientale» si precisa così come presenza di condotte inusuali e asimmetriche: scale alterate o prive di sensibile, pedali armonici, modi ritmici, orchestra arricchita di triangoli, piatti, tamburino (per le danze caratteristiche), arabeschi melodici, tendenza a un melodizzare melismatico. Ne risulta una vera e propria lingua, le cui caratteristiche – in presenza del soggetto o del titolo «orientale» – saranno per decenni la vocalità melismatica, la frequenza di ritmi ostinati, l’abbondanza di pedali armonici, l’eterofonia strumentale dei doppi pedali, l’insistito cromatismo coloristico, le scale variamente alterate o difettive. Questo lento evolversi di linguaggi poetici, narrativi, pittorici e musicali ispirati dall’Oriente o all’idea di Oriente precede, accompagna (e poi prolungherà amplificandola) la lunghissima genesi dell’Africaine di Meyerbeer. VENEZIAMUSICA e dintorni | 9 Dossier «Africaine» GIACOMO MEYERBEER I 150 anni di un grande compositore che torna alla Fenice J di Francesco Bertini* akob Liebmann Meyer Beer nacque il 5 settembre 1791 in una ricca famiglia berlinese. Il padre Jakob Herz Beer, membro di una famiglia di banchieri ebrei di Francoforte, si trasferì a Berlino dove sposò Amalia Meyer Wulf, figlia di un noto uomo d’affari e donna particolarmente sensibile alle espressioni artistiche. Fin da piccolo Jakob seguì lezioni di piano e già a undici anni era ritenuto un bimbo prodigio. Durante l’adolescenza intraprese lo studio della composizione, abbandonando la casa natia nel 1810 e cominciando a fondere il cognome della famiglia materna con quello paterno. I progressi non si fecero attendere e nel 1812 produsse Jephthas Gelübde, prima opera di un certo successo. Meglio conosciuto come pianista incomparabile, in quel periodo si dedicò con continuità all’attività concertistica spostandosi a Parigi nel 1814. Appariva come un giovane promettente, ricco e ambizioso, ma ancora non ben indirizzato. La svolta, necessaria a rafforzare la formazione culturale, giunse con il viaggio in Italia dove arrivò nel 1816 e rimase, salvo brevi interruzioni, fino al 1824. Quale omaggio alla terra che accrebbe notevolmente le sue qualità compositive, cominciò ad utilizzare il suo nome nella forma italianizzata «Giacomo». Il primo contratto operistico lo vide impegnato nel Teatro Nuovo di Padova con il debutto del melodramma semiserio Romilda e Costanza. Negli anni seguenti compose per il Teatro alla Scala di Milano (Margherita d’Anjou, L’esule di Granata), per il Regio di Torino (Semiramide riconosciuta) e per La Fenice di Venezia dove trionfò con Il crociato in Egitto nel 1824. Con quest’ultimo titolo Meyerbeer divenne uno dei più impor- 10 | VENEZIAMUSICA e dintorni tanti compositori del panorama italiano, dopo la partenza di Rossini per la Francia, e cominciò a manifestare un interesse eclettico e cosmopolita per stili e generi appartenenti alle più disparate tradizioni, in netto disaccordo con i nazionalismi allora in piena maturazione. Negli anni seguenti rallentò il proprio lavoro, per la morte del padre e per il matrimonio con la cugina Minna Mosson, ma non tralasciò di intrattenere contatti con Parigi, meta musicale che lo attraeva particolarmente e già lo glorificava a seguito della prima esecuzione, dovuta all’interessamento di Rossini, del Crociato in Egitto nel Théâtre-Italien. Fu proprio con la decisione di dedicarsi alle scene francesi che egli cambiò radicalmente la propria vita e la cultura musicale dell’intero Ottocento: Meyerbeer divenne l’iniziatore di un genere, quello del grand-opéra, destinato a influenzare l’intero panorama europeo in molteplici campi artistici. In quel periodo iniziò la fondamentale e proficua collaborazione, durata tutta la vita, con il librettista Eugène Scribe. Il 21 novembre 1831 giunse sulle scene Robert le diable, l’opera della consacrazione a livello internazionale. Le novità furono molte, dalle scenografie maestose alle nuove invenzioni illuminotecniche, basate sulle più recenti scoperte. Cifra stilistica caratterizzante il lavoro meyerbeeriano fu la capacità di sintesi delle tre culture musicali allora più in voga: la raffinatezza della forma e dell’armonia tedesca si intrecciavano allo stile canoro italiano e alla consolidata abilità drammatica francese. Ma la novità più eclatante consisté nell’esigenza dell’autore di prolungare smisuratamente le prove con * Musicologo Dossier «Africaine» modifiche alla partitura apportate costantemente, in una incessante ansia perfezionistica. In quegli anni si manifestò pure la debolezza caratteriale di Meyerbeer che diffidava dei giudizi del pubblico e sentiva il peso, da riscattare ad ogni costo, della discendenza ebraica. L’ambiente parigino rappresentava l’occasione migliore per dimostrare le proprie capacità e il valore di composizioni troppo spesso sottovalutate. Con gli eventi dell’epoca napoleonica e del Congresso di Vienna, all’inizio degli anni trenta dell’Ottocento la storia cominciò ad assumere importanza in relazione ai gruppi sociali dando voce alle masse, in un connubio di fantastico e reale tipico del romanticismo imperante. Un profondo studio delle tradizioni religiose e un’attenta stesura del testo letterario, che venne corretto da varie mani, furono alla base di Les Huguenots, un’opera di vaste dimensioni che richiese ingenti masse e grandi sforzi artistici. È questo il lavoro che canonizzò definitivamente il grand-opéra, divenuto nel frattempo un fenomeno di massa in Francia. Meyerbeer fuse la tradizione orchestrale di stampo italiano con lo stile francese, in una combinazione che sintetizzava entrambe le culture con un’integrazione dei singoli numeri musicali in un quadro più ampio e unitario. Dopo il grande successo il compositore si rimise al lavoro, tergiversando però sul soggetto da musicare. Alla fine scelse due progetti che portò avanti assieme: L’Africaine e Le prophète. A seguito di un breve periodo dedicato a L’Africaine, egli si concentrò su Le prophète ultimando la prima stesura della partitura nel 1841. La sua scrittura legata indissolubilmente ai cantanti a disposizione, o a quelli espressamente richiesti, lo indusse a posticipare la rappresentazione, apportando sostanziali cambiamenti alla partitura, fino al 1849. L’opera impressionò per la magnificenza della messinscena che, tra le altre cose, impiegava per la prima volta la luce elettrica. Subito dopo rimise mano a L’Africaine, abbandonata nel 1843, lasciando e riprendendo il lavoro più volte fino alla morte, salvo la battuta d’arresto per la scomparsa dello storico collaboratore Scribe. Il 2 maggio 1864, a prove appena iniziate, Meyerbeer morì lasciando al musicologo belga François-Joseph Fétis l’arduo compito di dare un assetto definitivo alla composizione che, proprio per la lunghezza della gestazione, non possedeva la coerenza della produzione precedente, pur denotando la cura minuziosa nell’orchestrazione e l’interesse rivolto alle nuove tecniche vocali. VENEZIAMUSICA e dintorni | 11 Dossier «Africaine» LA «PRIMA» ALLA FENICE (1868) Il racconto del debutto veneziano in un documento storico straordinario L a lunga e dettagliata critica apparsa nella «Gazzetta di Venezia» del 2 marzo 1968 si rivela documento storico prezioso per poter cogliere l’atmosfera che permeava la Fenice nel giorno del debutto dell’Africaine (1 marzo). Anonimo come allora di costume, l’estensore dell’articolo va dritto alla sostanza – complice l’ampia disponibilità di spazi – senza perdersi in dissertazioni vaniloquenti di cui spesso sono affollati i giornali di oggi. Per comprendere che cosa sia l’Africana, come musica, bisogna prima parlar del libretto, perché, solo porgendo un’idea delle svariate situazioni drammatiche, ch’egli offre, e che furono sublimate dall’illustre Meyerbeer, è possibile dare una immagine, se pure scolorita, di questo poema musicale. La portoghese Inez (la Mongini), figlia dell’ammiraglio Don Diego, ama Vasco di Gama (Carrion), che con Diaz è partito da due anni per tentare il passaggio del Capo di Buona Speranza, e ripete, nella prima scena, la canzone d’amore colla quale si sono lasciati; ma il padre le annunzia che il Re ha deciso ch’essa sposi Don Pedro (Mitrovich), presidente del Consiglio, ed essa, da quella figlia obbediente ch’ell’è, si adatta, specialmente quando le dicono che Vasco di Gama, gente ignota, come dice il libretto, è perito nelle onde. Frattanto il Consiglio del Re, composto di Don Pedro, del grande inquisitore, di due Cardinali, di quattro Vescovi, in perfetto costume, e d’altri consiglieri, s’aduna per decidere se s’abbia a mandar alcuno sulle tracce di Diaz, o desistere dall’impresa; ma l’inquisitore ed i suoi seguaci, che, come più tardi lor rinfaccia Vasco di Gama, son nemici della luce e la serrano in carcere, perché, mal- 12 | VENEZIAMUSICA e dintorni grado ad essi, non li rischiari, si mostrano fin dalle prime contrarii a nuove imprese. Dopo un inno, nel quale i Vescovi invocano l’ispirazione celeste, viene introdotto Vasco, non più morto, il quale propugna la sua causa chiedendo solo un buon naviglio, e promette a’ suoi protettori tesori immensi, riservando a sé l’immortalità. Per sorreggere la sua domanda, ei trae innanzi al Consiglio due schiavi d’una razza sconosciuta, e che devono appartenere al nuovo mondo ch’egli vuole scoprire. Questi sono Selika (la Lotti), regina d’un paese, che non è già nell’Africa, come farebbe supporre il titolo dell’opera, ma nell’Indostan, e Nelusko (Merly), schiavo di Selika, è tratto con essi in servaggio. Vasco vorrebbe che Selika, indicando al Consiglio la sua patria, persuadesse quegl’increduli, ed essa, innamorata com’è di lui, quasi il farebbe, se lo schiavo non le ricordasse il giuramento di non tradire il popol suo; sicché a Vasco manca lo sperato appoggio, ed ei si ritira per attendere il giudizio. Alcuni de’ consiglieri, capitanati da Alvaro (Galletti) vorrebbero secondare l’ardita impresa, ma l’inquisitore ed i Vescovi trovano che Vasco è un empio, perché nei libri santi non si parla del nuovo mondo, e ne nasce un parapiglia, nel quale, con assai poca dignità, i Vescovi ed i consiglieri attaccan lite, come le comari sul mercato, e per poco non vengono alle mani. Finalmente, non si sa perché, la burrasca si pacifica, ed ogni consigliere si leva dalle tasche una palla, ch’ei ripone in un vaso aperto, ed il presidente del Consiglio, con rara divinazione, capisce da tutte quelle palle uguali, riposte in un solo vaso, che il Consiglio ha dannato l’intrapresa. Vasco naturalmente rimbrotta i giudici ed il grande inquisitore lo condanna alla prigione eterna, mentre gli altri per poco nol gettan giù dalla Dossier «Africaine» finestra. Così finisce il primo atto, nel quale ormai si scorgon delineate tre specie d’amore, quello puro di Inez, l’amore voluttuoso di Selika, l’amore feroce, ma timido ed ignorato di Nelusko. Nel second’atto, Vasco di Gama è nelle carceri dell’Inquisizione; ma esse non sono quali noi sin ieri ce le avevamo raffigurate, giacché gli è lasciata la compagnia, certo non ingrata, di Selika, v’entra e n’esce a suo talento Nelusko, e poi Don Pedro, Inez, Don Alvaro ed Anna, per cantare un settimino, ch’è una delle cose saglienti dell’opera. Vasco dorme, e, col solito sistema dei drammi, si sogna ad alta voce della cara compagna, che non è già Selika, ma Inez, e la buona Selika, in compenso, gli canta una berceuse, che noi più volgarmente chiameremo nanna. Nelusko, che ha indovinato l’amore della sua regina per lo straniero, tenta due volte d’ucciderlo, ma ne è impedito da Selika. Allora Vasco si sveglia e fa un corso di studii geografici coll’Africana, la quale fa sì rapidi progressi, che in un paio di minuti tutto apprende, e segna sulla carta al suo diletto la via, per la quale si può girare il tremendo Capo. Figuratevi quanta gioia desti nel cuore di Vasco la scoperta, e qual magnifico tema sia questo per un duetto, nel quale Vasco prorompe nella poetica frase: L’immenso servigio Mai più scorderò. Il grato affetto di Vasco per Selika dura però qual lampo, perché, appena viene Inez ad annunziargli ch’egli è reso in libertà, purché vada in esilio, ei, sospettandone la gelosia, le dona la schiava, ma resta poi nel colmo dell’avvilimento, quand’ode che Inez ha giurato fede a Don Pedro per salvarlo, e che questi, coll’aiuto delle carte presentate e dell’acquisto di Selika e Nelusko, tenterà ei medesimo l’ardito passaggio, nominato già dal re a governatore dei paesi che sarà per iscoprire. L’atto terzo si apre e si compie sulla nave dell’ammiraglio. S’apre con un coro di donne, a cui tien dietro uno di marinai, finché ambedue s’uniscono in una preghiera del mattino, ossia a S. Domenico. Benché alcuni credano di avere già varcato il fatal Capo, il sospetto comincia a spargersi nella ciurma, il mare principia ad agitarsi, e Nelusko, il nocchiero, addita come unico scampo di salvezza il volgere al nord, ma lo fa con un accento sì cupamente selvaggio, che lo spettatore ben comprende voler egli trarli tutti a certa ruina. Si segue il perfido consiglio, e Nelusko intuona un canto di sinistra allegria, ch’è la leggenda del gigante Adamastor. Ma vedete che cosa vuol dire la fortuna; là in mezzo a quei mari, prima insalutati, si scorge un vascello con bandiera portoghese, dal quale viene Vasco di Gama a salvare, com’ei dice, quei suoi compagni, che vede avviarsi agli scogli, ov’è perito Diaz. Siccome però ei confessa a Don Pedro, ch’egli è venuto più ch’altro per salvare Inez, il suo aiuto è mal corrisposto, ed ei sarebbe fucilato, se Selika, lanciandosi con un pugnale contro Inez e minacciando di ferirla, ove non si lasci la vita a Vasco, non ottenesse con tale stringente argomento la di lui salvezza. Don Pedro condona la morte a Vasco, ma lo vuol prigioniero, e, appena non ha più quel salutar timore di Selika, lo condanna a morte. Ma, per fortuna, in quel momento la tempesta infuria, e sorge improvvisamente dalle onde uno scoglio, sul quale il bastimento va ad inclinarsi dolcemente, tanto da offrir campo ad una mano di selvaggi, che non si sa come vengano e donde vengano, di assalire il naviglio, di ucciderne o metterne in fuga la ciurma, sicché, in mezzo a quella scena di lutto, rimangon soli sulla tolda Selika e Nelusko, che la presenta ai selvaggi come la loro regina; imperocché bisogna sapere che lo schiavo ha avuto la bravura di condurre il bastimento a rompersi appunto nel centro del regno. Sulla spiaggia del mare, dice il libretto, ma noi diremo su d’una piazza, fra magnifici monumenti, Selika, accompagnata dal fido Nelusko, dal gran bramino, da sacerdoti, indiani, amazzoni, ec. fa il suo ingresso trionfale nel regno avito, e dopo di aver giurato che alcuno straniero non profanerà di sua presenza impura il sacro suolo della patria, entra nel tempio per farsi incoronare di nuovo, e mantenere in tutto il suo fiore le tradizioni del diritto divino di re Guglielmo. Quando la scena è deserta, capita Vasco, che non è morto nemmen questa volta, ma è tosto assalito da bramini e da soldati, i quali vogliono trucidarlo, bench’egli, credendoli più ingenui di quel che sono, li preghi di lasciarlo almeno ritornar alla nave, per far sapere in Europa che qui Vasco giunse vincitor (!!). Non si potrebbe però fare un altro atto se Vasco non vivesse, e quindi giugne a tempo VENEZIAMUSICA e dintorni | 13 Dossier «Africaine» Selika, la quale dichiara ai bramini ch’egli è fratello loro, perché le ha già dato mano di sposo ed obbliga Nelusko a giurar che la pietosa menzogna è verità, sicché viene a dare egli stesso in braccio all’amata l’odiato rivale. Vasco accetta il matrimonio improvvisato, pur di aver salva la pelle, e là sulla piazza si fa una invocazione alla santa Trinità, di Brama, Visnù, Sivà, e poi un preludio di cerimonia nuziale col far bere ai coniugi un liquore consacrato. Frattanto che i preti vanno all’altar, a’ nostri sommi degl’inni a cantar, Selika e Vasco rimangon soli sulla scena, e Vasco, che allora, per la prima volta, viene a scoprire l’amore di Selika, n’è subitamente rapito per modo, da morir quasi di voluttà e di gioia, e da promettere di dimenticar Inez, il Portogallo e che so io. Finita la cerimonia in chiesa, si celebra il matrimonio civile, e poi Vasco e la sposa vengono tratti al talamo da uno stuolo di leggiadre donzelle. Ma nemmeno Inez è morta, e l’atto quarto si termina con un lontano addio di essa alla patria, il quale però non impedisce che Vasco entri in casa a consumare il matrimonio. Nell’atto quinto, Selika ha scoperto Vasco accanto ad Inez ed è straziata dalla gelosia, ma venendo a conoscere, in un magnifico duetto con Inez, che Vasco, pur amando Inez, vuol restar fedele alla legittima consorte, fa un eroico sacrifizio del proprio amore e commette a Nelusko di condurre Vasco ed Inez liberi sul legno di Vasco, che ancor si vede da lungi, riservandosi di assistere alla partenza della nave, che seco porta il suo cuore, dall’alto d’una rupe sotto l’ombra di un manzanillo. Questo manzanillo, per chi nol sappia, è una specie di bubon upas, è l’hyppomane mancinella dei botanici, albero venefico, la cui ombra in prosa produce mali di capo ed oftalmie, a chi s’addormenti sotto di essa, ed in poesia induce voluttà celesti, che in brev’ora traggono a morte. E quest’è la morte eminentemente poetica, scelta da Selika a stromento di suicidio; aspetta sotto quell’ombra il passaggio del naviglio e muore in un voluttuoso delirio, in compagnia del fido Nelusko, che solo, di tutto il popolo, ha avuto il coraggio di tenerle compagnia sotto l’albero fatale. Il libretto, come avranno capito i lettori, se hanno avuto la pazienza di seguirci fin qui, è la più accellerata cosa, che si possa immaginare, quantunque sia fattura dello Scribe, ma, come dicemmo, offre tanta larga copia di nuove situazioni, da soddisfare il 14 | VENEZIAMUSICA e dintorni più appassionato compositore di musica. Se non ci fossero che la scena della tempesta, e quella lugrubemente voluttuosa della morte sotto al manzanillo, queste due sole, musicate maestrevolmente come furono dal Meyerbeer, basterebbero per far passare sopra a tutti gli enormi difetti del libretto. La musica, checché se ne voglia dire, è veramente stupenda, imperocché al solito fare grandioso, armonico e letteralmente espressivo del Meyerbeer, accoppia uno studio particolare della melodia, sì gradita a noi italiani, da rendere quest’opera più simpatica di qualunque altra dello stesso autore, e noi, se non temessimo che ci tacciassero di eresia, come i vescovi fecero di Vasco, vorremmo dire ch’essa segna un avvicinamento di Meyerbeer all’arte italiana. Sicuro che l’armonia è quella che predomina, che l’accompagnamento ha il più delle volte il passo avanti al canto, che da per tutto si scorge uno studio particolare della musica imitativa, ma pur c’è molta melodia, specialmente in tutta la parte di Selika, e, uscendo di teatro, si vanno involontariamente ricercando colla voce quei canti, che rimasero profondamente impressi nell’animo. Parlare della maestria tecnica della composizione, è un pleonasmo, allorché si tratta di Meyerbeer, ma alcuni accompagnamenti sono sì nuovi e sì espressivi, che superano l’aspettazione; specialmente quello della leggenda di Adamastor, nel quale ci parve che i suonatori battessero la corda col rovescio dell’archetto, e l’altro di stromenti d’ottone nella canzone dei fiori, hanno un non so che di singolare e di attraente, che non si vorrebbe mai che finissero; come stupendo è l’effetto delle famose sedici battute all’unisono degli stromenti da corda, che servono di preludio alla scena del manzanillo. I pezzi più notevoli dell’opera sono l’aria d’Inez nel primo atto: Addio, terra nativa, il coro dei vescovi, la proposta di Vasco nel primo tempo del finale: Dovessi pur la vita perdere, la frase di Nelusko: Ridotta in servitù, e la stretta del finale nel primo atto; nel secondo, la bellissima melodia nella berceuse: Figlio del sol, mio dolce amor, l’aria sommessa di Nelusko, Figlia di regi, a te l’omaggio, il duetto tra Vasco e Selika, ed il famoso settimino, con quegli stupendi accompagnamenti di violini e trombe; il corale dei marinai, O gran San Domenico, e l’originalissima ballata: Adamastor re dell’onda nel terzo; nel quarto la marcia indiana, però inferiore a Dossier «Africaine» quella del Profeta, il coro danzato Leggiadri fiori, e l’intiero duetto fra soprano e tenore, ch’è tutto quello d’incantevole e delizioso che si può immaginare; il duetto fra le due donne e tutta la scena finale dell’atto quinto. Certo qua e là vengono alla mente Roberto il Diavolo, gli Ugonotti e il Profeta, ma il pensiero n’è tosto distolto da armonie nuove e svariate che si succedono, ed anche quelle reminiscenze, che pur qua e là si risentono, non fanno che l’effetto di rendere più prontamente gradita l’impressione. Insomma, l’Africana è indubbiamente una bell’opera, che si sentirà ogni sera più volentieri. Quanto all’esecuzione, vuolsi innanzi tutto parlar dell’orchestra, che ha la parte più difficile e sostanziale, e diremo francamente che, specialmente per una prima rappresentazione, essa ha corrisposto all’aspettazione che se n’aveva; la intonazione, il colorito c’è, e basta solo che nelle successive recite si delineino un po’ meglio alcuni dettagli, che rimangono ancora alquanto confusi, sicché talvolta l’effetto s’indovina piuttosto che realmente si senta. E forse l’effetto potrebbe assai più facilmente raggiungersi, se ci fosse magiore equilibrio negli stromenti da arco, non essendovi che sei viole e cinque violoncelli di fronte a ventiquattro violini, mentre ci vorrebbero dodici viole ed almeno otto violoncelli; questo sbilancio si fece sentire specialmente nelle famose 16 battute del 5. atto, delle quali tuttavia si volle la replica, e che piaceranno ogni sera di più. La Mongini, intimidita in sulle prime, prese coraggio, quando fu animata dal pubblico, e, da quella cantante fina e di buona scuola ch’ell’è, cantò assai delicatamente la sua parte; peccato solo ch’essa non sia del pari eccellente nella parte drammatica del canto e dell’azione. La Lotti, colla sua voce fresca ed argentina, colla sua perfetta intonazione, col canto appassionato, ebbe felicissimi momenti e nella berceuse dell’atto secondo e del duetto del quarto atto specialmente arrivò alla perfezione, e ne fu vivamente rimeritata dal pubblico. Anch’essa pero, in qualche punto, fu meno felice nell’interpretazione drammatica, e talvolta fu più dama che schiava; rifulse però in tutta l’opera come un vero gioiello. Il Merly ha, più che interpretata, creata la parte di Nelusko ed in essa si mostrò veramente quell’insigne artista che ce l’avevano decantato; né meglio potevasi esprimere quella vergine energia, quella devozione senza confini, quella rossa fierezza, quel cupo vago ed indefinito, che, sì magicamente espressi da Meyerbeer, formano di questo personaggio un ente a sé, e quasi un dramma nel dramma. La di lui parte è però estremamente faticosa, e, dopo di aver detto magnificamente la scena innanzi al grande inquisitore, e l’aria Figlia di regi nel secondo atto, non potè dare al resto della sua parte quel colorito marcato, che egli aveva saputo imprimerle nel principio. Fu unico nel famoso grido sinistro Volgete al nord e dappertutto grande artista. Del Carrion non occorre parlare, giacché è un valente artista, che tutti già conoscono, e che con isquisita maestria sa supplire anche là dove mal gli risponderebbe la forza della voce; qua e là egli ebbe felici momenti, e fu vivamente applaudito nei due duetti colla donna nel secondo e nel quarto atto. I cori furono applauditi nel primo atto e nel secondo. Dei ballabili non parliamo, perché propriamente ballabili non ce ne sono. Quanto alla messa in iscena essa è grandiosa e non possiamo che lodare lo sfarzo col quale fu eseguita; forse i vestiarii non saranno da per tutto i più esatti, ma son sempre ricchi e pittoreschi, né d’altronde è ancora accertato il luogo, dove avvengono i fatti. Naturalmente la scena del vascello non può qui produrre quell’effetto, ch’essa raggiunse altrove; il palco scenico ha troppo poco sfondo, perché ci possa essere vera illusione; ad ogni modo però, in questa parte l’impresa fece ancor meno di quello che permetteva lo spazio e prometteva lo sfarzo adoperato per tutto il resto, e quasi quasi col vascello fece naufragio l’opera intiera, essendo totalmente mancato l’effetto della scena della burrasca. Con grande lusso e magnificenza è pur messa assieme la marcia indiana, durante la quale v’hanno sul palco scenico ben 265 persone. Gli scenarii poi sono splendidissimi e d’una mirabile illusione. E qui chiuderemo, facendoci una domanda. Il nostro giudizio è anche quello del pubblico? alla quale risponderemo: sì, ma del pubblico di domani, giacché ier sera esso era ancora sotto l’impressione della novità, della meraviglia, ed anche della fatica. La prontezza per altro, colla quale esso colse ed applaudì i pezzi, che furono meglio eseguiti, ci sono arra ch’esso fra poche sere converrà nel nostro giudizio che questo è e rimarrà il migliore spettacolo della stagione. VENEZIAMUSICA e dintorni | 15 Dossier «Africaine» SULL’«AFRICAINE» Meyerbeer, il «grand-opéra» e il successo dell’opera postuma G di Massimo Contiero* iacomo Meyerbeer e il grand-opéra francese sono giustamente accostati in ogni manuale di storia della musica. Va detto però che la parte iniziale della carriera del compositore si svolse in Italia, dove era venuto su consiglio di Antonio Salieri e dopo aver studiato pianoforte con Muzio Clementi. La sua consacrazione internazionale avvenne con Il crociato in Egitto, opera debitrice di Rossini, scritta nel 1824 per la Fenice (che l’ha opportunamente ripresa nel 2007) e per completezza va anche ricordato che, dal 1832 al 1843, ebbe l’incarico di direttore dell’Opera reale di Berlino, dove fece rappresentare l’opera patriottica Ein Feldlager in Schlesien. I suoi grand-opéra sono quattro, Robert le diable (1831), Les Huguenots (1836), Le Prophéte (1849) e L’Africaine (1865), in fondo solo uno in più dei tre titoli di Donizetti per l’Opéra, Les martyrs, La favorite, Dom Sébastien, dei tre di Verdi, Jérusalem, Le vêpres Siciliennes, Don Carlos e meno della metà di quelli di Auber. Tuttavia l’identificazione del genere avvenne soprattutto con Meyerbeer. Figlio di ricchi banchieri ebrei, si poteva permettere di scrivere senza ansia di guadagno, prendendosi tutto il tempo necessario per sviluppare a fondo le potenzialità spettacolari delle trame che gli approntava Eugène Scribe con i suoi libretti. Il desiderio di grandeur del pubblico parigino, che spesso si associa al Secondo Impero, si manifestò già all’epoca della monarchia orleanista. La borghesia urbana, il ceto emergente, si recava all’Opéra, teatro fortemente finanziato dallo Stato, e pretendeva di assistere a rappresentazioni colossali, in cinque atti, con balletti, organico orchestrale dilatato, grande impiego di masse per cortei, sfilate interminabili e 16 | VENEZIAMUSICA e dintorni preziosi costumi. Voleva ammirare sontuose scenografie, spesso firmate da artisti diversi a seconda degli atti e che venivano anche riprodotte, per essere ulteriormente ammirate, sui giornali illustrati dell’epoca. Simbolo di questa stagione, Meyerbeer trovò l’apprezzamento in Francia di Balzac, Chopin, Georges Sand, Berlioz, Liszt, ma l’avversione feroce in Germania di Schumann e di Wagner, che pure Meyerbeer aveva sostenuto ai suoi esordi. Lo stile del compositore, nella nuova realtà francese, subì una mutazione verso un canto incline alla narrazione, a dialoghi serrati, pur non mancando nelle sue pagine vere e proprie arie e perfino delle «strette» che, nella loro concitazione, sembrano cabalette larvate. L’Africaine tiene senz’altro conto anche degli apporti lirici di Gounod, il cui Faust era apparso nel 1859. I primi tre atti del libretto dell’Africaine furono proposti da Scribe fin dal 1837, ma problemi con le potenziali interpreti (Falcon e Cruvelli) nonché il volgersi del musicista ad altri progetti, dilatarono per quasi trent’anni la composizione dell’opera, al punto che Verdi, facendo visita ad un Meyerbeer ammalato, lo trovò che ancora lavorava febbrilmente alla strumentazione dello spartito. La morte lo costrinse a lasciarla incompiuta. Venne rappresentata postuma nel 1865, completata dal musicologo-compositore belga François-Joseph Fétis, il quale fu responsabile probabilmente del titolo ingannatore. La protagonista è palesemente un’hindu che adora Brahma, Shiva e Visnù, non un’africana. Meyerbeer voleva intitolare l’opera Vasco Da Gama, il navigatore portoghese, alle cui scoperte si * Critico musicale – Musicologo Dossier «Africaine» fa riferimento nella vicenda. Egli è conteso tra due donne, Inès e Sélika, e quest’ultima, la presunta selvaggia, dimostra straordinaria grandezza d’animo: salva la vita a Vasco e perfino rinuncia a lui, lasciandolo alla rivale per poi suicidarsi. Benché l’opera sia stata un successo e nello stesso anno della sua prima parigina sia stata data a Bologna e Londra, è dal 1892 che L’Africaine non si vede alla Fenice, in linea con una decadenza del grand-opéra nel XX secolo, abbandonato da un pubblico che i kolossal li voleva vedere al cinematografo. Un’aria – «O Paradis!» – cantata con estatico stupore da Vasco al momento dell’arrivo nella rigogliosa terra di Sélika, è stata incisa da mille tenori, a partire da Gigli, Fleta, Lorenz ed ha tenuto viva la memoria di questo titolo. Ma l’opera contiene numerose pagine di pregio. Citeremo innanzitutto la grande aria di Sélika del II atto, l’Air du sommeil «Sur mes genoux, fils du soleil», dolce berceuse che si apre ad un’accorata dichiarazione d’amore, aria che dispiega ricche fioriture e cadenze. Vigorosa è anche la ballata di Nélusko che invoca, durante la perigliosa navigazione «Adamastor, roi des vagues profondes». La scrittura dell’autore domina poderosi pezzi d’assieme, distilla raffinatezze strumentali nel preludio, negli entr’acte, nella Marche indienne che apre il IV atto e nel Choeur dansé, Remparts de gaze, cachez l’extase che lo chiude. Meticoloso e competente Meyerbeer, che assisteva alle prove e cambiava la partitura fino all’ultimo, prescrisse fin dallo spartito che Sélika dovesse essere un soprano drammatico (forte chanteuse) e indicò come esempio vocale Alice, di Robert le Diable o Valentine degli Huguenots. Indicò un tenore drammatico anche per Vasco (fort tenor) suggerendo di far riferimento a Raoul, di Huguenots, o Arnold, di Guillaume Tell. Tra le poche testimonianze discografiche, spicca la produzione di San Francisco del 1971, Verret e Domingo straordinari protagonisti. VENEZIAMUSICA e dintorni | 17 Dossier «Africaine» LE VOCI DELL’«AFRICANA» Grandi interpreti tra Otto e Novecento G di Giorgio Gualerzi* iugno 1962, a Castell’Arquato. Fra i vincitori del prestigioso Premio Illica c’era Eugenio Gara, principe dei «vociologi» (termine a quell’epoca non ancora di moda). «Maestro», gli disse Franco Capuana, autorevole direttore d’orchestra presente alla consegna del Premio, «lo sa che l’anno prossimo dirigerò l’Africana al San Carlo?» Secca e inattesa la replica di Gara: «Chi sarà il baritono?». E aggiunse, a guisa di ammonimento: «Sa, io ho ascoltato Titta Ruffo». Capuana incassò il colpo e si limitò a pronunciare il nome del malcapitato baritono chiamato a impersonare il selvaggio Nelusko: Aldo Protti, che, pur essendo il migliore sulla piazza, alla prova dei fatti fece rimpiangere il grande pisano, restando addirittura a mezzo per carenza di fiato nella famosa Ballata del terzo atto («Adamastor re dell’acque profonde»). Fu questa la pagina che contribuì a fare di Nelusko uno dei personaggi chiave della carriera di Titta Ruffo, che, ebbe a scrivere lo stesso Gara, «non sapevi se più ammirabile nello sconvolgente grido “All’erta marinar!” o nella mesta preghiera a Brahma, oppure nel riso agghiacciante della Ballata e nella toccante scena dell’addio». Il travolgente binomio Titta Ruffo-Nelusko finì addirittura per identificarsi con l’opera stessa, facendo dell’Africana un titolo per baritono, con tenore e soprano in funzione subordinata. Del resto che Nelusko dovesse essere affidato a un baritono di primissimo rango fu chiaro fin dagli esordi italiani, a cominciare dal Comunale di Bologna, nel novembre 1865, che vide scendere in campo addirittura il re dei baritoni di allora, Antonio Cotogni. E infatti molti dei suoi successori – da Leone Giraldoni (primo Simon Boccanegra) a 18 | VENEZIAMUSICA e dintorni Francesco Pandolfini (primo Amonasro alla Scala) – appartengono all’aristocrazia baritonale della seconda metà dell’Ottocento. Non ne faceva invece parte, ancorché apprezzabile durante la sua carriera di belcantista, il «creatore» della parte alla Fenice di Venezia, Luigi Merly. Egli, commentava «La Gazzetta di Venezia», «si mostrò veramente quell’insigne artista che ce [sic] l’avevano decantato, né meglio potevasi esprimere quella vergine energia, quella devozione senza confini, quella rozza fierezza, quel cupo vago e infinito, che, sì magicamente espressi da Meyerbeer, formano di questo personaggio un ente a sé, e quasi un dramma nel dramma». Una parte certo «estremamente faticosa», cui Merly sembrò essere solo in parte adeguato: infatti «dopo di aver detto magnificamente la scena innanzi al Grande Inquisitore, e l’aria “Figlia di regi” nel secondo atto, non potè dare al resto della sua parte quel colorito marcato, che egli aveva saputo imprimerle nel principio». In ogni caso «fu unico nel famoso grido sinistro “Volgete al nord”, e dappertutto grande artista». Merly aveva già impersonato Nelusko al Carlo Felice di Genova nel 1866-1867, ottenendo dal critico del «Corriere Mercantile» un giudizio sostanzialmente più favorevole: «Tutti sovrasta per potenza di voce e verità di espressione drammatica». Il contraltare di Nelusko è rappresentato da Selika, che, sotto il profilo vocale, inclina al soprano drammatico verdiano quale si delineò nel Ballo in maschera, nella Forza del destino e in Don Carlo. Non è infatti per caso che la prima Elisabetta, la belga Marie Sasse, sia stata anche la «creatrice» di * Critico musicale Dossier «Africaine» Selika. Analogamente alla Scala – nel marzo 1866 e nella successiva ripresa del dicembre 1870 – la parte fu interpretata dalla grande cantante viennese Antonia Frietsche, nota in Italia come Antonietta Fricci sposata Baraldi, che nel primo Don Carlo italiano a Bologna impersonò Eboli. Alla Fenice viceversa Selika toccò a un autentico soprano, Marcellina Lotti Della Santa, dalla singolarissima identità vocale: la voce «per la sua purezza adamantina, acquistava nelle note acute una potenza di squillo straordinaria, non raggiunto da nessuna delle voci di soprano anche maggiormente celebrate per la loro forza ed intensità». Questo giudizio di Gino Monaldi rafforza la convinzione espressa dalla «Gazzetta di Venezia»: «la Lotti, colla sua voce fresca ed argentina, colla sua perfetta intonazione, col canto appassionato, ebbe felicissimi momenti e nella berceuse dell’atto secondo e nel duetto del quarto atto specialmente arrivò alla perfezione, e ne fu vivamente rimeritata dal pubblico». Nonostante talune riserve sull’interpretazione drammatica, che la vide talvolta «più dama che schiava», la Lotti «rifulse in tutta l’opera come un vero gioiello». Durante gli anni sessanta la Lotti si trovò spesso associata a Manuel Carrión, ad esempio proprio alla Fenice in occasione dell’Africana, nella quale il tenore sivigliano – uno fra i maggiori esponenti del filone «di grazia» – si confermò «un valente artista [...] che con isquisita maestria sa supplire anche là dove mal gli risponderebbe la forza della voce». Carrión fu solo l’iniziatore, con il parmigiano Emilio Naudin «creatore» della parte all’Opéra, di una privilegiata dinastia di auree ugole che ebbe in Vasco da Gama un punto di forza, annoveran- do non pochi autorevoli esponenti del Gotha tenorile novecentesco. Uno su tutti, documentato da un’incisione memorabile: Beniamino Gigli, per ascoltare il quale vennero allestite nel luglio 1933 sei recite dell’Africana all’Arena di Verona. «Qui», scriverà Eugenio Gara nell’ Illustrazione Italiana, «il finimondo si scatena all’ultimo atto, dopo l’aria “Oh paradiso” [...] che Gigli canta con voce paradisiaca sul serio». Essa, «che ha la serena lucentezza del platino, dà la scalata alle supreme vette del pentagramma con giovanile candore e si effonde in soavissime cadenze pur senza stemperarsi in stucchevoli vaporosità». Quarta fra cotanto senno s’impose, nella parte di Inez, Carolina Mongini, la quale «da quella cantante fina e di buona scuola ch’ell’è, cantò assai delicatamente la sua parte», senza tuttavia essere «del pari eccellente nella parte drammatica del canto e dell’azione». In linea generale, a Venezia la musica dell’Africana piacque parecchio, risultando «veramente stupenda, imperocché al solito fare grandioso, armonico e letteralmente espressivo del Meyerbeer, accoppia uno studio particolare della melodia, sì gradita a noi italiani, da rendere quest’opera più importante di qualunque altra dello stesso autore». L’Africana insomma, concludeva il critico della «Gazzetta di Venezia», «è indubbiamente una bell’opera, che si sentirà ogni sera più volentieri». Dal marzo 1868 al gennaio 1892 le sere trascorse alla Fenice in compagnia dell’opera postuma di Meyerbeer furono cinquantanove ripartite in quattro edizioni; dopo di che su questo grand-opéra dal libretto sconclusionato ma spettacolare e ricco di bella musica calò il sipario. VENEZIAMUSICA e dintorni | 19 Dossier «Africaine» «ACCOMPAGNARE LO SPETTATORE DENTRO LA VICENDA» La lettura del regista Leo Muscato L eo Muscato, dopo aver lavorato giovanissimo con Luigi De Filippo, nel ’97 si trasferisce a Milano per frequentare il corso di regia della Paolo Grassi. Da allora allestisce propri spettacoli, orientandosi prevalentemente verso la drammaturgia contemporanea. Da poco frequenta anche il teatro musicale, conquistando il Premio Abbiati 2012 come miglior regista d’opera. È attualmente alle prese con l’imminente debutto dell’Africaine. L’opera di Meyerbeer è straordinariamente bella, ci sono delle pagine musicali davvero importanti, che permettono allo spettatore di essere preso e condotto in un altro luogo di percezione. E questo è tipico del grand-opéra, che fino ad ora non avevo mai affrontato, provenendo io dalla prosa, anche se da qualche anno mi occupo con una certa costanza anche di lirica. Da un punto di vista musicale dunque L’africaine riserva molte sorprese, per quanto si tratti di un’opera che Meyerbeer non aveva nemmeno autorizzato: aveva cominciato a lavorarci, dopodiché – complice una malattia – l’aveva messa da parte, dedicandosi ad altre cose che erano rimaste in sospeso. Quando si è trattato di mettervi mano il compositore non era più in condizione di poterlo fare, e il progetto è stato affidato ad altri, che l’hanno terminato modificandolo in maniera sostanziale, a partire dallo stesso libretto. Il primo ossimoro di quest’opera nasce dal titolo: si chiama L’africana ma di africano non c’è niente, e proprio per questo all’estero spesso viene intitolata Vasco de Gama. Il vero protagonista infatti è un navigatore, che – superato 20 | VENEZIAMUSICA e dintorni di Capo d’Africa – trova «una grande isola dalle palme verdi», e ci sono tutte le ragioni per poter credere che si tratti del Madagascar. Durante la fase di malattia di Meyerbeer era scoppiata la moda dell’India, e quando si è trattato di riprendere l’opera e di mettere mano alla trama si sono semplicemente cambiate alcune parole e – negli atti quarto e quinto – l’ambientazione è stata completamente spostata in India. Questa discrepanza ci ha un po’ accompagnati nel lavoro di creazione, perché ci poneva nell’obbligo di fare delle scelte, soprattutto per quanto riguardava la direzione da imprimere allo spazio scenico, se cioè rispettare le indicazioni o invece creare un’astrazione. Alla fine ha vinto un pensiero: L’africaine in Italia non viene rappresentata da quarant’anni, e nel mondo comunque è molto poco allestita. Quindi abbiamo optato per farne una versione che rispettasse l’ambientazione che era stata prevista allora. Decontestualizzarla, creando luoghi «altri» rispetto a quelli che sono indicati, sarebbe stata una forzatura. Da anni cerco di perseguire un obiettivo: restituire allo spettatore di oggi, per quanto mi è possibile, la qualità di percezione che poteva avere all’epoca in cui l’opera venne scritta e messa in scena per la prima volta. Rispettiamo perciò la distanza temporale voluta dagli stessi autori, che avevano retrodatato la vicenda di trecentocinquant’anni. Darne una lettura contemporanea avrebbe significato tradire quella distanza che loro stessi avevano fissato. C’è però una cosa che siamo costretti a tradire: i grandopéra erano un’immensa occasione spettacolare, lo spettatore francese, o quantomeno parigino, era preparato durante tutto l’anno a questi veri e propri eventi: veniva organizzata una serie di ma- Dossier «Africaine» nifestazioni che andavano ad accrescere l’interesse verso questi appuntamenti. Per dirla in modo semplicistico, potremmo azzardare un paragone con il grande evento che la macchina hollywoodiana crea attorno a un film come Avatar. Dunque lo spazio che veniva destinato allo spettacolo era esageratamente grande, e noi purtroppo non ce lo possiamo più permettere. La storia prevede dapprima un’ambientazione cinquecentesca e portoghese, poi nel terzo atto una nave sull’oceano, che durante una furiosa tempesta si va a scagliare contro gli scogli e viene assalita dai pirati. Nel quarto siamo finalmente arrivati in India, in un’isola, e vediamo questo mondo meraviglioso che viene raccontato nella famosa aria «O paradiso». Nel quinto atto, infine, siamo in un promontorio sempre all’interno della stessa isola. Con lo scenografo Massimo Checchetto e il costumista Carlos Tieppo abbiamo cercato di dare allo spettatore la possibilità di immaginarsi questi luoghi. Ne è nata una scenografia di grande essenzialità, dove però vi sono degli elementi, come citazioni di atmosfere e paesaggi emotivi, che speriamo possano essere molto evocativi per il pubblico. Ma la cosa più importante, e quella che mi preme di più, è il lavoro con gli interpreti: sono abituato, venendo dal teatro drammatico ed essendo stato prima attore che regista, a porre le maggiori energie in questo ambito, occupandomi di ogni persona coinvolta, dall’ultimo figurante al protagonista assoluto. L’attenzione alla recitazione, al gesto e ai movimenti, è per me fondamentale: attraverso questo processo interpretativo mi auguro che lo spettatore riesca a ricreare dentro di sé, per esempio, la sensazione del mare e la percezione di essere su una nave. Più in generale, mi sono spesso chiesto qual è l’apporto che un regista di prosa può dare all’opera. Questa è la domanda per eccellenza… Io continuo a darmi una risposta: sono un fruitore d’opera, nel senso che la ascolto e la vado a vedere a teatro, e molto spesso la cosa che mi viene a mancare è il racconto: sovente quello che vince su ogni altra cosa è un concetto, un’idea che restano però profondamente astratti e vanno a discapito della narrazione. A me invece piace prendere per mano lo spettatore e portarlo a seguire il racconto senza avere la necessità di guardare i sopratitoli o di capire perfettamente le parole che vengono pronunciate. Quello che accade in scena, gli stati d’animo che stanno vivendo i personaggi, sono sempre codificati con un movimento, con un’azione, e questo crea la fabula. Per questo è mia abitudine chiedere ad alcune persone che non conoscono l’opera se hanno capito la trama. È uno degli obiettivi che considero più importanti nella costruzione di una regia. (testo raccolto da Leonardo Mello) VENEZIAMUSICA e dintorni | 21 Le nuove stagioni – Una panoramica italiana SU IL SIPARIO! I cartelloni dei Teatri nazionali D ove va il teatro d’opera italiano? Dopo aver dedicato un approfondimento alle stagioni lirica e sinfonica della Fenice, proponiamo ora una panoramica delle principali Fondazioni italiane che si occupano di musica d’arte, anche se, per esigenze di brevità, limitata soltanto al versante operistico, tralasciando l’attività concertistica, che ricopre però analoga importanza nella programmazione. A una prima analisi, pur rapida e a volo d’uccello, sembra difficile individuare delle chiavi di lettura univoche, o delle direzioni preferenziali, se si eccettua un ricorrere piuttosto insistito alle opere di Verdi, sulla scia delle celebrazioni per il bicentenario della nascita, che ormai ci lasciamo alle spalle. Un punto di convergenza, non particolarmente positivo, pare essere invece una certa scarsità di opere contemporanee: la musica d’oggi sembra non trovare ancora la sua giusta collocazione nei cartelloni, a fronte di un’attività compositiva tutt’altro che stantia, sia tra i musicisti già affermati – tra i quali si citano almeno Ambrosini, Sciarrino, Vacchi, Solbiati, Mosca – che tra molti interessanti giovani che decidono di affrontare questo difficilissimo mestiere. Emerge d’altro canto la tendenza dei Teatri a instaurare proficue collaborazioni, anche internazionali, rispondendo in questo modo alla crisi e permettendo, nei casi migliori, la circolazione degli spettacoli anche al di fuori dei propri palcoscenici. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta, a livello nazionale, nel prossimo futuro. La stagione 2013/2014 del Teatro alla Scala si compone di sedici spettacoli, dieci d’opera più 22 | VENEZIAMUSICA e dintorni sei di balletto. Sette titoli su dieci sono di autori italiani (Verdi, Rossini, Donizetti, Mascagni) o su libretto in lingua (Così fan tutte di Mozart). Giuseppe Verdi è ancora in posizione dominante, con tre allestimenti: La traviata, Il trovatore e Simon Boccanegra. Daniel Barenboim, direttore musicale del Teatro, dirigerà tre opere: La sposa dello Zar di Rimsky-Korsakov, in una nuova produzione con la regia di Dmitri Tcherniakov; il citato Simon Boccanegra, ripresa dello spettacolo del 2010 orchestrato da uno dei massimi registi italiani viventi, Federico Tiezzi; Così fan tutte di Mozart, nuova produzione inscenata da Claus Guth. La Traviata chiude le celebrazioni dell’anno verdiano e apre la nuova stagione il 7 dicembre 2013, con il ritorno di Daniele Gatti sul podio, il debutto di Diana Damrau come Violetta e la regia ancora di Tcherniakov, nato a Mosca nel 1970 e già vincitore di quattro Golden Mask, massimo riconoscimento russo dedicato agli spettacoli teatrali (l’artista, pur giovane, ha firmato già una quindicina di opere, principalmente di autori connazionali, ed è giunto al suo terzo Verdi, dopo Aida e Macbeth). Interessante si preannuncia il trittico Le Spectre de la rose – La rose malade – Cavalleria rusticana, che unisce danza e melodramma accostando alle coreografie di Michail Fokin e Roland Petit il capolavoro di Mascagni, messo in scena da Mario Martone. Ad aprile tocca poi a Les Troyens di Hector Berlioz, versione musicale dell’Eneide virgiliana, con Gregory Kunde nei panni dell’eroe e Antonio Pappano alla direzione, in un allestimento curato da David McVicar e frutto di una coproduzione con Royal Opera House di Londra, San Francisco Opera e Wiener Staatsoper. A maggio poi arriva a Milano, dopo il debutto fran- Le nuove stagioni – Una panoramica italiana cese, l’Elektra di Strauss nella versione del grande Patrice Chéreau, da poco scomparso. Tra le molte iniziative, si segnala almeno, in ambito extralirico, Un nuovo «Ciclo Pollini» che in quattro programmi pone in dialogo Beethoven e il nostro tempo, con undici Sonate per pianoforte e brani di Boulez, Sciarrino, Stockhausen, Lachenmann. Ne faranno parte Pierre Boulez come direttore, l’Ensemble Intercontemporain di Parigi, il Klangforum Wien e Musikfabrik Köln. L’anno nuovo, al Regio di Torino, porta in dote il Flauto magico mozartiano, in un riallestimento della produzione originale del Massimo di Palermo creata da Roberto Andò. Si prosegue con due Puccini, la Butterfly secondo Damiano Michieletto e Turandot secondo Giuliano Montaldo, entrambi diretti da Pinchas Steinberg. Ancora Puccini poi, sia con la Tosca che con Gianni Schicchi, in abbinata con Una tragedia fiorentina di Alexander von Zemlinsky (che trae l’opera dal testo di Oscar Wilde A Florentine Tragedy). È poi la volta del rossiniano Guglielmo Tell nella versione di Graham Vick (ripresa da Lorenzo Nencini), coprodotto con il Rossini Opera Festival di Pesaro, e soprattutto del nuovo The Rake’s Progress di Stravinsky, opera su libretto di Wystan Hugh Auden e Chester Simon Kallman che vide la luce alla Fenice nel 1951 (e che anche il Teatro veneziano riproporrà la prossima estate), ed è ora realizzata dallo scozzese David McVicar (tra gli enti produttori figura la Scottish Opera di Glasgow). Chiude il cartellone La vedova allegra di Franz Lehár. Un Parsifal particolare apre il 14 gennaio il cartellone del Comunale di Bologna, festeggiando i cento anni dalla prima esecuzione italiana del capolavoro wagneriano, avvenuta proprio qui il 1 gennaio 1914: si tratta dell’allestimento curato da Romeo Castellucci per il Théâtre de la Monnaie di Bruxelles, dove è andato in scena nel 2011: l’artista romagnolo, che cura anche le scene, le luci e i costumi, è una delle stelle del panorama teatrale internazionale, in cui si trova estremamente a proprio agio sin dai tempi della colossale e bellissima Genesi, lavoro che è impossibile ascrivere a un genere preciso e codificato, e che brillò – all’inizio degli anni duemila – per l’assenza di coproduttori italiani, come sempre lungimiranti con i propri fiori all’occhiello. A dirigere l’orchestra sarà Roberto Abbado, reduce dal successo del Macbeth firmato nientemeno che da Robert Wilson e andato in scena nel capoluogo emiliano lo scorso anno. Tra gli otto titoli lirici (cui si aggiungono due balletti), da segnalare, sul versante contemporaneo, la prima assoluta di – qui non c’è perché – di Andrea Molino su libretto originale di Giorgio van Straten, che trae il titolo da Se questo è un uomo di Primo Levi e il cui protagonista assoluto è il vocalist e performer David Moss. È tutto verdiano l’esordio del Carlo Felice di Genova: si aprono le danze con il Rigoletto allestito da Rolando Panerai e diretto da Fabio Luisi, per passare poi all’Otello nella versione di Davide Livermore (sul podio Andrea Battistoni). Ma gli appuntamenti con il genio di Busseto lasciano il posto, nel 2014, a grandi classici come i pucciniani Madama Butterfly e Bohème, le mozartiane Nozze di Figaro, il rossiniano Barbiere di Siviglia e l’immortale Carmen di Bizet, nella messinscena ancora di Davide Livermore, ormai affermato regista d’opera che agli esordi ha lavorato anche per la Fenice, per il Regio di Torino e per il Verdi di Trieste. Da segnalare anche tre opere in forma di concerto, Suor Angelica, Il Tabarro, Anna Bolena, che completano una programmazione sostanzialmente incentrata su un repertorio tradizionale. Il San Carlo di Napoli sceglie per l’ inaugurazione della stagione un titolo classico, Aida, affidato per la scena a Franco Dragone e per la direzione d’orchestra a Nicola Luisotti. Verdi tornerà nel corso del 2014 grazie a un nuovo Otello con la regia di Henning Brockhaus e la direzione di Renato Palumbo, mentre al repertorio appartengono Il barbiere di Siviglia rossiniano in una ripresa del 1998 che può contare sugli splendidi scenari di Emanuele Luzzati, e i Pagliacci di Leoncavallo nell’onirica versione di Daniele Finzi Pasca. Si passa poi a Evgenij Onegin di Čajkovskij nel pluripremiato allestimento realizzato da Michal Znaniecki per l’Opera di Cracovia (in coproduzione con Bilbao e Poznan Opera), e all’opera schiettaVENEZIAMUSICA e dintorni | 23 Le nuove stagioni – Una panoramica italiana mente partenopea Don Checco di Nicola De Giosa: eseguita per la prima volta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1850, Don Checco ebbe un tale clamore da diventare il titolo operistico più rappresentato insieme alla Traviata di Verdi. Allievo preferito di Donizetti, De Giosa si inserisce tra i compositori napoletani che, durante l’Ottocento, tentarono di mantenere in vita la tradizione dell’opera buffa, rifacendosi a moduli rossiniani e donizettiani. In chiusura la Salome straussiana, in uno spettacolo del Teatro Comunale di Bolzano. Una nuova produzione, firmata da Emma Dante, esponente di punta del teatro sperimentale che dopo la Carmen alla Scala ha evidentemente preso gusto all’opera, caratterizza il gennaio del Massimo di Palermo: si tratta di Feuersnot di Richard Strauss, atto unico che rappresenta la seconda prova operistica del compositore tedesco. Seguono un immancabile spettacolo verdiano, l’Otello (coprodotto con il San Carlo), il Don Giovanni di Mozart e – in arrivo da Stoccarda – la Norma di Bellini. Completano il programma La fille du Régiment di Donizetti, la Tosca di Puccini e, da Dresda, Švanda, dudák di Jaromir Weinberger, «Volksoper in due atti» su libretto di Miloš Kareš. Riccardo Muti dà l’avvio alla stagione 20132014 del Teatro dell’Opera di Roma con un inedito Ernani, fosca vicenda ricavata dal dramma di Victor Hugo e messa in scena a novembre da Hugo de Ana. Il cartellone, l’ottobre successivo, si conclude con un altro Verdi, Rigoletto, affidato al giovane e talentuoso Leo Muscato, regista anche dell’Africaine di Meyerbeer che apre la programmazione della Fenice. Tra questi due estremi verdiani però c’è spazio per molti altri spettacoli, che rendono la realtà capitolina una delle più interessanti a livello nazionale. Come è ormai consuetudine, il primo appuntamento dell’anno nuovo sarà dedicato al Novecento, in questo caso con le uniche due opere liriche di Maurice Ravel, L’enfant et les sortilèges e L’heure espagnole, su libretto rispettivamente di Colette e di Franc Nohain. Lo spettacolo, prodotto dal Glyndebourne Festival, è la prima delle ospitalità, cui segue il Maometto secondo di Giacomo Meyerbeer secondo Pier Luigi Pizzi nella rodata 24 | VENEZIAMUSICA e dintorni produzione della Fenice. Tra le riprese si cita almeno L’elisir d’amore di Donizetti nella versione di Ruggero Cappuccio, mentre novità, oltre a Ernani e Rigoletto, sono anche la pucciniana Manon Lescaut, curata da Chiara Muti, e la Carmen di Bizet, in un allestimento in collaborazione con il Teatro di Santiago del Cile. Per una volta si vuole menzionare anche la sezione dedicata alla danza, dove trova posto un coreografo d’eccezione come Micha van Hoecke, impegnato sia nell’evento Verdi Danse che in Notes de la nuit, dove le sue creazioni si alternano a quelle di Francesco Nappa e di Jacques Garnier. Dalle coreografie contemporanee si torna poi alla classicità del Lago dei cigni di Čajkovskij nell’elaborazione di Patrice Bart. Al Petruzzelli di Bari, infine, a novembre giunge un grande regista come Luca Ronconi, che riallestisce per la terza volta il Falstaff verdiano in una nuova produzione che vede il bravo Daniele Rustioni alla direzione d’orchestra. La vera inaugurazione della stagione avviene però a gennaio, con Elektra di Richard Strauss, affidata a un cineasta di fama come Gianni Amelio. Anche la seconda novità, i Pagliacci di Leoncavallo, vede alla regia un altro importante esponente della settima arte quale Marco Bellocchio. Si procede con la ripresa della Traviata nella versione di Ferzan Özpetek, e con il Trittico pucciniano (Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi) firmato da Damiano Michieletto in un allestimento coprodotto da Theater an der Wien e The Royal Danish Theatre (premio Reumert 2013 per il miglior spettacolo). Tra le ospitalità trovano posto poi la Lucia di Lammermoor donizettiana curata da Graham Vick per il Maggio Musicale Fiorentino e, in arrivo da Aix-en-Provence, Il flauto magico mozartiano messo in scena da William Kentridge. In conclusione si vuole dare conto delle omissioni. Non sono qui citate realtà di peso come il Teatro Verdi di Trieste, il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Lirico di Cagliari: il motivo di queste assenze consiste nell’impossibilità, attraverso i rispettivi siti internet, di reperire informazioni sulle loro programmazioni operistiche. Le nuove stagioni – Una panoramica italiana Gli organigrammi delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane Teatro alla Scala (Milano): sovrintendente e direttore artistico Stéphane Lissner (da ottobre 2014 Alexander Pereira); direttore musicale Daniel Baremboim Maggio Musicale Fiorentino: commissario straordinario Francesco Bianchi; direttore principale Zubin Mehta Teatro Carlo Felice (Genova): sovrintendente Giovanni Pacor; segretario artistico Giuseppe Acquaviva Teatro Massimo (Palermo): commissario straordinario Fabio Carapezza Guttuso; direttore artistico Eytan Pessen e Lorenzo Amato (consulenti) Teatro Comunale di Bologna: sovrintendente Francesco Ernani; direttore artistico Nicola Sani (consulente); direttore principale Michele Mariotti Teatro Petruzzelli (Bari): commissario straordinario Carlo Fuortes; direttore musicale Daniele Rustioni Teatro dell’Opera (Roma): sovrintendente Catello De Martino; direttore artistico Alessio Vlad Teatro Regio (Torino): sovrintendente Walter Vergnano; direttore musicale Gianandrea Noseda Teatro La Fenice (Venezia): sovrintendente Cristiano Chiarot; direttore artistico Fortunato Ortombina; direttore principale Diego Matheuz Teatro San Carlo (Napoli): sovrintendente Rosanna Purchia; direttore artistico Vincenzo De Vivo; direttore musicale Nicola Luisotti Teatro Lirico (Cagliari): direttore artistico Umberto Fanni Teatro Verdi (Trieste): sovrintendente e direttore artistico Claudio Orazi VENEZIAMUSICA e dintorni | 25 Le nuove stagioni – Morassi e Rossini BEPI MORASSI E IL BELCANTO B epi Morassi, regista di lungo corso sia nella prosa che nella lirica, negli ultimi anni si è trovato ad affrontare numerose opere del cosiddetto «belcanto», da Donizetti a Bellini a – soprattutto – Rossini. Come mai, dopo tante esperienze nel teatro drammatico, a cominciare dal lavoro con Giovanni Poli, e altrettante nel grande ventaglio operistico, si è orientato con una certa costanza su questi autori? La risposta più semplice potrebbe essere: perché mi propongono quel repertorio… Scherzi a parte, la vita è sempre imprevedibile, e non si può mai sapere dove la professione ti porta. Io ho cominciato con la prosa, molti anni fa. Poi, nell’84’85, sono stato aiuto regista di Roberto De Simone – erano i tempi della Gatta Cenerentola – e ho cominciato a frequentare le «zone di confine» tra teatro e musica, operando in un territorio contiguo, dove parola e suono venivano continuamente mescolati. Mi è poi stata affidata la ripresa di Crispino e la comare, e da allora è iniziata la mia avventura nella lirica, ambito in cui prima non mi ero mai cimentato. Direi che l’’84 è stato l’anno di svolta: a Roma mi avevano chiesto di mettere in scena un Molière, e feci Monsieur de Pourceaugnac, che però, nella nostra elaborazione, era diventato a tutti gli effetti uno spettacolo musicale, grazie all’apporto di un compositore come Germano Mazzocchetti. Dunque anche nei lavori di prosa molto presto hanno fatto capolino le sette note, e direi quindi che il percorso di avvicinamento all’opera era quasi inevitabile. Poi, nell’ultimo periodo, mi 26 | VENEZIAMUSICA e dintorni è capitato di affrontare più volte il belcanto, Donizetti, Bellini, Rossini: probabilmente quel genere di drammaturgia musicale – pur essendomi provato anche in altri tipi d’opera – mi è congeniale, oltre a rappresentare sempre una bella sfida. All’interno di quel mondo, ovviamente, ci sono molte differenze: Rossini, ad esempio, possiede una fortissima teatralità, e mi permette di mettere in gioco le conoscenze che ho acquisito in passato, soprattutto nel campo della commedia dell’arte. È questo infatti il suo iniziale impegno artistico, quando lavorava con Giovanni Poli e a l’Avogaria. Come proietta queste sue esperienze in ambito belcantistico? Prima di tutto vorrei dire che parlare di commedia dell’arte rischia sempre di essere riduttivo, perché quasi tutti hanno in testa un cliché di questo tipo di teatro, e lo riportano automaticamente alle solite quattro maschere. Ma questo è un modo di guardare quantomeno semplicistico: il succo della commedia dell’arte sta nel fatto che è il primo esempio di teatro professionistico. Da questa particolarità, per esempio, nasce la tendenza al virtuosismo. Ma c’è un altro aspetto, che ho ereditato da Poli e che ho sempre cercato di perseguire, e cioè il cogliere, di quel tipo di recitazione, il concetto di astrazione, di gesto mai realistico. Che proprio Rossini, per tornare alla domanda, traduce in musica. È in questo, secondo me, che si può accostare alle pratiche della commedia dell’arte, non tanto e non solo nella corrispondenza tra personaggi, che pure – anche se sembra banale dirlo – esiste. Quan- Le nuove stagioni – Morassi e Rossini do ho preso in mano Il barbiere di Siviglia, infatti, ho subito pensato che fra don Bartolo e Pantalone vi fosse una corrispondenza: i ruoli classici della commedia dell’arte, i due vecchi, gli amorosi, il servo, in un certo senso confluiscono nell’opera. È un dato di fatto, a patto però che poi tutto non si risolva in macchietta. Mentre la tipizzazione astratta dei personaggi fornisce una potente arma per affrontare un fenomeno prettamente teatrale come Rossini. Perciò la sua musica a mio avviso è più giusto allestirla in questa chiave che come invece alle volte capita di vedere, soprattutto in Germania. Per me – lo ripeto – l’astrazione è fondamentale: e da questo assunto deriva il fatto che, in linea teorica ma non troppo, un bel Rossini si potrebbe realizzare anche senza allestimento, solamente sfruttando il gioco coreografico, inteso nel senso etimologico di «disegnare nell’aria», attraverso movimenti e gestualità che non devono mai cedere al realismo. Forse ora il Barbiere non lo rifarei esattamente uguale a quello nato ormai parecchi anni fa, ma comunque, nelle diverse edizioni, la riuscita è sempre dipesa dalla propensione degli interpreti a perseguire un disegno d’insieme, lasciando perdere i personalismi e le caratterizzazioni realistiche. Per questo amo molto lavorare con artisti giovani, che sono più equilibrati e disponibili: diventa più interessante, ed è sempre una scoperta continua. Mi parli di un altro allestimento fortunato, L’elisir d’amore di Donizetti, tornato in scena poco fa alla Fenice. È uno spettacolo cui sono molto affezionato, e che nella sua gestazione ha avuto due fasi. La prima, che definirei più generica, si basava su un cast di grandi cantanti. Nella seconda fase invece ho voluto imprimergli la direzione cui accennavo poco fa. In quest’ultima edizione, avendo avuto la possibilità di lavorare con una compagnia di giovani, bravi tanto dal punto di vista vocale che da quello teatrale, mi è stato possibile far prevalere la mia visione: grazie alla disponibilità di questi interpreti, all’equilibrio che si è creato tra di loro, ne è nato uno spettacolo armonico, senza punte ma con un livello molto alto di concertazione e anche d’interpretazione complessiva. È stato molto piacevole reinventare delle situazioni proprio perché si è potuto puntare in direzione dell’astrazione. Lavorare con artisti che non hanno ancora – e forse non avranno mai – la necessità di essere per forza osannati dal pubblico, permette di comprendere che l’equilibrio teatrale generale è più importante che non il risultato del singolo. In questo senso è stato determinante anche l’apporto del direttore d’orchestra, Stefano Montanari, che è una persona teatralmente molto attenta e stimolante. A gennaio andrà in scena al Malibran, con la sua regia, La scala di seta, uno degli atti unici di Rossini. Come ho cercato di fare con L’inganno felice, mi piace far vedere che i cinque atti unici di Rossini – normalmente considerati opere minori, piccoli gingilli che hanno però in nuce le grandi opere – appartengono già al Rossini maggiore. E per centrare questo obiettivo è necessario costruire una drammaturgia che li contenga, certo senza sovrastarli, perché si rischia se no di appiattirli o soffocarli, mentre sono dei meccanismi già perfetti di per se stessi, anche teatralmente parlando. La scala di seta la ambienterò in un’atmosfera cinematografica, con tutto un mondo che ruota intorno alla vicenda: è come se si vedesse tutto attraverso la vetrata di un grande albergo. Lavoro con grande piacere con i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti, perché da loro provengono sempre idee nuove e interessanti. Tra l’altro l’allestimento della Scala di seta è stato progettato da Fabio Carpene, lo stesso che aveva realizzato L’inganno felice. Forse perché tra noi esiste un’affinità, dei dieci, quindici progetti presentati il suo è quello che più da vicino si collegava alla mia idea. (l.m.) VENEZIAMUSICA e dintorni | 27 Contemporanea – «Aspern» «ASPERN» AL MALIBRAN L’analisi di Salvatore Sciarrino A a cura di Leonardo Mello spern, il lavoro di Salvatore Sciarrino ispirato al racconto di Henry James, dopo trentacinque anni (il debutto, al Teatro della Pergola di Firenze, risale all’8 giugno del 1978) è tornato in scena a ottobre in un nuovo allestimento del Teatro La Fenice a cura del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche del Teatro dello Iuav e la direzione di Marco Angius. Ne parliamo con l’autore. Perché ha scelto Henry James, un autore estremamente letterario, per un’opera teatrale? Perché è uno fra i primi, in senso moderno, a scoprire lo sdoppiamento, a indagare i problemi dell’identità, del moltiplicarsi e dello scambiarsi dei ruoli. Conosce bene i meccanismi della creatività e tutto ciò che ha a che fare con il doppio, con l’immagine, con il moltiplicarsi delle immagini. Esplora la problematicità del linguaggio. Tutti questi elementi in James sono già presenti. Come mai il Carteggio Aspern? Prima di tutto perché è la storia di uno scrittore sulle tracce di un altro scrittore. E questo fa scattare un meccanismo per cui si può immaginare un compositore sulle tracce di un altro compositore, che posso essere anche io stesso… Tant’è vero che il Carteggio Aspern si conclude in un nulla di fatto: in realtà questo misterioso scrittore addirittura scompare, dato che le sue carte vengono bruciate. 28 | VENEZIAMUSICA e dintorni Cosa ci può dire dell’edizione del ’78? Era uno spettacolo magico, oltre che macchinoso come scenografia. Le mie opere non si basano mai su una drammaturgia teatrale nel senso tradizionale. Direi piuttosto che stanno «dopo il cinema», chiamando con quest’espressione in causa l’idea di inquadratura, sequenza e taglio delle scene. Allora il tutto era giocato su dialoghi in cui cambiava il punto di vista: la stanza veniva vista da parte di uno dei personaggi, oppure da parte del secondo, del terzo… Molti teatri avrebbero voluto riprenderlo, ma rinunciarono per la manovrabilità degli elementi scenici. È questo il motivo per cui non girò, ricordo soltanto una nuova produzione a Stoccarda, dove Aspern venne inserito in cartellone. Ma non l’ho vista: di solito non seguo molto le mie cose, perché penso che debbano avere la loro vita. Di che tipo di struttura musicale si tratta? Da più parti viene lamentata una certa difficoltà nel capire cos’è il moderno. Finché però noi agitiamo questo spettro non entreremo mai in contatto con le opere. Perciò sono abbastanza contrario a raccontare un mio lavoro, perché il racconto è già la sintesi di un’esperienza vissuta da altri, quindi non comunica l’esperienza. Genericamente, per quello che riguarda la stranezza o l’unicità di questa operazione – non potrei chiamarla opera e nemmeno singspiel, che in fondo era un termine provocatorio e di comodo – potrei dire che porta in scena il suono dell’inanimato, cioè ripropone Contemporanea – «Aspern» continuamente la sorpresa, lo stupore e l’entusiasmo di tornare sempre bambini. Che non vuol dire tornare indietro nel tempo, ma essere sempre capaci di rinnovarsi. Dal punto di vista sonoro, è un po’ come fare l’esperienza del suono delle stanze vuote: cosa si sente quando non c’è nessuno? Lo spettacolo d’altro canto può essere molto semplice e godibile, e ora viene realizzato in modo lievemente diverso rispetto alla prima edizione, che dirigevo. Ma è giusto che le cose cambino e trovino nuove fisionomie. Se dovessimo ascoltare Mozart come lo eseguiva lui stesso la sua musica sarebbe morta. Io stesso come autore mi entusiasmo nell’assistere a nuove soluzioni per i miei lavori. Marco Angius contrae e sovrappone: ci sono dei momenti di inspessimento del tessuto tra parola e suono. Mi sembra una lettura riuscita, anche perché dà al tutto una sorta di atmosfera di quell’epoca, gli anni settanta. In realtà Aspern, un po’ come tutto quello che ho scritto, nasceva in aperta polemica rispetto a quello che si faceva allora. Era un oggetto che nessuno sapeva bene come collocare, assolutamente non ortodosso. Nello sviluppo delle varie tappe della mia evoluzione drammaturgica ho sempre avuto un’ idea sistematica: quella di riuscire ad affrontare un problema alla volta per poi alla fine rimettere insieme tutto. A quell’epoca mi trovavo ancora nella fase in cui volevo combattere con la parola parlata. Aggiungo che si è trattato di un tentativo di riduzione estrema di tutti i mezzi a disposizione: gli organici si rimpiccioliscono, la scrittura diventa solistica, le masse si concentrano in linee, magari più spesse. Questa riduzione è il presupposto per poi lavorare meglio sull’espressione dei mezzi. Il linguaggio quasi si pietrifica, o si polverizza. E questo fenomeno è ancora più evidente oggi in un’acustica come quella del Malibran. Che significa per lei «combattere con la parola»? È chiaro che con la parola come struttura logica non si combatte ma ci si allea, e anzi bisogna sempre mantenere, nel canto, anche la forza e il potere della parola. In questo caso si trattava proprio di un fatto tecnico, la messa a fuoco di un modo di gestire un testo in scena. Il testo nor- malmente viene cantato, mentre in questo caso c’è una cantante che fa la parte della cantante e non impersona alcun personaggio. Qui i personaggi, che normalmente in un’opera cantano, parlano. È un’operazione che crea il presupposto per rendere centrale la parola, come ancora accadrà in Lohengrin. Così come a sua volta Luci mie traditrici rovescia il modello formale di Lohengrin, basato sulla parola e solo alla fine sul canto: è solo cantato e alla parola è destinata solo l’ultima scena. Ma lì ci troviamo già in una fase in cui io avevo creato uno stile vocale mio, inconfondibile. Nella mia carriera di drammaturgo c’è stato un momento di crisi, o meglio di presa di coscienza del fatto che, mentre usavo gli strumenti per quella che era veramente la rivelazione della loro natura, la stessa cosa non facevo con le voci, le quali seguivano gli strumenti in maniera piuttosto ibrida. Certo non con residui del canto tradizionale, però neanche con l’invenzione di nuovi canti. Si «impastavano» agli strumenti ma non avevano una loro caratteristica articolazione, che invece ho costruito in una decina d’anni, partendo dal grado zero, rappresentato da Vanitas, e passando attraverso composizioni magari non pienamente teatrali, come La perfezione dello spirito sottile. Però Perseo e Andromeda – ed erano passati appunto dieci anni – afferma davvero un nuovo stile. Ci sono delle invenzioni che sostituiscono egregiamente il recitativo perché sembrano parlate e invece sono controllate con il canto, efficacissime perché sono l’inizio di una nuova possibilità di esprimere tutte le sfumature psicologiche. Questo è un fatto estremamente importante, a me interessa il teatro rappresentativo. Al contrario il teatro come arredo della scena non solo non mi interessa, ma mi sembra una modalità assolutamente negativa nel campo dell’arte. Io desidero riformare il teatro, ovviamente non nel senso di un ritorno all’indietro ma ponendomi l’obiettivo di crearne nuove forme. Il potere del teatro è sociale, perché si gode insieme agli altri della rappresentazione e si esce dalla sala mutati. Anche la musica è un’attività sociale, perché la sua fruizione è collettiva, ma a teatro noi ci immedesimiamo in altre persone e in altri luoghi, e questo ci cambia, ci dà una coscienza dell’altro e di noi stessi che prima non possedevamo. VENEZIAMUSICA e dintorni | 29 Contemporanea – «Aspern» In conclusione, andando oltre Aspern, vorrei il suo parere sulla situazione in cui deve operare oggi un compositore. La disattenzione nei confronti della musica, rispetto alle altre arti della contemporaneità, è particolarmente acuta. Ma questo dipende soprattutto da come abbiamo impostato la società e la scuola. Nelle altre nazioni la didattica segue altri percorsi, che comprendono e favoriscono l’abitudine alla musica e alle arti sceniche, quindi le giovani 30 | VENEZIAMUSICA e dintorni generazioni non hanno questa difficoltà. Come fa il pubblico ad abituarsi a cose che non ha mai sentito se l’esperienza di andare a un concerto diventa un fatto puramente occasionale? Per questo non abbiamo più pubblico. L’Italia poi è un Paese di pigri, di televisivi, anzi di televisori. Non so come sia possibile uscire da questa situazione. Dal canto mio, dopo molti anni di docenze all’estero, ho accettato di tornare a insegnare qui, per spirito di servizio, perché è l’unica cosa che posso fare per il mio Paese, anche se è una goccia nel mare. Contemporanea – «Aspern» SALVATORE SCIARRINO Una biografia artistica del compositore palermitano G di Gianfranco Vinay* ianfranco Vinay è uno dei maggiori studiosi di Salvatore Sciarrino. Con la sua autorizzazione presentiamo in traduzione italiana un estratto del suo saggio dedicato al compositore e pubblicato sul sito dell’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/ Musique di Parigi (ircam.fr), dove è possibile trovare anche l’elenco delle opere e una nutrita bibliografia. Salvatore Sciarrino, salvo per qualche corso in privato, ha studiato la musica e la composizione come autodidatta. Tale scelta fu decisiva per lo sviluppo di una personalità libera, alla ricerca costante di una visione interiore e poetica capace di guidare operazioni pratiche e tecniche di composizione musicale. Per il giovane artista che aveva cominciato a comporre fin dall’età di dodici anni, le «Settimane Internazionali di Nuova Musica» di Palermo (19601968), uno dei primi festival di musica contemporanea in Europa, non furono solamente un’opportunità per entrare in contatto con compositori di spicco all’epoca (tra cui Stockhausen che ebbe un impatto del tutto particolare sulla sua personalità artistica), ma gli diedero anche l’opportunità di presentare al pubblico le sue prime opere. In Aka aka to I, II, III, creato nel 1968, la lussureggiante vegetazione di suoni strumentali che accompagna i vocalizzi del soprano che canta un testo di Bashō, sospende il tempo in un’estasi sonora. Amore e Psiche (1972), su libretto di Aurelio Pes, la prima opera di Sciarrino, è un allargamento di tale drammaturgia sonora estatica, basata su un continuum strumentale che sostiene i vocalizzi delle quattro voci acute (contro-tenore, mezzo soprano e due soprani), nonché la recitazione dell’at- tore. Nel campo della musica orchestrale, le prime opere importanti sono una Berceuse (1969) basata su principi aleatori che articolano un intreccio di quattro gruppi di strumenti, e Da a da da (1970), entrambe presentate alla Biennale di Venezia. Dall’inizio della sua carriera, è una poetica di sfida e di superamento a nutrire al tempo stesso la sostanza sonora e la forma delle sue opere. La sua posizione rispetto al passato non è storico-parodica, ma piuttosto vicina a quella che Luigi Nono riassume nel titolo di un’opera-manifesto: La Lontananza Nostalgica Utopica Futura. Appropriarsi della tradizione vivente per estrarne elementi che possano articolare un linguaggio nuovo, rifiutando però la tradizione nelle sue forme accademiche. Quest’ultima impedisce difatti di sfruttare l’«approccio antropologico» agli strumenti, caro al compositore: «servirsi di strumenti esistenti, tali e quali come sono, ma farli rivivere», inventando «tecniche nuove che la tradizione consolidata impediva di vedere». La virtuosità trascendentale (soprattutto quella di Chopin e di Paganini) fu cruciale nel percorso di Sciarrino per un rinnovo delle tecniche e delle sonorità degli strumenti. Basandosi sul principio che chiama «inerzia auditiva» (oltre una certa soglia, l’orecchio è incapace di discriminare due o più suoni eseguiti ad alta velocità), Sciarrino compone opere in cui esplora nuovi mondi sonori. Nella prima Sonata per piano (1976), la rapidità di esecuzione trasforma le figure pianistiche in filamenti, in fosfeni sonori; nei sei Capricci per violino (1975-1976), le acrobazie del solista che suona * Musicologo – Université de Paris VIII – St. Denis VENEZIAMUSICA e dintorni | 31 Contemporanea – «Aspern» soprattutto su armoniche iper-acute conducono a una metamorfosi della sonorità dello strumento. A coronamento di questo primo periodo d’intensa creatività è Un’immagine d’Arpocrate, grande opera per piano, orchestra e coro, la cui composizione richiese parecchi anni (1974-1979). L’atmosfera sonora, cosparsa delle risonanze dei piatti e delle armoniche iper-acute delle corde, degli arabeschi sonori del pianoforte e dei soffi degli strumenti a fiato, comunica un sentimento di allontanamento, di distanza abissale, preparando la rivelazione finale dell’enigma poetico sottostante, con il coro che canta frammenti di Wittgenstein e Goethe. La gamma espressiva del compositore non doveva ridursi tuttavia a sonorità evanescenti e fantomatiche, alle figure musicali «filanti» così caratteristiche delle sue partiture negli anni settanta. Sciarrino comincia presto a esplorare altre sonorità che rievocano fenomeni sonori corporali o naturali: respirazione, soffi, battiti del cuore, grida di animali, percussioni, ecc. Gli strumenti a fiato, a causa dell’intima relazione «pneumatica» tra il corpo del musicista e quello dello strumento, diventano il campo di sperimentazione privilegiata di queste sonorità e di queste figure musicali «biologiche». In questa ricerca, è centrale come strumento il flauto. All’aure in una lontananza (1977) è il prototipo di una serie di brani per flauto solista, che vanno a rinnovare il repertorio e la tecnica dello strumento nei seguenti decenni. In ogni brano, alcune figure musicali prodotte dalle nuove tecniche di emissione sonora (armoniche naturali o artificiali, suoni soffiati, respirazione amplificata, glissandi acuti) o dalle tecniche di avanguardia trasformate in figure sonore (suoni molteplici, colpi di lingua, percussioni di chiavi) sono disposte seguendo varie strategie per drammatizzare la combinazione e la messa in risonanza di tali figure nello spazio sonoro e temporale. Sciarrino chiama «forma a finestre» questo modo di disporre le figure, in cui ciascuna apre un nuovo spazio temporale – così come nel caso delle «finestre» normalmente inserite nelle interfacce informatiche. Nelle presentazioni delle proprie opere, il compositore prende sempre più coscienza del fatto che questo sistema di disposizione, oltre alla ripetizione (nel senso del «ritornello» di Deleuze), 32 | VENEZIAMUSICA e dintorni sono i principi fondanti su cui si articola la sua musica. Avendone preso coscienza, svilupperà una speculazione sul rapporto tra musica, altre arti e coscienza umana, i cui principi sono spiegati in Le figure della musica. Queste figure, ispirate dai processi naturali e matematici (processo di accumulo e di moltiplicazione), dalla fisica (little bang), dalla biologia (trasformazioni genetiche) e dall’informatica, mostrano che una certa forma, moderna, di psico-acustica è alla base della sua poetica e della sua pratica creatrice. A dimostrazione del rinnovamento della sua arte musicale verso la fine degli anni settanta, sono i titoli delle opere, la cui natura cambia. La nomenclatura tradizionale lascia oramai il posto a titoli che suggeriscono immagini poetiche – immagini notturne (Ai limiti della notte, Autoritratto nella notte, Allegoria della notte, La navigazione notturna), mitologiche (Hermes, Raffigurar Narciso al fonte, Centauro marino, Venere che le Grazie la fioriscono), enigmatiche (Come vengono prodotti gli incantesimi?, Muro d’orizzonte), cromatiche (Codex purpureus, Introduzione all’oscuro, Esplorazione del bianco), ecc. La funzione di questi titoli, così come quella delle note di programma, non è quella di identificare i «soggetti» delle corrispondenti rappresentazioni sonore, ma di offrire agli ascoltatori alcune vie di accesso possibili alla sua musica. La notte, il silenzio, il vuoto, i giochi visivi tra immagini sonore e archetipi culturali, biologici e antropologici: tutto suggerisce metafore che costruiscono un universo sonoro e poetico in costante espansione. Nel campo della musica per pianoforte, il compositore mira allo stesso scopo poetico, come nei lavori per strumenti a corde e per strumenti a vento: concepire traiettorie formali in grado di fare risuonare figure sonore capaci di svelare l’anima dello strumento (o, nel caso del pianoforte, la sua natura di percussione). Tra le quattro sonate composte durante i decenni 1980-1990 (seconda, 1983, terza, 1987, quarta, 1992, quinta, 1994) la quarta, fondata su «risonanze mobili» di un solo gesto pianistico (due cluster simultanei alle estremità della tastiera ai quali rispondono due grappoli di tre suoni al registro centrale) è certamente radicale. Dopo una ricerca su varie soluzioni dramma- Contemporanea – «Aspern» turgiche sperimentate in tre opere teatrali composte negli anni settanta (Amore e Psiche, 1971-1972, Aspern, 1978, e Cailles en sarcophage, 1980), Sciarrino inaugura, all’inizio degli anni ottanta, una concezione drammaturgica nuova con Vanitas (1981) e Lohengrin (1982-1984). Vanitas, natura morta in un atto per mezzosoprano, violoncello e pianoforte è un ciclo di melodie su frammenti scelti tra testi poliglotti ricchi di immagini che appartengono alla costellazione simbolica rievocata dal titolo (la «vanitas» in quanto «vanità» barocca ed in quanto «vuoto»). Lohengrin, azione invisibile, è la rappresentazione sonora della follia della protagonista, Elsa, la cui voce assume una funzione cosmogonica. Come in un monologo di Beckett, la scena è un luogo sospeso tra vari stati di coscienza e realtà interiori (spazio mentale: coscienza, memoria) ed esterne (suoni della natura e del paesaggio sonoro che la circonda). Sciarrino, per confondere l’azione della «moralità leggendaria» di Jules Laforgue da cui ha tratto il libretto, usa il testo come serbatoio da cui estrae alcune frasi qua e là, ricomponendolo a suo piacimento, ma inverte anche l’ordine degli avvenimenti e degli episodi. D’ora in poi, la composizione di un’opera vocale sarà sempre preceduta da un lavoro sul testo. Mettendo insieme parole e frasi estratte da testi più lunghi, Sciarrino li adatta alle sue necessità poetiche, musicali e drammaturgiche, e soprattutto al principio dell’«azione invisibile», secondo cui la ragione di essere del teatro musicale non è la rappresentazione scenica in sé, ma il potere che ha la musica «di rappresentare, di suscitare pure illusioni». Tale principio è rispettato sia nelle opere dove l’azione è realmente «invisibile» (La perfezione di uno spirito sottile, per voce e flauto, 1985, ispirato da un testo orfico; Infinito nero/estasi di un atto, 1998, monodramma «acusmatico», concepito partendo dalle estasi di Santa Maria Maddalena dei Pazzi), sia in quelle rappresentate in teatro. Sia nelle opere derivate da testi letterari (Perseo e Andromeda, 1990 dalla «moralità leggendaria» omonima di Laforgue, Da gelo a gelo, 2006, dal diario della cortigiana e poetessa giapponese Izumi Shikibu), che nelle opere concepite partendo da opere teatrali preesistenti (Luci mie traditrici, 1996, da Il tra- dimento per l’onore, dramma barocco pubblicato sotto il nome di Giacinto Andrea Cicognini; Macbeth/tre atti senza nome, 2002, da Shakespeare). I testi originali diventano pretesti per attivare aspetti drammaturgici ai quali Sciarrino è particolarmente sensibile: l’impossibilità di amare (Lohengrin, Perseo e Andromeda, Luci mie traditrici, Da gelo a gelo); il fascino della notte, dell’oscurità e degli stati ai confini tra realtà e visione, tra esaltazione e follia; l’«ecologia sonora» (cioè il rapporto tra azione drammatica e il suo ambiente naturale sonoro). Un’opera emblematica della congiunzione poetica della notte e della lucida follia del genio è Morte di Borromini per orchestra con lettore (1988) che, dal testo autobiografico di Borromini, rappresenta sotto forma di melodramma la notte nella quale questo grande architetto si suicidò. Avendogli l’uscita dell’opera di Schnittke su Gesualdo (1995) impedito di evidenziare le analogie tra gli intrighi del dramma di Cicognini e la storia del principe musicista ed omicida, Sciarrino riprese il suo progetto di opera teatrale su Gesualdo in La terribile e spaventosa storia del Principe di Venosa e della bella Maria (1999) per il Teatro dei «pupi» siciliani. Alcuni brani musicali di Gesualdo e di Domenico Scarlatti vi sono rielaborati per voci, quattro sassofoni e percussioni, tra cui una Gagliarda, rielaborata anche con altri brani del principe di Venosa in Le voci sottovetro per voce e complesso di otto strumenti. Come precisato da Sciarrino nella presentazione di Cadenzario (per orchestra, 1991), antologia di cadenze mozartiane interrotte da bruschi tagli, l’interferenza tra il tempo (e lo stile) del passato e il tempo (e lo stile) del presente fa spuntare un terzo tempo: «la prospettiva immaginaria». Impostare e tenere sotto controllo una tale prospettiva è una sfida particolarmente audace, che il compositore ha affrontato in modo originale nella sua Trascrizione per flauto (1993) della Toccata e fuga in re minore di Bach. Nelle opere vocali e teatrali di Sciarrino, alla purezza del testo verbale corrisponde una nuova vocalità basata su una costellazione di piccole figure lamentose che ricordano una caratteristica della prosodia del linguaggio verbale: la fluttuazione dell’altezza e dell’intensità della voce secondo l’accentuazione delle parole e la pronuncia della frase. VENEZIAMUSICA e dintorni | 33 Contemporanea – «Aspern» Spesso la prosodia musicale non rispetta quella verbale, ed è raro che tra espressione verbale ed espressioni musicali sia messo in evidenza un «affect» per una figura rigorosamente corrispondente. Pure mantenendo l’intelligibilità del testo, il compositore rompe il rapporto tradizionale tra retorica e significato, il canto divenendo così un pantografo musicale che esprime l’antropologia e la patologia della voce umana. Negli anni novanta il catalogo di Sciarrino si arricchisce di opere strumentali, dove si spinge all’estremo la drammatizzazione del contrasto tra silenzio e scoppio sonoro. In due opere per orchestra (Soffio e forma, 1995, e I fuochi oltre la ragione, 1997), introduce spari di pistola. Nel 1997 sperimenta nuove forme di spazializzazione del suono, riunendo complessi giganteschi di flauti (Il cerchio tagliato dei suoni per 4 flauti solisti e 100 flauti migranti) o sassofoni (La bocca, i piedi, il suono per 4 sassofoni contralti e 100 sassofoni in movimento). In Studi per l’intonazione del mare, con voce, quattro flauti, quattro sax, percussione, orchestra di cento flauti, orchestra di cento sax, 2000) i due complessi «mostruosi» sono convocati e fusi per introdurre e accompagnare una voce di contralto che canta un testo di Thomas Wolfe su San Francesco d’Assisi. In parallelo, il compositore si è interessato da vicino alla musica vocale. L’alibi della parola a quattro voci (1994), L’immaginazione a sé stessa, per coro e orchestra (1996), Cantare con silenzio (1999) per sei voci, flauto, risonanze e «percussioni» e, più recentemente, Quaderno di strada (2003) per baritono e complesso strumentale, sono opere particolarmente ilustrative della sua ricerca di rap- 34 | VENEZIAMUSICA e dintorni porti nuovi tra testi e musiche. In Cantare con silenzio – ossimoro estratto da una delle estasi verbali di Santa Maria Maddalena dei Pazzi – riflessioni filosofiche sulla conoscenza (Michel Serres), sul rapporto tra tempo soggettivo e tempo obiettivo (Michel Serres e Henri Bergson), oltre che speculazioni scientifiche sul vuoto e la curva spazio-tempo (Edgard Gurzig e Isabelle Stengers) incitano Sciarrino a creare immagini musicali equivalenti. Nel secondo e nel terzo movimento, la relatività del tempo soggettivo rispetto a quello obiettivo è suggerita dagli sfasamenti e dagli spostamenti progressivi tra i ritorni delle figure, creando l’illusione di un capovolgimento dell’asse temporale. La raccolta più recente di brani per voci e strumenti, Quaderno di strada, composto partendo da tredici frammenti testuali registrati nei quaderni del compositore (di cui il titolo: quaderno di viaggio), è un’opera particolarmente importante nel percorso di Sciarrino, che mostra come la creazione artistica può salvare dall’oblio immagini frammentarie ed effimere, magnificandole e rendendole indimenticabili. (traduzione dal francese di Hélène Carquain) Tra il 2012 e il 2013 Sciarrino ha composto alcuni nuovi lavori, che citiamo in ordine cronologico: L’ideale lucente e le pagine rubate (per archi), Ombre nel mattino di Piero (quartetto n.9, per quartetto d’archi), Perturbazione in arrivo nel settore trombe (per corno e orchestra) e Gesualdo senza parole (per strumenti e percussione). Contemporanea – «Aspern» SCIARRINO FRA BRITTEN E JAMES Giochi di specchi e rimandi colti in una Venezia dai contorni foschi L di Michele Girardi* ’inventiva di Henry James ha nutrito abbondantemente le drammaturgie moderne: la sua prosa elegante, imbevuta di psicologia, l’uso raffinato del monologo interiore, il dono di saper maneggiare con maestria la suspense e, più in generale, il suo metodo di raccontare adottando il punto di vista di un personaggio esteriorizzandone le reazioni profonde, gli hanno guadagnato un posto d’onore fra gli scrittori tardo ottecenteschi e fin de siècle. Nessun melomane potrà mai scordare l’inquietudine sottile che permea le pagine di The Turn of the Screw, per citare uno dei suoi titoli più famosi e meglio adattati per la scena lirica. Sciarrino allude al capolavoro di Benjamin Britten mediante riferimenti formali (forma con variazione e Singspiel) e timbrici (orchestra da camera), come notava Giorgio Pestelli nella sua esemplare recensione della première […], ma anche per nessi intertestuali voluti, come la presenza di due bambini nel cast della prima assoluta fiorentina, i fratelli Georgia e Davide Lepore, la prima (scelta di gran peso drammatico) nel ruolo della decrepita Giuliana, il secondo in quello dell’ermafrodito. Come nota Tarcisio Balbo nell’In breve (contenuto nel libretto da cui si trae questo saggio, ndr.): «Si aggiunga che la prima rappresentazione di The Turn of the Screw avviene, nel 1954, nella Venezia in cui è ambientato anche The Aspern Papers dello stesso James, e che in entrambe le opere sono impegnati, accanto agli adulti, un bambino e una bambina, e diventa sin troppo facile creare, a scopo esplicativo, un multiplo gioco di specchi che rimanda da Britten a James ad Aspern di Salvatore Sciarrino, che, manco a farlo apposta, fu rappresentato per la prima volta nel 1978 a Firenze: la stessa città in cui James concepì e terminò il proprio racconto nel 1887». Non solo inquietudine, ma anche orrore circola nell’opera di Sciarrino, a cominciare dall’immagine di Giuliana che il narratore recepisce come una «reliquia» che «portava sopra gli occhi un orrendo schermo verde» (I.4). Vi si aggiunga un parallelo che sorge spontaneo nell’appassionato d’opera, fra la scena del tentato furto in cui il protagonista, invaso dalla sua passione, causa la morte di Giuliana (II.15), e quella in cui Hermann, nella Dama di picche, provoca il decesso dell’incartapecorita Contessa, roso dalla pazzia, per rubarle il segreto delle tre carte. Scelte drammatiche raffinate, che assecondano magnificamente il carattere della musica di Sciarrino. The Aspern Papers è forse una delle novelle più celebri e riuscite di James, ed è forse tra le sue vicende quella che ha incontrato maggior favore di musicisti e registi, teatrali, cinematografici e televisivi. Dal 1947 a oggi quattro pellicole, tra cui The Lost Moment (in italiano Gli amanti di Venezia), un thriller di Martin Gabel con molti tratti dell’horror, e un film per la televisione italiana diretto da Sandro Sequi nel 1972, protagonista Nando Gazzolo, fratello maggiore di Virginio interprete del narratore nella première di Aspern di Sciarrino sei anni dopo (solo un caso?). E se l’adattamento più celebre per il teatro di parola vide impegnata Vanessa Redgrave nel ruolo di Titta al Theatre Royal Hay* Associato di Drammaturgia musicale all’Università di Pavia VENEZIAMUSICA e dintorni | 35 Contemporanea – «Aspern» market di Londra, un’altra opera è stata ricavata dal racconto: oltre a quella di Sciarrino (1978), The Aspern Papers di Dominick Argento presentata dall’Opera di Dallas dieci anni dopo. In quest’ultimo lavoro il luogo dell’azione passa da Venezia al Lago di Como, e ancora la storia trasmigrerà una volta nelle Baleari (nel film Els papers d’Aspern di Jordi Cadena, 1991) e una persino nella foresta venezuelana (nel film di Mariana Hellmund, 2010). Strano, perché Venezia sembra proprio una sede ideale dove ambientare la fosca vicenda, e venne scelta proprio per il suo fascino cupo da James, che scrisse gran parte del racconto ospite di un’amica 36 | VENEZIAMUSICA e dintorni americana in un palazzo veneziano, nel febbraio 1887. Sciarrino valorizza questa scelta affidando al timbro del complesso strumentale un ruolo di primo piano, visto che l’opera, in realtà, è prevalentemente recitata dai tre attori. Una sola voce, di soprano, interviene intonando versi di Lorenzo Da Ponte: scelta emblematica, che inspessisce il tessuto simbolico della drammaturgia, pur rimanendo l’interprete quasi sempre assente dalla scena. (dal libretto di Aspern,Teatro La Fenice, Venezia 2013) Contemporanea – «Aspern» «ASPERN» 1978-2013 Due recensioni PRIMA DI ASPERN DI SCIARRINO AL MAGGIO MUSICALE DI FIRENZE I di Giorgio Pestelli mportante novità al XLI Maggio musicale Fiorentino: Aspern, singspiel in due atti di Salvatore Sciarrino e Giorgio Marini, è stato salutato da una positiva accoglienza al Teatro della Pergola. Sciarrino e Marini, coautore del libretto e regista dello spettacolo, hanno lavorato intensamente, con soddisfatti interventi e impronte digitali personali sul testo da cui l’opera deriva, The Aspern Papers (1888) di Henry James. Nello splendore decadente di un palazzo veneziano, due donne vivono in ritiro, con pochi soldi; la più vecchia, amica di un poeta morto da tempo, Jeffrey Aspern, l’altra sua nipote zitella non più giovane, lunga, pallida. Le due custodiscono gelosamente un carteggio del poeta, lettere d’amore, probabilmente. Uno scrittore, persona di pochi scrupoli, entra nella loro vita per impossessarsi delle carte, affitta alcune camere da loro, gioca ambiguamente con le ultime speranze matrimoniali della nipote, Titta. Questa resiste, e lo scrittore tenta di rubare le lettere, ma sorpreso dalla vecchia fugge. Quando la vecchia zia, poco dopo, muore, lo scrittore ritorna; Titta, in un ambiguo colloquio, sembra fargli capire che, sposandola,potrebbe entrare in possesso delle carte; lui non accetta e decide di partire; Titta il giorno dopo gli rivela di aver bruciato tutto il prezioso carteggio. Cifra eminente di tutto il breve racconto è l’ambiguità: tutto sembra, tutto può essere, gli interrogativi accumulati dall’autore devono restare irrisolti perché solo conta lo stato di incertezza universale, il clima che circola fra le figure o fantasmi della vicenda. A materia così sfuggente risponde una impaginazione musicale di grande rigore razionale; già nel Giro di vite (il paragone è fatale anche per la piccola orchestra, le voci di bambini), Britten aveva imbrigliato il tutto nella forma del tema con variazioni; qui Sciarrino si richiama a un tipo di opera settecentesca, il singspiel, commedia musicale a pezzi (o numeri) chiusi. Lo svolgersi della vicenda, o meglio il suo incrociarsi, è affidato a tre attori (la vecchia zia è impersonata da una bambina), spesso forniti di hoffmanniani doppi: si riproduce nel personaggio quel fenomeno di diffrazione che è tipico della ricerca sonora di Sciarrino. La parte musicale è volutamente distanziata dagli accadimenti (ma accade mai qualcosa?): una minima orchestra è collocata entro l’ex palco reale, a riscontro del boccascena; la dimensione vocale è consegnata a una voce di soprano, che scende in palco solo per cantare una canzone veneziana, altrimenti sta con gli strumenti e come strumento mobilissimo frantuma celebri versi di Da Ponte per Mozart. La formula riesce in uno spettacolo tagliente di salutare precisione; sono pochi i momenti inerti in una durata che supera le due ore. La musica di Sciarrino sembra all’inizio pesare come piuma ma sotto stanno unghie e uncini che dopo un po’ lasciano il segno: ritorna il suo stile strumentale, noto dai «capricci» e «notturni brillanti», i soffi e i refoli dei flauti; nuove invece le fasce armoniche, le sonorità magiche del timpano messo in risonanza da un piatto capovolto; ma nuova anche la proprietà teatrale di certi momenti quando una musica che sembra fatta di sospiri dà luogo a tenaci polifonie ritmiche: l’oscillare fra lo stato di «suspense» e il gesto ironico è più volte preVENEZIAMUSICA e dintorni | 37 Contemporanea – «Aspern» sente nella sola partitura musicale, capace poi di accogliere senza suture criptiche allusioni mozartiane. Eccellente in tutti i sensi la realizzazione: l’aspetto visivo e spettacolare è tracciato con mano maestra dalle scene di Pasquale Grassi e Giulio Figurelli: una Venezia fusa con la Londra vittoriana illustrata da Doré. Gli attori Virginio Gazzolo, Lisa Pancrazi e Georgia Lepore affrontano con successo la difficoltà di adeguarsi al tessuto musicale circostante, solo alcuni toni enfatici sono poco consoni al tutto. La soprano Alide Maria Salvetta mette a disposizione la sua intelligenza e quel finissimo, argentino strumento che è la sua voce per dare risalto alla cantatrice; ottimo il gruppo dei solisti strumentali, guidati dall’autore, Mario Ancillotti, Aldo Bennici, Germano Cavazzoli, Roberto Fabbriciani, Luigi Lanzillotta e Alessandro Specchi. Tutti sono stati festeggiati con calore alla fine dello spettacolo. (da «La Stampa», 10 giugno 1978) L’AMBIGUA «ASPERN» DI SCIARRINO A di Mario Messinis spern di Salvatore Sciarrino era caduta nell’oblio dal lontano 1978, dopo la prima assoluta alla Pergola di Firenze. Ora la Fenice saggiamente ripropone al Malibran il primo fondamentale contributo teatrale del compositore palermitano. Aspern è un’opera fantasmatica e ambigua. Quell’ambiguità che si trova anche nel Carteggio Aspern, il romanzo breve di Henry James, quasi un giallo. C’è un perverso scrittore (narratore) che mira ad impadronirsi di alcune carte di un poeta scomparso, Aspern, appunto, corteggiando la nipote dell’anziana signora che – presumibilmente – ne era stata l’amante. La donna, non più giovane e ormai sfiorita, è disposta a cedere quei fogli segreti, ma chiede di farsi sposare. Lo scrittore è incerto; quando ritorna, il giorno dopo, la nipote gli comunica di avere bruciato il carteggio. Sciarrino, nel libretto ideato assieme al regista Giorgio Marini, procede per sottrazione, sia nei confronti del testo letterario che nell’impostazione musicale, rendendo anche più sfuggente l’azione. In realtà il compositore evita l’evidenza narrativa con un racconto quasi inafferrabile. Sei strumentisti della Fenice, diretti con maestria da Marco Angius, realizzano impeccabilmente i bagliori luministici, magicamente frammentari, dell’opera. L’autore inventa un lessico eterodosso alla ricerca, in termini radicali, del suono incognito. Molto originale la caratterizzazione vocale nel rapporto con il Settecento: da un lato due canzoni veneziane da battello, evocate con pallori estenuanti; dall’altro le citazioni di versi delle Nozze di Figaro, resi irriconoscibili dai frastagliati e ironici decorsi melodici. Tre voci recitanti sfruttano le leggi del melologo classico-romantico, il giovane soprano ceco Zuzana Markova esalta le acrobazie dell’unico ruolo cantato. Lineare e stilizzato lo spettacolo, in collaborazione con la Biennale, curato dagli allievi dello IUAV guidati dai loro docenti, con quinte scorrevoli e suggestivi giochi di ombre negli interventi pantomimici di ascendenza nipponica. Prezioso il volume-programma, curato da Michele Girardi. (da «Il Gazzettino», 8 ottobre 2013) 38 | VENEZIAMUSICA e dintorni Contemporanea – La LVII Biennale Musica «ALTRA VOCE, ALTRO SPAZIO» La seconda Biennale di Ivan Fedele, direttore artistico della rassegna fino al 2015 P artito con un’«anteprima» come Aspern di Salvatore Sciarrino, il LVII Festival Internazionale di Musica contemporanea della Biennale si è svolto tra il 4 e il 13 ottobre scorsi, portando in laguna una serie di novità assolute, unite a celebri pagine della musica novecentesca. Prima delle recensioni conclusive di Mario Messinis e Paolo Petazzi, che seguono nelle pagine successive, presentiamo alcune breve riflessioni programmatiche del direttore artistico Ivan Fedele, ricavate da un’intervista curata da Cesare Fertonani e pubblicata nel catalogo della rassegna. «Il titolo “Altra voce, altro spazio” fa chiaramente riferimento a due dimensioni, la voce e lo spazio, di cui la musica ha investigato a fondo potenzialità e applicazioni in vari ambiti. Per quanto riguarda la voce, penso naturalmente all’opera, al teatro ma anche alla musica da camera e alla stessa voce sola. Lo spazio è il luogo della risonanza della musica, il luogo dove la musica vive: è la dimensione necessaria, insieme al tempo, perché l’evento sonoro accada. Se lo spazio è stato abitato e vissuto nella storia della musica via via in maniere molto differenti, da tempo i compositori non lo considerano più – e a ragione – un accidente ma piuttosto una componente strutturale e sostanziale del fare musica, al punto che le partiture recano spesso indicazioni specifiche relative allo spazio ideale in cui una certa composizione va eseguita. Gli aggettivi “altra” e “altro” alludono invece alle diverse e molteplici declinazioni di queste due dimensioni. L’obiettivo del festival è fotografare la natura vera e complessa della contemporaneità oggi: uno scenario quanto mai composito e sfaccettato in cui trovano posto autori di tutto il mondo. Seguendo quest’impostazione, occorre innanzi tutto dare adeguata profondità storica alla stessa contemporaneità e la scelta di alcuni autori è da interpretare in questa prospettiva. Prendiamo per esempio Helicopter String Quartet di Stockhausen. Oppure, sempre a mo’ di exempla, pensiamo a due pezzi di Berio come Ofanim e Altra voce: lavoro quest’ultimo che comporta una dialettica molto originale con l’ambiente dell’esecuzione e dà il la al titolo del festival. Ora, queste opere costituiscono lo sfondo storico su cui sono programmati i lavori dei giovani compositori. Al riguardo vorrei ricordare almeno il concerto intitolato Visioni con l’Ensemble L’Imaginaire e le musiche di Daniele Ghisi e Eric Maestri: qui un dispositivo elettroacustico agisce in “contrappunto” molto particolare con il suono e con come esso potrebbe essere stato pensato da un punto di vista visivo. Tengo poi in modo particolare al concerto del Collettivo /nu/ thing, che ha tra l’altro un blog – anche il web è un «altro» spazio – di discussione e approfondimento sulla musica d’oggi: in questo concerto lo spazio abitato non riguarda soltanto le modalità di diffusione e percezione del suono ma diviene anche una sorta di zapping tra le dimensioni acustica, elettroacustica e visiva. Un’ulteriore declinazione di spazio la troviamo poi nell’opera-performance di Pietro Luca Congedo, Homoiomèreia, che utilizza apparati percussivi da lui stesso costruiti e alcuni dei quali hanno un progetto che risale a Leonardo». VENEZIAMUSICA e dintorni | 39 Contemporanea – La LVII Biennale Musica SULLA BIENNALE 2013 Dai capisaldi della Nuova Musica agli autori emergenti L di Mario Messinis* a Biennale Musica godeva di buona salute prima della riforma dello statuto, cresciuto sull’onda del ’68. Allora si amava ripetere che i festival erano inutili e che la Biennale doveva liberarsi da usurate accademie. Nono e Vedova erano tra gli ardenti apostoli della rivoluzione. La conseguenza fu, per quanto riguarda la musica e il teatro, la rinuncia alla programmazione annuale. Nonostante i mezzi limitati, Paolo Baratta ha il merito di consentire alla musica di essere presente ogni anno (ha realizzato anche sale di ascolto acusticamente attrezzate). Ivan Fedele ha articolato felicemente il programma in senso tripartito: alcuni capisaldi della Nuova Musica talora scomparsi dal repertorio, prime esecuzioni della generazione di mezzo e una larghissima informazione su autori nuovi e nuovissimi. Luciano Berio ha dominato la rassegna, dopo Epifanie, con il celebrato affresco biblico Ofanim e con Altra voce, pagina di sublime incanto lirico. Impressiona il riascolto di Darkness di Donatoni, con i Percussionisti di Strasburgo, nei vorticosi automatismi dominati dal pensiero. I Madrigali di Sciarrrino evocano una natura enigmatica e reggono il confronto con l’aulico madrigalismo rinascimentale. Il trio di Hoso Kawa è di di beethoveniana pienezza. Tra le novità di compositori già ascoltati alla Biennale, sorprendono Rohn di Kaija Saariaho per la tenerezza elegiaca e Phonofania di Claudio Ambrosini per la primordiale visione cosmica. Alessandro Solbiati trascorre dall’asciutta razionalità, senza seduzioni esotiche, di Thai Song per 52 gong tailandesi, alla sottigliezza timbrica del Concerto per cymbalum e orchestra, che tocca i territori co- 40 | VENEZIAMUSICA e dintorni lorati di Kurtag e Ravel; Gabriele Manca sprofonda nell’inferno di violenze pianistiche accordali; Adriano Guarnieri, nell’intenso Al crepitio del sole, scopre espressionistiche nostalgie vocali viennesi e Matteo Franceschini, nel Concerto per corno di bassetto, piega lo strumento dell’idillio settecentesco a disinvolte piacevolezze. La scelta degli autori dell’ultima generazione è molto ampia, con il rischio però di esiti inevitabilmente discontinui. Si sono tuttavia notate alcune riuscite sicure. L’atto unico di Vittorio Montalti è un perfetto organismo comico in cui la parola si dissolve in un pulviscolo sonoro antinaturalistico, sorretto da una suggestiva impaginazione scenica minimalista: un esempio progettuale da seguire. Mi limito a segnalare fuggevolmente i nomi di Oscar Bianchi, Raffaele Grimaldi, Pasquale Corrado, Franco Venturini, Pierre Jodlowski. Innumerevoli i contributi elettronici, ma talvolta si ha l’impressione di una regressione tecnologica. Fedele ha un gusto molto sicuro per gli interpreti e le sorprese sono state continue, dal corno di bassetto di Marelli al violinista D’Orazio, dal violista Desjardins al mezzo soprano Monica Bacelli, dal contrabbassista Rossato alla viola d’amore di Fusi, dal pianista Alberti a vari complessi specializzati. Splendido epilogo alle Tese con un trittico corale dedicato ad alcuni crimini civili. Perché non possiamo vederla di Marco Stroppa è una pagina di forte concentrazione intellettuale con un finale livido, soffocato, molto poetico. Luca Francesconi in Let Me Bleed rivela la sua larga conoscenza della tradizione corale, dai Responsori di Gesualdo * Critico musicale Contemporanea – La LVII Biennale Musica a Coro di Berio, rinnovandola con una scansione grandiosa e drammatica. Infine Mauro Lanza, in Ludus de morte regis, indirizza le sue ardite ricerche analitiche verso esiti teatrali; tuttavia le riflessioni meditative e gli interventi gestuali appaiono talvolta dissociati. Senza confronti le esecuzioni dei Cris de Paris. Il Leone d’oro alla carriera è stato assegnato giustamente alla grande compositrice russa Sofia Gubaidulina, che ripensa a Bach in senso sperimentale (mi riferisco soprattutto alla musica da camera). Opportuna l’assegnazione del Leone d’argento alla Fondazione Spinola Banna, di eccezionale impegno formativo. VENEZIAMUSICA e dintorni | 41 Contemporanea – La LVII Biennale Musica LA LVII BIENNALE MUSICA Un racconto e qualche riflessione a margine D di Paolo Petazzi* ieci giorni fitti di concerti, con moltissime prime italiane, molte novità e alcuni lavori «storici» o comunque noti, formavano un calendario denso e ricco di aperture e informazioni. Tra i pezzi storici il culmine era il ricordo di Berio a dieci anni della morte, con capolavori come Epiphanies (versione definitiva, 1991, di Epifanie del 1959/61), e come il suo primo grande lavoro con l’elettronica dal vivo, Ofaním (1988), anch’esso proposto in modo impeccabile. È stato ricordato il centenario della nascita di Lutoslawski, forse ormai un po’ troppo «classico» per una Biennale. Al recente passato apparteneva l’opera proposta nella ludica apertura in «altro spazio», dedicata alla seconda esecuzione italiana del «quartetto con elicotteri» che Stockhausen scrisse nel 1992-1993. La sua idea era di fondere il suono del rotore di ognuno degli elicotteri con quello di un componente di un quartetto d’archi (finora sempre il Quartetto Arditti, per cui il pezzo fu scritto), dalla scrittura inevitabilmente concentrata soprattutto sul tremolo. Ogni membro del quartetto sale su un elicottero e suona la propria parte: solo il pubblico nella sala chiusa può avere un ascolto complessivo dei suoni provenienti dai rotori e dai musicisti degli elicotteri, inviati in sala e miscelati dai registi del suono (a Venezia gli autorevolissimi André Richard e Thierry Coduys). Le telecamere mostravano il quartetto d’archi e, almeno a tratti, i movimenti degli elicotteri; ma il «balletto» degli elicotteri previsto da Stockhausen si vede meglio nell’ottimo DVD da lui stesso curato. Poiché le caratteristiche di un ascolto realmente dal vivo sono per forza escluse, e le circostanze ambientali non erano le più favo- 42 | VENEZIAMUSICA e dintorni revoli, si sarebbe potuto usare il citato DVD evitando le spese del costoso giocattolo e cogliendo magari l’occasione per proporre un grande pezzo storico dello Stockhausen maggiore, per esempio Momente (da troppi decenni ignorato in ogni sede, non solo in Italia). Va comunque riconosciuto che la presenza a Venezia del Quartetto Arditti ha portato con sé anche un concerto che consentiva di constatare la persistente attrazione che esercitano sui compositori i quattro archi e culminava nella prima italiana del Quartetto n. 5 (1995) di Carter. In verità il nudo elenco delle prime esecuzioni in Italia offrirebbe molti spunti di riflessione a chi ha dubbi sul ruolo della Biennale in un Paese dove la musica di oggi in molte programmazioni non esiste, e gli spazi istituzionali scarseggiano: anche gli italiani più affermati trovano occasioni soprattutto all’estero. Si può ricordare, ad esempio, la bella serata corale conclusiva con due pezzi importanti già di qualche anno fa di Luca Francesconi (del 2001) e Marco Stroppa (del 2008) e uno più recente di Mauro Lanza, proposti dal gruppo francese Les Cris de Paris. O ancora, fra le altre, le presenze di Alessandro Solbiati, Matteo Franceschini, Gabriele Manca. Non ho potuto seguire tutti i concerti, e può darsi che i miei appunti escludano novità importanti. Senza esitazione mi sembrano da ricordare le prime assolute di Guarnieri e Ambrosini; particolare attenzione merita inoltre la serata di teatro musicale. In Fonofania di Claudio Ambrosini un coro di voci bianche evoca le prime parole infantili inserendosi con forte suggestione in un contesto * Critico musicale Contemporanea – La LVII Biennale Musica orchestrale caratterizzato dalla mobile, nervosa e tagliente invenzione del suono del compositore veneziano (lo ha diretto Roberto Abbado in un bel concerto insieme a Epiphanies di Berio). Era frutto di una commissione dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid un recente lavoro di Adriano Guarnieri su un testo liberamente tratto da Il canto del muezzin di Dino Villatico. Si intitola …Al crepitio del sole…l’inatteso vocio di silenzi…: si ammirano la tensione arroventata della linea vocale e il rapporto lirico-visionario con una materia musicale che affianca il quartetto d’archi a due tromboni, che forniscono al tempo stesso una base e una diversa spazialità agli strati sonori. La serata di teatro musicale aveva due protagonisti giovani, Raffaele Grimaldi (1980) e Vittorio Montalti (1984), entrambi interessati alla comicità in una dimensione acida, amara e grottesca, con testo e scelte musicali di carattere completamente diverso. Nella sua schematica brevità La macchina di Grimaldi, su libretto di Diego Giordano, sembra un apologo sulla condizione del compositore in un mondo in cui scrivere musica può essere considerata una pericolosa malattia. Ad uno «sconosciuto» che vorrebbe curare le proprie nevrosi viene diagnosticato «un disturbo della contemporaneità», da curarsi entrando in una macchina che sembra una gigantesca lavatrice. Ma si produce una trasformazione radicale, e, dopo varie fasi, dalla macchina esce un nuovo personaggio banale e volgare, che non ha nulla a che vedere con quello dell’inizio. Grimaldi usa un piccolo gruppo strumentale con efficace velocità e sapiente agilità, è meno persuasivo sul piano vocale, quando si concede intonazioni parodistiche talvolta forse troppo facili. Il libretto di Giuliano Compagno per Montalti si ispira a un testo di Perec, L’augmentation, con molta libertà e una semplificazione un po’ brutale, ma forse necessaria, e gli dà un nuovo titolo troppo lungo, L’arte e la maniera di affrontare il proprio capo per chiedergli un aumento. In Perec non ci sono singoli personaggi, ma sei voci, che, ciascuna con un ruolo preciso («proposta», «alternativa», «ipotesi positiva», «ipotesi negativa», «scelta», «conclusione») prospettano le diverse situazioni in cui può trovarsi chi va dal capo ufficio a chiedergli un aumento. Il libretto di Giuliano Compagno semplifica enormemente il testo di Perec, mette in scena l’impiegato, la segretaria, il capufficio, introduce qualche elemento nuovo, rinuncia ai caratteri letterari di raffinato gioco stilistico per offrire una immagine più diretta della condizione dell’impiegato che vuole chiedere un aumento e si smarrisce nel gioco delle possibilità. Lo smarrimento si realizza efficacemente nella vocalità di Montalti, che spesso frammenta la parola o la riduce a un borbottio incomprensibile, e la pone in rapporto con una scrittura strumentale sottile e rarefatta, calcolata con rigore. Mario Ancillotti dirigeva l’Ensemble Nuovo Contrappunto, bravi i cantanti, bellissimo lo spettacolo ideato per entrambe le opere dal regista Giancarlo Cauteruccio, giocando in modo agile e intelligente sulla mobilità di proiezioni. Infine un accenno ai Leoni. Aveva certo molte valide ragioni il Leone d’oro a Sofija Gubajdulina; ma sarebbe stato forse meglio renderle omaggio concedendo più ampio spazio ai suoi capolavori da camera invece di proporre nella serata inaugurale il solenne e retorico Glorious Percussion, interessante tuttavia nelle zone più oscure. Meritatissimo il Leone d’argento per le iniziative musicali della Fondazione Spinola Banna, cui era legato il bel concerto dei Neue Vocalsolisten di Stoccarda, un complesso vocale che è ormai una istituzione. Per loro Sciarrino aveva scritto i Dodici Madrigali (in parte riproposti a Banna come a Venezia) e Francesco Filidei (1973) ha composto Dormo molto amore, un pezzo dolorosamente ipnotico legato alla riflessione sulla morte a Pisa nel 1972 dell’anarchico Franco Serantini, lasciato morire in carcere senza cure dopo le percosse della polizia. A lui il pisano Filidei aveva dedicato il vasto e bellissimo N.N. e altri lavori: in questo si evoca in onirica sospensione una condizione tra il sonno e la morte, con un processo di crescente densità che poi si dissolve. VENEZIAMUSICA e dintorni | 43 Verdi/Wagner (1813-2013) – Contaminazioni VERDI VERSUS WAGNER: ALLA PARI? Un confronto tra due mostri sacri D di Quirino Principe* ue grandezze, due visioni dell’arte e del pensiero, due uomini; ci piace immaginarli simmetrici, paralleli. Questa nostra visione è insicura, e dev’essere verificata continuamente, di generazione in generazione, almeno fino a quando esisteranno le arti e, nel loro esistere, avranno significato nella società. Già questa persistenza di significato non è certa. L’Occidente è stato l’unica area planetaria nella cui tradizione e fisionomia le arti non si siano limitate a generare bellezza anche mirabile soltanto per decorare il potere o per rendere meno ripugnanti la credulità religiosa e il servilismo verso le caste sacerdotali. Soltanto in Occidente, le arti hanno legittimato la loro propria esistenza empiendosi di pensiero, di λόγος, di energia eletta a governare il mondo. Soltanto in Occidente, le arti sono riuscite, in una fase storica non remota, a non essere più mercimonio né potlatch né circenses; «in una fase non remota», poiché l’allegoria disegnata da Wagner nella fiaba Wieland der Schmied per una musica mai scritta denunciava gli obbrobri del passato, di un lungo passato. Quel destino di «non essere più» qualcosa di marginale e d’inessenziale di cui il mondo potrebbe anche fare a meno, e di «essere altro e più rispetto a ciò che si è stato», ha assunto respiro più ampio e caratteri particolarmente vistosi nella musica che definisco «forte», e che altri, in maniera impropria e insufficiente, si ostinano ancora a definire «classica». È quella che io chiamo «musica» senza aggettivi. Nella cultura occidentale, la musica ha guadagnato il diritto a una metamorfosi axiologica: se ai tempi di Alcmane a Sparta, o di Orazio nella Roma di Augusto e di Mecenate, o di Hildegard von Bingen, e ancora, sia 44 | VENEZIAMUSICA e dintorni pure a metamorfosi in atto, ai tempi di Guillaume Dufay o di Bartolomeo Tromboncino, la musica era soprattutto seducente ed emozionante creatrice di stati d’animo, Jacopo Peri, Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victória sono già all’opera per sollevarla al rango che è la sua entelechia: quello di nodo di significati, di linguaggio con un proprio lessico, una propria morfologia e sintassi, un proprio tessuto cellulare interno in cui significante e significato siano in relazione indissolubile. Questa fenomenologia per così dire orizzontale e diacronica si associa a una fenomenologia verticale e sincronica, la quale accoglie in sé una singolarità, una sorta di contrometamorfosi: un numero incalcolabile di musicisti, in ogni plaga d’Occidente, lascia coesistere l’antico e il nuovo, il passato e il futuro, ciò che la musica era stata e ciò che tendeva a divenire, ma si ravvisano due zone estreme in cui rari artisti di genio intendono la propria arte esclusivamente (o quasi) come linguaggio, pensiero, λόγος, verità, e altrettanto rari artisti di altissimo talento si appagano di connotati che certamente sono connaturati nella musica ma gravitano verso una concezione «naíve»: l’energia delle emozioni, la potente influenza sulla psiche e sul temperamento. Esempi del primo tipo: Gesualdo, Bach, Wagner, Debussy, Stravinskij. Esempi del secondo tipo: Händel, Telemann, Weber, Verdi, Saint-Saëns... Ci domandiamo: i due coetanei, Richard Wagner poco fa nominato e con un vantaggio d’anzianità di pochi mesi (Lipsia, sabato 22 maggio 1813 – Venezia, martedì 13 febbraio 1883), e Giuseppe Verdi (Le Roncole di Busseto, * Musicologo – Critico musicale – Scrittore Verdi/Wagner (1813-2013) – Contaminazioni Parma, sabato 9 o domenica 10 ottobre 1813 – Milano, domenica 27 gennaio 1901), sono veramente due figure simmetriche, parallele? Si direbbe di no, se le mie precedenti considerazioni sono accettabili almeno in parte. L’immagine di due sommi custodi del pensiero, di due dioscuri dell’arte, è affascinante anche come ombra fuggevole, come immagine eidetica, e comunque s’impone con la forza irresistibile di una Gestalt. Talvolta accade che l’enfasi di un accostamento celebrativo e di una simbologia plaudente corrisponda davvero a due grandezze di pari misura, in equilibrio come il bianco giorno e la nera notte nella scacchiera di Borges, o come la fresca notte e l’afoso giorno nella poesia Der Tod, das ist die kühle Nacht di Heinrich Heine. Torna alla mente la Stanza della Segnatura (la «segnatura di giustizia») in Vaticano: là, su commissione del papa Giulio II, Raffaello Sanzio (Urbino, venerdì 28 marzo o demenica 6 aprile 1483 – Roma, venerdì 6 aprile 1530) affrescò nel 15091510 quattro grandi allegorie, una su ciascuna delle quattro pareti: la Teologia, la Filosofia, la Giurisprudenza, la Poesia. L’allegoria filosofica è La Scuola di Atene: al centro della gloriosa architettura e della folla di teste pensanti in drammatico movimento, campeggiano Platone e Aristotele, indicanti, il primo, il cielo delle idee, il secondo, la terra delle cose reali. Torna alla mente anche il monumento che s’innalza nel Theaterplatz di Weimar, effigiante in bronzo i dioscuri della poesia tedesca, Johann Wolfgang von Goethe (Francoforte sul Meno, giovedì 28 agosto 1849 – Weimar, giovedì 22 marzo 1832) e Friedrich Schiller (Marbach sul Neckar, nel Württemberg, sabato 10 novembre 1759 – Weimar, giovedì 9 maggio 1805). Si affacciano alla memoria storica di ogni intelligenza d’Occidente degna di questo nome i dettagli storici che evocano intorno al «Goethe-Schiller-Denkmal» un’aura di vera e grande passione nazionale, etica e civile: l’iniziativa di Karl Alexander August Johann von Sachsen-Weimar, granduca di Sassonia-Weimar-Eisenach; l’originaria assegnazione dell’impresa allo scultore Christian Daniel Rauch (Arolsen in Assia, allora principato di Waldeck, mercoledì 2 gennaio 1777 – Dresda, giovedì 3 dicembre 1857), che avrebbe voluto rivestire i due poeti con abiti di antichi eroi; la ragionevole deci- sione di rivolgersi a Ernst Friedrich August Rietschel (Pulsnitz in Sassonia, sabato 15 dicembre 1804 – Dresda, giovedì 21 febbraio 1861), che optò per abiti moderni, sì da «far vivere» i due poeti fra i cittadini di Weimar; la divertente ma non frivola scelta di attribuire la medesima statura a Schiller, alto m. 1,90, e a Goethe, alto m. 1,69; l’opera perfetta del maestro fonditore Ferdinand von Miller (Fürstenfeldbruck in Baviera, lunedì 18 ottobre 1813 – Monaco di Baviera, venerdì 11 febbraio 1887) che realizzò le due figure in bronzo; l’inaugurazione avvenuta venerdì 4 settembre 1857 per celebrare il centenario della nascita di Karl August, il granduca di Sassonia-Weimar che aveva voluto la presenza di Goethe alla propria Corte e alla guida del più che illustre e glorioso Großherzögliches Theater dove Franz Liszt, con ardimentosa scelta e sfidando le infamie del potere di un re che aveva condannato Wagner alla fucilazione, diresse la prima «illecita» rappresentazione di Lohengrin; la memorabile esecuzione a Weimar, al culmine di quei festeggiamenti, della Dante Symphonie di Liszt (Hoftheater, sabato 7 novembre 1757). Ho profuso questi dettagli non per amore di inutili pleonasmi. Volevo sottolineare due casi di reale simmetria, di parità nella statura artistica e nella funzione storica. Ciò vale anche per Verdi dinanzi a Wagner? Non credo. L’unico elemento unificante ha certo molta visibilità ma non è decisivo: entrambi i compositori si dedicarono al teatro d’opera con impegno quasi esclusivo, aggiungendo al proprio rispettivo lascito pochi lavori non teatrali. Per ciascuno dei due, al di là della drammaturgia musicale soltanto una o due o al massimo tre delle altre composizioni sono importanti e degne di essere riascoltate più volte: di Wagner, i Wesendock-Lieder; di Verdi, il Requiem, i Quattro pezzi sacri, il Quartetto in Mi minore. Si pensi, a proposito di Wagner, alla differente distribuzione dei pregi tra le opere teatrali di Weber e le bellissime partiture sinfoniche e cameristiche di lui; a proposito di Verdi, alle composizioni pianistiche e vocali di Rossini, nonché alla Petite Messe Solennelle. In ogni caso, un elemento che accosti Verdi e Wagner quasi parificandoli ma che sia pur sempre una considerazione di una comune mancanza e non di una comune acquisizione, mi pare l‘anello debole di un ragionamento. La disparità VENEZIAMUSICA e dintorni | 45 Verdi/Wagner (1813-2013) – Contaminazioni tra Verdi e Wagner risulta invece, inequivocabile, nella diversa collocazione dei due compositori in merito al processo di metamorfosi della musica occidentale. Lo sappiamo tutti che Verdi, anche il meno affinato, anche quello dello «zúm-papa– zúm-papa», è capace di scatenare passioni, e che riesce a sedurci e a portarci al delirio. Ma è Wagner colui che trasforma la musica occidentale in linguaggio, difficile ai neofiti, ma intelligibile ai fedeli. E più ancora: a partire da Tristan und Isolde, a partire dal «Tristan-Akkord», egli compie una seconda metamorfosi, che è, a dire il vero, una transustanziazione: la musica di Wagner non è più simbolo dell’universo condensato in suoni, ma uni- 46 | VENEZIAMUSICA e dintorni verso creato dai suoni, anzi, rintracciato e identificato nei suoni dopo una queste du Gral e dopo una consacrazione della fisicità connaturata nei suoni. Il motivo iniziale di Tristan und Isolde non è simbolo del filtro d’amore: è il filtro d’amore. Il pedale e l’arpeggio di Mi bemolle non sono il nodo simbolico dell’origine dell’universo: sono l’origine dell’universo, e ogni volta che gli udiamo, misteriosamente in una parte inconoscibile di ciascuno di noi, a quell’ascolto emergono dal Nulla come universo. Ciò significa, semplicemente, che nelle mani di Richard Wagner la musica può essere Dio, e che Dio, semplicemente, potrebbe essere null’altro se non la musica. Verdi/Wagner (1813-2013) I «QUATTRO PEZZI SACRI» Un saggio inedito illustra i componimenti verdiani A di Chiara Facis* lla luce del bicentenario verdiano in corso, si può notare come l’immagine predominante del genio di Busseto nel panorama culturale d’oggi sia quasi esclusivamente quella di un autore laico a tutti gli effetti. È d’uopo a questo punto un’adeguata riflessione. I recenti festeggiamenti per la ricorrenza dell’Unità d’Italia hanno fatto sì che Verdi venisse considerato una volta di più come icona del Risorgimento, ma è opportuno sottolineare che l’interesse del sommo musicista per i rivolgimenti storico-sociali del suo tempo non costituisce da solo un dato esaustivo nei termini di un’adeguata considerazione del fenomeno Verdi nella sua indiscutibile complessità umana e culturale. Infatti, oltre ai rapporti di sincera amicizia intrattenuti dal musicista nel corso della sua esistenza con vari esponenti del clero, è possibile notare che Verdi ha incluso sponte sua nelle opere liriche pagine ispirate di carattere sacro mai commissionategli da alcuno. Parlare del Verdi sacro significa innanzitutto parlare del Requiem e le ragioni sono tante, in primo luogo l’assoluta venerazione nutrita dal compositore per uno scrittore eminentemente cattolico come il Manzoni: una considerazione tale da indurre il musicista a comporre una Messa solenne rimasta a tutti gli effetti un monumento della musica sacra di tutti i tempi. Ma ci sono pure altre composizioni che nella produzione religiosa verdiana meritano altrettanta attenzione. Ci si riferisce ai Quattro pezzi sacri pubblicati da Ricordi nel 1898. Opere di raro pregio e di profonda ispirazione, questi Pezzi rappresentano un ragguardevole esempio di equilibrio compositivo e finezza stilistica, anche più dello stesso Requiem che risente ancora dell’influsso evidente del grand-opéra e della vicina Aida (1871). Verdi li scrive nell’ultima, cruciale fase della sua esistenza, tra il 1886 e il 1897, cioè nel periodo in cui vede spegnersi l’adorata amica e compagna di una vita, nonché suo mentore elettivo, Giuseppina Strepponi, da tempo malata. Una perdita irreparabile per il Maestro che rivive l’antica ferita mai sanata della morte troppo precoce della prima moglie Margherita Barezzi e dei due figlioletti Virginia e Icilio, tutti scomparsi tra il 1838 e il 1840. Segnato dal grave lutto e in età avanzata, il musicista esprime la propria esigenza d’infinito rivolgendosi al repertorio sacro. Osserva sotto questo profilo Riccardo Muti: «Quando un compositore d’opere liriche come Verdi si rivolge alla musica religiosa, lo fa unicamente perché spinto da una profonda necessità interiore». Nascono in tal modo gli ultimi gioielli della produzione compositiva del Maestro di Busseto, vale a dire l’Ave Maria, lo Stabat Mater, le Laudi alla Vergine Maria e il Te Deum, distinguibili in due gruppi in rapporto al loro organico, in due «dittici» come li definisce ancora Muti, giacché l’Ave Maria e le Laudi prevedono voci a cappella, mentre lo Stabat e il Te Deum comprendono grande orchestra oltre al doppio coro. Questa breve collana di composizioni sacre si rivela alla lettura quasi un elogio agli albori della musica liturgica, al gregoriano e ai primigeni esempi polifonici che l’autore rielabora alla luce della propria koinè e del proprio stile compositivo. Singolare l’ideazione dell’Ave Maria per quattro voci miste su scala enigmatica, nata quasi per divagazione nel 1889 da una lettura della «Gazzet* Musicologa VENEZIAMUSICA e dintorni | 47 Verdi/Wagner (1813-2013) ta Musicale di Milano» che, in un numero dell’agosto 1888, propone ai suoi lettori di presentare le loro personali armonizzazioni su una scala enigmatica costituita in senso ascendente dalle note do, re bemolle, mi, fa diesis, sol diesis, la desis, si, do e dalle note medesime ma col fa naturalizzato in senso discendente. Su tale sciarada armonica (giacché proprio Sciarada l’autore voleva intitolarla) Verdi compone dunque la sua Ave Maria, utilizzando il testo latino liturgico rielaborato da Arrigo Boito, per revisionarla poi in una seconda versione nel 1897. Inutile cercare riferimenti con analoghe composizioni che la precedono – come l’Ave Maria per soprano e archi del 1880 o con gli omonimi esempi compresi nelle opere liriche, come l’aria dall’Otello –, poiché questa pagina polifonica si presenta come un lavoro di incredibile modernità nelle peripezie armoniche e nell’articolata linea melodica perorata in un contesto dinamico sempre sfumato e sommesso. Quello che doveva essere un semplice esperimento enigmistico si traduce nella scrittura verdiana in un magistrale esempio di perizia armonica, non dissimile dai saggi di matematico intellettualismo musicale che dilettavano i maestri del Quattrocento fiammingo. Nonostante ciò, Verdi lo reputa in un primo tempo «quasi un esercizio scolastico» e non lo include nella prima esecuzione dei Pezzi sacri ai Concerts Spirituels dell’Opéra di Parigi nel 1898, sotto la direzione di Paul Taffanel. Solo in seguito essa verrà posta a capo della breve silloge sacra nell’edizione Ricordi nel ’98. Lo Stabat Mater, secondo brano della serie, composto in sol minore nel 1897 sul testo latino della celebre sequenza attribuita a Jacopone da Todi, si presenta anch’esso con una sfida armonica già all’«incipit»: quattro quinte e un’ottava in orchestra seguite dal coro in dissonanza. Un esordio di forte impatto sensoriale per esprimere il dolore della Vergine ai piedi della Croce. La principale caratteristica della composizione risiede nell’alternanza di sezioni a cappella e parti orchestrate. Non mancano nell’intero contesto espansioni di struggente melodicità, ma l’autore ha voluto concentrare lo spessore emotivo sulle sillabe dei versi «Fac ut animae donetur Paradisi gloria» in cui l’immagine del trascendente è espressa da un lungo passaggio modulante ascensionale che prende l’avvio dai pri- 48 | VENEZIAMUSICA e dintorni mi quattro accordi del coro a cappella esposti «p» per poi dipanarne i successivi in una superba gradatio armonico-dinamica che coinvolge una dopo l’altra tutte le sezioni dell’orchestra per approdare sfolgorante al modo maggiore. Nella frase finale del brano viene riesposto da tromboni e corni, quale «memento», il cupo tema della frase iniziale che sfuma però ancora nella chiarità dell’accordo di chiusa al modo maggiore, il segno della speranza che non muore. Le Laudi alla Vergine Maria, terzo brano nell’edizione dei Pezzi sacri, vengono composte nel 1886 sul testo volgare dantesco all’esordio del XXXIII Canto del Paradiso. Gli ispirati versi della preghiera di San Bernardo alla Vergine sono trasposti in musica per voci a cappella di due soprani e due contralti, un organico esile, di monastica sobrietà, concepito quale elogio alla migliore tradizione polifonica di Basso Medioevo e Rinascimento, in cui sembra quasi di cogliere l’eco lontana della lezione di Hildegard von Bingen. Il tutto reso con una grafia musicale estremamente lieve. Verdi in questo contesto pone particolare attenzione all’importanza dei colori nonché delle dinamiche, oltre a privilegiare la voce principale arricchendola di passaggi cromatici e variegandone la linea melodica di inattese modulazioni. Il lavoro si presenta nel suo complesso privo di ogni aulicità e scevro da ogni componente severa, bensì vivo d’espressione affettiva e toccante nella sua ricerca d’infinito. Quindi, il Te Deum per soprano solista, doppio coro e grande orchestra. Prima di affrontarne la composizione, Verdi aveva studiato Palestrina e De Victoria. A proposito del carattere del brano liturgico, eseguito principalmente nelle solennità, in occasione di trionfi in campo bellico o di incoronazioni, il musicista osservava che il testo latino del Te Deum non si riferiva a trionfi o a vittorie, bensì a un Dio incarnato, Uomo ma anche Giudice che «l’umanità invoca con una preghiera – “Dignare Domine die isto” – commovente fino al terrore! Tutto questo ha nulla a che fare con le vittorie...» (lettera a Giovanni Tebaldini, 1 marzo 1896). Non trionfi, dunque, ma solo l’essere umano davanti a Dio in una supplica. Scritto come lo Stabat Mater nel 1897, l’ultimo dei Pezzi sacri è il brano di più ampio respiro. Il suo esordio vuole quasi accennare Verdi/Wagner (1813-2013) ad un excursus nella storia della musica liturgica, con il gregoriano dei primi due versi affidato prima ai bassi e poi ai tenori. Quindi le voci maschili vengono trattate in polifonia. Il successivo attacco dell’orchestra rappresenta il primo, lampante scarto dinamico: i due tuoni isolati, a pieno coro e a piena orchestra, del Sanctus. Il magma sonoro si scatena nelle battute successive («Dominus Deus Sabaoth») con il poderoso «crescendo» sulla scala cromatica dell’orchestra e, dopo tre passaggi modulanti di voci e strumenti assemblati («Pleni sunt caeli et terra»), passa al «ffff» con l’impennata della linea melodica al registro acuto («...majestatis gloriae Tuae»). Dopodiché l’autore smorza subito le dinamiche in un episodio melodico («Te gloriosus») e torna poi alla perorazione solenne preannunciata dalle trombe ed esposta quindi dal coro a cappella («Patrem immensae majestatis»). A una frase al «pp» del coro femminile («Tu ad liberandum») subentra un fugato il cui tema viene enunciato «in primis» dai tenori. Ritorna quindi l’intonazione a cappella sul verso «Miserere nostri»; infine, coro e orchestra insieme passano all’ultima, grande espansione melodica («Fiat Misericordia Tua») modulante all’acuto e poi perorata al «ff» dall’intero organico («In Te Domine speravi»). Il mi naturale che il soprano solista riprende dalla tromba per ripetere tre volte in crescendo, sempre sulla stessa nota, il verso «In Te speravi», prelude all’estrema, fulgida esplosione di coro e orchestra prima della chiusa siglata da otto accordi al «p» degli ottoni e dalla lunga nota scura e sfumata di violoncelli e contrabbassi: l’ultima invocazione prima del Mistero. Oltre all’evidente alternanza di episodi a cappella e frasi orchestrate, si può notare da quest’ultimo, importante pezzo sacro come i netti chiaroscuri dinamici suggeriscano il fatto che Verdi, nelle sue frequentazioni parigine, non abbia scordato gli esempi di Berlioz nel suo Te Deum e nella Grand Messe des Morts. Infatti i due musicisti si erano conosciuti personalmente e fra loro vi era grande stima reciproca. Pur sottolineando che Verdi non necessitava certo di gruppi d’ottoni supplementari ai quattro punti cardinali – come aveva fatto Berlioz a Notre Dame –, pare comunque che il Maestro di Busseto abbia voluto fare riferimento all’illustre collega francese, genio ribelle e incompreso dal suo tempo. Dopo la Prima parigina del 1898, i Pezzi sacri, ancora in numero di tre, vengono eseguiti in Italia al Salone dei Concerti dell’Esposizione di Torino con la direzione del trentunenne Toscanini. Sempre con lo stesso direttore sul podio nel 1946, la loro esecuzione avrebbe rivelato come soprano solista nel Te Deum un’altra, leggendaria interprete: Renata Tebaldi. L’autografo della silloge sacra non è mai stato reperito. Verdi ha voluto portare con sé nella tomba la partitura manoscritta del Te Deum. È questa un’ulteriore testimonianza della continua ricerca di spiritualità da parte del genio di Busseto. Pur considerando il grande musicista nella sua complessità umana e spirituale, si giunge alla necessaria conclusione che Verdi, alla luce delle sue vicissitudini, abbia saputo far proprio il messaggio dell’Ecclesiaste: strapparsi dall’anima la lama del dolore per sublimarlo. La sua lezione ultima e la più eloquente. VENEZIAMUSICA e dintorni | 49 Verdi/Wagner (1813-2013) «VERDI È UNIVERSALE» A colloquio con Myung-Whun Chung M yun-Whun Chun è uno dei più grandi direttori d’orchestra viventi. Lo incontriamo per parlare di musica, delle sue origini e della passione che rivolge alla nostra tradizione. strano, anzi mi sembra la cosa più naturale della mia vita. Maestro, lei è un forte conoscitore della musica italiana. Come si è avvicinato a questi repertori, provenendo dalla lontana Corea? L’anno scorso ho interpretato Otello e Tristano. Sono entrambi capolavori, soprattutto dal punto di vista musicale. Ma per quanto riguarda le parole, e le storie che vengono raccontate, non c’è confronto. Otello è Otello, Tristano drammaturgicamente mi sembra più debole. Nel caso di Verdi è emblematico che a un certo punto della sua vita abbia scelto Otello e subito dopo Falstaff: il più grande compositore ritrova nel più grande autore drammatico, Shakespeare, la giusta combinazione tra parole e musica. E in Otello ogni parola è una meraviglia. Prima di tutto bisogna dire che io sono nato in Corea ma ho vissuto fuori dal mio Paese quasi tutta la vita. Da molto tempo ho un rapporto speciale con l’Italia. Ciò nonostante, ravviso molte affinità tra Italia e Corea: in entrambe le nazioni si percepisce un grande amore per il canto. Nel mio Paese natale molto spesso, quando si celebra una festa, o anche una semplice cena, alla fine viene naturale cantare. E, anche se questo costume si è forse andato perdendo negli ultimi anni, so che questa modalità di stare insieme caratterizzava anche l’Italia. In entrambi i popoli è forte il desiderio di esprimersi attraverso il canto. E i coreani, fra tutti i repertori, prediligono quello italiano. In particolare, lei è un celebre interprete verdiano, come dimostrano l’Otello e il Requiem che ha diretto quest’estate nel Cortile di Palazzo Ducale. Personalmente, all’interno della vasta musica italiana, io considero Giuseppe Verdi il più grande. L’ho sempre pensato e ho sempre vissuto con la sua musica. Avvicinarmi a lui non mi è mai sembrato 50 | VENEZIAMUSICA e dintorni Dal punto di vista drammaturgico, trova delle differenze tra Verdi e il suo grande «rivale» Wagner? Quali sono le differenze, se ce ne sono, tra Italia e Corea nella fruizione e nell’ascolto della musica? Sì, credo che vi siano delle differenze. L’Italia è forse il Paese più ricco culturalmente nella storia del mondo. Non esistono altrove città come Venezia o Roma. Tuttavia la musica è un’arte vivace, che si deve rinnovare ogni volta. Non si può vivere soltanto del passato. In Corea non possediamo la vostra lunga storia, e questo si ripercuote nell’atteggiamento con cui ci accostiamo alla musica d’arte. Quando mi chiedono di dare una definizione di me dico prima di tutto che, come ogni altra persona, sono un essere umano. In secondo luogo un Verdi/Wagner (1813-2013) musicista, e in terzo un coreano. Molti dalle mie parti non comprendono questa gerarchia. Ma io rispondo che non può che essere così. In me prevale la natura di musicista, che si occupa di questa musica, che è la più grande di tutte e va molto oltre il Paese dove è nata. Non considero Verdi soltanto italiano. Quando viene eseguito, e quando viene ascoltato, diventa di tutti. In Corea mi sembra che la situazione sia più dinamica: la gente vive la musica, e soprattutto i giovani. La studiano, la eseguono con un’intensità e con una passione che credo sia difficile mantenere quando si può contare su una lunghissima storia, che rende tutto un po’ ovvio e normale. Possederla da una parte è un vantaggio, dall’altra può divenire un problema. Penso che in Italia si dovrebbe equilibrare meglio la vita musicale di oggi con il glorioso passato. le, perché la gente preferisce Beethoven e Mozart. Ma nella sua epoca Beethoven era soltanto uno dei molti, ed è invece sopravvissuto al test del tempo: lui è rimasto e il resto l’abbiamo dimenticato. Il giudizio sugli autori contemporanei verrà emesso molto dopo. Ora siamo in una fase di ricerca, ma fra mille compositori solo pochissimi resteranno nella memoria fra duecento anni. Uno di questi credo sarà certo Olivier Messiaen. In Corea abbiamo una compositrice molto interessante, Unsuk Chin, universalmente considerata tra le più grandi oggi. La sua musica, molto apprezzata in Germania, mi piace molto, e l’ho interpretata spesso. (l.m.) Quello che dice non può non avere ripercussioni sul panorama musicale (e teatrale) contemporaneo. La situazione della musica d’arte è complessa, perché tutto dipende dai compositori… Aspettiamo di trovare una nuova strada. Dopo l’epoca d’oro di Stravinsky, Schönberg, Messiaen si continua a cercare. I nuovi autori non hanno vita faci- VENEZIAMUSICA e dintorni | 51 RIP LOU REED, IL VENETO E LE RUGHE PROFONDE DELLA POESIA ROCK L di Giò Alajmo* a scomparsa di Lou Reed ha tolto dalla scena rock uno dei suoi punti di riferimento storici. A 71 anni il poeta cantante chitarrista che inventò i Velvet Underground, con cui trovò credito alla Factory di Andy Warhol nel periodo più ricco e creativo della New York anni sessanta, se n’è andato all’improvviso con un fegato trapiantato da poco e un fisico che sembrava aver superato indenne anni di eroina e vizi. Lou era persona di poche parole e niente mezze misure. Carattere scorbutico, scontroso e indisponente, e altresì capace di entusiasmarsi per progetti impossibili e di dedicare delicate parole d’amore alle sue donne, soprattutto l’ultima, la compositrice d’avanguardia Laurie Anderson. Per molti era stato fonte di ispirazione per la crudezza dei testi, l’essenzialità delle musiche, il modo ruvido di cantare con voce aspra e tagliente. Nelle sue rughe c’era il vissuto di un’intera generazione e il solco percorso da altre, i punk, i grunge, quella parte del rock che amava sperimentare o usare immagini forti. Enrico Ruggeri esordì travestito come il suo travestimento del ’73, capelli ossigenati corti, occhiali scuri, lo stesso look mostrato da Morgan a X-Factor solo qualche giorno prima della morte di Reed. Ma Venezia fu testimone di una delle operazioni più sperimentalmente «assurde» che lo riguardavano. Fu alla Biennale Musica di qualche anno fa. Un ensemble d’avanguardia contemporanea tedesca, gli Zeitkratzer, decisero di mettere in scena l’arrangiamento per orchestra di Metal Music Machine. E gli chiesero di intervenire con la sua chitarra nell’ultima parte. Ora: Metal Music Machine comparve sul mer- 52 | VENEZIAMUSICA e dintorni cato nel 1975, due album in vinile, quattro lati da 16 minuti e 1 secondo ciascuna, occupate esclusivamente da variazioni di rumore prodotte dalla sovraincisione di due chitarre elettriche innescate da riverberi differenti e dalla vicinanza di amplificatori ad alto volume. I più (discografici e gran parte del pubblico) lo presero per uno scherzo di cattivo gusto, alcuni gridarono al miracolo, al capolavoro di rottura che uccideva ogni schema preesistente portando il rumore al suo estremo musicale. Lou non ha mai svelato fino in fondo i suoi intenti, probabilmente chiudere il suo rapporto con la sua casa discografica con l’ultimo disco in contratto un po’ come fecero i Rolling Stones lasciando alla Decca un blues dal titolo impubblicabile come ultimo sberleffo. Certo che una versione orchestrale di un’ora di rumore fu una bella scommessa, tanto che un noto sito rock mi chiese poi se era vero che mezzo teatro si alzò e fuggì a metà. Non era vero. Come rimase in teatro a Mestre anche chi si trovò ad assistere a quello che sperava fosse un concerto di Laurie Anderson, al Teatro Toniolo, e che in realtà scoprì essere una conferenza sul suo mondo musicale, con Lou Reed sornione che si era seduto a metà sala ad ascoltare. Lou amava Venezia e l’Italia, per il modo diverso di affrontare le cose, per «l’eleganza nell’approciare gli argomenti». Non ti risparmiava niente, come si ricorda chi si trovò a intervistarlo impreparato e uscì in lacrime dopo che lui aveva giocato come il gatto col topo. Lo incontrai anni fa a Sirmione dopo averlo vi* Critico musicale RIP sto esordire in Germania nel ’73 con il famoso look biondo-punk di «Walk on the Wild Side». Era un Lou Reed tranquillo, sereno, disponibile e in pace con il mondo, grazie anche alla donna che aveva a fianco, Silvia, che lo aveva allontanato dall’eroina e che poi si dice gli avrebbe mangiato il patrimonio una volta finito l’idillio. Il Festivalbar lo aveva fra gli ospiti, ma Lou riuscì a far impazzire Salvetti obbligandolo a sconvolgere la scaletta per consentirgli di suonare dal vivo. Dovettero allestire un set in apertura di spettacolo. L’effetto non fu sconvolgente a confronto con le produzioni ipertecnologiche e registrate di quei tempi, ma Lou si divertì. Amato da Vaclav Havel, lo scrittore e presidente della Cecoslovacchia liberata, per cui suonò alla Casa Bianca, Reed ebbe sempre chiaro da che parte stare, cancellando per esempio un concerto in Austria per protesta contro l’ingresso al governo del leader di ultradestra Haider: «Liberi gli austriaci di eleggere chi gli pare, libero io di non metterci piede», commentò. Comparve invece nel 1996 a Conegliano, a quel meraviglioso festival di poesia mescolata a musica che Giorgio Checchin ha curato per anni portandovi la crema del beat e dell’underground. Con Fernanda Pivano a tenere le fila del dibattito, Lou si divertì a sentir tradotte in veneziano da Luca Costalunga e Sandra Vitalba le sue espressioni di vita newyorchese, regalando cinque poemi e alla fine, con la chitarra di Eric Andersen, anche un paio di canzoni, «I’ll Be Your Mirror» e «Heroin», abbracciando Nanda, la nostra «ragazza del beat». Massimo Bubola, il cantautore veronese coau- ture di numerose canzoni di De André, lo conobbe in quell’occasione: «Uno spirito di pura poesia. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di fare un paio di reading con lui e di essere in un suo film biografico. Amava il blues, Keats e Byron e così mi aveva soprannominato. L’Amarone ed il Bourgogne. Amava raccontare lunghe barzellette senza finale. Detestava i reality, la miseria di tanta musica. L’assenza di compassione. L’assenza di ali e quella di radici. Un grande vero poeta». Laurie Anderson ha voluto condividere con la gente il racconto degli ultimi giorni di Lou Reed e il momento della sua morte: «Ai nostri vicini di casa. Che autunno meraviglioso! Tutto scintilla d’oro, e che luce incredibile e morbida. L’acqua ci circonda da ogni lato. Io e Lou abbiamo trascorso tanto tempo qui negli ultimi anni, e anche se siamo gente di città questa è la nostra casa spirituale. La settimana scorsa ho promesso a Lou di farlo uscire dall’ospedale e di tornare qui a Springs. E ce l’abbiamo fatta! Lou era un maestro di tai chi e ha trascorso in maniera felice i suoi ultimi giorni qui, abbacinato dalla bellezza e dalla potenza e dalla tenerezza della natura. È morto domenica mattina guardando gli alberi e facendo solo con le sue mani da musicista la famosa forma numero ventuno del tai chi. Lou è stato un principe e un combattente e so che le sue canzoni sul dolore e la bellezza che c’è nel mondo riempiranno la gente con la stessa gioia incredibile che lui sentiva per la vita. Lunga vita alla bellezza che ci colpisce e ci passa attraverso e ci cade addosso». Laurie Anderson, sua moglie devota e amica per sempre. VENEZIAMUSICA e dintorni | 53 Altre musiche «TRE AMICI» La cronaca di un concerto di Keith Jarrett secondo Costanza, cinque anni I di Vera Costantini* l ritorno di Keith Jarrett è stato uno dei momenti più emozionanti dello scorso festival Lo spirito della musica di Venezia. Costanza, dialogando con la mamma, racconta la grande serata che ha vissuto alla Fenice, dimostrando che il miracolo della musica accade a tutte le età. La giornata in spiaggia è stata breve: l’appuntamento della sera ha reso inevitabile il riposino pomeridiano, un’incombenza alla quale Costanza si arrende solo in presenza di motivazioni valide e convincenti. Il concerto di Keith Jarrett, prospettato dalla mamma, pareva una buona ragione, soprattutto a fronte dell’ultima esperienza al Teatro La Fenice, pochi giorni dopo il suo quinto compleanno, in occasione del Don Giovanni di Mozart. «Devo fare finta che ho sette anni?», mi chiede anche questa volta, godendo della prospettiva di un’occasione legittima per raccontare una piccola bugia. «Nooo, ho parlato con uno dei responsabili, dice che chiunque può entrare a teatro, anche le bambine di cinque anni». «Anche quelli di quattro anni? ». «Sì». «Anche di tre?!?» – ormai il disappunto lascia spazio all’incredulità. «Ti ricordi quando ti dicevo che non è importante quanti anni si abbia, ma cosa si riesca a fare? Ecco, il teatro è aperto a chi riesce a seguire uno spettacolo. Basta volerci andare e avere il biglietto». «Io voglio andare». «È aperto a tutti quanti…», le dico, e lei: «… viva la libertà!». Costanza è convinta che sta andando a vedere un’altra volta il Don Giovanni, perché ormai identifica il teatro con quest’opera, al cui ascolto è, del resto, sottoposta ogni giorno. Mentre penso che 54 | VENEZIAMUSICA e dintorni vedere nel Don Giovanni l’opera per eccellenza (l’opera delle opere, parafrasando Jacques Offenbach), e quindi, per traslato, anche identificarvi lo stesso luogo fisico dell’opera, il teatro, non siano idee del tutto irragionevoli, salgo con Costanza in vaporetto e nel tragitto dal Lido a San Marco, davanti a un meraviglioso tramonto, discutiamo del concerto che andiamo a vedere. Non ci saranno cantanti in costume. Non ci saranno proprio cantanti, solo musica. «Keith Jarrett è uno dei più grandi pianisti jazz del mondo», le dico. «Suona solo lui?», mi chiede. «No», le dico, «con lui ci sono altri due». All’entrata, consegna con soddisfazione il «suo» biglietto alla maschera, con lo stesso gesto sicuro con cui, al gate delle nostre innumerevoli partenze, porge alla hostess carta d’imbarco e passaporto, aperto sulla pagina della foto. Andare a teatro è come partire? Di sicuro questo concerto rischia di essere un bel viaggio, da Venezia a…? «Ciao, Costanza!», esclama la maschera: che combinazione, si tratta di un ragazzo che è in capanna con noi al Lido! Ci avviamo verso la platea e incrociamo proprio quel signore che aveva sdoganato l’entrata a teatro per le bambine di cinque anni. Glielo presento a Costanza ed ecco che ormai il teatro è un luogo familiare. Persone che si conoscono, che si incontrano, si ride, si parla e si scherza. Questa volta siamo in platea. Costanza guarda con un po’ di nostalgia i palchi. Mi confida che le sarebbe piaciuta di più una «casetta» là sopra, come l’altra volta. Tra le file passano le maschere, a chiedere di spegnere i cellulari e di non usare macchine fotografi* Università Ca’ Foscari di Venezia Altre musiche che durante la rappresentazione. «A Keith Jarrett non piace proprio essere fotografato, non gli piace neanche un po’. Una volta è stato fotografato e lui si è alzato e non ha più continuato a suonare». «Dov’è il sipario?», mi chiede, guardando il palco su cui troneggia il pianoforte, collocato in posizione inconsueta. Niente cantanti, niente sipario. Questa volta non è di sicuro il Don Giovanni. Due file davanti alla nostra si siede un altro bambino, con sua mamma. Indossa una cravatta nera a papillon e un paio di pantaloni al ginocchio stirati con la riga davanti. «Deve avere nove o dieci anni», mi dice Costanza. Intanto le luci si abbassano, fino a scemare del tutto. Entrano gli artisti. Keith ha una camicia rossa e un’andatura da personaggio dei cartoni animati. Con grande soddisfazione di Costanza, scrosciano gli applausi. Costanza mi sussurra pianissimo domande all’orecchio e io le rispondo nello stesso modo. Non basta: la signora davanti si gira un po’ seccata e dobbiamo rimandare commenti e domande alla pausa. Le curiosità vertono principalmente sulla natura degli altri due strumenti: la batteria e il contrabbasso (la «chitarra grande»), soprattutto su quest’ultimo, le cui corde, spiego, vengono pizzicate e non suonate con un archetto. Costanza ripete il movimento delle dita sulle corde. Sono come tre voci diverse che discutono. A volte si sentono tutte e tre, intrecciate tra loro, altre volte il pianoforte tace e si sentono solo batteria e contrabbasso. Altre volte ancora si sentono pianoforte e batteria, ma niente contrabbasso, e così via, secondo tutte le possibilità lasciate aperte da un dialogo a tre voci (consumato in un bar a luci soffuse e davanti a un Manhattan ghiacciato, penso io). «Facciamo un gioco», propongo a Costanza, «quando il concerto ricomincia tu mi dici di volta in volta qual è lo strumento che ha un suono prevalente sugli altri e quando invece tutti e tre gli strumenti suonano insieme». Costy ci sta. Le luci si abbassano e i musicisti rientrano in scena. «Keith Jarrett si è cambiato la camicia», mi dice piano Costanza. Comunichiamo a piccoli gesti, per non farci sentire. Ridacchiamo in silenzio. Nel corso del secondo tempo, il concerto decolla. L’intesa tra i tre è palpabile, come manifesto diventa il loro piacere nel suonare insieme, nel rispondere l’uno agli altri due e viceversa, nel consolarsi e coccolarsi, nell’usare le note, le pause e il volume come parole di una lingua sconosciuta di cui si percepisce solo il tono – ironico, sommesso, suadente – e mai un significato univoco. Non c’è bisogno di imparare a chiedere il bis: i tre musicisti regalano al pubblico, rapito, ben tre pezzi in aggiunta, oltre la chiusura del secondo tempo. Usciamo ed è già notte. Ci attende fuori dal teatro un amico che invitiamo a una cena frettolosa: un antipasto e via, perché è già tardi e dobbiamo rientrare al Lido, dove Costanza e io trascorriamo le nostre estati. «Che ne dici del concerto?», le chiedo sulla Linea 1, sedute dietro, al fresco. «Bello», mi risponde. Dice che le è piaciuto soprattutto il contrabbasso. E dopo un po’: «Mamma, Keith Jarrett e gli altri sono sicuro tre amici». VENEZIAMUSICA e dintorni | 55 Dintorni OTTAVIA PICCOLO PARLA D’ARTE E DI DONNE MALTRATTATE T a cura di Leonardo Mello raviata e Carmen, a settembre riproposte «in tandem» alla Fenice, nella loro grande diversità raccontano storie di donne sofferenti, maltrattate, succubi di una società ipocrita e perbenista. Questo tema è tuttora estremamente attuale, e si declina in mille differenti sfaccettature. Da qui è partita una mobilitazione, da parte del Teatro, che ha dato luogo a molte iniziative, tra cui un partecipato reading di fronte alla Fenice, cui – nello stile spontaneo degli «antichi» happening – hanno partecipato molte esponenti della comunità artistica e della società civile. È stata anche lanciata una gara al miglior messaggio inviato ai social network della Fenice su questo drammatico tema, che si è poi aggiudicata Chiara Farnea con un significativo acronimo della parola Carmen. Della giuria – insieme a Gabriela Camozzi, Maria Laura Conte, Giusi Fasano, Simona Marchini e Barbara di Valmarana – ha fatto parte anche Ottavia Piccolo, una delle più importanti e colte attrici italiane, che – lavorando nell’arco degli anni con maestri quali Visconti, Strehler, Ronconi, Squarzina, Cobelli ecc. ecc. – ha vestito i panni di molte dolenti figure femminili. Con l’occasione ce ne racconta qualcuna. Andando a ritroso, senza preoccuparmi di un ordine cronologico, il primo spettacolo che mi viene in mente è Terra di latte e miele di una scrittrice italo-israeliana, Manuela Dviri. È la storia di una donna maltrattata sì, ma dalla vita, perché ha perso il figlio di vent’anni nella guerra del Libano e cerca di recuperare la propria esistenza a partire da questa tragedia. Ma per farlo – lei, donna ed ebrea – rifiuta di essere incasellata nella parte di «madre 56 | VENEZIAMUSICA e dintorni del caduto». E dunque rompe le regole secondo le quali esiste un comportamento corretto per chi ha vissuto una simile, tragica esperienza. Questo però la mette contro la società del suo Paese, fino ad essere accusata di qualsiasi cosa, perfino di essere antisemita. È una donna che si ribella al ruolo che le si vorrebbe cucire addosso. Un altro esempio è poi Buenos Aires non finisce mai: mi ero innamorata del libro di Massimo Carlotto, Le irregolari, e gli avevo chiesto di scrivere un pezzo per me. Non potendo farlo lui direttamente, mi ha consigliato due suoi giovani amici, Vito Biolchini ed Elio Turno Arthmalle, che insieme al regista Silvano Piccardi hanno costruito un personaggio femminile, inventato ma molto verosimile, cui sparisce il marito durante la dittatura e che per molti anni resta immobile, come paralizzata, fino a quando scopre le Madres de Plaza de Mayo e da lì in poi riconquista la sua vita e la voglia di lottare. Per approfondire la tematica siamo andati a Buenos Aires a conoscere queste Madri, e abbiamo compreso che rappresentano il paradigma perfetto della donna che fino a un certo punto si è occupata della sua casa, del suo lavoro, e poi, dopo il trauma orribile della perdita dei figli o del marito, si è messa in gioco completamente. La presidente dell’Associazione era una maestra, ma ce n’erano tantissime analfabete o quasi. Tutte loro si sono completamente dedicate a questa lotta e credo che il motivo stia nel fatto che le donne non hanno mai niente da perdere. Non è che gli uomini, in quel contesto, fossero assenti, o che non soffrissero per i loro cari scomparsi, però non hanno fatto nulla, perché un uomo ha sempre qualcosa da perdere: il lavoro, la posizione sociale, la rispettabilità… Per Dintorni una donna tutto questo può passare in secondo piano. Tornando a figure di donne sfruttate, o uccise per questioni «di cuore», le vengono in mente altre sue interpretazioni che potrebbe accostare a Violetta o a Carmen? Be’, prostitute ne ho interpretate diverse, dato che avevo una faccia angelica e la prostituta con la faccia d’angelo, magari di buoni sentimenti, funziona sempre. Te ne cito una soltanto, la Berta di Bubù di Montparnasse, il film che Mauro Bolognini ha tratto dal romanzo di Charles-Louis Philippe: in quel caso, più che di una donna maltrattata direi che siamo in presenza di una donna trattata come un calzino vecchio, usata e poi gettata via. Anche se, per esempio rispetto a Metello, dello stesso Bolognini, con il quale ho vinto il Premio per la miglior interpretazione a Cannes, non è stato un film riuscitissimo, quello era un personaggio che mi aveva molto impegnata, perché mi sembrava importante, pur essendo all’epoca ancora una ragazzina, poter raccontare il degrado fisico di questa donna. E in questo sono stata molto aiutata da Piero Tosi, che si occupava dei costumi, e che mi ha accompagnata nella metamorfosi. Lui per istruirmi mi diceva: «Una prostituta non si muove e non parla allo stesso modo di una ragazzina che fa la lavandaia...». Tornando al teatro, un caso diverso, ma fino a un certo punto, è stato Rosanero di Roberto Cavosi, una pièce sulle donne di mafia. Lì incarnavo una specie di capofamiglia di un clan composto tutto da donne, e di fatto portavo avanti i valori mafiosi. Ma le donne cosa fanno, in fondo? Trasmettono i valori della famiglia, siano che siano «buoni», sia che siano legati a logiche arcaiche e criminali. Però anche lei è succube di quelle logiche, quindi diviene carnefice e vittima allo stesso tempo, tanto che per tacitare una faida prima che esplodesse in una escalation di violenza cede il fratello più piccolo alla famiglia nemica, che ovviamente lo uccide. Poi, all’interno del repertorio classico, ci sono le varie Ofelia, Cordelia, Rosalinda... Ma anche un personaggio come Ofelia può avere molte sfuma- ture. Quando l’ho incarnata, nella prima edizione firmata da Gabriele Lavia nel ’78, anche lei era una vittima della famiglia. C’è una scena che di solito viene tagliata, dove Polonio le impartisce lezioni su come ci si deve comportare, su che cosa una donna può o non può fare. Ofelia di solito ci viene descritta come una fanciulla che impazzisce per amore, il che in parte è certamente vero, ma c’è di più, ci sono condizionamenti sociali e familiari che la opprimono. Lo stesso Laerte opera una violenta pressione su di lei. Grazie a Lavia credo di aver dato vita a una figura un po’ meno convenzionale di quella cui siamo abituati. Poi, sempre con Lavia, ho impersonato un’Alcmena nell’Anfitrione di Kleist: anche in quel caso la donna è uno strumento nelle mani di Giove. Le donne, fino a che non prendono in mano la loro vita, restano sempre strumenti. Lì in fondo si tratta di uno stupro, perpetrato nella totale inconsapevolezza di lei, che crede di fare l’amore con il proprio marito e ignora che invece è la suprema divinità che ha preso le sue sembianze. Parliamo ora di uno spettacolo molto applaudito, Donna non rieducabile di Stefano Massini, che narra la tragica vicenda di Anna Politkovskaja. Quando nel 2007 Stefano mi ha mandato il suo testo su di lei mi sono subito messa a disposizione, ed erano passati appena sei mesi dalla sua morte. Mi sono immediatamente innamorata della situazione, per come l’autore l’aveva trattata. Quella vicenda si poteva raccontare in diversi modi. Si poteva narrare di una vita in mezzo alla guerra, oppure raccontare didascalicamente la sua esistenza. Ma non era quello che volevamo fare: nostra intenzione era, attraverso i suoi scritti, far capire qual era il suo punto di vista rispetto alle cose. Negli anni poi il lavoro è cresciuto, anche grazie agli incontri, spesso pubblici, con i suoi due figli. E mi sono sempre più resa conto che lei era davvero una donna speciale, che se n’è fregata del suo tornaconto, perché poteva vivere di rendita con quello che aveva scritto fino ad allora. Invece ha preso la posizione più coraggiosa, dare voce alle persone che non ce l’hanno. Le madri dei soldati morti in Cecenia i cui VENEZIAMUSICA e dintorni | 57 Dintorni corpi non venivano nemmeno restituiti. Gli orfani giovanissimi mandati in guerra in quella che è stata chiamata la seconda «spedizione», che venivano magari uccisi per insubordinazione e nessuno si lamentava. Le donne cecene violentate e poi uccise. Lei, in tutti questi casi, si è battuta come una tigre per dire al mondo quanto accadeva, perché venissero istruiti processi e fosse fatta giustizia. È stata minacciata in tutti i modi, fino a che sono riusciti a farla tacere. Non voglio con questo dire che se fosse stata un uomo l’avrebbero trattata con i guanti, ma certo non ci sarebbero stati certi tipi di violenza – come la reiterata minaccia di stupro – tipicamente rivolti verso le donne. Come si può interpretare la vita di prostitute, donne violentate e maltrattate dagli uomini o dalla vita? In altri termini, come si fa a raccontare questo dolore? Quello che ho tentato di fare sempre, e soprattutto in questi ultimi anni in cui in un certo senso sono stata anche «motore» di alcuni spettacoli, sia con Cavosi che con Massini, è stato eliminare qualsiasi retorica. Raccontare il dolore è difficile, ma non si può nemmeno proporre un ricatto a chi ti ascolta, per cui più o meno gli si dice: «Ti sto raccontando vicende terribili, in modo da costringerti a piangere con me». Dopodiché tutti ce ne andiamo a casa contenti, in preda alla famosa catarsi liberatoria contro cui aveva lottato Brecht. Abbiamo voluto, nel narrare queste storie, mettere in evidenza 58 | VENEZIAMUSICA e dintorni anche i punti oscuri: non è che una madre, se perde un figlio, si trasforma automaticamente in eroina. Anche per il mio modo di intendere la vita, ho sempre cercato di asciugare, di non essere mai patetica. A questo proposito mi torna in mente uno spettacolo che mi ero dimenticata di citare, Processo a Dio, sempre scritto da Stefano Massini. Anche in quel caso il testo andava molto al di là del ricatto di cui parlavo prima. Stefano ci aveva messo dentro la responsabilità individuale: cosa ognuno di noi poteva e può fare oggi. Quindi anche il personaggio di Elga Firsch, che io interpretavo, aveva molti chiaroscuri. Non era «buona» soltanto perché si trovava in un campo di concentramento. Nell’interpretazione ho inteso sempre cancellare gli stereotipi della donna vessata, impotente, vittima. Ciò che mi interessa è trovare testi che raccontino la complessità di un personaggio, altrimenti è una narrazione a senso unico, che non interessa a nessuno. Mi sembra che, dalla narrazione funzionale a un plot, nel tempo lei abbia preferito esprimere una testimonianza. Sì, è vero. Per me oggi l’importante è raccontare qualcosa che mi riguardi come cittadina, come donna, come individuo politico nel senso più esteso possibile del termine. Perché trovo che il teatro, in questi tempi così confusi, possa dare delle chiavi di lettura della realtà che i giornali, i saggi dedicati a un argomento specifico, i libri di storia non ti riescono più a dare. Polemiche I NEMICI DELLA MUSICA Un testo corrosivo che i burocrati di ogni specie dovrebbero mandare a memoria I di Quirino Principe* l tema della scarsa attenzione alla musica da parte delle istituzioni italiane – in primo luogo la scuola – è stato nei mesi scorsi lanciato con forza da parte del Teatro La Fenice, che ha fatto sue le lamentele e il disagio di molti docenti. Pubblichiamo di seguito un estratto da I nemici della musica, un lungo ed eloquente saggio di Quirino Principe – amico generoso della nostra rivista sin dagli albori – nel quale, prima di affrontare con grande chiarezza e lucidità la situazione attuale, lo studioso analizza le responsabilità delle forze culturali che hanno reso il panorama musicale italiano desolante. È un appello accorato e sferzante, cui speriamo possano seguire repliche e risposte, che proporremo in queste pagine e nel nostro sito web. [...] fenomenologia della disperazione Conosciamo i volti dei nemici mortali e irriducibili della musica. Conosciamo i volti di quei malviventi recidivi. Li vediamo sedere nei posti d’onore di quei teatri d’opera che proprio essi dichiarano di voler cancellare alla vita culturale e sociale d’Italia. Li vediamo sedere in organi collegiali cui spetta il compito di promuovere l’attività artistica proprio dei teatri d’opera e delle associazioni concertistiche. Di che cosa li dobbiamo ringraziare? Di ciò che, oggi, è per la musica forte la possibilità di vita, in Italia. a) È in corso la progressiva scomparsa del pubblico della musica forte in Italia. Tra dieci anni sarà possibile ascoltare Bach o Gesualdo o Monteverdi o Debussy o Hindemith o Šostakovič soltanto in privato, da incisioni discografiche che diverranno sempre più vecchie e logore, e forse con qualche preoccupazione d’essere «scoperti» e denunciati dall’imam condominiale e consegnati al braccio secolare. Questo avverrà grazie al progressivo liquefarsi di ogni residuo gusto musicale e di ogni superstite conoscenza musicale, a causa dell’assenza della musica, come disciplina curricolare di studio, dal normale e generalizzato corso di studi. Nel frattempo, nel linguaggio della RAI o di autorevolissimi organi di stampa come il «Corriere della Sera» o «La Repubblica», espressioni come «musica italiana», «storia della musica italiana», «il Gotha della musica italiana», «la grande musica italiana», si riferiscono ai cantautori rock e pop, e al Festival di Sanremo. b) Non esistono prove selettive per l’assunzione in ruolo dei docenti di musica. Data tale inesistenza, il livello qualitativo dell’insegnamento musicale nei Conservatori, fino ad oggi ancora lodevole, è destinato a crollare rapidamente, una volta superata la soglia del mancato ricambio. c) La musica d’oggi, la musica contemporanea, è occultata nelle pubbliche manifestazioni musicali (concerti, stagioni d’opera…). È come se non esistesse. Ai giovani compositori è sottratto il futuro. d) Il potere legislativo è colpevole e impunito: i legislatori, quale che sia la loro parte politica, * Musicologo – Critico musicale – Scrittore VENEZIAMUSICA e dintorni | 59 Polemiche persistono nella loro scelta criminale di non dare alla musica il posto che le spetta nelle scuole di ogni ordine e grado. Una disciplina che venga insegnata soltanto nelle scuole specializzate (nel caso della musica, i Conservatori) è condannata a diventare oggetto museale. Una civiltà musicale degna di questo nome, come quella esistente in ogni altro Stato europeo, si nutre di cultura musicale diffusa non meno che di studi severi, selettivi e preparatori alla professione. e) Nella legislazione italiana, alla musica non è riconosciuto il rango di bene culturale, né le viene riconosciuto il diritto alla tutela. Nello Stato italiano, la musica è considerata dalla legge come danno alla salute, delitto acustico, rumore molesto, strumento per delinquere, e, nei casi di maggiore benevolenza da parte del potere esecutivo (forze di polizia, vigili urbani), come frivolo svago. Un’esecuzione musicale, in Italia, dev’essere valutata non dalla critica o dalla musicologia, per poter avere un valore legale e ufficiale; dev’essere valutata da un vigile, da un carabiniere o da un pretore, e l’unità di misura della valutazione è il decibel. f) Il potere giudiziario, nei casi in cui lo studio di uno strumento musicale da parte di uno studente di Conservatorio o di un concertista illustre nelle loro rispettive abitazioni «disturbi» un vicino ipersensibile, condanna quasi sempre il musicista a sanzioni pecuniarie dell’ordine di grandezza di centinaia di migliaia di euro (per «danni esistenziali»), talvolta anche al sequestro o alla perpetua inagibilità dello strumento, provocando la rovina di una famiglia, l’interruzione di un promettente e vocazionale corso di studi, e la disperazione − questa volta sì «esistenziale» − di alcuni cittadini integri ed esemplari. g) In Italia, la legge non considera lo studio della musica un lavoro. Di recente, ho domandato a un magistrato che cosa pensasse, egli, del caso di un gestore di discoteca, il quale, avendo l’ovvia abitudine di rincasare alle cinque della mattina, pretendeva di dormire da quell’ora fino alle dieci di sera, impedendo così a un giovane, diligente e talentoso studente di Conservatorio, 60 | VENEZIAMUSICA e dintorni suo condomino, di esercitare il proprio dirittodovere nell’unica fascia oraria consentita dal regolamento di condominio. Il giudice mi ha risposto, allargando le braccia e sollevando gli occhi al cielo nel tipico gesto della rassegnazione mediterranea, che non c’era alcuna via d’uscita per lo studente. Agli occhi della legge (pardon, della Legge!), un discotecaro svolge un lavoro, dal momento che produce un reddito e interessa il PIL, mentre uno studente di musica non svolge un lavoro bensì qualcosa di simile allo «svago», insomma fa qualcosa per suo «piacere», e non interessa il PIL. Nel conflitto d’interessi, la ragione è inevitabilmente dalla parte del discotecaro che esercita il suo diritto alla nanna ossia alla «salute» (!), e al quale il delinquente (ossia lo studente di Conservatorio) infligge danni esistenziali. dichiarazione di guerra Ai responsabili di questa situazione, noi siamo decisi a reagire. Con tenaglie arroventate, dobbiamo strappare denti e artigli ai nemici della musica. Luigi Berlinguer, ministro della Pubblica Istruzione dal maggio 1996 all’aprile 2000, con un paziente, lungo e faticosissimo lavoro di documentazione, di ricerca e di persuasione, è riuscito ad avvicinare il nostro sistema scolastico a un punto di svolta, che potrebbe essere decisivo. Mai l’inserimento della musica nel normale corso di studi di un cittadino italiano è stato un obiettivo così vicino: basterebbe un ultimo sforzo, e la meta sarebbe raggiunta. Berlinguer colpisce nel segno, osservando che la malattia mortale dell’istruzione musicale in Italia è la spaccatura di questa preziosa realtà educativa in due tronconi, finora impossibili a saldarsi con una stagnatura fatta di espedienti, come avviene, nel Ring wagneriano, alla spada Nothung, infranta e affidata al fabbro Mime, prima dell’intervento radicale di Siegfried. Occorre rifondere i frammenti nel crogiuolo e trarne una lama unica e sana, non stagnare o incollare. I due tronconi, osserva ancora Berlinguer, sono da un lato il DAMS o l’Istituto universitario di musicologia, dove gli studenti Polemiche discettano di Adorno e di Hanslick e magari di Boulez o di Dahlhaus ma non sanno suonare uno strumento qualsiasi e sovente non leggono neppure il pentagramma; dall’altro lato, il Conservatorio, dove gli studenti diventano bravissimi strumentisti ma rimangono ignoranti in letteratura antica e moderna, in storia, in filosofia, in matematica e fisica, nelle lingue moderne, in semiologia e linguistica, in sociologia, in economia, in legislazione musicale. Lato debole dei DAMS è, in sostanza, la prospettiva di far musica «parlata», e non musica «suonata» o «cantata». Da qui si deve cominciare. Il punto di partenza, affinché nel nostro infelicissimo Paese la musica possa avere vita, sviluppo e forza, sì da introdurre almeno la felicità della ragione e della bellezza in un contesto di sventure quali sono quelle in cui stiamo vivendo, è fare sì che tutti coloro che studiano apprendano la musica, e che tutti coloro che apprendono la musica imparino a farla, non soltanto a parlarne. Ma, a questo fine, a) D obbiamo strappare denti e artigli ai nemici della musica che hanno tradito l’eredità culturale italiana ad essi lasciata in legato. Con tenaglie incandescenti, roventi, ustionanti, dobbiamo punire coloro che hanno impedito a tanti giovani italiani di coltivare la propria vocazione per la musica; dobbiamo far sì che costoro non possano più nuocere. Costoro costituiscono una vera e propria organizzazione criminale. Siano puniti dalla Legge, in conseguenza! b) Dobbiamo obbligare i legislatori a cancellare l’infame equazione tra musica e rumore misurabile in decibel, tra suonare uno strumento e «delinquere». Se è vero (com’è vero!) che qualcuno, usando legalmente ma colpevolmente la propria autorità e il proprio potere, danneggia il diritto di chi affida alla musica e a uno strumento musicale la propria intelligenza e il proprio talento, sulla linea di una tradizione che ha reso grandissima l’Italia nel passato, allora costui dev’essere punito come chi danneggi gravemente altri beni culturali e artistici, come chi sfregi la Primavera di Botticelli o decapiti la Pietà Rondanini. Dovrebbe essere punito dalla legge con la pena estrema: la morte. Io sono un fermo assertore della pena di morte per i soli reati culturali, essendo i reati culturali i più gravi, poiché la cultura è più importante dell’economia, della politica, delle leggi, della salute; ma essendo io, come don Giovanni, «uom di buon cuore», mi accontento del veder condannati al carcere duro e ai lavori forzati i vili, i lacchè e i falsari: in particolare, gli pseudo-scrittori «serici», gli pseudo-mistici, gli pseudo-cantanti veggenti o non, gli pseudo-pianisti con o senza bigodini, le pseudo-poetesse, gli pseudo-attori dantologi. Pongo un’eccezione per coloro che stuprano la lingua italiana usando anglicismi a cascata. No, per quelli la Legge non deve avere compassione: a morte, a morte! c) I legislatori compiano finalmente il loro dovere, pur se faticoso. Dichiarino bene culturale la musica, e introducano nella legislazione strumenti che la tutelino e ne garantiscano il libero esercizio. Introducano finalmente, in tutti gli ordini e gradi dell’ordinamento scolastico, la musica come disciplina obbligatoria e curricolare, sì da cominciare a ricostruire la conoscenza della musica e il gusto per la musica nel corpo sociale dei cittadini italiani. Abbiamo dato prova d’infinita pazienza. Ora la pazienza è interamente esaurita. Offriamo ancora questa possibilità di ravvedimento ai nemici della musica: è l’ultima. Se la nostra offerta generosissima non sarà raccolta, dovremo combattere. Mi rivolgo ai molti giovani musicisti, offesi e disperati, amareggiati e umiliati. Amici, coraggiosi amici in cerca di un frammento di speranza, sappiate che l’accesso a quella via passa di necessità attraverso il muro infranto che ha nome: guerra senza quartiere ai nemici della musica. La Legge ci offre i mezzi per resistere alla distruzione, all’estinzione, all’agonia della cultura, che significa distruzione, estinzione, agonia dell’Italia. Io voglio combattere «usque ad sanguinem». Lancio un appello a coloro che in Italia tutelano la Legge e la applicano: per favore, permettetemi di combattere, aiutatemi a combattere, impedite che l’Italia scivoli nel Nulla! Non tradite la sovranità che vi è stata delegata dagli elettori, dai contribuenti fedeli, da coloro che odiano la volgarità, l’ignoranza, la menzogna, l’imbecillità! VENEZIAMUSICA e dintorni | 61 Polemiche in seconda persona, a coloro che vogliano combattere insieme con me. Lancio un appello ai giovani che hanno scelto di vivere poveri al servizio della cultura. So che siete numerosi quanto basta per spazzare via l’immondizia, per recidere le membra infette che si annidano e talvolta si nascondono all’interno del quadriforme apparato di potere che oggi, contaminato com’è da cellule malate, ci opprime e ci soffoca. Reagite con decisione estrema e inflessibile contro l’ignoranza, la volgarità, l’imbecillità. Aiutatemi: insieme, gettiamo il turpe e il malsano, il vile e il falso, la truffa affaristica o malavitosa o «religiosa» nell’immondezzaio della Storia. Ancora tacete, poiché vi hanno insegnato la rassegnazione, il «realismo», la moderazione (quella cosa ripugnante che alcuni chiamano anche «misura» e 62 | VENEZIAMUSICA e dintorni «buona educazione»). Vi hanno spiegato, alcuni con untuoso indottrinamento «religioso», altri con i sedativi della democrazia semi-laica, che la terra è una valle di lacrime, e che sono sempre altri che tengono il coltello per il manico. Ora è per voi, per noi, il momento di strappare di mano il coltello ai nemici, e di gettarlo nella discarica, in modo che essi non possano più afferrarlo. Costringiamoli ad affrontarci sul terreno delle conoscenze, della logica, della ragione, dell’intelligenza: su questo terreno, che ci appartiene, essi sono meno che nulla, e noi siamo vincenti in partenza. Contro l’ignoranza, contro la falsificazione, contro la menzogna, contro la volgarità, contro la viltà, contro l’imbecillità, contro il dominio dei «devoti» e dei lacchè, questo è un formale atto d’accusa, questa è una dichiarazione di guerra. Carta canta LE RECENSIONI A di Giuseppina La Face Bianconi* ndrea Fabiano insegna letteratura e cultura italiane alla Sorbonne, e da sempre coltiva la drammaturgia teatrale e operistica; Michel Noiray, ricercatore nel Centre National de la Recherche Scientifique, è specialista della musica europea fra Sette e Ottocento. Insieme pubblicano per EDT L’opera italiana in Francia nel Settecento, un volumetto in cui ripercorrono gli intrecci che «un’idea di teatro» – quella dell’opera italiana – determina nel venir accolta a Parigi. Francia e Italia avevano, quanto a poetica drammatica e sistema teatrale, visioni e istituzioni diverse, se non addirittura antitetiche: la storia dell’opera italiana in Francia va dunque trattata come «un fenomeno di alterità estetica sia di produzione sia di recezione». Il quadro tracciato dai due autori è snello e puntuale. Dà vivido risalto alle aporie che l’attrazione per l’opera italiana incontra nella prima metà del secolo, indi all’in* Ordinario di Musicologia e Storia della Musica all’Università di Bologna Andrea Fabiano – Michel Noiray, L’opera italiana in Francia nel Settecento. Il viaggio di un’idea di teatro, Torino, EDT, 2013 («Risonanze»), 118 pp., ISBN978-885920-287-5, 12,50 euro. Piero Weiss, L’opera italiana nel ’700, a cura di Raffaele Mellace, Roma, Astrolabio – Ubaldini, 2013 («Adagio»), 298 pp., ISBN 978-88-340-1651-0, 27,00 euro. Arrigo Boito, Il primo Mefistofele, a cura di Emanuele d’Angelo, V enezia, Marsilio, 2013 («Opere di Arrigo Boito»), 222 pp., ISBN 978-88-317-1623-9, 22,00 euro. e anche: Emanuele D’angelo, Arrigo Boito drammaturgo per musica. Idee, visioni, forma e battaglie, Venezia, Marsilio, 2010 («Saggi»), XVII-317 pp., ISBN 978-88-317-0700-8, 32,00 euro. VENEZIAMUSICA e dintorni | 63 Carta canta fatuazione per l’opera buffa tra il 1758 e il 1789. Al centro sta il clamoroso episodio dei «Bouffons» (1752-1754): magistrale per erudizione e nitidezza il capitolo sulla disputa filosofica suscitata dal successo delle troupes di cantanti-attori italiani specializzati negli intermedi, Pergolesi in primis, che per due anni «invadono» il tempio dell’opera francese classica, l’Académie Royale de Musique. Vent’anni dopo, l’arrivo di Gluck, che rimodella la tradizione autoctona della tragédie en musique, cambia di nuovo le carte in tavola; così come il trambusto della Rivoluzione scompagina i gusti del pubblico, sempre più attratto verso l’opéra-comique. Il saggio fornisce la cronologia delle opere italiane date a Parigi sia in francese sia in italiano, e un’aggiornatissima bibliografia. È un apporto di alta levatura, che tratteggia egregiamente un processo, contrastato ma fecondo, di acclimatazione e assimilazione d’un genere allotrio in un contesto intellettuale così orgoglioso come quello parigino. Un altro contributo di spicco alla comprensione storica del melodramma settecentesco proviene dall’editore Astrolabio di Roma, che pubblica L’opera italiana nel ’700 del compianto Piero Weiss, pianista e musicologo triestino emigrato negli Stati Uniti (ha insegnato a lungo alla Columbia e alla Johns Hopkins). I sette capitoli trattano partitamente i diversi generi dell’opera in musica: il dramma per musica, gli intermezzi comici, la commedia per musica a Napoli, il dramma giocoso a Venezia, le «riforme» di metà Settecento, la diffusione oltralpe; risalta tra tutti il capitolo sui drammi del Metastasio, visti in chiave teatrale, letteraria, musicale. Weiss è uno scrittore sopraffino: in ogni pagina si ammira l’acume critico, l’abilità 64 | VENEZIAMUSICA e dintorni nel cogliere con tratto semplice e immediato processi intellettuali complessi, la perizia nel leggere gli scritti dei trattatisti coevi e nel ricollegarli alla realtà scenica dell’‘evento’, lo sguardo attento sulla percezione degli spettatori, il loro gusto, la loro volubilità. È un affresco suggestivo e istruttivo, dove la pennellata ariosa si combina con l’amore per il dettaglio. Entrambi i volumi qui recensiti emanano da un progetto culturale ambizioso di alcuni anni fa: gli scritti erano stati infatti concepiti per la Storia dell’opera italiana EDT, diretta da Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli. L’opera non è stata ultimata: ma per fortuna degli appassionati alcuni saggi escono ora alla spicciolata. Emanuele D’Angelo insegna Storia dello spettacolo e Storia della musica nell’Accademia di Belle Arti di Foggia. Librettologo eruditissimo, ha dedicato studi importanti ad Arrigo Boito, tra essi un’ampia monografia apparsa da Marsilio nel 2010. Ritorna ora sul poliedrico «scapigliato», librettista e compositore, in particolare sul suo tormentato capolavoro, Mefistofele, dato alla Scala il 5 marzo 1868: fu un fiasco memorabile, risarcito con tagli e aggiunte nella più fortunata revisione bolognese del 1875. D’Angelo fornisce ora un’edizione critica accuratissima del «primo Mefistofele», che finora mancava. Il lavoro è ammirevole. L’ampio, dovizioso commento registra puntualmente i debiti contratti da Boito, verso per verso, nei confronti del Faust I e II di Goethe, ch’egli compulsò anche attraverso diverse traduzioni francesi e inglesi. L’edizione di Emanuele d’Angelo «rinfresca» come meglio non si potrebbe lo sguardo di filologi e melomani sull’immaginario poetico e teatrale di Boito. VENEZIAMUSICA e dintorni Le radici dell’«Africaine»: l’esotismo in letteratura, pittura e musica nella Francia di primo Ottocento di Adriana Guarnieri Sull’«Africaine» di Massimo Contiero Le voci dell’«Africana» di Giorgio Gualerzi «Aspern» al Malibran: l’analisi di Salvatore Sciarrino Biennale Musica 2013: due recensioni di Mario Messinis e Paolo Petazzi Verdi versus Wagner: alla pari? di Quirino Principe Lou Reed, il Veneto e le rughe profonde della poesia rock di Giò Alajmo I libri di Giuseppina La Face Bianconi Edizioni La Fenice
Scarica