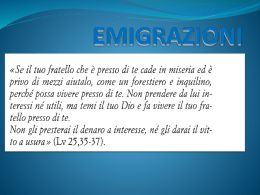3.1.6. I CAVALIERI DI EKEBU' 245 Tancredi Mantovani, [Rassegna musicale], «Nuova antologia» LX/1268, 16.1.1925 - pp. 2167 Siano rese grazie a Santo Stefano! In quasi tutti i capoluoghi delle nostre provincie i teatri si sono riaperti nella ricorrenza del tradizionale patrono delle scene liriche, salvo qualche deroga, come quella fatta dalla “Scala”, che ha iniziato la sua “Stagione” a metà novembre, o quella del “Regio” di Torino, che l’ha cominciata il 30 dicembre. Almeno così per due o tre mesi avrà sosta il ritornello della lamentata “crisi del teatro”, una delle tante crisi che ci travagliano, con scarsa probabilità di vederla risolta, stante che dipende dal costo quintuplicato delle spese degli spettacoli, sopra tutto di quelle delle masse orchestrali e corali. Certamente alla soluzione invocata non giovò la intromissione delle Camere del Lavoro, né ora val meglio quella dei Sindacati orchestrali, che, specie nella gestione diretta d’imprese, o per poca esperienza in materia, o per ragioni d’indole amministrativa, si sono risolte in disastri economici e spesso anche artistici. Ma l’argomento, meritevole di essere studiato e discusso a fondo, esorbita dai modesti limiti di una rapida rassegna, così per oggi dovremo sorvolare, passando alla cronaca abbastanza lieta della “stagione” lirica in corso. La “Scala” ha riaperto i suoi battenti con una ripresa del Nerone boitiano che poco prima aveva ottenuto una magnifica accoglienza al “Comunale” di Bologna. Delle novità assolute comprese nel “cartellone” scaligero ha già riportato, come tutti ricordano, un battesimo complessivamente molto onorevole La Cena delle beffe di Umberto Giordano, sul testo, necessariamente sfrondato, del notissimo poema drammatico di Sem Benelli. La seconda delle nuovissime opere, attesa con eccezionale interesse, saranno I Cavalieri di Ekebù di Riccardo Zandonai, sul libretto che Arturo Rossato ha tratto dalla Leggenda di Gösta Berling, il bel romanzo della rinomata scrittrice svedese Selma Lagerlöf, il quale compendia un seguito di novelle che s’intrecciano fantasiosamente con un carattere rapsodico tra un bizzarro miscuglio di elementi umani e di soprannaturali. Non ostante che il dramma si svolga in ben quattro atti a cinque quadri, Zandonai ci ha rassicurati che lo spartito avrà complessivamente proporzioni e durata normali, avendo egli rinunziato di proposito a digressioni o amplificazioni liriche, a preludî od intermezzi per lasciare il primato all’azione drammatica, per fare esclusivamente “del teatro”. E niente estremismo orchestrale o armonistico: una strumentazione molto leggera, che non soverchi le voci dei cantanti con le pletoriche sonorità dell’orchestra, una trama armonica chiara, riposante su le consonanze, senza il sistematico urto stridente spasmodico degli accordi eterogenei. In vero abbiamo tutta la fiducia che un musicista geniale, maturo d’esperienza qual è Riccardo Zandonai si sarà attenuto ai suoi propositi estetici. Del resto Riccardo Strauss, dopo le sonorità orgiastiche della Salome, non ha forse dato “macchina indietro” fino a ritornare alla limpidezza dell’orchestrazione mozartiana? E Igor Strawinsky non ha dunque scritto una sua recente partitura teatrale con soli dodici strumenti in orchestra? Segni di una evoluzione, se non di una reazione, di cui molti giovani compositori italiani votati all’estremismo dovrebbero tener conto per non andar incontro a delusioni. [...] 246 Giorgio Barini, Alla vigilia dei “Cavalieri di Ekebù”, «L’Epoca», 27.3.1925 - p. 3, col. 5-6 3.1.6/1 Quando seppi che Riccardo Zandonai aveva scelto a soggetto del suo spartito «La Saga di Gösta Berling» di Selma Lagerlöf, non conoscevo della forte scrittrice svedese che «Il meraviglioso viaggio di Nils Hogersson a traverso la Svezia»: il libro di lettura per le scuole; in esso le oche selvatiche, tra cui prima la vecchia Akka; e Jarro, l’onesta anatra, la quale, avendo compreso che gli uomini vogliono valersi di lei come richiamo, pone in guardia gli uccelli che accorrono; e Mirke, il gatto loico; e tutti gli altri animali si rivelano di così equilibrata e razionale mentalità, mentre la Svezia appare a traverso le pagine della popolaresca odissea la protagonista dell’opera geniale. Lessi subito «La saga di Gösta», in cui vivono e si agitano i tumultuanti cavalieri di Ekebù; e rimasi perplesso, non comprendendo come da quel libro denso e turbinoso, in cui i paesaggi e le figure si agitano e le avventure si svolgono con una volubilità caleidoscopica impareggiabile, fosse possibile ricavare lo schema sintetico e necessariamente scheletrico di un dramma per musica. Però, nella vicenda varia e agitata del romanzo, che rivelò al mondo la potenzialità creatrice della poetessa illustre, un elemento appariva dominante, così da giustificare l’attrazione del libro sul maestro: la potenza della musica, feconda, animatrice, inspiratrice di attività buone, di gaiezza sana e forte, largitrice di sentimenti nobili, di scatti vigorosi: un alito sonoro, vibrante conferisce alla rigida atmosfera scandinava inattese dolcezze, e alle passioni una intensità travolgente: ma è la molteplicità delle persone, delle passioni, delle visioni che non può stringersi nella rigida cerchia della scena lirica. E poi, il protagonista, prete spretato a causa dell’abuso di bevande alcooliche, instabile, violento, pur presentando innegabile fondo di bontà, di poesia, di eroismo, non è eroe lirico e non può avvincere e commuovere se non a traverso una acuta e continuata analisi psicologica quale può offrirci il libro mercé la riproduzione di episodii e pensieri e atti in cui si manifesta e si definisce l’anima e il cuore di Gösta. Né il successivo suo appassionarsi per una non breve serie di figure femminili, diverse ma ugualmente attraenti nella varietà profonda dell’immagine, del sentimento, del carattere, culminanti nella adorabile contessa Elisabetta, può trovare adeguata rievocazione scenica; sarebbe anzi causa di disagio e turbamento il loro affermarsi, e lo spettatore disorientato e affaticato non sopporterebbe un problema psicologico che il fatale schematismo degli scorci lascerebbe insolubile. Che dire poi dei cavalieri di Ekebù, di quella dozzina di buontemponi, parassiti, impenitenti adoratori di Venere e Bacco, le cui fisionomie appaiono oscillanti e livide a traverso la fiamma azzurrastra del “punch”, creduli come fanciulli, entusiasti, crudeli, viziosi, e poi redenti dalla sacra virtù del lavoro? Schiera tumultuosa, devota e ingrata di apostati, che non esitano a sacrificare quella rude comandante la cui mano buona li sollevò investendoli del cavalierato della sua terra, dando luce e sicurezza alla loro povera vita, turbati e convinti della meschina finzione diabolica di Sintram, mentre dalla morte serena della donna redenta riconquistano la vita propria, animatrice e gioiosa. Sarebbe occorso un miracolo per accogliere nella pratica sintesi dello scenario melodrammatico la fantasmagoria lussureggiante cui l’arte stupenda di Selma Lagerlöf ha conferito così impetuosa ricchezza di vita, in una serie di evocazioni di paesaggi caratteristici nei quali le persone acquistano rilievo nitido e colore brillante e caldo e si muovono e stanno con naturale efficacia. Ho letto il libretto di Arturo Rossato; e, in verità, è da riconoscere che egli ha ingegnosamente risoluto il difficile problema: è certo che ha dovuto rinunziare a moltissimi elementi di grande importanza e interesse; ha limitato la attività erotica di Gösta Berling al solo amore di Anna, la quale, nell’ultima parte, si sostituisce a Elisabetta prendendone il posto e le intenzioni; ha fatto appena ricordare con brevi frasi l’epica scena dell’accanito, terrificante inseguimento dei lupi nella gelida notte dietro la slitta pericolante; ha dovuto sopprimere ogni menzione della inondazione e del crollo della diga; e tante altre scene ed episodi indimenticabili. Invece ha dato inatteso sviluppo alla breve scena del quadro 3.1.6/2 plastico, chiuso col bacio di Gösta, sostituita con una rappresentazione in cui v’è tutta una scena di preparazione e poi un lungo dialogo amoroso con Anna, e quindi la ampia ripresa delle espressioni appassionate di Gösta, dimentico della parte, prorompente in un inno d’amore, interrotto dalle grida di Sintram. Pertanto, da un lato può sembrare sia stato, più che quale base salda, adottato come pretesto ad una azione esotica il romanzo-poema della Lagerlöf con la cernita dei materiali adattabili al tipo di “libretto”, fatti rimanere insieme, saldati abilmente; ma non è stato possibile eliminare l’intonazione alcoolistica, orgiastica, l’acre odore dell’acquavite, mentre le figure, le macchiette originali, delineate con personale caratteristica evidenza, sono andate ammassandosi, trasformandosi in un gruppo corale, con carattere di omogeneità, pure presentando differenze d’abito. 247 Giorgio Barini, “I Cavalieri di Ekebù” di R. Zandonai, «L’Epoca», 31.3.1925 - p. 3, col. 3-45 A ragione si è detto e ripetuto che Arturo Rossato è riuscito a compiere un lavoro che poteva ritenersi impossibile, ricavando uno schema scenico organico da quell’ampio e tumultuoso romanzo di Selma Lagerlöf «La leggenda di Gösta Berling» in cui si agita in una stupenda molteplicità di figure e di visioni tutta l’anima della Svezia d’un tempo, eroica e folle, intessuta di contrasti, poetica e volgare, sentimentale e alcoolizzata: da cui balza fuori vivo e fremente, tutto ombre e luci, generoso e umiliato, Gösta, il «Signore dai diecimila baci e dalle tredicimila lettere d’amore», il prete interdetto che nell’acquavite dorata cerca il sole e la morte e procede, tra i sorrisi e le lacrime delle belle fanciulle, parassita ingenuo, poeta avventuriero; ed al suo fianco la Comandante, tragica figura, ruvida e buona, che vide soffocato il suo sogno d’amore e ne prese aspra vendetta, aspramente scontata: lavoratrice e animatrice di lavoro, chiusa in una corta pelliccia, una pipa di creta fra i denti, un coltellaccio nel corpetto, corti e rigidi i capelli bianchi. Queste due figure giustamente campeggiano nel dramma musicale steso dal Rossato e musicalmente espresso da Riccardo Zandonai: e con i due assume importanza Anna, in cui è sintetizzato l’elemento femminile che a Giosta si volge, dandogli il cuore: le altre figure si uniscono quasi in amalgama corale formando una specie di sfondo plasticamente sentimentale dal quale si staccano Sintram, ciurmatore atteggiantesi a demonio; Cristiano, il capitano dei cavalieri, spavaldo e buono. Costoro si aggirano in un paesaggio nevoso, gelido, dal pallido sole: ed hanno atti e pensieri e tendenze che non rispondono ai nostri sentimenti, e, se pure ci interessano destando la nostra curiosa attenzione, non si accostano al nostro cuore, alla nostra anima. Assistiamo alle loro gioie tumultuose, allo scoramento, alla ribellione, alla redenzione per il lavoro; ma soltanto come a spettacolo caratteristico, senza riuscire ad appassionarci e commuoverci per le loro vicende. Se dobbiamo lodare il Rossato per l’ingegnoso suo lavoro, ancor più è da ammirare Riccardo Zandonai che ha avuto la forza di animare musicalmente e a far vive e colorite le immagini disegnate dal librettista, scaldandole con l’ardore sonoro delle idee melodiche, drappeggiandole nella ricca veste strumentale, avvolgendole in una atmosfera di armonie vibranti e gustose. Nel nuovo spartito il maestro ci appare più semplice nella elaborazione, più spontaneo e limpido nella ideazione, più sobrio e più significativo: e se ancora egli tende a ricavare forza espressiva dal non raro impiego di prorompenti scatti di voce che ascendono nel registro acuto tuttavia egli non vi insiste come nelle opere precedenti: ed ottiene efficacia con l’accento e la flessibilità melodica più che col grido. 3.1.6/3 Il primo atto si inizia con disegni e accenti ritmici e impasti strumentali che dànno sensazione ben riuscita della rigidezza di una nordica notte, e il dolore di Giosta si fonde plasmandosi nel gelido grigiore; lo sghignazzare sguaiato di Sintram, il garrulo cinguettare delle fanciulle che scorrazzano tra le nevi in scarpette da ballo, spargono di riflessi lucenti e arguti l’atmosfera invernale; Anna giunge e passa senza affermarsi, né ci commuove l’episodietto della babbuccia slacciata; mentre nell’incontro con la Comandante, che solleva Giosta dalla neve in cui giace e, narrandogli il dramma della propria vita, solleva anche l’anima e il cuore del giovane, la musica si stacca dalla funzione coloristica fino allora esercitata per assurgere ad espressione vitale e affettuosa: anche il tema ritmico da cui la Comandante è caratterizzata è nella sua brevità plasticamente significativo. Ecco finalmente la breve schiera dei cavalieri, i parassiti redenti della Comandante, spavaldi e gioiosi, che intonano a gran voce la loro canzone: «vecchia terra d’Ekebù»... di carattere popolare, irruente e squillante, rude al pari dei cavalieri, e che chiude l’atto con sonorità festosa e tumultuante. Il secondo atto, nell’ampia sala del Castello di Ekebù, si inizia con un nuovo brillante episodio delle vivaci fanciulle: riappare il disegno e il colore che le accompagnava per via, tra la neve: ed ancora l’irruzione di Sintram, che tombola giù per il camino, forma contrasto con la gaiezza delle giovinette: le quali però ben riescono ad allontanare il padre di Anna che vorrebbe portare via seco per strapparla all’amore di Giosta. Ed ecco ancora i cavalieri, che intonano ancora la canzone «gaia e disperata»: e la investitura di Giosta, con la presentazione dei cavalieri, ben caratterizzati da brevi commenti strumentali: e poi il primo duo fra Giosta ed Anna, i quali, mentre debbono accordarsi a provare la breve azione scenica da svolgersi durante la festa, esprimono il loro amore, che Anna vuol soffocare pel disgusto in lei destato dall’avvilimento in cui ha visto scendere l’uomo amato, mentre egli vuole redimersi: accento commosso, largo respiro melodico scaldano le espressioni di Anna; il sarcasmo spezza lo slancio lirico. Comincia la rappresentazione: l’orchestrina primitiva dei cavalieri, cui sovrastano le fantasiose volute del violino di Liecrona, ha un carattere nettamente grottesco; e Giosta, dopo le prime espressioni preparate per la recita, trascinato dall’impeto del cuore, prorompe in un alato canto d’amore, ardente e sincero, che contrasta nettamente con le rudimentali armonie dei cavalieri: è commosso e commuove, e, tra i commenti dell’uditorio stupìto e ammirato, Anna, affascinata e vinta, si getta fra le braccia del giovane. Riappare, urlante e maledicente, Sintram: questi è cacciato via, ma la Comandante, turbata dalle minaccie di lui, impone a Giosta di ricondurre Anna alla sua casa, di amarla e di rispettarla: Giosta, per mostrare la potenza e la purezza del suo amore, stende nel fuoco la mano; ed Anna lo trae via e stringe e bacia la mano ancor calda, e piange e chiede: «perché?... perché?...». Il secondo duo di Giosta ed Anna ha movenze e accenti tutto ardore; ma non si differenzia dal primo: la declamazione musicale si stringe e svolge in linee melodiche vibranti: Riccardo Zandonai ci offre idee di respiro più ampio di quelle che di consueto si incontrano nei suoi spartiti: e più schietto e spontaneo è il suo linguaggio sonoro. I «perché» di Anna richiamano alla mente i «perché» di Iris... Il primo quadro del terzo atto ci presenta i Cavalieri aggruppati attorno alla caldaia del ponce, coronata di azzurra fiamma, che fiocamente splende nella notte: festeggiano il Natale, e l’ardente bevanda li ha già vinti; Liecrona ha l’ubbriachezza sentimentale: piange pensando ai suoi, e suona il violino: e i Cavalieri pian piano intonano i dolci canti del Natale. Qui lo Zandonai ha trovato gli accenti più intimamente commossi del suo spartito: un senso di poesia anima il cantico sacro e si effonde con sottile dolcezza, e prende i cuori: lievi tocchi di arpa e di celeste illuminano e infiorano la melodiosa ninna-nanna, limpida ed espressiva. Sintram, camuffato da demonio, appare ad un tratto: nelle menti offuscate dall’ubbriachezza getta terrore e risentimento, di cui è vittima la Comandante, la quale si 3.1.6/4 allontana offesa e affranta, lasciando ai Cavalieri le ferriere di Ekebù, ma annunziando che, lei lontana, aridità e carestia invaderanno il paese: e parte, ricordando la materna maledizione. A questo quadro, efficace e significativo, sebbene il falso satanismo di Sintram non ci convinca, ne segue un secondo in cui abbiamo ancora un duo d’amore tra Giosta ed Anna, animato dal calore delle idee melodiche; e poi, dopo la vana preghiera della fanciulla cui non si apre la porta sbarrata della casa paterna, i due giovani hanno una nuova diffusa espansione amorosa, con cui termina l’atto. Non devesi nascondere che certi andamenti melodici, in cui le idee dello Zandonai si rivelano animate da un ardore passionale più vivo e intenso, presentano qualche riflesso di tendenze musicali non nuove: ma egli le esprime con linguaggio suo proprio, e sa loro imprimere potenzialità emotiva con mezzi suoi: non si può negare che i dialoghi d’amore tra Anna e Giosta cominciano a sembrare un po’ troppi. Il quarto atto si inizia con i lamenti e le rampogne del popolo stremato dalla carestia, cagionata dalla incuria, dalla dissipazione dei cavalieri, i quali, partita la Comandante, hanno abbandonato il lavoro immergendosi nelle gozzoviglie: e qui sembra udire sorgere dalle voci della folla e dal substrato strumentale un’eco lontana delle indimenticabili lamentazioni del popolo nel «Boris» del Mussorgski. Ma Giosta giura che la Comandante sarà fatta tornare e sarà ripreso il lavoro e la vita rifiorirà: i Cavalieri giungono e vanno alla ricerca della forte donna, e Cristiano impone a Giosta di rimanere per consolare e sostenere sua moglie: cosicché ne scaturisce un altro duo fra Giosta ed Anna, in cui risorgono le sensazioni che già animarono le precedenti scene d’amore. Ma quando Anna sta per lasciare il marito si odono voci che si avvicinano annunziando il ritorno della Comandante: la forte donna ha ottenuto il perdono materno ed ha voluto rivedere Ekebù per morirvi, dopo aver reso la vita alla vecchia sua terra, alle ferriere; eccola: essa lega in eterno i cuori di Anna e di Giosta; e, salutata dal fragore delle incudini e del maglio enorme, che significa la resurrezione del lavoro e della vita, muore serenamente, mentre la canzone dei Cavalieri prorompe con magnifica sonorità. Il maglio cade ancora, nel silenzio, in onore della Comandante spenta: e il velario si chiude rapidamente. *** Il nuovo spartito è nel complesso degno fratello delle precedenti opere di Riccardo Zandonai: vi si conferma la straordinaria abilità tecnica del maestro, la sicura padronanza di ogni risorsa tendente alla migliore estrinsecazione scenica; e in pari tempo vi si rivela una tendenza ad una più larga vena melodica, che, se pur non sempre originalissima nel fondo, si atteggia però con notevole senso personale nella elaborazione: e se il temperamento del musicista lo induce ad insistere in espressioni che tendono al conseguimento di effetti immediati più che alla rivelazione dell’intima essenza di sentimenti indagati con profondità di analisi, la sincerità del discorso musicale dimostra come egli intenda conseguire una purificazione ed elevazione dell’arte sua, che gli fa onore. *** La esecuzione che hanno avuto al Costanzi «I Cavalieri di Ekebù» è degna della massima lode: ed anche per questo spartito il primo nome da farsi è quello di Edoardo Vitale, che lo ha concertato e interpretato con vero amore ed alta intelligenza, riuscendo a dare una ammirabile sensazione di unità ad un lavoro così vario, spezzato e diffuso, pur curando con acutezza e diligenza eccezionali ogni minimo particolare. Francesco Merli ha impersonato il difficile personaggio di “Giosta” con molta arte, facendo ammirare la bellezza dei suoi mezzi vocali adoperati con sicura abilità; Maddalena Bugg è stata una eccellente “Anna”: è questa una parte che si adatta più di ogni altra alla sua voce, al suo temperamento; Sara Sadun ha eseguito con grande impegno la parte difficoltosa della “Comandante”; ottimo “Cristiano” è riuscito Taurino Parvis, per voce robusta e intelligente interpretazione; lodevoli Alga [sic] De Franco, Teofilo Dentale, Vittorio Julio; le ben riuscite schiere dei Cavalieri, tra cui il Nardi, il Pellegrini [sic], De Petris, Uxa; e delle fanciulle, tra cui la Tesorieri, la Lauri, la Benincori, la 3.1.6/5 Caputo. Ottima l’orchestra, e sopra tutto eccellente Oscar Zuccarini, violino solista; assai efficace e sicuro il coro istruito dal maestro Consoli: lodevoli gli scenari e gli abbigliamenti. La cronaca della serata porta: al primo atto un applauso al Merli e scena aperta, e sette chiamate alla fine di cui cinque allo Zandonai ed al Rossato; al secondo atto applausi a scena aperta alla Bugg e sei alla fine di cui cinque agli autori; al terzo, nei due quadri, nove chiamate delle quali sei allo Zandonai; al quarto otto chiamate di cui quattro all’autore: cogli esecutori sono apparsi il maestro Vitale, festeggiatissimo, ed anche i maestri Consoli e Ricci. 248 Guido Sommi, La prima dei “Cavalieri di Ekebù”, «L’Impero», 29.3.1925 - p. 3, col. 1-2-3-4 La sala del Costanzi era invasa ier sera da quel senso di febbrile attesa che precede sempre la prima di un’opera nuova, specie quando essa è l’ultima creazione di un musicista quale Zandonai, che ha dato già alla scena lirica italiana melodrammi riusciti in un certo senso, pieni di musicalità e di genio, tecnicamente costruiti con sapiente e sicurissima mano. Teatro vibrante dunque, elegantissimo, contenente quanto di intellettuale, di mondano, di politico e di artistico offre Roma capitale, fervida amica di tutte le manifestazioni artistiche italiane. Quando Edoardo Vitale giunge sul podio e la sala si spegne, il Costanzi si fa silenzioso [ed] attento, pronto ad ascoltare, a giudicare e a applaudire. E i Cavalieri di Ekebù hanno inizio. Il libretto Il libretto della nuovissima opera è tratto, come ormai già tutti sanno, dal poema di una scrittrice nordica Selma Logerlöf [sic]: La leggenda di Gosta [sic] Berling ed è stato sceneggiato con non poca fatica da Arturo Rossato, che da un romanzo poetico, pieno di personaggi e di simboli e di episodii infiniti e diversi fra loro ha saputo ricostruire un melodramma interessante, abbastanza conciso, non statico e non oscuro. E l’impresa non era certo facile. Siamo all’inizio del primo atto in un’osteria di Ekebù. L’inverno colora di bianco le strade, gli alberi, le montagne lontane; la neve soffoca i rumori, avviluppa del suo freddo manto le anime accese dei personaggi semifantastici. Giosta Berling, giovane prete sconsacrato perché sempre ubriaco, erra di bettola in bettola. Anima di poeta, egli è oppresso dalla sua stessa vita viziosa e sconclusionata. Deciso a troncare la misera sua esistenza, giunge all’osteria ove spenderà le ultime sue risorse per annegare la vita nel vino e nella morte. Ed ecco arrivare Sintram, personaggio strano, mefistofelico, miscuglio di varii tipi che si riscontrano spesso nei racconti nordici, che offre a Giosta del denaro onde questi si abbrutisca sempre più, si danni e si ammazzi, lasciando Anna, la sua bionda figliola, di cui è innamorato, libera a contrarre nozze cospicue e grandiose. Giosta, ubriaco, accetta e beve, finché cade bestialmente nella neve, vinto dalla sbornia e dal sonno. Giungono allora al castello alcune ragazze fra cui Anna che, vedendo Giosta, che pur ama, ridotto in uno stato umiliante, lo ritiene ormai completamente perduto e si lascia trascinar via dalle compagne, ignare del suo amore. Invece la Comandante di Ekebù, donna vecchia energica e generosa, decide di salvarlo e lo raccoglierà come altri miserabili ella ha raccolto, nel naufragio della vita. Giosta le racconta la sua triste storia e la Comandante rievocandogli la memoria di Anna, che egli potrà vedere la notte istessa al castello, lo persuade a vivere. Giungono allora tutti i cavalieri (gaia brigata di dodici spensierati lavoratori, rotti ad ogni fatica e ad ogni temerarietà agli ordini della 3.1.6/6 Comandante); ad essi la vecchia presenta Giosta. Essi lo salutano con il loro grido di esultanza. E Giosta diventa dei loro. Il second’atto si svolge nella gran sala del Castello di Ekebù, dove si prepara la recita di una commedia. Anna sta abbigliandosi per la rappresentazione, quando sopraggiunge Sintram che vuole portar via la fanciulla per non lasciarla alla mercé di Giosta. Ma il vecchio è cacciato via dalle fanciulle, che dopo d’aver aiutato Anna a vestirsi aprono le porte alla folla per la rappresentazione. Entra Giosta, che deve giurare fedeltà allo strano statuto dei Cavalieri e che dal capo di essi è consacrato dapprima, poi designato a recitare con Anna. La commedia ha il suo inizio. Giosta, infervorandosi poco a poco in un vero dialogo d’amore, dimentica che la sua è una finzione teatrale e le dice le cose più dolci che il suo cuore gli detta. Anna gli risponde e, dinanzi alla folla stupita e ammirata, la scena amorosa ha termine in un lungo ed infuocato bacio dei due innamorati. A questo punto balza d’improvviso Sintram, che giura vendetta ai Cavalieri tutti e alla loro Comandante che ha fatto sì che Giosta ed Anna potessero liberamente amarsi. La Comandante, colpita da un tristo presagio, impone allora a Giosta di ricondurre quella notte stessa Anna alla casa del padre. E tutti piegano il capo al volere della vecchia padrona. Il terz’atto è diviso in due quadri: nel primo vediamo la fucina dei cavalieri di Ekebù, che fanno baldoria per celebrare la notte di Natale. Cantano e bevono. Improvvisamente appare Sintram camuffato da diavolo, che tale è creduto dagli avvinazzati cavalieri. Sintram allora, giocando d’astuzia, riesce a istigarli contro la Comandante dicendo loro che questa vende a Belzebù ogni anno una delle loro anime per conservare le ricchezze donatele in gioventù da un amante. I cavalieri esplodono in una rivolta minacciosa quando ecco che entra la stessa Comandante cui Cristiano (uno dei cavalieri) getta in viso, alla presenza del marito di costei, l’accusa svelata da Sintram. La vecchia è vinta, il marito la scaccia ed ella si allontana altera, lasciando le miniere ed il castello ma predicendo sventura agli ingrati suoi cavalieri. Nel secondo quadro assistiamo al ritorno di Anna, ricondotta da Giosta, alla casa del padre. Ma la povera ragazza invano batte alla porta sprangata da Sintram, che la scaccia e l’abbandona sulla neve. Giosta allora la raccoglie e la conduce con sé. L’ultimo quadro si svolge dinnanzi alle deserte fucine di Ekebù. I cavalieri senza più la guida della Comandante hanno mandato tutto in rovina. La carestia regna. Si auspica al ritorno della Comandante, che infatti ritorna, ma sorretta dalla folla che l’ha trovata morente nella neve. Essa con delle parole di bontà e di pace perdona a tutti e chiama Giosta e Anna a sé. Li benedice, li esorta ad amarsi e per sempre. Poi impartisce ordini per la ripresa del lavoro nelle fucine. La sua voce fa il miracolo. La vita ritorna, i fuochi si riaccendono ed al ritorno del maglio e dei martelli essa muore felice, mentre la folla canta e benedice. E l’opera ha fine. La musica Non è possibile di parlare della musica della nuovissima opera di Zandonai in maniera generale, ché il carattere del lavoro è assolutamente di frammentarietà: frammentarietà data in gran parte dal libretto folto di episodi, di stati d’animo, di piccoli ma pur importanti dettagli dietro cui il musicista ha dovuto accodarsi ed adattarsi con una sottigliezza da equilibrista provetto. Bisogna perciò, per rendersi conto della musica dei Cavalieri di Ekebù, analizzarla via via abbandonando un episodio ritmico coloristico per seguire immediatamente un brano lirico, o prestare attenzione ad una frase ironica o ad un accenno eroico che d’improvviso si presenta a chi l’ascolta. Lo Zandonai in questa sua ultimissima opera si è trovato forse dinnanzi a questa difficoltà non lieve di saltare di continuo da un argomento ad un altro e la fusione dell’opera d’arte ne ha certo sofferto nel suo insieme, difficilmente costringibile entro una quadratura definita che le desse un assetto ben geometricamente esatto. 3.1.6/7 Gli slanci lirici sono sparsi in tutti e quattro gli atti di questa poderosa opera ma non hanno modo di nascere da una emozione sottile che si ingrandisca a mano a mano per giungere ad un apogeo di sentimento, generando uno stato d’animo ascendente e dilagante. E questo è forse il difetto principale di questi Cavalieri cui manca una linea interna che ne sia uno scheletro robusto. Intorno dunque a questo colosso senza una visibile ossatura interna, l’autore di Francesca ha lavorato di cesello e di bulino con, innegabilmente, molto talento. L’episodio di Sintram al primo atto sottolineato da un sottile e stridulo movimento ritmico che interrompe la grigia monotonia dell’inizio dell’opera è di un effetto originale, brillantemente messo in valore sia dal punto di vista del colore esterno che del contenuto psicologico; l’entrata della Comandante e la scena che ne segue (il racconto di Giosta di marca assai palesemente italiana stile melodramma), il coro delle ragazze fresco [e] leggermente russeggiante, la Canzone dei cavalieri, indovinatissimo brano sonoro di una bacchica e voluta pesantezza che chiude l’atto, sono elementi riusciti dal punto di vista teatrale e pittorico ed hanno in sé delle qualità di effetto assai rimarchevoli. Nel secondo atto il mosaico diventa ancor più fantastico e gli episodii e i sottoepisodii (li chiamerò così perché sono parte degli episodii medesimi) si rincorrono con una frenesia che abbaglia ma anche disturba la serenità di chi ascolta. La scena del teatro è forse musicalmente la parte più riuscita dell’opera, dove Zandonai si è lasciato andare a cantare assai liberamente senza freno e senza scrupoli. Questa scena cantata da Anna e da Giosta, con un accompagnamento di striduli ottoni e di soffocati legni, appena caricaturale, cui fa da contrasto un a solo cantabile di violino, è di un effetto veramente originale, divertente e poetico, né le nuoce l’entrata di Sintram che l’interrompe e il finale dell’atto in cui il sentimentalismo torna a far capolino leggermente più stanco. Buono d’effetto il coro dei cavalieri della prima parte del terz’atto, adagiantesi tristemente sulle modulazioni di un violino e sulle scalette della celeste; rumorosa e un po’ convenzionale la scena di Belzebù impersonato da Sintram; superficiale invece e non vivificata affatto dall’emozione del musicista quella seguente della Comandante e relativa rivolta dei cavalieri avvinazzati ma improvvisamente divenuti, per grazia di Dio, moralisti, puritani e forse in realtà solamente comunisti, al miraggio della proprietà delle miniere e dei beni della Comandante. La notte nevosa del principio del secondo quadro ha in sé elementi di bella poesia grigia e nordica, e la breve scena di Sintram e della madre è di una robusta drammaticità. Poi subentra l’elemento amoroso e sentimentale, ma questa volta non desiderato e non sentito profondamente, sicché la romanza sulla porta cantata da Anna è di una pericolosa debolezza. Arriviamo così al quart’atto che musicalmente è forse il meno interessante, per quanto però indubbiamente il più quadrato. L’invocazione di pace di Giosta è nondimeno di una bella enfasi, il coro dei cavalieri si inquadra con molta sottigliezza nel clima dell’atto e l’entrata della Comandante è di una certa efficacia. Ma quello che rialza però le sorti dell’ultimo atto, fatalmente monotono perché statico e non ricco d’azione, è il coro finale imperniato sulla canzone dei Cavalieri e validamente corroborato dallo scatenamento di tutti i martelli e del grande maglio delle fucine di Ekebù che rinforzano con i loro ritmi la pesante e lucente sonorità della pagina musicale più significativa del nuovissimo spartito. L’insieme dell’opera è dunque ricco di pregi, curato come sempre nello strumentale, arricchito di cori ben condotti; i personaggi sono scolpiti con tratti sicuri (ad eccezion fatta di quello della Comandante), ben individuati fra loro, drammaticamente e teatralmente riusciti, vivi di una vita loro, vita convenzionale del teatro melodrammatico, ma non confondibili però con quella delle tante larve che popolano oggi giorno stesso i palcoscenici della nostra lirica. 3.1.6/8 E i Cavalieri di Ekebù, se non sono un passo avanti nell’arte di Riccardo Zandonai, rappresentano però certamente un nobilissimo lavoro che può degnamente stare al confronto dei suoi fortunati predecessori. Il grande successo La tarda ora alla quale è finito lo spettacolo ci impedisce di parlare come vorremmo dell’ottima esecuzione dell’opera nuovissima di Zandonai, che ci ripromettiamo però di analizzare dopo la seconda rappresentazione. Diremo solo che Edoardo Vitale, alle prese con la lunga e complessa partitura, si è dimostrato ancor una volta l’animatore infaticabile dello spettacolo. A lui fecero degna corona il Merli nelle vesti di Giosta, il Parvis ottimo Cristiano, la Bugg, il Dentale e la Sadun. Buone tutte le parti minori, pur così importanti, disciplinati i cori, riuscite le scene, alcune delle quali veramente belle. Il successo si delineò fin dal principio magnifico. Applausi a scena aperta e alla fine di ogni atto agli esecutori e all’autore, in numero tale che ci è impossibile di ricordarlo con precisione. S.A.R. il Principe Ereditario, che aspettava allo spettacolo, volle dopo il second’atto congratularsi personalmente con Riccardo Zandonai chiamandolo in palco ed esprimendogli la sua ammirazione per la riuscita di questi nuovissimi Cavalieri, che dovrebbero ora cominciare a girare il mondo. Il successo di Roma è certo un buon auspicio. 249 F[rancesco] P[aolo] Mulè, Il successo de “I Cavalieri di Ekebù” al Costanzi, «Il Risorgimento», 29.3.1925 - p. 5, col. 3-4-5-6-7 (con la riproduzione di tre battute dell’inno dei Cavalieri e firma autografa di Zandonai con la data «Roma, 27 marzo 1925») La sala del teatro è gremita in ogni ordine di posti; in mezzo al pubblico sono molte fra le più note personalità dell’arte e della cultura romana; in tutti un’ansia di potere ascoltare la nuova opera di Riccardo Zandonai: meritato omaggio al giovane e infaticabile maestro, sul quale si fondano tante legittime speranze pel domani del nostro teatro lirico. Seguendo la rappresentazione Il primo atto Dalle prime battute comincia a farsi palese la chiara semplicità della partitura. Le frasi di Giosta, spontanee, istintive, rivelano il travaglio del giovane, il quale, sconsacrato da prete, vuol morire e affoga il suo dolore nell’acquavite. Semplicità di declamato e un’armonizzazione anch’essa semplice, che lo sottolinea con una proprietà che si conserva e anzi si compie nella sobria colorazione che riceve dall’orchestra. Sarà questo, salvo in qualche momento di maggiore espansione – in cui si avvertono delle esuberanze vocali e strumentali – il carattere fondamentale dell’opera. All’entrata di Sintram il sapore della musica cambia. Lo strano, il fantastico, il malefico dell’astutissimo uomo che si vuol far credere – e vi riesce – il demonio, s’insinuano nella tavolozza del desto musicista, che alla singolare figura dà delle frasi ambigue, con acri armonie e non so che fosco nell’orchestra. E semplicità, sempre. La quale ora acquista non so che candida dolcezza al sopraggiungere delle fanciulle, giù dal sentiero. È il noto, felice pennelleggiare col quale Riccardo Zandonai compone, a volta a volta, le sue atmosfere sonore. Il coro, nelle opere del maestro trentino, oltre che esprimere il prorompere d’un sentimento collettivo, ha anche un felice ufficio 3.1.6/9 coloristico e riesce di notevole efficacia teatrale. Dopo l’accorato linguaggio di Giosta e quello sinistramente cupo di Sintram, le garrule voci femminili punteggiano l’aria come uno sciame di farfalle bianche. Giosta è steso sulla neve, ebbro. Nel suo torpore ripete il nome di Anna la quale, venuta con le altre fanciulle, gli si avvicina un istante, ma le compagne la trascinano con loro verso il castello di Ekebù, dove si farà festa. E giunge la salvatrice, la Comandante, padrona del castello e delle officine. È con Samzelius, suo marito, un essere debole e vuoto, una larva d’uomo. Appena la Comandante scorge Giosta, si propone di salvarlo. Si fa precedere dal marito al castello e si dà a confortare il giovane. Siamo a una delle pagine più penetranti e più significative dello spartito. Pagina musicale suggestivamente umana. La Comandante ne balza con un carattere di tutto rilievo. Lo scorcio drammatico, nel quale è contenuta la storia del suo passato e del suo peccato d’amore, nella musica acquista una maggiore ampiezza. Riccardo Zandonai qui è andato a fondo. Ha trovato l’anima della Comandante e l’ha convertita con sincerità schiettissima in un linguaggio musicale che ne ha tutto il calore e il dolore. La commozione della musica si propaga negli spettatori. È tanta l’umanità di questa figura che al suo contatto Giosta ritrova se stesso, nel suo intimo, e il suo riaffacciarsi alla vita è espresso con un discorso melodico che nelle sue snodature, nelle sue inflessioni, nelle sue cadenze ne reca l’accoramento profondo e insieme una trepida ma non confessata speranza. Riccardo Zandonai ritorna con le sue virtù più insigni e con le voci più sue. Il consenso del pubblico è intero. Ed esso si mantiene sino alla fine dell’atto. Si fa anzi più caloroso, ché siamo alla canzone dei cavalieri di Ekebù, vibrata e spavalda in un imperioso ritmo di sanità popolaresca. Per intenderci: quando dico popolo dico la più genuina ed alta sorgiva di canti, alla quale vorrei si dissetassero tanti stitici e sudati accozzatori di soporifere esercitazioni cerebralistiche per apprendere che cosa è essenzialmente la musica. Il secondo atto Siamo in una sala del castello di Ekebù. Le fanciulle abbigliano Anna per una rappresentazione scenica. Il loro cicaleccio è un continuo rizampillare di frasi melodiche. Melodia, dico. Come quella del buon tempo antico, ma di Zandonai. Il pubblico ne piglia un sensibile diletto. Un rumore strano, nel camino. È Sintram. Sa che sua figlia s’incontrerà con Giosta, salvato dalla Comandante, e la vuole trascinare via. Frasi dure, crucciate, cui l’orchestra sottolinea cupamente. Ma i cavalieri di Ekebù stanno per giungere, annunziati dalla loro canzone. Le fanciulle spingono Sintram fuori della sala, nella quale irrompono i cavalieri seguiti dalla folla. La loro canzone scoppia squillante e festosa. Si ha l’impressione di uno di quei “concertati” all’antica, che mandavano gli spettatori in visibilio. Il pubblico è incatenato. Ed ecco un nuovo aspetto dell’opera, che è merito di Arturo Rossato aver reso dinamica e varia. I cavalieri di Ekebù consacrano Giosta loro compagno. Chi sono essi? Dei vagabondi salvati dalla Comandante. Situazione grottesca. E grottesca si fa la musica. Un grottesco, però, ottenuto con mezzi semplicissimi. Nessun tuffo nella tavolozza dei modernissimi. Zandonai insiste nella sua chiarezza. Canta. Con intenzioni comiche e burlesche, ma canta. Periodi melodici, sempre. Il grottesco vien su dall’orchestra, con certi suoi accordi volutamente bislacchi, con certi suoi suoni volutamente striduli e sconcertanti. Una preparazione al sapore musicale che avrà la rappresentazione. Ma assistiamo prima all’incontro di Giosta con Anna. Ritorna l’autentico Zandonai, quello delle migliori pagine della Conchita, quello della Francesca da Rimini. Un fraseggiatore ampio, con un fondo quasi costante di malinconia. Nell’esprimere l’amore Riccardo Zandonai è quasi sempre così, ed è lui. Non importa che qua e là si ravvisino modi mascagnani, veementi, impetuosi. Esteriorità. L’anima del canto è diversa. In quest’ebbrezza c’è sempre 3.1.6/10 non so che dolore. Zandonai in fondo è un musicista elegiaco. Il dialogo d’amore scorre fluido e vivo. Ma è interrotto. È l’ora della rappresentazione. Siamo, secondo me, ad una delle pagine più singolari non soltanto di quest’opera ma di tutta la produzione di Zandonai. Sul piccolo palcoscenico preparato nella sala la scena è cantata da Giosta e da Anna, ma l’orchestra è formata dai cavalieri di Ekebù. Sulla scena l’amore; in orchestra il grottesco. Ecco la difficoltà che a se stesso ha posto il compositore e, a mio giudizio, egli l’ha superata felicemente. Era tutt’altro che agevole dare ai due amanti un linguaggio appassionatamente melodico, d’un delicato sapore settecentesco, e fonderlo con le petulanti dissonanze di cui lo condiscono implacabilmente i giocondi cavalieri. Ma la difficoltà è stata, ripeto, superata, e la perfetta fusione appunto di due così diversi elementi – l’uno serio e sognante, l’altro brutalmente realistico – va messa all’attivo del maestro. Il terzo atto Nella prima parte Sintram, volendo vendicarsi della Comandante, penetra nella fucina del castello dove sono radunati, celebrando il Natale, i cavalieri di Ekebù. Il musicista, naturalmente, gli ha dato degli accenti da Mefistofele, un Mefistofele però di mediocrissima statura borghese, quale in realtà è Sintram. Comunque, i cavalieri, a quel suo sogghignante schiamazzare, lo credono il diavolo e si ribellano alla Comandante, giudicandola la causa d’ogni loro male. Il declamato musicale, nei sobrii chiaroscuri dell’orchestra, si incupisce. Le frasi fiere ed accorate della Comandante diffondono un profondo senso di tristezza. Ma di questa prima parte dell’atto ciò che musicalmente più mi piace è l’episodio nel quale i cavalieri celebrano il Natale. Una celebrazione materiata di non so che accoramento nostalgico. Uno dei cavalieri fraseggia patetico sul violino e gli altri cantano a coro una ninna-nanna, ricordo dell’infanzia e delle loro case lontane. Un gioiello di musica squisita, della nostra più bella tradizione e che va diretta alle anime. Come, nella seconda parte dell’atto, commuove per la viva e incisiva umanità dei suoi accenti l’invocazione di Anna dietro la porta della sua casa, alla quale Giosta, obbedendo alla Comandante, l’ha ricondotta nella notte stellata e gelida. Quest’invocazione è sgorgata di getto dalla sensibilità musicale di Riccardo Zandonai. Anche le altre scene, del resto, sono pervase d’un lirismo che sale dall’intimo e che nel suo calore pare fonda per sempre le anime di Giosta e di Anna, che, in odio al padre, si avvia con l’amante verso l’ignoto. L’orchestra corona l’atto con un “pianissimo” penetrante come la gioia muta d’una carezza. Il quarto atto Dal giorno in cui la Comandante s’è allontanata, attorno al castello di Ekebù sono piombate miseria e carestia. Le prime scene descrivono musicalmente l’angoscia del popolo. L’effetto è raggiunto, perché frasi e periodi musicali si snodano veramente con inflessioni di dolore. Ma io – me lo perdoni l’amico Zandonai – avrei preferito una maggiore contenutezza e una più profonda intimità di accento. Più che la tragica desolazione d’un popolo che non ha di che sfamarsi qui c’è una sua violenta e fragorosa rivolta contro i cavalieri. Comunque l’effetto è raggiunto e in certo senso teatrale Zandonai ha forse ragione. Efficacemente reso, nella travagliosa sobrietà dell’espressione musicale, il nuovo stato d’animo di Anna, che si crede l’origine prima della pubblica sciagura e vuole troncare, pure amandolo, i suoi rapporti con Giosta, che cerca dissuaderla con un declamato drammatico pieno ora di dolcezza ora di ardore. Ed eccoci ad una delle scene capitali dell’opera. Torna la Comandante, portata a braccia, moribonda. Ancora una volta, da lei si sprigiona un vivo senso d’umanità che investe tutti gli altri. Pure trattata di scorcio, la Comandante assurge con una ben definita fisionomia nella vita dei suoni, e sta tra le figure più recisamente caratterizzate di Riccardo Zandonai. Con la Comandante torna il lavoro. Le fucine si rianimano. La speranza rinasce in tutti. Il maglio batte sull’incudine. La passata miseria è 3.1.6/11 vinta dall’esultanza nuova. Un fremito possente passa nell’orchestra e si propaga sulla scena. Canti di gioia. I cavalieri intonano la canzone spavalda. La folla si unisce a loro. Orchestra e scena diventano un solo vulcano sonoro. È il trionfo dell’operosità umana. Una scena di carattere impressionistico, nel quale puoi distinguere l’intensa macchia generale, non la pennellata. Tanta la sonorità, che il ritmo, pure essendo così gagliardamente scolpito, si distingue appena. L’effetto teatrale è completo. Opera italiana Allorché il maestro Vitale occupa il suo posto, si fa silenzio religioso. Quale valore ha quest’ultima opera nella produzione di Riccardo Zandonai? Quali sono i suoi caratteri? C’è un progresso sulle opere precedenti? Risponderò a queste domande molto brevemente. Sulla Giulietta e Romeo la nuova opera segna un progresso. Progresso specialmente di chiarificazione. La tendenza alla semplicità, attuata nella Giulietta con melodie limpide e belle ma contrastanti con altri aspetti dell’opera che perciò ne usciva un po’ squilibrata, qui domina in tutto lo spartito, che vuole essere da cima in fondo un’affermazione d’italianità. Né il meccanismo di Wagner, né Strauss, né Debussy, né l’elegante cerebralità degli ultimi francesi. Nessuna astruseria, dunque, né armonistica né orchestrale. La melodia parla, l’armonia ombreggia e illumina, l’orchestra contribuisce alla più intensa espressione di questa e di quella con la sua colorazione varia e propria. I momenti d’enfasi sono compensati dalla squisitezza di moltissime pagine. Il compositore ha avuto cura di creare al dramma una ben determinata atmosfera sonora, e in ciò è riuscito stupendamente. Circa i caratteri dei personaggi, ne ho già detto qualche cosa seguendo il corso della rappresentazione. Sono nettamente individuati la Comandante, Sindram [sic] e complessivamente il gruppo dei cavalieri. Giosta ed Anna fanno quasi unica persona, confusi e fusi nel sentimento del reciproco amore. Aggiungerò che con quest’opera, come già con la Francesca da Rimini, Riccardo Zandonai si afferma uomo di teatro dall’istinto sicuro. Il successo Ecco la cronaca... numerica della serata. Primo atto: un applauso a scena aperta (tenore Merli) e alla fine sette chiamate, delle quali cinque all’autore e al poeta Rossato. Secondo atto: due applausi a scena aperta (uno alla signora Bugg) e sei chiamate alla fine, delle quali cinque all’autore col poeta. Terzo atto: complessivamente nove chiamate, delle quali sei all’autore. Quarto atto: otto chiamate, delle quali quattro all’autore. L’esecuzione Dirò in primo luogo che la presenza di Riccardo Zandonai e di Carlo Clausetti – specialmente di quest’ultimo, che ha avuto occhio per tutto – è stata molto utile. Si deve in gran parte a loro se l’opera ha avuto un’esecuzione che nel suo complesso non lascia troppo a desiderare. Per fortuna il tenore Merli (Giosta) si è prodigato in tutti e quattro gli atti con la sua bella voce e ha distratto dalle altrui deficienze. Anche la signora Brugg [sic] (Anna) ha sostenuto una valida fatica canora, uscendone con onore. La signora Matilde Sudan [sic] (la Comandante) ha mostrato di possedere nel registro grave una ben timbrata voce. 3.1.6/12 Il Dentale (Sintram) e il Parvis (Cristiano) non mancarono di efficacia. Ammiratissimo il primo violino prof. Zuccarini in due difficili a solo. I cori, istruiti dal valoroso maestro Consoli, molto intonati. Il maestro Vitale ha concertato e diretto l’opera con vivo amore, raggiungendo, specialmente al secondo atto, notevoli effetti. Ci consentirà il valente maestro un’osservazione: vorremmo che i passi nei quali la partitura è in se stessa un po’ enfatica non fossero, per giunta, esagerati dall’orchestra. Sono effetti di gusto discutibile e che danno fastidio agli ascoltatori. 250 Roberto Forges Davanzati, “I Cavalieri di Ekebù” di Zandonai, «L’Idea nazionale», 31.3.1925 - p. 3, col. 1-2-3 I Cavalieri di Ekebù sono stati applauditi, sabato sera al Costanzi, da un pubblico folto che gremiva la sala. La cronaca notarile ed onesta segna un applauso al racconto di Giosta, cantato con dovizia e dolcezza dal tenore Merli, magnifico interprete; sette chiamate alla fine del primo atto, chiuso dalla canzone fragorosa e ritmata dei Cavalieri, che il pubblico accoglie con gran favore come una promessa di carattere, di robustezza, di vastità corale dell’opera. L’esecuzione, sotto la guida animosa del maestro Vitale, si manifesta sicura, colorita, fusa. La Bugg offre la sua grazia bionda e la sua voce nitida ad Anna. la Sadun è la Comandante: manda talvolta il tra[ ] fra le note basse, ricche di sono[rità] e le note medie e alte un po’ esili, [ ] l’accento è vivo e chiaro e il personaggio è incisivamente segnato. Parvis [ ] perfetto capitano dei cavalieri: di[zi]one pura, canto ampio e timbrato, a[zione] spigliatissima e dominatrice. Al secondo atto le chiamate sono sei. Il corale ripete la promessa buona del finale del primo, ma non aggiunge novità caratteristiche. L’amore di Giosta e di Anna si abbandona a grandi pienezze canore; ma la fine dell’atto sull’apparizione di Sintram non ha efficacia. Il basso Dentale fa quanto è possibile, con intelligenza di attore, per animare di mistero sinistro questo personaggio, ma Sintram, che dovrebbe essere il deus ex machina della vicenda drammatica, vi resta estraneo. Il primo quadro del terzo atto, la rivolta dei Cavalieri alla Comandante, è gustato musicalmente ma disorienta il pubblico, che si sente allontanato da avvenimenti scenici poco chiari e niente affatto interessanti. Gli applausi hanno lacune di incertezza. Il secondo quadro: paesaggio di cave, cielo stellato, ululato di vento, appello disperato di Anna, canto d’amore di Giosta e Anna, ha un suo fascino decorativo, ma gli manca una vera, toccante emozione. Gli applausi vincono tuttavia qualche fugace resistenza e si ripetono unanimi. Sono nove chiamate per i due quadri. Al quarto atto il corale domina e si dimostra la parte più robusta dell’opera. L’amore di Giosta e Anna è, in quest’atto, una ripetizione canora e pleonastica. La morte della Comandante ha finezze di particolari, ma non può toccare l’animo degli ascoltatori. L’atto dà una conclusione all’opera col ritorno al lavoro che rinnova in una espressione più vasta e sonora e di alto sentimento la canzone dei cavalieri. le chiamate – anche questa è una brutta parola del gergo – sono quattro, dominate dalla fretta dell’[uscita] ma il finale è piaciuto. L’esecuzione non ha mai velato l’opera del maestro trentino e del suo collaboratore Rossato; anzi l’ha offerta al [pubblico] con chiarezza, con fluidità, con [ ], per merito maggiore del maestro Vitale. I Cavalieri, bravi cantanti [che] il Costanzi ha saputo accogliere e [man]tenere in questi anni per le parti minori; le Fanciulle amiche di Anna, [i] cori, addestrati dal maestro Consoli, hanno gareggiato con i personaggi maggiori. In tutti slancio, passione canora, [ ]plicità di azione scenica. Il giudizio del pubblico ha potuto essere però schietto, diretto, cordiale. E l’opera ha avuto il suo gran battesimo di applausi. 3.1.6/13 Questa cronaca lieta riconosce allo Zandonai virtù teatrali, melodrammatiche, e lo riaccoglie in quella cordialità tra pubblico e autore che egli sembra essersi conquistata largamente fra i musicisti della generazione post-pucciniana; non può tuttavia comprendere un giudizio sicuro sulla vitalità dell’opera; tanto meno un riconoscimento aperto, clamoroso, soddisfatto di quel desiderio di tempo nostro, di musica nostra, contemporanea, che è nel tormento irrequieto dei nostri pubblici, disorientati dalle esperienze e dai tentativi riflessi, culturali, intellettualistici, e assetati di fantasia e di ispirazione. Il maestro Zandonai ha il gran merito, specie in paragone di molti suoi detrattori, di tener fede al melodramma e di non mascherare la sua ansia di raggiungere l’anima degli ascoltatori con deviazioni di tecnica decorativa, preziosa, estranea; con teoremi artistici privi di capacità realizzatrici. Ma il suo merito non può annullare il vago, il fluttuante, il retorico di questo melodismo contemporaneo, dal quale non sappiamo più uscire, e che è l’atmosfera falsa non soltanto del nostro melodramma, sottolineato di ironie e di disprezzi da tanti novatori, ma anche del modernismo sinfonico e vocale di uno Schönberg. Se mai, Zandonai che cerca contrasti drammatici, espansioni liriche, personaggi definiti, quadrature episodiche, confessa sinceramente, nella sua struttura strumentale e vocale, quanto sia difficile affettare questa nebbia musicale e farne linguaggio canoro e sinfonico. I Cavalieri di Ekebù non si perdono nel lirismo esasperato di Giulietta e Romeo, poiché l’amore di Giosta e Anna non è parte assolutamente dominante della nuova opera; ma questo amore anch’esso, nei tre atti che lo comprendono, è immobile, superficiale, sperduto in una versificazione vacuamente imaginifica e in una musicalità diffusa, eccessiva, declamatoria, senza schiette definizioni melodiche, nemmeno di quella modestia che è stata delle ultime creazioni pucciniane; e soprattutto senza una vera umanità commossa. I personaggi appena si avvicinano perdono carattere, vaniscono in un linguaggio astratto, canoro, in cui l’affanno dell’espressione è al posto dell’espressione. I tre duetti di Giosta e Anna sono uguali, senza ascesa, senza varietà di accenti. I personaggi, anche per colpa della vicenda, sono immobili e ripetono, al principio come alla fine, una tristezza di nostalgia mortale. L’inesistente e quindi incomprensibile commedia recitata dai due innamorati al secondo atto prima di perdersi nell’esaltazione amorosa, ha alcuni fugaci accenti di dialogo melodicamente definito, seppure non originale, e sono accenti che riposano, che si desidererebbe fossero continuati. La Comandante avrebbe potuto essere dominante, di lineamenti incisivi e originali; ma qualche robusta sottolineatura orchestrale e il canto della morte non possono correggere l’estraneità di questo tipo bizzarro di donna che ha peccato e ha redento ma che non è mai in atto sulla scena, non domina mai la vicenda ma la attraversa senza prospettiva, senza nemmeno improvvise luci di cosiddette situazioni. Come, perché la Comandante racconti, nel primo atto, a Giosta ubbriaco il segreto della sua vita; perché il Capitano dei Cavalieri, che sono o almeno appaiono una compagnia di scrocconi beoni, l’accusi e la Comandante accetti subito di andarsene quando potrebbe ridurli all’obbedienza: tutto questo non è chiaro, non persuade, non interessa. E non v’è di peggio che persuadere il pubblico, a un certo momento, che non valga la pena di capire. Poiché quando si è capito, e si è data anche una integrazione personale alla vicenda scenica, si è capito soprattutto che non vale la pena di interessarsi all’umanità di personaggi che son tanto lontano da noi, e che si raccolgono in quadri casuali. Senza una vigoria, una logica, un impeto drammatico, sia pure esteriori; e senza nemmeno un modesto al di là di intenzioni e di mistero. I cavalieri hanno un carattere vocale popolaresco: robusto nella canzone, fine e accorato nella Ninna Nanna natalizia che luccica in sordina tra i fumi dell’ubbriacatura; ma il grottesco della loro sfilata e dell’accompagnamento orchestrale alla commedia e all’amore di Giosta e Anna è di una vivacità soltanto esteriore, ottenuta con procedimenti anche strumentalmente massicci. Sono tuttavia, con le grazie acquarellate dei cori di fanciulle e con i corali più vasti, specie nel quarto atto, i protagonisti di quest’opera 3.1.6/14 che in realtà non ne ha. Sono piuttosto una cornice che inquadra il melodramma, gl’impedisce di cascare dalle varie parti disunite nel lirismo inconcludente: sono il meglio dell’opera. Di Sintram, che dovrebbe essere il legame diabolico di questi casi nordici, ho già detto. I tentativi musicali di dargli un carattere sono vani e superficiali: non c’è da ricordare che il suono delle sonagliere della slitta che lo trasporta. Le sue apparizioni improvvise al secondo e al terzo atto sono insignificanti. Ma perché il maestro Zandonai s’è andato a cacciare in questo pasticcio scandinavo? Se egli fosse un musicista gravido di secondi fini, cercatore di esotismi preziosi, preoccupato di sperdere la realtà melodrammatica in un falso alone di significati più o meno profondi, si potrebbe capire l’errore. Ma egli ha confessato assai semplicemente ad un collega che nella fucina editoriale di Casa Ricordi c’era già allestita una traccia di libretto sul romanzo di Selma Lagerloff [sic]; che, compiuta Giulietta e Romeo, Arturo Rossato, suo collaboratore, gli aveva con fatica raccolti i cinque quadri dai molti episodi del romanzo, e che egli li ha musicati. Sui nostri palcoscenici gira ancora la Vally [sic] di Catalani; per onorare Puccini è stata rappresentata la sua prima opera: Le Villi; e altri esempi non mancano per persuaderci che di tempo in tempo, non si sa perché, un po’ per obbedienza a mode letterarie, un po’ per calcolo di colpire l’immaginazione credula dei nostri pubblici, un po’ per speranza di trovare del nuovo scenico, si infliggono ai nostri musicisti, che se le lasciano infliggere quando non le desiderino, queste pasticciose romanticherie nordiche, veramente mortificanti per il nostro spirito semplice, solare, armonico. Ammessa questa fatalità cieca, non è il caso di discutere il libretto di Arturo Rossato, il quale non avrebbe forse potuto farne uno diverso e migliore, ma avrebbe dovuto non farne alcuno, da quel romanzo. E non c’è nemmeno il caso di porre un problema estetico nell’incontro tra questa materia che si dovrebbe chiamar poetica e il temperamento musicale di Zandonai. L’indistinto e l’indifferente dei personaggi non ha certo giovato a correggere il melodismo lirico del maestro che in quest’opera, tenuta meditatamente in linee più raccolte, ha parentele mascagnane e ha avvicinato il racconto di Giosta all’“improvviso” dello Chénier. Molto invece s’è giovato il maestro dell’episodico e del corale, trattati con un senso largo, spigliato, che fa sperare in un suo desiderio di robuste e ampie costruzioni melodrammatiche. Nel canto permane l’amore agli ampi declamati, alle tessiture un po’ esasperate, che uguagliano i personaggi; nell’orchestra un desiderio di semplicità, di chiarezza, con finezze trasparenti, ma ancora con crescendi o scoppi di troppo fragorose sonorità. L’opera, nell’insieme, è fluida e piacevole. L’ascoltatore è continuamente richiamato ad essa, senza stanchezze e senza incomprensioni. C’è una bravura musicale che colora i quadri, ciascuno dei quali ha una nota particolare di rilievo. La banalità di qualche canto è sempre corretta o sfumata o nascosta in abili cadenze, come nel coro delle fanciulle. C’è un segno canoro in tutta l’opera che è ormai familiare del maestro e gli concilia subito l’attenzione del pubblico. E poiché l’esecuzione è piena ed efficace, il pubblico accorrerà ad ascoltarla. [...] 251 a[driano] b[elli], “I Cavalieri di Ekebù ” al Costanzi, «Il Corriere d’Italia», 31.3.1925 - p. 3, col. 1-2-3 (con foto di Zandonai) Avviso ai critici!... Quando al secondo atto sta per iniziarsi la commedia nel teatrino del Castello di Ekebù, Cristiano rivolto alla folla e agitando il corno che tiene in pugno grida: «Avviso a tutti i critici...». E l’orchestra commenta con tre inarrivabili ragli di asino. Poi continua: «Chi 3.1.6/15 ciancia ha una cornata!», e giù, altra indovinatissima armonia imitativa da far venire i brividi. Con questo avvertimento e con quel commento si rimane un po’ perplessi e... un po’ timorosi a scrivere intorno alla nuova opera di Riccardo Zandonai, e per cominciare affrettiamoci a riferire la cronaca lietissima della serata che si riassume in sette chiamate al primo ed applausi a scena aperta al racconto di Giosta; sei al secondo ed applausi all’aria di Anna e al coro dei Cavalieri; cinque al primo quadro del terzo, quattro al secondo quadro; sei chiamate alla chiusa dell’opera. Complessivamente dunque ben 29 chiamate, che costituiscono un autentico successo di pubblico (e l’opera non si concede facilmente ad una prima audizione), il che vale molto più del parere personale di questo o di quel critico. E dopo questa premessa, parliamo un poco della nuova opera di Riccardo Zandonai, cominciando dal libretto di Arturo Rossato. Il libretto L’argomento, com’è noto, è tratto dal romanzo La leggenda di Gosta [sic]Berling di Selma Lagerlof [sic], la popolarissima scrittrice svedese premiata nel 1909 col premio Nobel per la letteratura e il cui libro è considerato come un vero poema nazionale. Dalla farraginosa narrazione di psicologia incerta [e] nebulosa, esuberante di episodi e di particolari folkloristici Arturo Rossato è riuscito a compiere vera opera d’arte traendone un libretto scorrevole in relazione al romanzo e pieno di scene di colore come si addicevano alla peculiare attitudine del musicista. Manca certo di unità, e non pote[va] averne, ma non è esagerato affermare che data la narrazione della Lagerlof non poteva trarsi lavoro migliore di questo. Però tale libretto non è adatto per il nostro teatro, né per i nostri musicisti. Il soggetto nordico punto si avvicina al gusto del nostro pubblico, che non riesce ad interessarsi a certi personaggi né a comprendere certe situazioni. L’unica figura alla quale si può un poco appassionare la nostra anima latina è quella di Anna, che con la sua femminilità e con la sua bontà redime e trasforma Giosta, abbrutito dal vizio dell’alcool. Ma è fredda Anna, destinata a compiere l’alta missione di cui ogni donna dovrebbe andare orgogliosa, quella cioè di purificare, guidare e sostenere con la femminile dolcezza e con spontanei sacrifici l’uomo amato – ed in questo Anna rassomiglia un poco a Minnie – [ma] non riesce, al contrario della creatura pucciniana, a farci passare un brivido di commozione. Essa è fredda come la neve che ovatta il suo paesaggio ed opaca come la pesante nebbia di quei paesi. Lassù si possono anche concepire, attraverso le copiose necessarie libagioni, le fantastiche storie di diavoli e di fattucchiere e dar vita a chimere e realtà alle apparenze. Ma da noi ove sfolgora il sole e l’aria è tutta una vibrazione di fulgori si ama in altro modo e i nobili sacrifici e le alte missioni di donne si compiono con slancio e calore, così che da noi personaggi siffatti non possono appassionare né far nascere interesse. E se questa è la impressione per Anna, la più umana dei fantocci che l’altra sera abbiamo veduto agitarsi sul palcoscenico del Costanzi, è facile immaginare quale sia quella per gli altri. Il nostro pubblico passa indifferente ed anzi si urta dinanzi alla Comandante, che ha perduto ogni femminilità e fuma e parla a forza di scudiscio, e a quel branco di sfaccendati che sembra che lavorino solo per procurarsi da che bere e ubbriacarsi, e all’incomprensibile Cristiano che dopo averne fatto di tutti i colori si fa di un tratto scrupolo fino a cacciare la sua padrona e protettrice. La musica A questo insieme di fantasioso, di superstizioso e di leggendario che forma l’essenza della letteratura nordica, insieme cerebrale e punto interessante, Riccardo Zandonai ha cercato di dar vita attraverso una vera fantasmagoria di suoni: tanto più che alcuni episodi ed alcune scene si prestavano magnificamente per la sua prodigiosa tavolozza orchestrale. E ci è 3.1.6/16 riuscito, giacché l’attenzione [con la ] quale è stato seguito sino all’ultima nota il non breve spartito è dovuta esclusivamente alla magìa del musicista. Musica, questa dello Zandonai, più sostanziosa di intelligenza che non di cuore; musica in cui è tutto un succedersi di sensazioni diremmo quasi visive, ora abbaglianti, ora pallide, ora accese, ora smorte; un insieme di colori svariatissimi disposti con squisitissimo buon gusto, con efficacia di contrasti, con varietà di toni, con rilievo di chiaroscuri. Come colorista Zandonai non ha certo chi l’uguagli. Dalle scene in cui tutto sembra svanire in un’atmosfera di irrealtà e di sogno, di forme indefinite e iridescenti, passa a quelle in cui l’arditezza della forma e il cozzo dei colori più vivaci e disparati giungono all’iperbolico, con un equilibrio mirabile. Arte, questa dello Zandonai, nella quale egli ha raggiunto la completa maturità. Nelle scene con le quali si apre l’opera quei suoni incerti e indefiniti dànno una nota così realistica che giungiamo quasi a vedere il quadro di un melanconico tramonto nell’ampia distesa delle nevi; e così si [ ]nca della notte del Natale. Tanto le piccole scene in cui alcune pennellate di colore dànno a quel quadro indimenticabili iridescenze di colori, come ad esempio i soavissimi contrappunti della celesta all’[assolo] di violino; quanto la strana e impressionante poderosa scena dei cavalieri al primo atto e quella magnifica della ripresa del lavoro alla chiusa dell’opera sono scritte da Grande. Ma quella che è riuscita un vero capolavoro di arditezza è l’insuperabile commento del teatrino. Lo Zandonai è così padrone dell’arte sua che alle volte dà l’impressione di quegli acrobati che si divertono a far rabbrividire gli spettatori dinanzi ai loro pericolosissimi esercizi. Egli infatti attacca quella scena che sembra quasi pazza per la sua arditezza e la svolge, l’[ ] fino al parossismo. Cammina come sopra un filo sospeso su paurosi baratri, e sembra non accorgersi di nulla. va avanti con una disinvolta padronanza da sbalordire. Le regole armoniche non esistono più. Il p. Martini che rabbrividiva a due quinte di seguito si sarebbe suicidato! Eppure quella musica così veristicamente stonata attraverso l’arte di questo Mago vi appare come la più intonata musica che possa esistere, e il quadro non solo non urta il vostro udito ma vi prende e vi trascina. Oltre queste pagine inarrivabili che potrebbero davvero definirsi “musica per gli occhi”, i Cavalieri di Ekebù contengono brani in cui lo Zandonai si è abbandonato alla melodia larga e ampiamente svolta. Si è voluto a questo proposito osservare che egli, specie al secondo atto, si sia voluto avvicinare alla forma melodica mascagnana. Niente di più errato. Là Giosta improvvisa la parte della commedia e il suo canto non poteva essere che quel declamato melodico in cui la frase segue esattamente la musicalità della parola e del periodo. Ma v’è un abisso tra la melodia di Mascagni e quella dello Zandonai. Certo dal lato lirico, almeno come intenzioni, Zandonai è in progresso. Il racconto di Giosta al primo atto è veramente umano e riboccante di passione. Diverso per condotta e sviluppo è il racconto che segue della Comandante, ma non per questo meno pregevole del primo. L’aria di Anna al secondo è bella e di squisita fattura e così il duetto e così il canto della nostalgia al terzo; ma sono troppo poche pagine queste per una partitura così voluminosa. I dialoghi sono troppo frequenti e lunghi; la parte di Cristiano (ad eccezione della canzone che canta con i Cavalieri) ad esempio è tutto un declamato, e così quella di Sintram, e così via. Un effetto di commozione profonda che dilaghi dalle scene nella sala, un lampo di grande ispirazione, un fremito intenso e vibrante, un grido veramente umano che scuota e faccia provare il brivido, si attende invano durante le tre ore in cui durano i Cavalieri. In Francesca Zandonai trovò quei momenti, e così in Giulietta, ma in quest’ultimo lavoro non poteva trovarli perché l’azione non glie ne presentava l’occasione. Nei Cavalieri abbiamo una serie di scene e di quadri trattati con salda mano e con insuperabile abilità strumentale, ma mancano quell’equilibrio organico e quel calore che pur avevano Francesca e Giulietta ed anche Conchita. 3.1.6/17 Si è parlato tanto in questi giorni di successioni, ebbene sia; ma occorre che il genialissimo maestro trentino ricordi in qual modo il suo predecessore sceglieva i libretti e come si maturavano le opere nel suo studio e con quale pazienza venivano limate. Il libretto deve contenere passione che si comunica nella sala, deve contenere un soggetto che commuova profondamente e senza artifici; e solo a questa condizione si deve scrivere. Piuttosto che dare vita musicale a delle cose che lasciano il pubblico freddo e indifferente è preferibile non scrivere, proprio come faceva quel grande scomparso1. I Cavalieri, come osservavamo in principio, non si concedono ad una prima audizione, vanno ascoltati di nuovo perché contengono pagine pregevolissime di colore e buoni slanci lirici. L’opera appare un po’ lunga. Una revisione e opportuni ma coraggiosissimi tagli alla seconda metà dell’opera si impongono per la vitalità e la fortuna dell’opera stessa. Date a Riccardo Zandonai un libretto umano, nostro, sentito, passionale; un libretto organico, non eccessivamente lungo, in cui vicino al colore degli episodi e dello sfondo vivano in primo piano creature che sentano e soffrano come soffriamo e sentiamo noi, e lo Zandonai ci darà il capolavoro. La esecuzione La esecuzione è stata veramente eccellente; sul palcoscenico è stata una vera gara fra gli artisti maggiori e minori perché l’opera nuovissima venisse posta nella sua giusta luce. Riccardo Zandonai non poteva sperare migliore collaborazione. Vogliamo porre in prima linea Edoardo Vitale che è stato un meraviglioso animatore di particolari. Niente ha trascurato perché la varia, ricca, difficilissima partitura venisse posta in quel rilievo che meritava. Tutti gli effetti che alle volte nella musica dello Zandonai sono fine a se stessi sono stati dall’illustre direttore curati con quello scrupolo artistico che è sua caratteristica e riusciva a rendere nel giusto equilibratissimo tono. E dove poi la frase si elevava con respiro più ampio o la scena assumeva slancio e vigorìa la bacchetta del Vitale sapeva trarre dall’orchestra e dalle voci sonorità piena senza abusi e senza asprità, con una comunicativa che è valore e vanto del grande direttore. Il pubblico comprese tutto questo e salutò il grande direttore con applausi ed ovazioni piene di entusiasmo. Maddalena Bugg nelle vesti della dolce e appassionata Anna fu di una toccante umanità. Cantò con voce bella, uguale, estesa, con una dizione di una chiarezza ammirabile, con una emissione ricca di risorse, con un calore pieno di efficacia. E nella scena seppe essere gaia e spensierata, dolorante e appassionata, guidando il suo canto e le sue controscene con un intuito artistico e con una intelligenza di cui ci ha dato sempre prova ma che più che mai ha messo in valore nella nuovissima sua interpretazione. Giosta Berling ha trovato nel tenore Merli un interprete superiore ad ogni elogio. Cantante che non conosce difficoltà di tessitura e di emissione, in possesso di una resistenza invidiabile, di una intelligenza superiore e di grande calore comunicativo, ha avuto l’altra sera momenti felicissimi così che l’opera per merito suo si arricchì di un elemento veramente prezioso. Sara Sadun è tornata graditissima fra noi dopo una sua malattia, e per suo mezzo la parte della Comandante ha avuto un’interpretazione eccellente. Tutto quello che di rude, di forte, di maschio è contenuto in questa parte strana e lontana dal nostro temperamento è stato reso dalla valorosa artista in modo veramente reale. La Sadun, che ha una dizione di una impareggiabile chiarezza ed una voce che nel registro basso si amplia con risonanze baritonali, è stata molto ammirata e festeggiata. Il baritono Parvis (a proposito, rallegramenti cordialissimi per la meritata onorificenza di cui volle di motu-proprio insignirlo S.M. il re) era Cristiano e, diciamolo subito, il valoroso 1 È evidente in quest'ultimo capoverso l'allusione a Giacomo Puccini. 3.1.6/18 artista ha reso il personaggio con giusta rudezza ed ha cantato perfettamente, e non poteva essere diversamente. Teofilo Dentale sia con la voce sia col giuoco scenico sia con la sua non comune intelligenza ha dato al personaggio di Sintram il giusto rilievo. Il Nardi ha reso benissimo la parte di Licerona [sic], e la De Franco è stata una perfetta ostessa e madre. Ottimi i Cavalieri di Ekebù di Marcotto, Pellegrino, Tega, e Petri [sic], Uxa, Giusti, Soffiantini, Pastocchi e Freitas; e così le fanciulle: Tesorieri, Lauri, Benincori, Gualda2 e oltre le tutte. Benissimo i cori difficilissimi, istruiti dal M.o Consoli. Non dobbiamo dimenticare Oscar Zuccarini che nei due difficilissimi a solo di violino è stato pari alla sua grande fama per cavata, precisione e ritmo; e l’infaticabile M.o Luigi Ricci che ha preparato tutti gli artisti in modo da essere come sempre un vero, prezioso e insuperabile collaboratore dello spettacolo. Belli gli scenari eseguiti sui bozzetti del Carelli. [...] 252 M[atteo] Incagliati, Il successo de “I Cavalieri di Ekebù” al Costanzi, «Il Giornale d’Italia», 31.3.1925 - p. 7, col. 2-3-4-5 (con un ritratto a matita di Zandonai L’aspetto magnifico, imponente, sfolgorante che aveva assunto l’altra sera la sala del Costanzi – non un posto vuoto – conferiva da solo il tono all’avvenimento teatrale che è senza dubbio il più notevole dell’annata. Non mancava il Principe ereditario, rivelatosi ormai sensibile a ogni nobile manifestazione d’arte e in particolar modo di quella musicale. Dinanzi a così eletto e numeroso uditorio la nuova opera di Riccardo Zandonai, già accolta or son venti giorni alla Scala da un grande successo, fu riconsacrata alla benigna fortuna; e così, per una volta tanto, in questa nostra Italia che spesso pare divisa spiritualmente, il pubblico delle due maggiori metropoli si è trovato d’accordo nel giudicare un’opera d’arte, tanto d’accordo che la cronaca di Milano della prima rappresentazione dei Cavalieri è quasi simile a quella dell’altra sera al Costanzi. I Cavalieri di Ekebù seguono dunque la loro marcia con il loro inno giocondo e spavaldo, sorretti da una sorridente ed amica stella. Al Costanzi la cronaca segna ben trenta chiamate alla ribalta, alle quali parteciparono con Riccardo Zandonai il librettista Arturo Rossato, il maestro Edoardo Vitale e tutti gl’interpreti, e applausi a scena aperta lungo il corso della rappresentazione. L’opera d’arte Per quale fascino musicale i Cavalieri di Ekebù conquistarono il pubblico della Scala, dove la nuova opera si continua a replicare dinanzi a pubblico affollato e plaudente, è troppo noto ai lettori del Giornale d’Italia – ché su queste colonne intorno alla geniale partitura fu in quell’occasione largamente, diffusamente scritto3. Certo perché questo fascino abbia esercitato la stessa influenza sul pubblico romano bisogna che l’opera d’arte abbia insito in sé tali elementi di bellezza e tali fattori di teatralità da vincere ogni prova. Considerata così come un affresco dove campeggiano strane figure sullo sfondo di un nevoso triste paesaggio e dove si agita la folla, la nuova opera di Zandonai rivela con tipica 2 3 Ossia Caputo. v. in Appendice 1 i nn. 360 e 362. 3.1.6/19 ed espressiva rappresentazione musicale tre aspetti diversi, ai quali la fantasia dell’artista ha impresso una nota di suggestiva originalità: l’ambiente – il paesaggio della leggenda da cui il Rossato ha tratto il libretto –, l’amore di Anna e Giosta, il gruppo dei dodici Cavalieri. L’ambiente. La facoltà coloritrice di Riccardo Zandonai si rivela con tratti di originalità in ogni sua opera e in particolar modo nella Conchita, nella Francesca, nella Giulietta e in ultimo nei Cavalieri. Gli è che il senso di espressione di una determinata epoca e di un determinato paesaggio è tratto artisticamente dalla propria fantasia, senza ricorrere al folklore. Nei Cavalieri era facile impresa ricorrere alla espressione dell’esotismo. Invece Zandonai ha creato un mondo caratteristico e poetico con la sua musica, per cui l’ambiente della nuova opera è stato descritto attraverso singolari motivi musicali, senza attingere ad altra fonte che alla fonte della sua genialità. E così il paesaggio boreale si delinea a chiari segni sin dall’inizio dell’opera con un movimento eguale dei bassi nei quali par che pianga la natura desolata e fredda su cui si scioglie un lento e spezzato disegno dell’oboe. E poi l’ambiente è ravvivato dal guizzo sinistro di una sonagliera e da un leggiadro canto di fanciulle. La nota nostalgica non s’interrompe mai come i due amanti, Anna e Giosta, popolano la scena, e si insinua poi nell’anima della Comandante quando la sciagura si abbatte su di lei, e vince perfino il gruppo dei cavalieri quando la notte di Natale smorza ogni allegrezza. Ed è così con un intreccio di temi e attraverso una chiara nitida trama sinfonica che il senso del paesaggio si rivela e si disegna e par quasi che si ripercuota nelle voci dei vari personaggi. È la nota indeterminata e vaga rievocante il contenuto poetico di un mondo lontano, un mondo che la fantasia di Zandonai ha tradotto con la fantasia. La parte descrittiva è costruita dunque non sulla facile e comoda falsariga della musica nordica a cui pure avrebbe potuto attingere l’operista, ma attraverso gli scatti e i guizzi della genialità dell’artista. E così la parte lirica e la parte caricaturale – i due aspetti fondamentali della nuova opera – non seguono che la stessa traccia, recanti i segni e gli accenti espressivi di una individualità ormai ben delineata che la maturità dell’ingegno e dell’esperienza ha reso tipica. Onde lo stile di Zandonai può ormai considerarsi quale esso è: lo stile di un operista che parla con un suo linguaggio, con un’agile [e] potente fantasia. E in un’epoca nella quale l’opera dilaga e divaga negli stagni della più monotona esercitazione cerebrale, se pure spesso non rimanga ammorbata dai miasmi della imitazione esotica, è buona ventura per le sorti del melodramma che vi sia chi nella tradizione verdiana non si mostri né insensibile né tetragono. La vicenda d’amore. È un lirismo di schietta marca zandonaiana. Se Francesca e Paolo cantano una loro melodia d’amore, e Giulietta e Romeo palpitano di una vita melica tutta illeggiadrita da un ideal sogno di poesia, Anna e Giosta evocano dalle loro anime ritmi e motivi che la passione turba ed esalta. E l’amore qui – così nel secondo atto, come nel terzo, come nell’ultimo – ha una forma d’espressione con un insistente richiamo a quella melodia che, per quanto facciano e scrivano gli anemici e i balbuzienti degli aspiranti a battere con i loro piedi claudicanti le tavole del palcoscenico, Zandonai non pare sia di parere di ripudiare. Altri può ormai averle dato l’ostracismo e può averle detto addio vistala in fuga dall’abbaino o dalla porta della propria fantasia sorda e muta: non così chi nei Cavalieri si è rivelato cantore con tutta la gioia e l’esultanza di un artista capace di inebbriarsi alle voci dell’umanità, allo spirito delle passioni, a quel pathos senza di cui l’opera teatrale rischia di essere un... poema sinfonico. I Cavalieri. Com’essi si preannunciano al finale del primo atto, con la gaia fanfara, l’ambiente si rischiara, si ravviva. È la nota gioconda del dramma posta a contrasto col grigiore dell’ambiente nordico. E come essi appaiono sulla scena, l’inno: Vecchia terra di Ekebù, sorretto da un’idea melodica di ampia sonorità, squillante, vivace, ben marcata, saldamente costruita, a larghi intervalli, si spande d’intorno e rispecchia tutta la festosità, tutta la pomposa rudezza mista al grottesco di questa piccola brigata di buontemponi. Ma, con un’intuizione felice, Zandonai – e in ciò si rivela la grande arte di lui – ha inserito in 3.1.6/20 quest’inno un lieve senso di malinconia, quasi a preparare la tragedia che esploderà alla fine dell’opera. La visione dell’artista si è realizzata con una sintesi musicale di alto rilievo. In quest’inno è incluso tutto un dramma di allegrezza e di sciagura. Tutto il secondo atto – un atto di forte potente originalità, in cui è la trovata, la sorpresa di cui sono capaci solamente i grandi operisti – si riflette nella figurazione del gruppo dei Cavalieri. Arte senza dubbio grande questa di Zandonai, di avere cioè impostato una scena sul comico, sul quale s’innesta la nota lievemente sentimentale. Quale spirito non anima la grottesca rappresentazione dei Cavalieri? È un modello del genere in cui alla vocalità s’inserisce la pompa caricaturale strumentale. Com’è un modello di ben diversa fattura e di ben diversa ispirazione il canto di Natale nel primo quadro del terzo atto, un canto a quattro parti di tenori e bassi intrecciato dalle volute bizzarre e patetiche ad un tempo di un violino. I Cavalieri rappresentano l’anima, la luce, il palpito di questa opera. E tutto l’ultimo atto, così pieno di commossa umanità, echeggia del canto del Cavalieri. Il dramma della folla si delinea e si disegna nettamente. Il coro diventa così personaggio e popola la scena con i suoi vari atteggiamenti musicali. Il senso della teatralità ha il suo risalto netto. Come l’opera volge alla fine questo personaggio, il coro e il gruppo dei Cavalieri, assume sempre più aspetto determinato. La musica ha tratti ben marcati. La gaia canzone dei Cavalieri riprende il suo ritmo, i fiati in orchestra urlano, esultano gli archi e gli strumentini, e tutta la sinfonia echeggia di suoni prodotti dai colpi di maglio e di martelli. Ma non passi inosservato questo: che la canzone dei Cavalieri, in ultimo, muta di consistenza espressiva, così come l’azione drammatica richiedeva, e par quasi che meno spavalderia, meno gaiezza la sorregga, sorretta com’è da un senso di pietà e di poesia per la morte della Comandante. E in ciò Zandonai ha ben risposto al consiglio della sua genialità se è riuscito ad ottenere questo effetto di verità teatrale pur conservando all’inno dei Cavalieri le note e il movimento. Tale, secondo i dettami del De Sanctis, l’opera considerata in blocco: avremo tempo e agio di notare qualche menda. L’opera d’arte che ha tali elementi di bellezza musicale giustifica l’accoglienza avuta l’altra sera al Costanzi, così come già l’ebbe alla Scala. Lo spettacolo Ed occorre dir subito che la riproduzione della nuova opera è riuscita al Costanzi quale le tradizioni del massimo teatro della Capitale lasciavano prevedere. L’esecuzione è stata di quelle che non si dimenticano. Il maestro Edoardo Vitale ha prodigato per i Cavalieri tutte le sue eminenti doti di grande artista e di versatile musicista. Questa sua interpretazione, questa sua nobile fatica non teme confronti. L’orchestra sotto la sua guida ha suonato con una morbidezza, una nitidezza, una vivacità di suoni e di ritmi come la partitura richiedeva. La vita musicale della nuova opera si è sprigionata dall’orchestra in piena fulgida luce. Mirabili di effetto le sonorità piene e vibranti, senza che mai il tono di esse fosse calcato su una facile volgarità per accrescere l’effetto dinamico; soffusi di poesia tutti gli squarci lirici, e con tale espressività che il canto poté sempre sciogliersi in armonico disegno associato al comento orchestrale. Edoardo Vitale ha veramente sentita quest’opera e ne ha rivissuta l’intima essenza musicale con un’intelligenza e una sensibilità di cui mostrò intendere la portata, la significazione l’illustre autore, che volle al prezioso suo collaboratore dimostrare il vivo grato animo con parole che rappresentano la migliore critica, il migliore omaggio. Né da meno furono gli interpreti della scena. Maddalena Bugg, nelle vesti di Anna, cantò con una poesia accorata e con accenti deliziosi. La sua voce ebbe agilità e risonanze di così gradevole effetto che pareva l’anima del personaggio si confondesse con l’anima melica. Ogni suo canto si illeggiadrì del bel suono della sua voce, cui accresceva fascino un senso di 3.1.6/21 accorata espressione. E con quelle sue modulazioni, con quella profondità di sentimento ella rese di Anna ogni moto dell’anima, tutto lo spirito musicale. Dopo la romanza ebbe molti applausi. La Sadun fu una Comandante forte e rude e con le sue note basse conferì al personaggio un tono di fierezza. Nell’ultimo atto trovò accenti di accorata mestizia. Il tenore Merli può associare il clamoroso successo conseguito in quest’opera a quello dell’Aida. “Radamès” quale egli si rivelò senza emuli. Di Giosta intese il dramma e lo rivisse col canto e con la interpretazione mirabilmente. La sua voce così spontanea, così generosa, così educata e così insinuante ubbidì alle asperità dell’ardua tessitura docilmente, e ne trionfò. La espressività del suo canto non fallì mai e si cimentò vittoriosamente in tutti i brani, così in quelli lirici come in quelli drammatici. Espressività di patetico abbandono e di esultanza, che trovarono l’ugola preziosa sensibile e capace di spandere il canto in armonia dal suono. I suoi acuti magnifici pareva si spandessero con una facilità tanto prodigiosa da produrre un godimento di cui l’arte vocale da qualche tempo non è più prodiga. E così è giustificato l’applauso clamoroso che l’interruppe dopo il racconto al primo atto, ch’egli rese con tutta l’anima e la possanza della gola; e dopo il duetto con Anna al terzo atto, nel quale la voce trovò accenti di largo ampio respiro. Un Cristiano di superbo rilievo fu il baritono Parvis, che come sempre rivelò di non sapere dissociare l’arte del canto da quella dell’interpretazione. Egli scolpì il personaggio con tratti di tipica rappresentazione, conferendovi un che di rude e di forte. Il suo canto parve dare un tono di vivacità espressiva alla interpretazione. Non un segno, non una pausa, non un particolare sfuggì allo studio e all’intuizione di questo artista che onora la scena lirica col suo temperamento versatile e con il suo spirito di cantante. Di Sintram il basso Dentale rese la vivacità diabolica con intelligenza e misura. Tutti i tratti dello strano personaggio furono riprodotti con il canto e la mimica ottimamente. E del personaggio intese l’aspetto umano e quello fantastico. Olga De Franco, nella duplice veste di Ostessa e di Madre, si fece molto onore, artista di sensibilità e dalla intonata e morbida voce di mezzo soprano, eguale e armoniosa nei vari registri. Nella drammatica scena al terzo atto ella cantò con così commossi accenti che produsse un vero brivido, quel brivido di cui sono capaci le artiste che cantano con l’anima. Bene il basso Iulio. Caratteristico il gruppo dei Cavalieri, e cioè: Nardi, Marcotto, Pellegrino, Tegi [sic], De Petris, Uxa, Giusti, Soffiantini, Pastocchi, Freita [sic]. Lodevoli: Dorina Tesorieri, Laura Lauri, Margherita Benincori, Gualda Caputo. Il coro, istruito dal maestro Consoli, cantò con un impeto e una intelligenza che suscitarono la più viva ammirazione. Il Consoli è stato un collaboratore prezioso del successo che ha arriso alla nuova opera. I due “a solo” per violino furono resi dal prof. Oscar Zuccarini con maestria e con penetrante spirito musicale zandonaiano e sovratutto con una purezza di suono e una perfetta intonazione che valsero all’insigne strumentista la più ampia lode. Né bisogna dimenticare i maestri Ricci e De Fabritiis, che cooperarono [con] il maestro Vitale durante le prove. La messa in iscena fu curata, oltre che dalla signora Emma Carelli, dal comm. Carlo Clausetti, l’autorevole dirigente della Casa Ricordi. Il Clausetti, che alla vivida cultura musicale unisce buon gusto ed esperienza teatrale, è riuscito a far muovere le masse con una verità sorprendente e a non trascurare nessun particolare scenico perché l’opera avesse il risalto che il libretto consigliava. Le scene caratteristiche sono state ispirate dai bozzetti dell’illustre pittore comm. Augusto Carelli. La cronaca della serata 3.1.6/22 Ed ecco poche note di cronaca sulla serata. Alle ore 20.35 il maestro Edoardo Vitale dà inizio allo spettacolo. Nella sala buia si fa un silenzio religioso. L’attenzione è viva ed intensa. I primi applausi scoppiano calorosi e si prolungano per qualche minuto dopo il racconto di “Giosta”, cantato dal tenore Merli con foga appassionata. Come l’atto si chiude, con la canzone dei Cavalieri dal ritmo marcato e spavaldo, nella sala risuona l’acclamazione, che come appare il maestro Zandonai, evocato a gran voce, si eleva di tono, e le chiamate all’autore, al Rossato, al maestro Vitale e a tutti gli interpreti raggiungono il numero di sette. Il secondo atto interessa per la vivacità e per la originalità con cui è stato ideato. Dopo la scena della presentazione dei Cavalieri, alla chiusa del coro, vibrante e altisonante, la sala prorompe in un applauso; altro applauso dopo la romanza di “Anna”. Alla chiusa dell’atto Zandonai col Rossato, con Edoardo Vitale che vuole accanto a sé, [con] il maestro dei cori Consoli, un collaboratore prezioso del successo conseguito dalla nuova opera, e con tutti gl’interpreti, è evocato alla ribalta sei volte. Il terzo atto, come è noto, è diviso in due parti: in complesso si sono avute nove chiamate. Nella prima parte suscita viva commozione e profonda impressione il canto di Natale, reso dal gruppo dei Cavalieri con bella espressione e impeccabile intonazione. Nella seconda parte il duetto tra “Giosta” e “Anna”, cui il tenore Merli e la Bugg accrebbero fascino con la vivacità degli accenti e con tutta la passione delle loro voci. L’ultimo atto si inizia con un coro impetuoso che è applaudito, e si svolge poi con un duetto tra il tenore e il soprano che è tutto pervaso di una patetica mestizia. L’addio della “Comandante” impressiona per gli accenti pieni di abbandono e di angoscia, con melodia di schietto sapore italiano e dall’ampio respiro. Il finale dell’opera, colla canzone dei Cavalieri, i colpi di maglio, gli squilli dei martelli, impressiona per la sonorità e la genialità con cui il maestro Zandonai è riuscito a ideare, a costruire, a realizzare una scena che onorerebbe qualsiasi grande musicista. Gli applausi, le acclamazioni si prolungano e si intensificano: e Riccardo Zandonai con il Rossato e con tutti gli interpreti, a capo dei quali è il maestro Vitale, è indotto a presentarsi al proscenio otto volte. Un successo dunque che ha la sua schietta significazione nel numero delle chiamate alla ribalta: in complesso – a parte gli applausi a scena aperta – ben trenta. Il successo, dunque, di Milano alla Scala si è ripetuto al Costanzi. Dopo il secondo atto il Principe ereditario ha fatto invitare nel suo palco il maestro Zandonai e Arturo Rossato. Il Principe ricordò al Maestro di aver parlato con lui dei Cavalieri di Ekebù a Rovereto, compiacendosi di vederli ed ascoltarli ora, proprio così come Zandonai glieli aveva descritti. Osservò sorridendo che egli, il maestro, aveva pur dato un po’ di sole italiano tra le nebbie del Nord e gli chiese quanto tempo aveva impiegato per condurre a termine l’opera. Il maestro rispose che aveva impiegato quindici mesi, perché quando egli lavora è tenace come le sue montagne. Parlando dell’opera il Principe soggiunse che essa lo interessava molto e si congratulò vivamente anche col Rossato per il libretto che gli era piaciuto molto come gli era piaciuto il romanzo di Selma Lagerlof [sic]. 253 m[atteo] i[ncagliati], “I Cavalieri di Ekebù” al Costanzi, «Il Piccolo», 30.3.1925 - p. 6, col. 1-2-3 Lo spettacolo - Zandonai e il Principe Ereditario - Trenta chiamate La sala del Costanzi, per la prima dei Cavalieri di Ekebù del maestro Riccardo Zandonai, su libretto di Arturo Rossato, aveva l’altra sera l’aspetto delle occasioni solenni: non un posto 3.1.6/23 vuoto, una vera moltitudine. Nei palchi, nelle poltrone, nelle poltroncine le più belle e leggiadre dame, fra cui un numero eccezionale di straniere. Nel palco di Corte si notava il Principe ereditario, in un palco di prim’ordine il Commissario senatore Cremonesi e in poltrona il sottosegretario di Stato on. Mattei-Gentili. Alle ore 20.35 il maestro Edoardo Vitale dà inizio allo spettacolo. Nella sala buia si fa un silenzio religioso. L’attenzione è viva e intensa. I primi applausi scoppiano calorosi e si prolungano per qualche minuto dopo il racconto di “Giosta”, cantato dal tenore Merli con foga appassionata. Come l’atto si chiude, colla canzone dei Cavalieri, dal ritmo marcato e spavaldo, nella sala risuona l’acclamazione, che come appare il maestro Zandonai, invocato a gran voce, si eleva di tono, e le chiamate all’autore, al Rossato, al maestro Vitale e a tutti gli interpreti raggiungono il numero di sette. Il secondo atto interessa per la vivacità e per la originalità con cui è stato ideato e che ha rivelato una tipica originalità della fantasia del musicista. La parte caricaturale si fonde alla parte lirica, soffusa questa di una tenera leggiadra melodia erotica. Dopo la scena della presentazione dei Cavalieri, alla chiusa del coro, vibrante e altisonante, la sala prorompe in un applauso; altro applauso dopo la romanza di “Amia” [sic]. Alla chiusa dell’atto Zandonai con Rossato, con Edoardo Vitale che vuole accanto a sé il maestro dei cori Consoli, un collaboratore prezioso del successo conseguito dalla nuova opera e con tutti gl’interpreti, è evocato alla ribalta sei volte. Il terzo atto, come è noto, è diviso in due parti: in complesso si sono avute nove chiamate. Nella prima parte suscita viva commozione e profonda impressione il canto di Natale, reso dal gruppo dei Cavalieri con bella espressione e l’impeccabile intonazione. Nella seconda parte il duetto tra “Giosta” e “Amia”, cui il tenore Merli e la Bugg accrebbero fascino con la vivacità degli accenti e con tutta la passione delle loro voci. L’ultimo atto si inizia con un coro impetuoso che è applaudito, e si svolge poi con un duetto tra il tenore e il soprano che è tutto pervaso di una patetica mestizia. L’addio della “Comandante” impressiona per gli accenti pieni di abbandono e di angoscia, con melodia di schietto sapore italiano e dall’ampio respiro. Il finale dell’opera colla canzone dei Cavalieri, i colpi di maglio, gli squilli dei martelli impressiona per la sonorità e la genialità con cui il maestro Zandonai è riuscito a ideare, a costruire, a realizzare una scena che onorerebbe qualsiasi grande musicista. Gli applausi, le acclamazioni si prolungano e si intensificano: e Riccardo Zandonai con il Rossato e con tutti gli interpreti, a capo dei quali è il maestro Vitale, è indotto a presentarsi al proscenio otto volte. Un successo dunque che ha la sua schietta significazione nel numero delle chiamate alla ribalta: in complesso – a parte gli applausi a scena aperta – ben trenta. Il successo, dunque, di Milano alla Scala si è ripetuto al Costanzi. Dell’opera diremo stasera con miglior agio, per quanto della première svoltasi alla Scala in queste colonne si parlò con ampiezza. In queste affrettate e rapide note di cronaca basterà segnalare dopo il successo, cui si è fatto cenno più innanzi [!], alla vibrante esecuzione che fu quale non è facile immaginare per diligenza e per genialità dei singoli interpreti, primo fra tutti l’illustre maestro Vitale, animatore vigoroso [e] appassionato dello spettacolo, collaboratore quale egli si rivelò fraterno dell’autore, e poi: il tenore Merli, la Bugg, la Sadun, il baritono Parvis, il basso Dentale, Olga De Franco. Caratteristico il gruppo dei Cavalieri, e cioè: Nardi, Marcotto, Pellegrino, Tega, de Petris, Uxa, Giusti, Soffiantini, Pastocchi, Freita [sic]. Lodevoli: Dorina Tesorieri, Laura Lauri, Margherita Benincori, Gualda Caputo. Il coro, istruito dal maestro Consoli, cantò con un impeto e una intelligenza da suscitare la più viva ammirazione. Il Consoli è stato un collaboratore prezioso del successo che ha arriso alla nuova opera. 3.1.6/24 I due “a solo” per violino furono resi dal prof. Oscar Zuccarini con maestria e con penetrante spirito musicale zandonaiano e sovratutto con una purezza di suono e una perfetta intonazione che valsero all’insigne strumentista la più ampia lode. Né bisogna dimenticare i maestri Ricci e De Fabritiis, che cooperarono il maestro Vitale durante le prove. La messa in iscena fu curata, oltre che dalla signora Emma Carelli, dal comm. Carlo Clausetti, l’autorevole dirigente della Casa Ricordi. Il Clausetti è riuscito a far muovere le masse con una verità sorprendente e a non trascurare nessun particolare scenico perché l’opera avesse il risalto che il libretto consigliava. Le scene caratteristiche sono state ispirate dai bozzetti dell’illustre pittore comm. Augusto Carelli. Dopo il secondo atto il Principe ereditario chiamò nel suo palco il maestro Zandonai e il Rossato. Con l’illustre operista il Principe parlò a lungo di musica e dei Cavalieri. Domani sera, in 2a d’abbonamento, i Cavalieri si replicheranno, a prezzi meno alti della première. L’autore assisterà alla rappresentazione. Allo spettacolo assisteva dal palco di Corte il Principe Ereditario. Dopo il secondo atto il Principe ereditario ha fatto invitare nel suo palco il maestro Zandonai e Arturo Rossato. Il Principe ricordò al Maestro di aver parlato con lui dei Cavalieri di Ekebù a Rovereto, compiacendosi di vederli ed ascoltarli ora, proprio così come Zandonai glieli aveva descritti. Osservò sorridendo che egli, il maestro, aveva pur dato un po’ di sole italiano tra le nebbie del Nord e gli chiese quanto tempo aveva impiegato per condurre a termine l’opera. Il maestro rispose che aveva impiegato quindici mesi, perché quando egli lavora è tenace come le sue montagne. Parlando dell’opera il Principe soggiunse che essa lo interessava molto e si congratulò vivamente anche col Rossato per il libretto che gli era piaciuto molto come gli era piaciuto il romanzo di Selma Lagerlof [sic]. 254 Alberto Gasco, “I Cavalieri di Ekebù” di R. Zandonai al Costanzi, «La Tribuna», 31.3.1925 p. 3, col. 2-3-4 (con un ritratto a matita di Zandonai) La situazione nella quale Riccardo Zandonai si trova rispetto all’arte lirica italiana è singolare. Il fecondo, energico, abilissimo compositore trentino ha saputo guadagnarsi una meritata fama: comunque, sebbene il suo nome sia sulla bocca di tutti, la sua musica non può dirsi popolare. La folla canta e ricanta i motivi del Mascagni, del Puccini o del Giordano, ma quando vuol rievocare qualche melodia della prediletta Francesca da Rimini resta imbarazzata. Nessun frammento delle opere di Riccardo Zandonai apparisce nei programmi dei concerti ordinari. Orbene, nella nostra canora Italia, affinché una produzione lirica possa aspirare ad una vita rigogliosa, deve contenere qualche “pezzo” che il pubblico sia in grado di afferrare immediatamente e distaccare dalla compagine del lavoro: legge curiosa ma rigida. Ci sono altresì opere che sono state per così dire rimesse a galla e rimorchiate da una semplice romanza: citiamo la Wally, che deve i nove decimi del suo successo all’aria Ebben, ne andrò lontana e la Madama Butterfly che, dapprima incompresa e maltrattata, è riuscita a vincere le generali diffidenze in virtù della patetica romanza Un bel dì vedremo, trionfante nei salotti borghesi. Ciò premesso, non è da stupirsi se lo Zandonai – lottatore perspicace – abbia tentato nei suoi ultimi lavori di contentare la massa dei frequentatori degli spettacoli lirici cambiando il tono del suo discorso musicale, abolendo le fratture melodiche e rinunziando a quelle minuziose cesellature che rendevano molto caratteristiche le sue prime opere ma che stancavano e persino disorientavano gli ascoltatori meno diligenti e amorevoli. Per diventare 3.1.6/25 più gradito alla folla, il musicista di Giulietta e Romeo non ha esitato a deviare risolutamente verso il melodramma e a valersi dell’elemento popolaresco: la sua melodia, breve e piena di fremiti delicati, è diventata a mano a mano ampia e alquanto enfatica, alla maniera mascagnana. C’è stato, in questo, un reale progresso d’arte? Non oseremo affermarlo: però dobbiamo riconoscere che, mentre la gentilissima Conchita, abbandonata dal pubblico, era ridotta a menare una vita da crittogama, la Giulietta, fastosa ed anche ampollosa, passava da un palcoscenico all’altro e riscuoteva complimenti infiniti. Nei Cavalieri di Ekebù – che sabato sera il magnifico uditorio del “Costanzi” ha acclamato giocondamente – l’adesione dello Zandonai alle forme del melodramma italiano moderno (Fanciulla del West, Isabeau, ecc.) è ben chiara. Ci sono vari “pezzi” nitidamente configurati, conclusi da una cadenza à sensation e seguiti da una pausa per dare al pubblico il tempo di applaudire. Qualcuno di questi pezzi è realmente degno di essere assai applaudito e perciò si può vaticinare un giro fortunato alla nuova opera. La musica dei Cavalieri fluisce egregiamente: non ci sono, nella ponderosa partitura, ombre moleste o asperità irritanti. Il maestro vuol convincere, facendo mostra di una relativa semplicità e cantando l’amore e il dolore con accento esaltato. Ma più che nei brani lirici, ove l’influenza del Mascagni tende a diventare preoccupante, noi lo amiamo in quelli descrittivi, nei “quadretti di genere”, che spesso sono assolutamente deliziosi. Riccardo Zandonai è un colorista originale e sapiente. La sua orchestra ha mille voci e passa senza fatica dalle violenze orgiastiche alle iridescenze idilliache; la sua tavolozza armonica è ricca perché in essa si trova opportunamente mescolato l’antico al moderno ed anche all’ultra-moderno. Ad esempio, nella scena grottesca del teatrino al secondo atto, quando i Cavalieri improvvisano un’orchestrina a base di corni e violini miagolanti, ci sono dissonanze temerarie come in qualche passo del Renard di Strawinski e – si noti bene – l’effetto, lungi dall’essere urtante, risulta singolarmente gradevole. Lo Zandonai, musicista di solida cultura e uomo di teatro dotato di finissimo intuito, sa risolvere quasi tutti i problemi tecnici con una disinvoltura che sbalordisce: soltanto di fronte al problema sentimentale egli resta talora esitante... In complesso, la partitura dei Cavalieri merita un profondo riguardo. Non tutto in essa è oro e neppure argento: non riluce ovunque la fiamma dell’ispirazione geniale, ma ci sono numerose pagine brillanti e melodiche. In qualche momento l’opera diventa addirittura maestosa per il dispiegamento delle massime forze corali e orchestrali. Prima di elencare i passi più felici dei Cavalieri accenneremo ai pregi e ai difetti del libretto che il valoroso Arturo Rossato ha desunto dalla «Leggenda di Giosta Berling» di Selma Lagerlöf. Diciamo anzi tutto che l’aver tentato di condensare in quattro atti e cinque quadri alcuni degli episodi salienti di questo romanzo – alatamente poetico ma tremendamente caleidoscopico e farraginoso – è stata una impresa quasi disperata. Il librettista, per raggiungere l’intento, non ha esitato a eliminare alcuni indimenticabili personaggi della Lagerlöf e a mutare i connotati di altri: l’unica figura che non abbia subìto alterazioni di sorta è quella della “Comandante”: invece “Anna”, costretta a compendiare in se stessa le varie donne amate da Giosta, finisce per non rassomigliare ad alcuna di esse. Peggio anche, Giosta ha perduto l’aspetto che aveva nel romanzo. Egli – il più forte e il più debole degli uomini –, eroico e triviale, superbo e pieno di abnegazione, beone e aggraziato seduttore, vizioso e pur capace di atti di suprema bontà, prete sconsacrato e poeta irresistibile, è diventato nel libretto un semplice tenore che non si stanca mai di cantare in tono di elegia. Il “Sintram” del Rossato – che risulta dalla fusione di “Sintram” e di “Melchiorre”, le due anime perfide della terra di Ekebù – conserva per fortuna il suo carattere originario ed anche la combriccola degli spregiudicati Cavalieri è resa con fedeltà ed evidenza. Ma questi Cavalieri usurpano gran parte del posto che spetterebbe alla “Comandante”, ad “Anna” e a “Giosta”. In effetto, la Comandante al secondo atto diventa una semplice comparsa. La padrona di casa, prima di essere materialmente cacciata fuori della porta (ciò che accade al 3.1.6/26 terzo atto) è già esautorata. Nella Leggenda della scrittrice scandinava la situazione è molto diversa... Comunque, può darsi che il Rossato non sia stato impari al difficile compito assunto. Se il poema drammatico dei Cavalieri di Ekebù manca di spina dorsale, non è povero viceversa di scene interessanti e di scorci pittoreschi. L’azione non languisce mai e qualora il monotono secondo quadro del terzo atto – che ci mostra il vano ritorno di Anna alla casa paterna – fosse tolto o ridotto al minimo e per contro la scena della tragica partenza della Comandante potesse essere sviluppata sino ad acquistare quella solennità di cui difetta nella versione attuale, il libretto acquisterebbe un forte potere di seduzione. Lo Zandonai ha sfruttato con saggezza e circospezione quanto il testo drammatico gli offriva. La descrizione del triste paesaggio nordico invernale è sobria e di ottimo gusto. Il coro delle fanciulle piace per l’onda di benefica melodia che riversa sugli ascoltatori sitibondi; il lungo racconto di Giosta, un po’ viziato di retorica, termina con una indovinata variante del Te Deum e quello della Comandante ha accenti di rude nobiltà. Ottima l’entrata dei Cavalieri: il motivo Vecchia terra d’Ekebù è più da operetta che da dramma lirico ma piace perché plastico, vigorosamente ritmato e orecchiabilissimo. Lo Zandonai ne trae, più d’una volta nel corso del lavoro, effetti impressionanti. Nel secondo atto, a parte la ripresa del coro dei Cavalieri, presentato con lusso di sonorità, non c’è da notare che la scena del teatrino, prima umoristica e poi sentimentale. A parer nostro, l’inizio val meglio che la fine. Giosta ed Anna non riescono a dire nulla di peregrino. Invece i corni stonati dei Cavalieri e gli arabeschi del violino del rapsoda Liecrona si combinano in una sinfonia di acre sapore caricaturale. Il terzo atto comincia squisitamente. I Cavalieri cantano una tenera canzone sul Natale, mentre il violinista improvvisa una melodia in cui si alternano accenti languidi e disegni capricciosi. Qui c’è del sentimento veritiero e perciò comunicativo. Il quadro, blandamente nostalgico, ha un sicuro valore d’arte: rare volte lo Zandonai è stato più ispirato e commosso. La venuta del mefistofelico Sintram, tolti alcuni guizzi orchestrali, non ci reca sorprese e la culminante scena della rivolta dei Cavalieri contro la Comandante e la partenza di costei dalla fucina, per quanto ben condotta, non desta nello spettatore una particolare emozione. Della seconda metà dell’atto abbiamo detto che essa ci sembra superflua o, se non altro, prolissa. Però il motivo che l’orchestra svolge alle parole di Anna: Addio, vorrei tornar dolce e bambina deve esser colto come un asfodelo fiorito in una melanconica radura. L’ultimo atto è ben inquadrato e procede senza soste oziose. La morte della Comandante, mentre la fucina riprende il suo ritmo gagliardo, costituisce un episodio teatrale di prim’ordine. Lo Zandonai ha messo in opera tutti i suoi mezzi di strumentatore. La canzone dei Cavalieri si ripercuote stentorea fra il rombo delle incudini e del maglio. Il brano è vivo, palpitante e di sostanziale originalità. Nessuno può resistere a tanto ardore drammatico e musicale. Infatti, calata la tela sull’ultima scena dell’opera, le ovazioni del pubblico che gremiva la sala del “Costanzi” sono state assai clamorose. Riccardo Zandonai, il librettista Rossato, il direttore d’orchestra Vitale, il maestro Consoli, istruttore del coro e i principali artisti sono stati evocati sette od otto volte al proscenio. In tutto si sono avute circa trenta chiamate, di cui le più spontanee al primo e al quarto atto. Dunque un eccellente successo, che avrà una sicura influenza sul destino teatrale dei Cavalieri. *** Esecuzione unanimemente elogiata per l’equilibrio, il brio e l’esattezza. Lo Zandonai ha espresso con infiammate parole la sua riconoscenza al maestro Edoardo Vitale che, dispensando tesori di ingegno e di operosità, ha compiuto in modo esemplare la concertazione del nuovo lavoro. Il Vitale ha tratto il possibile dall’orchestra poderosa e disciplinata; il primo violino Oscar Zuccarini, nei vari a solo dell’opera, si è comportato da vero maestro. 3.1.6/27 Tra i cantanti, la Bugg ha emerso per la sua grazia soave e per il suo ottimo virtuosismo. Pieno di slancio e sempre invidiabilmente sicuro il tenore Merli, la cui voce ampia e di bellissimo timbro si è mantenuta fresca sino alla fine dello spettacolo, malgrado l’improba fatica sostenuta. Il Parvis è stato come sempre un cantante ed attore di rara potenza. Nella parte della “Comandante” la signora Matilde Blanco-Sadun ha avuto modo di dare novella prova della sua vivace intelligenza. Il Dentale è stato un “Sintram” genialmente malizioso. Lodevoli le parti minori dell’opera: il manipolo dei Cavalieri ha esilarato il pubblico con i suoi atteggiamenti faceti. Coro sontuoso, diretto dal valente e instancabile maestro Consoli; scenari di grande effetto, dovuti alla fervida fantasia del pittore Augusto Carelli e movimento scenico impeccabilmente regolato sotto l’alta guida del comm. Carlo Clausetti. Le repliche dei Cavalieri di Ekebù saranno certamente numerose. La prima è fissata per domani, martedì. 255 Ferruccio Rubbiani, I Cavalieri di Ekebù di Riccardo Zandonai, «La Voce repubblicana», 30.3.1925 - p. 3, col. 1-2-3-4 In un teatro gremito si è data sabato sera la prima rappresentazione della nuova opera di Riccardo Zandonai: I Cavalieri di Ekebù. La cronaca della serata è questa. Al primo atto: un applauso a scena aperta e sette chiamate alla fine, delle quali cinque all’autore e al librettista. Al secondo atto: due applausi a scena aperta e sei chiamate alla fine, delle quali cinque all’autore. Terzo atto: complessivamente nove chiamate, delle quali sei all’autore. Quarto atto: otto chiamate, delle quali quattro all’autore. Adempiuto così all’esattezza della cronaca proverò di dire perché I Cavalieri di Ekebù siano un’opera mancata. Il libretto Arturo Rossato ha tratto l’argomento del libretto da una saga di Selma Lagerlöf intitolata «Gösta Berlings Saga», un libretto che può non piacere per la nostra sensibilità diversa da quella dei popoli nordici – ma è poi vero che la sensibilità sia diversa soltanto perché noi siamo più loquaci e quelli più taciturni? – ma che ha un valore spirituale altissimo. Nientemeno che l’autrice, comprendendo nel suo significato una leggenda passante di bocca in bocca e immortalante con la saggezza del popolo una verità se non denegata misconosciuta dai cosidetti colti, ha preteso di giustificare una tesi di questo genere: non c’è peccato che non [si] redima con l’amore e con il lavoro. Ed è andata a pescare – o meglio il popolo che è saggio l’ha pescato – un peccatore eccezionale: un prete, Gösta è precisamente un prete scacciato dalla sua chiesa e dalla sua comunità per il suo peccato; peccato – notate come sia significativa questa ricerca – di gola ché egli non sa vincere il desiderio di bere. Come si salva? Ridonandosi all’amore di una dolce fanciulla che aveva abbandonata – nei paesi protestanti non è proibito, come è noto, ai preti di amare – e nella incapacità a muoversi di altri sacerdoti coraggiosamente continuatore di un lavoro fecondo malauguratamente interrotto. Il Rossato più che dalla significazione, in verità un po’ difficile, della saga è stato tratto dalla drammaticità degli episodi ed ha costruito il suo libretto su questo difetto iniziale, perché non è possibile in un argomento del genere scindere gli episodi dall’idea che li lega e legandoli li vivifica. Gösta, il prete, è rimasto, ma ahimè! altro che sconsacrato!... Infatti 3.1.6/28 l’autore ha intitolato il libretto: I Cavalieri di Ekebù. Se sono questi i protagonisti, il primo atto serve soltanto per introdurci nel loro regno. È nel primo atto tuttavia che noi veniamo a sapere – non avendo letto la saga di Selma Lagerlöf – come Gösta, ribattezzato in Giosta, sia stato scacciato per il suo peccato di gola dal presbitero, come abbia amata e poi abbandonata Anna e come sia costretto ad andare vagabondando, naufrago della fede, dell’amore e della vita. Caduto sulla neve, ubbriaco fradicio, lo trova, mentre si reca al suo castello, la Comandante, padrona del castello e delle miniere di Ekebù. Lo solleva, lo ridesta, gli fa confessare la sua storia dolorosa e lo invita, per non morire, ad arruolarsi tra i cavalieri che la servono e la temono. Chi sono? Dice la Comandante: «...Raccolgo da quel giorno i deboli e i perduti che Iddio mi manda intorno, dò loro la letizia, la fede ed i piaceri, li chiamo i Cavalieri. Sono i miei Cavalieri»; e più avanti si legge nel libretto, nel momento nel quale Giosta è consacrato cavaliere: «Odi fratello Giosta: da prode Cavaliere - vuoi tu tutta la vita gozzovigliare e bere? - e odiar sempre il lavoro - sedurre le fanciulle e disprezzare l’oro - e morire libero, lieto, ubbriaco e puro - lasciando il cielo al diavolo e il corpo ai lupi?». Tali sono i cavalieri di Ekebù, la canzone dei quali fa crescere le rose sulle squallide miniere dalla bocca sgangherata, seduce le spose della vecchia terra, dà la giovinezza, dà le sonagliere dalla garrula risata. La regina? Una donna che ha amato molto ed ha avuto in dono castello e miniere dal suo amante ed ora vive accanto al marito inconsapevole, fiera, strana e capricciosa. Nel secondo atto siamo dunque in questo regno di lavoro, di orgia e di amore. Giosta è consacrato cavaliere e vi incontra Anna, la fanciulla abbandonata, lì presente per festeggiare il Natale. Trova così l’amore l’occasione per riprendere la sua tela, che troncata del resto non fu mai ad onta delle apparenze e della ostilità del vecchio padre di Anna, Sintram, il quale, irritato, minaccia burla per burla, pianto per pianto, pianto ai cavalieri, pianto alla Comandante. Nel terzo atto la minaccia del vecchio incomincia a realizzarsi. È la notte di Natale. I cavalieri banchettano, sono allegri e bevono, bevono da prodi. Uno di loro piange. Ha male al cuore, tanto male: pensa alla sua casetta laggiù tra le foreste e al suo piccino biondo che attende col Messia il ritorno del padre vagabondo. Invidiato dai compagni che lo lasciano andar via. Ecco Sintram ad interrompere la scena patetica. Pianto alla Comandante, ha minacciato. È lì per farla piangere. Raccontando ai cavalieri la storia del suo amante, egli aggiunge aver stretto un patto con lei per il quale ogni anno, in cambio di fedeltà e di potere, gli viene ceduta l’anima di un cavaliere. Li aizza così contro la Comandante che è scacciata e piange perché vede avverarsi una predizione della vecchia madre che ella un giorno percosse e per cui fu da lei maledetta. Intanto Anna è ricondotta da Giosta alla casa paterna, dove la madre l’attende. Invano! ché Sintram non consente il suo ingresso. Scampata ai lupi – più buoni essi degli uomini o immune lei pel suo talismano d’amore – Anna non troverà scampo se non tra le braccia di Giosta. Cammineremo incontro al nuovo sole sempre così, tenendoci per mano... lontan lontano... e spunteranno viole su dalla terra tepida che odora. Sei la mia aurora, la mia dolce aurora ch’io porterò sempre nel cuore. La minaccia di Sintram si infrange così lungo la via? No. Egli ha detto: Pianto ai cavalieri. Nel quarto atto infatti li troviamo piangenti. Tutti i cavalieri, Anna e Giosta. Che è avvenuto? Poiché la Comandante ha lasciato Ekebù ecco quello che è rimasto. Canta la folla: Cavalieri della morte! Cavalieri del dolore! - Dove siete? Non udite? Siamo il popolo che muore - Le fucine sono spente! La miseria è già alle porte - Non udite, Cavalieri della morte? - Strugge il vento il nostro grano! Strugge il pianto il nostro cuore! - Non udite, non udite, Cavalieri del dolore? - Come voi sperdete i giorni, Dio vi sperda sull’istante - Torni qui la Comandante! Torni la Comandante! - 3.1.6/29 La folla ha capito dunque perfettamente quello che manchi alla vita di Ekebù. Ma perché se la prende allora coi due poveri amanti, Anna e Giosta, facendoli responsabili del disastro? Perché c’è di mezzo il peccato. Sintram ride dunque ancora da lontano, bieco. Anna se n’andrà via da Giosta che vive tra l’amore e il male, sacrificandosi per gli altri. Ma i cavalieri hanno capito che senza la Comandante non valgono nulla e sono disposti a richiamarla. Perché dunque Anna se n’andrà? Ecco che il riso satanico di Sintram si spegne. Il segno che ha chiesto Giosta al cielo viene. L’amore ha redento il peccato. La Comandante ritorna. Stenne [?], sfinita, moribonda, ne ritorna. E perdonata dalla madre sua. Anche lei redenta ritorna strumento di redenzione. «Come mia madre, la mia vecchia madre - posò la mano - su questo capo, ecco la poso anch’io - sul capo vostro. benedetti i baci - nell’amore di Dio. Amate! Amate!» Nella gloria d’amore il lavoro riprende. Le fucine si infocano, il maglio cade, ritorna il ritmo delle opere feconde. Ekebù rivive, mentre la Comandante muore. Eredi del suo regno sono Anna e Giosta. La musica Mi sono sforzato di ridurre ad una certa unità di ispirazione il racconto così come è reso da Arturo Rossato nel suo libretto, per cercare di rendermi conto dell’opera d’arte di Zandonai e per offrire un criterio obbiettivo e sereno di giudizio. Non trovo che l’opera del musicista guadagni ad essere vista così. La frammentarietà del libretto è passata tale e quale nella musica con questa differenza: i frammenti che sono nel libretto valgono poco, quelli che sono nella musica hanno un valore infinitamente superiore. Ma sono frammenti; e come negli episodi ci sono frammenti di cose, nei personaggi ci sono frammenti di uomini. Io non ho l’abitudine di chiedere confessioni estemporanee ad alcun autore perché ritengo prima di tutto che non sia ad esso vantaggioso, in secondo luogo che sia suo compito confessarsi intieramente nella sua opera d’arte e non tra una tazza di thè ed un biscotto. Ma se avessi avuto la fortuna – si dice così! – di incontrare Riccardo Zandonai per una di quelle strade della Roma antica che fanno dimenticare la Roma degli hôtels e dei salotti, perché il silenzio ed i ricordi invitano ad una sincerità immacolata, avrei dovuto chiedergli: Ma voi l’avete letta, maestro, la saga di Selma Lagerlöf? E avendola letta ci avete pensato su? Avete pensato a quello che significhi? Avete pensato che c’è lì dentro, attraverso la ingenuità della creazione popolare, una interpretazione originale del fenomeno, tutto spirituale, della redenzione? Sapete che cosa voglia dire per un prete – e badate che il popolo nella sua leggenda l’ha assunto a simbolo – essere sconsacrato? E sapendolo, avete pensato che Giosta, prete sconfessato per il suo peccato, deve essere riconsacrato dall’amore? Che si tratta cioè veramente di far Dio l’amore? E quel Liutram [sic] come ve lo figurate? Demone o uomo? O demone e uomo? Non avendo avuto la fortuna di incontrare Riccardo Zandonai in luogo tanto propizio alle serene confessioni, ho cercato una risposta alle domande sopradette, ieri sera... No; non è neppure il caso di farlo. La sua comprensione dell’argomento non va oltre più in là di quella del librettista. Non c’è nel libretto il senso della collettività creatrice di ogni leggenda: neppure nella musica c’è. Nessun spiraglio sul mistero per il quale il popolo ha fatto camminare sulle nevi bianche e la figura di Giosta e quella di Anna e quella della Comandante, e quella dei cavalieri. Sintram cos’è? Un padre irato soltanto o qualche cosa di più? Mistero. In un momento egli ha un grido ed un riso satanici, gravidi di avvenimenti. È una lotta che s’inizia; lotta tra chi? Fra un padre burlato ed una figlia caparbia? La posta è sproporzionata, perché la posta è la rovina di Ekebù. Allora è la lotta eterna tra il bene e il male che può assumere, come in questo caso, le forme più legalmente umane, tra la rigidità tradizionale di una morte che non sa perdonare e la libertà dell’amore che perdona e redime. Ebbene nella lotta egli perde. Chi si accorge che abbia lottato? Sarebbe bella che quel grido e 3.1.6/30 quel riso satanici fossero una trovata del bravo basso Dentale, che è del resto un artista intelligentissimo! Discorso non molto diverso si dovrebbe fare sul trionfatore che è Giosta. Intanto non è gran merito e non c’è proprio bisogno di chiamare in soccorso cielo e terra per vincere un nemico quale è Sintram... ma lasciamo andare! A sentire il librettista, Giosta beveva per confortarsi dalla solitudine e dalla tristezza della sua chiesetta e per rispondere a domande di questo genere: non ride il sole? non fioriscono dunque le viole? l’estate, calda di frumenti d’oro, lieta di vento, ebra di stridi e d’ale, non canta più coi miei vent’anni in coro? Non danza più per le sonanti sale, delle campagne, allegre di lavoro? Non so quale pastore di Svezia o di Norvegia si porga tali domande. Ma supponiamo che qui veramente Giosta sia assunto a simbolo, con una significazione più ampia. Non essendogli conteso l’amore, per inserirsi nella vita non aveva che un mezzo: il lavoro, sostanza, nelle molteplicità dei suoi aspetti, della vita stessa. Soltanto in questo modo egli avrebbe potuto riattaccare la sua mistica e religiosa alla complessa esperienza umana. Trascina invece per tutto il dramma la sua vicenda d’amore che avrebbe potuto benissimo concludere nel piccolo presbitero. Al musicista non è parso vero di presentarlo così come glielo ha presentato il librettista. Un momento ha pensato di cambiargli sembiante. Accortosi che le ragioni per le quali il giovane prete si sentiva a disagio nella chiesetta di Bro erano molto tenui, ha cercato di dare al suo petto un più largo respiro, di trasportarlo in un’atmosfera di misticismo nella quale deve pure aver vissuto. Gli fa cantare l’inno alla vita nel ritmo del «Tedeum». Ahimè! ché egli se n’è scordato in seguito! Giosta restando... Giosta di Rossato, quel «Tedeum», trattandosi di un prete protestante, finisce con l’essere una stonatura artistica molto banale. *** Opera allora mancata I Cavalieri di Ekebu? Finché nel giudicare di un’opera d’arte varranno criteri estetici precisi, nessun dubbio che questa sia la peggiore delle opere di Zandonai. Se invece ci si affida a quella certa soddisfazione superficiale per cui si concedono tutte le attenuanti possibili pur di non fare alcuna fatica a cercare le aggravanti, l’opera potrà anche essere giudicata la migliore di quante il musicista trentino abbia composte fin qui. Tutto sta ad intendersi sul criterio col quale giudicare. Io sono d’avviso che una propria logica interna debba guidare ogni opera d’arte. Avendo accennato in principio ai caratteri di frammentarietà de I Cavalieri di Ekebù potrei dire senza timore di contraddirmi che quasi tutti i frammenti possono piacere: il piccolo coro delle fanciulle nel primo atto, la canzone dei cavalieri, il racconto di Giosta, l’altro della Comandante, e i duetti d’amore tra Giosta e Anna, e il coro della folla nell’ultimo atto. La canzone del Natale che i cavalieri cantano nel terzo atto è certo una graziosissima cosa. Questo non vieta tuttavia di dare dell’opera d’arte un giudizio negativo. L’esecuzione Sotto ogni riguardo ottima è stata l’esecuzione. Il maestro Vitale ha collaborato generosamente, con la sua esperienza consumata e la sua intelligenza, con l’autore. Il tenore Merli ha profuso magnificamente la sua voce in una parte di notevoli difficoltà di tessitura. La Bugg è stata un’Anna piena di Passione e di candore, cantando scherzando e sospirando perfettamente. La Sadun, intelligentissima sempre, ha rivelate dolcezze alle quali la sua voce robusta non ci aveva abituati. Il Parvis ha riconfermato le sue doti di signore della scena e della voce, mentre del basso Dentale ho detto più sopra. Dopo aver lodati incondizionatamente i cori e per essi il loro bravo istruttore maestro Consoli, darò una lode speciale ai cavalieri che erano Nardi, Manetto4, Pellegrino, Tega, De 4 sic per Marcotto. 3.1.6/31 Petris, Nsca5, Giusti, Soffiantini, Pastocchi e Freitas. Oscar Zuccarini ha suonato gli a solo del violino con la perizia già nota e Augusto Carelli, con bel lavoro d’arte, ha dipinto le scene. Riccardo Zandonai non può certo rammaricarsi della edizione romana dei suoi Cavalieri di Ekebù! 256 Giulio Marchetti Ferrante, I Cavalieri di Ekebù - Il libretto di Arturo Rossato, «Il Popolo», 29.3.1925 - p. 3, col. 1-2-3-4 M’accinsi a leggere la «Gösta Berlings Saga» di Selma Lagerlöf a Stoccolma, in una sera di alta neve che pareva indicata per un tal libro. Il primo capitolo espone il dramma del giovane pastore luterano Gösta Berling che, in una piccola parrocchia lontana, ha cercato nell’acquavite un farmaco alla propria malinconia e, denunziato il vescovo pel suo vizio, deve in presenza di questi, nella chiesa ove s’affollano i suoi accusatori, pronunciare un’omilia, l’ultima, dopo la quale, com’egli presente, sarà pronunciata la sua condanna. Già si vede vergognosamente scacciato, bandito dal seno della chiesa e pur comincia a parlare. In quell’ora disperata è colto da un’esaltazione inattesa, la sua parola diviene eloquente, il suo pensiero ispirato. Egli si sente sollevato in una sfera trascendentale, il soffitto opprimente del tempio si dischiude offrendogli la visione del cielo, e dimentico di tutto Gösta Berling favella come un veggente. Poi l’estasi dilegua e l’oratore torna a discendere a poco a poco dalle nubi alla regione della realtà, per scoprire innanzi a sé la folla dei suoi giudici penetrata, commossa, decisa al perdono. Non dura però a lungo la conversione di Gösta Berling. Il demone dell’ubbriachezza non tarda qualche settimana dopo a riafferrarlo, ed allora la differita condanna si abbatte più severa sul suo capo. Espulso dalla sua parrocchia perché sconsacrato, egli è ridotto alle condizioni di quei vagabondi che vivono al margine della società, finché una sera – la sera di Natale – batte affranto alla porta di un’osteria sulla strada che conduce al castello di Ekeby, e abbrutitosi con un ultimo bicchiere di liquore, si lascia cadere sulla neve, attendendo la morte. Vedremo in seguito da chi e come Gösta fu salvato, poiché a questo punto comincia l’azione che Arturo Rossato ha rappresentato nel suo dramma lirico, posto in musica da Riccardo Zandonai. Voglio invece ricordare come, alla lettura di quel primo capitolo della «Saga», Selma Lagerlöf mi apparisse come una figlia prediletta di Dostoiewsky. L’incanto non fu però di lunga durata: ho dovuto riprendere il libro non so quante volte, in epoche diverse, e raccogliere tutta la mia perseveranza per giungere alla fine. Una “Saga” non è un romanzo ma una specie di poema in prosa e, come avviene per le epopee, più che di seguito deve esser letta poco alla volta, in episodi. Ne basta uno per accompagnare le lunghe notti iperboree. Pur stabilita una cosiffatta disposizione di spirito, essa non toglie che il genere letterario prescelto da Selma Lagerlöf in questa ed in altre sue opere – cito ad esempio quella che passa per il suo capolavoro, «Jerusalem» – riesca a noi Latini invincibilmente tedioso. La prolissità, le divagazioni di abbellimento, l’estenuante metodo analitico, quel voler esporre tutto, pedantemente, sino all’ultima sillaba senza lasciare alcun compito all’immaginazione del lettore può corrispondere, anzi corrisponde certamente, alla psicologia del lettore nordico, il quale si lascia condurre attraverso le pagine come un docile fanciullo, non alla nostra. 5 sic per Uxa. 3.1.6/32 È una delle principali ragioni per cui gli scrittori scandinavi come Selma Lagerlöf non sono adatti alla mentalità italiana, ed anche più difficilmente possono esser gustati in una traduzione, rimanendo in tal caso spogliati anche di quei pregi di forma che costituiscono un’attrattiva per chi può conoscerli nella lingua originale. Pur trovandomi in questo caso fortunato, non sono riuscito, come dissi, a interessarmi eccessivamente alla «saga di Gösta Berling». Selma Lagerlöf mi piace nelle cose brevi come il suo volumetto delle «Cristus legender», però se devo leggere per divertirmi un libro in lingua svedese preferisco lo stile nervoso e moderno di Heidestamm. *** Mi cagionò pertanto non poca sorpresa l’apprendere che da un lavoro come la «Gösta Berlings Saga» uno scrittore italiano aveva tratto il soggetto di un libretto ed un compositore della notorietà di Riccardo Zandonai l’ispirazione per un’opera lirica. Né le mie perplessità erano infondate. Della “saga” dell’autrice svedese – conosciuta evidentemente di seconda mano, cioè in una mediocre versione – il librettista Arturo Rossato ha rafforzato in modo ingenuo ed arbitrario qualche episodio, svisandola, togliendole quasi ogni rilievo originale. Ha cominciato collo stroppiare i nomi del titolo e dei protagonisti: Ekeby è diventato un Ekebù sonoro come un rullo di tamburi (“by”, pronunciato coll’u francese significa in svedese villaggio), pertanto come chi dicesse Frescoti invece di Frascati. La proprietaria del castello e delle miniere di Ekeby porta secondo l’uso svedese il titolo del marito, il maggiore Samzelius. È la “majorskan”. Questo titolo legittimo, grammaticale nella lingua di Svezia, è tramutato abusivamente in quello buffonesco della “comandante”, Gösta è divenuto Giosta, e così via. La scarsa curiosità del Rossato pei particolari della vita svedese, per citare un esempio fra i tanti, arriva al punto che egli ci ammannisce un agape dei Cavalieri a base di ponce fumante, mentre il ponce svedese, il liquore nazionale altrettanto comune nel paese di Gustavo Adolfo come da noi il vino di Chianti, è una specie di rosolio che si sorseggia freddo, alternandolo con acqua gazzosa gelata. Questi spropositi non costituendo che particolari d’importanza del tutto secondaria, sarei disposto a perdonare al librettista le sue fantastiche falsificazioni del costume, se egli non avesse altro sì rimaneggiato a suo modo l’essenza stessa del soggetto, alterando gli episodi che gli è piaciuto prendere dell’opera originale, con un procedimento che a me sembra artisticamente illecito, poiché v’introduce elementi e situazioni cui l’autore dell’opera originale medesima non ha mai pensato. E ciò è dimostrato dallo svolgimento ch’egli ha dato al suo dramma lirico. *** Abbiamo lasciato Gösta all’osteria presso Ekeby, mentre egli chiede insistentemente altra acquavite. S’odono le sonagliere di una slitta ed entra Sintram, un proprietario dei dintorni, padre di Anna6, la fanciulla che Gösta amò, riamato, ciò che è concesso – com’è noto – ad un pastore luterano. Per la sua bruttezza diabolica, Sintram è comunemente scambiato per Belzebù. Anche Gösta cade nell’errore, e l’altro finge di comprare l’anima sua per poche monete; poi, mentre il presunto demonio si allontana, l’ex prete cade sfinito sulla neve. Ed ecco sopraggiungere uno sciame di fanciulle che si recano al castello per festeggiarvi il Natale. Cantano madrigali, intrecciano carole, perdono le babbucce sulla neve, come se fosse una notte italiana di 6 In realtà, in Lagerlöf Sintram è il padre di un'altra donna. 3.1.6/33 primavera. Fa parte del gruppo Anna, la quale riconosce Gösta, scambia con lui brevi parole di obblio e prosegue il suo cammino. Allo sciagurato non resta davvero che morire. Per sua fortuna si trova a passare la Comandante di Ekeby. Il Rossato ce la presenta così: «ha una pipa di terra in bocca, indossa una corta pelliccia di montone, calza grossi stivali; il manico del coltello le spunta fuori del corpetto, i capelli bianchi coronano il suo volto di bella vecchia». Le cammina al fianco il tetro Samzelius, suo marito. La Comandante fa accogliere Gösta, mezzo assiderato, nell’osteria e gli domanda la sua storia. A sua volta, narra la sua, e in tutto questo non vi sarebbe di criticabile che l’espediente scenicamente infelice di due racconti che si susseguono. Senonché la Comandante rivela a Gösta – ch’è per lei il primo venuto – il terribile segreto del suo onore e della sua vita. Amò un uomo che era povero e dovette partire. Fu costretta a sposare il maggiore Samzelius; l’altro tornò ricco. Ella ne divenne l’amante e ne accettò in eredità il castello e le miniere di Ekeby. Inoltre commise anche un altro peccato: schiaffeggiò sua madre che le rimproverava la sua vergogna, e fu da lei maledetta. Nella «Gösta Berlings Saga» tale segreto, su cui si basa una delle scene culminanti, non è conosciuto che assai più tardi, ma nel libretto la Comandante prova il bisogno di divulgarlo immantinente, scontando in anticipo l’effetto di una interessante situazione ulteriore, e tutto ciò allo scopo... di cantare la sua aria del primo atto. Terminate le sue compromettenti confidenze, la Comandante propone a Gösta di entrare nel novero dei suoi cavalieri. Ella raccoglie i deboli e i perduti che Dio le manda attorno, dà loro la letizia, la fede ed i piaceri, li chiama Cavalieri, i suoi Cavalieri. Gösta rifiuta ma al nome di Anna, che la Comandante gli rammenta, cangia pensiero ed accetta. Irrompe a questo punto sulla scena la gaia schiera dei Cavalieri che intonano la loro caratteristica canzone: Vecchia terra di Ekebù chi fa crescere le rose sulle squallide miniere dalla bocca sgangherata? La canzon dei cavalieri sempre gaia e disperata. Heissan! Heissan! E tutti insieme si avviano al castello. Nel secondo atto ci troviamo appunto in una sala del Castello di Ekeby, ove si prepara una rappresentazione. Gösta ed Anna saranno i protagonisti della commedia. La folla attende impaziente, e mentre le fanciulle finiscono di adornare Anna, Sintram se ne scende per la cappa del camino su cui arde un gran ceppo – inverosimile discesa – e tenta invano di condur via la figlia. Entrano la Comandante, i Cavalieri, gl’invitati. Gösta è presentato solennemente ai suoi undici scioperati e spensierati colleghi, poi è lasciato solo con Anna per preparare la rappresentazione, e ne segue naturalmente un duetto di contrastato amore. Tornano gli altri e la rappresentazione incomincia, accompagnata dall’orchestra grottesca dei cavalieri. Similmente a quanto era accaduto in precedenti melodrammi da «Amleto» ai «Pagliacci», la commedia si muta però in realtà. Il duetto d’amore – il secondo nello stesso atto – diviene appassionato e incalzante, senonché compare il solito guastafeste Sintram e scaglia minaccie e maledizioni. Tutti si allontanano. Rimangono soltanto Anna, Gösta e la Comandante, la quale, non avendo avuto quasi nulla da fare durante quest’atto, invita Gösta a ricondurre la ragazza presso suo padre. 3.1.6/34 Il terzo atto è diviso in due quadri. Ci troviamo dapprima nella fucina di Ekeby, ove i Cavalieri hanno celebrato con larghe libazioni il Natale. Presi da malinconia, cantano una “Ninna-nanna” ed uno di essi, invaso dalla nostalgia della casa abbandonata, chiede ai compagni che lo lascino andar via per farvi ritorno. Mentre gli altri lo dissuadono, presso il fornello sorge la solita figura di Sintram. Questa volta egli ha preso davvero il costume del diavolo, venuto com’egli assicura a rinnovare colla Comandante il contratto mediante il quale quest’ultima gli garantisce annualmente l’anima di uno dei Cavalieri. A tale rivelazione gli ubbriachi divengono furiosi. Chiamano la Comandante, la coprono di insulti e, in presenza del marito, le rinfacciano la storia del suo amante e del dono di Ekeby, storia che gli spettatori conoscono sino dal primo atto ma il consorte della Comandante ignora... perché non si trovava in scena. Costui scaccia allora la moglie, la quale, senza proteste, si rassegna al suo destino e parte. Il secondo quadro raffigura lo spiazzo di una foresta bianca di neve, ove sorge la casa di Anna. Una delle pagine palpitanti della “saga” descrive la corsa notturna di Gösta ed Anna7 nella notte gelida, mentre una torma di lupi affamati insegue la loro slitta ed essi sono sul punto di esser sbranati. Non era possibile rendere liricamente la scena. Assistiamo soltanto al ritorno di Sintram, che trova la moglie sulla porta in attesa di Anna e brutalmente le impone di rientrare nella casa, di cui spranga la porta, annunziando che Anna non tornerà più perché è morta. Anna giunge invece col suo amato e, mentre la logica vorrebbe che si precipitasse, nel suo orgasmo, contro quella porta chiusa impetrando di esser accolta e perdonata, ella si trattiene all’aperto per scambiare con Gösta ancora un duetto d’amore a base di ricordi fanciulleschi. Finalmente si decide a battere. Ahimè, la porta rimane inesorabilmente serrata. Invano ella invoca – ed è questo il punto veramente drammatico dell’opera –, scongiura. Una finestra s’illumina e s’affaccia la madre. Sintram non vuole che ella apra, se vedesse la figlia l’ucciderebbe. Il padre brutale compare infatti, trascina via la moglie e la casa ricade nelle tenebre. Anna sarebbe perduta se Gösta non avesse atteso in disparte. Corre a sollevarla; la porterà con sé: Apri i begli occhi ancora, o della vita mio piccolo fiore. È la grande ora invocata da Dio E Dio ti dona a me. Guarda è l’aurora. *** Il quarto atto ci trasporta nella corte del castello di Ekeby, di cui i cavalieri sono rimasti padroni. Anna pure è là, insieme a Gösta. Tuttavia dalla partenza della Comandante ogni cosa è caduta nell’abbandono e nello squallore. Le fucine son mute, la gente intorno al castello muore di fame e attribuisce tanta jattura al fatto che Anna vive in peccato con Gösta. S’affollano questi miserabili nella corte di Ekeby imprecando, ed anche in questa scena, ch’è una delle più vibranti di umanità, non mi par dubbio che Selma Lagerlöf abbia inteso l’influenza degli scrittori russi. Il Rossato l’ha facilmente riassunta nel suo libretto. 7 Nel romanzo non si tratta di Anna bensì di Marianne Sinclaire. 3.1.6/35 Gösta cerca di placare la folla, i Cavalieri non veggono che un rimedio a tanta sventura: il ritorno della Comandante. Anna vuole anch’essa separarsi dal suo amato, il quale dolorosamente invoca il Signore: Signore! Ascolta! Toglimi la vita o dammi un segno della tua bontà. Il miracolo avviene. Voci confuse e liete annunziano il ritorno della Comandante. Ella entra sorretta dai cavalieri. È sfinita, è morente, ma ha ottenuto il perdono di sua madre e viene a chiuder gli occhi nel suo vecchio Ekeby. Le sue ultime parole sono tutta una invocazione alla pace, al lavoro, all’amore. Ella benedice Gösta ed Anna, poscia domanda perché le fucine non lavorino più. Per uno di quei prodigi riservati ai libretti d’opera, all’istante medesimo si riaccendono le vampe gioiose nei fornelli, il maglio torna a percuotere l’incudine, il lavoro festoso a cantare il suo ritmo. Mentre la canzone dei cavalieri riprende solenne, s’ode un grido: la Comandante di Ekeby è spirata. Così termina il quarto atto che è senza dubbio il più efficace dell’opera. *** Chi ha letto la complessa «Gösta Berlings Saga» può intendere quale pallido riflesso il Rossato, ad onta dei suoi sforzi, sia riuscito a fissarne in questi suoi «Cavalieri di Ekebù». Il suo torto è stato, a parer mio, di aver tentato l’impossibile: i personaggi del suo libretto rimangono ombre scolorite. Solo del gruppo dei Cavalieri, di questi gaudenti e lacrimevoli déracinés, il poeta ci ha presentato uno scorcio fedele, sentito e vigoroso. L’opera era così ardua che non si può essere severi con lui, tanto più che ad onta delle lacune, a dispetto di qualche verso claudicante, egli ha trovato forme molto più colorite ed eleganti di quelle che solitamente ci offre la pedestre mediocrità dei libretti d’opera contemporanei. Auguriamo ad Arturo Rossato di dedicare prossimamente il suo ingegno ad un soggetto che risponda alle sue aspirazioni d’artista meglio che i «Cavalieri di Ekebù». Giudicheremo questa sera l’espressione musicale che ha dato loro Riccardo Zandonai. 257 Giulio Marchetti Ferrante, I Cavalieri di Ekebù di Riccardo Zandonai, «Il Popolo», 31.3.1925 - p. 3, col. 1-2-3 La carriera di Riccardo Zandonai non fu facile né coronata di molte rose. Tralasciando i penosi tentativi della sua giovinezza, può dirsi che anche negli anni più fervidi della sua affermazione d’artista abbiano prevalso le spine. È che Riccardo Zandonai è uno spirito irrequieto, uno di quei musicisti che si sentono attirati verso la luce della perfetta creazione ma devono lottare diuturnamente contro gli ostacoli del volo. Anima sensibile, piena di delicatezze e di gusto, lo Zandonai non ha potuto ancora dispiegare mai queste ali in tutta la loro ampiezza, sia che gli manchino le penne maestre o, come sarei incline a ritenere, la pienezza del respiro. I suoi tentativi, tutti nobilissimi, rivelano il tormento delle aspirazioni di lui. Ma la sfera sublime, quella ove il genio trova la sua piena consacrazione, egli non l’ha ancora raggiunta. L’inizio della sua maturità di operista non avrebbe potuto essere più promettente. I due primi atti della sua «Conchita» (1911), troppo presto dimenticata, racchiudono pur sempre la più felice manifestazione del suo estro. E se il primo atto di «Francesca» (1914), per quanto 3.1.6/36 di genere diverso, sta in pari altezza con quelli di «Conchita», il suo ingegno non si è sollevato di più né si è sensibilmente accostato a quella vetta che sembrava vicina. La colpa, o la fatalità, di questa stasi è insita nell’errore o nella difficoltà dei compositori moderni di saper scegliere un soggetto corrispondente al proprio temperamento. Zandonai non si accorse che la peccatrice crudele e perversa del romanzo di Pierre Louys «La femme et le pantin» o la morbida e svenevole «Francesca» del dramma dannunziano non corrispondevano, per eccesso l’una e per difetto l’altra, alla sua individualità creatrice. Pertanto egli non riuscì a produrre due opere omogenee e complete ma si esaurì in «Conchita» nel perseguire forme eccessivamente vigorose per il suo mite ingegno. In «Francesca», abbandonato il concitato polifonismo della prima opera, si perdé invece in sdolcinature melodiche alla Tosti o in un preziosismo settecentesco, privo però di quella freschezza e fluidità che ha guadagnato in questo ultimo genere così vivo successo al WolffFerrari [sic]. Terzo tentativo, e tentativo di nuovo stile, l’opera «Giulietta e Romeo», costruita tutta artificiosamente, cerebralmente, senza una vera polla sorgiva d’ispirazione e pertanto, a dispetto della perizia tecnica sempre più raffinatasi nel maestro, assai più scarsa di contenuto musicale delle due precedenti sue creature. Quanto abbia contribuito a diminuire l’esito di queste tre prove la mancanza di discernimento nell’adozione dei tre libretti, non è chi non veda. Se a quello di «Conchita» e di «Francesca» può rimproverarsi un’esuberanza di elementi drammatici che lo Zandonai non è stato capace di afferrare ed esprimere, il libretto di «Giulietta e Romeo» è invece, nella sua vacua pretenziosità verbale, spoglio di ogni vibrazione lirica. Lo Zandonai non seppe pertanto in queste opere che plasmare in parte, di scorcio, i suoi personaggi o ridurli, nell’ultimo caso, a pallide e scolorite parvenze cui nessun espediente poteva dare contorni e sostanza. La musica Era da attendersi che, ammaestrato dall’esperienza, il compositore cercasse una materia più adatta per un nuovo tentativo. Chi mi ha usato la cortesia di leggere l’analisi che sabato sera feci su questo foglio del libretto dei «Cavalieri di Ekebù» si chiederà perché mai un artista del valore dello Zandonai sia andato a perdersi in un simile labirinto. Nello scarno libretto che il Rossato ha cercato di trarre dalla prolissa e complicata “saga” di Selma Lagerlöf, per quanto ridotte a pochi accenni, rimangono tuttavia tre diverse situazioni drammatiche che il musicista si trovava costretto a seguire ed a svolgere parallelamente, pure conglomerandole in un unico sfondo: il dramma del prete sconsacrato Giosta Berling colla sua alternativa d’ombre e di luci alla Dostoiewsky, complicato dalla passione dello stesso Giosta e di Anna; il dramma segreto che arrovella il cuore pieno di rimorsi e di coraggiose volontà della Comandante di Ekebù; il dramma, non meno imponente nella sua lacrimevole varietà umana, degli undici Cavalieri, naufraghi della società, ridotti allo stato di parassiti, i quali cercano di dimenticare nei sollazzi la ferita interna di ciascuno, la ruina vergognosa della propria esistenza. In verità era troppo per un estro così tenue come quello di Riccardo Zandonai. Eppertanto egli non è pervenuto che a darci il senso di uno solo di questi drammi, quello dei Cavalieri ch’egli ha espresso in un senso collettivo ma efficace, robusto, originale. I Cavalieri, anzi il gruppo dei Cavalieri, sono i soli personaggi dell’opera che esistano plasticamente, musicalmente. Quando essi intonano la loro caratteristica canzone «Vecchia terra di Ekebù», un fremito passa nell’uditorio, il pubblico prova la sensazione di trovarsi finalmente di fronte a qualche cosa di vivo immezzo al tedio crepuscolare onde il linguaggio degli altri personaggi pervade il resto dell’opera. Nella frase dei Cavalieri squillante con accento vigoroso su quel “sol naturale” fortissimo che scende all’ottava e, con larghe pause, 3.1.6/37 risale e torna a scendere come una ostentazione della fittizia gioia e confessione del buio dolore di quegli spavaldi e pur tristi gaudenti, lo Zandonai ha raggiunto tale espressione del suo valore di musicista che basterebbe quel brano – quello solo – a darci la misura della sua potenzialità. Del resto tutta la parte dei Cavalieri si mantiene costantemente vigorosa, spiccata, omogenea. Pertanto s’accresce in noi lo stupore allorché la raffrontiamo alle altre parti manchevoli dell’opera, poiché non si concepisce come un musicista capace di tanto possa peccare d’ineguaglianze così gravi. Tolta la figurazione musicale dei Cavalieri non rimane nella partitura che qualche episodio pregevole, che attesta qua e là l’eleganza personale del compositore. Quello che anzitutto fa difetto nei «Cavalieri di Ekebù» è l’elemento emotivo. Nei prolissi quattro atti non s’incontra una frase che riesca a toccare le nostre fibre. Anche nei rari punti in cui la drammaticità della situazione è posta in qualche rilievo nel libretto, la musica non perviene ad esprimerla. Cito a caso. Nella scena in cui Anna, innanzi all’uscio inesorabilmente chiuso della casa paterna, invoca la madre, la frase «Mi piegherò sopra il tuo cuore» è tenera ma non straziante. La stessa morte della Comandante all’ultimo atto risulta imponente per l’insieme degli elementi, specie il frastuono della fucina e le grida del coro e dei Cavalieri, fusi in esso in modo stupendo, tuttavia non commuove. E come potrebbe[ro] commuovere quelle ombre evanescenti che sono i personaggi dei «Cavalieri di Ekebù»? Eccettuati, come dissi, i Cavalieri e considerando a parte il convenzionalismo della figura diabolica di Sintram, questi personaggi cantano tutti sullo stesso accento. Basta considerare per persuadercene qualche spunto preso a caso nella riduzione per canto e pianoforte che ho appunto sotto gli occhi (complimenti alla Casa Ricordi per la nitida e bella edizione). Giosta è un tenore innamorato, come potremmo incontrarne in qualsiasi spartito romantico. Dove è la lotta di quest’uomo che celebrò i misteri della fede sull’altare e fu pastore di anime, fra le sue aspirazioni al bene e il suo vizio ripugnante? La virago raffigurata da Selma Lagerlöf nelle sembianze della Comandante è ridotta ad una fugace, pedestre apparizione cui è affidata una parte relativamente secondaria. Nell’atto secondo non si sa che cosa ella stia a fare sulla scena; nel terzo si lascia scacciare con mansueta rassegnazione. Solo nell’ultimo, al momento della morte, acquista un qualche risalto. Anna non offre nulla di caratteristico, né drammaticamente né musicalmente. Al compositore è mancata persino la malizia: avrebbe altrimenti compreso la poca simpatia che dovevano destare sulla scena le figure di un beone e di una vecchia. Dei duetti d’amore è meglio parlare il meno possibile: l’uno è più scialbo, insignificante dell’altro. Nel secondo atto siamo costretti ad udirne due di seguito, ed in essi il plagio ingenuo e certo involontario – ho troppo considerazione per la probità artistica dell’Autore per pensare altrimenti – risulta continuo, poiché l’alterazione di alcune cadenze non basta a mutare il carattere intrinseco di una frase. Verdi, Puccini, Ponchielli, Giordano, Denza, Tosti, Wolff-Ferrari [sic] vi sono profusi a piene mani. Lo stile di Mascagni (Arioso del tenore al primo atto) vi è riprodotto con una identità sorprendente. Le sviolinate dolciastre, le “ninna-nanna” insipide, le dissonanze ricercatamente originali dell’orchestra dei Cavalieri, le leziosaggini delle danze delle “Fanciulle” al primo atto, la banalità del coro di esse al secondo e certi insopportabili lenocini come nella presentazione dei Cavalieri, nella canzone del Diavolo, infine in mezzucci vecchi, stantii delle campane, 3.1.6/38 delle sonagliere, degli arpeggi di “celeste”, pesano inesorabilmente sul bilancio passivo dell’opera. Scarsissime compaiono in essa le frasi di un lungo respiro. Dalla tenuità di poche battute melodiche si passa continuamente ad accenni frammentari che non hanno carattere definito, che non costituiscono neppure il cosidetto declamato musicale. Dànno l’impressione di una ininterrotta ricerca di qualche cosa che il compositore non trova. Ne porge un esempio il quadro dell’agape nell’officina di Ekebù ove il lavoro notevolissimo della tecnica non riesce a dissimulare la povertà del pensiero. Di quando in quando uno sprazzo di luce, come nel coro superbo degli affamati all’ultimo atto, come al finale grandioso, impressionante dell’opera. Quel coro, qual finale, la canzone dei Cavalieri ci dicono che, se neppure questa volta la battaglia è stata vinta, Riccardo Zandonai può accingersi con coraggio ad affrontarne un’altra. Egli possiede la capacità necessaria per compiere un’opera degna del suo ingegno. L’esecuzione È una singolare fortuna per un operista il poter affidare la sua creazione all’ingegno di un direttore come Edoardo Vitale. Oltre la sua perizia grandissima e riconosciuta, egli reca nell’interpretazione di ogni nuovo lavoro – ch’è sempre un’ardua battaglia – una preziosa qualità: le doti generose del suo cuore. Edoardo Vitale cerca con cura fraterna, con paziente studio nell’opera altrui quanto vi può essere di più pregevole perché non rimanga nascosto. Infonde in quest’opera, per quanto è possibile, un calore di vita, una dignità d’arte, in modo da far tesoro di ogni elemento di successo. Conoscitore perfetto degli stili e dei temperamenti musicali, egli indovina per così dire il linguaggio appropriato di ogni composizione: intuito geniale che fu il maggior pregio dei grandi direttori d’orchestra italiani, da Mariani a Faccio a Mancinelli. Chi ha assistito sabato sera alla prima rappresentazione dei «Cavalieri di Ekebù» può essere testimone di quanto Riccardo Zandonai debba ad Edoardo Vitale. E accanto al maestro vanno ricordati, come è giusto, i suoi collaboratori: il De Angelis8, il Consoli, che istruì la massa dei cori, il Ricci, preparatore infaticabile, il quale stabilì l’affiatamento perfetto dei Cavalieri e delle Fanciulle. Infine la meravigliosa orchestra del Costanzi, in seno alla quale si fece notare particolarmente nei «Cavalieri di Ekebù» il violinista Zuccarini. Fra i singoli interpreti il successo principale della serata fu senza dubbio quello riportato dal tenore Francesco Merli, la cui dolce, duttile voce ha infuso nel personaggio di “Giosta Berling” tutto l’accento di passione che esso comportava, data la sua configurazione musicale. Artista intelligente e colto, il Merli si è poi studiato di riprodurre scenicamente l’aspetto del prete sconsacrato cui tormenta il contrasto fra il vizio, l’amore e le migliori aspirazioni. Fu nel primo atto un ubriaco misurato, senza esagerazioni di volgarità; negli atti seguenti l’ardente innamorato che nella passione profonda del suo cuore cerca la redenzione. Dei due applausi a scena aperta che si udirono risonare nella serata, uno andò a lui alla fine del racconto del primo atto, l’altro al coro pieno, impetuoso del secondo. Accanto al Merli diede una nuova prova del suo valore artistico il Parvis, che impersonava “Cristiano”, il duce dei Cavalieri. Il Parvis cercò di mostrarci più che una delle solite figure convenzionali della scena un personaggio caratteristico, vivente. E vi riuscì e, a sua volta, il pubblico apprezzò il suo sforzo. Sara Sadun, indisposta, non si trovava sabato nella pienezza dei suoi mezzi. Doveva inoltre sentirsi sacrificata in una parte così scarsa di risorse come quella della “Comandante”, parte che non le permetteva neppure di far valere la venustà della sua figura. Fece quanto può un’artista del suo valore in un’opera non adatta alla sua voce. 8 Forse lapsus per De Fabritiis. 3.1.6/39 Il continuo alternarsi di due registri in ottava senza, per così dire, note intermedie non poteva risultare a suo favore. Però anche in tali condizioni la Sadun riuscì a farsi applaudire. Non mi sembra di aver trovato in Maddalena Bugg l’interprete ideale della parte dei “Anna”. La sua voce bianca e fredda è risultata in armonia col paesaggio invernale, ma non ha vibrato in corrispondenza al caldo amore di Giosta. L’arte di questa bionda e rosea bambola alsaziana rivela l’artificiosità della scuola scenica francese; noi italiani amiamo più naturalezza e spontaneità. Ciò non significa che la Bugg non meriti elogio, e in particolare per il modo in cui cantò al terzo atto. Il Dentale volle imitare il Parvis, e non a torto. Egli diede anzi troppo rilievo al sinistro personaggio di Sintram. La De Franco si disimpegnò bene nella doppia parte a lei affidata. Né il Julio poteva far di più che mostrarsi in quella del tetro Samzelius. Rammentate le quattro fanciulle, Dorina Tesorieri, Laura Lauri, Margherita Benincori, Gualda Caputo, tributiamo un caloroso elogio ai Cavalieri, impersonati nei signori Nardi (che fu però alquanto lamentoso), Marcotto, Pellegrino, Tega, De Petris, Uxa, Giusti, Soffiantini, Pastocchi, Freitas. Pittoresche le scene per quanto riproducessero, piuttosto che la terra di Svezia, paesaggi di fantasia. Il castello di Ekebù appariva al primo atto somigliante ad un grande albergo svizzero. Anche meno svedesi i costumi. La cronaca della serata, messa la descrizione della sala gremita e sfolgorante, si riassume in poche righe. Alla fine di ciascun atto parecchie chiamate agl’interpreti, al Vitale, allo Zandonai. Il pubblico volle anche salutare i maestri Consoli e Ricci ed il librettista Arturo Rossato. Piacquero soprattutto il finale del primo atto, il coro “in pieno” del secondo, quello degli affamati al quarto ed il finale dell’opera. Complessivamente un successo di stima e di simpatia. 258 Ettore Montanaro, Il successo dei “Cavalieri di Ekebù” di R. Zandonai, «Musica» XIX/7, 15.4.1925 - p. 2, col. 2-3-4 / p. 3, col. 1 Il romanzo che sotto il nome di Leggenda di Giosta Berling corre il mondo dal 1891 vorrebbe essere una specie di epopea nazionale svedese, ed ha come tale tutte le caratteristiche speciali di quel popolo. Ambiente: nebbia, caligine densa, lunghissime notti, tristezza infinita, neve che attutisce i rumori e intorpidisce gli animi. L’ubriachezza che per noi, ricchi di sole, è sordido vizio, per quel popolo è sorgente di calore per il corpo, di fiamma per la fantasia. Le leggende s’intrecciano, si avviluppano alla realtà; realtà ed immaginazione sono talmente fuse da non distinguerle più. Il compito di Arturo Rossato, di togliere cioè da quel groviglio di motivi lirici e drammatici, da quel fluttuare delle narrazioni e delle immagini, situazioni drammatiche che manifestassero forze in conflitto per tesserne un libretto, è stato arduo. Come e perché Riccardo Zandonai abbia poggiato le radici della sua ispirazione su questi elementi per farne sorgere un dramma musicale a noi poco può interessare; interessa solo il fatto che il dramma è sorto rapidamente, e rapidamente parla al pubblico. Questi Cavalieri di Ekebù ci rivelano a priori uno Zandonai tranquillo, sereno e sicuro. Serenità e sicurezza che derivano precisamente da quel processo di maturazione a cui l’artista è giunto, in quest’opera, attraverso un coscienzioso lavoro di riflessioni e di rassodamenti. 3.1.6/40 Con questa ultima e nobile fatica, il M° Zandonai, muovendo speditamente verso una forma di chiarificazione nell’opera, ha saputo raggiungere effetti di squisito sapore lirico, che rivelano in lui l’artista di gusto e l’uomo dotato di un vero senso di teatro. Diciamo uomo di teatro poiché (è dolorosa la constatazione) la schiera degli operisti veri va assottigliandosi sempre più, non so se per fatale decadimento del nostro melodramma che consiglia ai giovani di volgere altrove i loro sforzi o se per un eccesso di ossequi a sistemi cerebro-sentimentali importati da paesi lontani che nulla finora, o quasi, ci dicono – non discuto qui tali idee, saranno magari nobilissime; certo si è che talvolta assistiamo a fenomeni veramente strani se non addirittura pietosi! Né intendiamo affatto pensare che scrivendo oggi per il teatro si debbano fedelmente ricalcare le linee dell’antico melodramma e rimanere imprigionati in tutti i suoi convenzionalismi: non siamo dei reazionari! Molto cammino si è fatto da allora fino ad oggi, e molto ancora – siamo certi – se ne farà; ma chi questo cammino crede di affrettarlo fino al punto di sconvolgere ogni cosa, praticando d’improvviso sistemi del tutto inusitati e mal tollerati per il solo capriccio di volere ad ogni costo fare del nuovo, negando così all’opera di teatro le sue esigenze, per introdurre sul palcoscenico fardelli di elementi estranei, compirà, secondo il nostro modesto parere, fatica vana. Ad un artista dunque quale lo Zandonai, che in questi «Cavalieri» ha saputo con fervida fantasia ideare, disegnare e realizzare con mano esperta quadri densi di situazioni vive, distribuendo laddove si rendeva necessario momenti musicali di tale squisita fattura che lasciano del tutto dimenticare l’irrealismo di cui è manierata l’azione, non si può non riconoscere qualità eminenti che fanno insieme l’uomo di teatro e l’artista nobilissimo. *** Molto lungo sarebbe seguire le vicende di tutta l’opera. Ci limitiamo solo a una rapida ricapitolazione. Al primo atto siamo in una radura nevosa. È sera. Giosta Berling, prete sconsacrato perché dedito al vino, erra vagabondo, accasciato dai fumi dell’alcool e moralmente disfatto per essere stato scacciato dalla chiesa. Deliberato a finirla con la vita, si arresta a spendere le ultime sue monete chiedendo ancora dell’acquavite. Dopo un breve dialogo con l’ostessa, sopraggiunge, annunziato dalle sonagliere, Sintram, essere strano che molti credono sia il diavolo. Giosta, mezzo ubbriaco, lo scambia per Belzebù, vuol vendergli l’anima; Sintram gli getta alcune monete perché beva ancora e si danni e si ammazzi. Scompare. Salgono la collina le fanciulle che vanno al Castello per la festa della notte di Natale, guidate da Anna, la bella figlia di Sintram, la quale scorgendo Giosta buttato in mezzo alla neve vorrebbe indugiarsi presso di lui, ma è condotta via dalle compagne. Qui il M° Zandonai schizza un quadretto lirico di una freschezza sinuosa che rompe l’atmosfera caliginosa. Entra la Comandante delle miniere e del Castello di Ekebù, energica e maschia figura di vecchia che, scorgendo Giosta condannato a morire sulla neve, decide di salvarlo ad ogni costo. Ella racconta le vicende buone e cattive della sua vita, mentre Giosta racconta la triste sua storia per cui è deciso a morire. Ma la Comandante, rievocando la figura di Anna che egli potrebbe rivedere la stessa notte nel suo castello, lo persuade a vivere. Il duetto tra i due procede vivo e serrato, avvolto da un’onda lirica scorrevole che si eleva in certi punti in frasi melodiche di ampio respiro attraverso le quali il maestro vuole e riesce a delineare i due caratteri. Sopraggiunge la matta compagnia dei Cavalieri cantando la loro spensierata canzone, di ottimo sapore popolare. 3.1.6/41 La Comandante presenta loro Giosta, il poeta del Warmland, nuovo cavaliere. Essi lo salutano con il loro grido di esultanza: «Heissan! Heissan!» mentre da lontano traversa la strada Sintram lanciando la sua risata sarcastica. *** Al secondo atto siamo nella sala del Castello di Ekebù in festa. Si prepara la recita di una commedia. Anna triste si abbiglia circondata dalle fanciulle. La scena è resa maggiormente spigliata da un fresco motivo, semplicissimo, in tempo tre ottavi sulla luminosa tonalità di mi maggiore. Si ode il rumoreggiare della folla che attende fuori del Castello e, da lungi, la canzone dei Cavalieri che stanno per giungere. Dopo di che le fanciulle, fattesi coraggio, strappano Anna a Sintram, lo spingono via ed aprono le porte alla folla ed ai Cavalieri, i quali irrompendo nella sala accolgono poi gioiosamente il nuovo cavaliere Giosta, che entra al braccio della Comandante. L’effetto corale, con il rincorrersi dei vari motivi affidati ai singoli gruppi, è ottimo e rivela nell’autore una perizia non comune senza cacciarsi, per questo genere polifonico vocale, nei banchi della scuola. Interessante la musica della presentazione dei Cavalieri, fatta dal Capitano Cristiano a Giosta, con la quale il M° Zandonai sottolinea e caratterizza assai felicemente i vari personaggi. Il nuovo cavaliere è designato a recitare nel teatrino del castello la commedia con Anna, che contiene una scena d’amore. Anna è riluttante, ma è lasciata alcuni momenti sola con Giosta il quale le ripete il suo antico amore che può solo redimerlo. Ella piangente lo respinge: è un maledetto! Tutti ora rientrano e la rappresentazione incomincia. Siamo al momento più saliente dell’atto: il duetto d’amore che l’autore ha costruito solidamente affidando ai due protagonisti frasi di alata fattura, armonizzate magistralmente con la musica grottesca eseguita dai cavalieri i quali con i loro strumenti disposti in orchestrina accompagnano il canto sulla scena. La scena tra i due finisce con un lungo bacio: Anna ammaliata dalle infocate parole d’amore dette da Giosta cede e si abbandona tra le sue pagine [!]; qui scoppia l’uragano: Sintram, entrato silenzioso nella sala, balza su un tavolo e giura, urlando, vendetta contro la Comandante e contro i Cavalieri. La Comandante colpita da un triste presagio impone a Giosta di ricondurre quella notte stessa Anna alla casa paterna. *** Il terzo atto è diviso in due quadri: nel primo siamo nella fucina del Castello di Ekebù; si fa baldoria dai Cavalieri, riuniti a cena per celebrare la notte di Natale. Un punto qui ci piace segnalare: il canto del cavalieri: una nenia nordica, che è fatta di nostalgia e di aspirazione alla bontà. È un canto semplice, schietto, denso di colorito con interludi di violino: una delle pagine più belle scritte dallo Zandonai. *** L’opera si chiude con un quadro su uno sfondo denso di umanità. Le fucine sono deserte; la folla affamata per la carestia che regna in paese dopo la cacciata della Comandante, implora che questa torni a dare lavoro e prosperità. Appare Giosta il quale giura che la Comandante tornerà. Eccola, sorretta dai Cavalieri che l’hanno trovata morente per via. Essa vuole che la vita torni, e come per incanto i fuochi si riaccendono, il maglio riprende il suo ritmo pesante, e mentre i Cavalieri intuonano di nuovo il loro canto, la Comandante muore. L’autore fa qui appello al suo talento di forte operista e riesce a costruire un momento denso di suggestione che desta grande interesse; così l’opera si chiude trionfalmente. 3.1.6/42 *** In linea generale, la musica dello Zandonai si è semplificata rispetto alle sue opere precedenti. Gli spunti descrittivi, le ricercatezze del suo tecnicismo – interessante – hanno lasciato il campo a un discorso melodico e dritto. Egli lascia scorrere l’onda musicale senza frenarla. Forse gli è rimasta in alcuni punti una certa maniera solenne ed accademica nei declamati e certi accenti forzati drammatici. Ma qui tagliamo corto con le osservazioni e gli appunti. L’autore ha salutato i critici con un triplice raglio d’asino in orchestra all’aprirsi del teatrino al secondo atto! È un avviso di cui bisogna tener conto. Zandonai è un grande compositore già da qualche lustro. I Cavalieri di Ekebù sono un’altra nobile manifestazione della sua arte e da lui altre ancora ne attendiamo. *** Lo spettacolo è stato allestito con ogni cura e sfarzo. Il M° Zandonai dovrà essere molto grato al M° Vitale che ha concertato e diretto l’opera prodigandovi affettuosamente tutto il suo altissimo valore, realizzando, nella sua giusta misura da grande direttore quale egli è, tutti gli effetti contenuti nella difficilissima partitura. Il movimento scenico è stato personalmente curato in maniera brillante dal Comm. Clausetti della Casa Ricordi. Agli artisti tutti, che hanno lodevolmente cantato con slancio e impegno l’opera, chiediamo scusa se lo spazio ci obbliga a rinunziare ad una singola segnalazione. 259 Vice, “I Cavalieri di Ekebù” al Costanzi, «Il Tevere», 30.3.1925 - p. 3, col. 1-2 (con un bozzetto di scena e, in sovrimpressione, un ritratto di Zandonai) Della nuova opera di Zandonai che un pubblico compatto ha voluto accogliere lietamente la parte che maggiormente secca è il libretto. La leggenda di Giosta Berling che ha inspirato questi Cavalieri di Ekebù è tutta vaporosa e tenue: i personaggi hanno una inconsistenza fiabesca e le azioni si svolgono come nei libri delle fate, in una atmosfera tutta nebbie che sfalda i contorni e dà ai più inverosimili incontri ed alle più strambe avventure un sapore veramente poetico. Arturo Rossato ha voluto trasformare la leggenda in un episodio qualunque di vita, senza pensare che tutto quel mondo trasportato dal regno dei sogni nella ben definita cerchia di una Ekebù storica sarebbe apparso, nella migliore delle ipotesi, per lo meno ridicolo. E difatti i 12 Cavalieri di Ekebù con quel loro particolare attaccamento agli strumenti musicali ed il grande amore per il vino e l’acquavite assomigliano terribilmente ad uno qualsiasi dei circoli di divertimento che fioriscono nei quartieri popolari di Roma; la Comandante per quanto si sforzi di fumare la pipa e di assumere un tono autoritario non si comprende bene cosa ci stia a fare sulla scena; Sintram ha un brutto e bilioso carattere; Giosta ed Anna poi sono tormentati da una curiosa tristezza e spesso pronunziano parole cupe e disperate. Quale azione possa nascere da simili personaggi non si comprende bene ed infatti le vicende cui assistiamo non hanno nessuna ragione di essere, ché seguono a cause e premesse assolutamente arbitrarie. Per questo allorché sentiamo parlare di morte non riusciamo a prendere la cosa molto sul serio, né ci impressionano le molte parole e le troppe frasi che sentiamo pronunziare durante i quattro atti. Diremo a conclusione che tutto quanto vediamo svolgersi appare così esterno e voluto da non interessare affatto e da apparire anzi terribilmente noioso. La musica che Zandonai ha posto intorno al libretto di Arturo Rossato non si allontana da quei canoni che sono stati dichiarati, non si sa bene da chi, caratteristica del melodramma 3.1.6/43 italiano. Per seguire questi canoni che sono la salvaguardia del nostro più puro tradizionalismo (così dicono alcuni), Riccardo Zandonai si è lanciato a capofitto nel recitativo più aperto e spampanato che si possa immaginare; quando rimangono soli in scena soprano e tenore le urla arriveranno al cielo, gli acuti saranno brillanti e seduttori ma la musica non apparirà mai con i suoi caratteri più veri quali il ritmo e la melodia. Grandi suoni, un grande affaccendarsi lungo le scale diatoniche e cromatiche, un arrampicarsi ed un discendere continuo, così, senza nessuna ragione attraverso tutte le possibilità canore, mai il nascere di una espressione che richiami intorno a sé interesse e simpatia. Questa, a detta di alcuni, è la vera musica italiana, a noi essa appare invece una brutta corruzione del recitativo continuo wagneriano. Nei Cavalieri di Ekebù dominano due elementi: quello cui abbiamo già accennato ed un altro più vivo e meno informe che accompagna i movimenti di masse, gli scherzi delle fanciulle, tutto quello insomma che vorrebbe avere un carattere gaio e spensierato. In questi elementi Zandonai pur non arrivando mai ad assumere un carattere ed uno spirito personale fa pensare alle sue cose migliori quali Conchita ed alcune parti della Francesca: nuoce però la preoccupazione di seguire la vicenda che fa deviare la musica dalla via che dovrebbe percorrere diritta e sicura. Non staremo ad illustrare uno per uno gli episodi musicali del melodramma: diremo solo che vediamo affiorare qualche attimo di vera vita musicale in quei momenti dove dominano gli elementi di colore. E così il coro dei cavalieri nei primo atto ha qualche buon accenno ed il coretto sopra la melodia del violino sa dare una certa commozione musicale; il finale dell’opera invece appare retorico e manierato. A conclusione diremo che «I Cavalieri di Ekebù» ci appaiono nella stessa atmosfera della Giulietta e non segnano certo un passo avanti nell’arte del maestro Zandonai. *** L’esecuzione è stata ottima e tale da essere ascritta a lode dell’impresa del Costanzi. Il maestro Vitale ha curato con grande amore e coscienza la concertazione dell’opera aiutato dal maestro Consoli che ha istruiti i cori con grande perizia e buon gusto. I Cavalieri hanno costituito un gruppo straordinario per affiatamento ed abilità. Loro capo era Taurino Parvis che ha come sempre dimostrata grandissima abilità ed intelligenza, ed i suoi colleghi Nardi, Marcotto, Pellegrino, Tega, De Petris, Uxa, Giusti, Soffiantini, Pastocchi e Freitas hanno ben tenuto il loro posto. La Comandante era la Blanco Sadun che ha fatto di tutto per dare vita ad un personaggio di stoppa, affermandosi come sempre ottima cantante. Giosta ed Anna erano impersonati dal tenore Merli e da Maddalena Bugg e può dirsi che esecutori migliori non era possibile trovarli: i due artisti hanno curato con grande amore la loro parte ed hanno sfoggiato una voce capace di infinite possibilità. Bene la De Franco ed il basso Dentale che era Sintram. Il violinista Zuccarini ha sfoggiato come sempre le sue ottime virtù nella canzona di Liliecrona9. Belle le scene ed i costumi dovuti ad Augusto Carelli. Il successo è stato non molto caloroso ma ha procurato all’autore ed agli interpreti circa venticinque chiamate. 260 9 Propriamente Liecrona: Liljecrona è la dizione che si trova nel romanzo originale di Lagerlöf. 3.1.6/44 I “Cavalieri di Ekebù” n’ajoutent rien à la renommée du maestro Zandonai, styliste prestigieux, «L’Italie», 31.3.1925 - p. 4, col. 5-6 Nous commencerons une fois par la fin, puisque c’est de l’inspiration des décors que nous partirons pour parler du nouvel opéra du maestro Zandonai. Le créateur des scènes a essayé en effet de donner à son œuvre une valeur purement lyrique à travers des jeux de lumières et des rayons bleus, verts et violets. C’est par ces moyens qu'il a réalisé la nuit ne Norvège [!], cette nuit que les livres de écoles élémentaires appellent la “nuit blanche”. Ainsi l’atmosphère est saccagée malgré un effort sérieux et la Norvège n’y gagne rien. C’est seulement dans la seconde partie du troisième acte que l’effet semble un peu mieux saisi, mais il est trop tard. Il en est de même des autres scènes (celle du château qui rappelle trop Moncalieri, qui n’est précisément pas la Norvège). La musique nous a laissé la même impression. La riche instrumentation dont Zandonai a toujours embelli son œuvre est portée ici à ses limites extrèmes et atteint une rare perfection technique: éblouissante pour les technisiens mais qui ne dit rien à l’oreille du profane. L’ensemble en souffre et devient monotone et sans expression, même si de nombreux détails harmoniques peuvent vous intéresser et vous émerveiller. C’est une “stylisation” orchestrale, mais qui n’a qu’un canavas trop mesquin pour s’imposer – ce qui n’empêche pas certains fresques tableaux d’égayer l’esprit. Les sensations parfaitement traduites par la riche sensibilité musicale de Zandonai ont souvent des effets éclatants, mais sans profondeur d’émotion: telle les harmonies imitatives vigoureusement fouillées, le sentiment du grotesque rendu par l’opposition des violons et des cors, l’étincelant tableau des forges, qui dans les cadences rythmiques fait surgir les étincelles du marteau aussi bien à travers l’orchestre que sur la scène, voilà tant de réels bijoux de cet opéra. Mais tout ces éléments se perdent dans la grande ligne de la partition qui ne brise jamais le cadre purement technique. Il faut être des compétents de musique pour s’intéresser à cette partition, pour suivre avec curiosité les étranges combinations des flûtes et des instruments profonds, pour prendre en examen avec un intérêt purement scientifique cette instrumentation mécanique et complexe. Le public ne peut goûter cet effort. Evidemment le maestro Zandonai a accompli un travail des plus difficiles; mais son tort est d’avoir choisi un livret aussi vide et sans âme que les Cavalieri d’Ekebù, dont la réduction (tirée du roman de Selma Lagerloff) nous fait perdre tout respect pour le Prix Nobel accordé à cette œuvre. Ce choix nous étonne d’autant plus que l’histoire italienne offre tant de sujets grandioses à un musicien (et Zandonai l’a vu lui-même avec la Francesca da Rimini, Giulietta e Romeo, Conchita, etc.). Quel besoin de recourir à des légendes sans signification, telle que celle de la commandante? L’effort du maestro Zandonai (de même que celui du metteur en scène) a été énorme, mais sans résultats. Son talent n’en est pas moins éclatant et plein de possibilités étincelantes. –––––L’exécution a été excellente de la part de tous les interprètes, qui ont donné à cet opéra toutes les resources de leur talent. Le maestro Vitale, mis aux prises avec une partition si âpre et si longue, a su s’en tirer avec son habituelle compétence et sa fine intuition musicale. M. Merli a dessiné avec une grande vigueur musicale le rôle de Giosta ed Mme Bugg a chanté avec une ravissante souplesse. Excellente Mme Sadun dans le rôle de la Comandante et plein d’intuition M. Dentale qui a réalisé un Sintram réussi. Tous les autres rôles ont trouvés des interprètes vigoureux et saisissants. Très fêté aussi le Maestro Consoli qui a dirigé les chœurs avec une grande vigueur. 3.1.6/45 Le succès a été chaleureux et le maestro Zandonai a dû se présenter maintes fois à la rampe entouré de ses vaillants interprètes. –––––Assistait S.A.R. le prince héritier, qui a vivement félicité l’auteur. Dans les loges de la Cour nous avons remarqué: amiral Bonaldi, marquise Campanari, don Giuseppe et don Alighiero Giovanelli. Dans la salle on notait de nombreuses personnalités, entre autres le baron Acerbo. On remarquait aussi: marquise Spinola, comte et comtesse Taverna, marquis et marquise Carrega, prince et princesse Borghese, duchesse et Mlle di Roccapiemonte, comte et comtesse Sommi, M. et Mme Masier, Mme Dettori, si élégante dans sa vaporeuse toilette blanc et rose, Mme Arrivabene, comte Piccolomini, Mme Sleiter très fêtée, aussi que la comtesse [R]olli, princesse Ruspoli, comtesse Rossi, Mme Carrettoni, Mme Martinez, princesse Aldobrandini, comte Macchi di Cellere, Mme Zarii, comm. Ravasini, etc. etc. 261 La seconda de “I Cavalieri” al Costanzi, «Il Piccolo», 1.4.1925 - p. 6, col. 2 Iersera, al Costanzi, dinanzi ad una sala affollata di pubblico sceltissimo, si è avuta la seconda dei Cavalieri di Ekebù, la nuova opera del maestro Zandonai. Assisteva allo spettacolo anche Umberto Giordano che si associava agli applausi con vivo fervore. Il successo si è rinnovato nella recita di iersera con lo stesso fervore e con la stessa unanimità di consensi della première; anzi spesso è stato più caloroso e alla fine dell’opera entusiastico. Dopo il racconto del tenore Merli si sono avuti i primi applausi. Alla fine del primo atto che si conclude con il gaio e spavaldo coro dei Cavalieri, tutto il pubblico si abbandona al più schietto entusiasmo. Il maestro Vitale e gli interpreti sono evocati alla ribalta. S’invoca a gran voce l’autore. E Zandonai apparve al proscenio tra il maestro Vitale, la Bugg, il tenore Merli e il baritono Parvis. Si sono avute sette chiamate. Il secondo atto interessa per la vivacità e l’originalità della musica e per la costruzione della scena intonata al grottesco, in cui s’insinua una lieve onda melodica col duetto tra tenore e soprano. La cronaca segna un vivo applauso dopo il potente e fastoso coro a metà dell’atto – e dopo la romanza della Bugg. In fine il maestro Zandonai col Vitale e tutti gli interpreti deve presentarsi alla ribalta sei volte. Del terzo atto il primo quadro, che contiene le più belle e geniali pagine di questa forte e ispirata partitura, impressiona per lo spirito musicale e suscita profonda commozione. Alla fine molti applausi con tre chiamate agl’interpreti e al violinista Oscar Zuccarini che ha reso l’a solo con vera maestria e sommo spirito musicale. Il secondo quadro interessa vivamente per la vicenda drammatica e suscita consenti di ammirazione fra il teenore e il soprano. Alla fine Zandonai ha otto chiamate. L’ultimo atto, costruito così saldamente e pervaso da un senso di umanità, è seguito con intensa attenzione. Dal coro iniziale tutto impeti, attraverso il duetto tra i due amanti e l’addio dolente della Comandante, fino al finale in cui la canzone dei Cavalieri si eleva come un inno mentre la fucina riprende il ritmo del lavoro tra i colpi formidabili di maglio e il festoso battere dei martelli, in una sinfonia di suoni – non una scena passò senza che fosse accolta con favore. Chiusosi il velario, tutta la sala scatta in un’acclamazione che non tende a terminare, tanto che Zandonai è indotto a presentarsi alla ribalta ben sette volte. In ultimo un’ovazione saluta l’operista illustre. 3.1.6/46 L’esecuzione è stata mirabile per valentia dei singoli interpreti e per fusione di tutti gli elementi vocali e orchestrali. Furono perciò ammirati e applauditi la Bugg, la Casazza10, la De Franco, il tenore Merli, il baritono Parvis, il basso Dentale e tutto il gruppo dei Cavalieri. Superbo per slancio e impeccabile per intonazione il coro. Il maestro Edoardo Vitale fu il trionfatore dello spettacolo per la genialità con cui diresse e animò ogni scena. Con il successo di iersera I Cavalieri di Ekebù hanno ormai saldamente e definitivamente assicurata la loro fortuna. [...] 262 Gaffurius, [Vita musicale romana], «Rivista nazionale di musica» VI/187, 3.4.1925 - p. 1035 Il bilancio della prima rappresentazione de I Cavalieri di Ekebù al Costanzi è costituito da 26 o 27 chiamate alla ribalta – oltre 3 applausi a velario levato durante lo spettacolo – all’autore Zandonai, al librettista Rossato e agli interpreti, fra i quali sono stati applauditissimi il tenore Merli, il soprano Bugg, il baritono Parvis, il violinista Oscar Zuccarini, la massa corale ben preparata dal Consoli, la magnifica orchestra e, primo e al disopra di tutti, l’illustre direttore Edoardo Vitale, che ha penetrato e diretto l’opera con sensibilità, sapienza e fraternità artistica tali che qui a Roma si è potuto giudicarla ancora più avvedutamente della Scala, ove Toscanini non era riuscito a dare al secondo atto tutto il rilievo dovuto e possibile, emerso invece con piena efficacia al Costanzi. La Sadun, che può fare sfoggio ancora di belle note centrali e basse, non ci è apparsa a suo agio nella parte della “Comandante”, che richiede il possesso di acuti squillanti e a cui non ha dato il carattere di figura rigorosamente in predominio su tutti gli altri personaggi della leggenda drammatizzata. [...] 263 Adriano Lualdi, “I Cavalieri di Ekebù” di Riccardo Zandonai, «Il Giornale d’Italia», 7.1.1938 - p. 3, col. 3-4 Riascoltata dopo dieci o dodici anni dalla sua prima edizione scaligera, l’opera di Riccardo Zandonai riconferma, in generale, le impressioni già prodotte. Ad esprimere con maggiore fedeltà il senso di lontananza leggendaria, di sogno vicino alla realtà e di realtà vicina al sogno che son proprii della Leggenda di Giosta Berling di Selma Lagerlöf, sarebbe stata utile, nel congegnare il libretto, una maggiore libertà rispetto alle buone regole tradizionali della struttura melodrammatica, più coraggio nel tracciare lo schema della vicenda scenica, meno timore di correre qualche rischio. Nel romanzo della Lagerlöf, l’amore ha certamente una larga parte; ma più nel senso dello spazio che in quello della profondità. Non sono i fatti amorosi che, nel libro, più ci hanno preso e interessato e commosso. Ci ha colpito, bensì, il forte odore di acquavite – “l’odore ambiente” –, le credenze popolari, gli intermezzi lirici, i costumi paesani, quei Cavalieri di Ekebù che sono zingari ma attaccati alla loro terra; guasconi ma incapaci di generosità e di eroismo; scavezzacolli ma pieni di scrupoli; «avventurieri, ragazzacci da frustare», come li considera la Comandante, ma non indegni di perdono. Gli episodi d’amore sono molti, ma non di grande rilievo: sembrano narrati più per dimostrare un fondo di rettitudine in tutti questi personaggi dalle apparenze spregiudicate che per magnificare l’onnipotente forza della 10 Non si comprende se la citazione (unica in tutti gli articoli consultati) di Elvira Casazza in questa produzione sia da considerarsi una svista da parte dell'articolista o se segnali una eventuale sostituzione della titolare avvenuta in una delle repliche. 3.1.6/47 passione amorosa. Nella Leggenda, gli affetti familiari hanno quasi più importanza, a giudicare dai fatti. E tutto in essa si svolge in un mondo fantasmagorico, vicino, più che al romanzo, al poema. Al teatro fuori della tradizione di cui, dato l’ingegno del compositore e quello del librettista, avremmo forse potuto avere un bel saggio; al teatro più lontano dalle abitudini del pubblico ma più prossimo alle ragioni dell’arte e più vicino allo spirito della leggenda, lo Zandonai ha preferito il teatro della tradizione e degli schemi e dei motivi scenici più comuni. Alcuni episodi sono stati scelti da lui e dal Rossato come base dell’azione; i personaggi ridotti notevolmente nel numero e alcuni fusi in uno solo; l’amore di Giosta e Anna eretto a nucleo e legame della vicenda teatrale. Quanto ai Cavalieri, essi ci appaiono quasi soltanto dal lato festaiolo, sì che quando la Comandante invita Giosta ad entrare nella decurie dei suoi protetti parlando di “redenzione” non si capisce bene di quale redenzione parli. Sinclair e Sintram del romanzo divengono, nel libretto, una persona sola: Sintram, il quale però è Mefistofele per due; la Comandante rimane, nel trapasso dal libro alla scena, molto fedele all’originale; Cristiano e Anna sono, tra le figure secondarie, le più vive. *** Il senso del teatro, l’estro decorativo, la ricerca della chiarezza e della semplicità nel modo di esprimersi musicalmente sono le qualità che meglio risaltano in questo spartito di Riccardo Zandonai. Tolto molto opportunamente il secondo quadro del terzo atto, che nella prima edizione milanese era apparso del tutto pleonastico sia dal punto di vista drammatico che da quello musicale; alleggerita qualche altra scena, l’opera mantiene desto l’interesse dello spettatore, sia per la varietà e quel che c’è di colorito nel suo tessuto musicale che per la relativa speditezza del suo procedere: relativa perché non giova ad essa quel molto che c’è di retorico e di enfaticamente stantio in più di una scena e in più di una situazione. La cosa più notevole della partitura è, a mio modo di vedere, la scena iniziale del terzo atto, di Liecrona con i Cavalieri. Liecrona suona sul violino una canzone nostalgica e i Cavalieri rispondono in coro, sommessamente. Il brano, e specialmente quello corale che ha l’andamento e il potere suggestivo di un antico canto di popolo, è non solo d’effetto ma veramente bello. Il più bello di tutto lo spartito. Negli altri atti c’è da ricordare la scena delle fanciulle, nel primo, convenzionale ma non priva di grazia, il racconto della Comandante, l’arrivo dei Cavalieri, di sicuro effetto. Nel secondo, il fresco e grazioso inizio della rappresentazione nel teatrino e la scena dell’apparizione di Sintram, condotte con molta abilità. Nell’ultimo, la prima scena e quella che segue, fra Cristiano e i Cavalieri, e la fine dell’opera, quando la Comandante muore tra il frastuono dell’officina nella quale ricomincia a pulsare il ritmo del lavoro: pagina di poesia e di indubbia efficacia. *** Ottima è stata l’esecuzione di insieme offertaci da Tullio Serafin di quest’opera. L’orchestra ha suonato magnificamente sotto la sua bacchetta animata e vibrante: è stata potente nelle grandi sonorità, delicatissima nelle pieghe liriche. L’insieme dello spettacolo ha recato ancora una volta il segno della grande aristocrazia artistica del suo primo animatore. Benissimo ha cantato il coro istruito dal M.o Canca [sic], bene si sono portati gli artisti nel loro complesso: più lodevoli come insieme però, per la sicurezza e la cura e la serietà dello studio di cui hanno dato prova, che per le qualità individuali che alcuni hanno mostrato. La signorina Giuseppina Sani, la Comandante, a parte l’impostazione gutturale che toglie volume e metallo alla voce e chiarezza e forza alla dizione, ha eseguito come meglio ha potuto la sua parte; ma certo non le ha dato quella autorità e quella energia di accenti che sarebbero state necessarie. Al polo opposto, il baritono Benvenuto Franci, Cristiano, che dispone di quei ricchi e sicuri mezzi vocali che da tempo ammiriamo, ha forse ecceduto in violenza. bene ha reso, però, il carattere del personaggio. Lodevole è stato José Luccioni nella 3.1.6/48 lunga faticosa parte di Giosta Berling. Egli ha dimostrato ricchezza e forza di mezzi vocali, ha avuto una dizione abbastanza chiara, è stato scenicamente assai efficace. Molto bene anche la signorina Pia Tassinari nella parte di Anna, alla quale, sia col canto che con la scena, ha conferito un appropriato carattere di poesia. Benissimo il Romito nel personaggio di Sintram, per voce e scena; eccellente Alessio De Paolis, Liecrona, che nella prima scena del terzo atto è stato, oltre che pregevole cantante, attore perfetto nell’episodio della violinata. Benissimo tutti gli altri: il Pacini, la Dubbini, il Marucci, il Bianchi, il Titta, il Giusti, il Mazziotti, il Romano, lo Sbalchiero, il Conti, il Taddei. Discrete le scene su bozzetti di Giorgio Quaroni dipinte da E. Polidori, ma specialmente la prima e l’ultima di un carattere novecento che legava male coi costumi di Veniero Colasanti pretto 1930: precisazione di epoca che, dato il libretto, sarebbe forse stato meglio non sottolineare. Il successo dello spettacolo è stato molto caloroso, con cinque o sei chiamate alla fine di ogni atto a tutti gli artisti, al M.o Serafin, all’autore, al regista Piccinato e al Colasanti. 264 Mario Rinaldi, I Cavalieri di Ekebù al Teatro Reale dell’Opera, «La Tribuna», 7.1.1938 - p. 3, col. 2-3 Il dramma lirico I Cavalieri di Ekebù fu tratto, da Arturo Rossato, dalla Leggenda di Gösta Berling di Selma Lagerlöf, vincitrice del premio Nobel per l’anno 1909. Sarebbe nostro dovere esaminare se tanto il Rossato quanto lo Zandonai abbiano interpretato a dovere il pensiero della illustre scrittrice; ma il lavoro non è nuovo. Ci limiteremo perciò a fare poche considerazioni di carattere generale. Zandonai, lo si è detto mille volte, è un romantico, ma il romanticismo, nel Cavalieri di Ekebù, non si manifesta tanto nel lato amoroso quanto in quello fantastico. La leggenda originale esigeva questo. In Francesca e in Giulietta tutto è avvolto nell’amore, in quest’opera invece tutto è pervaso di mistero. La Comandante è soltanto apparentemente l’animatrice dell’azione; ma sopra di lei, nell’ombra, c’è il genio malefico di Sintram. E questi ha una certa parentela con Samiel, il “Cacciatore nero” del Freischutz [sic]. Romanticismo... Nei Cavalieri di Ekebù le parti d’assieme sono nettamente superiori agli a soli e ai duetti. Basterebbe citare, per convincersene, l’allegra masnada dei buontemponi ospitati e sfamati dalla Comandante. L’amore tra Anna e Giosta può interessare, ma non appassiona e non avvince. Chiunque altro avrebbe portato in primo piano questa coppia sfortunata e felice. Zandonai invece ha preferito dare un carattere ad ogni singolo personaggio, imprimere un colore ad ogni atto. La prova evidente di questa affermazione ce la forniscono principalmente la figura della Comandante e tutto il terzo quadro. Senza l’aiuto di temi e di astruserie orchestrali il musicista ha impresso alla parte della donna un carattere di superiorità che la leggenda originale esigeva. Nell’assistere al terzo atto – compatto, organico, ardito nella concezione – ci sono venuti alla mente i nomi di Velasquez e di van Tilborgh: così Borodine, nel descriverci nel suo Principe Igor le orgie di Galinski, non ha attinto da diversa fonte. Dovremmo ancora ricordare l’entrata delle donne al primo quadro, l’apparizione dei cavalieri con il loro festoso inno, l’appassionata rappresentazione del secondo atto, la morte della Comandante, ma lo spazio ce lo vieta. L’opera ha certamente i suoi difetti, qua e là manca d’ispirazione, al primo atto procede un po’ indecisa, ma nel complesso appare quale produzione d’un musicista esperto, padrone dell’orchestra e conoscitore del teatro. Abbiamo ragione di ritenere, inoltre, che Zandonai 3.1.6/49 sarebbe stato ancora più convincente se il Rossato avesse saputo cogliere con più grande evidenza le parti di maggior effetto del testo originale. L’interpretazione dell’opera da parte del maestro Tullio Serafin è stata felicissima: coloriti perfettamente impastati, sonorità ben dosate, slanci sicuri ed efficaci. La massa orchestrale ha secondato il suo direttore con encomiabile accortezza. Nella difficile parte della Comandante si è fatta ben notare, per la sua intensa drammaticità, Giuseppina Sani, la quale ha suscitato emozione ed impressione nei due quadri della partenza dal castello e della morte. Gentile e amorosa si è rivelata ancora una volta Pia Tassinari (Anna) che ha avuto momenti di estrema dolcezza, particolarmente nel duetto del secondo atto. Il tenore José Luccioni ha dato tutto se stesso nella parte di Giosta: ci è molto piaciuto, nella bella scena del primo quadro, sia come cantante che come attore. Benvenuto Franci conosce a meraviglia la parte di Cristiano: ieri sera attirò più volte su di sé l’attenzione del pubblico; il suo canto è sempre generoso e la sua dizione è sempre chiarissima. Nella terrificante parte di Sintram abbiamo applaudito Filippo Romito, artista non troppo noto a Roma, ma che qualcuno ricorderà in una avvincente esecuzione del Boris al Teatro Quirino. Il Romito – beato lui – sta sul palcoscenico come in casa propria e vanta una voce forte e ben timbrata. Una parola di lode va anche diretta ad Alessandro [sic] de Paolis che è stato cantante e... violinista di prim’ordine: molti spettatori hanno avuto la precisa sensazione che fosse lui a suonare l’istrumento di Paganini, ma dietro le quinte, invece, c’era il professor Rovere che... pensava al resto. Ricordiamo inoltre il Pacini e la Dubbini e il gruppo dei Cavalieri. Ottimo il coro diretto dal Conca e suggestivi, con caratteri di sana novità, i bozzetti scenici di Giorgio Quaroni, realizzati dal Polidori; additiamo in modo particolare la desolante scena del primo atto e il colorito quadro della fucina al terzo. Ricchi, vari e pittoreschi i costumi di Veniero Colasanti. Efficace e brillante la regìa del Piccinato, il quale ha impresso un carattere di personalità al bellissimo quadro della notte di Natale. Tullio Serafin e i suoi collaboratori sono stati fatti segno a numerose chiamate alla ribalta; si è anche presentato Riccardo Zandonai che il pubblico romano ha riveduto e applaudito con vero piacere. 265 Notte d’Epifania «... Appena si spensero le luci in sala per l’inizio del quarto atto, le signore incominciarono nel buio a manovrare cautamente le mani sotto gli abiti preziosi, senza distogliere l’interesse dallo spettacolo. Si udiva un fruscio di sete e di rasi che sembrava un mormorio di primavera. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte: le signore pian piano si sfilarono una calza che con una spilla od un fermaglio di brillanti venne assicurata al davanzale del palco o al bracciolo della poltrona. Poi, nella sala, si stabilì un’aria di trepida attesa. Quando si riaccesero le lampade, era mezzanotte e un quarto: la Befana era passata a cavallo alla sua scopa e le calze erano colme di gioielli, di conti della sarta pagati, di buoni per ascoltare gratuitamente le voci di Gigli e di Lauri Volpi, della Cigna o della Tassinari... Era la befana offerta dai cavalieri, non di Ekebù, ma dai cavalieri e commendatori che avevano accompagnato iersera al Reale le rispettive splendenti consorti, la befana offerta dalla direzione del magico Teatro alle sue belle fedeli. Con piccole grida di gioia, le calze ricolme vennero ritirate dalle proprietarie che giubilando e applaudendo si affrettarono all’uscita con una calza alla gamba e l’altra in mano come se avessero fatto la spesa al mercato delle meraviglie. Belle e luccicanti come fate, le signore iersera meritavano simili doni e avevan diritto di credere ancora al sogno nutrito in una non troppo lontana fanciullezza...». 3.1.6/50 Invece non è stato così. Non è accaduto nulla di tutto ciò: cavalieri, commendatori e direzione del teatro non hanno riempito nessuna calza. Chi crede più alle favole ed ai miti dell’infanzia? Chi. 266 m[atteo] i[ncagliati], I Cavalieri di Ekebù di Riccardo Zandonai, «Il Messaggero», 6.1.1938 p. 5, col. 3-4 I Cavalieri di Ekebù di Riccardo Zandonai non venivano riprodotti sulle nostre massime scene da diciassette11 anni. Nel farne ritorno, è parso che la lunga assenza sia da addebitarsi a un errore di miopia. Perché un’opera come questa, di tale e tanta spiccata originalità, meritava di essere tenuta d’occhio. I quattro atti – e duole che in questa edizione sia stato soppresso quello del Natale, di così profonda e sentita nostalgia – rappresentano tanti distinti ambienti, ché in ognuno di essi l’autore ha saputo trovare un clima di evidente suggestione, clima che è generato da una sensibilità in stato di commozione, di grazia. Appunto, per ciò, tutta l’opera è segnata da uno spirito e da una fantasia di schietta profondità espressiva e figurativa. V’ha in essa un tale slancio drammatico e una tale effusione di lirismo che può ben dirsi che tutta l’opera si elevi a un grado di eccellenza psicologica e teatrale. Ed era compito codesto ben difficile a tradurre in forma, se si pensa che la favola si svolge in terra straniera, nella Svezia, in un’epoca lontana. Ora con i ritmi e il colore, opportunamente ideati e sviluppati, i Cavalieri di Ekebù hanno un vibrante risalto sia nella struttura sia nelle oasi di profonda incisione sulle fonti o sulle tenere emozioni suggerite dalla vicenda. E sono incisioni di schietta [e] ardita fantasia. Nella scena del “teatrino” al secondo atto, il lirismo zandonaiano culmina nella maggiore espansività; ed è forse, dei quadri con il richiamo della musica antica, sottolineata da tutto un substrato di modernità, il più caratteristico. Senza dire degli altri quadri, è da mettere in chiaro questo: che nei Cavalieri di Ekebù Zandonai ha raggiunto il giusto equilibrio tra gli elementi della scena e quelli dell’orchestra, e, secondo le opportune incidenze sceniche, con tale misura che emerge ora l’uno ora l’altro. Sotto l’aspetto dei vivaci contrasti si notano, egualmente disciplinati, il pittoresco, lo spirito drammatico, quello descrittivo, quello lirico. A un’opera così complessa, Tullio Serafin, che già l’aveva diretta al Metropolitan di New York, ha prodigato tutta l’energia della sua maestria, tutto lo spirito della sua fantasia, tutta l’effusione della sua tempra d’artista. Si è riconosciuto iersera una vigorosa commossa dedizione nel nobile intento di portare al successo l’opera, un tale equilibrato slancio drammatico e un tale abbandono di verace lirismo, che è parso suo scopo precipuo d’infondere ai Cavalieri di Ekebù una risorgente vita scenica. Primeggiò sulla scena il baritono Benvenuto Franci che al finale primo sfoggiò con ardita espressività le ampie folgoranti note del registro alto; e poi nel secondo atto modulò il canto a dolcezza di mezza voce, attraverso una incisività di sillabazione in particolar modo lodevole. Ché questo grande artista segue i precetti del suo glorioso maestro, Toto Cotogni, che gl’insegnò che a ben cantare bisogna mettere in valore la parola, l’accento, la espressività. Senza di che è come cantare in un imbuto. Facendo onore al prezioso insegnamento il Franci disegnò e animò la figura di Cristiano con tocchi di potente rilievo e con gradassi atteggiamenti. Nella figura complessa e arditamente espressiva della Comandante, Giuseppina Sani cantò con tutti i moti di un’anima in tumulto: bella, armoniosa voce, squillante e di bel colore nelle 11 In realtà tredici. 3.1.6/51 note acute, e sillabazione incisiva. È da aggiungere che all’efficacia del canto, ella associò uno spirito interpretativo di eccezionale rilievo. Fu dunque una Comandante che scolpì il personaggio, e con la voce di questo concorse a esprimere con potente risalto i vari agitati stati d’animo. Pia Tassinari cantò nel secondo atto con dolcezza e effusione di caldo lirismo. Il tenore José Luccioni s’infervorò, emettendo forti acuti, nei punti drammatici, ma la sua voce difetta di quei chiaroscuri che valgono a dar varietà di colori al canto. Il basso-baritono Filippo Romito conferì alla sua parte incisività d’accenti. Con responsabilità assolsero il compito loro tutti gli altri: Adolfo Pacini, Alessio de Paolis, Agnese Dubbini, Millo Marucci, Mario Bianchi, Enzo Titta, Blando Giusti, Nino Mazziotti, Salvatore Romano, Bruno Sbalchiero, Gino Conti e Giuseppe Taddei. Il coro, istruito dal valoroso infaticabile maestro Giuseppe Conca, cantò con intonazione e con bell’accento, e con fusione colorita, recando all’opera il concorso di una efficace collaborazione. La messa in scena, affidata a Carlo Piccinato, fu intonata all’ambiente; e ben distribuite, pittoresche apparvero le figurazioni della massa corale. Pericle Ansaldo, con quella sua versatilità così pronta e agile, parve assurgere a un deus ex machina della complessità dell’allestimento scenico. Il maestro Luigi [parte illeggibile] festa di colori, i costumi, su figurini del Colasanti. Cronaca lieta: molti intensi applausi a fine di ogni atto con circa venticinque chiamate complessive al Serafin, agli interpreti di canto e all’autore, festeggiato e acclamato. 267 L[uigi] C[olacicchi], “I Cavalieri di Ekebù” di Riccardo Zandonai, «Il Popolo di Roma», 6.1.1938 - p. 5, col. 6-7 Fra gli operisti italiani viventi, per così dire, a grande tiratura, Riccardo Zandonai è il più giovane ma non il meno quotato. Non lo battono in popolarità che i maestri della “giovane scuola” Mascagni e Giordano, e, fino a un certo punto, Cilèa. Ma Zandonai sembra a molti il più “moderno” di tutti, il più aggiornato tecnicamente, e insieme il continuatore di una tradizione che, partendosi da Wagner e dai veristi, giunge fino a noi senza urtare negli scogli dell’“avanguardia” contemporanea. Zandonai ha insomma un suo pubblico che vede in lui il genuino rappresentante della modernità bene intesa. Ecco, per l’appunto: la “Sana modernità”. Zandonai è precisamente l’operista della “sana modernità”; che sa trattare con scaltrezza l’orchestra, arricchendola di tutti i ritrovati della più avanzata strumentazione, nel mentre sa esprimersi melodicamente mediante un linguaggio fra passionale e sensuale, fra enfatico e raffinato, che ricorda in qualche modo il verismo e il wagnerismo, senza che sia né l’uno né l’altro, e senza tuttavia che riesca a definirsi con caratteri fortemente personali. È esso un linguaggio, comunque, non privo di commozione, che è quanto dire di facoltà liriche; specie quando descrive sentimenti torbidi o repressi o indistinti, oppure certe atmosfere grigie e malsane. Non è il linguaggio della gioia e del luminoso amore, come c’insegnano «Francesca», «Giuliano» e «Giulietta e Romeo»; e ben lo definì il Rossi Doria allorché trovò che “anche l’accordo perfetto di do maggiore non suona gioioso o compiutamente sereno. Vi si ha sempre il dubbio di sottintesi...”. Quando infatti questa musicalità si schiarisce e si alleggerisce, ossia nella «Farsa amorosa», si ha un altro Zandonai, meno autentico anche se più fresco e grazioso. Da quanto si è detto, è facile immaginare che il soggetto tra fiabesco e allucinato dei «Cavalieri di Ekebù», che ben potrebbero chiamarsi cavalieri di Belzebù per quel clima diabolico che alita intorno ad essi e alla loro Comandante, è un soggetto tipicamente zandonaiano. E invero ci sembra che il nostro compositore vi abbia trovato materia 3.1.6/52 sufficiente per farvi risaltare la sua natura; una materia così fosca opaca pesante, che al musicista non ha concesso che raramente di abbandonarsi a quei voli melodici violenti quanto esteriori che si notano invece di frequente in «Giulietta e Romeo» e più ancora in «Giuliano». In «Ekebù» la vena sarà forse meno ricca e densa che in queste opere e in «Francesca»; ma nei «Cavalieri di Ekebù» ci pare di scorgere una maggiore nobiltà di linea, un composto equilibrio di tutti i suoi elementi teatrali e musicali. Per certi motivi di ambiente, per certa compattezza di forza descrittiva, per certi interventi corali, per certo martellamento ritmico scoperto o sotterraneo, i «Cavalieri di Ekebù» ci fanno pensare un poco al «Dibuk»12, meno realizzato. Vogliamo dire che ci troviamo pressappoco sullo stesso piano operistico con personaggi dalla psicologia complessa e insondabile, avvolta nelle nebbie dell’alcool o nelle brume di un passato procelloso. Si tratta naturalmente di impressioni fugaci, suscitate più che altro da analogie momentanee, e alle quali non vorremmo si desse troppo peso. Resta comunque il fatto che, pur con mezzi musicali più modesti delle altre sue opere, vale a dire con minore ricchezza e slancio di melodia, i «Cavalieri di Ekebù» sprigionano egualmente un certo potere emotivo: più sensibile, ben inteso, quando siano valori di pura musicalità ad assorbire e dominare il dramma. In questi casi la felice impressione che può destare il buon taglio d’una scena, l’accostamento di due episodi contrastanti, l’abile distribuzione del colore ambientale, è fatta più viva e immediata dal riflesso che tali coefficienti di teatralità hanno nella musica. Come avviene, ad esempio, nel finale corale del primo atto in cui il tema ritmico dei Cavalieri si afferma imperiosamente, nel finale lirico del secondo, tenero, sentito e notturno come i più toccanti momenti di «Francesca», nel coro a voci sole del terzo, trapunto dagli svolazzi d’un violino, nel duetto di Giosta e Anna dell’ultimo atto e nel ritorno della Comandante, pure di quest’atto. Il finale dell’opera, con la ripresa del lavoro al ritmo delle incudini, è invece alquanto esteriore, e ci sembra che non adempia nemmeno alla sua funzione teatrale. Opera complessa e difficile, i «Cavalieri di Ekebù» offrono numerose possibilità di spettacolo. E l’allestimento che ne ha curato ieri il Teatro Reale dell’Opera è stato dei più adeguati che si potesse desiderare, e senza dubbio uno dei più attraenti dell’attuale stagione. Efficientissima la realizzazione musicale, affidata a Tullio Serafin, che ha penetrato a fondo lo spirito della partitura, mettendone in luce ogni elemento vocale o strumentale che avesse una sua ragione di particolare rilievo. Efficientissima anche per la partecipazione di cantanti valorosi e appropriati quali Giuseppina Sani, che è stata una Comandante di risorse ragguardevoli, dalla voce adatta a quel personaggio e in ispecie dal gioco scenico plastico, possente, efficacissimo, che denota un’intelligenza interpretativa di prim’ordine; Pia Tassinari, in Anna, che è il personaggio lirico femminile, aderente e commovente; José Luccioni, Giosta, ieri sera in pieno possesso dei suoi robusti mezzi canori come non mai; e Benvenuto Franci, il sempre possente Franci dalla voce di bronzo, semplicemente perfetto nel Capitano dei Cavalieri. Assai bene anche Filippo Romito. A una simile efficienza musicale ha infine portato il suo contributo il coro istruito dal maestro Conca: un coro che ha molto da lavorare, ed ha assolto egregiamente il suo compito, risultando intonato e vigoroso. Quanto alla parte scenica dello spettacolo, vi hanno cooperato il regista Carlo Piccinato, che ha trovato nella molteplicità dei quadri d’insieme, di cui l’opera abbonda, materia adatta alla sua sensibilità e alle sue possibilità di affreschista pittoresco; lo scenografo Giorgio Quaroni i cui bozzetti realizzati dal Polidori sono parsi indovinati soprattutto nel primo e nell’ultimo atto: questo, che rappresenta l’officina e il cortile del castello di Ekebù immerso in una luce livida da miniera nordica; e finalmente il direttore dell’allestimento Pericle 12 Opera di Ludovico Rocca (1934). 3.1.6/53 Ansaldo, che ha offerto un’ennesima prova della sua fertilità in fatto di trovate sceniche e di “meccanismi” d’ogni sorta. Lo spettacolo, al quale assisteva un pubblico numerosissimo, è stato accolto da crescente successo, concretatosi in venti chiamate complessive all’autore, ai cantanti, al maestro Serafin e al regista. 268 Vice, “I Cavalieri di Ekebù” di R. Zandonai al Teatro Reale dell’Opera, «Il Tevere», 67.1.1938 - p. 3, col. 4-5 La leggenda di Gösta Berling di Selma Lagerlow [sic] che nell’adattamento librettistico di Arturo Rossato ispirava l’estro di Riccardo Zandonai (1925) subito dopo Giulietta e Romeo (1922), è tornata dopo tredici anni a rivivere sulle scene del Teatro Reale, sotto la direzione di Tullio Serafin. La strana Comandante delle miniere di Ekebù con lo scudiscio in mano e la pipa in bocca, l’amore di un ex-prete sognatore e bevitore di acquavite per la bionda figlia di un uomo-demonio, il fare grottesco dei Cavalieri minatori, gli urli di una folla fanatica imprecante contro il pastore evangelico amante, possono attrarre ed entusiasmare il popolo svedese che attraverso quelle figure rivede i personaggi tipici delle leggende nazionali, non noi mediterranei che dallo spirito di quelle leggende siamo molto lontani, pronti ad entusiasmarci invece per ben altri episodi, in cui la passione umana, innanzi tutto, trovi motivi più adeguatamente realistici per esplodere e giustificarsi, sia pure in tema di leggenda. Facendo dunque astrazione dall’episodio romanzesco e fermando l’attenzione sulla parte musicale, bisogna riconoscere che il maestro trentino ha intuìto perfettamente lo spirito drammatico del libretto e l’ha ritratto con mano sicura, dando ad un’azione così frammentaria una unità di costruzione che la sorregge ed inquadra nei confini dell’opera in musica. La stessa scena romantica della commedia – teatro nel teatro – che si svolge nel castello di Ekebù è incastonata così meravigliosamente nel secondo atto dell’opera da formare con quello un tutto organico. È questa, senza dubbio, la pagina più bella dello spartito, nella quale, attraverso l’amore dei giovani amanti, lo Zandonai rivela il suo temperamento caldo e appassionato quale era già apparso in Francesca e in Giulietta. Il contrasto tra la musica dei Cavalieri – la parte finta della commedia – e la musica dei protagonisti – la parte reale della commedia stessa – è reso con tale potenza espressiva e con tale unità di stile da far pensare ad un vero miracolo di tecnicismo musicale. Se la parte episodica dei Cavalieri di Ekebù e l’assenza di una vicenda drammatica più intensamente umana – e quindi musicale – potrebbe consentire un’attenuante sulla rarità delle rappresentazioni dell’opera nei teatri nazionali, non così invece il lato artistico dell’opera medesima, che rivela una costruzione solida e vitale per una chiara impronta di originalità che il compositore ha saputo dare alla sua melodia. *** Tullio Serafin ha condotto l’orchestra con robusta animazione, penetrando la partitura con animo sempre aderente allo spirito caricaturale, poetico e drammatico della nordica leggenda. Pia Tassinari ha interpretato la parte di Anna con appassionato fervore e con voce sicura e pieghevole ad ogni effetto. José Luccioni ha dato molta enfasi alla parte del pastore evangelico (Gösta) supplendo così alla debolezza del registro medio della sua voce. Ha espresso il racconto al primo atto con esuberanza passionale e la dichiarazione amorosa nel duetto del secondo atto con impeto drammatico. Giuseppina Sani nella difficile parte della Comandante si è rivelata un’artista ricca di risorse interpretative, benché la voce non possegga potenti vibrazioni sonore. Superiore ad ogni elogio Benvenuto Franci che nella veste di Cristiano ha sostenuto la duplice parte caricaturale e drammatica dando ad ognuna un 3.1.6/54 potente efficace risalto. Anche Filippo Romito nella veste di Sintram si è fatto molto ammirare per la chiara dizione e la voce ampia e sicura. Una lode ad Alessio De Paolis che, oltre a confermare le sue notevoli qualità di cantante, ci ha dato l’illusione perfetta di un abile violinista. Al coro istruito dal maestro Conca spetta un particolare elogio. Gli applausi numerosi alla fine di ogni atto, rivolti al maestro Serafin e agli interpreti, sono divenuti più intensi e calorosi quando al proscenio è comparso il maestro Zandonai. 269 Giorgio Prosperi, “I Cavalieri di Ekebù” di Zandonai al Teatro dell’Opera, «Il Piccolo», 6.1.1938 - p. 3, col. 7 Il maggior titolo di merito di quest’opera è senza dubbio quello d’aver imposto trionfalmente in vari paesi il nome di un musicista italiano; da Riga a Stoccolma, dove essa è considerata ormai come opera nazionale. Sotto questo punto di vista la nostra gratitudine verso lo Zandonai è veramente vivissima; l’illustre maestro tuttavia non ce ne vorrà se continuiamo a preferire la sua Francesca e la sua Giulietta, le quali assieme ad una quantità innegabilmente superiore di invenzione musicale realizzano un clima secondo noi più affine allo spirito dell’autore. La leggenda nordica, con la uniformità dei suoi ghiacci e delle sue nebbie e il fuoco nascosto dei suoi diavoli, si fonde dolcemente al tepore mediterraneo, senza crolli e senza sussulti; più d’una volta il dramma prende il sopravvento sulla musica, scendendo più in giù del recitativo fino al declamato: e qui certo niente di male; ma il gelo del fiordo assidera i contrasti sentimentali fino a risolverli per naturale liquefazione. Tuttavia, se non proprio l’unghia del genio, senti qua e là l’esperienza e la classe: il finale del maglio è uno strumento scenico di prim’ordine. Il primo coro dei cavalieri non manca di potenza e di effetto. Occorrerebbe forse, per valutare tutto nella sua giusta misura, una esecuzione eccezionale sotto ogni punto di vista; quella di iersera fu purtroppo solo normale, che non è poco date le difficoltà della partitura; ma non è nemmeno moltissimo. Il tenore Luccioni, attore eccellente disciplinato, volonterosissimo, possiede una voce di ottimo timbro ma di eccessiva uniformità: i suoi interventi si somigliano tutti, senza distensione [?]; Pia Tassinari e Benvenuto Franci furono le due figure più a posto: ottima voce, ottima scena specie il Franci che la dominò in lungo e in largo col canto e coi movimenti; Giuseppina Sani, che dispone di mezzi senza dubbio adattissimi alla figura di Comandante, attese gran parte del primo e del secondo atto per metterli totalmente in valore; Filippo Romito, Sintram, alternò momenti di pieno convincimento a qualche ritardo dell’azione sul canto. Eccellente sotto ogni punto di vista fu la compagine dei Cavalieri e delle Fanciulle. In compenso di qualche perdonabile incertezza nella schiera dei protagonisti, registriamo invece stavolta con piena soddisfazione il perfetto allestimento dello spettacolo. Eccellenti le scene del Quaroni, specie quelle del primo ed ultimo atto, d’un lievissimo senso fiabesco; ben inquadrata ed equilibrata la regìa di Piccinato; il maestro Tullio Serafin fu il consueto forte trascinatore del complesso vocale e orchestrale. In complesso uno spettacolo più che soddisfacente, che il pubblico mostrò di gradire sinceramente, se si considerano i numerosissimi applausi e le calorose manifestazioni di simpatia tributate personalmente all’autore. 270 Francesco Mecheri, “I Cavalieri di Ekebù” triomphent au Royal dans une admirable édition, «L’Italie», 7.1.1938 - p. 1, col. 1-2-3-4 3.1.6/55 Devant un public d’exception, la Direction du Royal nous a présenté hier une édition superbe de ces «Cavalieri di Ekebù» du maestro Riccardo Zandonai, opéra qu'on avait le tort d’oublier pendant trop de temps, puisqu’il ne parissaît plus sur nos scènes depuis dix-sept13 années. Certes, le livret que l’illustre compositeur de Rovereto a choisi pour l’enrichir de notes suggestives – et que le poète Arturo Rossato a tiré avec un sens aigu d’une légende norvégienne [!] de Selma Lagerlöf – présente des difficultés insurmontables, tellement il reste loin de notre sensibilité latine. Car les personnages qui vivent cette espèce de “saga”, même s’ils sont campés avec une vigueur puissante, nous laissent en général indifférents pour tout ce qu’ils font, et bien rarement arrivent à nous émouvoir. Comment pourrait-on admettre chez nous qu’un ivrogne tel que ce malheureux Gösta Berling puisse frapper le cœur d’une âme câline et douce, de cette Anna – la figure la mieux réussie du drame? C’est vrai qu'avant d’arriver à un tel état de compréhension, il y a entre les deux – au deuxième acte, dans la scène du “teatrino” – un dialogue dont il serait injuste de ne pas reconnaître la ravissante chaleur. Et puis, dans cet acte nous trouvons un Gösta admirablement transformé par les soins de cette curieuse héroïne qu'est la “Commandante”. Mais tout cela est-il suffisant pour enflammer d’amour une jeune fille si pure et rêveuse? Nous nous permettons de ne pas le croire. Et ces drôles de types que sont ces chevaliers, ne vous paraissent-ils pas assez ingrats envers leur bénéficatrice – car, au fond, ils sont des ratés – lorsqu'ils l’insultent et la menacent de mort, jusqu'au point de la forcer à abandonner le champ? Nous estimons vivement à cet égard que l’œuvre de rédemption entreprise par cette Commandante – qui, d’ailleurs, est une femme dans le vrai sens du mot, et non pas une sainte – ne peut pas avoir fait d’eux des êtres séraphiques, capables de la renier au moment où ils connaissent l’origine de toutes ses richesses. Nous ne voyons en eux que des ingrats! Et pour l’admiration que nous avons pour le réalisme sur la scène, nous préférons de ne pas vous parler de cette ignoble figure de Sintram, le père d’Anna – le personnage le plus obscur que nous ayons jamais vu – qui nous fait tout simplement rire, tellement son apparition soudaine en diable nous laisse au troisième acte incrédules. L’unique belle scène du drame – nous entendons le drame en prose, non le livret de M. Rossato, qui d’une matière si âpre a tiré un vrai “miracle” d’adaptation lyrique – reste à notre avis la mort de la Commandante. Ici, enfin, nous nous trouvons en présence de personnages humains: ici nous commençons à comprendre la beauté trop cachée de cette œuvre. Un peu tard, si l’on veut! Le sujet donc est d’une froideur glaciale. Tout autre musicien que M. Zandonai n’y aurait pas vu son affaire. Mais notre illustre compositeur s’est senti plus sûr que les autres, a fait la tentative et avec ses mélodies harmonieuses et fougueuses en même temps a sauvé l’opéra. Il y a, en effet, dans cette partition, des pages d’une beauté supérieure, où vous pouvez facilement vous apercevoir jusqu'à quel haut degré peut arriver la veine inépuisable d’un musicien de génie. En M. Zandonai – nous sommes heureux de le constater une fois de plus – plusieurs talents sont réunis ensemble. Car non seulement ce maestro a une sensibilité particulière au point de vue mélodique, mais il est aussi un symphoniste d’une puissance unique et de même un savant polyphoniste. En outre, il connait à la perfection l’orchestre et sait quels miracles on peut avoir de tour instruments, soit seul soit à l’unisson. 13 Cfr. nota 11. 3.1.6/56 Quelques pages, telles que la “Chanson des Chevaliers” au premier acte, le duo d’amour entre Gösta et Anna au deuxième, l’invective des Chevaliers et la réponse de la Commandante au troisième, et enfin la sublime scène le ma Mort de celle-ci, ne peuvent d’aucune façon laisser indifférent tout esprit doué d’un minimum de sensibilité, mais au contraire enthousiasment ceux qui comprennent les vraies beautés d’une musique originale et toujours chaude ed émouvante. L’exécution que le Royal nous a offerte nous a parue digne de son nom. Mme Giuseppina Sani a été une Commandante douée d’une énergie virile et a chanté constamment avec un équilibre propre de sa haute classe; Mme [!] Luccioni a été de son côté un Gösta efficace et riche en expressions romanesques et dramatiques. Mme Pia Tassinari a donné une nouvelle preuve de son talent multiforme d’artiste consciente de sa noble mission. Nous ne pouvons absolument dire aucun bien de M. Franci, qui n’a fait que crier et gesticuler d’une façon horrible, sans jamais donner l’impression d’avoir pénétré le rôle qu'on lui avait confié. M. Tullio Serafini [sic] a dirigé les “Cavalieri” avec le zèle qui lui est habituel et qui fait de lui la meilleure baguette que nous ayons désormais chez nous. M. Carlo Piccinato a été un régisseur qui a bien mérité nos louanges. Dignes d’éloges sont aussi les décors de M. Polidori et les costumes sur manchettes de M. Colasanti. L’auteur a été évoqué plusieurs fois à la rampe avec les interprètes et les autres organisateurs de cette belle soirée. [...] 271 Mario Rinaldi, [La musica a Roma - Teatro Reale dell’Opera], «Rassegna dorica» IX/4, 20.2.1938 - p. 69 Riccardo Zandonai è tornato al Teatro Reale con i Cavalieri di Ekebù, opera che non si rappresentava a Roma da vario tempo ma che possiede pagine di valore come quella della recita al 2° atto e come tutto il 3° atto che, nel suo complesso, forma un quadro di interesse musicale non comune. Il romanticismo dello Zandonai si palesa in questo lavoro più nel lato fantastico che in quello sentimentale e questo va a onore dell’autore il quale avrebbe certamente meglio espresso musicalmente il romanzo originale se il Rossato avesse compiuto una rifusione più fedele. Ottima l’esecuzione diretta con calore dal Serafin. Sono stati applauditi la Sani, la Tassinari, il Luccioni e il Franci. 272 Renzo Rossellini, I Cavalieri di Ekebù, «Il Messaggero», 15.1.1954 - p. 3, col. 7-8-9 (con una foto di Gianna Pederzini in costume di scena) Esiste anche il “caso Zandonai”: quello di un compositore, ossia, che aveva tutti i titoli e tutte le qualità per essere uno dei provvidi continuatori della tradizione operistica italiana. A venticinque anni era già un autore noto: con il «Grillo del focolare», sua prima fatica, più ancora con «Conchita», si era rivelato musicista agguerrito, di idee personali, d’un fiuto teatrale infallibile. A ventotto anni Zandonai già dava il suo capolavoro: la «Francesca da Rimini», che è una grande opera, una delle più belle dei nostri tempi. Poi, pur con alterna fortuna ma sempre con maestria di linguaggio, vennero altri spartiti a testimoniare la ricchezza inventiva del compositore. Ebbe sostenitori autorevoli, amici fervidi, un editore che 3.1.6/57 credette in lui; le sue opere stavano già entrando nella coscienza e nel gusto del pubblico, quando, a poco a poco, ogni cosa rientrò nell’ambito della normalità, si andò sbiadendo il nome che aveva suscitato sicure speranze, vivaci interessi. Ecco il “caso Zandonai”: rientra come un modellino, aderisce come uno stampo a tutti gli aspetti della crisi teatrale italiana. La decadenza di Zandonai cominciò di colpo appena si modificarono le strutture organizzative del nostro teatro, quando dalla iniziativa privata si passò a forme differenti di amministrazione, dove gli interventi presero altra fisionomia, nuovi criteri si sostituirono a quelli esistenti e l’individuo soggiacque alla collettività. Da allora, nel nostro teatro, la confusione dei valori, con la conseguenza – che proprio gli autori contemporanei maggiormente soffrirono – di livellare ogni nome, ogni opera, di rendere tutto indifferente al pubblico e molte cose spesso intollerabili. Il fatto più deprecabile nel campo dell’arte è la politica del contentino, quella politica che, attraverso la “rotazione” indiscriminata di opere e di autori, senza tenere in debito conto il valore, è divenuta la pericolosa regola dei nostri teatri. Lunga premessa per venire a parlare dei «Cavalieri di Ekebù» e che varrebbe per non poche opere del repertorio moderno italiano. Perché, appunto, uno spartito come questo, che dovrebbe normalmente familiarizzare col pubblico, rappresenta invece un avvenimento di carattere sporadico, sul quale si possono ancora accendere delle discussioni. Da un consuntivo tanto magro il critico è costretto a trarre argomento per la sua azione divulgatrice, nella speranza sempre che le cose finiscano per modificarsi nel senso indicato dalla giustizia. Ed eccoci dunque a parlare di un lavoro che ha una lunga ed anche gloriosa storia, ormai ignorata. Settimo dei lavori teatrali di Riccardo Zandonai, lo spartito dei «Cavalieri di Ekebù» vide la luce al Teatro alla Scala nel 1925, sotto la direzione di Arturo Toscanini che ne fu il primo, genialissimo interprete. L’argomento dell’opera, ricavato da un famoso romanzo di Selma Lagerlof [sic] – la «Leggenda di Gösta Berling» – se presentava da un lato alcune lacune nella caratterizzazione e fisionomia dei personaggi, a volte contraddittori nei loro sentimenti, offriva al musicista larghe possibilità per cementare, in una partitura di grande impegno coloristico, la somma delle sue esperienze di uomo di teatro e di sinfonista. I «Cavalieri di Ekebù» furono per il loro autore una cosciente prova delle proprie forze, un tentativo ponderato e risoluto di dare un nuovo impulso, pur conservando le linee tradizionali di una espressione fondata sul canto, al melodramma italiano. La volontà di allargare gli orizzonti delle vedute teatrali è evidente: la scrittura si fa intensa e complessa di elementi fioriti dalle più certe esperienze della musica del tempo. Una coralità che quasi potrebbe dirsi alla Moussorgsky, alimentata da un sinfonismo che sembra distillato dalle migliori vinacce straussiane, prepara il tessuto sonoro sul quale va ad impiantarsi il canto, d’una coerenza e di una schiettezza tipicamente nostrane. Gli aspetti salienti e vari del teatro musicale moderno sono dunque riassunti nel tentativo estremo di cementarli attraverso una concezione unitaria dell’opera lirica. Impresa degna di un musicista che preferiva ai facili successi del conformismo i rischi e le incognite di un cammino solitario, da percorrere con passo ardito fino alla mèta. Il valore dei «Cavalieri di Ekebù» è tutto qui: possono i personaggi dell’opera, attenuati dalle poetiche nebbie di questa saga nordica, essere più o meno conseguenti, diciamo anche più o meno simpatici, quindi comunicativi al gran pubblico, può l’azione risultare distante dalla sensibilità realistica del nostro mondo, ma la musica si afferma e si espande con un vigore straordinario, esprime la certezza dei sentimenti, il calore di un umano, sentito linguaggio. Trascorrono le ore dello spettacolo piacevoli e rapide: l’interesse non langue mai, l’emozione arricchisce le suggestioni che scaturiscono dalla coloritissima partitura. E poi bastano la scena del “Teatrino”, il Natale dei Cavalieri, la morte della Comandante a garantire la ricchezza dell’opera, il suo diritto alla vita. 3.1.6/58 Esecuzione amorevole, appassionata, convinta: a cominciare dal maestro Oliviero De Fabritiis, che è stato un concertatore stupendo della complessa partitura, un animatore intelligente, sensibile ed ispirato dello spettacolo, tutti gli interpreti hanno soddisfatto la complessità dei ruoli loro affidati. Gianna Pederzini nella parte della “Comandante” che è figura preminente dell’opera, ha offerto un’altra suggestiva prova del suo talento drammatico, della sua dedizione all’arte: è stata felice in ogni gesto e per ogni accento. La giovane Rina Malatrasi ha cantato con calorosa emozione ed ha avuto emissioni di bello smalto e sicura musicalità. Pieno di dignità vocale il tenore Mirto Picchi; efficaci per la gustosa caratterizzazione dei personaggi il Malaspina ed il Cassinelli. Il coro ha magistralmente cantato: il merito del suo vigoroso intervento va anche all’autorevole istruttore maestro Giuseppe Conca. Successo caloroso, con applausi a scena aperta, numerose chiamate al termine di ciascun atto. 273 Guido Pannain, I cavalieri di Ekebù di Riccardo Zandonai, «Il Tempo», 15.1.1954 - p. 3, col. 8-9 Nella vita artistica di Riccardo Zandonai, il periodo che segue immediatamente la Francesca da Rimini segna un momento di particolare disagio. L’artista, che nel teatro lirico aveva mostrato di poter dire una sua parola schietta, avrebbe dovuto raccogliersi, attendere, meditare. Invece fu trascinato ad operare da interessi pratici e professionali che sono, per definizione, contrastanti con quelli dell’arte. Così che, d’allora in poi, egli si trovò in perenne conflitto con se stesso: l’anima d’artista ch’era in lui, tolta alla tranquillità della contemplazione e spinta ad attingere méte a cui repugnava; l’uomo di teatro, il professionista del teatro, vòlto alla ricerca di risultati utilitari, in ogni caso estranei alla sfera dell’arte. I Cavalieri di Ekebù risentono di questo interiore e drammatico disagio. È un’opera sostanzialmente mancata perché manca d’interiore necessità, ma è insieme ricca di pregi musicali. E questa non sembri una contraddizione, perché l’artista ch’era nel fondo, pur sonnecchiando (quandoque bonus...) non poteva mancare di essere vigile e presente ad attingere, a tratti, risultati considerevoli. Nel modo in cui fu ridotta a opera di teatro, la Leggenda di Giosta Berling diventa un dramma incoerente. I personaggi e le situazioni che hanno luogo per loro hanno una vita scenica priva di nessi e di spirituale consistenza. Ognuno va per conto suo e nessuno trova la via di un’adeguata rappresentazione. La Comandante ha un suo dramma, che è un dramma morale, e Anna e Giosta anche ne hanno uno proprio, che è un dramma di amore. Tra questi due drammi, messi l’uno accanto all’altro senza ragione estetica, non c’è rapporto: o meglio ce n’è uno, ma in superficie, artificioso e distaccato, che non incide sull’anima onde il personaggio rimane sospeso nel vuoto, senza vita, come un manichino. Le faccende della Comandante non interessano Anna e Giosta e viceversa; e non interessano, cioè non commuovono, lo spettatore e neppure il musicista. Anzi, meno di tutti il musicista; come altra volta, invece, lo avevano interessato e commosso il travaglio nevropatico di Conchita e «la pietà dei duo cognati» che, grazie alla musica, si configurarono in dramma. E andrei anche un tantino indietro perché del buono c’è anche nella dimenticata Melenis. Ora è appunto il musicista, nei Cavalieri di Ekebù, che, più avveduto dell’uomo di teatro, non si lascia fuorviare dalla falsa retorica librettistica e, abilmente aggirandola, volge la sua attenzione al particolare e all’episodio e se lo lavora con innamorata raffinatezza di artefice. Così elabora un tessuto orchestrale di tale efficace sobrietà e colorita varietà da valere di modello e d’insegnamento. E venne fuori un canovaccio di episòdi deliziosi quali l’inizio dell’opera, degno della tavolozza di Rimsky-Korsakof; la pittoresca scena della 3.1.6/59 rappresentazione nel Castello di Ekebù, con la stupenda intuizione timbrica d’un violino che s’inserisce armonicamente fra timbri eterogenei; il Coro del Natale, anch’esso cullato al suono del violino di Liecrona (pensare che il librettista l’aveva chiamato «il suon delle budella conce»!); il tragico coro del derelitto popolo di Ekebù al quarto atto, sorretto da uno svolgimento sinfonico di singolare ampiezza. Invece quanta retorica nell’amoroso sgolarsi di Giosta e Anna, quanta precarietà di atteggiamenti nella parte della Comandante, quale vacuità d’accenti nell’esibirsi di un preteso diavolo che né meno nel cuore dell’indulgentissimo Papini, credo, troverebbe clemenza. L’opera di Zandonai ha avuto, al Teatro dell’Opera, un’accuratissima e forbita esecuzione soprattutto per quanto riguarda la concertazione e la direzione del maestro Oliviero De Fabritiis che, secondato dalla valorosa orchestra, ha presentato la mirabile partitura in tutta la sua cesellata raffinatezza. Gianna Pederzini è stata, nella parte della Comandante, la vigorosa attrice che abbiamo sempre ammirata. Sempre opportuna di atteggiamento e di pronunzia, guardatela, al finale, disfatta e morente, come ella appare trasfigurata. La parte di Giosta ha trovato nella voce di Mirto Picchi accenti puri e generosi, e il basso Antonio Cassinelli ha fatto il possibile per dare consistenza al diabolico Sintram, con robustezza vocale di raro pregio. Esuberante Cristiano il baritono Malaspina; opportunamente intonato Mariano Caruso nella parte di Liecrona. Per non turbare l’armonia delle lodi dovrei tacere della parte di Anna, affidata a Rina Malatrasi, un sopranino dalla voce diseguale e sgradevole. Del coro basterà dire che è stato istruito dal maestro Conca. 274 Nino Piccinelli, Nevi di Svezia sulle avventure dei “Cavalieri” - L’opera di Riccardo Zandonai ha avuto sulle scene romane la superba interpretazione di Gianna Pederzini, «Momento Sera», 16.1.1954 - p. 3, col. 6-7-8-9 (con un disegno che ritrae G. Pederzini nel ruolo della Comandante) Dal romanzo della scrittrice svedese Selma Lagerlöf, La Saga di Gösta Berling, Arturo Rossato trasse il libretto dei Cavalieri di Ekebù, mentre Riccardo Zandonai diede espressione musicale alla poesia nostalgica della poetessa svedese. L’eroe della vicenda, Gösta Berling, è l’uomo che incarna tutta la fantasia sbrigliata: pronto in un momento d’oblio, sotto l’impulso delle libazioni, della musica e della danza, a sfrenarsi e ad essere vittima delle tentazioni, per soffrire poi di tutta la tristezza e di tutti gli scrupoli che le brume invernali nordiche sanno destare nell’anima svedese dai multipli aspetti, nelle ore di riflessione. Il filo che unisce l’azione è costituito dagli avventurosi Cavalieri di Ekebù, galanti e spensierati, armoniosa coincidenza di «simbolismo e di lirismo, di attaccamento al suolo della patria e nello stesso tempo di spirito di avventura, il tutto dominato da quell’indolenza e noncuranza incorreggibile che fu la causa maggiore della devastazione di tanti patrimoni di famiglie aristocratiche svedesi». La leggenda è dominata dalla figura di una donna, vera discendente delle eroine delle antiche Saghe, fatta di forza, di spirito di organizzazione e nello stesso tempo dama e donna: vera incarnazione di un personaggio nazionale che ha il suo posto nella storia della Svezia. Vestita di pelliccia di montone, stivali e frustino, energica Comandante, Signora delle ferriere, quindi donna benefica e donna di società festosamente banchettante: capace oggi di odio e di disprezzo, capace domani di mettere a nudo il pentimento del suo cuore. Il trasparente tessuto che fa da sfondo all’azione dei personaggi è un intreccio delle pittoresche Saghe della nevosa Svezia: racconti dove l’anima svedese, inquieta, silenziosa, allucinata da chimere, impasto di fantasia e di realtà, vi è espressa in tutta la sua complessità. 3.1.6/60 L’umanità di Gösta, con tutti i suoi errori e le sue follie, la bizzarria dei Cavalieri, bohémiens diseredati e sperduti, l’amore di Gösta e di Anna e soprattutto l’imponente ed energica figura della Comandante – «creatura mai doma, che un bel giorno, scacciata dalle sue officine, vi ritornerà morente, portando ancora in sé il fuoco sacro che ridarà calore e vita alle miniere deserte, e riaccenderà la speranza nel cuore dei Cavalieri» – hanno particolarmente interessato la fantasia musicale di Riccardo Zandonai; e non avendo potuto attingere dal folklore la sostanza musicale per ambientare la vicenda, egli tentò – e in parte vi riuscì – di creare la necessaria atmosfera dove potessero respirare tutti i complessi personaggi della Saga. L’elemento lirico pervade e agita tutta la partitura e i pezzi d’assieme sono quelli che maggiormente predominano. Il discorso musicale è chiaro, anche se talvolta tende alla esaltazione melodica. Di bell’effetto la soave nenia di Natale e di giusto equilibrio sonoro l’invocazione collettiva che precede il ritorno della Comandante morente: un inno grandioso che si eleva e prende forza al ritmo del maglio sull’incudine ed al rianimarsi delle officine ed al moto delle macchine. I Cavalieri di Ekebù furono rappresentati per la prima volta, sotto la direzione di Toscanini, alla Scala la sera del 7 marzo 1925, e nella stagione successiva vennero dati a Roma14. In occasione della recente riesumazione dell’opera fatta a Trento per celebrare il geniale musicista, in una nostra nota15 consigliavamo gli Enti lirici a togliere dall’immeritato ed ingiusto oblìo un lavoro tuttora vitale. Il ritorno dei Cavalieri sulle scene del Teatro dell’Opera è stato salutato ieri sera dal vivo consenso del pubblico. Sotto la direzione vigile e sensibile del maestro Oliviero De Fabritiis, la partitura zandonaiana ha trovato la sua adeguata e chiara potenza espressiva. Gianna Pederzini, nelle vesti della Comandante, ci ha offerto un altro saggio del suo eccezionale temperamento di cantante-attrice, trasfondendo nel complesso personaggio l’inesauribile ed inconfondibile gamma espressiva della sua sensibilità artistica e musicale: potente e prepotente nell’atteggiamento del comando, ardente e accorata nell’invettiva, dolce, suadente, sofferente nel pentimento e trasfigurata nella morte. Il lirismo del linguaggio zandonaiano ha trovato nella bella voce di Rina Malatrasi (Anna) piena rispondenza di calore e di colore. Ecco un’artista che vorremmo riascoltare sulle nostre scene. Mirto Picchi è stato un efficace Giosta, anche se un poco discontinuo nel canto. Esuberante più nell’azione scenica che nella voce Giampiero Malaspina; abbastanza composti Antonio Cassinelli, Vito Susca, Gianna Borelli e Mariano Caruso. Buona in complesso la regìa di Riccardo Moresco; ma nel finale, quando, all’arrivo della Comandante morente, le officine e il maglio si rianimano, e al canto dell’incudine si eleva l’inno alla vita, al lavoro, il movimento delle masse non ha certo assecondato l’esplosione sonora dell’orchestra. Ottimo il coro istruito dal maestro Conca. Molti applausi a scena aperta e alla fine di ogni atto. 275 Luigi Pizzuti, “I Cavalieri di Ekebù”, «Il Paese», 15.1.1954 - p. 3, col. 6-7-8 Gli epigoni wagneriani nostrani, fra i quali indubbiamente è Zandonai, non hanno mai saputo separarsi completamente dalle radici del melodramma ottocentesco. Il melodramma, 14 15 La prima rappresentazione romana avvenne invece nello stesso mese di marzo 1925. La nota non risulta essere comparsa su «Momento Sera». 3.1.6/61 per intenderci, che Wagner con malanimo soleva chiamare “Donizetti & C”. Si sono mossi così in un permanente equivoco, fra un sistema male acquisito e peggio adottato, difforme alla natura loro e l’amarezza di chi guarda alla cosa ripudiata con nostalgia. In fondo, ma non per tutti o almeno in vario grado fra i tanti della schiera, una insufficienza si denuncia quale origine del loro disorientamento ed è quella di non saper cantare con abbandono ben educato, con stile. A complicare vieppiù le cose, Zandonai, questo Zandonai dei «Cavalieri di Ekebù», per aspirazione a modernizzare i procedimenti compositivi a specchio con quello che si mostrava altrove con ben altra validità, introduce nuovi elementi nella miscela che se ne raffredda e insipisce. Che cosa ci dice lo Zandonai dei «Cavalieri di Ekebù»? Parole, parole, parole. Alla fine dell’opera nulla rimane se non una gran noia. La leggenda di Giösta [sic] Berling di Selma Lagerlöf, spoglia di quella sua misteriosa poesia nordica, presta una trama banale per una mera successione di episodi, unica evidente aspirazione dell’operista. La musica dovrebbe almeno colorire, sottolineare gli episodi cruciali del dramma, creare l’ambiente lirico, invece si pregia in una stagnante minuteria di suoni in preziosità di moda, con una inesorabile e compunta continuità da mortificare la pazienza del più rassegnato degli spettatori. È inutile attendere il momento culminante, un risveglio purchessia, un elemento di rilievo, qualcosa insomma che ti scuota dal sopore col quale sei impegnato in una strenua lotta. Ora si dirà: ma perché il Teatro dell’Opera mette in scena tali opere? Noi non lo sappiamo. Non è la prima né l’ultima: altre se ne annunciano. Congetture se ne fanno tante, ma chi può affermare qualcosa? Viene notato solo che la Direzione dell’Opera sembra essere animata da una pietosa mania soccorrevole verso le cose di poco conto, che è lodevole disposizione di animo, ma solo per il fine caritatevole. Non finirà il Teatro dell’Opera per diventare un Pio Istituto per il soccorso dei minori? La rappresentazione, costosa rappresentazione di molti milioni, ha avuto come concertatore e direttore Oliviero de Fabritiis, ben noto al pubblico di Roma perché si debba spendere parole in favore della sua accortezza; maestro del coro, che si è ben distinto, Giuseppe Conca, e regista Moresco, il quale non sempre si è sforzato di rendere quella possibile elementare verosimiglianza che sempre occorre raggiungere per non mettere a dura prova l’amore per il melodramma con il buon senso. Dalle scene, curate dal Cruciani, abbiamo riportato la sola ammirazione della serata, quella che ci è venuta dalla scena della fucina del castello di Ekebù, abbozzata da G. Giacomo Colombo nella visione di una pittura fiamminga del seicento. No, bisogna aggiungere che anche Gianna Pederzini si è fatta ammirare per quella sua capacità scenica disinvolta e appropriata, talvolta un po’ cachet ma indubbiamente efficace per stile, vivacità e prontezza, specialmente se si riferisce ai modi comuni degli altri attori, che tuttavia, occorre dirlo, in questo caso sono stati in un livello abbastanza dignitoso. Citiamo dunque Mirto Picchi che è stato un ottimo Giösta Berling e Rina Malatrosi [sic] nella dolce parte di Anna, ambedue generosi per rendimento vocale e tutti gli altri dal Cassinelli al Malaspina, dal Susca al Caruso e alla Borelli nelle parti di fianco. L’opera ha riscosso un successo di stima che si è manifestato con applausi al Direttore e agli interpreti. 276 G. Sciacca, “I Cavalieri di Ekebù”, «Il Quotidiano», 15.1.1954 - p. 5, col. 6-7 Si direbbe che il Teatro dell’Opera abbia voluto, quest’anno, giocare dei brutti tiri ai nostri musicisti da poco scomparsi. Dopo il cattivo servizio reso a Wolf-Ferrari con la rappresentazione de «I gioielli della Madonna», la sua unica opera veramente fallita fra le tante graziosissime da lui composte – 3.1.6/62 anche prescindendo dal suo capolavoro «I quattro rusteghi» –, ecco che ora è la volta di Riccardo Zandonai, con la ripresa de «I cavalieri di Ekebù». Riccardo Zandonai non fu certo un musicista di talento quanto Wolf-Ferrari ma anch’egli, tuttavia, fra le diverse opere scritte, ne ha alcune che, pur non potendosi definire capolavori del teatro lirico, sono pur sempre rappresentabili per una certa dignità di mestiere che in esse traspare. Se, per ovvie ragioni, si è a volte costretti a mettere in scena opere di dubbio successo di compositori viventi, ciò non ha più ragione di essere quando il compositore sia, purtroppo, morto. Allora ci si domanda: perché andare volontariamente incontro ad un sicuro, già sperimentato, inutile insuccesso? Certe imprese sono dannose, soprattutto, alla memoria degli stessi musicisti che si vogliono ricordare; dannose al buon nome del nostro teatro in particolare, e dell’opera italiana in generale. Anche volendo mettersi coscienziosamente alla ricerca dei pregi musicali che appaiono qua e là nella partitura de «I cavalieri di Ekebù», mai tali pregi potranno essere sufficienti per giustificarne l’intera rappresentazione. In ogni caso si tratta di qualità più sinfoniche che drammatiche o liriche. Tutte le creature della leggenda, infatti, appaiono come fantocci di stracci, nessuno ha una sua vera voce, anche quando l’orchestra riesce a sollevarsi dal fondo di un quasi costante, rumoroso nulla. Tutti gli interpreti hanno fatto del loro meglio per rendere sopportabili le rispettive ingrate parti. Gianna Pederzini con le sue eccellenti qualità drammatiche e la giovane Rina Malatrasi con la purezza del suo canto. Così Mirto Picchi, il Cassinelli e gli altri. Bene istruiti, come sempre, i cori del Conca; vigile la direzione di Oliviero De Fabritiis. 277 R. F., I Cavalieri di Ekebù, «Il Momento», 15.1.1954 - p. 3, col. 9 Riccardo Zandonai fu uno dei nostri ultimi operisti di valida tempra. Come tutti gli artisti, pur nella sua breve esistenza, creò un capolavoro: la Francesca da Rimini. Fatta questa premessa, è chiaro che poter conoscere altri frutti della sua invenzione è certamente interessante, soprattutto per i cultori di cose musicali, ma è anche a priori scontato che niente più si potrà scoprire di peculiarmente edificante nell’ambito della personalità zandonaiana, tanto meno in quello della produzione operistica di questo ultimo periodo. I cavalieri di Ekebù (ultimo lavoro di teatro di Zandonai [?], Scala 1925) è una leggenda nordica genericamente affibbiata a “un’epoca lontana” in terra di Svezia. Ma è una leggenda che di leggendario ha, sì e no, l’indispensabile zampino guastafeste di Belzebù; ma ha più della vicenda terrena, per non dire terra-terra, con il difetto di non essere stata raccontata con il crisma di una sofferta umanità. Probabilmente Zandonai, imbarcatosi nel lavoro, a un certo punto dovette sentire che dei fatti della Comandante, di Giosta Berling e compagnia non gli importava un gran che. E allora è venuta fuori l’opera ragguardevole per taluni aspetti, ben costruita, molto elegante specie nello strumentale per non piacere, ma poco spontanea e sentita per poter suscitare entusiasmo. Un guizzo genuino si accende al secondo atto al duetto della duplice rappresentazione al castello di Ekebù tra il pastore protestante Giosta e la giovane Anna. Molto riuscito e di felice esito teatrale l’intreccio comico-sentimentale tra i cavalieri che commentano la scena, ironici, con i corni, e il dolce dialogo del violino che sostiene l’ardente dichiarazione di amore dei due. La cerimonia dell’investitura e tutti i cori scritti per i cavalieri; l’assolo del violino al terzo atto; e il ritorno alle fucine al quarto atto, vanno segnalate come le pagine più vive che mantengono desto l’interesse del pubblico. 3.1.6/63 Gianna Pederzini è un’attrice sempre molto sicura del suo prestigio scenico e quindi è stata una autorevole Comandante. Mirto Picchi, Giosta Berling, affinato nel canto, generoso nel volume; fresca e corretta la voce di Rina Malatrasi, Anna. Bravo Antonio Cassinelli, Sintram e a posto Giampiero Malaspina, Vito Tusca [sic], Mariano Caruso e Nella Borelli. Ha diretto con fermezza Oliviero De Fabritiis. 278 I cavalieri di Ekebù, «L’Unità», 16.1.1954 - p. 3, col. 2-3 Accolta da applausi a scena aperta e alla fine di ogni atto, l’opera I cavalieri di Ekebù che Riccardo Zandonai, il valoroso musicista trentino, scrisse una trentina d’anni orsono valendosi di un soggetto tratto dal romanzo La saga di Gösta Berling di Selma Lagerlöf, ha rivisto ier l’altro, dopo tempo, le scene del Teatro dell’Opera. Pur non essendo una delle creazioni più riuscite di Zandonai, come la Francesca da Rimini per esempio, questo lavoro è una chiara dimostrazione del gusto e delle nobili aspirazioni del compositore, oggi relegato in una zona d’ombra che non merita. Musicalmente l’opera non è certo tutta di prima mano; si avvertono qua e là varie influenze, assorbite magari, ma sempre evidenti. Ciò porta naturalmente a discontinuità le quali nuocciono alla narrazione. Il clima stesso poi nel quale si trovano a muoversi i personaggi è talvolta dispersivo, anche se le intenzioni che stanno dietro le sagome dei protagonisti vorrebbero significare più di quanto non si veda. Non mancano però pagine nelle quali la mano di Zandonai ha trovato un ritmo felice, aderente alla sua sensibilità, pagine che suonano in maniera piacevole ed efficace. Tra gli interpreti va ricordata per prima Gianna Pederzini, la quale ha animato anche scenicamente la figura della Comandante. Mirto Picchi ha sostenuto la parte di Gösta brillantemente. Buoni nelle loro parti Antonio Cassinelli, il Malaspina e Mariano Caruso. Rina Malatrasi, nella parte di Anna, ha dimostrato le sue possibilità vocali. Oliviero De Fabritiis ha guidato lo spettacolo con l’esperienza teatrale che ben sappiamo. 279 E[ttore] Montanaro, “I cavalieri di Ekebù” di Zandonai riaccolti festosamente dal pubblico romano, «Il Popolo», 15.1.1954 - p. 2, col. 2-3-4-5-6 Il Teatro dell’Opera ha ricordato il maestro Riccardo Zandonai con una pregevole esecuzione de «I cavalieri di Ekebù» che tornano fra noi dopo lunga assenza. Il pubblico romano si è mostrato lieto di questo nuovo incontro con l’opera del maestro trentino ed ha applaudito con entusiasmo ad ogni atto. Accoglienza festosa dunque, che rende impenetrabile il fitto mistero sull’ostinato oblio cui è stata tenuta per lungo tempo la partitura. Il suo lento cammino per i teatri nazionali sembra quasi l’espiazione di una colpa che può ravvisarsi nella ricchezza dei valori espressivi che l’opera racchiude. A distanza di tanti anni dalla sua nascita, la partitura conserva inalterati tali valori con la vitalità, la freschezza melodica e l’impeto drammatico. Quel linguaggio zandonaiano del quale molto si è parlato e discusso, ancora oggi tende i fili di una curiosa polemica. «I cavalieri di Ekebù» segna una svolta importante nella produzione lirica di Zandonai. Il lavoro di rinobilitamento del melodramma verista, così felicemente iniziato dal maestro con la «Conchita» – e che in «Francesca da Rimini» assume aspetti di singolare significazione – trova ne «I cavalieri di Ekebù» la più brillante affermazione. L’opera perviene a una nuova e significativa conquista. Il raggiungimento degl’ideali fortemente e appassionatamente sognati dall’artista, premiano la sua nobile fatica. 3.1.6/64 Inseritosi nella scala dei valori dei grandi operisti italiani senza allontanarsi dal solco tracciato, Zandonai, nel tradurre personali concezioni, procede arditamente verso la méta desiderata, con una musicalità pulsante, satura di emozioni, ricca di fioriture suggestionanti. Con «I cavalieri di Ekebù» la produzione melodrammatica di Zandonai riceve nuovo impulso, prende più ampio respiro umano e, collocatosi in una linea di grande nobiltà, segna – si è detto – nuovi confini sul piano dell’opera lirica. Gli schemi in uso apparivano ormai logori: bisognava sostituirli con mezzi modernizzati. Il vecchio “mannequin” balbuziava: occorreva modificarne la disegnatura e rinvigorirne il linguaggio. L’ansia di scoprire un mondo nuovo s’era fatta bruciante. Incappato nella lettura delle avventure romantiche di «Giosta Berling», singolare tipo di libero pensatore, il maestro si sentì preso come in una rete di lusinghe. I pittoreschi luoghi nordici lo esaltarono. Le figure simboliche che vagano per questi luoghi eccitarono la sua fantasia. Il desiderio di dare palpito umano a queste figure costituiva il tema assillante, la prevalente ragione della vita del compositore. Il suo spirito si placò quando dalla rinverdita fantasia scaturirono nuove creazioni. Zandonai seppe, con felici procedimenti, fondere e armonizzare il sentimento e il carattere nordico con il gusto e la sensibilità latina. Senza formalizzarsi nella documentazione di un folclore di maniera, è riuscito a dare alla sua musica un vigore lirico di ampio respiro umano. Scavando nelle intimità dell’animo del popolo nordico, Zandonai ha portato nel campo musicale un mondo lontano e ricco di suggestioni. La particolare sensibilità dell’artista ha consentito al compositore insigne di esprimere l’ambiente della Svezia leggendaria scaldata dalla fiamma tradizionale del nostro teatro lirico. Il Teatro dell’Opera ha obbedito a questa celebrazione come a un sacro rito, allestendo lo spartito con paterna premura senza nulla lesinare alle esigenze della partitura. Guidato dal gesto animoso del maestro Oliviero De Fabritiis – la cui profonda esperienza direttoriale e il grande amore che sa porre in tutte le cose gli hanno consentito di mettere in giusto rilievo tutti i particolari della difficile partitura – un gruppo di artisti ha recato un apporto considerevole. Gianna Pederzini, nelle vesti della “Comandante”, che è al centro dell’azione, è stata una interprete stupenda. La reincarnazione del personaggio ha trovato nella Pederzini un’artista vibrante, sensibile, magnifica. Pieno di espressione e ricco di sentimento il canto di Rina Malatrasi, nella parte di “Anna”. Umberto [sic] Picchi, alle prese con un ruolo non facile (Giosta Berling), si è disimpegnato con onore. Efficacissimo Sintram il basso Cassinelli. Preparato dall’abile maestro Conca, il coro ha collaborato bravamente. L’esito è stato – si è detto – vivo e copioso. 280 Vice (RC), I Cavalieri di Ekebù, «La Voce repubblicana», 17.1. 1954 - p. 3, col. 2-3-4 I Cavalieri di Ekebù è un’opera che si riallaccia alla tradizione melodrammatica dell’ultimo ottocento. Il testo poetico è stato tratto da A. Rossato dalla famosa opera La leggenda di Gösta [sic] della scrittrice svedese Gelma [sic] Lagerlöf, composizione che appartiene a quel mondo romantico fantastico leggendario, a tinte fosche e denso di drammaticità, così caratteristico della letteratura nordica. La trama di questo dramma giuoca sugli eterni temi e vicende dell’animo umano: sublimazione e purificazione attraverso la sofferenza e il dolore in un’atmosfera di velato misticismo ove a tratti incombe, come una macchia oscura, il pauroso senso dell’ignoto. 3.1.6/65 L’opera di Zandonai non si discosta, come si è detto, dai modelli tradizionali. Essa risulta, infatti, da un ben congegnato susseguirsi di recitativi, ariosi, cori, duetti, ecc. Il sistema musicale è pur sempre quello diatonico-tonale, con qualche sporadico impiego della scala esafonica, di cui l’A. si serve per dare un carattere al personaggio di Sintram. Tradizionali le armonie, se si eccettua qualche accordo dissonante un po’ complesso che risulta dall’aggiunta di note estranee ad armonie comuni. L’opera è concepita melodicamente. Zandonai tende con tutte le forze verso il canto puro e verso un’originalità di canto, ma l’adesione (o imprigionamento) a vecchie formule melodiche ed un’ispirazione che non si eleva mai a grandi altezze gl’impediscono di realizzare il suo sogno. Nei momenti di maggiore intensità lirica (racconto di Gösta al primo atto, duetti fra Gösta ed Anna al secondo, terzo e quarto atto, ecc.) sembra a volte che il canto prenda quota, s’innalzi, ma sono sprazzi di luce per ricadere assai spesso. I recitativi sono invece quasi sempre di un’efficacia espressiva e di un’incisività notevole, specie quelli della Comandante. Notevoli i cori: ben caratteristico quello della canzone dei cavalieri, con un tema incisivo, forte, ben ritmato, virilmente imponente, e di una efficace potenza drammatica i cori della folla, soprattutto quelli nella scena della miseria e dell’invocazione al ritorno della Comandante (ultimo atto). Lo strumentale vivo, esuberante, colorito, ben aderente alla scena ed al canto, crea spesso un’atmosfera suggestiva a colori oscuri. Preciso il taglio dei singoli pezzi. Si sente in tutto il ferrato mestiere di un musicista di buona tempra. Il personaggio meglio espresso è quello della Comandante nella sua dolorosa solitudine e sotto il peso di un triste passato che né l’abitudine ad una pratica di altruismo né le distrazioni di una laboriosa e forte occupazione valgono a soffocare, [...] Coerenza stilistica, incisività dei temi che ne caratterizzano la psicologia, aderenza della musica al testo poetico. Musicalmente scialbe ed anonime invece le figure di Gösta (il personaggio principale) e di Anna, e troppo simili l’uno all’altra. Il loro canto tuttavia, sebbene imbrigliato da vecchie formule melodiche, non è privo di coloriture ed inflessioni romantiche e di dolci e delicate espressioni idilliache e simpatiche risonanze. Ben caratterizzata la tenebrosa, sghignazzante figura di Sintram con uno strumentale efficace poggiante su formule esafoniche. Anche il personaggio di Cristiano ha buon rilievo. Citiamo alcune fra le migliori parti dell’opera: primo atto: all’inizio un movimento cupo ai bassi a cui si aggiunge il lampeggiamento nel registro medio di una quarta discendente, creano un’atmosfera pesante e misteriosa che ben c’introduce al dramma della disperazione di Gösta. Ben delineata sotto lo sfondo di accordi aspri dissonanti e mediante l’impiego di formule melodiche esafoniche la figura sghignazzante, lugubre di Sintram. Non trascurabile è il coro delle fanciulle su un motivo fresco e vivace di carattere popolaresco. Efficace lo strumentale che accompagna il racconto di Gösta, movimentato, denso, con dolci mormorii e cinguettanti note ribattute di una freschezza primaverile. Ben caratteristica la Cantata del Natale, con un bel tema di carattere dolce e agreste di una toccante semplicità. Notevole il coro della Canzone dei Cavalieri di Ekebù (tema gagliardo, incisivo, che si ripete spesso durante il corso dell’opera, sostenuto da uno strumentale nutrito, pieno di slancio ma in alcuni tratti anche strepitoso, effettistico). Secondo atto: simpatico l’inizio con un tema fresco, vivace, ben ritmato, ritornante, che crea un’atmosfera festosa. Caratteristiche la presentazione dei cavalieri a Giosta (pochi tocchi che abbozzano assai bene le grottesche figure) e la sviolinata di Liecrona sopra il gustoso e bizzarro motivetto dell’orchestrina dei cavalieri. Terzo atto: armonioso, dolce, pervaso di tristezza il coro dei Cavalieri, a cui fa da efficace controcanto o si alterna il patetico violino di Liecrona. Ben concitata e drammatica la scena dell’espulsione della Comandante in un crescendo efficace e vigoroso; commovente l’addio della stessa che si conclude efficacemente con il melodico singhiozzo lugubre di 3.1.6/66 Samzelius. Quarto atto: efficace inizio con il coro della folla che invoca il ritorno della Comandante con sempre crescente drammaticità, sopra un ondeggiante, tumultuoso, irrequieto movimento dei bassi. Di una certa potenza la scena della ripresa del lavoro dei cavalieri, dietro l’incitamento della Comandante: un coro robusto, incalzante verso il fortissimo, sostenuto da uno strumentale nutrito e prorompente, finché si ode il tonfo possente del maglio. Ben segue la canzone dei cavalieri, mentre l’orchestra è sempre agitata (quartine rapide di violini, persistenza del suono metallico del maglio, strappate vigorose ai bassi. Crescendi impressionanti sulle parole sciogli! tuoni! Giù!). E sotto il martellante infuriare dell’orchestra che ricanta una tragica frase in minore, muore la Comandante. La presente edizione di quest’opera si può definire molto soddisfacente. Buono il complesso dei cantanti: efficace Gösta Mirto Picchi, ben intonato alla parte e stilisticamente a posto (voce di buon timbro ma piuttosto povera di risonanze). Una dolce e gentile Anna Rina Malatrasi (piccola voce, dolce, simpatica, ben impostata). Ben scolpito il personaggio della Comandante dalla Pederzini, sia per la incisività e drammaticità della recitazione che per la straordinaria espressività del suo canto, solo un tantino turbata negli acuti da oscillazioni della voce. Ottimi il Cassinelli nella parte di Sintram e G. Malaspina in quella di Cristiano. Commovente Liecrona il Caruso. Abbastanza bene gli altri. Magnifici i cori diretti da G. Conca. Sobrie, ben fatte le scene e con una tonalità di colori di buon gusto e ben appropriata. Ha diretto con molto impegno e calore Oliviero De Fabritiis. Molti calorosi applausi alla fine di ciascun atto. Un appunto: nella presente edizione offerta dal Teatro dell’Opera è stata eliminata la seconda parte del terzo atto, la quale contiene alcune fra le pagine più belle e commoventi dell’opera, come quelle dell’inutile e triste tentativo di Anna di far ritorno alla madre. Tale taglio non ci sembra sia giustificato. 3.1.6/67
Scarica