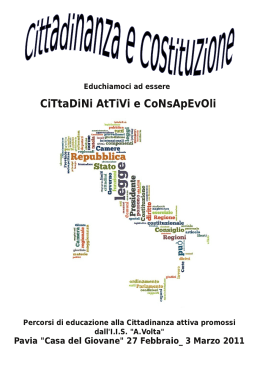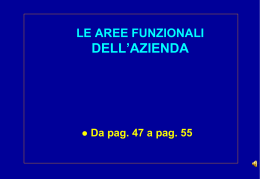anteprima MARCO CIPOLLINI LA IMMORTALE Copyright 2014 Marco Cipollini [email protected] anteprima 3 INDICE INTRODUZIONE pag. 5 PARTE PRIMA UN INIZIO pag. .10 UN ALTRO INIZIO pag. 20 IL TERZO INIZIO pag. 26 L’INCONTRO pag. 30 UN DIVERBIO A VOCE BASSA pag. 34 L’ORIGINE DI UN’OSSESSIONE pag. 37 LA LEGGENDA pag. 41 TRA DUE FUOCHI pag. 45 PARTE SECONDA LA SECONDA VITA DI TERESA pag. 51 NOTIZIE SU DI LEI pag. 62 UNA DUPLICE ELENA pag. 65 PROGETTI E VATICINIO pag. 68 LE FUNZIONI DI UN ANGELO CUSTODE ( I ) pag. 72 FURORE E QUIETE SERALE pag. 75 LE FUNZIONI DI UN ANGELO CUSTODE ( II ) pag. 87 L’INFANZIA DI PHOSPHÓROS pag. 90 LE FUNZIONI DI UN ANGELO CUSTODE ( III ) pag.100 PARTE TERZA LA VITA FELICE pag.105 STRAGE E FUGA pag.117 IL SEGRETO DI ELENA PATERNÒ pag.130 anteprima 4 L’INSEGUIMENTO pag.135 TATTICHE DI POSSESSIONE pag.142 A BORDO pag.147 VIBRAZIONI SENTIMENTALI DI ELENA PATERNÒ pag.159 PARTE QUARTA UN PROFETICO VIAGGIO IN TRENO pag.166 PREPARATIVI PER LA SPEDIZIONE IN TERRA D’ALBIONE pag.177 LA FLOTTA SALPA pag.180 UN VULCANO IN MEZZO AL MARE pag.184 COME UNA CORSA A OCCHI BENDATI pag.194 FATTI E SOGNI DI TERRA E DI MARE pag.199 ISOLE pag.214 FUGA VERSO LE RIVE DELLO IONIO pag.233 I GIORNI DELLA RICERCA pag.237 PARTE QUINTA LA BEATA CATASTROFE pag.253 APPUNTI CONCLUSIVI pag.258 TUTTO È UNO pag.265 anteprima 5 INTRODUZIONE ovvero LA STORIA DI MOLTE STORIE A una certa pubblicistica ebdomadaria è parso ghiotto creare un cortocircuito fra la tragica morte di Elena Paternò e di Guido Petri, avvenuta quasi tre anni or sono, e il romanzo “storico” di quest’ultimo, ritrovato sulla sua scrivania domestica, proprio nel centro, dov’era stato lasciato da lui al momento di partire per quel meridione che tanto amava e conosceva. La sensazione è che egli lo abbia riletto (almeno in parte), atto inconsciamente oracolare circa il suo viaggio senza ritorno. Ora, se ci fosse un nesso diretto, causale, fra la vicissitudine letteraria e quella biografica, gli estremi temporali della stesura de La immortale sarebbero evidenti, considerando che “la passionale vicenda del professore e dell’allieva”, per dirla con i titoli dei rotocalchi, si comprime in sette, otto mesi. Quindi il romanzo sarebbe stato scritto fra l’autunno e l’inverno di quell’ultimo loro anno di vita. Petri aveva una impareggiabile conoscenza storica e topografica dei luoghi narrati, non abbisognava certo di precedenti ricerche erudite. Tutto risolto? Nient’affatto. Alcuni squisiti filologi, che hanno esaminato il dattiloscritto, storcono la bocca. Anche solo restando alla superficie della questione, si nota che i caratteri tipografici ivi usati sono i medesimi dei testi scientifici di Petri scritti non meno di dieci anni prima; in seguito, con la continua evoluzione della scrittura elettronica, l’illustre storico adoperò un altro font, e mai più il precedente. Ciò depone a sfavore circa una subitanea sublimazione di Elena Paternò nel personaggio di Phosphóros; casomai sarebbe la ragazza reggina a risultare la proiezione reale di una figura fantastica concepita in precedenza, come un sogno che all’improvviso si solidifica davanti agli occhi di Petri. Inoltre lo stile arioso, pigmentato, musicalmente “allegro” del romanzo, induce a pensare a un autore nel pieno vigore fantastico, direi euforico, la cui poiesis era aperta ancora in varie direzioni; a un Petri quindi più giovane, oltretutto non ancora provato dall’agonia e dalla morte della moglie, e che trovava il tempo di dedicarsi con anteprima 6 vena liberatoria a una scrittura inventiva, magari lavorando di notte, dopo il metodico lavoro accademico. Il lavoro spossante della Storia della Magna Grecia lo recluse poi per un decennio nel chiostro certosino degli studi storici. L’ipotesi su quel font usato in precedenza per La immortale coinciderebbe con quella di un romanzo non condotto a una completa rifinitura allorché a Petri si dischiuse l’idea di dedicarsi toto corde al suo capolavoro storiografico, non procrastinabile anche per motivi editoriali. Ma ci sono delle pietre d’inciampo. Quella irremovibile è la stesura del poemetto Un vulcano in mezzo al mare, che s’innesta idealmente nel carme protoellenistico che fu edito dalla prof. Vignani in un lasso di tempo in cui l’opus magnum di Petri lo stava già rendendo famoso: un post quem indiscutibile. Considerazione che vale ovviamente per la traduzione in versi ― senz’altro successiva alla stesura del Vulcano ― che Petri condusse sul testo protoellenistico, e che con il titolo di Isole fu inserita nel romanzo come una reliquia gloriosa, ovvero uno di quei torsi marmorei che nel Cinque e Seicento erano completati delle membra mutile. Ora, dato che il lungo prosimetro di Petri ha il proprio rizoma nel di lui poemetto nautico, che a sua volta è rizomatico di quello protoellenistico, la stesura de La immortale si sposta molto in avanti. In tal caso l’interruzione sarebbe stata causata dalla malattia e dalla morte della moglie, che tanto lo provò moralmente. Queste considerazioni sembrano prevalere su quelle, pur valide, del font non più usato e dello stile “giovanile”. Ma nessuna ipotesi è inoppugnabile. Un’annotazione circa Un vulcano in mezzo al mare. Se il frammento poematico edito dalla prof. Vignani, e riscritto dal prof. Petri con il titolo di Isole, rappresenta l’humus da cui in seguito nasce il tutto, è il poemetto in endecasillabi la ghianda del successivo romanzo. Su un dettaglio curioso si è tentati di spigolare: la resa “neoumanistica” dei nomi, di gusto antiquario. Pare indubbio che lo spunto creativo sia stato dato all’Autore proprio dal nome della protagonista, Phosphóros, resa con il sofisticato (e pedante) Lucifero. Il lettore avrà già intuito dove si vuole arrivare: a quel soprannome da Petri assegnato bonariamente alla compagna di classe di Teresa, che doveva averlo colpito per la sua conclamata avvenenza. Quando lesse di Phosphóros, la memoria gli cor- anteprima 7 se a lei, il cui nome e cognome egli aveva reso per celia Lucifero. Tale giocoso epiteto fu quindi il profetico annuncio di quella Elena Paternò che in seguito incarnò (e sostituì) l’ideale estetico, e l’ossessione erotica, del professor Petri. Il cui amore per Teresa, la moglie defunta, si poneva su tutt’altro piano. Mi piace proporre qui una ipotesi (ipostasi) del tutto gratuita, e che in parte contraddice quanto sopra esposto (la verità spesso esonda dall’asfittico sillogismo). E cioè che l’inizio della stesura della narrazione petriana risalga al periodo in cui, parallelamente, Elena Paternò conobbe la sua malformazione: duplice mala formazione, sia di un corpo sia di un romanzo il cui finale è solo abbozzato. Il maturo docente e la bellissima studentessa non potevano non incontrarsi: la potenza della Dea aveva lanciato dardi nell’una e nell’altra direzione. E mi piace, ancora, riportare in coda il parere di un amico, che vuol rimanere anonimo ma del quale svelo almeno le iniziali, D. R.. Riguardo quanti hanno valutato poco positivamente la struttura a patchwork, giudicata artificiosa e poco organica, di questo testo complesso, comprendente (a) il romanzo frammentario di Petri (l’originario La immortale, titolo poi esteso al resto); (b) la vicenda biografica di Guido Petri e di Elena Paternò, et alii; (c) i cinque episodi riguardanti la vita di Teresa Albani, la moglie di Petri; il suddetto mi ha scritto: “Ritengo che di questo libro così articolato si comprenda l’organicità stilistica e narrativa solo se lo si vede non secondo la classica prospettiva unitaria sottesa al ‘romanzo’, genere letterario ormai abbrustolito nelle molochiane fornaci dell’industria editoriale, ma secondo un triplice punto di vista, per così dire polifonico e contrappuntistico. Ovvero il romanzo antico, orchestrato con molti personaggi e varietà di luoghi, con i suoi ventosi orizzonti marini, paragonabile a una sinfonia con i suoi tempi ‘allegri’ e i suoi ‘larghi’; la vicenda di Petri e della Paternò, con Gigli e la Vignani in subordine, come un quartetto; la storia di Teresa (è lei la vera immortale) come una sequenza di variazioni di uno strumento a solo ― sorridi pure della mia acribia auricolare, ― ora una viola da gamba, ora un oboe, infine un organo. Forse il mondo si è fatto abbastanza confuso e complicato da farci apprezzare opere come questa, un testo proteiforme per afferrare il quale la nostra singola visione (veteroprospettica) è ormai insufficiente, così come lo è per sceverare le sempre più in- anteprima 8 tricate vicende del teatro globale (profetizzato da The Globe di Skakespeare?) le quali fanno di noi individui non più dei protagonisti, ma comparse smarrite sulla scena”. Che sia questo il modo meno inadeguato non tanto per comprendere questa armonizzata congerie narrativa, bensì, o hypocrite lecteur, per esserne compreso? anteprima PARTE PRIMA anteprima 10 UN INZIO La mano esita se lasciare o prendere questo o quello. Ma si decide. Sulla mensola di camera ― la occuperà Luisa, che ne ha una più piccola, magazzino di cianfrusaglie ― stanno allineati alcuni oggettini, molto cari a Teresa. Tra due giorni si sposerà e nella vita che si va costruendo con l’uomo che ama, di quella precedente vuole portare il minimo necessario. Ha trovato una scatoletta di latta colorata (conteneva amaretti) per riporveli. Della fine che farà tutto il resto poco le importa, il suo cuore è slanciato all’avvenire. Il primo che prende è una grossa conchiglia bivalve, un comune cardium, notevole solo per le sue dimensioni. Quando bambinetta lo trovò sulla spiaggia della Darsena, a Viareggio, le sortiva dal palmo della mano. Aveva già raccolto moltissime nicchie, ma essa era la più grande e per di più integra, e quindi non la mescolò con le altre nei barattoli di vetro; la pose sulla mensola di camera ― la sua sorellina di un anno dormiva ancora nella stanza dei genitori ― e ogni volta che la riprendeva, anche a distanza di anni, per qualche istante riviveva quelle sue estati meravigliose. Il padre, un piccolo imprenditore dell’abbigliamento in società con un amico, poteva permettere una lunga vacanza alla famiglia. Vivevano a Empoli; perciò affittava a Viareggio una villetta nei pressi della grande pineta di Darsena, dov’egli si recava per il fine settimana e per la quindicina di ferragosto. La viareggina era sempre la medesima, in quanto la prenotavano di anno in anno; ma quello in cui, di giugno, nacque Luisa, non vi andarono e persero la caparra ― ma che importava?, erano così felici ― e la villetta fu data a un’altra famiglia. La piccola Teresa fu mandata al mare con gli zii, a Tirrenia, che a lei piacque lo stesso, anche se la mamma le mancava, specie la sera. Gli anni successivi il babbo riuscì a riavere quella viareggina, ma Teresa ormai ne era un poco disamorata. L’interruzione dell’estate precedente e la nascita di Luisa, alla quale la mamma prestava le maggiori attenzioni, erano state percepite da lei come conclusive di anteprima 11 una fase della sua vita, l’età dorata del primo eden, e quella grossa nicchia a forma di cuore ne racchiudeva il senso misterioso e solare. Il suo esterno bombato e convesso, con la costolatura color ruggine, le dava un senso di rude forza protettiva, scrignante il concavo interno, come smaltato, nel quale si annidava il rumore infinito del mare. Il cardium, con la sua forma a cuore, significava la sua infanzia pura e beata, illesa dalle aggressioni del mondo. Pone la conchiglia nella scatola. Prende dalla mensola il grosso cristallo di quarzo, che brilla nel sole primaverile. Quando lo trovò, durante una gita scolastica in montagna in Garfagnana, aveva nove anni. Rivede la scena. Lei con le compagne, due per due, formano una fila con le due maestre, una a capo una in coda. Sono stanche per la salita sassosa. Qualcuna, pure lei, vuol fare pipì. La fila si ferma. Teresa si apparta tra delle roccette, il luogo è erboso, si accuccia e procede. Come si alza, si accorge che vicino al suo bagnato c’è quel sasso stupendo, lucente. Ma come lo prende, ecco a due passi che guizza nell’erba un serpentello. Lei lancia un grido. Accorrono le maestre, le compagne. Saputo del rettile (una vipera? un biacco?) fanno allontanare tutte le bambine. Ma Teresa si mette il quarzo in tasca. Per lei quel sasso così bello rimarrà sempre legato all’esperienza del serpente, avrà quindi un significato duplice, enigmatico: la geometrica luce e bellezza che nasconde il pericolo viscido, il male. Durante la preparazione per la Comunione, legge il libretto di dottrina, illustrato; ci sono Adamo ed Eva (decentemente infrascati) con il Pomo e il Serpente. Ha un’illuminazione: il suo quarzo è una specie di Pomo, la cristallina memoria di un male che lei però ha evitato. In Teresa rimarrà sempre questo senso di sdoppiamento tra la bellezza e il male, che la vita con gli anni le conferma. Prende ora un grosso chiodo rugginoso. È a sezione quadra, la punta rotta e un po’ torta, un oggetto molto vecchio, forgiato a mano chissà quando. La larga capocchia ha subito pazientemente parecchi colpi, è deformata. Lei lo trovò tutto sporgente dal muro anteprima 12 del cimitero, sul punto di cadere. Lo stringe nella mano, stringe a lungo gli occhi. Esso rappresenta il periodo più cupo dei suoi vent’anni di vita. Fu l’anno che ebbe il menarca. Non lo visse drammaticamente, e poi stava venendo a diverse sue compagne; ne parlavano complici tra di loro. Quando Teresa vide le mutandine sporche s’impaurì. La mamma sorrise, disse: “ora sei grande, signorina. Devi fare molta attenzione”. Attenzione a cosa? Non lo chiese. In seguito alla disgrazia, in retrospettiva ella vide quella perdita di sangue come un preannuncio di quanto sarebbe accaduto tre mesi dopo. Il babbo, era la fine di gennaio, morì dopo pranzo per un infarto fulminante. Lo trovò la mamma accasciato sulla poltrona, credeva che pisolasse. Lo scosse, e lui scivolò quasi sul pavimento. Teresa e Luisa, in cucina, udirono l’urlo e videro la mamma dalla porta di salotto correre fuori, e gridava chiedendo aiuto. Le sorelle andarono di là e videro la scena: il babbo, afflosciato, aveva il capo piegato da una parte, la faccia una specie di smorfia, gli occhi semiaperti. Urlarono anch’esse e scapparono. Vennero i vicini, dopo un quarto d’ora l’ autoambulanza, gli infermieri, il medico. Nulla da fare. Teresa e Luisa furono condotte dai vicini perché non assistessero. A lei rimase sempre stampato nella mente che il vicino, anzianotto, disse piano alla moglie: “ci farei la firma a morire a quel modo”. La ragazzina non ne capì il senso, ma le parve un desiderio terribile. Teresa aveva tredici anni, Luisa sette. La mamma non volle che la figlia minore vedesse il padre nella bara aperta; così Luisa fu subito portata via dallo zio Mario e dalla zia Elisa anche per i giorni successivi. Luisa pianse, ma poi se ne andò abbastanza tranquilla col suo orsacchiotto in braccio. Teresa le ha sempre invidiato quell’atteggiamento positivo che nell’agire sa risolvere un’avversità. Teresa invece, la madre per mano la condusse a lato della bara, dicendo: “guardalo un’ultima volta, non lo vedrai più”. Parole che la marchiarono nell’anima, le più tremende di tutta la sua esistenza, a parte quelle di un medico in un lontano futuro. La bambina rammen- anteprima 13 tò che il prete a catechismo aveva accennato con garbo alla morte in altro modo, e cioè che i defunti si ritrovano in paradiso, dove nulla del bene della vita si perde. Ma sua madre poteva mentirle? “Guardalo un’ultima volta, non lo vedrai più!” E Teresa lo fissò, impietrita. Ma era il suo babbo quello? La faccia era scurita paurosamente: lì per lì credé che fosse un negro, che il colore livido preannunciasse le tenebre eterne che sono sottoterra: altro che paradiso! L’orrore davanti ai suoi occhi contraddiceva totalmente le parole del prete. Si volse a guardare la mamma con angoscia. La faccia di lei, in due giorni invecchiata di vent’anni, era calcificata, gli occhi vitrei, come assenti, fissavano l’uomo amato, trasformato dalla morte in una cosa estranea e ripugnante. Tutto era irredimibile, ingiusto. La vita l’aveva tradita crudelmente. Poi mamma e figliola furono dai parenti condotte fuori, perché era venuto il saldatore con i suoi attrezzi. Teresa uscendo vide di sghembo la faccia carbonosa del babbo rasoiata alla vista dal coperchio zingato. E non lo vide più. Fu solo allora che la mamma riprese a piangere disperata, consolata invano dalle donne. In chiesa il sacerdote parlò ancora della Comunione dei Santi e che i vivi avrebbero rivisto per sempre i loro cari. Era quello che Teresa voleva sentir dire. Ma come girò gli occhi e vide a fianco la madre, velata di nero, con la faccia impietrita, lo sguardo perso nel vuoto, non seppe a chi credere dei due: la mamma pareva più vicina alla realtà cadaverica del padre, chiuso là in quell’astuccio enorme, che la corona di fiori (il quarzo e il serpente) non riusciva a rendere meno terribile. Al momento della comunione la donna fu sollecitata, quasi sospinta, dalla sorella e dalla cognata a prendere l’ostia, ciò che fece meccanicamente, quasi con astio. Teresa invece la prese con la precisa volontà di rivedere un giorno il padre: la comunione non si chiamava così perché preparava alla Comunione dei Santi? E Luisa, che era assente? Non l’avrebbe mai rivisto, lei, il babbo? Non seppe rispondersi. L’intera realtà, la chiesa, il mondo, anteprima 14 tutto vacillava. Ma la consolarono un poco l’incenso e i canti alla fine. Al cimitero vide introdurre la cassa nel forno, e lo strusciamento sordo la fece rabbrividire. Scoppiò a piangere, fu consolata dalla zia, che la portò un poco lontana. Ma fu lei a voler tornare. Il becchino murò il buco quadrato e buio e ci passò una mestolata di calce, sulla quale scrisse le iniziali del padre e la data. Il sacerdote benedisse un’ultima volta il defunto. La cerimonia era conclusa. La gente a gruppetti se ne andava. Fu uscendo dal cancello che Teresa scòrse nel vecchio muro scrostato quel grosso chiodo. Lo toccò appena, ed esso si staccò, le cadde in mano: un segno del destino. Un’altra fase della sua vita era conclusa. Infatti la vita familiare cambiò recisamente. In quel primo mese vennero gli zii quasi ogni giorno (verso sera). Poi diradarono le visite. Alla piccola Luisa furono rivolte le attenzioni più delicate. Teresa si sentì un po’ messa da parte. Ma senza le intrusioni d’affetto dei parenti ebbe più spazio per i propri genuini moti dell’animo, per delle riflessioni meno filtrate dalla pietà riversata dalle zie. Perché la madre pareva non curarsi delle bambine, inabissata in una tetra solitudine. Era come il guscio di un frutto risecchito, bacato dentro. La situazione economica fu ben presto chiarita. L’altro socio, una brava persona, dati alla mano espose che la ditta non passava uno dei periodi più floridi e che al defunto apparteneva il 40% del capitale. La madre, consigliata dai parenti e da un ragioniere, chiese la liquidazione della quota spettante, che avrebbe investito in un negozio di tessuti o di abbigliamento. Il socio chiese una dilazione perché, in quei tempi di magra, non disponeva di un fido bancario adeguato. Così la madre riprese a cucire per la stessa ditta, di cui era comproprietaria, come aveva fatto agli inizi per aiutare il marito a metterla su. Teresa vedeva ogni due tre giorni una macchina scaricare a casa enormi involti neri, contenenti i tagli di stoffa. La macchina da cucire, rimessa in funzione dopo anni, teneva occupa- anteprima 15 ta la mamma, distogliendola in parte dalla disperazione. Ci stava a ore e ore, fissa, aggobbita, senza curarsi della casa né gran che delle bambine. Così fu presto supplita dalla sorella Nara, zitella, in buona parte delle funzioni materne. Spesso la zia si fermava a dormire da loro (nel lettone con mamma), e dopo quattro mesi di quel va e vieni ci risiedé. Teresa imparò a badare al fuoco, e piano piano, seguita dalla zia, a cucinare. E se già da tempo aveva smesso di giocare alle mamme, ora aveva fatto il balzo: era una piccola adulta. Ma non era questo cambiamento di vita ― la cucina, rifare il letto e le pulizie ― a contare di più per lei, bensì quanto era avvenuto dentro la madre. La sua faccia senza espressione, senza che guardasse più negli occhi lei e la sorella, feriva il suo animo più della sparizione del babbo, quella sua assenza dallo spazio che prima occupava in casa. La poltrona di lui, terribilmente vuota: nessuna ci sedeva più. Soltanto Luisa ci si buttava; ma la mamma la faceva alzare. Il posto di lui a capotavola, vuoto. Ci stava la zia quando mangiava da loro, e poi, accasatasi, fu il suo fisso. Nel bagno l’assenza del suo spazzolino da denti, del suo pennello da barba. Delle sue scarpe nello stanzino. La memoria del padre era il suo vuoto. La Morte era il Vuoto. Rimanevano due fotografie di lui incorniciate: una in salotto, che felice abbracciava le bambine; l’altra nella camera della mamma, che la teneva per mano, sorridenti. L’unico sorriso della casa. Teresa a veder sempre la mamma come pietrificata si fece l’idea che l’amore per il marito, un tempo flusso continuo di gioia, ora le aveva calcinato il cuore. Era dunque l’amore la prima causa di quell’arida sofferenza senza lacrime? Chi ama è destinato prima o poi a patire l’assenza di chi ama; a meno di non morire tutti e due insieme, era inevitabile di ridursi a soffrire in modo così ripulsivo. Nemmeno riusciva a piangere, la donna. Teresa ebbe proprio questo pensiero una sera che nell’ombra della stanza vide la madre, china e appartata: “non riesce nemmeno a piangere quella donna”. E anteprima 16 provò per lei, per sé, una solitudine insopportabile. Avrebbe voluto sparire dal mondo, cioè da quella casa. Quella notte nel buio della sua camera, attorcigliata nel letto, Teresa prese una decisione assoluta: non avrebbe amato nessuno per non dover soffrire in quel modo. Scritte nella mente queste parole, sentì di essersi salvata, o meglio, tristemente salvata. Non avrebbe provato l’amore come una fonte di gioia, ma nemmeno sofferto per la perdita di chi si ama, perché questo patimento sovrasta come una pietra tombale il ricordo di ogni gioia provata; anzi, il ricordo dei momenti felici non solo non lenisce, bensì aggrava nella solitudine la sofferenza della privazione. Sì, chi ama è destinato a soffrire, è ingannato dall’amore che tanto promette e infine dalla carne recide ogni gioia. “Io non mi innamorerò di nessuno!” Disse questo stringendo quel chiodo. E piombò nel sonno come morta. I giorni che seguirono, fatta questa scelta, si sentì più sicura; non più tranquilla, ma più salda nel comportamento. Anche a scuola, dove tutti mostravano un occhio di riguardo per l’orfana, le cui veci materne erano adempiute dalle zie Elisa e Nara, specie da quest’ ultima, che ormai faceva parte integrante della famiglia. Le insegnanti notarono che la bambina “aveva elaborato il lutto in modo eccezionalmente maturo per la sua età”. Le zie se ne compiacquero, anche se il loro buon senso vedeva nell’indifferenza della nipote di fronte a ogni cosa un atteggiamento poco naturale. E poi, “elaborazione del lutto”: ma che modo di parlare era? La bambina era intristita, era tutta qui la sua maturità. Al contrario Luisa rideva e piangeva come prima, seppure la perdita del babbo finisse per manifestarsi in lei con atteggiamenti ribellistici. Data la situazione, tutto le era permesso, e ciò la rese un poco pretenziosa. Che ci si poteva fare? Era un’orfanella e andava accontentata. Accadde alla messa di suffragio per l’anniversario della morte del babbo. La madre nemmeno vi era presente. Le zie Nara ed Elisa, col marito Mario, e altre due parenti accompagnarono le sorelle in chiesa. Teresa assisteva alla cerimonia come assente, indurita. Che anteprima 17 fosse in chiesa o a scuola era lo stesso: c’era ma non c’era. Solo una cosa le dava la certezza di essere nel mondo dei vivi: il chiodo che portava in tasca o nella borsetta. Ogni tanto doveva stringerlo, e si sentiva meglio. Duro, spigoloso, ruvido, le diceva: “io ci sono realmente, e tu dunque ci sei”. Guai se lo avesse perduto! Al momento d’inginocchiarsi all’offertorio, chissà perché, forse perché i pochi presenti avevano la fronte china, lei guardò di sottecchi al grande crocefisso alto sull’altare, e vide le mani di Gesù trafitte da due chiodi grossi e vecchi quanto il suo. Nessuna analisi positiva può spiegare quanto avvenne dentro di lei. Ma fu che Teresa si identificò nel crocefisso, la cui faccia sofferente, di moribondo, la strappò di colpo da quella perdurante insensibilità. Il suo cuore irrigidito si sciolse e a lei scesero delle calde lacrime. Celato il viso tra le mani giunte come in preghiera, fece in tempo ad asciugarle. Poi fece la comunione con il cuore che le batteva a precipizio, come un puledro che tenuto troppo al chiuso venga liberato all’improvviso. Quella notte nella sua cameretta, nel buio pregno di respiri e sospiri, Teresa scoprì che la sua salvezza era nella via della religione. Il mutamento fu presto avvertito dalla zia. La madre viveva nel suo carcere di solitudine. Il suo invecchiamento era pure esteriore. Non si curava più l’aspetto, diverse ciocche ingrigite spuntavano dai suoi capelli castani. Invano la sorella le diceva di tingerli. Lei non voleva saperne, era infastidita a sentirselo dire. Forse il tingersi i capelli le avrebbe ricordato la vita con il marito, il tempo della gioiosa giovinezza. Teresa prese a frequentare la chiesa con regolarità, mostrando fervore, anche un poco esteriore, nelle pratiche religiose. La zia se ne compiacque, don Pietro ancor di più, e cominciò ad avere dei colloqui, prima brevi, poi sempre più approfonditi, con la ragazzina. Il sacerdote si sorprendeva della sua volontà di pregare, di frequentare le funzioni, e di come tale mutamento fosse stato repentino. “Opera della Grazia” disse don Pietro alla zia Nara col suo mite anteprima 18 sorriso. Ma la zia ci vedeva qualcosa di forzato: andare in chiesa sì, esagerare no. Un giorno d’aprile che Teresa passava per la via del convento delle monache, era sera, fu dolcemente colpita dal canto tenue, remoto, delle suore, proveniente da oltre il muraglione della clausura. Era appena percepibile, ma quel suono di molte voci serene e concordi la commosse beatamente. Di là da quel grande ruvido muro, dal quale spuntavano le fronde di alcuni alberi, c’era la gioia. Doveva essere una gioia diversa da quella provata dai suoi genitori, che per la madre si era risolta in un patimento senza rimedio. Doveva dunque esistere un amore che non implicava un rapporto personale, ma elargito liberamente verso tutto e nulla, e dunque non poteva essere infranto dalla morte di una persona amata. Era lo scioglimento del suo dilemma, che giaceva pesante nel fondo del suo cuore: amare provando gioia e dunque sofferenza, o non amare non provando alcuna sofferenza ma nemmeno una gioia? Ecco, esisteva un amore diverso, che elargiva solo gioia. Quella notte decise: “mi farò monaca!”. L’occasione per visitare il convento venne presto, provvidenziale. Siccome le monache operavano riparazioni fini di cucito, la zia disse che vi sarebbe andata per far rammendare il velo di seta, ricordo di sua madre, che si era lacerato togliendolo dal baule a causa di un chiodo sporgente. Teresa colse al volo l’occasione, chiese di accompagnarla. La zia ne fu assai contenta. L’entratura del monastero era in fondo a un vicolo cieco. Non c’era il campanello elettrico, ma ancora una catenella di ferro da tirare. Lo fece Teresa, a cui quella stranezza antiquata dètte uno strano senso di sicurezza: stavano entrando davvero in un altro mondo. Il massiccio portone di quercia, scurito dai secoli, si aprì da solo ed esse lo varcarono. In realtà dietro a schiuderlo c’era la suora portinaia, quarantenne, una delle più giovani del convento. Teresa e la zia furono introdotte in una sala, detta parlatorio, con un grande tavolo al centro e quattro sedie, una per ogni lato. Alle pareti bianche erano un crocefisso e anteprima 19 alcune immagini di sante monache. Venne una suora più anziana e la zia mostrò il velo lacerato. Mentre la religiosa lo esaminava con cura minuziosa, la zia diceva i motivi per cui le era tanto caro. Infine la monaca disse che era riparabile, ma che occorreva tempo e lavoro. Non era questione di prezzo, assicurò la zia. Quindi lei e la nipote rifecero il percorso inverso, finché il massiccio portone scuro non fu richiuso alle loro spalle. Teresa provò questa sensazione fisica: di essere passata da un mondo chiuso e sicuro a quello spalancato e insicuro di ogni giorno. Circa tre settimane dopo alla zia fu comunicato ― per quali mezzi non si sa, dato che il convento non aveva un telefono, e le monache non uscivano che in casi eccezionali ― che il velo era stato riparato. Alla zia era stato detto anche il prezzo (modesto). Siccome quel giorno lei aveva prenotato all’ospedale una visita dal flebologo, disse che sarebbe andata l’indomani. Ma subito Teresa si fece avanti dicendo: “zia, fammici andare me! Lo faccio volentieri!”. La mamma la guardò sì e no incuriosita e lasciò decidere alla sorella. Che consentì. Le dètte in una busta i soldi richiesti e si raccomandò che si comportasse a dovere nel convento. Mentre camminava da sola, il cuore di Teresa batteva forte, era inquieta e felice. Finché in fondo al vicolo sempre in ombra, tirando la catenella, si calmò all’improvviso. Il massiccio portone scuro si aprì e lei, preceduta dalla portinaia, andò nella sala della volta precedente. Venne la solita monaca e si stupì che vi fosse la ragazzina da sola. Teresa spiegò il caso, mostrando la busta con il denaro, che la suora non aprì. Invece aprì l’involto e mostrò il lavoro fatto: un’incredibile opera di ragnatela. La suora si alzò per salutarla, e Teresa già voltata per andarsene, si bloccò e ingenuamente, senza formalità, le disse: “sorella, vorrei farmi monaca anch’io. Come si fa?”. La suora la guardò stupita, sorrise tenuemente, e le disse di sedersi. Erano sedute a due lati contigui del grande tavolo, tra di loro lo spigolo. La suora non parlò. Il silenzio era bianco e prezioso. Prese anteprima 20 con delicatezza la mano di Teresa, e la tenne nella sua (cerea) senza stringerla, guardandola come da una lontananza al di là del tempo. Per quanto? E le disse, mite sorridendo: “figlia mia, io conosco le tue pene, e per te ho pregato e pregherò ancora. Mi fa piacere la tua richiesta, ma, credimi, la tua vita non è destinata dentro le mura di un convento. Va’ all’aperto, respira il mondo, e vivi serenamente, come deve fare un buon cristiano. La tristitia vitae ― conosci un po’ il latino, vero? ― è un grave peccato. Va’, dunque, e sii felice!”. Si alzò e le fece un segno di croce, sussurrando una benedizione in latino. Quindi la suora portinaia la riaccompagnò all’uscita. E il massiccio portone di quercia si chiuse per sempre alle spalle di Teresa. Uscita, si sentì frastornata, la cavità del capo ronzante per le parole appena udite. Come poteva la madre superiore conoscere le sue pene? E sarà stato vero che aveva pregato per lei e lo avrebbe fatto ancora? Non poteva certo mentire una suora. E soprattutto l’aveva colpita quella specie di ordine, “vivi serenamente, sii felice”, e che era un peccato grave chiudersi nella tristezza. Teresa se ne andava con l’involto tenuto tra due mani, il capo pieno d’aria luminosa, ed ecco il piede colpì una biglia di vetro: schizzò in avanti, saltellando sulle lastre. Quando nella connessura tra due pietre si fermò, lei la raccolse. Era una pallina di vetro celeste, in cui si concentrava la luce solare. Di chi sarà stata? Da tempo i bambini non giocavano più con le biglie. Le dètte gioia stringerla in mano, e sentì che da quel momento iniziava una nuova fase della vita. Ecco, prende la pallina celeste e la mette nella scatoletta. UN ALTRO INIZIO “Mi scusi…” “Sì?” “Sto cercando il professor Petri. Sa dove posso trovarlo?” “Non è in Dipartimento. Io lavoro con lui. La posso aiutare?” “Ah bene. Avrei da consegnargli questa lettera. È del professor Veganò, di Reggio…” “Ah, Veganò, lo conosco anch’io.” anteprima anteprima
Scarica