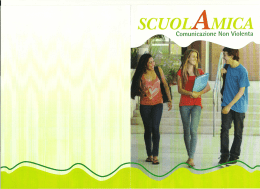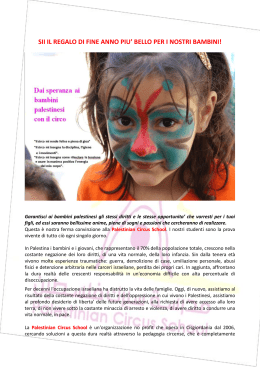Notiziario settimanale n. 554 del 02/10/2015 versione stampa Questa versione stampabile del notiziario settimanale contiene, in forma integrale, gli articoli più significativi pubblicati nella versione on-line, che è consultabile sul sito dell'Accademia Apuana della Pace sociale e siano uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Rispetto a questi principi, si vieta di ricostituire il partito fascista e di diffondere idee razziste e l'incitazione alla discriminazione razziale. Le indagini della scuola psicanalitica di Francoforte hanno cercato di individuare i tratti e le caratteristiche di una personalità orientata al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo, considerando il pensiero rigido e la personalità autoritaria, come una sorta di ricettacolo per l'insorgenza del pregiudizio antisemita e razzista quali elementi di un pensiero standardizzato e conformista. 02/10/2015: Giornata internazionale della nonviolenza. 03/10/2015: Anniversario della strage di Lampedusa: 366 migranti morti. 10/10/2015: Giornata internazionale contro la pena di morte Io cambio il futuro: 2 ottobre giornata internazionale della nonviolenza Milano, Casa Delle Donne Via Marsala, 8 MM2 Moscova, ore 09:00 (organizzato da: Casa delle donne di Milano, Mondo senza guerra e senza violenza, Centro nonviolenza attiva, Comunità per lo sviluppo umano) Indice generale Editoriali..........................................................1 I meccanismi sociali del razzismo (di Laura Tussi).................................... 1 Storia, bene, male. Giorni di grazia (di Enrico Peyretti) ............................. 2 Evidenza...........................................................2 Corpi civili di pace: “avviare al più presto la sperimentazione” (di Gabriella Lanza)........................................................................................ 2 Approfondimenti.............................................3 Qual è la vera ricchezza di un paese? (di Marco Grisenti) ......................... 3 I fratelli e le sorelle di mare e di terra (di Alessio Di Florio).....................4 Pietro Ingrao e la sfida del femminismo (di Lea Melandri).......................4 Il genere nel linguaggio (di Redazione Combonifem)................................ 5 La magia del libro e delle librerie: intervista ad Andrea Geloni (di Andrea Geoloni)..................................................................................................... 5 Notizie dal mondo........................................... 6 Non c'è più tempo (di Osservatorio Balcani e Caucaso, Rivistailmulino.it) ................................................................................................................... 6 Resistenza nonviolenta in Palestina: fermezza, creatività e speranza (di Katherine Hughes-Fraitekh)....................................................................... 7 Editoriali I meccanismi sociali del razzismo (di Laura Tussi) In Europa, sono fattore di enorme preoccupazione le politiche repressive, così come gli atteggiamenti xenofobi e intolleranti, nei confronti dell'immigrazione clandestina e delle minoranze. Esempio di queste politiche e di questi atteggiamenti è la decisione del governo italiano di rendere reato l'immigrazione clandestina. Le istituzioni hanno elaborato un sistema normativo contro i comportamenti intolleranti e razzisti. L'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, in Italia, prevede che tutti cittadini abbiano pari dignità 1 I ragazzi allevati secondo lo stile educativo autoritario tendono a reprimere i sentimenti negativi nei confronti di genitori severi e a sviluppare un atteggiamento di sottomissione verso l'autorità, ma anche a proiettare contro persone più deboli le loro frustrazioni. La personalità autoritaria è caratterizzata da rigidità, stereotipi, incapacità di tollerare l'ambivalenza e il cambiamento. Secondo Adorno, lo stereotipo antisemita e razzista è un potere completamente antiilluministico, naturalista, irrazionale e superstizioso che si afferma anche in una società razionale e tecnologica. Questo aspetto dell'analisi pone l'accento sulla personalità dell'individuo intollerante, mentre gli studi di psicologia sociale degli ultimi decenni accentuano e pongono in evidenza le dimensioni sociali del pensiero e del contesto che agevolano il formarsi dello stereotipo e del pregiudizio etnico e di genere. Palmonari sostiene che il naturale sviluppo di un'interazione fra l'attività cognitiva dei bambini e delle bambine, la risonanza emotiva e l'ambiente socio-culturale determinano l'insorgere delle categorie concettuali dello stereotipo e del pregiudizio. Le caratteristiche personali, quali la rigidità ed economicità di pensiero, le frustrazioni e la conseguente dimensione relazionale intraindividuale, determinano l'insorgere della concezione intollerante nella relazione. Dunque, quali sono i principali elementi che spiegano la nascita e l'evoluzione del pregiudizio, dell'intolleranza e dell'odio razzista e antisemita? Gli studi sul pregiudizio sono riconducibili alle relazioni sociali e ai processi di categorizzazione che tendono ad amplificare le differenze tra i gruppi e rafforzare le somiglianze all'interno degli stessi. Alla base del pensiero prevenuto e preconcettuale, sussistono meccanismi di categorizzazione che permettono di inserire gli “altri”, automaticamente, in predefinite tipologie distinte per caratteristiche di genere, età, ceto sociale, etnia, e altro ancora. I pregiudizi che sorgono nei gruppi e fra i gruppi sono riconducibili alla teoria realistica del conflitto che evidenzia le contese sociali per l'utilizzo delle risorse e la competitività sul piano economico e politico. Il concetto di identità sociale è costituito dagli aspetti dell'immagine di sé che derivano dalle categorie sociali, di cui l'individuo percepisce l'appartenenza. La teoria di Bandura, relativa al disimpegno morale, evidenzia i meccanismi tramite cui l'individuo arriva a compiere azioni immorali, giustificando il proprio comportamento, usando eufemismi, distorcendo le conseguenze, dislocando le responsabilità. Inoltre, nella società autoritaria, monolitica e ideologica, strutturata in senso gerarchico, sono abituali i meccanismi di discriminazione. In tali contesti, come nella Germania nazista, è possibile osservare una progressione di azioni che muovono critica e dissenso contro il gruppo bersaglio, discreditandolo e autorizzando ripercussioni violente e brutali, giustificando il discredito stesso, perché tali atteggiamenti sfociano nella considerazione che il capro espiatorio costituisce una categoria sociale inferiore e degenerata. Fromm aveva evidenziato come nei regimi totalitari la vita e la sorte dei cittadini viene riposta nelle azioni politiche e nelle decisioni di un capo assoluto, dove la mancanza di condivisione democratica e di autonomia critica costituisce elemento di rischio per la possibile comparsa di meccanismi di distruzione. In situazioni di insicurezza sociale e di difficili condizioni di vita, le circostanze possono attivare sentimenti di ostilità e rivalsa nei confronti di persone percepite come responsabili di simili problemi. Infatti, colpevolizzare gli altri, trasformarli in capri espiatori, diminuisce le proprie responsabilità. Questi processi possono rappresentare motivo di conflitto e fomentare i fenomeni di antisemitismo, razzismo e xenofobia. In ogni programma politico di contrasto del pregiudizio, assumono importanza la tipologia di struttura sociale, le disposizioni culturali, le condizioni economiche e sociali, la presenza di conflitto, i rapporti tra gruppi, la storia collettiva e le predisposizioni individuali. In una società democratica, dove sono in atto meccanismi di condivisione e partecipazione alle decisioni, tramite la considerazione della cittadinanza attiva, nell'autonomia critica, soprattutto tramite il rilievo posto all'istruzione scolastica e alla libertà degli ambiti di stampa, risulta possibile considerare la presenza di anticorpi atti a prevenire gli elementi che ingenerano lo stereotipo, il pregiudizio e la discriminazione che, inevitabilmente innescano meccanismi di distruzione e atrocità collettive. Attualmente tutto questo non appare così scontato, a causa delle degenerazioni del gioco democratico, rischio sempre presente in caso di affidamento totale delle istituzioni al capo carismatico e anche perché il meccanismo del capro espiatorio agisce in condizioni di crisi sociale, morale e politica e di insicurezza e di incertezza istituzionale. Laura Tussi da PeaceLink.it (fonte: Unimondo newsletter) link: http://www.unimondo.org/Notizie/I-meccanismi-sociali-del-razzismo-152591 Storia, bene, male. Giorni di grazia (di Enrico Peyretti) … Ogni tanto, però, appaiono momenti di grazia, di luce, apparizioni di verità, di umanità, di bontà. Cioè, giorni in cui il bene supera il male, snebbia l’orizzonte, è alba sperante. La storia umana non è mai definitiva, non è finita e non è ferma. Non è difficile essere pessimisti riguardo all’umanità e alla storia. Ci riusciamo tutti. Lo facciamo spesso, con l’aria di essere intelligenti, critici, e di avere solidi criteri morali, tristemente offesi dalla realtà. Ma c’è anche altro. Ci sono i giusti sconosciuti, quelli che reggono il mondo. Ma per lo più sono ignoti: tutti godiamo il frutto della loro virtù umile, coraggiosa, nascosta, e non li riconosciamo, non li vediamo. Ogni tanto, però, appaiono momenti di grazia, di luce, apparizioni di verità, di umanità, di bontà. Cioè, giorni in cui il bene supera il male, snebbia l’orizzonte, è alba sperante. La storia umana non è mai definitiva, non è finita e non è ferma. Oggi, davanti ad un fiume umano di profughi in disperata corsa alla salvezza – salvezza dalla guerra, dalle dittature, dal malessere economico; cioè da tutti i mali a cui tutti noi qui accanitamente cerchiamo di sottrarci, uno per uno, si salvi chi può, e chi non può si arrangi – davanti a questo fiume umano mosso da bisogno, speranza, volontà, anche astuzia, e decimato da annegamenti, osteggiato da muri e fili spinati, usato da mercanti di vite, odiato da sfruttatori cinici della paura ignorante, condannato da chi adora il sangue nazionale ed è pronto a spargere quello umano; davanti a un tale fiume di vita abbiamo sentito, dopo un bel po’ di esitazione, che siamo tutti ugualmente umani, in realtà ugualmente bisognosi, dietro le nostre fragili sicurezze. Prima tanta gente comune, poi persino i governi (mica tutti, però!), ci siamo convertiti all’accoglienza. Abbiamo accolto e rifocillato i profughi anche con l’ “inno alla gioia”, di un’Europa rinata. Sappiamo bene che il politico di professione pensa, più che alla realtà, all’effetto che fa, a cosa 2 serve. Eppure, ad un certo punto, conviene a tutti essere umani. Può capitare a me quel che capita a te. Oltre che giusto, per sentirci umani, è anche il modo meno pericoloso e meno vergognoso di vivere. E’ illusorio un ottimismo sistematico, è distruttivo un pessimismo sistematico. E’ intelligente e benefico osservare e ricordare che siamo tutti capaci di bene e di male, e che dunque l’intero cammino umano può procedere alla morte o alla vita, al nulla o all’essere. Impariamo e tratteniamo la lezione alta di questo momento di grazia, di verità umana, riflesso di una più alta verità, che sempre ci sollecita. Non c’è sentenza piena sull’esistenza. Si tratta di farla vera, buona. Vorrei parlare di ottimismo dell’ostinazione, della tenacia, che ogni volto umano bisognoso ci impone, al cuore prima che alla politica. Buona domenica! (fonte: Azione Nonviolenta, rivista del Movimento Nonviolento) link: http://www.azionenonviolenta.it/storia-bene-male-giorni-di-grazia/ Evidenza Corpi civili di pace: “avviare al più presto la sperimentazione” (di Gabriella Lanza) Dopo due anni dalla approvazione dell’emendamento che istituisce i corpi civili di pace, il progetto deve ancora partire. “Entro il 2016 vogliamo che 500 giovani portino nel mondo un nuovo concetto di pace ma bisogna fare presto”, afferma Marcon, promotore della proposta di legge Due anni di ritardo sono tanti, la sperimentazione dei Corpi civili di Pace deve partire al più presto”. Per Giulio Marcon, deputato di Sel e promotore della proposta di legge che permette a gruppi di giovani volontari di svolgere azioni di pace nelle aree di conflitto, il tempo ormai è agli sgoccioli. L’avvio del progetto era previsto dalla legge di stabilità del 2013 ma ancora non sono stati presentati i decreti attutativi. Oggi durante il tavolo di discussione “Corpi civili di Pace, tra sperimentazione e stabilizzazione”, associazioni e rappresentati del Governo hanno cercato di fare un punto della situazione. “In Italia è più facile cambiare la Costituzione che far partire la sperimentazione dei Corpi Civili. Il nostro obiettivo è quello di ripensare il concetto di pace: non servono le armi per difendere un Paese. Quasi 4000 persone in Italia hanno già fatto esperienze all’estero di questo tipo”, continua Marcon. Resta poco più di un anno per dare inizio alla sperimentazione dei Corpi Civili: “Dobbiamo selezionare 500 giovani in 15 mesi. Abbiamo paura di non poter rispettare i tempi. Chiediamo al Governo l’impegno di far partire i primi giovani entro la fine del 2016”. Bisogna poi capire come passare dalla sperimentazione alla stabilizzazione. “Abbiamo presentato una proposta di legge firmata da 70 parlamentari di diversi schieramenti politici. Ora aspettiamo delle risposte dal Governo”, conclude Marcon. Il testo presentato definisce i Corpi Civili di Pace come gruppi operativi non violenti e non armati formati da operatori di pace, volti a realizzare attività di prevenzione, mediazione, costruzione della pace e ricostruzione civile nelle aree di conflitto. Hanno l’obiettivo di promuovere la riconciliazione e prevenire conflitti armati. In concreto i giovani volontari dovranno sostenere i processi di democratizzazione, monitorare il rispetto dei diritti umani e dare sostegno a profughi, sfollati e migranti e alle popolazioni che fronteggiano emergenze ambientali. A gestirli sarà l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile. Prima di partire dovranno seguire un corso formativo di almeno 400 ore. Nella proposta si chiede anche di estendere i progetti a tutti i cittadini italiani e stranieri tra i 18 e i 65 anni. Il sottosegretario per le Politiche sociali parla al tavolo di discussione sui Corpi civili di Pace: “Siamo in ritardo ma ce la faremo. La nostra priorità resta quella di garantire la sicurezza ai giovani volontari” Luigi Bobba, sottosegretario per le Politiche sociali con delega al servizio civile ha risposto alle associazione riunite al tavolo di discussione “Corpi civili di Pace, tra sperimentazione e stabilizzazione” che da due anni chiedono l’avvio del progetto: “C’è la volontà di dare inizio a una sperimentazione seria, siamo in ritardo ma ce la possiamo fare”. Non manca però di sottolineare i punti critici di un piano che è ancora tutto in divenire: “Non sappiamo ancora bene come definire i Corpi civili di pace. I giovani devono svolgere compiti non facili in situazione di conflitto o di post conflitto senza mettere a rischio la propria vita. Per questo dobbiamo muoverci negli ambiti e nelle regole dettate dal Servizio civile all’estero”. Sul rischio che solo realtà associative già affermate in operazione di pace possano accedere al progetto, Bobba rassicura: “I soggetti già abilitati possono unirsi a realtà che non hanno ancora esperienza e arricchire in questo modo il panorama di riferimento”. Altro nodo da sciogliere è l’accesso ai Corpi Civili di stranieri residenti in Italia: “Non abbiamo voluto estendere anche a loro il servizio civile perché solo i volontari italiani possono essere protetti nelle nostre ambasciate. Dobbiamo trovare le modalità per ampliare questo status di protezione anche agli stranieri”. Le associazioni hanno poi chiesto a Bobba di instaurare una collaborazione più forte con il ministero degli Esteri: “Ci sono delle aperture, la Farnesina guarda con attenzione e interesse a questa sperimentazione”, ha risposto. “Il nostro impegno”, ha concluso Bobba, “è quello di far partire subito il comitato di monitoraggio e di rispettare i tempi stabiliti. Vogliamo però essere sicuri di garantire a questi giovani la loro sicurezza personale. Solo così il progetto potrò essere efficace e utili per le popolazioni che si trovano in situazioni di conflitto”. “I volontari – ha assicurato Bobba – partiranno entro la fine del 2016” Non sorprende quindi che in cima alla classifica si trovino tutti paesi emergenti, i cui sistemi politici sono spesso traballanti, e le cui economie presentano certamente falle consistenti. D’altro canto, però, i suoi abitanti hanno imparato a convivere con questi limiti, che saggiamente tendono ad allontanare dalle loro tavole da pranzo e neutralizzare con le piccole grandi felicità che la vita gli regala. Il Guatemala ha il potere di insegnare tante cose a un visitatore. Viviamo in un’epoca in cui il dato dello stato di salute di un paese non è più riflesso nell’indice di ricchezza economica, espresso dal PIL. Si tratta ormai di un fatto assodato, che trova il consenso delle istituzioni, dei mercati, addirittura dagli organi più accaniti del neoliberismo. Celebri le critiche dei premi Nobel Paul Samuelson, o dei più recenti Amartya Sen e Joseph Stiglitz, ambedue autori di statistiche alternative, nonchè delle due testate economiche più famose al mondo, il Wall Street Journal e il Financial Times, quest’ultimo che parlava di come il PIL fosse diventato un’ossessione globale. Altro non è che un’invenzione recente, una convenzione strumentale voluta e imposta da una squadra di burocrati, supportata da una marea di economisti. Un’astrazione statistica che, oltre ad essere imprecisa, non considera determinati aspetti della società, come l’istruzione, la qualità delle cure mediche, le condizioni dell’ambiente, la serenità e la sincerità delle persone; non misura la bellezza dell’arte, la solidità dei rapporti familiari, l’intelligenza del dibattito pubblico o l’onestà dei suoi esponenti. Ciò che include invece sono le sigarette, le spese per gli incidenti stradali, gli antifurti, la distruzione delle foreste, le armi di distruzione di massa, le forze dell’ordine per combattere le rivolte nelle nostre città, i programmi televisi che incitano alla violenza e diseducano i nostri figli. In sistesi, citando le parole di una personalità come Bob Kennedy: “il PIL misura tutto, eccetto quello che rende la vita degna di essere vissuta”. Articolo di Gabriella Lanza per il Redattore Sociale (fonte: Azione Nonviolenta, rivista del Movimento Nonviolento) link: http://www.azionenonviolenta.it/corpi-civili-di-pace-avviare-al-piu-presto-lasperimentazione/ Approfondimenti Economia Qual è la vera ricchezza di un paese? (di Marco Grisenti) Credo sia importante cercare di rispondere a una domanda tra tante: perchè tanti Europei e Nordamericani, giovani e meno giovani, hanno interesse a trasferirsi in un paese come il Guatemala? Bene. Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un coraggioso sondaggio promosso dal Sole 24 Ore che proponeva una classifica dei paesi per la qualità della vita condotta dai suoi abitanti, a prescindere dal PIL. L’inchiesta si basava su una serie di quesiti di ordine generale, rivolti vari segmenti delle popolazioni, da cui si traevano gli spunti per creare dei profili di benessere quotidiano nazionali. Si trattava di esperienze quindi, non di indicatori ufficiali. La classifica dava i cittadini del Paraguay come i più soddisfatti della propria qualità di vita, mentre al quarto posto il lettore trovava proprio il Guatemala. Ora, tralasciando il presupposto velatamente utopistico dell’inchiesta, probabilmente ognuno di noi, chiamato a farlo, stilerebbe una classifica diversa, ricamata sulla propria esperienza personale (un immaginario giro del mondo, in qualcosina più di 80 giorni). Perchè la natura stessa dell’argomento è molto sensibile ai soggettivismi. Tuttavia, c’è sempre un fondo di verità che viene a galla, anche in questi casi. È pur vero che paesi come il Guatemala sono divorati dalla povertà e perseguitati da problemi di risonanza mondiale, che fanno storcere il naso anche dall’altra parte del mondo. Ma è altrettanto vero che la maggior parte della gente si accontenta di molto meno per definirsi “felice”, rispetto a un occidentale. Le persone possiedono uno stile di vita più semplice, e il loro motto potrebbe essere riassunto in un laconico: meno si ha e più si apprezza ciò che si ha. 3 Chi trae vantaggio da un PIL molto alto? Il Guatemala cresce stabile a un tasso annuale medio del 3,60% circa dal 2002 (4,80% il primo trimestre 2015), mantiene un’inflazione sistematicamente inferiore e le previsioni sono altrettanto positive. Ciò che risulta meno positivo invece sono le facce dei lavoratori guatemaltechi di fronte ai propri salari minimi. Difficile spiegargli il progresso economico quando vedono cambiare un numero all’interno dei conti dello Stato, però ancora non lo vedono nelle proprie buste paga, quei pochi che ne ricevono formalmente una. Questo a pesare sul fatto che un paese va visto e vissuto, vanno esplorate le sue case, compresi i suoi sentimenti. Che la Cina presto riesca a superare gli Stati Uniti o che il Brasile sia la prima economia Latinoamericana conta molto relativamente. Probabilmente è giunto il momento di adottare altri tipi di indicatori, che guardino meno ai meri aggregati di spese nominali, e indaghino maggiormente sul benessere delle persone e dei ceti meno abbienti. Credo che anche da parte degli investitori stranieri debba affermarsi questo tipo di sensibilità volta a procurare maggiore salute sociale e ambientale a una comunità, a fianco al valore economico. Vogliamo davvero che negli anni a venire paesi come il Guatemala crescano sul modello di ispirazione capitalistica statunitense, o nella frenesia e totale assenza di tutela del paesaggio che hanno attraversato molti paesi industrializzati a suo tempo? Io non credo. La buona notizia è che si stanno sviluppando indicatori ben più completi e accreditati. Utile quello elaborato dallo stesso Amartya Sen per le Nazioni Unite, chiamato Human Development Index (indice dello sviluppo umano), che di fatto arricchisce il PIL misurando, tra il resto, la qualità della salute e dell’istruzione. Ma perchè lo HDI non riceve abbastanza attenzione? Perchè il suo uso è fondamentale soprattutto per le categorie più povere. La popolazione ricca s’interessa di più del PIL perchè è lì che si concentrano i loro massimi benefici. Usare statistiche alternative significa anche dirottare l’attenzione sulle ONG, sulla cooperazione e il terzo settore, di cui quasi non si parla. Vi sono poi altri studi come quello promosso dall’ONU, chiamato World Happiness Report, che mira a ordinare i paesi del mondo per “felicità interna lorda”, o il Genuine Progress Indicator, che misura lo sviluppo economico integrando nella somma dei ricavi generati a livello nazionale anche i fattori ambientali e dunque i costi legati al consumo delle risorse naturali. Forse, però, il più rigoroso è l’indicatore che prende il nome di Social Progress Index (indice di progresso sociale), promosso dalla non profit Social Progress Imperative, che racchiude in un’unica macro-misura componenti di performance sociale e ambientale, sintomatici dello sviluppo di benessere di una nazione. La differenza rispetto ai precedenti è che il SPI tiene traccia direttamente dei risultati sociali e ambientali raggiunti da una nazione, più che di fattori esclusivamente economici, e può essere letto in sostituzione degli altri indicatori. In sintesi, pare che si sia imboccata la strada giusta, anche se c’è sempre il rischio di una moltiplicazione feroce di questi indicatori, spesso ridondanti, che non fanno altro che bombardare il lettore di dati, fornendogli informazioni poco chiare e pratiche. O peggio, esponendolo a delle falsità. Mai dimenticarsi dei danni causati da dati falsi, soggettivi, mal interpretati, mal selezionati, o ahimè dalla sovrabbondanza di dati. In ogni caso, il punto fondamentale è che il mondo non è fatto solo di mercificazione monetizzabile ma, soprattutto, di persone e capitale intangibile sociale che detta il vero status di un paese, e lo rende più o meno vivibile rispetto ad altri. Sennò perchè una persona di un paese “sviluppato” avrebbe interesse ad andare a vivere in Guatemala? Il fascino di vedere un mondo più autentico, i pensieri che si celano dietro il sorriso di una famiglia, di una signora intenta a tessere una tela per sua figlia, di un agricoltore felice di accoglierti nella sua terra, sono insegnamenti che, credo, mettano tutti d’accordo. Sono anche i piccoli gesti che, indipendentemente dai numeri, alla fine, ti rendono orgoglioso di far parte di un popolo. Marco Grisenti (fonte: Unimondo newsletter) link: http://www.unimondo.org/Notizie/Qual-e-la-vera-ricchezza-di-un-paese152637 Immigrazione I fratelli e le sorelle di mare e di terra (di Alessio Di Florio) “Certe crisi son soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire” cantava il sommo maestrone Francesco Guccini già nel 1970. E a furia di urlare, alle frontiere di quest’Europa in crisi e che più di qualcuno già vede morente, alla fine è uscito un fiume impetuoso, un uragano che tutto travolge. Le migliaia e migliaia di migranti protagonisti di quest’estate, da Ventimiglia a Calais, da Lesbo alle frontiere ungheresi partono, viaggiano, protestano, sperano e disperano mossi dai più elementari bisogni e necessità umane ma la loro r-esistenza e presenza racconta e vale molto di più. Dall’essenza dell’umano vengono le lezioni e le stelle polari più forti e profondi. Per l’Europa ma soprattutto per quel vasto arcipelago che si definisce “di sinistra”, ripiegato e alla ricerca di se stessa tra dialoghi tra ceti politici, soluzioni più o meno verticistiche, nostalgie canaglia, tentazioni leaderistiche e tutto il vasto armamentario che, in Italia ma non solo, ben conosciamo. I fratelli e le sorelle del mare e di terra sono avanti, sono oltre tutto questo e chiedono, a chi oggi zoppica sulla terra, di volare alto, molto in alto. E, per farlo, è doveroso ripartire dall’essenziale, dal cuore di tutto. Le cronache di questi mesi, e specialmente di questi ultimi giorni, ci documentano e dimostrano la crisi della “fortezza Europa”, delle politiche sicuritarie e criminogene in Italia portate avanti con la Turco-Napolitano, la Bossi-Fini e i decreti sicurezza di Maroni e Berlusconi, l’ipocrisia dei maggiori trafficanti di armi e guerre al mondo (insieme agli Usa) che mentre sventolano pseudo nobili e alti vessilli democratici, liberali e di tolleranza fanno affari con coloro che a parole dicono di combattere. Isis compreso. 4 Aylan veniva da Kobane, la città divenuta simbolo della resistenza kurda e della lotta contro l’autoproclamato califfato islamico. Kobane e i kurdi non hanno mai lanciato proclami, hanno fatto la cosa più semplice e immediata di questo mondo: combattuto, resistito, difeso la propria vita ed esistenza. Ed hanno vinto. Davanti a tutto questo in Occidente abbiamo letto e sentito proclami, allarmi, roboanti dichiarazioni d’intenti che non si sono mai concretizzati di nulla. Mentre si realizzava l’opposto e, in maniera più o meno diretta, si favoriva e si finanziava proprio l’Isis. Ogni tanto la nostra grande stampa scopriva Kobane e le combattenti kurde. Definite eroine, osannate e acclamate. Fino all’inizio dell’offensiva di Erdogan, quando chi realmente, concretamente, ogni giorno lotta e vince contro l’Isis è tornato ad essere considerato criminale e terrorista. Perché nei mesi dei proclami europei e della lotta kurda il Pkk di Apo Ocalan neanche per un secondo è stato tolto dalla lista nera di Europa e Stati uniti. Tutto questo e molto più ci raccontano le immagini e i video di queste settimane. Immagini e video che impongono un punto fermo, che chiedono lineari e coraggiose prese di posizioni. Quelle immagini sono la tappa odierna di una Storia vera e profonda, che affonda le radici nei più nobili capitoli del libro dell’Umanità. Come il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, i partigiani italiani ed europei contro il nazifascismo, gli autentici internazionalisti, le voci coraggiose e indipendenti che hanno denunciato oppressioni e sfruttamento, mafie e dittature, sono pronti a scrivere pagine di dignità e libertà, di vera umanità e progresso. Ma chiedono scrittori e voci pronte, orecchie attente e occhi non aperti soltanto a metà. (fonte: Comune-info - Associazione Persone Comuni) link: http://comune-info.net/2015/09/migranti-4/ Politica e democrazia Pietro Ingrao e la sfida del femminismo (di Lea Melandri) Per capire quanto fosse radicale la sfida che il femminismo, da luoghi considerati tradizionalmente “non politici”, veniva facendo al modello di civiltà maschile, basta leggere la conversazione che Rossana Rossanda fece con Pietro Ingrao all’interno di un ciclo di trasmissioni per Radiotre nel 1978: Ingrao È che affrontare le questioni dell’emancipazione femminile comporta affrontare punti di fondo dell’organizzazione della società in generale. Ti faccio un esempio: se vuoi affrontare davvero il rapporto donna/uomo, devi investire caratteri e dimensioni dello sviluppo, occupazione, qualità e organizzazione del lavoro, fino allo stesso senso del lavoro. Contemporaneamente – ecco dove la dimensione diventa diversa – vai a incidere sulle forme di riproduzione della società, sul modo di concepire la sessualità, i rapporti di coppia, i rapporti tra padri e figli, l’educazione, il rapporto tra passato e presente, forme e natura dell’assistenza, eccetera. Cioè una concezione storica, secolare del privato, tutta una concezione delle stato, tutto il rapporto tra stato e privato (…) Rossanda Le donne sono portatrici di una visione della società fortemente interiorizzata nel privato, perché il privato è stato il campo dove sono state collocate, dal privato hanno assunto valori e norme, hanno derivato un modo di essere e quindi un’idea della comunicazione e dei rapporti. Bene, questo è un loro limite o un loro valore? Se è un limite, la questione femminile è essenzialmente un ritardo; le donne devono imparare la politica e la politica deve facilitare la loro ammissione. Ma se non fosse così? Non viviamo in questi anni un dubbio sui principi dell’organizzazione politica della società, una critica alla sua astrattezza, una tendenza riportare l’accento sulla persona? In questo la specifica esperienza dei rapporti fra persone della donne non può rappresentare un pesare sull’organizzazione tradizionale della sfera politica, modificarla?” (Rossana Rossanda, Le altre, Feltrinelli 1989, p.217) Non dovrebbe stupire il fatto che venga da parte di un uomo la visione più radicale della posta in gioco: l’uscita dalla logica della complementarità, del semplice ribaltamento di un disvalore in valore, della “mancanza” in un “di più”, di un riequilibrio di poteri che non intacca alla radice la dualità su cui si è retto finora il dominio maschile. (fonte: Comune-info - Associazione Persone Comuni) link: http://comune-info.net/2015/09/pietro-ingrao-e-la-sfida-del-femminismo/ Prospettiva di genere Il genere nel linguaggio (di Redazione Combonifem) Correva l’anno 2012 e il mese di aprile quando, per la prima volta, scrivemmo un pezzo su Combonifem magazine, sottolineando la necessità di un linguaggio che declinasse alcune parole al femminile, riconoscendo un cambiamento dei tempi certo, ma, ancora di più, il fatto che diverse cariche istituzionali e professioni lavorative venivano ricoperte da donne. Da qui, commentavamo, la necessità di avere termini rispondenti alla realtà. Perché chiamare le persone per nome significa riconoscerle. Se il ministro per le Riforme costituzionali è una donna, si dice ministra, scrivevamo, e se “non vi piace”, perché vi “suona male”, dovrete in qualche modo “farvelo piacere”, perché non è una questione di gusti ma di grammatica. Non c’è scampo! Nel dicembre 2013 lo scrisse anche l’Accademia della Crusca:«Non esistono due opzioni, il genere in grammatica è un parametro fisso come lo è un numero, è un meccanismo regolatore della nostra lingua». Nel luglio 2014 l’associazione Giulia (acronimo di Giornaliste unite libere e autonome) presentò alla Camera dei Deputati una guida, Donne, grammatica e media. Un piccolo libretto, comprensivo di un glossario che facesse un po’ di chiarezza sulla declinazione dei termini riferiti a cariche o professioni. Oggi, settembre 2015, anche l’Ordine dei giornalisti, grazie al Gruppo di lavoro Pari opportunità del Consiglio nazionale, arriva a pubblicare una guida: Tutt'altro genere di informazione. Manuale per una corretta rappresentazione delle donne nell'informazione. Il testo parte dalla rappresentazione che i media fanno della donna, analizzando i titoli di giornali e telegiornali, quando la donna fa notizia o è chiamata a commentarla (un quadro piuttosto sconfortante a dire il vero), per arrivare a elencare (con casi di studio concreti) le cattive pratiche che veicolano stereotipi di genere, palesi o sottili, e a indicare linee guida e raccomandazioni. Non leggeremo più “il ministro della Salute è incinta” (che, vogliamo dirlo?, non ci vuole un manuale perché salti all’occhio la discordanza)? In realtà il cammino è lungo. Il linguaggio è la declinazione del pensiero. E questo ci dice che il problema è culturale, riguarda gli stereotipi che circondano il femminile, la rappresentazione comune che si ha della donna. È anche vero che spesso rappresentazione e realtà non coincidono e allora è proprio partendo da quel che ci circonda, da quel che le donne sono riuscite a conquistarsi nel tempo, che dobbiamo ripartire. Dal dato di fatto che oggi ci sono ministre, avvocate, notaie, architette, chirurghe e… una cancelliera! Il compito di usare termini corretti però non appartiene solo ai media (che dovrebbero riappropriarsi del compito di informare e formare), ma anche alla famiglia, alla scuola, alla società intera. Il linguaggio riguarda tutti e attraverso il linguaggio passa il riconoscimento e il rispetto. Per cui è davvero tempo che ci diate del lei! (fonte: ComboniFem - Newsletter Suore Comboniane) link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2350 Società La magia del libro e delle librerie: intervista ad Andrea Geloni (di Andrea Geoloni) Cosa ti ha spinto ad aprire una libreria? 5 È quello che ho sempre voluto fare. Solo che pensavo fosse impossibile campare vendendo libri (e in effetti un po’ lo è). Come pensi sia cambiato il lavoro del libraio negli ultimi 10 anni? Lo faccio da meno di dieci anni, ma anche confrontandomi con i colleghi credo che il lavoro del libraio indipendente sia da una parte più complicato e dall’altro più stimolante. Non ti puoi sedere mai. Una base di competenze ci vuole, ma non puoi prescindere da un aggiornamento continuo, dal sapere di cosa si parla sui social e persino su Vanity Fair. Essere “sul pezzo” è fondamentale. Ma lo è anche non perdere di vista che siamo bravi solo se leggiamo. Ossia se poi chiudiamo i social e Vanity, e apriamo un libro. Una specie di doppia identità necessaria. So che è impossibile, ma se dovessi identificare un tuo cliente standard più o meno come lo descriveresti? Io sono un libraio fortunato. Ho molti clienti ai quali basta che dica “questo”: e sono soddisfazioni, perché vuol dire che il consiglio precedente è andato a segno. Ma forse professionalmente sono più importanti quelli che hanno anche qualcosa da insegnarmi, in un’ottica di scambio tra umili e appassionati lettori. Però il mio cliente standard è anche uno a cui piace chiacchierare, non necessariamente di libri. Forse siamo diventati presidi di scambi di umanità, in senso lato. Qual è la soddisfazione maggiore che ti da il tuo lavoro? Il vero libraio è san Giovanni Battista: noi indichiamo il Messia. Quando punto la pistolina sul codice a barre del Conte di Montecristo, e so che la persona che ho davanti sta per incontrare Edmond Dantès, e che quello sulla pistolina è l’umile dito che indica la luna: quello è il momento migliore. Cos’è che ti fa davvero cascare le braccia? Quelli che pensano che un libro sia una merce come le altre. Con tutto che pago le fatture e l’affitto come gli altri commercianti: ma chi pensa che un libro vada promosso con i trucchetti del marketing non ha capito nulla. Poi lo so che i grandi numeri si fanno anche coi trucchetti del marketing, ma preferirei che chi si occupa di grandi numeri tacesse su cosa vuol dire fare il libraio, che è un’altra cosa. A ciascuno il suo. E poi sì, lo devo dire: quelli che hanno il conto in Banca Etica e comprano i carciofi bio e lo zucchero integrale e poi però non si fanno problemi a comprare i libri su Amazon. La cosa più assurda che ti ha chiesto un cliente? A parte l’ormai vasta letteratura sugli strafalcioni – che fanno anche tenerezza, e li faccio anche io – la cosa più assurda, diciamolo, sono gli sconti. Gli sconti sui libri sono assurdi, e nei paesi civili infatti sono vietati, cosicché i libri costano meno per tutti. Noi ovviamente facciamo piccole promozioni (quel poco che è sostenibile) e sulle spese medie qualcosa levo, ma mi trovo davanti gente che da per scontato che io possa comportarmi come chi ha margini che sono più grandi dei miei anche di dieci volte. Poi capita che chi chiede lo sconto sul librino da otto euro poi ti chieda se è ancora in commercio il fotografico nel quale si parla della villa medicea ove risiede. Giuro, è successo. Mentre chi conosce davvero il valore dei soldi, e dei libri, è meno facile che chieda sconti. Il ricordo più bello della tua esperienza da libraio? Quando Vargas Llosa venne in libreria e mi pagò con la carta, e io vidi sulla carta “Mario Vargas Llosa” e pensai: ma guarda questo, oltre allo stesso nome ha anche una somiglianza impressionante. Giuro. E poi quando venne la Vanoni, canticchiando “L’uselin della comare”. E poi i clienti normali, quando vengono a farti vedere il bimbo appena nato, o quando portano gli amici. Ma non finirei più. Pensi che la presenza della tua libreria apporti un miglioramento al tuo quartiere/ alla tua città? Perché? Non è che lo penso: lo so. Ma non è che sto lavoro lo faccio io da solo. Lo fa anche chi frequenta le librerie indipendenti. Un centro storico senza una libreria – e purtroppo ce ne sono tanti - è come un cono senza il gelato. Però tanti si lamentano solo quando le librerie chiudono, perché fa cittadino responsabile e attento. Bisognerebbe pensarci prima, finché le librerie sono aperte. Le istituzioni, certamente, ma anche le singole persone. Cosa può dare in più una libreria indipendente che i negozi delle grandi catene non possono dare? A parte la comodità per il cliente di non dover stare a spiegare al commesso che Tristram Shandy non è l’autore di Vita e opinioni, essere indipendenti per un libraio vuol dire promuovere quello che davvero ci piace e non quello che decidono gli uffici marketing che hanno pagato tot di diritti e devono rientrare delle spese. Essere liberi di mettere in prima fila il titolone della grossa casa editrice (perché è indubbio che spesso con maggiori mezzi si stampino autori migliori) ma anche di affiancarci il grande scrittore sconosciuto pubblicato dalla piccola casa editrice. E anche essere liberi di dire alla cliente che conosci bene, e che si fida di te: guardi che di quel libro secondo me può fare a meno. Ti capita di contribuire, nel tuo piccolo, al successo di qualche libro? Ehi, parli col suggeritore del titolo Morte dei marmi! Quindi certo che sì. A parte questo (che è una cosa a cui tengo tantissimo, anche perché è venuta chiacchierando, mentre Fabio Genovesi girottolava in libreria, senza brainstorming o indagini di mercato) è indubbio che nel sottobosco delle case editrici indipendenti le librerie indipendenti riescono a fare molto. Sono numeri che farebbero sorridere i grandi manager, ma che spesso fanno la differenza sia per noi che per loro. Poi ora coi social è tutto più semplice, sia fattivamente che in potenza, se riusciamo a fare sempre più rete. Se io so che a Fabrizio Piazza (libraio indipendente a Palermo) è piaciuto un libro, siccome c’è stima, so che un’occhiata gliela devo dare anch’io, e che probabilmente piacerà anche a me e ai miei clienti. Cosa ti spinge ad andare avanti in questa attività? Le mie socie, i miei clienti. E poi l’idea che sia possibile fare bene il proprio lavoro. Parlo del mio, certo, ma parlo di tutta la filiera. Dagli scrittori, agli editor, ai traduttori, agli editori, agli agenti, ai librai. Forse non si percepisce da fuori, ma se non ci fosse una passione fortissima, coi numeri che girano saremmo tutti a casa. Invece stringiamo i denti e resistiamo, non si sa nemmeno fino a quando, e a volte nemmeno a cosa stiamo resistendo. Ma sappiamo perfettamente, senza il minimo dubbio, che ne vale la pena. Andrea Geloni Libreria NINA Via Mazzini, 54 Pietrasanta (Lu) (fonte: http://matteobblog.blogspot.it) link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2349 Notizie dal mondo Europa Non c'è più tempo (di Osservatorio Balcani e Caucaso, Rivistailmulino.it) Tanti muri e filo spinato in quest'Europa a più di 25 anni dal crollo del Muro di Berlino. Ma non saranno le barriere a salvare gli europei, ma la capacità di dare risposte comuni e immediate alla crisi dei profughi. Un dossier co-prodotto da Osservatorio Balcani e Caucaso e la rivista Il Mulino. Dopo avere considerato per decenni il Muro di Berlino come simbolo dell’arretratezza culturale e ideologica, oggi scopriamo che l’Europa in cui abbiamo creduto è piena di barriere, filo spinato e cemento armato. La strada compiuta dai primi accordi del dopoguerra verso una vera unione politica è tanta, forse non è mai stata sottolineata a sufficienza e ha 6 sofferto dello stile così poco amichevole uscito dalle scrivanie di cristallo di Bruxelles. Tuttavia, il senso di appartenenza a un’idea davvero larga e comune, culturale ancor prima che politica, scompare di fronte ai drammi umanitari prodotti dalle nostre frontiere stato-nazionali. Che fine ha fatto l’Europa unita che avevamo immaginato di poter realizzare, seppure poco alla volta? I due punti di riferimento che ci hanno permesso di sentirci parte di una entità più grande, non solo geografica, in certi momenti quasi di una comunità - Schengen e la moneta unica - sono a rischio. Ogni giorno emergono fratture e disconnessioni gravi, con alcuni paesi membri sempre meno disponibili a ragionare in termini di politiche comuni. Eppure negli anni gli appelli alla necessità di una maggiore integrazione non sono mancati. Ma sottovalutando le conseguenze del populismo e lasciando incompiuta la riunificazione europea post-’89, siamo arrivati alla situazione attuale. Con i muri e le barriere ottieni anche una rimozione culturale dell’altro. Alla fine della guerra fredda, infatti, quando l’Europa si è ricomposta abbiamo fatto una fatica tremenda a ritrovarci. Basti pensare alle modalità con cui si è ottenuto l’allargamento dell’Ue: sono serviti cinque anni solo per formulare i criteri di Copenaghen, vale a dire una promessa vaga e scontata di integrazione europea, mentre da decenni i paesi centroeuropei attendevano il loro “ritorno in Europa”. Mentre l’Europa post-comunista sprofondava nella cosiddetta transizione pagando un prezzo altissimo in termini sociali, Unione Sovietica e Jugoslavia si disfacevano in solitudine. Solo la Germania si affannava, ma per compiere la sua stessa riunificazione. Negli anni Novanta, abbiamo ampiamente deluso le aspettative dell’Est anche con l’accoglienza riservata ai profughi balcanici e ai migranti interni alla casa comune europea: per paura dello scafista albanese o dell’idraulico polacco. Ventisei anni dopo la tremenda frattura tra l’Est e l’Ovest è ancora da sanare. Continuiamo a ignorare tutta la storia politica, economica e sociale dell’Europa centro-orientale e non abbiamo affatto rielaborato quel fallimento ideologico. Incompiuta la riunificazione culturale dell’Europa, oggi ci sentiamo assediati dal mondo esterno e ci ritroviamo in balia della paura: della competizione economica con i paesi emergenti, del terrorismo internazionale, dello scontro militare con la Russia, dei rifugiati. Paura, sostanzialmente, di perdere il benessere conquistato. Da decenni parliamo di globalizzazione, ma per rispondere alle minacce e alle sfide transnazionali a essa collegate (crolli in borsa, terrorismo, guerre, migrazioni) ci illudiamo ancora del rifugio offerto dalla comunità nazionale e della protezione dei muri. Evidentemente, il contagio economico della crisi del 2008 non ci è bastato. Pensiamo seriamente di poter evitare da soli le conseguenze delle guerre in paesi che immaginiamo ancora lontani. Ma come poteva rimanere localizzato in Turchia il problema della gestione di milioni di profughi dalla Siria? E come potevamo rimanere estranei alla dissoluzione dell’Iraq - che per altro abbiamo provocato noi con una guerra pretestuosa? Impreparati a tutto ciò che richiede interventi politici sovranazionali o transnazionali, ci mostriamo sempre pronti alla bisogna a calpestare i principi liberali predicati fuori casa. Ogni giorno accettiamo gravi violazioni dei diritti umani, ignorando del tutto gli insegnamenti del recente passato europeo. Gli albanesi che morivano a migliaia per attraversare l’Adriatico negli anni Novanta sono arrivati comunque in Italia e oggi costituiscono una comunità bene integrata di mezzo milione di persone. Quando perdono il lavoro tornano a emigrare altrove: in Canada, in Svizzera, in Germania. Perché l’immigrazione si sposta là dove c’è crescita economica. Dalla società civile europea arriva la spinta a trovare soluzioni impellenti per aiutare chi fugge a rischio della vita. Non saranno le barriere, il cemento e il filo spinato a salvare gli europei, ma la capacità di dare risposte comuni e immediate alla crisi dei profughi cogliendo la sfida umanitaria come occasione di crescita politica. Non c’è tempo da perdere: ragioniamo subito sulle proposte concrete di revisione delle procedure per la richiesta di asilo e lavoriamo per rendere possibile la domanda di accoglienza nelle delegazioni Ue nei paesi a rischio o nei primi paesi di approdo. Le soluzioni provvisorie, incomplete, rendono ancora più precaria la gestione di un evento di cui possiamo prevedere la portata storica ma non le conseguenze umanitarie, politiche ed economiche. E, naturalmente, accrescono la forza dei nazionalismi e costituiscono un carburante straordinario per i populismi. La sfida migratoria ci pone davanti a un interrogativo simile a quello che Renan si pose a fine Ottocento a proposito della nazione: se l’Europa sia tenuta insieme solo da una comunione di interessi o se conti ancora qualcosa anche una vera comunanza di princìpi. (segnalato da: centro Studi Sereno Regis) link: http://www.balcanicaucaso.org/aree/Europa/Non-c-e-piu-tempo-164312 Palestina e Israele Resistenza nonviolenta in Palestina: fermezza, creatività e speranza (di Katherine HughesFraitekh) “Non voglio che i miei figli vivano una vita come la mia. Per i miei bambini, e per tutti i bambini, io cerco un futuro senza occupazione e senza violenza. Dobbiamo avere speranza e resistere. Nota dell’editore: l’8 giugno 2015 Iyad Burnat di Palestina, uno dei leader di spicco della resistenza nonviolenta, è stato insignito del James Lawson Award per gli Obiettivi Conseguiti nella Pratica del Conflitto Nonviolento. Il premio, istituito nel 2011, è conferito durante un incontro annuale sull’educazione ai conflitti nonviolenti, organizzato dall’International Center on Nonviolent Conflict (ICNC) in collaborazione con la Fletcher School of Law and Diplomacy della Tufts University in Massachussetts. Durante il suo discorso di ringraziamento e nel corso di un’intervista in collegamento video con Amber French e Katherine Hughes-Fraitekh del ICNC, Iyad ha parlato delle motivazioni che sostengono il movimento capeggiato dal villaggio di Bil’in, dei passaggi chiave nella costruzione e nel mantenimento del movimento, delle strategie e delle tattiche usate, dell’importanza di Israele e delle alleanze internazionali, delle lezioni apprese durante il percorso e della strada ancora da percorrere. Per Iyad Burnat, la resistenza nonviolenta è centrale nella vita di tutti i giorni come lo è l’ulivo dal tronco attorcigliato attorno a cui si sviluppa il suo villaggio natale di Bil’in, nei territori occupati della Cisgiordania. Padre amoroso di cinque figli, con un ampio sorriso e occhi profondi e penetranti, è riconosciuto non solo in Palestina ma anche tra accademici e voci influenti in tutti il mondo come un coraggioso “leader tra i leader” in un movimento esemplare di resistenza nonviolenta. Negli scorsi decenni immagini e filmati della resistenza di Bil’in si erano già diffusi in tutto il mondo, in larga misura grazie all’impiego, tipico del movimento, di azioni creative che hanno man mano attirato l’attenzione della stampa internazionale. Il movimento ha acquistato poi una visibilità significativa, soprattutto negli Stati Uniti, nel 2012, quando il film Five Broken Cameras (girato tra l’altro dal fratello di Iyad, Emad Burnat) ha ricevuto una nomination come miglior documentario all’Academy Award. La nomination ha contribuito a far conoscere gli sforzi straordinari di un piccolo gruppo di agricoltori palestinesi che con azioni e strategie nonviolente cercano di respingere l’occupazione israeliana e di fermare l’esproprio delle terre finalizzato alla costruzione di insediamenti illegali e muri divisori. 7 Inizialmente, Iyad si unì al movimento pluri-decennale di resistenza nonviolenta in Palestina come allievo e membro del comitato di una scuola di Bil’in. Da allora, lui e la sua famiglia sono stati vittime di forti repressioni sotto l’occupazione. All’età di 17 anni fu arrestato dall’esercito israeliano e costretto, sotto interrogatorio, a firmare una confessione scritta in ebraico – a lui incomprensibile – relativa a crimini che non aveva commesso. Fu quindi condannato a due anni di carcere minorile in una prigione nel deserto, il che lo costrinse poi a laurearsi in ritardo, rovinando la carriera da medico che lo attendeva. Nel 2014 uno dei suoi figli è stato colpito a una gamba da un proiettile sparato a freddo da un soldato, mentre marciava di fianco al padre in una manifestazione nonviolenta, incidente le cui conseguenze soffre ancora oggi. Nonostante tutto, nel corso degli anni Iyad non ha smesso di ripetere il suo messaggio. “Noi non abbiamo niente contro gli ebrei; ma siamo contro l’occupazione isrealiana.” Da Bil’in alla scena internazionale Bil’in è stato uno dei primi villaggi (insieme a Budrus e Jayyous) a organizzare una resistenza nonviolenta contro il muro, giudicato illegale secondo le norme internazionali perché il progetto prevedeva che passasse attraverso i territori occupati, invece che lungo quella Green Line che è il confine attuale tra Isreale e i territori palestinesi. In risposta a questa sfida, nei primi anni 2000 Iyad e altri membri della sua comunità si allearono con altri villaggi in tutta la Cisgiordania e, più di recente, anche nella striscia di Gaza. Pur trovandosi ad affrontare una continua repressione da parte dei soldati e dei coloni israeliani – che include violenze, arresti, torture, irruzioni notturne nelle case, rapimenti di bambini e uccisioni di attivisti disarmati – , i palestinesi di Bil’in e degli altri villaggi hanno continuato a resistere in maniera nonviolenta. Da menzionare, tra le tante modalità, una marcia con cadenza settimanale che si ripete ogni venerdì da più di dieci anni. Queste proteste settimanali, che continuano ad attirare nuovi partecipanti, sono la punta dell’iceberg di questo movimento nonviolento sempre più vivo e degno di attenzione, che trae ispirazione da grandi personaggi come Gandhi, Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela, ma anche dall’esperienza diretta della Palestina nella lotta nonviolenta all’inizio degli anni ’30 e, in seguito, nei primi e nonviolenti aspetti della seconda intifada. Agli attivisti locali si sono progressivamente uniti numerosi alleati da tutto il mondo: israeliani, palestinesi residenti all’estero, comunità dal nord e dal sud del mondo. Forti le parole di un visitatore, il premio Nobel sudafricano Desmond Tutu, durante la sua visita al villaggio di Bil’in: “Proprio come un uomo semplice qual era Gandhi ha guidato con successo il movimento nonviolento in India, e persone semplici come Rosa Parks e Martin Luther King hanno condotto la lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, persone altrettanto semplici stanno portando avanti qui a Bil’in una lotta nonviolenta che li porterà alla libertà.” Personaggi di calibro internazionale che hanno partecipato alle proteste settimanali a Bil’in i premi Nobel Mairead Maguire, irlandese, e Desmond Tutu, sudafricano; • Luisa Morgantini, ex Vice Presidente del Parlamento Europeo; • Jimmy Carter, ex Presidente degli Stati Uniti; • Mary Robinson, ex Presidente dell’Irlanda; • Gro Harlem Brundtland, ex Primo Ministro della Norvegia; • Fernando Henrique Cardoso, ex Presidente del Brasile; • Ela Bhatt, avvocato indiana che lotta per i diritti dei poveri e delle donne. Alcuni di loro, tra cui Luisa Morgantini e Mairead Maguire, hanno riportato ferite durante la protesta. Burnat spiega che la spinta alla resistenza dei palestinesi è radicata nella loro realtà quotidiana – la vita e l’ambiente circostante, sotto l’occupazione, insegnano loro a resistere. “Ho imparato molto da Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela, ma più ancora me l’ha insegnato la vita. Quando lotti e vivi sotto occupazione, quando soffri ogni giorno, impari a resistere. È una cosa che viene dalla vita. La lotta nonviolenta viene dalla vita. Noi siamo persone semplici, e la resistenza nonviolenta è parte delle nostre vite.” Creatività contro repressione, e con successo Iyadi parla poi del processo di elaborazione di quelle tattiche creative e sempre diverse che sono il tratto distintivo del movimento di resistenza del villaggio. I membri del Bil’in Popular Committee e il gruppo Stop the Wall Coalition si incontrano con cadenza settimanale per discutere e analizzare le ultime notizie, i temi chiave del momento e la situazione politica interna ed esterna, e propongono nuove idee e azioni mirate a conseguire obiettivi a breve termine e realizzabili, in linea con strategie di più ampio respiro. Queste idee e azioni sono poi messe in atto da alcuni membri del movimento dopo un’attenta scelta strategica del luogo e delle tempistiche. A ogni nuova lezione appresa, i metodi e le tattiche vengono migliorati e perfezionati. Questo processo è molto simile a quello attuato dai palestinesi di Gerusalemme Est, della Cisgiordania e della striscia di Gaza durante la Prima Intifada (1987-93), che fu caratterizzata da un grande uso di azioni nonviolente, supportate da comitati locali di tutta la Palestina. Il processo decisionale nel Bil’in Popular Committee Bil’in si è fatta conoscere per le sue marce settimanali e per la creatività delle idee e la varietà delle tattiche nella resistenza nonviolenta. Ricordiamo gli attivisti che si sono legati agli ulivi che dovevano essere sradicati dalle ruspe per spianare il tracciato del muro; quelli che si sono chiusi in gabbie che necessitavano di una gru per essere rimosse; o quelli che si sono incatenati a pilastri d’acciaio piantati a terra. Trasportano case rimorchio e vi si barricano dentro per reclamare la propria terra rubata, imitando la stessa tattica usata dai coloni illegali israeliani. Gli agricoltori di Bil’in cercano anche di conquistare i soldati, offrendo loro dei fiori e scherzando con loro nel tentativo di stabilire una connessione umana, nonostante i soldati continuino ad arrestare, picchiare e a volte uccidere molti dei loro compagni. Adam Horowitz, vicedirettore di Mondoweiss, è testimone oculare di un raid notturno “Il 7 luglio alle 3:30 del mattino i soldati israeliani, interrompendo la quiete di Bil’in, hanno fatto irruzione in diverse case. Sono arrivati con una lista di dieci persone da arrestare. Quando gli attivisti palestinesi, israeliani e internazionali sono arrivati sul posto, le forze d’occupazione israeliane stavano maltrattando e intimidendo queste persone… Alla prima reazione degli attivisti e dei membri della comunità, i soldati li hanno caricati a colpi di manganello e granate. Intanto alcuni attivisti cercavano, con una barricata improvvisata, di impedire che le jeep se ne andassero. Le forze di occupazione hanno risposto con un fitto lancio di granate e si sono poi fatte strada attraverso la barricata, raggiungendo altre case lungo la strada. Là hanno arrestato un ragazzo e consegnato nove ingiunzioni di comparsa a famiglie di giovani che non erano presenti. Tutto questo senza alcuna spiegazione né avvertimento. Le jeep hanno poi sfondato una seconda serie di barricate e sono scomparse nella notte.” Un altro metodo di resistenza nonviolenta che la gente di Bil’in ha messo a punto è una precisa risposta a una forma di repressione che i soldati israeliani hanno cominciato a usare estensivamente nel 2009 e nel 2010 – i raid notturni nelle case dei residenti. Queste incursioni vogliono mettere paura alle famiglie, e hanno lo specifico obiettivo di individuare e arrestare bambini, al fine di far desistere le famiglie dal continuare la 8 resistenza. Per contrastare questa strategia, Iyad e il Popular Committee hanno avuto l’idea di intensificare le loro dimostrazioni e farle di sera, prendendo così per sfinimento i soldati che di giorno devono sorvegliare il muro e di notte contenere le proteste. Questa tattica ha portato a un’importante, seppur piccola, vittoria per Bil’in – i raid notturni non sono cessati del tutto ma sono diminuiti significativamente, passando da una frequenza giornaliera a uno o due a settimana. Così le famiglie hanno guadagnato un po’ di sollievo e non devono sopportare questi traumi ogni notte. Per preparare i propri bambini a una vita di lotte sotto occupazione, e per contrastare più efficacemente la violenza, gli abitanti di Bil’in spiegano loro il contesto del conflitto in cui si trovano e come resistere in maniera nonviolenta. Li educano quindi ad azioni e attitudini nonviolente, e li abituano a non considerare la vendetta come un’alternativa valida. I genitori cercano inoltre di gestire sentimenti incontrollabili di rabbia e frustrazione incanalandoli in gesti simbolici come gettare pietre o palloncini pieni d’acqua. (Nella letteratura sulla resistenza civile il lancio di pietre non è considerato una tattica nonviolenta. Molti palestinesi, tuttavia, obiettano che si tratta di un atto simbolico non inteso a ferire uomini israeliani, dal momento che essi dispongono di veicoli blindati e in generale di una potenza militare di gran lunga superiore. Per loro lanciare pietre significa mostrare capacità di azione e determinatezza nel resistere). I bambini sono anche incoraggiati e messi nella condizione di organizzare le proprie marce. Una di queste è catturata in Five Broken Cameras, dove si vedono i bambini marciare da soli mostrando ai soldati israeliani cartelli che dicono “Lasciateci dormire” o “Vogliamo dormire”, in riferimento ai raid notturni. Nel film si vede anche un dialogo toccante tra un padre e suo figlio, che non capisce perché i suoi genitori non rispondano alla violenza con la violenza o non proteggano se stessi e gli altri con la forza contro i soldati e i coloni israeliani. Obiettivi interni: ostruzione, copertura mediatica e coinvolgimento di attori internazionali Gli obiettivi interni della resistenza nonviolenta erano: far impennare il costo di costruzione del muro; delegittimare il muro e suoi sostenitori; ritardarne la costruzione, così da far guadagnare tempo alle azioni legali e alle strategie mediatiche. Questi obiettivi sono stati raggiunti. Il costo della costruzione è cresciuto vertiginosamente; molte voci dal mondo ora mettono in dubbio la legittimità del muro di separazione; e la sua realizzazione è stata ritardata di anni. Mentre la costruzione veniva ostacolata, la causa di Bil’in ha raccolto sostenitori in Israele e nella comunità internazionale, guadagnandosi il favore del “tribunale della pubblica opinione”. Contemporaneamente gli attivisti palestinesi hanno collaborato con avvocati israeliani alleati per discutere la loro causa legale contro la costruzione del muro nei tribunali civili israeliani (che godono di una relativa indipendenza rispetto ai tribunali militari israeliani attivi nei territori occupati). La loro tesi sosteneva che fosse illegale costruire un muro all’interno del confine riconosciuto a livello internazionale tra Israele e i territori occupati, e citava sentenze internazionali tra cui il cruciale Parere Consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 9 luglio 2004, che sosteneva la posizione dei palestinesi. Il 4 settembre 2007 Bil’in ottenne una grande vittoria, quando la Corte Suprema israeliana impose al governo di modificare il tracciato del muro dei pressi di Bil’in. Il Procuratore Capo Dorit Beinish scrisse nelle motivazioni della sentenza: “Non eravamo convinti che fosse necessario, per ragioni strategiche o di sicurezza, mantenere il tracciato del muro all’interno del territorio di Bil’in.” Il ministro della Difesa israeliano disse che avrebbe rispettato la sentenza, ma di fatto non hanno cominciato a smantellare una parte del muro per ricollocarlo altrove fino al 2011, dopo quattro anni di instancabili azioni nonviolente e pressioni affinché l’ordine venisse fatto rispettare. Questa sentenza ha obbligato lo stato israeliano a restituire circa 50 ettari di terra ai contadini di Bil’in. Anche dopo la vittoria nella disputa legale, la causa di Bil’in ha continuato ad attirare sostenitori e attenzione da parte dei media. La scelta di azioni creative, l’uso di immagini forti e accattivanti, l’abilità nel trasmettere il loro messaggio, l’educazione di giornalisti in tutto il mondo e i tour internazionali dei leader della comunità, per non dimenticare il film Five Broken Cameras, hanno da un lato incrementato in maniera significativa il numero di apparizioni mediatiche e la consapevolezza del pubblico riguardo all’esistenza di movimenti nonviolenti in Palestina, dall’altro allargato le fila degli alleati attivi. Un’altro punto chiave della strategia della Stop the Wall Coalition è il coinvolgimento di partecipanti esterni e internazionali, israeliani inclusi. Iyad racconta che all’inizio gli abitanti erano perplessi riguardo alla presenza di esterni, ma col tempo la presenza di alleati internazionali nelle proteste di Bil’in, che prevedevano anche l’accompagnamento sicuro alle case, ha avuto come conseguenze una riduzione delle azioni potenzialmente mortali contro i manifestanti da parte dell’esercito israeliano, meno devastazioni durante i raid notturni, una documentazione indipendente ed esterna delle violenze e di altre forme di repressione contro i manifestanti, e una maggiore visibilità a livello internazionale per le lotte di Bil’in e di altri villaggi. Di ritorno, questa porta a Bil’in una solidarietà internazionale sempre più ampia e una maggiore conoscenza della realtà dell’occupazione israeliana in Palestina. L’importanza di essere uniti, a livello locale e con i palestinesi all’estero Iyad comprende l’importanza di restare uniti e parla spesso di ampliare il movimento, dell’importanza di avere obiettivi e valori condivisi e di restare in contatto con altri palestinesi. Conosce bene la strategia del divide et impera messa in atto dagli israeliani per dividere i palestinesi residenti in Terra Santa – all’interno dei confini del 1948, nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est – gli uni dagli altri, con checkpoint, posti di blocco e processi amministrativi. Iyad confessa tristemente: “Non sono mai stato laggiù, non posso entrare. Non sono mai stato a Gerusalemme, e vivo solo a 25 km…nè al mare, né a Gaza…” La sua storia è comune a molti palestinesi della sua generazione. Le azioni e le leggi israeliane hanno cercato di esacerbare le divisioni etniche, religiose, geografiche e politiche tra i palestinesi. Beduini, cristiani, drusi, ebrei, musulmani della Palestina storica; sostenitori di diverse fazioni politiche; abitanti delle città, dei villaggi, rifugiati; palestinesi residenti all’interno dei confini del 1948, residenti nei territori occupati, in Gerusalemme Est, a Gaza, palestinesi dispersi nella diaspora – a ognuno di questi gruppi è stato imposto un diverso status, e di volta in volta benefici o sanzioni. I cristiani palestinesi residenti in Israele hanno recentemente rifiutato un programma, proposto da un membro dello Knesset (parlamento) israeliano, per concedere loro privilegi speciali, così da metterli contro i loro compatrioti musulmani. Yariv Levin, leader della coalizione al governo nello Knesset, ha motivato così la discutibile proposta: “Il mio governo garantirà una rappresentanza e un trattamento diverso alla gente cristiana, diversi da quelli riservati ai musulmani.” Iyad ricorda anche la divisione tra i rifugiati palestinesi che vivono fuori dalla Palestina storica in campi profughi o esiliati in vari Paesi arabi come la Giordania, il Libano e la Siria, e i palestinesi dispersi nella diaspora e riuniti in comunità in varie parti del mondo. Afferma: “I palestinesi di tutto il mondo devono marciare a fianco dei palestinesi che sono qui, dobbiamo restare insieme e uniti nella stessa lotta. Per esempio, i palestinesi in Giordania, Libano e Siria sono oppressi da regimi e devono ribellarsi e dire no. Io esigo la mia libertà, esigo il mio diritto di tornare nella mia terra natia. Bisogna essere disposti a perdere qualcosa. La libertà non arriva su un piatto d’oro (proverbio arabo). Questo è un diritto per tutti, diritti umani per vivere in libertà, giustizia e uguaglianza.” Per rispondere alle tattiche repressive, Iyad è convinto che i palestinesi debbano restare uniti per resistere. Verso una terza intifada con il sostegno globale 9 Nel discutere i piani futuri e la strategia globale, Iyad sottolinea l’idea del movimento e sua personale: l’inizio di una terza intifada in Cisgiordania e nei territori occupati. “Vogliamo una intifada come la prima. Una terza intifada in Palestina riunirebbe qui tutti i palestinesi. Ci sono tanti problemi all’interno della comunità palestinese, tra la Cisgiordania e Gaza e tra partiti politici, Fatah/Hamas e altri. Dobbiamo lanciare la terza intifada, così saremo tutti insieme contro l’occupazione, non ognuno per sé.” I palestinesi ora si sentono più divisi che mai, e capiscono che senza unità perdono la superiorità numerica necessaria per affrontare il governo israeliano. La ragione fondamentale per cui Iyad sostiene la terza intifada è il bisogno di unificazione. Burnat aggiunge: “Vorrei costruire un movimento globale per mettere fine all’occupazione. Vorrei che tutto il mondo cominciasse a fare pressioni sul governo israeliano affinché rispetti la legge e ponga fine all’occupazione.” Elenca poi le modalità principali con cui gli alleati internazionali possono fornire un supporto nonviolento alla Palestina. La prima è la campagna Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), avviata nel luglio 2005 sull’esempio dell’omonima campagna sudafricana e forte a oggi di più di cento ONG palestinesi, che ha come scopo l’attuazione di pressioni politiche ed economiche su Israele fino a che questo non risolverà di attenersi alle leggi internazionali e ai principi universali dei diritti umani. La seconda modalità invocata da Iyad è il coinvolgimento delle associazioni universitarie Students for Justice in Palestine presenti negli Stati Uniti, in Canada e in Nuova Zelanda – attualmente ne esistono più di cento solo negli Stati Uniti. Infine, parla di ricevere supporto da o unirsi a gruppi che offrono protezione ai civili disarmati e accompagnamento sicuro ai palestinesi nei territori occupati. In molte delle sue azioni, Bil’in si affida anche ad associazioni solidali di attivisti nonviolenti, come le israeliane Gush Shalom e Anarchists Against the Wall e l’International Solidarity Movement (ISM), per avere qualcuno che possa offrire un minimo di protezione e allo stesso tempo documentare gli eventi. Dal 2005 la comunità di Bil’in ha perso due dei suoi attivisti più impegnati: Bassem Abu Rahmah, morto il 17 aprile 2009, a 29 anni, per un candelotto di gas lacrimogeno che lo ha colpito al petto – incidente documentato in Five Broken Cameras – e sua sorella Jawaher Abu Rahmah, morta il 31 dicembre 2010, a 36 anni, in seguito a un attacco con gas lacrimogeni. Dobbiamo avere speranza e resistere Il movimento Stop the Wall Coalition dimostra che fermezza (sumud in arabo) e disciplina nonviolenta sono ingredienti essenziali per il successo. I membri delle comunità e dei villaggi hanno imparato che devono continuare a battersi, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, nonostante tutta la violenza che subiscono. La libertà non arriva su un piatto d’oro. “Devi essere pronto a sacrificarti per la libertà, e soprattutto devi credere nella tua causa e in quello per cui lotti. Se ci credi andrai avanti, se andrai avanti vincerai.” Bastano poche ore in compagnia di Iyad per capire da dove trae la sua speranza e la sua fermezza: i suoi figli, e specialmente il più giovane, Mohyialdeen, di 15 mesi, che ha gli stessi occhi scuri e penetranti del padre. Egli racconta: “Abbiamo speranze di cambiare la situazione. Speranze di un futuro migliore per i nostri bambini. Non voglio che i miei figli vivano una vita come la mia. Per i miei bambini, e per tutti i bambini, io cerco un futuro senza occupazione e senza violenza. Dobbiamo avere speranza e resistere.” 14 luglio 2015 Traduzione di Fabio Poletto per il Centro Studi Sereno Regis Titolo originale: Nonviolent resistance in Palestine: steadfastness, creativity and hope https://www.opendemocracy.net/civilresistance/katherine-hughesfraitekh/nonviolent-resistancein-palestine-steadfastness-creativity-and-hope (fonte: Centro Studi Sereno Regis) link: http://serenoregis.org/2015/09/18/resistenza-nonviolenta-in-palestina-fermezza-creativitae-speranza-katherine-hughes-fraitekh/
Scarica