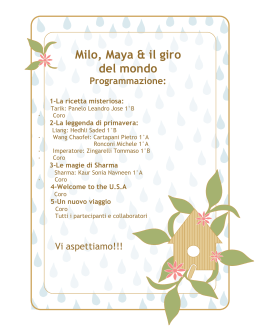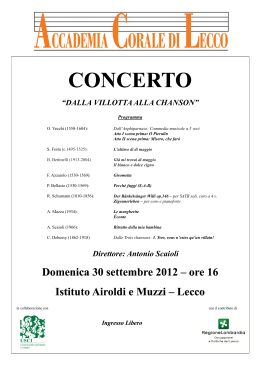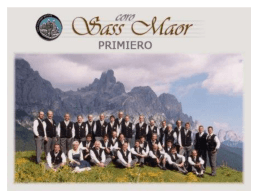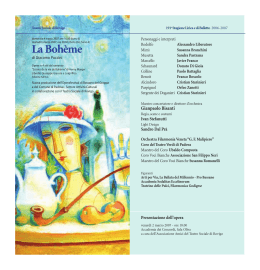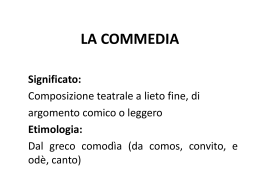Anteprima Estratta dall' Appunto di Storia del teatro e dello spettacolo Università : Università degli studi di Milano Facoltà : Sc.Comunicazione Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. Possibilità di guadagno vendendo appunti, tesine, lezioni private, tesi, svolgendo lavori stagionali o part time. www.ABCtribe.com ABCtribe.com - [Pagina 1] L' Appunto A partire dalla pagina successiva potete trovare l' Anteprima Estratta dall' Appunto. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. Il numero di pagina tra le parentesi tonde si riferisce a tutto il documento contenente l'appunto. Sull'appunto stesso in alcuni casi potrete trovare una altra numerazione delle pagine che si riferisce al solo appunto. Grafico dei voti medi per questo esame: Grafico dei giorni medi per la preparazione di questo esame: Grafico Copyright © ABCtribe.com. Vietata la riproduzione. Grafico Copyright © ABCtribe.com. Vietata la riproduzione. Clicca qui per i grafici aggionati su Storia del teatro e dello spettacolo >> ABCtribe.com - [Pagina 2] Capitolo 1: il teatro greco • Il luogo scenico: la nascita dello spettacolo om Abbiamo notizie sullo spettacolo greco dai suoi esiti maturi nel V secolo a.C.: nessuna testimonianza documentaria. Sappiamo che il teatro greco è un originale modello di edificio teatrale per creare generi drammaturgici codificati, destinati a condizionare il futuro sviluppo di tutto il teatro occidentale. Gli studiosi collegano l’origine del teatro in Grecia ai riti e al folclore che accompagnavano le cerimonie religiose, con molte melodie e danze ritmiche. Origini rituali del teatro. Riti legati alla fertilità della terra. X Aristotele la nascita della tragedia risale ad un canto popolare corale in onore del dio Dionisio durante le cerimonie a lui dedicate. Il legame con alcuni rituali è dato anche dall’ambiguità di alcuni elementi del luogo scenico. Cuore dello spazio teatrale del V secolo è infatti l’orchestra (dal verbo greco orchemai = mi muovo danzando), un’area di forma circolare in terra battuta riservata alle danze del coro. Le origini dell’orchestra sono antiche rispetto al dramma, che risalgono alle aie circolari, utilizzate come spazi per la trebbiatura del grano, usate per le danze rituali e feste religiose. Poi le maschere sul volto dell’attore, si riconduce a usi cerimoniali. Legami con la religione per la costruzione di teatri in prossimità di templi. Divinità principale legata al teatro è Dionisio, dio della fecondità e dell’ebbrezza. Con l’arrivo ad un’originale forma drammatica, si abbandona il legame con il rito, che si ripete nei secoli, cedendo il posto ad una creazione autonoma. Ruolo di spicco spetta ad Atene, dove si afferma il teatro, diventando uno dei tratti caratteristici della sua civiltà. Almeno fino alla fine del V secolo ac, la storia del teatro occidentale ha coinciso con avvenimenti drammatici apparsi in scena nella città di Atene. • Il luogo scenico nella Grecia antica: e.c • Esigenza di ampi spazi all’aperto per gli edifici teatrali. I teatri più antichi erano costituiti da un semplice spazio AB Ct rib livellato in terra battuta, collocato ai piedi di un declivio naturale, sul quale prendevano posto gli spettatori. La parte inferiore, orchèstra, al centro c’era l’altare del dio. Poi successivamente si introducono le gradinate in legno sul pendio della collina, prima destinate a pochi poi a tutto il pubblico. Ma non abbiamo quasi alcuna testimonianza. Ci pervengono le testimonianza di Vitruvio, architetto latino, con de architettura dl I sec ac e con il grammatico greco Polluce con onomasticon, II sec ac. Attraverso varie testimonianze si è fatto un modello di teatro ligneo preeschileo, precedente l’epoca di Eschilo, con cavea a pianta trapezoidale e gradinate costruite lungo il perimetro dell’orchèstra. Tale forma doveva avere il teatro di Torico in Attica e il teatro di Siracusa nei loro progetti iniziali. Il prototipo dell’edificio teatrale greco del V secolo è il teatro ad Atene dell’Acropoli dedicato a Dionisio e alla base del declivio naturale dell’Acropoli fu realizzata un’orchèstra di forma probabilmente ancora trapezoidale. Dietro si vedeva l’aperta campagna. Esempio è il prometeo incatenato di Eschilo, dove si realizzava la caduta nell’abisso dell’eroe, l’attore riappariva in scena nella tragedia successiva. Nell’evoluzione accanto all’unico attore appaiono un secondo e un terzo attore, ed è necessario costruire una tenda o baracca per depositare maschere, costumi, attrezzature sceniche, e consentire l’entrata in scena. la costruzione chiamata skenè è in legno, e rende necessario lo spostamento dell’orchèstra verso il declivio riservato al pubblico, per creare uno spazio adeguato a ospitarla. (vedi figure pag.22 e 23). Nuova orchestra più piccola. La skenè ha anche l’elemento scenografico, con un’ambientazione urbana dei drammi seriori. Struttura allungata con una parete frontale con vari disegni, ai lati della skenè ci sono due paraskènia, due avancorpi, tra di essi c’è una pedana, sulla quale recitano gli attori. Nella facciata della skenè si aprono della parte dell’ingresso degli attori. Nel IV secolo le porte passano a 3, per la ricostruzione della skenè in pietra. Alle estremità del palco si aprono due passaggi detti pàrodoi,che consentivano l’entrata e l’uscita del coro. La parte per il pubblico, della thèatron, luogo in cui si vede, di forma prima trapezoidale e dopo emiciclica, meglio visibile. Era costituito da gradinate lignee, divise da un corridoio, detto diazoma, con scalette, klimakes, che consentivano l’ingresso e l’uscita al pubblico. altra via d’accesso è un sentiero che taglia le colline dell’Acropoli e che è alla sommità delle gradinate. Le strutture delle gradinate dovevano essere solide, con il sostegno di terrapieni. Nella prima fila c’erano personalità eminenti e ospiti d’onore. Al centro il posto d’onore ben ornato, era riservato al sacerdote di Dionisio. • Il luogo scenico nell’età ellenistica: • Nel IV secolo decade la potenza politica di Atene e c’è la diffusione delle attività teatrali. La tragedia è esportata fuori dall’Attica, e c’è la produzione di numerosi edifici teatrali. Ci sono i teatri di Epidauro e Di megalopoli nel Peloponneso, il teatro di Pergamo vicino alla costa turca, il rifacimento del teatro di Dionisio e di Siracusa. Rappresentazioni teatrali più frequenti, privilegiano la componente spettacolare con scenografia più illusionistica, ABCtribe.com - [Pagina 3] forti emozioni, spettacolo da cerimonia civico-religiosa al divertimento e alla manifestazione culturale. Svalutazione del ruolo del coro, interesse per il protagonista e l’intreccio. Sotto il profilo architettonico ci si concentra di più sulla scena che sull’orchestra. La facciata della skenè è più alta e monumentale. La piattaforma davanti ad essa lascia posto a un lungo e stretto palco, logèion, sorretto da un colonnato, la proskènion. Su tale struttura agiscono gli attori. Dietro la facciata presenta 3 aperture larghe , thyròmata, dove ci sono pannelli in legno dipinti, pinakes, in funzione di scenografia. L’orchestra si rimpicciolisce, c’è dislivello tra il coro e la parte in cui operano gli attori. L’azione si svolge inizialmente a livello dell’orchestra, per poi trasferirsi sul palco vero e proprio. Le parodoi collegano la skenè alla cavea tramite portali, pylones, che la sormontano. Esempio di teatro nel periodo ellenistico è il teatro Epidauro, costruito tra il IV e III secolo sotto progetto di Policlito. Edificio con eccezionale resa acustica. La circonferenza dell’orchestra è avvolta per circa due terzi delle gradinate per il pubblico sulla sua linea tangente c’è la skenè fra il palco e le due ali della cavea, le parodoi sono monumentali portali in pietra a due ingressi che uniscono la scena che limita le gradinate. Esiste intorno all’orchestra un canale lastricato per lo scalo dell’acqua piovana, l’euripo, dal IV secolo. (fig. pag. 28) C’è anche il teatro di Eretria nell’Eubea. L’edificio fu costruito addossando la cavea a un terrapieno artificiale, con muri di sostegno. Spazio per il pubblico a semicerchio con due bracci che si uniscono all’orchestra. La skenè è in pietra più profonda e complessa e con l’arretramento dell’orchestra verso la cavea. Al centro c’è una scala che va ad un passaggio collegato con il centro dell’orchestra, la saletta di Caronte, per apparizioni varie. • Lo spettacolo: om • Generi drammatici: • Risalgono al 534 ac le prime rappresentazioni di spettacoli teatrali in Grecia. Pisistrato introdusse gli agoni AB Ct rib e.c drammatici nelle dionisie grandi o urbane, feste istituite in onore di Dionisio. In seguito con l’aggiunta di spettacoli comici. Inserivano nelle rappresentazioni anche ricorrenze importanti della vita politica e religiosa, c’erano delle competizioni, e le rappresentazioni tragiche e comiche erano il corrispettivo teatrale delle gare atletiche per conseguire un primato davanti alla comunità. I poeti erano chiamati a comporre solo in vista delle gare ma successivamente si ripresero le opere al di fuori dei concorsi. Le gare erano distinte in generi, prime le tragedie con una trilogia di tragedie, poi un dramma satiresco. Il complesso delle opere costituiva una tetralogia, ed erano rappresentati dall’alba al tramonto. La tragedia era un rafforzamento dei valori della civiltà greca e si attingeva dai racconti mitici, e i personaggi erano eroi della tradizione. Lingua e stile sono elevati, lontani da ogni locuzione volgare e quotidiana, pensieri tradotti in altissima forma poetica, il verso è forma espressiva delle parti chiamate liriche e per il dialogo. Poi c’è la commedia, con concorsi separati. Soggetti presi dalla realtà quotidiana, attualità, come guerre e condizione sociale della donna. Invettive contro personaggi politici in vista, i personaggi sono uomini comuni, capaci di risolvere le situazioni, seguono scene buffonesche. L’intreccio è diviso in 2 parti dall’intervento del coro, con situazioni svincolanti dall’argomento. Altro genere è il dramma satiresco, stessa struttura metrica della commedia, stesso linguaggio, e i personaggi tratti dal mito. Manca però la solennità dei caratteri e la trama, c’è lieto fine. Scene farsesche, moti e lazzi anche volgari, festosità del coro. Dal IV secolo il genere inizia a decadere. Oltre alla declamazione poetica nelle gare c’era la danza, il canto del coro, l’accompagnamento musicale, la scenografia. • Feste religiose e agoni drammatici • Le rappresentazioni erano all’interno del programma delle diverse feste per Dionisio. La solennità più antica era quella delle Antesterie, a fine febbraio dove si spillava il vino nuovo. Feste più importanti erano Lenee, le grandi Dionisie, con ampio spazio agli spettacoli teatrali. Fuori città c’erano le piccole dionisie o dionisie rurali, a dicembre e gennaio, con concorsi tragici e comici con testi già conosciuti. Le lenee erano ad Atene nel mese di gamelione, a gennaio febbraio, prima nel recinto sacro di Dionisio leneo poi nel teatro dell’Acropoli. C’è la processione per le vie della città e competizioni teatrali, soprattutto commedie, in seguito anche tragedie. Era una festa locale dove si radunava la popolazione della città, senza stranieri fra il pubblico svolgendosi in un periodo invernale. Altre feste più importanti per le rappresentazioni drammatiche erano le grandi dionisie o dionisie urbane, ultima tra le feste, era nel mese di elafebolione, marzo aprile, era una festa panellenica che riuniva esponenti di tutto il mondo dato che era il periodo della riapertura della navigazione e dei commerci. Rappresentazione di tragedie con rituali che rappresentavano la potenza e lo splendore di Atene. Importanza anche politica e religiosa. Feata finanziata dallo stato e dai cittadini più abbienti. Il magistrato preposto alla direzione della festa era l’arconte eponimoa cui spettava la scelta dei drammaturghi. Ammetteva tre poeti tragici che forniva una trilogia seguita da un epilogo. C’erano anche tre poeti comici che in seguito divennero cinque, con la diminuzione degli interventi del coro. L’arconte ABCtribe.com - [Pagina 4] om designava ad ogni drammaturgo un corego, che si occupava del coro e delle spese necessarie. Chi offriva i suoi servigi allo stato riceveva in cambio l’esenzione dal servizio militare e riconoscenza pubblica. La coregia era quindi un atto di generosità per la patria. L’assegnazione del corego al poeta era determinante ai fini della gara dato che provvedeva a tutte le spese. Successivamente si decidevano i giudici, i tritai, venivano redatti dieci diversi elenchi di candidati corrispondenti alle 10 tribù che esistevano, e i nomi andavano in 10 urne e poi rivelati a tutti. Il giorno prima della festa si teneva la cerimonia del proagon, la gara preliminare. Era la presentazione ufficiale dei concorrenti dove partecipavano tutti per fornire tutte le informazioni. Questa festa durava 6 giorni, tutti partecipavano e c’erano anche animali destinati ai sacrifici. Il primo giorno non comprendeva gare teatrali, ma a competizioni tra cori. Le gare invece vere e proprie si svolgevano in una sola giornata, prima le gare comiche poi nei 3 giorni successivi le tragedie. Gli inizi degli spettacoli erano preceduti da riti ufficiali che ribadivano il carattere religioso e sociale della manifestazione. Devoto omaggio alla divinità, solidarietà e prestigio della polis. Si purificava il luogo scenico con un sacrificio di un maialino e di purificava poi la scena. seguiva una sfilata e la proclamazione delle onorificenze dei cittadini per i servigi resi alla patria e venivano presentati i figli dei caduti giunti alla maggiore età. Poi arrivo dei giudici, e iniziava la gara con squillo di tromba. Neppure il difficile periodo delle guerre persiane ostacolò queste manifestazioni (500-479 ac). Riduzione dei giorni però da 4 a 3. al termine delle rappresentazioni c’erano le cerimonie per determinare il vincitore. C’era una classifica e i vincitori erano incoronati dall’arconte con un serto di edera, pianta sacra a Dionisio. Poi gli veniva dato un premio in denaro e il suo nome veniva poi inciso su tavole esposte al pubblico dell’Acropoli. Da questo Aristotele trasse spunto per le Didascalie nel IV secolo ac, e le vittorie dionisiache urbane e lenee. Simile era la cerimonia per le premiazioni dei comici, che avveniva subito dopo la recita dell’ultima commedia con apparati meno suntuosi. L’ultimo giorno aveva luogo un’assemblea, dove i cittadini giudicavano l’operato dell’arconte, dei coreghi e dei giudici. Era possibile fare reclami e ricorsi. Celebre è l’episodio di Demostene che nel 349 ac disse di essere stato colpito mentre fungeva da corego. Scrisse poi per l’occasione Contro Midia. Il personale coinvolto per l’organizzazione è vario, attori, musicisti, istruttori, comparse, comprimari, coro, macchinisti, costumisti, coreuti, 500 cantori, 24 per il coro, il pubblico. e.c • Gli attori: rib • Figura in origine vincolata alla struttura del coro: da esso l’attore si sarebbe distaccato, impersonando un ruolo AB Ct drammatico, ponendo fine alla pratica di risolvere nel canto corale la rappresentazione della vicenda. La parola hupokritès in greco designa l’attore, colui che risponde. Risponderebbe alla domanda del coro, evocando una trama dotto forma di monologhi, o dialoghi intrecciati con il capo-coro. Altra spiegazione del termine è interprete, spiegando al coro gli intrecci della trama. La responsabilità del passaggio alla forma drammatica è di Tespi, attore autore, che si sarebbe distaccato dal coro dando vita ad un nuovo spettacolo. Originariamente l’attore coincideva con l’autore del dramma, anche musico e coreografo. Da metà V secolo, l’attore si emancipa dal poeta, vengono poi introdotti premi separati. Tutti gli interpreti dovevano essere di sesso maschile e tutti i personaggi femminili erano interpretati da maschi. Le parti infantili erano interpretate da bambini che figuravano come comparse mute. Nella poetica, dove si affronta lo sviluppo della tragedia, Aristotele attribuisce ad Eschilo l’introduzione del secondo attore e a Sofocle quella del terzo. Si distinguevano in protagonista, parte principale, poi deuteragonista o secondo attore con i ruoli degli antagonisti eroici in lotta con il protagonista. I personaggi secondari o negativi erano del terzo attore, triragonista. Ogni attore doveva sostenere più di una parte perché erano solo in 3. attenzione quindi alla composizione del testo. C’erano dei consiglieri che giustificavano le entrate e le uscite dei personaggi. Per alcune scene particolarmente difficili da gestire con soli 3 attori, si ricorreva alla comparsa muta, il kophon prosopon, che poteva rimanere in scena anche per lunghi tratti senza parlare. Un numero maggiore di attori avrebbe reso difficile, dato l’uso delle maschere, il riconoscimento dei personaggi e capire da chi provenivano le battute. La voce era il pregio maggiore dell’attore, era importantissima per farsi sentire da tutto il pubblico. doveva essere bravo nei monologhi e nei dialoghi, infatti passavano molto tempo ad esercitarsi. L’attore doveva poi avere grande compostezza in scena, la recitazione tendeva ad essere stilizzata. Più avanti la gestualità se fece più sciolta e animata. L’esibizione dell’attore era considerata servizio di pubblica utilità e educazione. Dal 449 il protagonista è stipendiato dallo stato e a lui spetta la scelta degli altri due attori, la sua interpretazione può essere premiata e il suo nome inserito nei pubblici elenchi dei vincitori. Nel IV secolo la fama dell’attore aumenta, alcuni hanno compiti diplomatici, nascita dei fenomeni di divismo, si concedevano frequenti licenze sulla lettura del testo e apportavano modifiche. Fenomeno che investe particolarmente Euripide, arrivando ad imporre agli attori di attenersi a quello scritto perché c’era già una copia originale negli archivi di stato. Ampiezza delle parti cantate che porta l’evoluzione dello stile recitativo e l’esaltazione delle capacitò melodiche dell’interprete con i pezzi più famosi n una sorta di recitals, tratti da varie tragedie, soprattutto dal III secolo ac. Si forma un nuovo genere di attore professionista, tragoidos, che si esibisce cantado con l’accompagnamento della cetra e dell’auto. L’attore estende anche le sue interpretazioni alle parti in trimetri giambici. Compare anch la figura del komoidos, l’attore comico dotato di analoghi requisiti vocali, che si esibisce nella commedia nuova. Ci sono poie le compagnie di professionisti, con ABCtribe.com - [Pagina 5] la costituzione della corporazione detta degli artisti di Dionisio, per lungo tempo, con attori anche auleti, istruttori, coreuti, e poeti. La corporazione intrattiene rapporti con i committenti degli spettacoli. Si afferma un teatro di intrattenimento, svincolato dall’originario fine educativo e celebrativo, che arriverà in Italia esercitando influssi sull’attore romano. • Il coro: • La sua presenza rimanda alle origini del dramma. Nella metà del V secolo il coro tragico era composto da dodici AB • Scenografia e scenotecnica: Ct rib e.c om elementi, portati a 15 da Sofocle, nella commedia invece c’erano 24 coreuti. I membri del coro erano reclutati dai coreghi fra i cittadini, forniva loro un istruttore per l’addestramento. Ogni coro era guidato da un corifeo, che dialoga con l’attore durante l’azione. A volte il coro si divide in sue semicori, con un capo a testa. Tutti erano di sesso maschile, il luogo d’azione era l’orchestra, dove il coro danzava e durante le sezioni recitate dagli attori stava in silenzio, con disposizione quadrangolare su varie file. L’entrata in scena avviene in corrispondenza della parodo, il canto d’ingresso che prende nome dalla porta d’accesso all’orchestra che costituisce l’inizio nelle tragedie o segue il prologo. Il ritmo del canto era anapestico, adatto alla marcia di ingresso o a metri lirici e essere eseguito dal coro dopo l’ingresso. Altro momento era lo stasimi, canti da fermo, che intervallano le parti per l’azione. Lo spettacolo poteva chiudersi con una sezione in musica che accompagnava l’uscita. Altri canti nei momenti di tensione dell’azione, come il kommos, mi percuoto in senso di dolore, dialogo lirico fra attori e coro. Nel V secolo, il coro era nella parodo, nei dialoghi, e nella parabasi, canto posto a metà azione dove ‘autore faceva esprimere al coro le proprie riflessioni sulla vita sociale e artistica. I coreuti si presentavano senza maschera trattando i vari argomenti non estranei all’azione. Cosi il coro rimane in scena per tutto il dramma, dopo la parodo andava nell’orchestra ed erano immobili durante la recita. Necessaria la presenza per l’uditorio che poteva confrontare l’azione eroica con la propria quotidianità attraverso la mediazione del coro. Situazioni esemplari del comportamento umano, che commentavano un concetto attingendo all’azione. Nella commedia il coro parlava in nome del poeta esprimendo opinioni per la solidarietà del pubblico. per Orazio è consigliere e moderatore di effetti. Coro è spettatore ideale, ed era un commentatore. Il coro agiva sempre all’interno delle vicende tragiche, dato che è sempre parte di un insieme. Evoluzione: nella prima metà del V secolo il coro ha notevole rilievo, come in Eschilo. Con Sofocle l’interesse si sposta sull’individuo e il coro perde un po di importanza. Serie di interventi per limitare il ruolo scenico del coro, le parti corali diminuiscono, ampliamento delle parti liriche. Il coro non condiziona più l’azione ma commenta il tema centrale. Allontanamento accentuato nel IV secolo dove si riduce a puro intermezzo lirico, senza nesso con la trama. • Innovazioni per catturare l’attenzione con vari effetti, si utilizzavano come scenografia gli elementi naturali come rocce e cespugli, che erano alle spalle dello spazio scenico, altare posto al centro dell’orchestra. In seguito la facciata della skenè assunse una funzione di fondale. Dal IV secolo, ci fu l’uso delle tre porte, sulla parete della skenè, quella centrale per il protagonista, a destra per il secondo attore e sinistra per il terzo. Poi le parodoi per l’accesso di altri personaggi che venivano a destra dall’agorà e a sinistra dalla campagna. Le prime scene dipinte risalgono a metà V secolo. L’introduzione delle prime scene parzialmente dipinte risale alla metà del V secolo. La pìnakes è la tela dipinta. Disegni assai stilizzati posti entro le aperture della skenè per suggerire i luoghi di ambientazione. È di Sofocle l’invenzione della scenografia. Era riconosciuta la magnificenza dell’apparato scenico, l’esistenza di una pur semplice scenografia prospettica. A volte per ottenere dei cambi di scena si ansavano i periàktoi, prismi a base triangolare ruotanti su perno, forse collocati in prossimità delle pàrodoi e recanti una porzione di scena diversa dipinta su ogni facciata che veniva poi mostrata al pubblico facendo girare il tutto. L’azione si svolgeva all’aperto e non poteva contare su effetti luminosi artificiali, dato che gli spettacoli si svolgono alla luce del giorno. Non esistevano sipari. Quindi non si rappresentavano uccisioni o scene particolarmente complesse. C’era l’uso di arredi, o cose di forte significato simbolico o evocativo. Arredi e oggetti di scena venivano introdotti solo per il valore drammatico e suggestivo. Sofocle mostra un’attenzione particolare per arredi e oggetti scenici carichi di potere evocativo. Per Euripide gli oggetti di scena divengono mezzi efficaci al fine di accentuare la tensione, caratteristico è l’impegno della dettera come oggetto simbolico dove poi si sviluppava la vicenda. C’è poi l’impiego dell’oggetto personale come riconoscimento che viene inaugurato nella tragedia euripidea e poi nella commedia nuova. Altro elemento era il carro trionfale seguito dal corteo, che esprimeva la magnificenza e il trionfo effimero dell’eroe che si preparava alla catastrofe. Grande effetto dato dalle macchine teatrali, una è l’enkùklema, piattaforma girevole spinta fuori da una delle porte di fondo immaginando scene che si sviluppavano all’interno. Grandi effetti drammatici. Altro meccanismo era la mechanè, sollevava in aria o calava dall’alto attori, di solito divinità. Frequente in Euripide per apparizione degli dei. Nella commedia invece si usava per le parodie delle vicende tragiche rompendo l’illusione scenica. C’erano poi effetti speciali con tempeste con tuoni e fulmini, con il ABCtribe.com - [Pagina 6] keraunoscopèion, e il bruontèion. All’apparizione degli dei era riservato anche il thèologeion, terrazza posta sopra la skenè dalla quale gli dei pronunciavano i loro discorsi. Per la comparsa di fantasmi si usava la scaletta di caronte, passaggio sotterraneo che collega la parete ad una botola al centro dell’orchestra. • Costumi: • Ricavato dall’abbigliamento sacerdotale per il culto di Dionisio, ben distinto dall’abito quotidiano. A Eschilo risale • Maschere: AB Ct rib e.c om il merito di aver introdotto costumi che permettevano l’immediata individuazione sociale del personaggio. Gli eroi di alto rango, sia maschili che femminili, avevano una tunica, chitòne, che scendeva fino alle caviglie, dotata di maniche lunghe. Poteva essere anche più corto, come il guerriero. I colori anche erano importanti, per lo più a righe chiare e vivaci e ben ricamate, gli uomini di governo avevano abiti porpora, i poveri abiti scuri, il lutto era nero, mentre i vinti avevano vesti a brandelli. Sopra il chitone gli attori indossavano un mantello lungo e ampio, bimàtion, oppure corto e rotondo, chlamùs, variamente colorato o ricamato. Gli indovini avevano un mantello speciale, agrènon, lavorato a rete e lungo fino ai piedi. Persone si umile estrazione sociale avevano vesti semplici di colore pallido e spento. I personaggi femminili portavano spesso il peplo, pezza di lana quadrata appuntata sulle spalle e fermata da una cintura, mentre l’abito per la dea era il phàros, raffinata veste di lino. Ai piedi l’attore indossava calzari o stivaletti in pellame morbido, a volte con ricchi ricami. Il costume tragico era sempre convenzionalmente anacronistico, gli abiti erano contemporanei nonostante narrassero vicende più antiche. Per gli stranieri c’erano abiti dell’epoca. I persiani avevano berretti ricamati e calzoni. I personaggi tragici avevano copri capi, ma anche per i mercanti, frequenti i veli per le vergini, cerchi di mantello o diademi per le dee, corone per gli araldi e i messaggeri. Poi ci sono gli accessori, che definivano i personaggi. Nel IV secolo anche il costume si evolve, arriva una calzatura con suola alta fino a 15 cm, il kòthornos, simbolico della tragedia. Imbottiture al torace e al ventre, coperte dal costume che era completato da una maschera dalla fronte enorme e una massa di capelli ricci, onkos. Il costume teatrale della commedia antica era una tunica corta e imbottita, dotata di un fallo in cuoio. Forme grottesche esagerate e copricapo e accessori particolari come elementi di comicità. C’erano anche scene di travestimento. Nella commedia nuova scompare il fallo e l’imbottitura, mentre il costume si avvicina agli abiti quotidiani con differenze in base al personaggio. Il colore più importante e simbolico, rosso per i giovani, nero per i lenoni e i parassiti, azzurro per le donne mature e il bianco per i nobili. I costumi del coro erano meno elaborati, ma c’era vasta gamma; il coro delle eumenidi, costumi neri e maschere con shock emotivo al pubblico. espressivi anche i costumi dei coreuti, che in alcune opere di Aristofane si presentavano con l’aspetto di animali, insetti isole, nuvole. Poco informati sul costume del dramma satiresco, il coro indossava solo perizomi in pelle di capra a cui erano appesi un fallo e una cosa, mentre gli attori indossavano rifacimenti grotteschi del costume serio corrispondente. • La presenza delle maschere deriva dalle processioni e dalla cerimonia delle origini in cui essa costituiva elemento necessario per conseguire il distacco rituale dal quotidiano e l’accostamento all’atmosfera sacrale. Origine religiosa, uso di tipo funzionale e pratico, c’era distanza con il pubblico e i mutamenti del volto risultavano impercettibili. La maschera enfatizza e fissa l’espressione principale, la rendeva evidente e informava lo spettatore anche sull’età e la condizione sociale dell’eroe fin dal suo ingresso. La maschera consentiva di riconoscere subito i personaggi dato che la trama già era nota. Era poi più facile passare nei panni di altri personaggi durante lo spettacolo. Tutti indossavano una maschera tranne il flautista che suonava senza maschera. La maschera copriva interamente il volto e la parte anteriore della calotta cranica, orecchie incluse, e si indossa sopra un berretto di feltro. Perforazione agli occhi e alla bocca. Sotto gli occhi c’era una sottolineatura con striature colorate. I materiali erano lino, sughero e legno, ritoccati a stucco e dipinti in bianco per simulare il colorito della pelle per le donne e in tonalità bianco grigia per i maschi. La serie più ricca rinvenuta a Lipari ha maschere della commedia nuova, III secolo, ci furono presentati 28 tipi diversi di maschere tragiche e 44 di maschere comiche. Nel V secolo non si disponeva di cosi tante maschere e il mutamento dello stato d’animo raramente corrispondeva ad una maschera. Accanto alle maschere tradizionali ce en erano altre speciali come quelle per le divinità, per i personaggi mostruosi o fantastici o quelle per personaggi politici o letterati. Nell’età di Licurgo c’è un nuovo tipo di maschera, bocca più larga, labbra maggiormente dischiuse, fronte spaziosissima, con un’acconciatura a forma di piramide. Primo passo verso la maschera tragica di età ellenistica con fronte aguzza, segnata dal tratto forte di folte sopracciglia, occhi grandi e sbarrati, bocca spalancata. Nella commedia nuova il personaggio appare suggerito già esteriormente, per l’età, condizione sociale, carattere. • Musica: ABCtribe.com - [Pagina 7] • Musica posto preminente. Già dall’inizio per i riti religiosi, alla musica erano attributi poteri magici, considerata dono degli dei. Musica legata a danza e poesia, il coro si muoveva nell’orchestra, che si muova con braccia e gambe sulla musica. Musica esclusivamente vocale, funzione di accompagnamento della voce umana. Strumenti erano la cetra e la lira, poi l’aulòs e il càlamos, simili a oboe e flauto. Più rari erano le trombe, strumenti di percussione o arpe e sistro. Fin dal IV secolo c’era la presenza di un citarista e di un auleta che all’inizio dello spettacolo si posizionava presso la thymele e poi ai margini dei palco. Le musiche per tragedie e commedie erano opera dei drammaturghi, con ruolo quindi anche di compositori. Nella tragedia la musica interviene solo con la parodo, prima parte rigida, ritmo lento e scandito, per la sfilata del coro, la seconda era libera creazione melodica del compositore. La musica di accompagnamento della parte recitata aveva ritmo più o meno rapido. Nell’epilogo, con l’uscita del coro, si tornava al ritmo iniziale. Lo spettacolo ha subito variazioni sulle componenti melodiche. Per Eschilo, anche compositore, c’era più musica di parti parlate, la musica era un sottofondo che esaltava la parola poetica e disciplinava i movimenti del coro. Strutture ritmiche ben definite. Sofocle attribuì meno importanza alla melodia ma preferiva motivi orecchiabili. A lui è dovuta anche l’introduzione di strumenti orientali, come arpa, cetra, aulòs. Con Euripide la musica assunse più rilievo, parti cantate predominanti, e abili professionisti. Inventa anche duetti e terzetti lirici e recitativi, dove le voci si inseguono. L’unico documento completo che abbiamo è l’Oreste di Euripide, libertà compositiva, rilievo all’interpretazione, che porterà alla modifica dello spettacolo in età ellenistica in un recital dei migliori brani. Nella commedia la musica era importante, ritmo lineare, forma vivace, suoni raffinati, apprezzate anche le parodie di celebri motivi musicali della tragedia. • Il pubblico: om • In quanto evento pubblico di rilevanza religiosa e politica, lo spettacolo teatrale era rivolto all’intera comunità. La AB Ct rib e.c struttura ad ampio semicerchio, denota la destinazione a tutta la popolazione 17.000 persone per il teatro di Epidauro e 14.000 per quello di Dionisio. Gli spettatori giungevano a teatro sin dal mattino del giorno fissato per l’agone drammatico, erano provvisti di cibo e bevande dato che durava tutto il giorno. Nel V secolo il pubblico era di cittadini liberi, per i quali l’ingresso era pagato dallo stato. C’erano anche molti visitatori da altre città. Fin dal V secolo le donne libere presenziavano agli spettatori drammatici, con minore frequenza rispetto agli uomini, dall’inizio del IV secolo il pubblico comprendeva anche le donne, i bambini, e schiavi accompagnati dai padroni. Il pubblico frequentava con passione, curiosità di vedere i miti della tradizione, giudicavano gli organizzatori, osservavano con attenzione ogni particolare. Pubblico attento e competente. Il pubblico era solito chiedere il bis di pezzi più riusciti gridando authis, ancora. Erano graditi aneddotici ben dosati, uno sviluppo chiaro dell’intreccio e i passi in cui si trasmesse devozione religiosa, moralità pubblica e valori umani in generale. Applaudivano energicamente per esprimere il loro consenso. Se non piaceva fischiavano, battevano i piedi contro i sedili, e a volte lanciavano oggetti agli attori arrivando a sospendere la rappresentazione. Cercavano di ammorbidire il pubblico con opere di elogi alla libertà di Arene. I poeti comici scherzavano volentieri con il pubblico. Aristotele individua nel pubblico nel IV secolo due tipi di spettatore: il cittadino istruito e attento, dall’altra l’artigiano o l’operaio che dormono o fischiano a sproposito. Nel IV secolo il pubblico muta comportamento e diventa più indisciplinato e insofferente. Quindi anche prima non tutti erano esperti e attenti e non erano in grado di cogliere i vari riferimenti alla vita politica o alla cultura del tempo come la commedia aristofanesca. Si manteneva vivo l’interesse grazie ai personaggi grotteschi, comici anche se non si coglievano i significati dei messaggi. Impegno finanziario assunto dallo stato per permettere alla maggior parte dei cittadini di poterne usufruire. Gli invitati non pagavano, il resto si, costo era 2 oboli. Dall’epoca di Pericle, lo stato concesse ai cittadini liberi un risarcimento del prezzo di ingresso al teatro che ammontava a duo oboli per un giorno di spettacolo e a una dracma per tre. Il ricavato dei biglietti era incassato da un amministratore che con esso provvedeva alla manutenzione e ai lavori per migliorare l’edificio. I biglietti avevano contrassegni in piombo, e dal IV secolo anche in bronzo su cui era incisa da un lato la testa di Atene, e dall’altro l’indicazione del settore del theatron a cui lo spettatore era destinato con una lettera. Non c’erano posti numerati. Poi anche biglietti in avorio e osso, riservati a persone importanti. Le prime file erano per le autorità e vi provvedeva lo stato. Prime file per sacerdoti, funzionari in carica, condottieri militari, benefattori e i figli di maggiore età dei caduti in guerra. Poi i giudici. Massimo onore per i sedili di marmo lungo la circonferenza dell’orchestra occupati dagli arconti e dalle massime autorità religiose. Il sedile centrale era per il sacerdote di Dionisio. Gli stranieri, ospiti d’onore della città erano accompagnati a sedere da un funzionario. Si aggiungevano i membri del consiglio ai quali era riservato un settore particolare, gli strateghi e gli efebi. Si mescolavano tutte le classi sociali. Assidua frequentazione che trasformava lo spettacolo in un significativo strumento culturale sostenuto dagli organi di governo a beneficio di tutti i cittadini. • La drammaturgia: • Nascita della tragedia: ABCtribe.com - [Pagina 8] • La parola tragoidìa è un termine antico di etimologia incerta, è composto da tràgos=capro e oidè=canto. Ci sono varie interpretazioni, nell’età ellenistica significa canto per il capro, sia come capro premio per la gara di canto o canto eseguito durante il sacrificio di un capro, animale sacro a Dionisio. Altra possibilità è canto dei capri, cioè di attori travestiti da capri. Due origini diverse del dramma. È indubbio che è nata all’interno delle celebrazioni legate al rito religioso di Dionisio. Fonte più autorevole è Aristotele che nella poetica ci informa che la culla della tragedia è costituita dall’improvvisazione di coloro che intonavano il ditirambo, inno corale in onore a Dioniso. Ci dice che la tragedia delle origini subì molti mutamenti e ci mise un po’ per liberarsi della sua iniziale impronta satiresca. Legame confermato dal fatto che è attribuito a Arione di Corinto il passaggio del ditirambo da rozza improvvisazione a forma d’arte corale interpretata da un coro di satiri. Il dramma satiresco era prodotto dallo stesso autore delle tragedie su argomenti provenienti dal medesimo patrimonio mitologico costruito con schemi metrici e stilistici simili, interpretato dal coro già usato per la tragedia. I cori tragici originariamente celebravano le vicende e i patimenti degli eroi e solo dopo furono trasferiti alle vicende dionisiache. • Con il V secolo la tragedia diventa genere letterario, il pubblico esigeva che la tragedia si sviluppasse e.c om secondo una successione di parti fisse, doveva aprirsi con un prologo, lunga introduzione costituita da un monologo, un dialogo o una scena che chiariva l’identità dei personaggi. Inizialmente non esisteva ma con Euripide assume importanza dato che introduceva la vicenda e dava un quadro ben preciso. Poi seguiva la parodo, canto introduttivo del coro, in 2 parti distinte. In alcune tragedie si ha una seconda parodo detta epipàrodo. Le parti riservate alla recitazione degli attori erano gli episodi, con numero variabile da 3 a 7, una o più scene con dialogo fra attori e attori e coro. C’erano anche parti cantate dall’attore nel canto a solo della monodia o canti del coro in alternanza con l’attore. Metro tipico è il trimetro giambico, verso che produce il ritmo spontaneo della conversazione corrente. Gli episodi erano intervallati dagli stasimi, canto del coro che poteva integrare l’azione, o in seguito apparire indipendenti alla vicenda. La ripetizione dell’alternanza episodio-stasimo è l’ossatura strutturale della tragedia. L’ultimo episodio era chiamato esodo, privo di struttura, è di forma diversa nelle varie tragedie. rib • La grande stagione della tragedia greca: Ct • Eschilo: Primo è Eschilo, con prima vittoria di un concorso drammaturgo nel 848 a.C. Dei suoi predecessori AB sappiamo poco, PRATINA di Fliunte, autore di tragedie e drammi satireschi, e FRINICO di Atene, tragedie ispirate a vicende della storia greca contemporanea. Eschilo fu autore di drammi, coreografo, maestro di effetti speciali. Abbiamo 80 titoli di drammi e 7 opere complete: persiani, sette contro tebe, prometeo incatenato, supplici, oltre a Agamennone, coefore, eumenidi,che costituiscono l’orestea, unica trilogia dell’antichità giunta a noi. Concezione della trilogia come gruppo di drammi legati dal medesimo soggetto mitico, sviluppato in fasi distinte da ognuno di essi. Questa forma di trilogia legata è per lui un’esigenza formale per esprimere le proprie convinzioni religiose e morali, dove protagonisti erano tutti. Elementi centrali sono il destino, il rapporto dell’uomo con le forze sovrannaturali, volontà degli dei come infallibile, problema della giustizia, rapporto colpa pena. Alla norma della trilogia tematica si sottraggono i persiani rappresentati nel 472 a.c. come secondo dramma di una terna di tragedie senza nesso di argomento. L’opera rappresenta un unicum in quanto il poeta vi sviluppa un soggetto storico di viva attualità quale la vittoria greca sulle truppe persiane di Serse. Si rivive la dolorosa esperienza della guerra nell’animo del popolo persiano. È affidata al coro una parte predominante, dall’azione satirica e dall’apparato scenico assai semplice. Tragedia riconosciuta come di impianto arcaico, legata alla struttura della tragedia delle origini. 474 a.c., sette contro tebe, tragedia di lail e edipo, seguita dal dramma satiresco la sfinge. Si affronta il dramma di una famiglia condannata al fato, edipo è costretto a uccidere il proprio padre e a sposarsi con la madre. L’azione inizia quando epido è gia morto e i suoi figli sono in lotta fra loro, battaglia e morte dei due fratelli. Eteocle è l’eroe centrale che è sia guerriero magnanimo e figlio di edipo su cui incombe la maledizione paterna. Assume su di se il destino di tebe e della sua famiglia. Le supplici, dopo il 469 ac. sono una delle sette tragedie completamente conservate di Eschilo. Facevano parte di una trilogia tragica che comprendeva Gli Egizi e Le Danaidi, più il dramma satiresco Amimone.Narra dell'arrivo ad Argo dall'Egitto di cinquanta figlie di Danao fuggite per evitare il matrimonio forzato con i cugini e che con l’ospitalità ottenuta dal re Pelasgo facevano seguito le nozze e l’uccisione dei mariti da parte delle ragazze. Una invece risparmia il marito. Apre la scena il coro, vero protagonista. Poi c’è prometeo incatenato, tratta di dei, prometeo viene incatenato a una rupe della scozia per aver rubato il fuoco all’olimpo e averlo donato con eccessiva benevolenza agli uomini. Zeus vuole sapere la sua sorte. Significato della tragedia complesso, un ribelle combatte la tirannia di zeus. Prometeo è colpevole però per l’insubordinazione nei confronti dell’autorità divina. C’è poi una riconciliazione tra zeus e il titano, con un consolidamento del pi dio. Con l’orestea nel 458 ac compone una trilogia sulla maledizione caduta sulla casa degli atridi. Primo dramma è Agamennone, annuncio della vittoria dei greci giunto a Argo. La regina Clitemnestra vede ABCtribe.com - [Pagina 9] avvicinarsi il ritorno del marito e il giorno della vendetta per il sacrificio della figlia. Arriva Agamennone, la regina poi si alza in piedi sui due cadaveri. In Coefore, la regina, tormentata dal rimorso invia alla tomba di Agamennone la figlia Elettra. Arriva anche Oreste tornato per vendicare il padre. I due fratelli si incontrano e gridano vendetta. Oreste va alla reggia sotto mentite spoglie e trucida Egisto, amante della regina, poi la regina stessa. Il giovane dopo la gioia cade in smarrimento e viene perseguito dalle Erinni, mostri simbolo dello sdegno dei morti consanguinei. In Eumenidi, Oreste si era rifugiato nel tempio di apollo viene poi inviato dal dio alla città di Pallade, ad Atene, per rimettersi al giudizio del tribunale. I voti sono pari e solo l’intervento di Atena scioglie Oreste dalla colpa. La dea invita le Erinni a deporre la vendetta e a mutarsi in Eumenidi stabilendosi ad Atene. I temi centrali, sono il problema della giustizia e il rapporto colpa pena. La trilogia è esplorazione della natura della giustizia terrena e divina. Gli dei puniscono la violenza che genera altra violenza. Per Eschilo è indispensabile l’intervento della divinità che è una necessità sociale. Moralista, discepolo di Zeus, capace di esprimere le grandi verità dell’esistenza in uno stile solenne. Stile magnifico e sfarzoso, vocabolario vastissimo, innovativo, creazione di epiteti composti da due o più termini. Impiego di straordinarie immagini metaforiche che percorrono i drammi, padronanza dell’effetto spettacolare, ardite coreografie curate dal poeta. • Sofocle: attività per tutto il V secolo, nella sua carriera ottiene 20 vittorie superando ogni suo rivale. Popolare AB Ct rib e.c om fino alla morte. Dei 130 drammi da lui firmati, a noi ne sono arrivati 7: antigone 442 ac, aiace, edio re, trachinie, elettra, filottete 409 ac, edipo a Colono. Uso della trilogia composta da drammi autonomi per soggetto e sviluppo. Impone la misura drammatica formale destinata a affermarsi come unica espressione del genere tragico nella tradizione teatrale in Occidente. La scelta di pezzi autonomi nella trilogia e la rinuncia alla continuità tematica rispondono ai gusti di Sofocle, che ama costruire il dramma intorno a un unico personaggio protagonista assoluto. La visione tragica, si risolve nella rappresentazione dell’agire o del partire di un uomo solo, che entra in conflitto con il destino e i valori suoi personali. I suoi eroi sono incarnazioni dei grandi valori dell’umanità, che difendono da ogni compromesso. Sono creature inflessibili fedeli alla loro natura e ai loro disegni fino alle conseguenze estreme. Caratteri presenti in Antigone dove la vicenda si collega alla saga texana, ideale prosecuzione di sette contro tebe di Eschilo. Dopo la morte di Polinicia, Antigone, figlia di Edipo, contravvenendo alle leggi dello stato seppellisce il fratello, lasciato insepolto perché considerato nemico della patria. Viene arrestata e rinchiusa dove si uccide mentre lo sdegno degli dei colpisce la famiglia del nuovo re di Tebe. Valori racchiusi nella protagonista fiera del suo eroismo e della sua fede. Simile è Aiace, protagonista della tragedia eponima che sceglie la morte per non tradire il suo ideale di vita degna e gloriosa. Accecato dall’ira per volontà di Atena, fa strage di greggi credendoli l’esercito nemico. Tornato lucido si uccide dalla vergogna. Sottolinea l’accettazione eroica della sorte da parte del personaggio che non ha indugio, chiuso nel suo orgoglio. Eroe domina la tragedia, e l’ultima parte sulla sepoltura del morto risulta più debole. Poi ci sono Elettra e Filottete che ripropongono il personaggio magnanimo tormentato da sofferenze. Elettra riprende l’argomento di Coefore, dal punto di vista della fanciulla, con la scena del riconoscimento e poi l’episodio della morte, mentre Filottete ruota intorno alla figura del guerriero abbandonato a Lemno al quale i greci cercano di rubare l’arco necessario per la conquista di Troia. Tutti i personaggi accettano con dignità la loro sorte. Poi c’è le trachinie su due protagonisti Eracle e Deianira, vittime dell’amore, Deianira innamorata e gelosa invia a Eracle un liquido mortale che la uccide e l’altra succide per il rimorso. La più celebre tragedia è Edipo re, ispirato alla saga dei Labdacidi, e sull’indagine che Edipo ignaro del suo passato, conduce per scoprire l’assassinio di Laio fino a scoprire il suo orribile stato di parricida e sposo della madre, arriva a punirsi e si cava gli occhi e si maledice. Perfetta concentrazione delle parti, nel successo degli eventi e dei colpi di scena. crea degli episodi che mantengono viva l’attenzione dello spettatore con vari imprevisti e peripezie. Sempre lui è protagonista di Edipo a Colono, giunto a Colono, Edipo con Antigone, ottiene ospitalità nel luogo dove un oracolo gli ha predetto che dovrà lasciare la vita. Lo visitano i figli, il sovrano di Tebe, il re di Atene. Rimane distaccato da tutti, sapendo di dover abbandonare la vita. Sofocle poi si congeda dal pubblico. l’opera rivela un pessimismo della visione esistenziale del poeta. La vita umana gli appare colma di infelicità e dolore, e vano è per l’uomo cercare una spiegazione dato che la giustizia divina agisce per vie imperscrutabili. Armonia e eleganza di stile, è anche maestro nell’uso teatrale. Effetti spettacolari meno numerosi, interesse più sull’intreccio e sul dialogo. • Euripide: la sua tragedia porta in se le tracce dei rivolgimenti culturali e politici ella civiltà ateniese alla fine del V secolo. Scarso numero di vittorie, successo in seguito. Ci sono pervenute 17 tragedie: alcesti 438, medea 431, eraclidi 430, Ippolito 428, Andromaca 425, ecuba 425, supplici 424, eracle 423, ione 418, elettra 417, troiane 415, Ifigenia in taurine 412, elena 412, fenicie 408, oreste 408, baccanti e Ifigenia in aulide ABCtribe.com - [Pagina 10] Ct rib e.c om dopo il 405. è innovatore radicale, ama rielaborare le leggende, costituire nuove versioni di celebri miti o episodi poco conosciuti spostando i luoghi dell’azione, la successione degli avvenimenti e modificando la genealogia dei personaggi. L’intreccio è complesso e ricco di peripezie. Eroi con caratteristiche imprevedibili, passando da un ruolo al suo opposto con grande disinvoltura. Ridimensionamento della statura eroica del personaggio, ci sono eroi e eroine assai fragili, che trovano la forza dell’azione e del gesto titanico solo di fronte alla morte con grande coraggio. Scandaglio della psicologia femminile, con grandi figure di donne come Alcesti, tragedia a lieto fine con eroina protagonista che accetta di morire in luogo del marito e viene poi strappata agli inferi da Eracle. Domina l’anima delicata di Alcesti. Più risoluto è il carattere delle due eroine Medea e Fedra. Medea è abbandonata da Giasone che preferisce la figlia del re di Corinto, medita la vendetta eliminando insieme alla rivale i suoi figli. Passionalità e orgoglio dominano, e Fedra protagonista dell’ ippolito coronato, è regina infelice che vive il suo amore per il figliastro e l’unica via d’uscita è la morte. Nessuna delle eroine rinuncia ad abbandonare il loro caso, atteggiamento riconducibile alla formazione dell’autore di Atene. Sul protagonista vertono anche Ecuba e Eracle, che presentano una violenta Trasformazione dell’eroe e il dramma ricorre a elementi patetici e al gusto per l’orrido. Si esprime anche in tragedie che mettono in scena la collettività come Eraclidi, supplici, troiane, fenice. Rappresentazione della catastrofe di un gruppo etnico o familiare, l’azione procede con episodi autonomi. Sperimentazione anche in elena, ione e Ifigenia in taurine con sviluppo romanzesco della vicenda, lieto fine, carattere borghese dei personaggi, mostrano evidenti punti di contatto con la commedia nuova. La trama di elena: elena donna fedele e virtuosa, mai giunta a troia, è andata in egitto e viene trovata da Menelao e organizzano una fuga dal sovrano che vorrebbe sposarla. Fuga si ritrova anche in ifigenia in auride, e ione sul ritrovamento di un figlio esposto un fasce e creduto morto. Caratteristiche dei drammi dell’ultimo periodo sono l’uso di prologo espositivo, il ricorso all’impiego del deus ex machina. Informa attraverso il prologo degli antefatti delle vicende spesso nuove e complesse. L’apparizione di una divinità per mezzo di una macchina teatrale è mezzo tecnico cui il poeta ricorre per concludere un dramma difficile. Le baccanti, ultima opera, vede protagonista una divinità, di Dionisio, la vendetta nei confronti dei nemici del culto. Opera nella quale Euripide utilizza un episodio della storia sacra di Dionisio per costruire personaggi drammaticamente efficaci nelle figure del dio e del re Penteo, inserendoli in n intreccio unitario che procede con tensione crescente verso un finale di grande tragicità. La tragedia di Euripide ha un linguaggio tratto dalla conversione corrente, stile semplice e lineare, verso mosso e vivace, soluzioni metriche libere e ricche. • Il dramma satiresco: negli agoni drammatici del V secolo era ricorrente l’abitudine di far seguire alla trilogia AB tragica un dramma satiresco, eccezione è l’ Alcesti, di Euripide, con definizione di pezzo prosatiresco. La maggior parte scompare in epoca antica, sopravvive solo il ciclope di Euripide, altro dramma satiresco di Sofocle è i cercatori di tracce o i segugi , e altri frammenti di diversi lavori. Il dramma satiresco risponde all’esigenza dei drammaturghi greci di sollevare lo spirito del pubblico che avesse appena assistito alle tragedie, spettacolo giocoso, comico. C’è la caricatura degli eroi mitici, linguaggio, ritmi metrici, congegni scenici, sono del tutto simili alla tragedia. rifacimento di stile elevato, l’estensione del dramma è più contenuta, il coro è costituito da satiri, mitologici ambienti del bosco e campagna, metà uomini e metà capri, creature rozze e primitive, arroganti, sono i principali personaggi. Il coro è scortato da un accompagnatore, il loro genitore Sileno, che oltre ad avere una parte nel dramma, interviene nell’esecuzione del coro come corifeo. C’è la beffa del teatro serio. Esempio è ciclope di Euripide, la vicenda si ispira all’incontro tra Ulisse e poliremo, atmosfera qui spensierata e giocosa con contrappunto comico per i satiri in scena. intervengono con il loro aiuto goffo mentre odisseo sta attaccando il mostro, cosi dove sileno distrae l’eroe con le sue chiacchiere per rubare del vino. Nelle trame del dramma satiresco gli eroi sella tragedia subiscono in riadattamento comico, sono immersi in un clima di assurdità che li rende disarmonici nel complessivo tono burlesco, si trasformano loro malgrado in veri eroi comici. Riproduce anche circostanze del genere serio ribaltandone il significato. Spesso l’eroe è intelligente e mette a punto intrighi per sopraffare mostri e nemici, il protagonista diventa il briccone scaltro. Il dramma si presenta come specchio deformato delle tragedie e il protagonista tragico riappariva ridicolo. Abitudine di trarre alimento da una casistica ristretta dei temi, situazioni e personaggi fissi. Esempio è il Ciclope, con eroe mitico, sconfitta di mostri e giganti, ospitalità violata, evasione o salvataggio finale del protagonista. Nella conclusione rientra il coro dei satiri che recitano la parte di schiavi sottratti alla tutela di Dionisio che alla fine ottengono il permesso di ritornare. C’è poi il ricorso magico al prodigioso, appaiono spesso maghi e maghe, fattucchiere, mostri, esseri fantastici e oggetti fatati, ambientazione esotica, lieto fine. Il pubblico sapeva che l’eroe doveva combattere contro mostri da favola, solo apparentemente spaventosi, già rassegnati a una sconfitta. Dal 340 i drammi satireschi incominciarono a essere rappresentati indipendentemente dalle tragedie. Nasce un nuovo tipo di dramma satiresco, si mantiene il coro di satiri, ma la trama si ispira a temi della commedia contemporanea. Abbandono di intrecci mitologici per privilegiare la satira attuale. Esempio sono ABCtribe.com - [Pagina 11] Agen di Pitone del 324, su commissione di Alessandro magno per screditare il suo ministro Arpalo. Poi ci fu Timocle. • La commedia attica antica: su questa commedia la fonte principale è Aristofane, nella sua Poetica, ci dice Ct rib e.c om che la commedia nasce in seno alle falloforie, processioni legate al rito della fecondità, nucleo fondamentale a inizi VI secolo era il trasporto di enormi falli, simboli della riproduzione e della fertilità. I fallifori si accompagnavano con canti rituali inneggianti ai demoni della fecondità e poi a Dionisio. Il termine komoidia ha il significato di canto del komos, accesso alla gioia e la baldoria che accompagnavano il simposio celebrato dopo il corteo. Altra etimologia risale a kome, villaggio, la commedia sarebbe stata in canto del villaggio. Per gli atenesi la commedia nasceva dal passaggio nel villaggio di un gruppo di attori, mentre i Dori si Megera rivendicavano il merito. È probabile che la concomitanza delle feste falloniche abbia favorito l’inserimento della beffa nei confronti del pubblico in più le processioni e l’inno propiziatorio. Somiglianza tra il canto fallonico e la parabasi, una delle parti fisse della commedia attica del V secolo, dove il coro sfila davanti al pubblico per rompere ogni illusione scenica e cantare un inno in onore del dio, con beffe rivolte agli spettatori. La falloforia fornisce alla commedia la componente lirica del coro, la componente drammatica risale alla farsa fliacica, scene improvvisate dai fliaci attori irregolari, con travestimento grottesco. La farsa fliacica è un’azione teatrale su curiose situazioni quotidiane con forma di comicità. L’origine andrebbe cercata a Megera sull’Istmo. Il primo nucleo del teatro comico con elementi farseschi si rintraccia in ambiente dorico. Esempio sono le opere di Epicarmo, poeta comico, la sua commedia è insieme di scene farsesche intorno a un filo drammatico, azione pura e rapida senza coro, basata sulla parodia mitologica di eroi come Odisseo e Eracle, e argomenti di vita quotidiana. Elemento drammatico con elemento lirico attico, dando vita ad una forma di atre nuova. Dal genere drammatico più illustre derivano il prologo e la parodo. Nella prima parte c’è forma fissa, agòn, dove il protagonista e l’’antagonista si minacciano. A metà commedia gli attori si allontanano e la scena viene occupata dal coro, che si rivolge al pubblico e sfila. Intermezzo con canti e parti recitate, la parabasi, è lo strumento poi con cui il poeta esponeva le sue idee. L’azione poi riprendeva con una seconda parte costituita da scene buffonesche. I più antichi commediografi attici sono, Chionide, Magnete, di cui non abbiamo notizia, poi Cratino e Eupoli, a metà V secolo, con parodie mitologiche e attacchi a personaggi politici. AB • Noi abbiamo notizie solo di Aristofane, 44 lavori, ne abbiamo 11: acarnesi, cavalieri, nuvole, vespe, pace, uccelli, lisistrata, tesmoforiazuse, rane, ecclesiàzuse, pluto. Le sue commedie attingono dalla realtà ateniese, ridicolizzando vizi e costumi dell’epoca con attacchi anche a singole persone. Tecnica del cabaret. In acarnesi, il coro conferisce il titolo alla commedia, che è costituito dai carbonai del demo attico di Acarne, rappresentati come fautori della guerra contro Sparta. Tema principale è la guerra e le negative conseguenze. Il protagonista Diceopoli decide di stipulare la pace con la città nemica. Contrasto tra la tranquilla esistenza di lui e la tensione del partito della guerra, mentre il poeta mette in scena parodie della tragedia con Euripide. Attacchi politici, buffonate, scherzi, lodi alla pace, critica della produzione tragica contemporanea. La satira politica trova espressione compiuta nei cavalieri, con stretto rapporto con la vita politica di Atene, vuole dare battaglia a Cleone, potente demagogo, rappresentandolo in scena sotto le vesti di paflagone, servo astuto di demo, capace di dominare il padrone. Alla fine dopo vari contrasti e episodi si arriva alla cacciata di paflagone e restituisce a demo serenità. Incentrate sulla satira degli intellettuali e dei filosofi sono le nuvole dove Aristofane muove un attacco a Socrate e alla di lui dottrina. Il contadino strepsiade sommerso dalle spese, decide di frequentare la scuola dei filosofi per imparare la tecnica per non pagare i debiti. Cacciato manda il figlio al suo posto, ma il giovane si ribella al padre. Si da qui corpo alla metafora e si traducono concetti astratti e filosofici in forme concrete e quotidiane. Ci sono poi le allusioni letterarie, il più bersagliato è Euripide che appare in acarnesi, rane, tesmoforiazuse. Nelle rane, c’è la discesa agli inferi di Dionisio, incaricato di riportare in vita il poeta. Indeciso tra Eschilo e Euripide, vince Eschilo. Qui le scene di umorismo precedono la parabasi, e la seconda parte è più seria, soggetto letterario che culmina nel duello poetico tra i due tragici. Espressioni dense di nomi di eroi e intonazioni ricalcate sullo stile epico. Le composizioni corali e i canti a solo divengono buffoneschi e volgari accompagnamenti di danze. Parodia delle eroine femminili è la vicenda di tesmoforiazuse, dove le cittadine atenesi prendono posizione contro il poeta, reo di averne smascherato i difetti in modo plateale nelle sue tragedie. Frequenti gli echi distorti del linguaggio poetico euripideo, posti in bocca agli eroi comici, salendo sul piedistallo che gli fornisce la scrittura lirico tragica esprimendo i problemi della realtà. Il pubblico non sapeva cogliere le allusioni letterarie ma la satira rimaneva godibile anche grazie alla presenza di costumi e arredi scenici che accentuavano il significato delle parole. Trionfo della fantasia e dell’estro comico sono gli uccelli, considerati il suo capolavoro. Desiderio di una vita ABCtribe.com - [Pagina 12] umana diversa, spensierata e lieta come quella degli uccelli, crea una città fantastica posta nell’aria fra gli dei e gli uomini. Il coro è composto da creature alate, con piume, è un ingrediente scenico per prodigiosi spunti sia per gli effetti scenici sia per la musica. Gli uccelli incarnano il lato musicale e fantasioso della commedia antica e il suo vertice di sfarzosità scenica e costante riferimento alla realtà cittadina. Il costume sociale è colpito nelle vespe, giudizi popolari che proprio come le vespe che formano il coro, amano pungere gli altri cittadini. Con la pace e lisistrata torna a trattare della pace, con soluzioni come lo sciopero sessuale. Le altre due commedie, ecclesiazuse e pluto si differenziano per l’affievolito ruolo del coro. La parabasi è eliminata a favore di un intervento coreografico dei coreuti con pezzi lirici di repertorio. Agganci con l’attualità ma anche interesse su argomenti più generali come il contrasto fra sessi, ricerca della felicità. Nelle ecclesiazuse le atenesi approvano una risoluzione che porta il potere della città nelle loro mani. Pluto è a lieto fine, il dio della ricchezza distribuisce i suoi favori agli uomini sulla base dei loro meriti. Il consenso del pubblico rimane costante per tutta la carriera. • La commedia attica di mezzo e la commedia nuova: si colloca la commedia di mezzo fra il 385 e il 336 ac, AB Ct rib e.c om nessun testo completo è giunto fino a noi. Il ruolo del coro si riduce e si elimina la parabasi. Scomparsa dell’elemento lirico e musicale, mancano invenzioni fantasiose nelle trame per lasciare posto a intrecci ispirati alla realtà quotidiana, attacchi politici occasionali. Argomento prediletto è la parodia mitologica. Fra i poeti attivi si ricordano Anassaride, Antifone e Alessi. La commedia nuova, con la commedia intera di Menandro. Collocata a partire dalla morte di alessandro magno la commedia nuova prosegue il processo di distacco dalle forme comiche del V secolo. Il coro non ha più alcuna parte nella rappresentazione della vicenda e i suoi interventi servono solo a intrattenere il pubblico con canti e danze negli intervalli. Gli attacchi personali diventano rari, scompare l’insistito riferimento alla finzione scenica, vengono eliminate le interruzioni dell’azione. La commedia nuova privilegia emozioni e contrasti quotidiani, rivolge il suo interesse ai rapporti interpersonali di una compagine sociale assai ristretta. La trama verte su innamoramento contrastato arricchito da colpi di scena, sorprese e litigi. Gusto per l’indagine psicologica e i commediografi sviluppano lo studio dei caratteri umani dando vita a personaggi destinati ad avere notevole fortuna in tutto il successivo teatro di ispirazione classica. Fra i modelli cui la commedia muova si rifà non sarà inutile ricordare la tragedia euripidea, soprattutto in riferimento al romanzesco e alla rappresentazione dell’amore in scena. I maggiori esponenti sono nella prima metà del IV secolo: Difilo, Filemone e Menandro. Il misantropo, e frammenti di altre tre commedie: samia, fanciulla tosata, arbitrato. Il misantropo, l’intreccio ruota intorno alla figura del contadino anemone, che vive solo con la figlia. Il ricco sostrato innamorato della ragazza, cerca il consenso del padre che alla fine dopo un salvataggio accetterà. Carattere complesso e multiforme. Innamoramento, femminilità della giovane amante, la saggezza della nutrice, imprudenza dello schiavo e la passione per la burla del cuoco. Il contatto con il pubblico è istituito attraverso il prologo. Le caratteristiche si accentuano nelle commedie successive, che propongono una comicità più raffinata. Ne la donna di samo, la trama è intorno ad un bambino nato fuori dal matrimonio e di una donna che accetta di far credere il bimbo suo figlio e consente il matrimonio fra i due genitori. La fanciulla tosata, ha caratteristiche della commedia del IV secolo, storia di un amore e presunto tradimento. L’arbitrario, ci sono 2 sposi, e della violenza subita dallo stesso marito prima che i due si incontrassero e del bambino che è nato. I due alla fine si conciliano. Gli altri personaggi sono riconosciuti dal pubblico, per le maschere e i nomi. I temi sono la vita privata dell’individuo, l’amore, sentimento umano e quotidiano. La sua commedia strappa risate. Il suo mondo trae ispirazione dalla realtà per mettere in rilievo la fragilità dell’uomo e la finzione del caso nella vita di ogni giorno. Lieto fine e mancanza di personaggi veramente negativi. Esaltazione della virtù fondamentali dell’uomo onesto e della sconfitta della falsità. • Il mimo: grande favore verso il pubblico, origini più antiche, è una rappresentazione popolaresca, consistente in una serie di scene comiche brevi, prive di nessi organici, di intreccio e lasciate all’improvvisazione degli interpreti che vi inserivano danze, esercizi acrobatici e imitazione dei suoni della natura. Non fu mai introdotto nelle competizioni drammatiche ufficiali, ma solo a esibizioni di piazza. Non si sa bene quando iniziarono ad andare su un testo scritto. Uno è Sofrone del V secolo. Solo dal III secolo il mimo si diffonde in tutto il mondo di lingua greca. Eroda, anni 250 ac, testimonia la fortuna del genere, i suoi 8 mimiambi, propongono scenette quotidiane agite da personaggi per molti versi analoghi a quelli tipici della commedia nuova, come amanti infedeli, artigiani e schiavi. Eroda ha un linguaggio affettato e prezioso, hanno però scarsa efficacia drammatica. Nella seconda metà del III secolo si diffonde il mimo basato quasi esclusivamente sulla danza e linguaggi gestuale. ABCtribe.com - [Pagina 13] CAPITOLO 2. IL TEATRO ROMANO AB Ct rib e.c om 1) Il Luogo scenico 1.1 Gli edifici teatrali greco-romani La società romana mostrò diffidenza nel costruire teatri stabili in pietra, l’austero senato riteneva contraria al buon costume la presenza di teatri in muratura perché avrebbero potuto offrire occasioni di ozio. Pertanto gli spettacoli ebbero luogo per lungo tempo entro primitive strutture lignee, erette provvisoriamente e strutte quando il periodo di festa entro cui le rappresentazioni erano inserite fosse terminato. Fino agli ultimi anni della repubblica, gli unici veri edifici teatrali presenti nel mondo romano rimasero circoscritti nell’area geografica –ellenistica, dove si impose un nuovo modello architettonico caratterizzato dal ripensamento e modifica di alcuni elementi costitutivi dei precedenti elementi greci (edifici eretti a Permesso(figura 2.1 pag 94), Patara, Megara, Efeso II sec a.C., mostrano caratteri originali che li differenziano dal periodo precedente: - zona riservata al pubblico si avvicina alla scena (con gradinate che partono direttamente dall’orchestra) - la zona dell’orchestra viene ristretta dall’avanzamento della struttura scenica - il palcoscenico, si fa più basso e profondo rispetto alla norma ellenistica - la scena, realizzata in pietra si sviluppa alta e sontuosa, assumendo carattere monumentale - resta assai poveramente decorata la parte sottostante il palcoscenico il proskénion. 1.2 Gli edifici teatrali romani Gli spettacoli a Roma si svolsero entro strutture lignee provvisorie, costituite semplicemente da un palco rettilineo e sopraelevato (proscaenium), disposto longitudinalmente lungo una parete , nella quale si aprivano porte per consentire le entrate in scena degli attori, la parete era provvista di una piccola tettoia, gli spettatori prendevano posto su panche disposte davanti al palco, collegato a terra da una breve scala di 5 o 7 gradini. Strutture idonee alla rappresentazione di commedie e tragedie venivano erette anche all’interno dei circhi o presso i templi . Teatri di pietra cominciarono ad apparire nella prima metà del I secolo a. C., ma soltanto nel 55 a.C. Roma ebbe un theatrum lapideum edificato da Pompeo(l’edificio di cui non resta alcuna traccia, presentava un ardita soluzione architettonica costituita da una serie di gradinate di pietra (cavea) sostenuta da una sistema di arcate , alla cui sommità sorgeva un tempio dedicato a Venere victrix, accessibile soltanto attraverso le gradinate medesime, la connessione con il luogo di culto permise la sopravvivenza dello stesso giustificandolo agli occhi del senato.)vedi figura 2.2 pag 96 Nel 13 a.C. fu eretto a Roma un secondo teatro stabile, quello di Balbo, seguito due anni più tardi da quello realizzato da Augusto in memoria del defunto nipote Marcello(Teatro di Marcello figura 2.3 pag 97). Il teatro di Marcello si presenta come una costruzione autonoma , eretta all’interno della città su un terreno pianeggiante , non si sente più la necessità di sfruttare un declivio naturale. Nell’ordine inferiore sono collocati gli ingressi al teatro, collegati con un sistema di scale che consentono di raggiungere , ogni settore (cuneus) della cavea e di accedervi tramite i vomitoria, ingressi con soffitti a volta , orizzontalmente le gradinate sono percorse da corridoi (diazoma ) come nel teatro greco mentre la sommità della cavea è disposta una galleria in legno o pietra detta porticus. La scena acquista in profondità ed è chiusa alle spalle da una festosa scaenae frons. Nell’età imperiale numerosi furono gli edifici teatrali costruiti oltre che nella capitale, in tutta la provincia romana e adornati sempre più sontuosamente : i luoghi di spettacolo più antichi, quelli di Siracusa e Pompei furono modificati e dotati di facciate sceniche più ricche, mentre i teatri ellenistici venivano adattati al nuovo stile architettonico romano. La preferenza del pubblico per gli spettacoli coreografici e circensi favorirono lo sviluppo dell’anfiteatro (letteralmente doppio teatro), costituito da una vasta arena ellissoidale circondata da gradinate. Fra i più famosi anfiteatri diffusi in tutto il mondo romano erano quello di Pompei (80 a.C.), Capua e Bozzoli (I sec d. C.) mentre a Roma il maggiore era certamente l’anfiteatro Flavio, detto Colosseo inaugurato nel 80 d.C.. 2)Lo spettacolo 2.1 Forme arcaiche di spettacolo indigeno Le origine dello spettacolo romano risalgono a una varietà di rudimentali manifestazioni drammatiche, sostanzialmente comiche e satiriche che connotano il temperamento del realistico popolo italico primitivo, amante della beffa personale, della battuta ridanciana, pungente, spinta non di rado fino al limite dell’oscenità. I FESCENNINI VERSUS : Un linguaggio fortemente sboccato e una comicità violenta costituivano i tratti del fescennini versus, canti rustici improvvisati che accompagnavano le feste per la mietitura e la vendemmia e che in seguito si estesero anche a numerose occasioni sociali della Roma repubblicana, divenendo caratteristici delle feste nuziali. Il termine fescenninus è posto da alcuni grammatici antichi in relazione con al città falisca di Fescennio (nell’Etruria) mentre da altri è giudicato derivazione di fascinum = malocchio e anche membro virile, con attribuzione a tale forma poetica di una funzione apotropaica, di allontanamento cioè delle energie negative tramite riferimenti indecenti. LA SATURA Prima forma drammatica originale del teatro romano, il termine è di origine controversa: la connessione con il greco saturos è del tutto falsa, mentre appare più verosimile l’etimologia che ricollega tale forma di spettacolo a satura ABCtribe.com - [Pagina 14] AB Ct rib e.c om lanx, un piatto misto di primizie che veniva offerto agli dei ed era chiamato satura per la varietà e l’eterogeneità degli ingredienti. Gli artisti che ne erano interpreti furono detti histriones, da ister termine etrusco per attore. Quando Livio Andronico introdusse sulle scene il modello greco di teatro drammatico, gli attori dilettanti abbandonarono la satura per tornare al vecchio scambio di frizzi liberi in versi, perciò gli attori professionisti la utilizzarono come un exodium come scherzo comico posto in chiusura della rappresentazione di uno spettacolo teatrale LA FABULA ATELLANA Di origine italica, fu anche la fabula atellana, forma di farsa popolare costruita su uno schema predeterminato che prevedeva un intreccio arricchito da equivoci e divertimenti farseschi(tricae) sul quale gli attori improvvisavano battute salaci, lazzi e scherzi comici. Il nome deriva dalla città osca di Atella (tra Capua e Napoli), all’epoca territorio di stretto contatto con le forme spettacolari diffuse nella magna Grecia. Caratteristiche principali: - la presenza di personaggi fissi e ricorrenti: Maccus lo sciocco, Baccus il mangione ingordo e chiacchierone sguaiato, Pappus il vecchio stupido, Dossennus il gobbo astuto o il ghiottone parassita -tendenza alla tipizzazione - impiego di vere e proprie maschere - improvvisazione estemporanea da parte degli interpreti Il successo dell’atellana fu così grande che essa venne assimilata per diventare il genere prediletto dai dilettanti, assumendo la collocazione di exodium ossia di scena comica conclusiva negli spettacoli tragici , finendo per includere anche parodie di soggetto mitologico. IL MIMO Una forma di spettacolo di origine greca che fu accolta prontamente dalle popolazioni italiche e poi dai romani, diventa negli ultimi anni della repubblica e in età imperiale il più popolare e fortunato fra gli spettacoli teatrali. Nel 238 a.C. l’istituzione di una festa in onore della dea Flora divenne un’importante occasione annuale per l’esibizione di tale tipo di spettacolo, a Roma si è evoluto fino a diventare la rappresentazione di un episodio di vita quotidiana, con trama semplice e conclusione inaspettata ma poteva anche limitarsi a una rappresentazione di arte varia con canti, danza e giochi di abilità, gran parte dell’attrattiva era la presenza di interpreti femminili, la cui esibizione rasentava spesso i confini della decenza 2.2 Generi drammatici Con la conquista della Magna Grecia (282-272 a.C.) agli influssi italici sul mondo dello spettacolo romano si sostituì la preponderante influenza ellenica. Da Taranto sarebbe giunto Livio Andronico, il più antico fra gli autori drammatici latini conosciuti, grazie al quale nel 240 a.C. Roma ebbe la prima rappresentazione di tragedia regolare ( cioè con testo scritto e con attori che dovevano apprendere a memoria). Dopo una prima fase di riduzione e adattamento degli originali greci, si passò presto all’introduzione entro schemi e argomenti ellenici di elementi propri dello spirito latino, più vicini al gusto del pubblico romano. Il testo teatrale di qualsiasi tipo fosse era chiamato fabula, termine che necessitava di un aggettivo qualificativo per l’individuazione dei generi. Gli autori latini trovarono i loro modelli ideali nella grande produzione greca del V secolo con una netta predilezione per l’opera di Euripide. La tragedia latina di diretta ispirazione greca fu detta fabula cothurnata (dall’alto calzare a mezza gamba indossato dagli attori tragici ellenistici), o meno frequentemente fabula crepidata (da crepida sandalo greco). Ben presto accanto alle tragedie di ambientazione greca comparve un genere di tragedia nazionale, con soggetto, personaggi e costumi romani, detto fabula praetexta (dalla toga bordata di porpora indossata dagli attori per imitare l’abito dei magistrati romani). Analogamente la commedia latina trasse ispirazione dalle opere fiorite nell’ambito della commedia nuova greca, adatte a divertire il pubblico con intrecci ispirati alla vita quotidiana, il genere più diffuso è la fabula palliata, grecizzata nella trama oltre che nei costumi dei personaggi che indossavano il pallium ampio mantello tipicamente greco. Mentre la fabula togata prendeva il nome dalla toga romana, commedia di ambientazione romana o italica si distingueva ulteriormente in trabeata quando i personaggi in scena erano del ceto dei cavalieri, tabernaria se ambientata fra le classi popolari. 2.3 L’organizzazione degli spettacoli : i ludi Anche a Roma le rappresentazioni drammatiche e gli spettacoli di vario genere erano promossi e disciplinati dallo stato e avevano luogo in occasione di pubbliche feste religiose. Dapprima legati a occasioni episodiche , i ludi divennero presto stabili(ludi stati), legati a determinati periodi dell’anno e finanziati con denaro pubblico: I ludi romani celebrati in onore di Giove Ottimo Massimo nel mese di settembre I ludi plebei istituiti con l’intento di assecondare il gusto del popolo minuto per gli spettacoli I ludi florales istituiti in onore della dea Flora nel 238 a.C. in essi predominavano le rappresentazioni di mimi che per sottolineare i legami con i rituali della fecondità, introdussero esibizioni di ballerine nude, gioghi di animali e rituali orgiastici. Ludi votivi per le celebrazioni di eventi particolari, quali grandi vittorie militari, funerali di grandi personaggi importanti, inaugurazione di monumenti pubblici e più tardi circostanze fauste e infauste legate alla famiglia imperiale venivano organizzati i ludi votivi spesso prolungati e sfarzosi a testimonianza della grandezza e della magnificenza del committente. ABCtribe.com - [Pagina 15] Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. ABCtribe.com - [Pagina 16] Preparati con le domande di ABCtribe su Storia del teatro e dello spettacolo. 1. Il prof.puo' chiedere per prima doma Risposta: La risposta da dare e' la seguente:il teatro e' spettacolo,c'e' in esso una conte [Clicca qui >> per continuare a leggere]. 2. Le innovazioni Risposta: Pre-naturalisti - attenzione per il lavoro di pr [Clicca qui >> per continuare a leggere]. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Storia del teatro e dello spettacolo e guadagna punti >> * Lezioni Private per Storia del teatro e dello spettacolo >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di ABCtribe.com è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. Il presente file può essere utilizzato in base alle tue necessità ma non deve essere modificato in alcuna sua parte, conservando in particolare tutti i riferimenti all’autore ed a ABCtribe.com; non potrà essere in alcun modo pubblicato tramite alcun mezzo, senza diverso accordo scritto con l’autore ed i responsabili del progetto ABCtribe.com. Per eventuali informazioni, dubbi o controversie contattate la redazione all’indirizzo [email protected]. ABCtribe.com - [Pagina 17]
Scarica