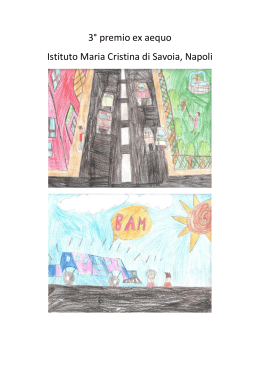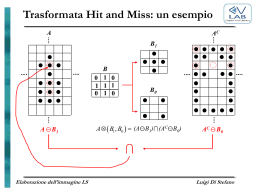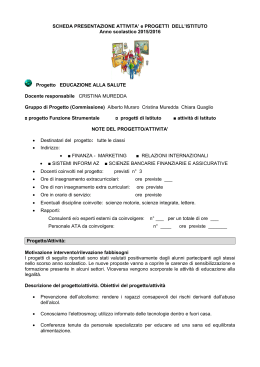Riccardo Becheri CINQUE STORIE D’AMORE di cinquant’anni fa e di sempre Prato 2014 EDIZIONE FUORI COMMERCIO di cinquanta copie numerate a mano e firmate dall’autore. E’ vietata qualsiasi riproduzione. Prato 2014 COPIA N° ©Tutti i diritti riservati all’autore [email protected] www.riccardobecheri.it 1 INDICE 1. Sul gran banchetto che si tiene nel Regno della Luna alla nascita di ogni bambina Pag. 5 2. Ermenegilda la zoppa Pag. 25 3. Incubi Pag. 59 4. Saggio di teologia sessuale Pag. 71 5. Giovani dalla Lucania Pag. 89 2 3 SUL GRAN BANCHETTO CHE SI TIENE NEL REGNO DELLA LUNA ALLA NASCITA DI OGNI BAMBINA 4 5 Nel regno cristallino della Luna si aspettava con ansia la nascita della Barbara, per indire il tradizionale banchetto che una volta era riservato alle figlie dei più potenti re, ma che adesso, in era democratica, viene bandito per ogni neonato, di qualunque condizione sia. A tale scopo, lassù sono stati creati addirittura due grossi ministeri dai burocratici nomi di «Ministero per le Accoglienze alla Nuova Umanità Femminile» e di «Ministero dei Cazzi Nuovi», che in gergo però vengono semplicemente chiamati M.M. (Ministero Maschi) questo; e M.F. (Ministero Femmine) l’altro. Accenneremo appena alla storia dei suddetti ministeri, gli unici due di quel fortunato regno: non c’è nemmeno un re, sebbene sia un regno. Basti dire che tanto tempo fa l’M.F., composto soprattutto di buone fate, pianificava un’umanità tutta perbenino, casa e lavoro, famiglia e timor di Dio; l’M.M. (maghi, stregoni, indovini e altri maschi) auspicava al contrario sane generazioni di gaudenti senza tabù sessuali; e per tener fede al proprio motto «Libertà e Parolacce», si era intitolato con il nome riferito di sopra. Però, era successo quello che sempre succede: i partigiani delle due fazioni avevano cercato con ogni mezzo di sottomettere la potenza nemica. E dopo vicissitudini che sarebbe lungo raccontare, ci si ritrovava ora con il Ministero Maschi in mano alle fate e col Ministero Femmine dominato dai maghi. Fosse stato solo questione di cambiare le sedi ministeriali, poco male. Il fatto e’ che, durante la penetrazione in campo nemico, le due quinte colonne avevano dovuto assumere il linguaggio dell’altra parte e, per far carriera tra i nemici, far mostra non solo di condividere, ma di fanatizzare le idee che segretamente combattevano. Andò a finire, col passare degli anni, che tutti rimasero persuasi dalle proprie affermazioni traditrici, trasformando così la cristallina ipocrisia in sincerità cristallina. Tutti gli uomini, è risaputo, si fanno più convincere dal cumulo e dalla violenza delle parole, specie poi se sono dette da loro stessi, 6 che dall’evidenza e dalla giustezza delle idee; e le fate e i maghi del Regno della Luna non sono in fondo molto differenti dagli uomini. Il Ministero Maschi, dunque, era il ritrovo di bellissime fate in costumi succinti, con cosce e seni scoperti, coi grandi occhioni sottolineati e sopralineati dalle matite e con le avide labbra sempre in attesa di baci. Il Ministero Femmine, quello interessato alla nascita della Barbara, era invece un covo di gabbanoni maturi e riflessivi tutti presi nell’opera di salvamento della moralità. Appena avuta notizia della felice nascita della Barbara, questi capi dell’M.F. spedirono gl’inviti per il grande banchetto a tutti gli abitanti del regno, compresi i capi, o meglio le caporione dell’altro ministero, senza eccezioni o dimenticanze; e ciò in seguito alle dolorose esperienze dei tempi antichi, quando qualche strega non invitata, per risentimento e invidia, lanciava tremende maledizioni sulla piccola nata. Oggi però, dobbiamo riconoscerlo, di streghe così cattive non ne esistono più: tutte le abitanti del Regno della Luna, streghe o fate che fossero in passato, hanno assunto il provocante aspetto sullodato e si sono votate anima e corpo alla loro ideologia sessuale; anima e corpo, il corpo soprattutto . A quel banchetto fu naturalmente invitato anche il folletto Ariele: doveva rappresentare la Barbara e difenderne gl’interessi quando i convitati avrebbero deciso il suo futuro. A lui, o a lei (non si sa bene: Ariele non ha sesso), questo difficile incarico era affidato direttamente dalla Costituzione del Regno della Luna: le benemerenze guadagnate da Ariele in tale Ufficio sono ben note a tutta l’Umanità, la quale altamente apprezza il suo spirito di sacrificio e la sua dedizione al dovere, preclare virtù che resteranno come fari indicatori per le future generazioni di folletti. La costituzione aveva scelto Ariele per quell’incarico perché 7 è l’unico folletto che esista e che mai esisterà (è immortale come tutti gli abitanti della Luna) e perché, non avendo sesso, dovrebbe essere superiore alla contesa dei due ministeri. Oltre ad Ariele intervennero al banchetto (giacché tutti erano invitati ma non obbligati a venire) anzitutto i due ministri in persona: la bellissima fata Verde, la quale indossava un paio di calzoncini del suo colore che arrivavano fino a tre quarti delle cosce, lasciando però scoperto il pancino, teso e morbido, con un meraviglioso ombelico che richiamava alla mente dolci profondità, su cui non insisteremo sicuri d’esser già stati capiti. Intorno agli omeri, aveva due cerchietti d’oro a cui erano fermati con borchie di smeraldi sfaccettati dei corti nastri, sempre verdi, che talvolta per il movimento dei bracci velavano i due stupendi seni, ma che più spesso semplicemente incorniciavano col loro colore la diafana nudità dei seni stessi, lasciati scoperti secondo una moda recente. Ai piedi questo ministro, che tutti gli stati terrestri invidiano al Regno della Luna, non calzava niente: le nude piante premevano il marmo della sala dei banchetti con tanta civetteria da seccare la gola anche ai maschioni là presenti. Già! C’eravamo dimenticati del ministro maschio, sebbene facesse gli onori di casa. Nei secoli scorsi era stato un famoso mago, noto dovunque con il nome di Zerbino, ma poi aveva lasciato perdere la magia, bianca o nera che fosse, e s’era dato alla politica: in breve tempo aveva raggiunto i più alti onori. Per adeguarsi alle sue funzioni, con le sue arti aveva assunto un aspetto venerando, una faccia chiara e solenne, due occhi profondi, una lunghissima barba bianca; e sempre indossava una larga gabbana grigia che copriva tutto il suo corpo imponente. Ma sotto tutto questo paludamento, batteva tuttavia un cuore giovane e innamorato, segretamente innamorato della bella fata Bianca, più volte ministro dell’M.M. negli anni scorsi, sempre candida e desiderabile, presente anche lei al banchetto in onore della Barbara. 8 Rinunceremo per brevità a descrivere una per una le meravigliose fate intervenute alla festa; fra le più importanti nomineremo la fata Scarlatta, quella Turchina, la fata Stella, le fate Arminocinotrostafigibilla e Arminotrostafigibillabad, due sorelle gemelle della potente famiglia degli Arminocinotrostendecasil, le fate Melissa, Alcina e … e tante, tante altre. E dato che fra il moralismo ed il libero amore preferiamo quest’ultimo, rinunceremo, questa volta per astio, a descrivere le venerande barbe presenti là in gran numero, e le chiameremo in causa quando proprio non ne potremo fare a meno. Specialmente se ne coglieremo qualcuna in un momento di debolezza, giacché tutti hanno i loro momenti di debolezza, anche i moralisti di mestiere, i politici, i rivoluzionari e i salvatori di patrie. Finalmente, raggiunto un numero sufficiente di convitati, fu aperto il banchetto. I due ministri, con in mezzo Ariele, si erano seduti al centro d’una lunghissima tavola a ferro di cavallo; gli altri si erano disposti via via, secondo le simpatie. Nessuno però era legato al suo posto: tutti andavano e venivano da un estremo all’altro, per parlare o ascoltare, per sorridere o farsi vedere; Ariele poi, era in un continuo svolazzo lungo tutta la tavola. Il mago Zerbino comunicò la lieta occasione che aveva portato a quel banchetto, elogiò la puerpera che giù in Terra stava felicemente recuperando le forze, lodò la salute e la vivacità della neonata, che un giorno, disse concludendo, sarebbe diventata una brava madre di famiglia e una moglie onesta. Si era appena chetato che la fata Verde era scattata in piedi e aveva preso a gridare con la voce sciocca delle donne comizianti: «E la bellezza di questa bambina non la rammentiamo? Perché se non è una bella figliola, nessuno dei miei ragazzi la vorrà d’intorno; e così non potrà diventare né una madre né una moglie virtuosa, ma resterà zitella e trista e d’impaccio per gli altri. Sarà un essere sterile e dannoso, come qualche ministero di 9 nostra conoscenza, al contrario di quello che io, benché indegnamente, ho l’onore di rappresentare». Il mago Zerbino fece la faccia di tutti i colori delle fate presenti; gettò indietro l’alto scranno che conteneva la sua monumentale persona e tuonò: « Qui si trascende! » Ma non poté aggiungere altro perché Ariele, libratosi sopra la tavola, dette fuori con uno strido acuto l’ordine: «Zitti tutti!» E mentre il mago Zerbino si rimetteva a sedere, tutti effettivamente si chetarono. «Dobbiamo riconoscere» continuò il folletto «che la bellezza non è molto importante in una donna. Se c’è, non guasta; ma una ha la possibilità di rifarsi con l’arte. E sia ben chiaro che non sto pensando ai cosmetici, alle puppe di gomma o ad altri riempitivi: sto parlando dell’arte d’amare e di farsi desiderare A questo proposito m’è venuta in mente una scena che ho visto in uno dei miei Viaggi sulla Terra. Voi tutti sapete che spesso mi mescolo ai comuni mortali, i quali però non mi vedono con quei loro occhietti sempre vuoti e preoccupati; e così posso andare in mezzo alla peggior canaglia di questo mondo tranquillo tranquilla. Proprio da certa gentaglia ho preso il vizio di parlare nel modo sboccato che i signori maghi mi rimproverano col loro nobile eloquio. Un giorno, dunque, era venuto a mancare, diciamo pure che era morto, uno dei più potenti notabili di uno dei tanti stati terrestri. Siccome l’avevo tenuto a banchetto, come ora per la Barbara, e poi l’avevo seguito per tutta la sua vita, mi parve mio dovere partecipare al funerale, benché invisibile a tutti. Il poveretto era morto prematuramente all’età di novant’anni; dico prematuramente perché, pur avendo raggiunto quell’età, era rimasto sempre con un cervellino piccino così. Questo non gli aveva impedito (anzi, l’aveva molto favorito) di fare un treno, o forse anche un monte, di biglietti da diecimila, da povero in canna che era nato. E inoltre era stato creato cavaliere di non so 10 quanti ordini, commendatore, e infine membro d’un certo senato, che poi sarebbe il ritrovo dei vecchioni più importuni, inutili e scioperati di quello stato, ma che laggiù è tenuto in molto onore. Però tutta questa storia di cervelli, quattrini e onorificenze è un’altra storia. Allora, tornavo dal funerale con l’animo soddisfatto di chi ha visto seppellire un potente, quando dal vano di una finestra di una casa di un paese di campagna di uno stato di una terra, cioè della terra, vedo una vecchia gobba brutta, che fa dei cenni a un bel giovanotto. Fui tanto incuriosito che, zitta e invisibile, seguii il giovane fino in camera della gobbetta. Lo scopo dell’incontro sembrava fissato già prima perché, senza tanto discutere, si spogliarono, si distesero sul letto e cominciarono a fare all’amore. Devo dire che il giovane avrà avuto al massimo diciassett’anni; la gobba, mi sembrò in quel momento, dai quarantacinque ai cinquanta. Lasciamo perdere l’età, ma quant’era brutta! Aveva la faccia vizza, mezza dipinta e male, il collo sgonfio, la grande gobba, il petto all’indietro anziché all’infuori, due ossi ritti per fianchi, un ciuffetto spelacchiato nel mezzo e due stecchi d’osso e cuoio al posto delle gambe. Eppure, stesa su quel letto e con quel giovanotto sotto o addosso, valeva perlomeno dieci veneri e quindici fate di questo regno. Macché belle puppe e mele ravviate! Lì c’era l’arte: saltava, si scuoteva, si rigirava, grondava, urlava e poi baciava e stringeva e mordeva e succhiava e rabbrividiva. E alla fine, ricominciava da capo; sino a quando quel povero giovane che era cascato nelle sue mani, cioè tra le sue cosce, non ebbe raggiunto il traguardo di sei. Allora, dopo un necessario riposo, fu lasciato andar via, smunto, spompato, e con la colonna vertebrale accorciata di venti centimetri. Questo, cari signori, è ciò che conta in una donna. E quelle belle bambole che poi, in posizione orizzontale, assomigliano al buco d’un acquaio, dovrebbero essere 11 condannate a portare al collo un cartello con su scritto: “E’ tutt’apparenza : ‘un ho sugo”». Ariele non aveva ancora chiuso la bocca che la fata Bianca s’era alzata esclamando: «Se Ariele fosse un uomo, con molto piacere gli daremmo un saggio della nostra arte, perché noi fate si vale quanto codesta gobba, se non di più. A parte ciò noi siamo proprio del suo parere. E se una donna non è capace di trastullare a dovere il suo uomo, faceva meglio a rimanere nei coglioni di suo padre. E questo vale anche per gli uomini: ricordatevelo voi con i vostri gabbanoni». Zerbino ebbe un sussulto alle dure parole dell’amata; e non resisté più. Si decise: con la mano destra, fece un gesto pronunciò la formula magica, e lui e la fata Bianca si ritrovarono distesi su una solitaria spiaggia assolata, con davanti il mare splendente e alle spalle una pineta con freschi prati, sorgenti d’acqua pura, un ruscello tintinnante e, poco discosta, una villa con due spaziose verande dalle quali si poteva scorgere il sorgere del sole, seduti su divani e poltrone o stesi su stuoie e cuscini sparsi ovunque. Il mago Zerbino, nel momento stesso dell’incantesimo, aveva ripreso il suo corpo giovane e gagliardo di tanti secoli fa. Ma non per questo avrebbe potuto ingannare gli occhi della fata Bianca, che, dopo il primo attimo di smarrimento, avrebbe potuto con un semplice gesto della mano rendere del tutto vana la magia di Zerbino e ritornare all’istante nella sala dei banchetti all’M.F. . Ma lei non fece niente di tutto ciò; al contrario, si rivolse con fare protervo al bell’incantatore che le stava acconto e gli disse: «Oh, Oh, signor ministro, siamo forse caduti in preda ad alcuni innominabili desideri da libertino?» «Via Bianca!» rispose Zerbino col tono dimesso di chi allo stesso tempo si scusa e accusa. «Possibile che tu non capisca quand’è l’ora di mandare all’inferno le teorie e di vivere semplicemente la vita, senza infastidirla con le parole? Voi 12 donne avete un a gran zucca dura: è difficilissimo farvi entrare in testa un’idea, ma quando c’è entrata, è impossibile mandarla via». Stranamente, la fata Bianca non reagì: aveva sulle labbra un sorriso non si sa se di compiacimento o d’ironia. Zerbino proseguì: «Sono stanco del ministero, dell’umanità femminile e della salvezza della moralità. In fondo, che ce ne importa a noi dell’umanità e dei suoi destini? Ma che vada pure a rotoli! Il bello poi è che l’umanità potrebbe benissimo fare a meno di noi e dei nostri ministeri. E come sarebbero felici! A me piacerebbe restare qui, e vivere in mezzo a questa natura solitaria e delicata. Con te». Zerbino si sporse verso la fata Bianca e la baciò. Lei teneramente rispose. Quindi s’alzarono, entrarono nella pineta e si diressero alla villa, tenendosi in un molle abbraccio pei fianchi e scambiandosi brevi parole d’amore in un soffio, come per timore che l’aria si stupisse e li deridesse per la loro ingenua semplicità. Sulla veranda, sopra un divano accogliente, fecero all’amore nel modo e violento e affettuoso che due persone adulte che si vogliono bene sono solite fare; e non alla maniera isterica dei giovani introvertiti, che certuni ci propongono per farsi notare e far quattrini. E dopo finalmente si sentirono stanchi, felici ed uniti. Ma anche affamati. Scesero dal divano, ma non vollero sedersi alla tavola che era lì pronta, in un atteggiamento così formale. Zerbino allora prese dei piatti e una fruttiera ricolma; la fata Bianca, due bicchieri e una bottiglia di fresca acqua di sorgente; e si sdraiarono sulle stuoie vicinissimi l’uno all’altra, con la testa appoggiata sui cuscini. In questa posizione piluccarono qualcosa dai piatti, calmarono con l’acqua la grande sete che danno i giochi d’amore, e più che altro godettero della loro vicinanza. Zerbino dopo un po’ disse «Restiamo qui davvero, in questo paradiso dove nessun altro può entrare, io e te soli. Passeremo le 13 giornate a nuotare in mare o nel ruscello, e ci costruiremo una barca, non con la magia, ma col lavoro delle mani, per la soddisfazioni di costruire; e faremo delle gite in barca e delle lunghe passeggiate nella pineta». «Oh, si! E io dipingerò: ho sempre sognato di dipingere alla maniera degli antichi maestri cinesi: quei loro paesaggi con i bambù inclinati e coi rami contorti d’un albero che sembrano uscir fuori dal quadro, e con al centro una piccola casa, tutta di legno e carta, minuscola, fragile». «E io scriverò poesie: poemi più lunghi di quelli d’Omero; e nei momenti di malinconia, quando piove o dopo il tramonto del sole, brevi elegie; e per te scriverò canzoni d’amore e ballate, e canti a non finire per la felicità di vivere, d’avere una donna come te, d’essere soli e in pace e, soprattutto, per la fortuna d’aver ricevuto un cuore e un cervello e per la contentezza di non averli intristiti in cose triviali come la politica, la carriera, i soldi o la maldicenza». E qui, con voce sommessa, il mago Zerbino recitò questi versi: I miei sogni sono un grigio tabernacolo contadino che resiste al tempo. La poesia che li guida, canto trepido di bellezza, ancor mi raggiunge. 14 La mia vita: Oh, roseto, i cui petali ad uno ad uno fioriscono eterni! Così cantava Zerbino. Ma noi, ormai, dobbiamo lasciare il mago e la fata alla loro felicità. Si sa che le persone felici si rassomigliano tutte, mentre invece ogni infelice è infelice a suo modo. Frase questa che, tolto il lieve velo filantropico stesovi sopra per renderla accetta alla massa, significa che la felicità degli altri ci dà uggia, mentre le loro disgrazie ci fanno piacere e non ci stancheremmo mai di sentirne di nuove. Torniamo perciò nel salone dei banchetti all’M.F., dove, se non proprio disgrazie, troveremo almeno delle disavventure. I maghi più svegli lì presenti avevano subito notato la contemporanea sparizione del mago Zerbino e della fata Bianca; e senza perder tempo in congetture lubriche s’erano buttati immediatamente a intrigare per scalzare Zerbino dalla sua carica. Il gran mago Trimanzone, attorniato dai suoi fedeli, aveva fermato Ariele a metà d’un volo e cercava ora di trarlo dalla sua parte, lusingandolo e facendogli proposte oscene in bravi versi decasillabi (in privato parlava sempre in versi, specie decasillabi, più raramente in prolississimi martelliani o in isdrucciolosissimi settenari; in pubblico, al contrario, adottava una prosa assai concettosa). Diceva dunque ad Ariele: Quando Ariel nel segreto matura la libidine amara del cuor, non diciamo al suo sguardo :«Perdura!» Lui non ha od ovaie o coglioni 15 per sfogarsi dal torbido amor; epperciò noi faremgli guatar tale amplesso ch’ei possa uguagliar un amante che sale in arcioni. E sempre con questo passo rimato chiese ad Ariele, in cambio dello straordinario spettacolo offertogli, d’affrettare l’indirizzo d’auguri alla neonata Barbara, chiamando a presiedere la cerimonia, nella inspiegabile e ingiustificata assenza del ministro, lui, il grande e benstimato e onorevole mago Trimanzone. Sennonchè , Ariele benché fosse allettato dall’offerta, non seppe resistere alla tentazione di prendere in giro il mago rimante e versificante. E rispose con questi versi metafisici, secondo il vezzo degli ultimi poeti alla moda: Dalle fredde aurore stiracchiate da torrida luce, venne. Non gabbiani volavano ma verdi serpenti. E lui si inoltrò nei grappoli di infinite distese. Le ciocche di uva si allungarono, fino a raggiungere il cerchio perfetto dei quadrati. Chi grida di affacciarsi? Il vuoto delle finestre è stato strappato a sua madre e distrutto, e gettato in un angolo. Ho visto verdi montagne fuggire lungo balaustre di ferro, per non esser mangiate da una farfalla senz’ali. Che altro mi resta? 16 C’è molta noia, in fondo. Non diciamo la faccia che fece il mago Trimanzone a sentire queste strofette. Inspirò tanta aria da creare un vortice nella sala, poi si trattenne un attimo al massimo della tensione e infine espirò dal naso con un unico colpo secco. Con tutta la sua dignità, girò lentamente la testa e guardò oltre, in silenzio. Il banchetto tirava avanti con crescente disagio. Alcuni maghi, i più giovani, si erano distratti e amoreggiavano con le rappresentanti del ministero nemico. Le caporione dell’M.M. non celavano la loro soddisfazione per quello sfacelo ideale e organizzativo. Si venne insomma a una situazione per cui tutti i maghi importanti, anche i più fedeli a Zerbino, si videro costretti a chiedere ad Ariele di concludere il ricevimento senza aspettare il ritorno del ministro; scandalo mai avvenuto da che il Regno cristallino della Luna è il Regno cristallino della Luna; e che di per sé portava alla sostituzione del ministro assente col nuovo mago che avrebbe presieduto la cerimonia. Ariele, allora, si librò alto sopra la tavola reclamando silenzio e attenzione, poi, sceso in basso, chiamò ai suoi lati la fata Verde e l’integerrimo mago Trimanzone, così stimato da tutti per il suo attaccamento alla tradizione e alla Costituzione del Regno. E finalmente disse: «Alla Barbara, questo nuovo fiore che si è appena aperto alla vita, io, a nome di tutto il regno lunare che domina le influenze celesti sui destini dei mortali, auguro e preservo un lungo cammino. Per la nostra benigna disposizione, la sua vita non conoscerà fratture che la conducano alla perdizione, né si fermerà al piatto benessere che la getterebbe nella noia e 17 nell’indifferenza. Sarà sempre entusiasta di vivere, perché nell’animo rimarrà giovane e pura fino alla tomba. E se come donna, non le è dato di diventare un grande e di lasciare un segno nella storia dello spirito umano, essa, come donna, sarà felice. Proverà e possederà a lungo le gioie dell’amore, partorirà figli che non le daranno dolori e riempirà il resto della sua vita con attività e interessi che non la facciano però assomigliare a una scimmia insulsa. E a coronamento della sua vita, morirà senza rimpianti. Questo decretano alla Barbara le influenze astrali che io rappresento». Ariele finì il discorso fra un clamore d’applausi. Poi, stabilitosi un po’ di silenzio, il mago Trimanzone s’alzò gongolante dallo scranno che era stato di Zerbino e pronunciò con la voce del fato le seguenti parole: «La celebrazione in onore della Barbara è terminata». Stese la mano come per dire:«Attimo, fermati!», fece lo sguardo pensieroso e la faccia raccolta e, dopo un abbondante minuto di solenne immobilità, tenne una concione in questi termini: «Abbiamo attraversato una lunga fase in cui una minoranza, non autorizzatamente , ha inferito, appoggiandosi alla autorità del mago Zerbino, di zerbinare o zerbinizzare la totalità della collettività dei maghi. Dobbiamo, nella nostra nuova qualità di Autorità ministeriale, rievocare e richiamare davanti agli occhi della memoria di tutti, il processo, lo svolgimento, la graduale evoluzione, il subdolo evolversi di tale nominata zerbinizzazione. Primo, in ordine a una nostra presa di coscienza della effettualità storica. Secondo, a disvelamento della effettiva maturità di certi zerbinizzatoristi nostrani. Terzo, affinchè tali inauspicabili zerbinizzazionature non si hanno a ripetere in un futuro più o meno prossimo. Direi dunque che, oggi, pure la Dezerbinizzazionatura è fattibile: l’ambiente è ricettivo e gli 18 strumenti sono adeguati. Ciò che difetta è proprio una volontà, da qualunque parte proviene, è pur piccola, è pur invisibilmente minuscola, diametralmente opposta alla nostra di Dezerbinizzazionaturare, di non- dezerbinizzazionaturare lo ambiente della Alta e Media Burocrazia Ministeriale o, generalmente parlando, di tutta quanta la Coscienza Mentale Burocratile: nemmeno in vitro tale coltura è coltivabile o economicamente redditizia o lascivamente accarezzabile nel chiuso di certe Torri di Avorio oggi di moda in alcuni strati ormai tagliati fuori dalla viva circolazione delle idee veramente di oggi. Dunque, sulla base della considerazione della situazione di ogni e qualsiasi manifestazione odiernamente concepita di vitale Idealità concreta, nessuno vorrà o potrà trascinare le Masse Contadine, gli insostituibili e positivi, e cristianamente presenti in ogni posto di lavoro, Lavoratori e del Braccio e della Mente, con la loro Carica rivoluzionaria, li vorrà o potrà trascinare, dicevo, in una folle corsa verso una pretestuosa disdezerbinizzazionaturazione. Questi certuni, che possiamo definire rottami sociali e culturali, non disderbinizzazionaturerebbero il processo ormai avviato, e inarrestabile, sulla corsia evidenziale del futuro, emergente, andamento della realtà politica e sociale, ma soltanto estrinsecherebbero la loro apolitica e asociale e aprioristica illusione di potere non tenere conto delle istanze della collettività. La Non-Disdezerbinizzazionaturizzazione non è niente di meglio della semplice, ma ugualmente con esito positivo, è ben chiaro, Ridisderbinizzazionaturizzazione; ed è evidente che noi dobbiamo preferire la e combattere per e diffondere la e sacrificarsi per, se richiesto dalle circostanze o dal Destino Cinico Baro, la prima Tesi, la Tesi Non-Disdezerbinizzazionaturizzazionica o semplicemente, con termine invalso nelle cronache politiche, il nostro incrollabile Antidisdezerbinizzazionaturizzazionismo. Molte sono le cause che ci condussero al triste passo veterofilozerbinizzazionaturiz- 19 zazionista: il fall-down Demografico, con le sue componenti psichiche e psico-amatorie; l’innalzamento della Curva Ascensionale Nascite registrato dai nostri Uffici Informazione, pure registrato dai S.S.S. (Servizi Statistica Statale), e pure registrato dai registri anagrafici di qualunque, a scelta Ufficio Anagrafico Comunale, o Provinciale, o Regionale, o Statale; infine l’insita struttura di rottura nella conduttura che dalla catena di produzione delle linfe vitali sociali non poteva più attingere il Vertice della Piramide Ministeriale, che andava così soggetto a una anchilosatura , ma che, con inane e intieramente, di una intierezza veramente intiera, improduttiva attivizzazione a vuoto della Energia Risorsile Umana e Ministeriale, cercava un punto di sutura con, una linea di apertura a, un piano di cattura di, una sfera di autovitallizzatura a mezzo di….. la cultura e la congiuntura moderna. Tutto ciò miseramente fallì: e l’immane, incommisurabile baratro dello Ex-Destrorsofilozerbinizzazionaturizzazionismo strangolò con le sue gelide mani la nostra reciproca, fattiva, Co-operazione, deflorando la verginità dei nostri Ideali Sociali Comunitari. Laddove alcuni di uomini o donne oppure, generalmente definendo, un 5%, massimo un 5,50% dei membri del Corpo Elettorale, di fronte a quel baratro, infinitamente e reiterativamente, ma intrinsecamente poveramente, non sapevano pòrci, ripòrci, che la consueta e desueta soluzione del problema posto invece nei termini concreti dalla Emergenzialità Temporo-Culturale da noi indegnamente ricoperta nel presente momento storico. Davanti ai qualificati Rappresentanti della Umanità intiera, di fronte a questa Assise Ecumenica e Universale, dirimpetto a tanta e così sensibile Parte della Opinione Pubblica, di contro alle Autorità Costituite, sotto la coscienza del Giudizio immancabilmente positivo che su noi sarà per pronunziare il foro Supremo della Storia futura, da questa Alta Tribuna, noi diciamo chiaramente e scanditamente: “Basta col canone paradigmatico 20 di un inqualificabile e insostenibile iperdestrorsofilozerbinizzazionaturizzazionismo! Basta col parimente insostenibile criptosinistrorsofilozerbinizzazionaturizzazionismo!” Il dilemma va posto nei seguenti tre termini e gridato e ribadito e incanalato in ogni angolo del Paese, radio e teletrasmesso ovunque sta una coscienza influenzabile dai moderni Mezzi di persuasione Occulta: «Non Superultravietofilozerbinizzazionaturizzazionatevi, né Ergaselfgottaantidisdezerbinizzazionaturizzazionatevi, ma Gaudiobyselfconscienceprofilodezerbizzazionaturisticiziamoci!» A questo punto successe una cosa che gli annali del Regno cristallino tacciono per censura prudente. Il mago Zerbino, che con le sue arti magiche aveva udito e visto tutto quello che era successo nella sala, aveva deciso di dare un ultimo saluto ai suoi collaboratori e nemici. Con la sua grande magia, appena Trimanzone ebbe detta l’ultima parola, immobilizzò dov’erano e com’erano i presenti; e, prima che si riavessero dalla sorpresa, mandò nella sala un turbine che sollevò tutto e tutti per aria. Alla fine della magia, le bellissime fate si ritrovarono strette in un mazzo, avvolte e legate dalla lunga tovaglia, che lasciava intravedere solo la punta dei nasi, una mano fino al polso e un piede fino alla caviglia, a mo’ di punizione. Ariele era steso per terra, a pancia all’aria e a bocca aperta: una bottiglia caduta sul tavolo proprio sopra di lui, o di lei, gli aveva rovesciato nello stomaco il suo contenuto a novanta gradi. Ora il folletto cantava con voce avvinazzata sconce canzoni, dando di volta in volta un bacio a un grosso piede di gesso, che abbracciava con la destra, e una carezza a un’oscura pelliccia stesa alla sua sinistra. Il mago Trimanzone si ritrovò a cavalcioni del seggiolone ministeriale, con le cosce sui bracciali, il culo nel vuoto, il mento appoggiato all’alto schienale e la barba ciondoloni. In testa, simile a un tocco, aveva un colino rovesciato che 21 lasciava strisciare grovigli di spaghetti giù per le gote e il collo; nella mano destra stringeva un mestolo, mentre sulla sinistra teneva un popone. Di fronte a lui un grande specchio rifletteva la triste figura. Degli altri non importa parlare. 1964 22 23 ERMENEGILDA LA ZOPPA 24 25 I Era nata il 13 Aprile, giorno di Sant’Ermenegildo, per questo le avevano messo nome Ermenegilda, un nome ridicolo. Quando divenne una ragazza, i parenti e i conoscenti cercarono invano di abbreviare quel nome: Ermenegilda rimase, e tutto intero. Alcuni l’avevano chiamata Ermene, ma non suonava bene e avevano smesso; altri Gilda, finché non uscì un film nel quale la protagonista, bella e seducente, portava quel nome; allora anche loro smisero di chiamarla così, perché pareva detto per scherno. Infatti Ermenegilda era nata zoppa, cioè senza un’anca, come diceva la gente. Se stava poggiata sul piede destro, non ci accorgeva per niente del difetto: le due gambe erano perfettamente uguali. Ma bastava che essa spostasse il peso del corpo dalla parte sinistra che il tronco e il bacino si inclinavano paurosamente verso terra con una mossa mostruosa e goffa. Lei stessa si metteva molte volte davanti allo specchio dell’armadio, chiusa in camera sua, a rimirare le sue gambe. Stava con tutto il peso sul piede destro e si dondolava lentamente, come assaporando la forza e la stabilità di quella gamba. Il sinistro lo posava mollemente per terra. Stava a lungo a guardarsi nello specchio, nella naturale posizione eretta, e le sembrava impossibile che spostando impercettibilmente la massa del suo corpo sarebbe stata costretta a quell’inchino di sghimbescio, ridicolo, orribile a vedersi. Eppure, ecco, ogni volta avveniva, puntualmente. Oppure no? Questa volta, forse, l’anca avrebbe retto e il suo corpo sarebbe rimasto diritto anche se lo poggiava sul piede sinistro. Sì, questa era la volta buona! Non poteva essere condannata per tutta la vita e quella pena senza colpa; questa volta avrebbe retto. Ed ogni volta che pensava così, quasi si convinceva di non 26 aver più quel difetto; ed ogni volta che provava, sprofondava dolorosamente verso terra, sulla sinistra. Ma poco dopo, o il giorno seguente, di nuovo si alzava e si abbassava sul piede destro per provarne la forza e di nuovo si illudeva che anche col sinistro avrebbe fatto altrettanto e di nuovo sprofondava vergognosamente verso terra. Così era arrivata a ventotto anni. Viveva sola con la vecchia madre in una casetta a “La Querce”, una frazione del Comune di Prato, fra città e campagna. I suoi compaesani non le piacevano: dietro le spalle, lo sapeva, la chiamavano “ la Zoppa, Ermenegilda la Zoppa”. E lei cercava di evitarli. Quando non era a lavorare, prendeva la bicicletta e pedalava finché non era stanca, lontano, dove nessuno la conosceva. Le piaceva andare in bicicletta perché poteva muoversi senza zoppicare e sembrava una ragazza come le altre. Faceva forza solo con la gamba destra, ma teneva fisso il piede sinistro al pedale facendolo roteare completamente, di modo che nessuno che già non la conoscesse avrebbe potuto accorgersi del suo difetto. E lei ne era felice. Spesso i giovanotti che incontrava la guardavano con quello sguardo inconfondibile, non con commiserazione come quando era a piedi e zoppicava, ma con ammirazione e con voglia. Talvolta le fischiavano o le sorridevano o le facevano dei segni. Questa era una grande gioia per lei, l’unica che poteva ricavare dal fatto di essere donna o di desiderare naturalmente gli uomini. Le sue amiche, quelle che avevano la sua età, erano tutte sposate, avevano dei figli, una famiglia. Ma lei? Nulla, niente. Se Dio non le aveva dato un’anca, poteva forse darle un marito, un amore, dei figli? Lei era solo uno scherzo di natura: a che scopo trovare un marito a uno scherzo di natura? Un giorno in cui si sentiva particolarmente oppressa per la sua infermità, le parve di aver raggiunto il limite delle sue sofferenze e privazioni. Ora basta, si disse, anch’io voglio avere qualcosa nella vita. 27 Era il pomeriggio di una domenica di Agosto. Faceva caldo. Si era spogliata quasi del tutto per trovare del refrigerio, sdraiata sul letto, al buio. Ma poi si era alzata, aveva aperto uno scuretto e si era messa davanti allo specchio. La pelle era liscia e curata; le gambe piene e tondeggianti. I muscoli si disegnavano sopra i ginocchi dando alle cosce una forma sfuggente, guizzante. Il ventre largo e teso. Il sedere un po’ grasso, vistoso, con due seni che sembrava cantassero quando erano liberi e si muovevano. Il collo, le mani, gli orecchi erano freschi. Solo le fattezze della faccia erano rozze e non molto invitanti. Ma lei cercava di correggerle e di abbellirle con un trucco esperto e non visibile. Si acconciava i capelli all’ultima moda. Andava dalla parrucchiera due volte la settimana e aveva sempre la testa pulita e ben ordinata. Usava i profumi più delicati. Indossava le camicette, le maglie, le gonne più attraenti e costose. Spendeva, per essere seducente, buona parte dei suoi guadagni di rammendatrice, come un fiore che si ricopra di mille petali colorati e di mille profumi e sul quale neanche un insetto si ferma a succhiarne l’essenza. Per chi erano quei vestiti dai colori così morbidi? Quei profumi? Quei capelli ora gonfiati, ora stirati, ora attorcigliati sul capo? Quei rossetti e tutte le ciprie e creme? Per chi erano quei seni aperti? E il ventre? E le cosce? Davvero nemmeno un insetto osava posarsi su di lei, per compassione o ribrezzo. Ed eccola là, con mille attrattive e sterile come un mulo. A che scopo l’ossessionante, puntuale ritorno del mestruo che ogni mese le ricordava che anche per quel periodo niente era successo? A che scopo tutto il suo essere donna? Tutto in lei, a che scopo? Perché per lei non c’erano mai gioie e soddisfazioni? Eppure nonostante il suo desiderio, non poteva, non poteva in alcun modo avere un uomo per sé, legato per tutta la vita, lo sentiva. C’era come un muro invalicabile fra lei e le persone che conosceva, un muro creato dal suo difetto e dai sentimenti che 28 esso ispirava negli altri, dallo scherno alla compassione. Nessun uomo avrebbe mai oltrepassato quel muro per restarle vicino per sempre. Nessuno l’avrebbe mai sposata. Ma non poteva rinunciare a tutto. Sì, non si sarebbe mai sposata: a questo il suo intimo si era già rassegnato, ormai. Ma un figlio, perché non poteva avere un figlio? Un figlio che le si stringesse vicino, un figlio per cui vivere e che avesse quello che lei non aveva avuto, un figlio che le volesse bene anziché compatirla? Sì, questo non potevano negarglielo: un figlio! Oh, si immaginava le risa ironiche della gente, dei suoi compaesani, quando fosse comparsa in giro con la pancia gonfia. E le loro chiacchiere: «Hai visto, anche Ermenegilda la zoppa ha il ganzo.» Oppure: «Toh! Anche l’Ermenegilda, zitta e zoppa com’è, si è fatta ingravidare.» Tutto questo avrebbero detto, e qualcos’altro di più maligno e cattivo. Ma a lei che cosa importava di costoro e delle loro chiacchiere? Perché si mettevano a giudicare e a pretendere che lei rinunciasse a tutte le gioie nella vita? Che contropartita le avrebbero offerto in cambio delle sue privazioni? Niente. Perciò stessero zitti e pensassero ai fatti loro. Lei voleva un figlio e lo avrebbe avuto. Neanche Gesù e la Madonna avrebbero potuto fermarla. In cambio dell’anca che le mancava e di tutti i dolori che gliene erano derivati poteva bene chiedere un figlio anche se non era sposata. Sì, questo solo pretendeva e pregava: di avere un figlio. Ma chi, chi glielo avrebbe fatto fare? Doveva trovare un uomo, un giovanotto che venisse con lei per una sola volta, non di più certamente perché non desiderava affatto continuare una illecita relazione che ripugnava a tutto il suo essere. E ci sarebbe riuscita a trovare quest’uomo, lo sapeva. Il suo corpo non era spiacente, era solo l’infermità, ma stesa su un letto era appetitosa come qualsiasi altra donna giovane e fresca. Il problema era riuscire a portare un uomo in camera senza che quello fuggisse, preso dal disgusto alla vista del suo passo zoppo, davanti a 29 quell’orribile inchino di traverso. Ci voleva qualcuno….. un giovanotto di bocca buona, che non guardasse tanto per il sottile. Sì, un giovane di diciannove, venti anni, di quell’età in cui la voglia di fare all’amore sprizza fuori dagli occhi ed è sempre pronta a sfogarsi su chiunque. E doveva essere sano e anche un bel giovane, perché da lui sarebbe nato suo figlio. Per lei come madre non c’erano pericoli o dubbi. Aveva chiesto anni prima a un dottore se poteva avere figli e se sarebbero nati zoppi come lei. Il medico aveva risposto affermativamente alla prima domanda. Per la seconda aveva tirato in ballo un monte di storie, eredità e probabilità, ma alla sua richiesta di una risposta chiara, aveva replicato: «Se lei dovesse avere dei figli quasi sicuramente saranno tutti perfettamente normali.» A lei questa risposta era parsa soddisfacente e rassicurante. Ora doveva trovare il giovane adatto. Non doveva essere della Querce, perché potevano nascere questioni se il figlio crescendo fosse venuto ad assomigliare al padre. Doveva essere di lontano, che nessuno aveva mai visto e che, possibilmente, nessuno vedesse più, dopo. Ma dove conoscerlo, studiare se andava bene per quello che doveva fare e …. invitarlo? In fabbrica! Sì, in fabbrica era il luogo adatto. C’erano tanti giovani che lavoravano insieme a lei, giovani di tutte le età e di tutti i gusti, che certo non si sarebbero fatti pregare per compiere quell’ufficio. Ma sarebbe stato necessario sceglierne uno riservato, che poi non spifferasse tutto agli amici in fabbrica. Del resto che le importava? Quando avesse ottenuto ciò che voleva, si sarebbe licenziata da sé e avrebbe cambiato fabbrica. Era una brava rammendatrice e poteva cambiare quanti posti voleva. Che lui ne parlasse pure! D’altronde non avrebbe potuto continuare ad avere sempre sotto gli occhi il padre di suo figlio e trattarlo come un estraneo. Appena raggiunto lo scopo doveva cambiare fabbrica e non rivedere mai più colui che l’avrebbe resa madre. Anche perché 30 costui non insistesse ad avere altri appuntamenti, caso mai. Era fermamente decisa a troncare subito la relazione: il suo scopo era di aver un figlio, non un amante; a questo ormai aveva rinunciato. E inoltre, lui poteva impensierirsi e fare qualche scenata, quando vedesse che lei era rimasta incinta. Sì, dopo il fatto avrebbe lasciato quella fabbrica e avrebbe cercato di non rivedere mai più colui che l’avrebbe fecondata, colui che avrebbe fatto di lei, fiore sterile, una madre. II Il giorno seguente, e per tutta la settimana, osservò e soppesò i giovanotti che lavoravano con lei. Seduta al suo banco, mentre rammendava le pezze, dava di tanto in tanto occhiate profonde ora a questo ora a quello. C’era Mario, il follatore, bel ragazzo, alto e buono, ma troppo fortunato con le donne: l’avrebbe senza dubbio rifiutata, lei, una sciancata, se poteva avere, come correva voce, tante ragazze giovani e belle. C’era poi Roberto, altro follatore, ma era un tipo giallo e malaticcio: non era il caso. Paolo, un tipo grande e grosso a cui erano affidate le mansioni più basse e faticose, ma tutti lo prendevano in giro e lo tenevano per tonto. C’erano altri uomini, però tutti sposati o fidanzati e tutti di un’età che non era quella da lei voluta. C’era anche un tipino, che nonostante si chiamasse Adone (ma tutti lo chiamavano Àdonne), sembrava un topo, piccolo e capelluto. Costui lavorava a una cimatrice, la macchina più vicina al banco di Ermenegilda. Per via della sua aria continuamente spersa e timida, tutti lo trattavano con sufficienza, come un bambino di cui non vale la pena di occuparsi. Anche Ermenegilda si era adeguata al tono comune e lo trattava come un ragazzo benché avesse ventuno o ventidue anni. Àdonne le sembrava il più 31 circuibile di tutti, ma non le piaceva l’idea che suo figlio venisse ad assomigliare a quel cosino minuscolo. C’erano altri: Sandro il magazziniere, il tipo adatto ma fidanzato. Il fatto che alcuni fossero fidanzati, e a maggior ragione sposati, le pareva che escludesse la possibilità che essi acconsentissero al suo desiderio: il paragone con l’altra, con la moglie o la fidanzata, sarebbe stato schiacciante per lei. Era meglio lasciarli perdere. Ah, ma ecco chi poteva andar bene: Gino il garzatore. Aveva venti anni all’incirca, era un ragazzo discreto, dava l’impressione di essere un tipo taciturno, pur avendo un carattere comprensivo. Una volta, mesi addietro, le aveva chiesto con voce amica: « Non puoi far niente per il tuo difetto? Un’operazione?... Nulla? Del resto non devi prendertela troppo: ognuno ha la sua croce.» E le aveva sorriso affettuosamente. Lei si era confusa (nessuno in sua presenza toccava mai quell’argomento) e non aveva risposto. Però gli fu riconoscente delle parole e soprattutto del tono e del sorriso. Sì, Gino era il giovanotto adatto: non aveva prevenzioni per il suo mancamento, era sano e forte, non era fidanzato ed era sempre in caldo come tutti i ventenni. Doveva parlargli, invitarlo. Ma come fare, cosa dirgli? Ci avrebbe pensato. Intanto lo osservava, alla sua macchina in fondo allo stanzone. Doveva conoscere le sue abitudini per poterlo fermare e per parlarci insieme, da sola, almeno per cinque minuti. Lui lavorava a turni, mentre lei faceva quattro ore la mattina e quattro la sera, perciò non potevano incontrarsi entrando o uscendo. Per di più lei non aveva nessuna ragione di lavoro per andare dall’altra parte dello stanzone dove stava lui. C’era solo una possibilità: quando Gino abbandonava per un momento la sua macchina per andare al gabinetto doveva passarle quasi accanto; non poteva non vederlo. Allora lei si sarebbe alzata e gli sarebbe andata dietro. I gabinetti erano nel cortile, a forse settanta passi dal suo posto. Certo con la sua gamba zoppa non poteva riprenderlo all’andata. Ma lo 32 avrebbe aspettato sulla porta dei gabinetti per le donne. E quando lui fosse uscito da quelli degli uomini, lì accanto, si sarebbe messa al suo fianco e così, ritornando ai loro posti, gli avrebbe parlato…. Ma cosa gli avrebbe detto? Doveva pensarci, doveva prepararsi al colloquio. Intanto si era alzata e si era diretta verso i gabinetti. Contò i passi. Dal suo banco fino a lì c’erano sessantaquattro doppi passi, sessantaquattro inchini da fare all’andata per seguirlo, e altri sessantaquattro inchini al ritorno. Sarebbe stato molto imbarazzante parlargli mentre zoppicava. Ma forse sarebbe riuscita a trattenerlo un minuto e a fargli la proposta stando ferma sulla gamba destra. Ci avrebbe provato. Comunque la cosa importante era di preparare qualche frase, un discorsetto allusivo con un semplice invito a venire a casa sua: ci avrebbe pensato. Perché l’unico posto dove compiere quella bisogna era a casa sua, naturalmente. Sua madre, per un giorno, poteva mandarla da qualche parte per restare sola ad aspettare il giovanotto. Poteva mandarla da sua zia, la sorella di sua madre, che le aveva invitate spesso a passare una domenica in casa sua; lei si sarebbe scusata di non poter andare. Sì, avrebbe fatto così. Che l’incontro avvenisse di domenica e solo di domenica era inevitabile. Gli altri giorni lavorava e non poteva far venire il giovanotto di sera, anche perché sua madre a quell’ora non si sarebbe allontanata da casa. L’appuntamento dunque era per la domenica successiva. Ma c’era un’altra questione da risolvere: sarebbe stata fecondabile domenica prossima? Aveva sentito parlare, discutendo fra donne di un metodo per limitare le nascite, saltando alcuni giorni in cui la donna è feconda. Ma quali erano questi giorni? Come fare a saperlo? A chiederlo alle donne sposate, che forse lo sapevano, si vergognava… Poteva darsi che ci fossero delle pubblicazioni, dei libri sull’argomento. Sbirciò, senza successo, in tutte le vetrine di librerie e cartolerie che conosceva. Aveva ritegno a entrare a chiedere, un 33 po’ per l’argomento della richiesta e un po’ perché non aveva mai comprato libri. Ma ebbe fortuna. Quasi per caso vide in un’edicola di giornali un librettino che faceva per lei. Portava un sottotitolo alquanto ottimista: “La Scienza ha Fissato Senza Possibilità d’Errore i Momenti di Fecondità” Era quanto le bastava. Lo comprò e lo lesse d’un fiato. Non ci capì molto in verità, ma rileggendo con calma e aiutandosi con dei calendari esplicativi che erano nel testo, riuscì a farsi un’idea di come stessero le cose. Il suo periodo era di ventisei giorni, poco meno della media. Siccome nel libretto, però si esemplificava solo il caso più frequente, il periodo di 28 giorni, doveva fare dei calcoli secondo certe regole per poter sapere quali fossero i giorni adatti al concepimento. Fece diverse volte il calcolo perché si imbrogliava spesso, fino a che si convinse che quei sette giorni circa che il libro indicava come giorni di concepimento finivano il martedì o il mercoledì della settimana successiva. Dunque la domenica era in pieno periodo positivo. Era un’occasione favorevole. Tutto sembrava venire incontro al suo desiderio di maternità. Mancava però la cosa più importante: il padre. Ma si sentiva talmente ripiena di sé e del suo proposito che non dubitò un momento di riuscire a convincere Gino. In quei giorni, fece in modo che sua madre decidesse di passare la domenica dalla sorella, ripulì e lucidò la casa, specialmente la sua camera da letto, e rilesse più volte il famoso libretto che le dava sempre un’impressione che quello che stava per fare, già tutto previsto e scientificamente calcolato, fosse non solo possibile e ammissibile, ma quasi già realizzato. E preparò anche dei discorsi, che avrebbe dovuto tenere a Gino, degli atteggiamenti, dei sorrisi, che a parer suo dovevano fargli capire l’essenziale e invogliarlo, pur senza scoprirsi eccessivamente e far apparire triviale la cosa. Tutti i pomeriggi (Gino lavorava nel turno di sera) osservava il futuro padre di suo figlio attimo per attimo. Quando lui veniva verso i banchi delle rammendatrici, si faceva 34 rossa in viso e il cuore le palpitava. Temeva, anzi era sicura, che tutti si fossero già accorti della sua tresca, delle occhiate, dei rossori. E non si decideva mai a seguire il giovanotto quando lo vedeva dirigersi verso il cortile. Al pomeriggio del venerdì era agitatissima: era il penultimo giorno! Se l’indomani non si fosse presentata l’occasione propizia…. Oggi era il giorno decisivo. Tutti i minuti dalle due alle sei le parvero ore, nell’attesa che egli si decidesse finalmente ad andare al gabinetto. Si spaventò, vedendo arrivare le cinque, all’idea che forse lui ci sarebbe andata verso le sei, quando lei era già uscita di fabbrica. Ma come Dio volle, quella tortura ebbe termine poco dopo. Gino andava verso l’uscita dello stanzone, verso il cortile. Lei si alzò e lo seguì. Le sembrò che tutti, le altre rammendatrici e gli operai, la guardassero ghignando e si dicessero: «Toh, va ad accalappiare quel giovanotto!» Comunque, continuò a stargli dietro, a una decina di passi. Lui, inconsapevole della macchinazione di cui era oggetto dall’inizio della settimana, entrò tranquillamente nei gabinetti riservati agli uomini e ci si trattenne cinque minuti. Ermenegilda col respiro sospeso, ripassandosi in mente le parole che doveva dire, era appostata dietro l’uscita dei gabinetti per le donne, tesa a carpire ogni rumore e ogni figura che passasse. Alla fine udì lo scroscio di uno sciacquone, il colpo secco di un paletto tirato e vide uscire nel cortile Gino, l’amante tanto atteso. Gli si mise accanto. «Ciao» gli disse. «Ciao» rispose lui. Fecero cinque passi in silenzio. Cinque passi! Quanti ne mancavano ad arrivare al suo banco? Doveva cominciare a parlare assolutamente. «Sai» cominciò, «ho pensato, perché non ci troviamo qualche volta?» No, ma cosa diceva? Non era questo quello che doveva dire. Ma quali erano le parole che aveva preparato? Come fare a 35 ricordarsele, ora, camminando, quando ogni passo era un avvicinarsi alla fine del colloquio, mentre lui l’ascoltava e non sapeva. «Trovarci?» rispose lui. «Dove? A far che?» «Ecco….» Erano già tanto vicini alla porta dello stanzone! Doveva fermarlo, parlargli con calma. Non poteva…. Non poteva lasciarlo andare così. Lo prese per un braccio, trattenendolo. «Perché non vieni a casa mia, domenica pomeriggio?» Si era fermata, mettendosi in equilibrio sulla gamba destra e gli sorrideva invitante, senza preoccuparsi più di quello che diceva. Doveva tentare tutto e lo tentava. Gino la guardò meravigliato. Non capiva bene, non perché le parole o il sorriso non fossero chiari, ma perché non si aspettava un simile invito. «A casa tua?» ripeté. «Sì, così…. Per una merenda.» Era diventata rossa dalla vergogna, anche perché Gino spingeva troppo in là, volutamente le pareva, la sua sorpresa e perché un sorriso ironico gli si intravedeva sulle labbra. «Una merenda? Macché! Col caldo che fa non ho mai fame.» E rise. Aveva dato alle parole un significato ambiguo, mentre col riso beffardo pareva volesse sottolineare che il vero motivo del rifiuto stava nel senso riposto di esse. Ermenegilda si sentì tremare tutta. Si guardò intorno per sfuggire le ultime occhiate canzonatorie di Gino e per vedere se nessuno aveva assistito alla sua vergogna. Il giovanotto intanto era entrato nello stanzone, sempre ridendo. Lei lo seguì dopo un minuto, a testa bassa, cercando di non vedere e di non udire. Tutte le sue fantasie, i suoi desideri di quei giorni crollavano nel ridicolo, nello scherno. In quella settimana aveva come condensato la sua esistenza: sofferenze, giuste aspirazioni, l’opinione dei suoi simili e di se stessa, tutto aveva offerto, 36 dentro di sé, a contropartita di un minimo di felicità e di scopo nella vita. Ed ecco che tutto svaniva, che tutto le veniva negato. Ma perché, Dio mio, perché? E aveva anche comprato quel libro e si era compiaciuta della sana regolarità del mestruo! E aveva perfino costretto sua madre a sloggiare di casa per la domenica! Quanto era stata stupida. Non sapeva che lei viveva soltanto per essere torturata? Che solo per questo Dio l’aveva fatta? Il risentimento l’aveva invasa tutta rendendola dura di ragionamenti e di sentimenti verso di sé e verso gli altri. Finalmente arrivarono le sei: l’ora di alzarsi e di uscire da quello stanzone soffocante. Con la faccia contratta, aspettò che le altre donne, spuntatrici e rammendatrici, se ne andassero per non essere costretta alla loro compagnia e alle loro chiacchiere. Quindi si alzò anche lei e si preparò ad uscire. Già aveva raccolto le sue poche cose e si era incamminata, quando Àdonne, il cimatore piccolo e peloso lì vicino, le disse: «Ciao Ermenegilda.» La ragazza si fermò di botto e lo guardò con cattiveria. Che Gino avesse raccontato il fatto e lei fosse già sulla bocca di tutti? Perché allora quell’Àdonne la salutava, contrariamente al solito? L’aria quasi spaurita di lui alla sua silenziosa reazione al saluto, la convinse che la sua diffidenza non aveva ragione di essere. All’improvviso le balenò un’idea nella testa. «Cosa fai domenica prossima, nel pomeriggio?» Gli chiese con voce severa. «Mah, non so…. Niente.» Rispose timidamente il giovanotto. «Perché non vieni da me, alla Querce?» Come tutti in fabbrica, anche lei provava un senso di superiorità su Àdonne. Ed ora le era particolarmente piacevole avvalersi di questa superiorità. «Allora» insisté, «vieni?» Il giovanotto la guardava stranito. Lei allora gli sorrise incoraggiante e, senza dubitare della sua risposta, gli dette 37 l’indirizzo preciso. «Verrai, vero?» Àdonne parve capire e sorrise. Disse di sì. Lei aggiunse, senza provare minimamente vergogna con sua sorpresa: «Vieni verso le tre: a quell’ora, col caldo che è, non c’è nessuno per la strada.» «Alle tre. Ci sarò.» III E infatti, alle tre in punto della domenica, Àdonne bussò alla porta di Ermenegilda. La ragazza già da diverso tempo era pronta ad accoglierlo. La madre era andata via in mattinata. Da sola, fino alle tre, aveva avuto il tempo di preparare la casa e se stessa in modo da colpire piacevolmente Àdonne, non tanto per lui personalmente, quanto per essere sicura che egli fosse nel migliore stato d’animo cosicchè la sua contentezza venisse trasfusa nel figlio che doveva essere concepito. Aveva dato la cera e lucidato in tutte le stanze in cui lui poteva entrare, in salotto, in cucina, nel corridoio e, soprattutto, in camera sua. Questa stanza l’aveva predisposta alla visita con cura particolare. Quella mattina stessa aveva cambiato i lenzuoli e le federe al letto, spolverato più del solito i tappeti e lucidato gli specchi. Già in settimana aveva lavato le tende della finestra e le aveva inamidate. Ora la camera era in ordine. La finestra e gli scuretti socchiusi in modo da creare una penombra riposante e confidenziale. Il letto fresco e fragrante. Gli scendiletto al loro posto. Aveva preparato anche il suo corpo all’incontro e, come sperava, al concepimento. Non solo si era lavata e improfumata e 38 acconciata i capelli e truccata il volto; non solo aveva indossato poco prima delle tre un paio di mutandine di lilion color velo di cipolla e un reggipetto e una sottoveste altrettanto aerei e trasparenti, ma durante la mattinata aveva fatto ben quattro irrigazioni vaginali, secondo i consigli del libretto che aveva comprato. Questo infatti, dopo aver constatato che il metodo Ogino-Knaus oltre che per limitare le nascite poteva servire anche per lo scopo opposto, dava alcuni consigli affinché il concepimento avvenisse e avvenisse nelle condizioni migliori. Qui appunto era espressa l’idea che lo stato di felicità e di soddisfazione dei genitori, compiendo l’atto, avrebbe influito beneficamente sul figlio. E qui inoltre, dopo tanti altri consigli, si invitava a fare, prima dell’unione, una irrigazione vaginale con acqua contenente un grammo di bicarbonato di sodio per litro, per ridurre una certa acidità. La ragazza disciplinatamente aveva comprato il bicarbonato di sodio in una farmacia e in quella mattina aveva fatto, come si è detto, quattro irrigazioni, di cui l’ultima poco prima dell’arrivo di lui. Dopodiché si era messa pazientemente ad aspettare le tre. Tutto era fatto, al suo posto, pronto ad accogliere il visitatore. Certo Àdonne non era l’ideale del maschio procreatore, piccolo, tegoso, timido com’era. Comunque era meglio che nulla. E poi anche lui riluceva di una certa qual bellezza, quando ti guardava con gli occhi spauriti o sorrideva. Ma tanto che importanza poteva avere la bellezza delle forme quando il bambino che doveva nascere sarebbe stato, con la grazia di Dio, sano, normale, diritto? Questo solo era il suo desiderio. E mentre attendeva pregò la Madonna che glielo facesse realizzare. E le chiese una volta ancora perdono del peccato che stava per commettere. “Tu mi capisci!” le disse a modo di scusa e d’intesa. Così, con l’animo in pace e il corpo fresco, accolse Àdonne. 39 IV Convincere il giovane a fare la sua voglia le fu molto facile, considerando che questi era venuto con l’intenzione di convincere lei a fare la sua. Anche il defloramento, che prima aveva silenziosamente temuto, non le dette nessuna noia di rilievo. Tutto era andato secondo le sue aspettative. Subito dopo l’atto era stata quasi un quarto d’ora immobile su un fianco, nella più riposante posizione, secondo i consigli del suo libretto. Dopo questo primo riposo aveva cercato di sbarazzarsi alla svelta del fecondatore ormai inutile. Appena ci riuscì e fu sola, tornò sul letto, si coprì con una coperta, benché facesse caldo, e rimase tutto il resto del pomeriggio in riposo a covare lo sperma che aveva tanto faticosamente ottenuto. Per tutto quel giorno e per il seguente non si lavò la parte per paura di sciupare qualcosa. A dire il vero si era aspettata qualcosa di più entusiasmante dall’unione con uomo. Tutto invece era stato molto deludente da un punto di vista puramente sessuale. Questa delusione rafforzava il suo proponimento di non continuare la relazione. Il suo scopo era un altro e, per ora, era raggiunto. Aspettò con ansia il giorno in cui il mestruo avrebbe dovuto tornare. Nell’attesa badava di stare calma, di non affaticarsi, di non prendere fresco. Con Àdonne non sapeva come comportarsi. Doveva interrompere irreparabilmente il legame? E se poi il mestruo tornava? Doveva forse arrendersi alla prima prova negativa? Era meglio tenerselo buono, a disposizione caso mai ci fosse stato ancora bisogno di lui, cosa che sperava con tutta l’anima non avvenisse. Davvero era stato molto deludente il tanto decantato amplesso maschile: deludente e umiliante. Umiliante fino all’ultimo grado le era parso, oltre al troppo precipitoso, ripugnante, contatto dei corpi, anche il fatto di approfittare o di concedersi (non sapeva 40 bene) a quel giovanottino che aveva sette o otto anni meno di lei. Ermenegilda pregava di fondo al cuore di non essere costretta a rinnovare quella vergogna. Àdonne, dal canto suo, pareva molto soddisfatto di aver trovato uno sfogo alla sua voglia virile. Ogni minuto, quando era a lavorare, lanciava all’amante occhiate e sorrisi d’intesa e di ringraziamento. Talvolta si avvicinava a lei con fare circospetto, come un cospiratore, e cercava di avviare un discorsetto, che lei, Ermenegilda, sapeva bene dove sarebbe finito. Perciò tentava di prevenirlo, ma con imbarazzo; e talvolta lo trattava freddamente e talaltra gli sorrideva dolcemente senza rispondere. Questa indecisione durò due settimane. Una mattina, con suo grande disappunto, un flusso regolare di sangue le fece sapere che, se voleva diventare madre, avrebbe dovuto riprovare il maschio. Cominciò pertanto a rispondere con sorrisi di intesa ai tentativi di approccio di Àdonne. Il giovane, che i primi giorni si mostrava beato e soddisfatto, era diventato negli ultimi insistente e piagnucoloso, morso com’era dall’amara impressione che le sue soddisfazioni virili sarebbero cessate sul nascere. Lei cercò di rassicurarlo e gli fece intendere con tatto che per il momento non si poteva, ma che, appena l’impedimento fosse scomparso, l’incontro che lui voleva sarebbe avvenuto, con pieno appagamento di entrambi. Àdonne a questa promessa parve rinascere. Però, Ermenegilda se ne rese conto, non si poteva differire l’impedimento per due settimane e mezzo come sarebbe stato necessario per raggiungere il periodo favorevole. La voglia di lui, che, sfogata una volta, non voleva più contenersi come per l’innanzi, esigeva il possesso immediato del suo oggetto. Perciò, cessato che fu l’impedimento, gli dette il richiesto appuntamento per la domenica pomeriggio. Questa volta andarono fuori di casa, in un boschetto isolato dove lui la portò con la sua motoretta. Ermenegilda quel giorno non si era preparata all’incontro come la volta precedente. Sapeva, dal suo libretto, che non 41 poteva succedere niente; ci andava solo per accontentare il ragazzo che si impazientiva. Non sarebbe cominciato oggi quel misterioso fenomeno che poteva portarla a partorire un figlio. Tutto quanto doveva succedere era ormai ben conosciuto, e ripugnante: palpeggiamenti vari, rantolii, un succhiare di baci, un contatto interno che l’avrebbe riempita. Tutto qui. Niente che avrebbe fatto di lei una madre, cioè una donna completa, normale; niente che avrebbe dato calore alla sua esistenza, un avvenire e un seguito alla sua vita sciagurata. Pure doveva assoggettarsi, ma lo faceva controvoglia. All’inizio, quando lui pretese di baciarla sulla bocca, l’assalì il disgusto e lo stomaco si rifiutò. Si voltò allora da una parte e non volle farsi toccare da quelle labbra aperte, umidicce. Ma, quando il giovanotto lasciò perdere i baci e passò ad altre cose, con sua grande sorpresa sentì da prima un certo solletico, poi un formicolio, quindi brividi e spasimi di meravigliosa potenza e infine una pace, una calma mai provate. Anche i baci di lui non le davano più disgusto, anzi le pareva che mentre era lì, fremente sotto di lui, lei stessa li avesse cercati e voluti. Come poteva essere tutto ciò? Come mai l’altra volta non era successo niente di simile? Perché ora si era lasciata andare, non aveva tenuto a mente quale era il suo scopo! E questo era pericoloso per lei: non doveva, non poteva avere un uomo per sé, si ripeté. Un figlio, questo era quello che voleva e le poteva essere concesso: quel giovanotto era solo un mezzo. Si doveva ricordare di questo: lei era solo una povera ragazza sciancata, nessun uomo poteva provare amore per lei. Àdonne veniva con lei solamente per sfogare la sua voglia repressa, perché era brutto, peloso, timido, assomigliava a un topo e non trovava nessun’altra donna che ci stesse. Non era mai stato con nessuna, prima, glielo aveva chiesto, e lui lo aveva ammesso, abbassando gli occhi. Per questo veniva con lei. E lei non doveva farsi illusioni. 42 Si arrabbiò quasi con Àdonne e si fece riportare immediatamente in città. Egli cercò di ottenere un altro appuntamento per la domenica successiva, ma lei rifiutò con una scusa. Lui propose un incontro durante la settimana, dopo il lavoro, ma lei non ne volle sentir parlare. Si trovarono d’accordo per rivedersi dopo due settimane, a casa di lei, come la prima volta. Ermenegilda attese questo incontro con non minor ansia di quello del mese precedente. Ogni minuto ripeteva a se stessa che lo faceva per avere un bambino; che il desiderio di avere un figlio era una cosa naturale, santa, nemmeno la religione poteva negargliela, ma un amante…. Un amante no! Era peccato, era una cosa innaturale, sudicia; lei voleva una cosa per sempre, con la benedizione di Dio e degli uomini; e siccome non poteva avere un uomo per sempre, non lo voleva affatto. Lo avrebbe usato solo per ottenere un figlio. Anche questo era peccato, lo sapeva, ma in fondo la sua azione era redenta dallo scopo con cui lo faceva e dallo spirito con cui ci si sottometteva. E poi…. E poi Dio poteva ben chiudere un occhio su quel peccato per ripagarla delle privazioni della sua vita. Quando arrivò all’incontro, come la volta precedente fu assalita dal ribrezzo per quell’esserino che le rantolava intorno, duro e puntuto dalla sua voglia, ancor più capelluto e disprezzabile del solito. Ma lasciò fare con buona volontà, come se dicesse che sopportava anche questo per riscattare la santità e la bellezza del suo proponimento. E mentre lui toccava, palpeggiava, e baciava, si ripeteva nella mente come una litania i suoi pensieri e le sue decisioni e si rammentava, per consolarsi, che quel giorno era in pieno periodo favorevole e che quella era l’ultima volta che soggiaceva a quel contatto. Ma quando, nonostante tutta la sua volontà contraria, cominciò a sentire un formicolio, dei brividi, uno spasimo, niente più le passò per la mente. Desiderò soltanto che ciò succedesse in eterno, senza 43 sosta, senza momenti tristi, soli, inutili. Anche Àdonne in quegli attimi le pareva bello, alto, forte, sicuro; e lei se lo baciava e stringeva con forza. Per che cosa aveva fatto, durante l’attesa, due o tre irrigazioni vaginali con acqua contenente bicarbonato di sodio, un grammo per litro? Per che cosa? Come tutto le parve sciocco ora, al confronto. Anche questa volta fece dieci minuti di sosta, alla fine. Ma invece di sbarazzarsi del giovanotto subito dopo, lo pregò di ricominciare e lo stuzzicò perché lo facesse. V In seguito, a mente fredda, non poté che riflettere su quanto era avvenuto. Sì, si era lasciata andare e aveva perso di vista il suo scopo. Ma, Dio mio, come erano pieni, significativi quei momenti di ebrezza nel grigiore della sua vita! Come aveva potuto fare a meno di quella gioia per ventotto anni? Già provava desiderio di ritrovare quei brividi e quegli spasmi che le strappavano l’animo e le forze. Oh, sapeva bene che non poteva avere un uomo eccetera, eccetera, ma perché rifiutare anche queste briciole di godimento? Quanto si fosse trovata incinta e quindi la sua vita si fosse instradata secondo i suoi desideri originali, allora avrebbe trovato la forza di rinunciare a godere dell’uomo per amore di suo figlio. Ma prima, a che scopo? Dopo tanti anni di rinunce e patimenti, perché imporsi altre privazioni? Certamente, dato che la relazione sarebbe durata del tempo, la gente avrebbe cominciato a sospettare e a malignare. Ma che gliene importava, a lei, delle chiacchiere della gente anche se giustificate? Come si permettevano costoro di trinciare giudizi senza conoscere i suoi patimenti, i suoi dolori senza speranza? La Madonna, solo la 44 Madonna poteva capirla. Lei era buona, santa, amorevole verso di lei. E in fondo anche lei era una donna. Perciò poteva capire quanto avveniva in lei, capire e perdonare. Sì, solo la Vergine Santa la capiva e la perdonava. E chi altri l’avrebbe assistita e confortata quando sarebbe rimasta incinta e tutti l’avrebbero abbandonata ghignando? Chi altri se non lei? Oh, si immaginava bene tutti i titoli che le avrebbe affibbiato la gente quando il pancione gravido…. Ma la gente poteva dire qualsiasi cosa, di lei. Di lei, ma di suo figlio? Dio mio Madonnina santa!.... Eccome no? Come poter credere che non l’avrebbero chiamato con spregio “Figlio di N.N.” S’immaginò il momento in cui sarebbe andata a dichiarare la nascita in Comune. L’impiegato avrebbe chiesto il nome del padre. «Chi è?» E lei cosa avrebbe risposto, cosa avrebbe provato dentro di sé, dicendo «non lo so» oppure «non lo voglio dire?» E s’immaginò anche suo figlio in mezzo agli altri ragazzi. Come poter sperare che gli altri ragazzi non lo canzonassero e non lo chiamassero bastardo? Bastardo! Lei, da bambina, non era stata forse chiamata tante, ma tante volte, zoppa, storpia, sciancata, dagli altri bambini? E come sperare che non facessero così anche con suo figlio? Ma perché non ci aveva pensato prima a questo? Forse era ancora in tempo. Anche il mese precedente non era successo nulla, forse anche questa volta tutti i conteggi e i giorni di fecondità sarebbero risultati sbagliati e il mestruo sarebbe riapparso regolarmente. E per il futuro? No, non poteva rinunciare a quel contatto con un uomo. Ci sarebbe stata attenta. C’erano tanti sistemi per evitare una gravidanza. Quel sistema, quel conteggio di giorni fecondi e infecondi non serviva principalmente a quello scopo? E dunque! Bastava sorvegliare il calendario, dare gli appuntamenti ad Àdonne nei giorni adatti, fare delle raccomandazioni al giovanotto, e tutto si sarebbe risolto. Ma certamente! Purtroppo doveva, ancora una volta, fare una rinuncia: doveva 45 rinunciare ad avere un figlio. Ma era per il suo bene, per il bene del bambino. Che figlio poteva essere quello senza un padre, senza un nome! Era suo dovere privarsi di una felicità, se questa doveva costare l’infelicità di una creatura che avrebbe dovuto essere tutta la sua vita, tutto il suo bene. Sì, rinunziava! E per la prima volta lo faceva con gioia, perché capiva il valore di quella rinuncia. E inoltre, se non avesse avuto un figlio, poteva continuare la relazione con Àdonne, senza scadenze, senza l’imbarazzo e i problemi che avrebbe creato una gravidanza. Ma certo! Sapeva che prima o poi Àdonne l’avrebbe abbandonata. Ma perché preoccuparsi di ciò, prima di allora? Naturalmente era chiaro che lei non rinunciava ad avere un figlio per tenersi l’amante. No! Doveva rinunciare al figlio per amore del figlio stesso. Se così facendo poteva continuare a stare insieme ad Àdonne, era forse colpa sua? E perché non doveva approfittare di questa possibilità? Non era questa una nuova rinuncia, un’altra rinuncia dolorosa, forse più dolorosa di tutte le altre della sua vita? E quindi aveva ben diritto a una piccola ricompensa. Se anche la Madonna l’aveva compresa e perdonata quando desiderava di farsi illecitamente ingravidare in forza delle privazioni umilianti e dolorose della sua vita, poteva a maggior ragione essere scusata ora, che a quella larga fila di dolorose rinunce un’altra se ne aggiungeva tanto gravosa per il suo essere di donna. E tanto più che la maggior parte, e la più grave, del peccato che commetteva, ora scompariva. Che colpa era avere un’amante, in confronto a quella di procreare un figlio illegittimo? E dunque! Si era fermamente decisa a non avere un figlio. D’ora in avanti avrebbe preso le più grandi cautele per evitare una disgraziata gravidanza. Ma che stupida era stata le volte passate! L’importante era di non essere già rimasta incinta. Se con l’aiuto di Dio e della Madonna, questo non era, tutto si sarebbe sistemato nel più giusto e naturale dei modi. 46 Così, soddisfatta e ansiosa nello stesso tempo, aspettò l’inizio del mestruo, non senza prendere le prime e più necessarie misure. Fece cioè la sera stessa della domenica delle profonde irrigazioni vaginali con acqua pura, senza il bicarbonato di sodio, perché questo favoriva la vita degli spermatozoi e quindi le gravidanze. Nei giorni seguenti, alle insistenze di Àdonne cedette con prontezza e buona voglia: del disgusto che l’aveva assalita le prime volte non si ricordava nemmeno. Si trovarono e godettero l’uno dell’altra, con le opportune misure di sicurezza, diverse volte durante due settimane: qualche volta dopo le sei, all’uscita di Ermenegilda dalla fabbrica, due volte di domenica pomeriggio. Infine, più che cedere alle insistenze, era lei stessa che insisteva con occhiate e cenni di testa che richiamavano il giovanotto ai suoi doveri di maschio corteggiatore. VI Al termine della seconda settimana Ermenegilda cominciò a preoccuparsi: il mestruo non compariva; ed era già in ritardo di due giorni, cosa assai strana per lei sempre così regolare. Attese altri cinque giorni con l’animo oppresso da fosche previsioni e, non avendo visto ancora niente, decise di fare l’analisi dell’urina. La mattina del giorno successivo, prima di andare a lavorare, passò dall’ospedale e, con non poca vergogna, tirò fuori la sua brava boccettina chiedendo la desiderata analisi. La risposta si sarebbe saputa la sera stessa. Ad Àdonne, benché in quei giorni lo avesse visto due volte da sola, non aveva detto niente naturalmente. E aveva temuto che lui le chiedesse come mai questo mese gli impedimenti….Ma si era convinta, una volta di più, che gli uomini, e specialmente i 47 giovanotti, di certe cose sono quasi all’oscuro. Meglio così, almeno fino a quando le analisi non avessero parlato. E queste, dopo tanta attesa, parlarono: positiva. “Significa che l’urina è di una donna incinta” spiegò gentilmente l’infermiera. Era incinta, disgraziatamente, sfortunatamente, malauguratamente incinta! Dio mio, sempre disgrazie, dispiaceri, delusioni! Dunque mai sarebbe stata felice e tranquilla. Ed ora che fare? Certo aveva tanto desiderato un figlio, un essere suo, completamente suo. Ma come non sapere quanto egli avrebbe sofferto per il fatto di non avere un padre? Come poter spiegare che la gente non l’avrebbe chiamato bastardo? Eppure poteva rinunciare? Poteva mandare a male quella gravidanza?.... No, era contro i suoi principi, i suoi sentimenti: non avrebbe mai potuto procurarsi l’aborto. E Àdonne? Cosa dire, come comportarsi con lui? Doveva lasciare quella fabbrica e non rivederlo mai più, come aveva determinato prima? Sì, era la cosa più onesta che poteva fare. Ma….tra cinque mesi doveva smettere di lavorare per il periodo di maternità. Se cambiava fabbrica proprio ora, aveva diritto a quella indennità e assistenza? Non lo sapeva con sicurezza, ma le pareva di no. E perché arrischiare la sua relativa sicurezza economica? In fondo Àdonne era il padre del bambino e aveva diritto a sapere cosa si stava preparando. Non era vero che sarebbe stato più onesto tacere: era anzi suo dovere mettere Àdonne al corrente della gravidanza. Lui venendo con lei, si era assunto la sua parte di responsabilità: non era mica un bambino; era maggiorenne, perciò…. Oh, come tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi! Ma certamente! Come poteva, come poteva osare, lui, di non acconsentire al matrimonio? Oh sì! Tutta la sua vita si stava trasformando. Finalmente Dio la ricompensava dei torti e dei patimenti subiti. Avrebbe avuto un marito, come tutte le donne di questo mondo, e dei figli, figli legittimi, con un padre e una 48 madre onesta, e un nome. Grazie, Madonnina santa, grazie! E perché Àdonne non avrebbe dovuto acconsentire? Il figlio era suo: su questo non c’erano dubbi. E poi lei non era forse una brava ragazza, lavoratrice, onesta, che guadagnava bene? Cosa poteva pretendere di più Àdonne, brutto e piccino com’era, timido e peloso? E lei sarebbe stata una moglie, affettuosa e comprensiva, una madre esemplare. Questa era stata la vera e unica aspirazione della sua vita, tutto il suo essere era nato per questo. Certo c’erano delle difficoltà: lei era zoppa e per di più era di sette anni più vecchia, ma tutte le difficoltà si appianano quando ci sono dei figli che uniscono. E lei era pronta da parte sua a chiudere un occhio sulle debolezze di lui. Era poco più di un ragazzo, come non scusarlo se ogni tanto faceva una scappatella con qualche donnetta di malaffare? Sì, gli avrebbe permesso questo e anche qualcos’altro, purché, naturalmente, egli non trascurasse lei per le altre. E così, con un minimo di buona volontà e comprensione, tutto si sarebbe appianato e chiarito. Ora doveva preparare Àdonne a ricevere la notizia; e preparare anche le famiglie. Sua madre, povera vecchia, era un po’ svanita e prendeva per buono, senza commenti, tutto quello che lei faceva; gli altri suoi parenti non avevano importanza. La famiglia di lui, invece la preoccupava. Chissà che tipi erano! Comunque avrebbe predisposto con tatto l’incontro e la rivelazione. Per prima cosa invitò Àdonne a venire a casa sua la domenica pomeriggio, ma senza dirgli nulla di speciale. Invece di mandar via sua madre, come le volte precedenti, gliela fece trovare a bella posta sulla porta di casa. Il giovanotto fu presentato come “un amico di fabbrica”; fu intrattenuto con chiacchiere dalla vecchia e gli fu apparecchiato anche un piccolo rinfresco con vermut e biscotti. Àdonne, pur nella sua ingenuità, dovette accorgersi di qualcosa. E quando alla sera, dopo che erano stati 49 del tempo soli, Ermenegilda da un discorso all’altro arrivò a chiedergli di farle conoscere i suoi parenti, lui puntò i piedi e non volle saperne. La ragazza sulle prime cercò di convincerlo senza forzare troppo, ma invano. Allora lei rapidamente decise che era venuto il momento di far intravedere qualcosa a quello sciocco ragazzo ostinato. E dopo un po’ di silenzio e altri discorsi insignificanti, gli disse: «Sai, il mestruo mi ritarda: da sette giorni.» Il giovane parve non capire, poi arrossì e chiese cosa poteva significare e se lei credeva…. Lei allargò le braccia con rassegnazione. Chi poteva sapere? Speriamo di no! Il ragazzo era rimasto visibilmente scosso a quella notizia, sicché lei cercò di rincuorarlo, dicendogli che tutto si sarebbe accomodato in ogni modo, che bastava avere comprensione e senso di responsabilità, anziché lasciarsi impaurire come bambini, e che quello che avevano fatto lo avevano fatto di comune accordo e da persone adulte. Questi discorsi, se ne accorse, non rincuoravano punto Àdonne. Comunque, finì cambiando tono, avrebbe fatto le analisi che si fanno in simili casi e tra qualche giorno si sarebbe saputa la risposta precisa. Il giovanotto si sentì avviluppato, senza che lo avesse voluto, in una marea d’impegni, responsabilità e oneri. Non sapeva cosa dire o fare e neanche cosa pensare. Desiderava solo una cosa: scappare di lì. Ma Ermenegilda lo tratteneva con discorsi pieni di comprensione reciproca, di senso dell’onore e, sì, di affetto reciproco. Finalmente lei lo lasciò andare, con l’intesa che si sarebbero rivisti in settimana, una sera quando lei avesse avuto i risultati. Il lunedì e il martedì il giovanotto sul lavoro sembrava stralunato, oppresso. Il mercoledì Ermenegilda ritenne giunto il momento opportuno per la rivelazione. Gli dette, senza altre spiegazioni, un appuntamento per la sera stessa. Le prime parole che gli disse quando lo incontrò furono: «Sono incinta.» Àdonne 50 restò di sasso. Lei per far vedere che non mentiva, tirò fuori il foglio con il risultato delle analisi fatte la settimana precedente. Il giovanotto non era capace di dir parola, pareva anzi che fosse lì lì per piangere. Ermenegilda cercò di calmarlo. In fondo non c’era niente di male: succedeva a tanti. Certamente ora dovevano rimediare il rimediabile, dovevano cioè sposarsi al più presto. (Il ragazzo si scolorì ancora di più, sentendo esprimere in parole il pensiero che lo tormentava da tre giorni). Ma non c’era da preoccuparsi per questo: l’essenziale era che ci fosse fra loro quel buon accordo e quella buona volontà di metter sù una famiglia, così come erano stati d’accordo nel fare quelle cose che li avevano portati ad aspettare un figlio. Perché l’importante era l’avvenire e la felicità del loro figliolo, che lui nascesse e crescesse in una famiglia unita, con una madre e un padre pieni di premure. Entrambi lavoravano, avevano un buon posto e guadagnavano bene: dal lato economico non c’erano preoccupazioni. Lui non doveva fare il militare e quindi erano perfettamente liberi. Certamente le rispettive famiglie avrebbero ricevuto un duro colpo alla notizia; ma, dopo il primo momento di smarrimento, sarebbe senza dubbio prevalso il buon senso e il sentimento delle responsabilità di ognuno. E poi, a guardar bene le cose dovevano ringraziare Dio perché non potevano chiedergli niente di meglio. Non erano forse il primo amore l’uno dell’altra? Non avevano forse lui preso la sua verginità e lei quella di lui? E cosa c’era dunque di meglio di questo per costruirci sopra un matrimonio? Dovevano perciò ringraziare Dio e la Madonna e rassegnarsi con gioia alla Loro volontà. Il giovanotto di tutte quelle parole non ne afferrava la metà: era visibilmente turbato. Tutto ad un tratto disse: «Devo pensarci, devo pensarci.» E piantò la ragazza, allontanandosi senza aggiungere altro. Ermenegilda si sentì soddisfatta di come aveva condotto la cosa. Àdonne si sarebbe impaurito, disperato. Ma bastava che le 51 lei non lo mollasse, che nei giorni seguenti gli fosse continuamente vicina, al lavoro e dandogli tutte le sere un appuntamento. Bastava che continuasse a parlargli con affetto e semplicità del matrimonio e lui si sarebbe lasciato a poco a poco convincere ed avrebbe fatto ciò che era suo dovere fare. Sì, il futuro le si presentava roseo, per la prima volta in vita sua. Sentiva dentro di sé, in modo misterioso ma sicuro, che anche per lei c’era su questa terra uno spicchio di felicità. VII Con suo grande dispiacere non vide Àdonne al suo posto di lavoro la mattina successiva. “Forse ha cambiato turno, per una ragione o per un’altra,” pensò. E attese con impazienza il cambio di turno, alle due. Ma anche a quell’ora Àdonne non venne a lavorare. I compagni di lavoro che lo sostituivano non sapevano niente. Ad andare a chiedere in ufficio cosa gli fosse successo si vergognava. Perciò attese sempre più preoccupata, il giorno dopo. Ma non lo vide, né la mattina né la sera. Il sabato, il terzo giorno, non resisté più. Prese e andò a chiedere notizie. «E’ venuto a licenziarsi proprio ieri» le dissero. Non ci credeva: non poteva essere! Cosa poteva significare quel licenziamento, se non…. Ma come poteva scappare in questo modo, senza una parola, una spiegazione. Non era possibile! Tra loro ci dovevano essere per forza delle spiegazioni, una possibilità di parlare, di convincere. Quella sera stessa, appena uscita da lavorare, sarebbe andata a cercare Àdonne a casa sua. Era necessario: ci sarebbe andata! E infatti ci andò, preparata a tutto. Sapeva che Àdonne abitava a Narnali, un paesino sulla via Pistoiese, ma non sapeva dove con precisione. Chiedendo a dei bottegai, le fu indicata la porta di 52 una casetta lungo la strada. Bussò. Una bambina di sette o otto anni, che dalla somiglianza poteva essere una sorella di Àdonne, le aprì e la lasciò passare. Dalla strada si entrava direttamente in una specie di ingresso-salotto-sala da pranzo. “Entrata sono entrata” si disse Ermenegilda quando fu dentro. “Almeno la porta in faccia non potrà chiudermela.” Chiese se c’era Àdonne. La bambina non rispose nulla e chiamò sua madre. La madre era una donna grossa, bassa e dall’aspetto volgare. Era anche becera, come poté rendersi conto subito. L’aggredì infatti con una voce sgradevole, dicendo: «Cosa vuole lei dal mio figliolo?» e senza aspettare risposta continuò: «Sarebbe l’ora che lei lo lasciasse in pace, ha capito? Tanto lo so chi è lei, con codesta gamba zoppa! Il mio figliolo è anche troppo buono: invece di malfamarla per tutta la fabbrica, ha preferito venir via per non far scandali. Ma ora la signorina viene anche a cercarlo a casa, la verginella!... Lo deve lasciare in pace quel povero figliolo: non le basta di avergli fatto perdere il posto in fabbrica? Ah ma se ero io, gliene cantavo due in mezzo allo stanzone, che dopo sarebbe andata via lei dalla vergogna. Ma già, lei di vergogna non ne deve provare. E stai zitta perché in casa mia parlo solo io! La povera ragazzina infamata! Se tu avevi il pizzicore, ti dovevi grattare anziché andare con gli uomini. O non lo sapevi che a andare intorno a quei cosi c’è il pericolo di ingravidare? E ora perché tenti di tirare il tranello al mio ragazzo? È forse il più imbecille dei tuoi ganzi? E poi non ci credo neanche che Àdonne sia venuto a divertirsi con te. Con tutte le donne che può avere, sarebbe grullo ad andare con una storpia come te. E stai zitta e ferma, hai capito? In casa mia ti dico quello che mi pare e piace. Anzi, ti devi levare subito da tre passi: fuori di casa mia! Fuori! E ringrazia Iddio che sei tutta sciancata, perché sennò a forza di calci in culo ti riportavo io al tuo paese.» Dicendo le ultime parole, la donna aveva aperto la porta, 53 aveva preso Ermenegilda per un braccio, l’aveva spinta con forza sulla strada e infine aveva sbacchiato sonoramente l’uscio. Le grida erano state udite distintamente e, come succede nei paesini, si era raccolta là intorno una dozzina di vicini curiosi. Costoro, chi serio chi ridendo, fecero largo per far passare Ermenegilda la quale non sapeva se piangeva o no, se era rossa o sbiancata in viso, se camminava o correva. Dopo aver guardato per un attimo, con smarrimento, le facce dei presenti e poi la porta chiusa, non poté far altro che prendere la sua bicicletta appoggiata lì accanto e partire…. Partire con quanto più forza aveva nella sua gamba destra, andare via, lontano da quella gente, da quella casa! Dio mio, come aveva potuto quella orribile donna da strada trattarla in quel modo! Falsa, becera, triviale! Ah non c’era da meravigliarsi se con una madre del genere Àdonne era diventato una specie di topo spaurito. E lui, lui, a raccontare tutto alla mamma, come un bambino, e poi a scappare! Come aveva potuto! Certamente era stata lei, la madre a consigliarlo, a imporgli di venir via in quel modo, senza una parola, un saluto. Stupido bambino pauroso! Non voleva rivedere più nessuno né figlio né madre, nessuno. Che vergogna! Che vergogna! Quella donnaccia non le aveva dato neanche il tempo di parlare: subito a offendere, a sbraitare. E lei cos’altro avrebbe potuto dire, oltre a quello che aveva detto? Niente, proprio niente; tanto più che quella non ascoltava nemmeno. Ma basta! Non voleva pensar più a loro…. Quello stupido ragazzino di Àdonne non avrebbe neanche visto suo figlio! E lei, scema che non era altro, aveva sperato, sognato…. E ora? Le restava solo di buttarsi sotto un treno. Madonna santa, che disperazione era quella! Perché tutti i suoi sogni di felicità venivano sempre delusi? Questa volta aveva sperato davvero di poter metter sù una famiglia sua, marito, figlioli. Ed ecco cosa aveva ottenuto: umiliazioni e offese. Sempre così, per lei c’erano 54 soltanto dolori, mai un attimo di gioia, di serenità, di pace, mai. Sì, in quegli ultimi due mesi aveva avuto delle soddisfazioni, aveva conosciuto un uomo e la speranza si era riaccesa, ma solo per esser poi ancora più maltrattata. Ed ora eccola lì, sola, derisa e in attesa di un figlio, di un figlio illegittimo. E che doveva fare? ammazzarsi forse? No, non si sarebbe ammazzata: sarebbe stato troppo comodo, troppo semplice per tutti. Voleva vivere e voleva avere questo figlio! E se gli altri volevano malignare, malignassero pure, tanto a lei non gliene importava nulla. Pregava la Madonna solo di una cosa: di avere un figlio sano, normale e di riuscire a farsi amare da lui. Soprattutto questo chiedeva alla Madonna che l’aveva sempre protetta, che suo figlio, da grande, non si vergognasse di lei e non la considerasse una donnaccia per non avergli dato un padre. Questo era lo scopo della sua vita d’ora in avanti. A tutto il resto poteva rinunciare con gioia: alla considerazione della gente, se considerazione si poteva chiamare quel volerla tenere in disparte, e avrebbe rinunciato soprattutto al contatto con gli uomini. Rinunciando all’amore degli uomini avrebbe dimostrato a suo figlio, e anche a se stessa e agli altri, che lei era una donna onesta e perbene e che suo padre era stato il suo primo e ultimo amante…. In quello stesso istante fu urtata di striscio da una macchina che la sorpassava. L’agitazione che la rodeva le aveva causato una specie di appannamento alla vista e una pericolosa disattenzione. Si era così spostata inavvedutamente verso il centro della strada, era stata colpita e scaraventata per terra. Si vide del sangue: fu subito soccorsa da diverse persone che chiamarono un’ambulanza. All’ospedale fu accertato che, a parte poche escoriazioni niente affatto gravi, la perdita di sangue era di origine semplicemente mestruale; un mestruo più abbondante e doloroso del solito in verità, ma ciò era perfettamente comprensibile date le circostanze in cui era repentinamente 55 iniziato. La prima considerazione che Ermenegilda fece, passato il dolore e la tensione della caduta, fu: “Così, non sono più incinta.” E dopo un intervallo di stupore in cui il suo cervello non riusciva a formare un pensiero, concluse: “Almeno se questo era successo due settimane fa, mi sarei mantenuto Àdonne come amante.” 1962 56 57 INCUBI 58 59 Mia moglie non ha ancora ventun anni e già abbiamo una figlia di due anni e mezzo. Abitiamo in una vecchia casa insieme a mia madre e a mia sorella. Elisabetta, la mia bambina, dorme da circa un mese nella camera della nonna e della zia, in un letto normale da una piazza. Nella cullina di tubo cromato e cordicelle, che tenevamo accanto al nostro letto e nel quale lei ha dormito fin dalla nascita, non si rigirava più. Si scopriva di continuo, si raffreddava, pisciava e poi si svegliava e piangeva. Così abbiamo deciso, con dispiacere, di metterla nell’altra camera. Una settimana fa, verso le due di notte Elisabetta si svegliò d’improvviso, piangendo a dirotto. Subito si svegliarono mia sorella e mia madre, che cercarono in tutti i modi di calmarla, senza riuscirci. Infine il rumore giunse fino a noi: mia moglie s’alzò e andò di là, mentre io mi rigiravo, con tutti i sensi ancora presi dal sonno, fuorché l’udito, teso ad aspettare che il pianto cessasse. Dopo poco mia moglie, per non costringere suocera e cognata a restare sveglie, prese la bimba in collo e la portò in camera nostra, chiudendosi la porta alle spalle. E’ nel carattere di mia moglie il non voler recare fastidi o chiedere semplicemente piaceri a mia madre e a mia sorella; e questo lo fa non con umiltà, con gentilezza d’animo, ma con una certa durezza, con l’aria di dire: “Così non avrete da lamentarvi di me.” Per la verità, non tutta la colpa di questo atteggiamento sgradevole è di mia moglie: mia madre e anche, ma meno, mia sorella l’hanno quasi obbligata a quel modo di fare, stringendo troppo spesso i labbri contrariate quando un piacere veniva richiesto. C’è in tutta la mia famiglia un egoismo assai forte che secondo i vari caratteri va da una specie di ritegno a dedicare tempo agli altri, fino all’avarizia più spinta. E quando mia moglie vuol farmi notare questo lato familiare del mio carattere, aggiunge il suffisso peggiorativo al mio cognome e mi butta sulla faccia l’aggettivo composito che ne risulta. 60 Per tornare alla bambina, fu messa nel nostro letto, nel mezzo fra me e mia moglie. Tutti i bambini, che io sappia, ma la mia in particolar modo, dormono agitati, con continui cambiamenti di posizione, mettendosi ora di traverso ora da piedi. Così avvenne anche quella notte: la bambina, nel nostro letto, s’addormentò quasi subito; noi invece, un po’ perché ci mancava lo spazio solito nel quale siamo abituati a dormire, un po’ per i colpi di quelle manine, di quei piedini e della testa, restammo più svegli di prima. Dopo forse un quarto d’ora, non resistei più e dissi a mia moglie di riportare la bambina di là, nel suo lettino. Eravamo appena ricaduti nel caldo torpore che precede il sonno, quando il pianto della bambina si fece udire più forte e più disperato di prima. Chi non ha mai avuto figli non può sapere cosa sia il pianto d’un bimbo nel mezzo della notte, nel chiuso di quattro muri: è un tormento terribile, capace, in un parossismo d’irritazione, di far smarrire la ragione a una persona di nervi deboli. Mia moglie gettò via le coperte esclamando: «Ma cos’ha quella bambina stanotte!» Corse di là e sulla soglia dell’altra camera gridò: «Cosa c’è? perché non dormi?» poi raggiunse la bimba e chiese concitata:«Hai la bua al pancino? alle gambe? al braccino? Dove? Dillo!» Elisabetta continuava a piangere senza sapere o poter rispondere. Allora udii mia moglie esclamare:« Ora te lo do io il piangere la notte!» e sentii i colpi d’una sculacciata. La bimba aumentò il pianto fino all’acuto più alto, quando la voce si rompe. Mia moglie intanto gridava:« Non devi piangere, capito? Ti fo prendere dal Babau! Non de-vi pian-gere! Zitta! Zitta!, ho detto! Babau mangia questa bambina! Mangiala!» Elisabetta smise davvero di piangere: un singhiozzo convulso non le lasciava il tempo di strillare. L’inspirazione avveniva a scatti rapidissimi, attraverso la bocca e il naso allo stesso tempo. Quando i polmoni erano dilatati al massimo, c’era un momento 61 di silenzio, come un’ attesa di qualcosa di violento e d’incomprensibile; poi, l’espirazione, in un colpo solo, con un rumore sordo nel fondo della gola. Quindi riprendevano gli scatti, con i quali i polmoni richiamavano l’aria come potevano, con tutta la forza del soffocamento. Mia moglie ritornò nella nostra camera con l’amara soddisfazione d’aver ottenuto ciò che voleva. Non mi guardò, ne io guardai lei. Si mise sotto le coperte lontano da me, sull’orlo del letto, voltata dall’altra parte. Di là, udivo mia madre e mia sorella che dicevano a Elisabetta con tono dolce:« Non devi piangere; sennò ti prende il lupo e ti porta via.» Oppure:«Sennò la mamma ti fa tottò. Dove hai la bua?» chiedevano, «al piedino? Fai vedere il piedino: stai fermina.» Elisabetta doveva essere sul suo letto in piedi o a sedere; e mia madre voleva, m’immagino, metterla giù distesa ed entrare anche lei nel suo letto per abbracciarla e consolarla. La bimba però non voleva esser toccata da nessuno e respingeva la nonna, che diceva per impaurirla: «Mamma mia! C’è il Babau: vieni qui, vieni qui da me.» Questa minaccia però non calmava per niente Elisabetta; e mia madre non riusciva a farla stendere e ad abbracciarla. La sentivo ogni tanto dire a mia sorella: «Guarda com’è cattiva questa bambina.» Dopo l’ultima minaccia di mia madre, mi parve che Elisabetta riuscisse a dominare per un momento il singhiozzo e chiamasse: «Babbo!» Ma non ero sicuro, perché le altre voci si mescolavano a quel grido che poteva anche essere un semplice singhiozzo. E comunque preferii credere d’essermi sbagliato. Dopo cinque minuti il singhiozzo d’Elisabetta si placò in modo da permetterle di ricominciare a piangere più forte di prima. Mia moglie s’alzò per la terza volta e gridò: «Io l’ammazzo quella bambina!» «Tu non ammazzi proprio nessuno!» feci in tempo a gridare, 62 ma restai a letto. Mia moglie era già nell’altra camera, aveva raggiunto la bambina e aveva ricominciato a sculacciarla sonoramente. Urlava: «Io t’ammazzo di botte se non stai buona. Stai giù; stai ferma!» Elisabetta non voleva stendersi e probabilmente s’irrigidiva tutta, come fa in simili casi. Mia moglie continuava a sculacciarla e a gridare: «T’ammazzo!» e «Ti butto dalla finestra!» La bimba fu presa di nuovo dal singhiozzo di prima, che non le dava il tempo di piangere. Sentii mia moglie gridare:« Ora stai giù e dormi. Se mi fai venire un’altra volta di qua, ti strozzo.» E con la vana illusione d’aver chetata la bambina ritornò nella camera dove io, irritato, mi rigiravo da un fianco all’altro. Non era ancora entrata nel letto, che Elisabetta riprendeva a piangere tra un singhiozzo e l’altro, a scatti nervosi. Infine udimmo rumori di coperte sbattute, mentre mia madre gridava: «Cosa fa? E’ impazzita questa bambina!» E mia sorella:«La fate ammalare dalle botte.» Intanto il pianto si faceva continuo e intenso. Mia madre diceva alla bambina: « Vieni nel nostro letto, stai qui con noi, non piangere, sennò viene la mamma e ti picchia. Non piangere, bella.» Elisabetta, ad ogni parola della nonna, rispondeva con un no rauco e prolungato. Mia moglie allora esclamò con rabbia: «Non so più cosa fare con quella bambina. La devo ammazzare?» Queste parole mi fecero finalmente decidere ad andare di là. Ordinai a mia moglie: «Tu stai qui e zitta». M’infilai le ciabatte e aprii la porta della mia camera. A quel rumore, mia madre disse ad Elisabetta: «Ecco la mamma, ora la senti.» La bambina, al rumore della porta, dei passi, all’avvertimento della nonna, s’era sbiancata in volto e il pianto le si era congelato sulle labbra. Era seduta sul letto di mia madre, ma al mio arrivo s’era girata su se stessa, per alzarsi e fuggire. Quando s’accorse che ero io e non la mamma, 63 stette come un istante pietrificata nel suo terrore, poi si sciolse in volto e rilassò le membra e il corpo; infine scoppiò in un pianto dirotto porgendomi le braccia e chiamandomi: «Babbino! Babbino!» Io la presi subito in collo; la stringevo, le davo bacini sulla faccia bagnata, l’accarezzavo e la chiamavo «Briciolino». Le dissi anche: «Babbino viene a letto con te, nel tuo lettino. Non piangere.» Nel suo ultimo accesso isterico la bimba aveva scaraventato da una parte il proprio guanciale e aveva buttato giù l’incerato, la pezza assorbente e i lembi del lenzuolo. Mentre aspettavamo che mia madre sistemasse il letto, Elisabetta, sempre piangendo, si lasciava andare completamente fra le mie braccia. Sentivo che lei cercava di aderire a me quanto più poteva: il suo piccolo corpo era tutto sul mio petto, i braccini stretti intorno al mio collo, la testa reclinata sulla mia spalla, in una posa piena d’affetto. Il lettino era pronto e ci appoggiai Elisabetta. La bimba però non voleva rompere il contatto con il mio corpo, da cui prendeva protezione e forza. «Vengo con te, a letto, non temere.» le dissi. E la stesi sul lenzuolo. Mentre mi levavo le ciabatte e mi coricavo, Elisabetta mi chiamava con le braccia aperte e invitanti, come un’amante. Ci mettemmo su un fianco voltati l’uno verso l’altra. Io l’abbracciavo alla vita; lei mi cingeva il collo con le mani, mentre con le gambine cercava di stringermi ai fianchi. Aveva smesso di piangere: solo il singhiozzo la scuoteva, non il singhiozzo irrefrenabile che dianzi non la lasciava nemmeno piangere, ma quel singhiozzo che viene dopo il pianto, stanco e torpido. Le parlavo senza costrutto, per distrarla; le parlavo del mare e dei laghi, cose per lei favolose e piene d’una grande bellezza. Dopo poco prese a sbattere gli occhi dal sonno e io mi chetai. Perché aveva pianto tanto quella notte? Perché le mie donne, mia madre, mia sorella e persino mia moglie, non erano riuscite a 64 calmarla? Mia madre e mia sorella non avevano con lei quel legame che era necessario per darle aiuto in quel momento. Ma mia moglie, perché non era stata di nessun conforto per Elisabetta e anzi le aveva prolungato nella realtà l’incubo che l’aveva scossa nel sonno? Perché? Come qualche volta mi succede, riflettevo tra me, immaginandomi di parlare a mia moglie. Le dicevo: “Tu hai le mani troppo svelte. Prima di picchiare la bambina, cerca la causa che la fa piangere. No, non basta chiedere in tono duro se ha la bua al pancino. Se è malata, lo puoi vedere a colpo d’occhio. Sono altri i mali che tu devi scoprire e rimediare. Cosa aveva stanotte? Solo un incubo. Ma un incubo per un bambino è qualcosa di terrificante. I bambini non distinguono bene i sogni dalla realtà. Solo in seguito, diventando grandi, s’accorgono della differenza tra ciò che accade loro da svegli e quello che sognano. Così è per Elisabetta. Fai conto di sognare, che so? che noi tutti siamo morti e che anche tu stai per morire e che t’inseguono. Identifica quest’incubo con la realtà, come fanno i bambini. E poi svegliati: tu cerchi qualcuno, una persona cara, che ti possa aiutare, proteggere e con la sua presenza ti possa convincere che quella paura è illusoria e che invece esiste l’amore, la bellezza, la gioia. Ed ecco l’unica persona che ti può soccorrere che ti chiede sulla faccia: “Hai la bua al pancino? No? E allora tieni!” E giù botte urli e minacce e quei tuoi sfoghi che per lei devono essere terribili, quando dici: “Io t’ammazzo! Io ti butto dalla finestra! Io ti strozzo!” E anche quel chiamare il lupo o il babau: “Vieni, mangiala”. Ma che mondo è il tuo, dove tutto è fatto per paura ? L’unico sistema che tu conosci per ottenere una cosa giusta è la minaccia, il ricatto, lo sventolare lo spettro del male più spaventoso possibile. Quale inferno hai dentro di te, per credere che per primo esista il male, l’incubo? E che non c’è amore e bellezza, se non ottenuti tramite loro? Quale inferno? E 65 come puoi rivolgerti a tua figlia che ti chiede di testimoniarle la positività dell’universo, dicendole: “Io ti strozzo?” In fondo, Elisabetta ti chiede soltanto che tu le dia la forza di vivere, di vivere nonostante gl’incubi, il dolore, il male. Lo so: quest’aiuto che bisogna dare è faticoso; e le nostre forze sono limitate, talvolta non bastano nemmeno a noi stessi. Ma proprio sulla pochezza delle nostre forze è basato l’istinto della famiglia, lo scegliere fra tutta l’umanità quattro, cinque, dieci persone, dicendo: “Ecco, fra me e loro c’è un rapporto di reciproco affetto; e quando io sarò stanco, loro mi aiuteranno; e quando essi saranno stanchi, io li aiuterò.” Non ti chiedo di redimere il mondo col tuo amore, ma solo d’infondere in tua figlia l’energia necessaria per vivere, quella energia che è fede nella gioia e nella bellezza prima d’ogni altra cosa. Per questo, quando tu la picchi per farla star zitta, lei piange ancora più forte. E se tu le imponi di tendersi e di star ferma nel letto, lei s’alzerà e getterà via le coperte e il guanciale. Perché in quel momento lei non vuole più vivere. Con le tue grida, le tue botte, le tue minacce hai rotto la sua fede nella vita; e lei, allora, vorrà distruggere tutto, anche se stessa. Sì, l’isteria distruttiva passerà; ma la cosa peggiore rimarrà in lei e s’accumulerà nel suo animo: la convinzione del male, la giustificazione del dolore, il porre per primo l’inferno sulla vita felice. Fino a quando un giorno anche lei, per ottenere da sua figlia una cosa giusta, minaccerà di gettarla dalla finestra.” Così m’immaginavo di parlare a mia moglie. Nel frattempo, Elisabetta era caduta in un sonno profondo, scosso soltanto dagli ultimi singhiozzi. Allora m’alzai, rincalzai le coperte, spensi la luce e tornai in camera mia. Mi ripetevo che quelle cose dovevo dirle davvero a mia moglie e non tenerle per me, come succedeva il più delle volte. E non dovevo fare nemmeno come le altre poche volte che parlavo, quando impartivo con tono 66 imbarazzato una lezioncina maritale uggiosa e inconcludente, togliendo dal mio discorso tutte le parole altisonanti. Entrai nel letto. Mia moglie era stesa su un fianco, voltata dall’altra parte, nella posizione che assume quando siamo irritati l’uno con l’altra. Pareva che avesse udito davvero tutto quanto avevo immaginato di dirle. Mi sembrò che volesse addirittura replicare, accusandomi. E io la prevenni pensando: “No, non lo dire: anch’io ho la mia parte di colpa. Tu non sapevi quelle cose, tu non ci avevi mai pensato. Ma io sapevo; conoscevo tutto e sono rimasto a letto. Domattina volevo alzarmi presto per scrivere, avevo bisogno di riposo e m’illudevo che tu l’avresti calmata. Ho persino fatto finta di non sentire il grido della bambina che mi chiamava. Sì, sono arrivato a questo punto: d’ingannare me stesso, pensando che era solamente il rantolo d’un singhiozzo e non la parola “Babbo”. Solo dopo che per tre volte ti eri alzata ed eri andata di là, e solo dopo che tu ti eri arresa dicendo: “Non so più cosa fare”, mi sono deciso a provare io a calmarla. Ormai non c’era altro da fare e il mio stesso egoismo, per dormire, m’ha fatto alzare e m’ha costretto a portare il mio aiuto a Elisabetta. Tutto ciò è vero; e questa è la mia parte di colpa. Ma tu, perché non sapevi?” A questo punto non potei più sopportare la parte di pedagogo. Mi spostai nel centro del letto, allungai un braccio e attirai verso di me mia moglie. Lei mi rispose subito, voltandosi su quest’altro fianco e abbracciandosi a me con forza. Pronunziò solo un “Oh!” come se lasciasse sfuggire l’aria che a lungo aveva trattenuto nei polmoni. Anche lei cercava di aderire al mio corpo quanto più poteva, per trarne conforto e protezione. E mentre lei, abbracciandomi, si sentiva “più buona”, come mi dice spesso, io diventavo triste, sfiduciato, pieno di dubbi. 67 Vedevo quasi la paura e l’incertezza che la dominavano. Mia moglie non era la sacerdotessa iniziatrice della Dea Paura, come volevo dipingerla io poco prima. Anche lei era una piccola bambina con gl’incubi; e reagiva come poteva di fronte al mio egoismo, a quello d’Elisabetta, dei miei familiari, di tutti. Vivere costa fatica a chiunque. 1963 68 69 SAGGIO DI TEOLOGIA SESSUALE 70 71 Conosco bene le ironie che su noi teologi ha tentato di ammannire questo secolo traviato e lo scherno che ci viene gettato addosso, quando affermiamo la nostra familiarità coi segreti dell’altro mondo. Ebbene ora è giunto il momento della nostra rivincita! Grandi cose sono successe di là; e solo noi potremo illuminare gli uomini sul da fare nel rivolgimento che ci attende. A noi ancora dovranno rivolgersi i sapienti, i filosofi, gli scienziati, gli uomini di governo, per indirizzare su nuovi principi la vita umana. E’ la notizia più straordinaria dal giorno dell’Annunciazione alla Vergine. Finalmente siamo stati autorizzati a comunicarla a tutti da chi ora comanda. E godo; e quasi mi scappa il riso dalle labbra al pensiero di cosa succederà. Ma procediamo con ordine. Si sa, o si dovrebbe sapere, che l’unica, fondamentale differenza tra angeli del bene e angeli del male, tra angeli-angeli e angeli-diavoli, è la differenza che c’è tra uomini e donne; e precisamente nel senso che i diavoli sono uomini e gli angeli sono donne. Conferma questa verità anche l’esperienza millenaria delle pitture, dove i diavoli, più o meno bestiali, sono sempre delle bestie inconfondibilmente maschie (per non dire degli affreschi a San Gimignano dove i diavoli hanno certi ciondoli lunghi una pertica). Gli angeli invece sono sempre delle belle ragazze formose. Certo non vogliamo fondare l’affermazione teologica sul sesso degli angeli e dei diavoli sul mero esempio dei pittori: la nostra solida base è e rimane l’autorità della tradizione e dei libri sacri, che proprio grazie al capovolgimento avvenuto nell’aldilà acquistano finalmente quella chiarezza di significato di cui mancavano quelle interpretazioni pittoriche. Cos’è, insomma, tutta la storia della lotta di Lucifero con Dio se non la storia della lotta tra due maschi per conquistare il favore (e i favori) dell’harem degli angeli? Sul fatto, poi, che Dio sia maschio e non femmina, né tanto peggio una via di mezzo, su 72 questo mi pare che non ci sia dubbio. Dio disse: “Voglio creare un essere a mia immagine e somiglianza” e fece un uomo, non una donna; poi s’incarnò sì nel ventre d’una donna, ma per nascere uomo; e infine lasciò come immagine visibile di sé stesso sempre un uomo. Si è ragionato talvolta d’una papessa esistita intorno al mille e scoperta perché le venne il mestruo proprio durante una processione. Ma questa è una leggenda che non rientra nella genuina tradizione su cui noi ci fondiamo; ed è senza dubbio da attribuire a quei soliti denigratori che spargono il loro veleno sulle cose sacre e sulla teologia. Dunque, tra Dio e i futuri diavoli, guidati da Lucifero, s’instaurò un conflitto ideologico sull’istituto del matrimonio. Dio era per la poligamia (la propria con gli angeli) lasciando i futuri diavoli a vedere e a rodersi. Questi, nemmeno a farlo apposta, erano di parere differente: da considerazioni statistiche sull’approssimativa uguaglianza del numero degli angeli col numero dei diavoli dobbiamo arguire che essi fossero strenui difensori del matrimonio monogamico, cioè del matrimonio sacramentale, cristiano e occidentale, fatta la dovuta eccezione per i vedovi, che si possono riposare, mentre per gli altri non c’è divorzio che tenga. Proprio nell’eccezione per i vedovi e nel secco rifiuto del divorzio traspare l’intenzione diabolica che ha informato la teoria matrimoniale. Perché (è il diabolico ragionamento) se io muoio prima di mia moglie, lei tanto è tenuta a gettarsi sul mio rogo e a morire con me, mentre, se muore prima lei, io non rimango in bianco ma mi posso risposare. In quanto al divorzio, bisogna assolutamente vietarlo, perché altrimenti Dio con miraggi e altri suoi mezzi induce mia moglie a chiederlo, lui subito glielo concede e io rimango a vedere un’altra volta. Fatta tra loro questa santa e diabolica teoria matrimoniale, i futuri diavoli la proposero a Dio per bocca di Lucifero, che all’insaputa di tutti desiderava d’amore infernale l’arcangelo 73 Michela, la prima in dignità e la più bella degli angeli femmine. Dio, a sentire quelle richieste, fece un monte di storie. Sapeva bene che se concedeva quella legge matrimoniale, a lui non sarebbe rimasto che scegliersi per moglie un solo angelo che avrebbe assunto il titolo di Sua Maestà la Dea, dopo di che lui era fritto perché quella avrebbe cominciato a fare e disfare secondo i suoi capricci di donna, impacciandosi nel governo dell’universo; e lui in conclusione avrebbe fatto la fine di Giove con Giunone. Dio allora, forte dell’esperienza del suo predecessore, cercò in tutte le maniere di dissuadere i diavoli dai loro progetti matrimoniali: “Perché volete sposarvi? E non state bene così, liberi e senza pensieri?” Insomma un monte di storie. Fino a quando Lucifero perse la pazienza e sbottò a dire:” O Dio, ma siamo uomini come te!” Dio non fece più discorsi: prese la palla al balzo e cominciò ad accusare Lucifero e i suoi seguaci di superbia, di volerlo detronizzare, di essere dei sovversivi, di voler instaurare la proprietà comune dei mezzi sessuali di contro alla santa sua proprietà privata. In conclusione, a forza di pedate li mandò tutti al diavolo e lui rimase in Paradiso solo e beato con tutti i suoi angeli. La parte passiva che hanno gli angeli in tutta questa faccenda è una riprova che sono donne: alle donne chi gli capita gli capita, gli sta sempre bene, purché venga. I diavoli dunque, ritrovatisi in giro per il mondo e non potendo più sperare nell’angelica soddisfazione, riversarono il loro grande amore sulle donne terrene, che meglio di nulla sono, anche se non raggiungono la perfezione degli angeli. All’inizio sembra che ci sia stata della confusione: baccanali, misteri, sabba, incubi e succubi, messe nere, necrofilia, esorcismi, possessioni. Ma sono tutte storie vecchie, prive di sicure testimonianze, e non si sa bene che pensarne. Poi, sfogato il primo ardore, (e ci saranno voluti, mettiamo, 15 miliardi di coiti per, mettiamo, 2 miliardi di diavoli, il che fa 3x10 elevato alla diciannovesima coiti e moltiplicato questo numero per litri uno 74 che è, mettiamo, la quantità di sperma emessa da una diabolica eiaculazione, si ottiene centimetri cubi 3x10 alla ventunesima. E mettiamo che quelle cifre possano anche essere maggiori, ben si vede che è giustificato attendersi che qualche teologo ci dimostri proprio in quel primo sfogo sessuale l’origine degli oceani. Inoltre, il liquido diabolico ha, con ogni evidenza, una composizione molto differente dalla nostra: niente vieta di credere che vi germoglino coralli, vi si schiudano conchiglie, vi nuotino pesci e balene; dal che si dedurrebbe che da quel liquido nacque la vita sulla terra e non, come finora avevamo creduto, dall’argilla) sfogato, dicevo, il primo ardore, i diavoli s’accorsero che le donne non sono angeli. E nemmeno uomini. Allora Lucifero ebbe un’idea veramente diabolica. Col suo grande potere costrinse noi teologi a radunare un concilio e a decretare che da allora in poi le donne avrebbero avuto l’anima come gli uomini, immortale, perfettibile ecc. ecc., contravvenendo in pieno al proposito di Dio. E questi non poté farci nulla! Quando ne fu informato dall’arcangelo Gabriella, la decisione era già stata votata dal concilio e lui dovette uniformarsi al decreto e cominciare a creare le anime femminili. Con questo regalo dell’anima Lucifero sperava d’infondere nelle donne dell’orgoglio, che le spingesse a salire, non dirò alla perfezione angelica, ma almeno sullo stesso grado d’imperfezione degli uomini. Ma si sa che fine fanno le leggi demagogiche: lasciano sempre il tempo che trovano. E Lucifero vide subito che il semplice regalo dell’anima non bastava a migliorare le donne. E con diabolica intuizione, ne comprese la causa. Infatti, diceva, che una di loro abbia raggiunto al massimo il titolo di Madre di Dio (e che fatica e intrighi c’è voluto per farglielo avere!) ha sulle donne un effetto demoralizzante; è necessario invece renderle corresponsabili della divinità. Da qui ebbe origine una lunga battaglia per trasformare il Dio Uno e Trino in Dio Uno e Quattrino (Quattrino non in senso di denaro, 75 perché questa trasformazione è tanto che avviene, ma nel senso di quaternità), facendo la Madonna partecipe della consustanzialità divina. Questa volta, però, Dio stava attento a frappose divini ostacoli al disegno di Lucifero. Dio non ne voleva proprio sapere d’avere accanto una moglie, una figlia o una madre che fosse. Se, rispondeva, se fate Dio la Madonna perché è la madre di Cristo, bisogna far Dio anche Sant’Anna, perché è la madre di Maria, e così di figlia in madre si risalirebbe ad Eva. Dopo di che non mi resterebbe che assumere anche tutti i vicari maschi che Gesù ha lasciato in terra per essere al gran completo. Ma voi non pensate che quassù il problema demografico diventerebbe più grave che in India o in Cina; senza contare che mi riducete Cristo a far parte d’uno che ha abolito il matriarcato per introdurre la legge salica. Insomma non ci fu verso convincere Dio: noi teologi riuscimmo ad ottenere per Maria l’immacolata concezione, l’assunzione in cielo corpo e anima e l’altro titolo di Madre della Chiesa; ma niente di più. Lucifero allora concepì un altro grandioso progetto infernale: cercò d’attribuire a Dio una pura spiritualità senza sesso. Da ciò discendeva che i suoi rappresentanti in terra, avendo un sesso ben determinato dalle leggi, non avevano ragione d’esistere; per cui bisognava combattere il papismo, il sacerdozio, la fede pubblica e la tradizione che avallava tutto ciò. Questo, per sgombrare la strada all’uguaglianza tra uomini e donne. Non poco fu il successo di Lucifero: circa mezza cristianità abbracciò la sua diabolica Riforma ed affluì via via all’Inferno per aver fatto versacci in direzione di Roma, per essersi divorziati e risposati, per questioni filologiche sui cugini o i fratelli di Cristo e per dei versetti della Bibbia che c’erano o non c’erano. Però Dio era corso ai divini ripari, al solo pensiero che il voto d’un concilio lo facesse rimanere in Paradiso come puro spirito senza sesso, insieme a due miliardi d’angeli-femmine insoddisfatte. E 76 non solo aveva aizzato il papa contro quella riforma aborrita, ma aveva mandato anche un messaggio risentito a Lucifero, nel quale gli ricordava che, quando gli aveva fatto concedere il titolo di Signore di questo mondo, lo aveva fatto apposta per limitare il suo dominio alla terra e che perciò non doveva azzardarsi a legiferare anche in Paradiso e addirittura sulle Loro Persone. Infine, per punizione, gli ordinava di non uscire più dall’Inferno. Ora, stare all’Inferno per l’eternità è un po’ scocciante. E’ scocciante non tanto per gl’immaginosi tormenti, come pensa il popolino, quanto per quella vita al chiuso, sottoterra, senza mai vedere il sole, con quelle zaffate di zolfo; e poi per la faccia spaurita dei nuovi arrivati che s’aspettano chissacchè e prima che s’ambientino, imparino a orizzontarsi tra i budelli e le bolge e ti si levino da tre passi, ci vuole un anno. Lucifero però non si fece abbattere da quella divina e ingiusta punizione; e pensò subito, con magnanimità diabolica, di realizzare nell’Inferno quell’innalzamento spirituale della donna che non gli era riuscito sulla terra. Si deve sapere che coloro che muoiono in peccato si radunano, innanzi tutto, in un gran piazzale chiamato “Piazzale della sosta permessa”. Qui, ad alcuni diavoli, i dannati devono dare le proprie generalità: nome, cognome, sesso, razza, titolo di studio posseduto e condizione sociale, dopo di che vien loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo “a scopo d’istruzione”. Per i feti nati morti o abortiti, che sono tanti, è stata escogitata la “aggregazione”, per cui ogni dieci feti dannati si fa un dannato adulto e non ci si pensa più. Per i bambini morti senza battesimo è stata adottata una speciale cura ormonica che tempo sei mesi li fa diventare adulti. Queste misure erano state prese, per evitare che l’Inferno diventasse un gigantesco nido per l’infanzia abbandonata, quando a un certo momento non bastarono più i diavoli per dare il biberon a tutti i marmocchi miagolanti, o una specie di bidone della spazzatura per 77 raccogliere i mostriciattoli abortiti. I dannati, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono seguire un corso d’istruzione accelerato che prevede lezioni di “Infernologia”, “Teoria del male”, “Storia del peccato”, “Topografia e statistica infernale” e altre lezioni supplementari a scelta tra “Come indurre in tentazione”, “Come sviare le menti alle fonti della menzogna” ecc.. Quando il dannato ha superato brillantemente gli esami degl’insegnamenti fondamentali e di almeno tre insegnamenti supplementari, viene nominato “apprendista diavolo in prova”: dopo un anno passa in pianta stabile e quindi segue la carriera di tutti i diavoli: se ottiene per tre anni consecutivi la qualifica di “distinto”, oppure per un anno la qualifica di “ottimo”, viene promosso sottocapomanipolo, poi capo manipolo, sottocenturione, centurione, sottoseniore, seniore, superseniore, Gran diavolo di terza, seconda, prima e infine Caporale d’Onore. Il titolo di Gran Diavolo molto raramente viene concesso a semplici diavoli che vengono dalla leva dei dannati; in genere è riservato ai diavoli originari. Il titolo di Caporale d’Onore era stato creato ad personam e a vita, cioè in eterno, per Lucifero. Lucifero si mise dunque, con molta buona volontà, a riformare quest’ordinamento vecchiotto. Innanzi tutto abolì le cattedre istituite durante la moda del sadismo, quella di Teoria dello stupro, quella di Tecnica della tortura, l’altra di Psicologia del rinchiuso e ne istituì altre come, per esempio, quelle di Igiene della vita sessuale, Controllo e prevenzione delle nascite, Psicanalisi, Psichiatria, Psicoterapia e Psicopatologia delle psicosi sessuali. Poi costrinse diavoli vecchi e nuovi a un corso d’aggiornamento che comprendeva, fra l’altro, anche una serie di conferenze tenute da lui in persona. Resteranno memorabili quelle intitolate “Sull’amor platonico come ideale comune agli uomini e alle donne, ai dannati e agli eletti”, “Il progresso come a priori della natura femminile”, “La comunicabilità 78 eterodiretta”. E insomma l’attività diabolica riempì tutto l’Inferno e arrivò fin sulla terra. Ma col passare degli anni, purtroppo, si fecero sempre più rari gli arrivi di giovanotti e di ragazze; l’arrivo di qualche professionista sulla quarantina cominciava a diventare un avvenimento, una festa addirittura l’arrivo di ventenni morti in incidenti stradali. E che sugo c’era a insegnare sessuologia a una vecchietta di ottant’anni? E a chi poteva interessare se una vedova piena d’acciacchi diventava o no simile agli angeli? Allora Lucifero si disgustò di tutte le donne terrene e sentì più amara ancora la nostalgia del Paradiso, quando ogni giorno incontrava l’amata Michela, così splendente d’ogni perfezione femminile. La pena di quell’amore infelice gli tolse la voglia di continuare la sua generosa opera. Così cominciò a non uscire più dal suo castello, posto nel più profondo dell’Inferno, e a trascurare i suoi compiti e i suoi ideali. Ai gran Diavoli che venivano a prendere ordini per trasmetterli in tutta la scala gerarchica rispondeva che facessero come a loro piaceva. E quelli, ambiziosi com’erano, non se lo fecero ripetere troppo. Fu l’anarchia: Lucifero non usciva, non sapeva, non comandava; i Gran Diavoli non andavano più da Lucifero, tramavano, ordinavano, si combattevano. Successe persino che una fazione di diavoli, per combattere un’altra fazione di diavoli, cominciò a fare del bene, a predicare il Vangelo e a raccomandare la penitenza. Grande fu la confusione nelle coscienze; s’arrivò al punto che uno, nel fare il bene, non sapeva più se ubbidiva a Dio o a qualche partito diavolesco. Così Dio, visto che l’Inferno non eseguiva più gli ordini divini per la diffusione del male, inviò giù il suo messaggero, l’arcangelo Gabriella, per ordinare a Lucifero di presentarsi al suo cospetto. Ma Lucifero non ricevette nemmeno l’arcangelo. La Gabriella, che si credeva non solo la più desiderabile e la più importante creatura di Dio, ma che su Lucifero aveva perdipiù 79 costruito qualche pensierino, si sentì tanto offesa che fece a Dio una lagna come se si fosse trattato dello schiaffo d’Anagni. E tanto fece e disse che Dio montò in una collera tremenda: l’Inferno fu squassato dal terremoto, la terra si rabbuiò tutta e le stelle si fermarono per un giorno intero. Infine Dio chiamò l’arcangelo Michela e disse: «Tu sei la principessa dei miei angeli, la più alta, la più forte, la più bella. Cingi la tua spada di fuoco e scendi da Lucifero. E come sempre hai fatto, vincilo anche questa volta, umilialo e conducimelo qui in catene. Fino al tuo ritorno vittorioso non guarderò più in basso: né la terra né l’Inferno penderanno dai miei occhi, ma si sosterranno da sé o da sé crolleranno.» A queste parole l’arcangelo Michela represse a stento i segni della sua gioia; cinse subito la spada e si precipitò nel profondo dell’Inferno, mentre Dio, ridata la prima spinta alle stelle e alla terra, fissò lo sguardo solo in se stesso, come aveva promesso. L’Inferno, tra il terremoto e l’anarchia, sembrava una città bombardata e abbandonata. Michela non trovò nessun difensore che la ostacolasse; i portoni del castello di Lucifero erano scardinati, le sale e i corridoi vuoti. Michela avanzava con la spada in pugno scivolando in un volo leggero. Cominciava a credere che non ci fosse più nemmeno Lucifero, quando lo trovò nella sua camera-studio, seduto nella sua poltrona, appoggiato al suo tavolo. Lui, vedendola entrare, accennò un sorriso e continuò a guardarla in silenzio. Infine le disse: «Ti aspettavo. Quando ho sentito il terremoto ho capito che saresti arrivata. Che ordini hai?» «Di condurti da Lui in catene.» «Ma sì» disse pacato Lucifero, « sia fatta la sua volontà.» «Come!» esclamò Michela «Non ti difendi?» «Perché dovrei difendermi? Per essere battuto da te e fare dopo invece che ora quello che Lui vuole? Sono stanco di questa recita. Mi sembrano lontani i tempi quando, travestito da 80 principe dei persiani, lottavo con te anche ventiquattro giorni di seguito. E la Gabriella che andava e veniva a raccontare a tutti quello che si faceva! Bei tempi, ma così lontani! E tu non sei stanca di portare codesta spada, di vestire la corazza e di duellare di qua e di là?» L’arcangelo Michela, che s’aspettava un bel duello, e dopo una discussione con Lucifero, guidata da lei però, si sentì imbarazzata da quella domanda diretta e arrossì, come se fosse stata sorpresa in un atteggiamento disdicevole. Lucifero se n’accorse, ma non volle approfittarne. Disse semplicemente: «Mi dispiace d’averti rimproverata. Tu fai bene: ubbidisci al tuo signore e alla tua natura di donna. Chi resta sempre insoddisfatto sono io, l’incontentabile. Ti ricordi i primi tempi della creazione, quando eravamo si può dire ragazzi e io vivevo ancora in Paradiso? Tu volevi giocare a mamme e io di figurine con la muriella; tu a rimpiattino e io all’una luna. Facevo sempre il contrario di quello che facevi tu; ma dentro, avrei voluto giocare e divertirmi insieme a te. Volevo e non volevo; ed ero scontento anche dei miei giochi.» Michela sorrise a quei vecchi, cari ricordi. D’un tratto, si sentì come una sciocca, con quell’attrezzo fiammeggiante in mano che non le serviva a nulla contro le parole. Si sfiorò la fronte e i capelli con la mano sinistra, emise un sospiro, sorrise e si mosse con quel suo volo composto verso il caminetto alla sua destra. Appese la spada alla rastrelliera degli attizzatoi, accanto a quella nera di Lucifero; si slacciò la corazza e la gettò indietro su una poltrona; infine si avvicinò al tavolo. La sua bellezza rifulgeva ancora di più per la semplicità della tunica celeste che la copriva fino al ginocchio e le modellava le forme. Lucifero ebbe un gran moto di gioia nel vederla posare la spada e la corazza. Ma un pensiero lo turbò subito. «No, Michela» disse. «Portami da Lui: lo rivedrò volentieri; e rivedrò volentieri anche certi piccoli angoli del Paradiso che mi 81 ricordano tante cose. Non posso desiderare che anche tu patisca i miei tormenti. Dimentichi che ora Lui ci sta guardando?» Lei s’illuminò d’un riso pieno, ma non spiegò nulla. Anzi, lo punse per sfidarlo: «Tu, il Ribelle, hai paura d’esser visto mentre disubbidisci!» «Michela, non provocare il mio orgoglio, altrimenti…» «Altrimenti, cosa?» «Perché non resti con me?» disse tutto d’un fiato Lucifero. E continuò, affollando le parole l’una sull’altra: «Sarai regina dell’Inferno, invece che serva in Paradiso. E non è meglio? Padrona di te stessa… e di me. Rimani e sarà tutto nostro, l’Inferno e il mondo intero.» Michela sorrideva felice. Ma ancora non volle dir nulla; e con voce petulante esclamò: «Ma tu sai che io non posso volere il male.» «Il male? E chi può volere il male? Io voglio te, ho sempre voluto te, e tu non sei il male. Ma tu, mi hai mai desiderato, come io ti ho desiderata, da sempre?» Lucifero, così dicendo, le aveva teso la mano. Lei rise con tutta la sua bellezza e gli avvicinò la mano, ma senza arrivare a toccarlo, come giocando a farsi pregare. E con voce calda di malizia rispose: «Ti desidero ora. Che vuol dire “da sempre”? Non è uno dei tuoi inganni il tempo?» Lucifero finalmente s’alzò dalla poltrona, prese le mani di Michela, l’attrasse verso di sé e la baciò lievemente. Poi s’abbracciarono e si baciarono con foga. Infine, su un vecchio, comodo letto che era nascosto in un angolo dietro un paravento a persiane, colmarono la distanza che troppo a lungo e troppo profondamente li aveva separati. Dopo che ebbero soddisfatto il primo impeto dell’amore, rimasero ancora sul letto, abbracciati, carezzandosi dolcemente. E poterono parlare di nuovo. Michela disse: 82 «Anch’io, lo sai? ti ho desiderato fin da quando giocavamo insieme. Ma tu, un po’ mi cercavi e un po’ mi sfuggivi; e io non sapevo cosa pensare.» E aggiunse subito: «E le nostre grandi battaglie? Anche la lotta è uno stare vicini.» « Io, ora, penso quasi» disse Lucifero, «che Dio forse ebbe ragione a non istituire il matrimonio quando glielo chiesi. E sai perché? Perché altrimenti io avrei voluto te e non solo io, ma anche altri diavoli ti avrebbero voluta, tu che sei la più perfetta creatura di Dio. E se tu avessi scelto un altro, credi che io sarei stato felice e contento lo stesso? Ma io l’avrei aspettato da qualche parte e gli avrei infilato in gola un coltellaccio lungo così.» «E io, allora» aggiunse Michela, «cosa avrei fatto se tu avessi scelto un altro angelo? Tutte, a cominciare dalla Gabriella, non sognano altro che te, la tua virilità, il tuo destino. Sì, è un bene che le cose siano andate come sono andate.» «Già» esclamò Lucifero, «però darei non so cosa per vedere la faccia di Lui ora. Tu, la prediletta di Dio, sei diventata mia! Non credere che ti abbia voluta per questo, pur tuttavia oggi è il giorno del mio trionfo.» Michela, a quelle parole, si sciolse ridendo dall’abbraccio di Lucifero, si levò in ginocchio sporgendosi sopra di lui gli confessò: «Ora posso anche dirtelo: Lui non ci ha visti; e non ci vede ora. Quando tu hai rifiutato di ricevere la Gabriella, è stato preso da una gran collera. Forse per questo si è lasciato sfuggire una promessa che mai sennò avrebbe pronunciata: finché io non tornerò in Paradiso, Lui non guarderà più in basso. Tutto quaggiù è abbandonato a se stesso, la Terra e anche l’Inferno. E così, mandandomi da te, Lui mi ha fatta padrona del destino di tutto il creato.» Lucifero rimase per un attimo senza parole. Poi fu rischiarato da un riso profondo e disse: 83 « Tu… Simulatrice più del diavolo! Tu avevi deciso di non tornare in Paradiso prima che te lo chiedessi! Sì, resta, resta con me: noi due siamo fatti per stare insieme. Ah, ma hai pensato cosa succederà? Vieni, vieni! Lo voglio dire a tutti.» Balzarono giù dal letto, indossarono di nuovo le loro tuniche e, quasi correndo, salirono sulla torre più alta del castello. Da lassù, affacciato agli smerli, Lucifero mandò un grido tremendo che fece vibrare tutto l’Inferno e agghiacciare le anime dei diavoli e dei dannati. Dovunque essi fossero, a Costantinopoli a fare del bene o in Giòlica a fare del male, subito accorsero sotto le mura del castello infernale, ogni legione col suo Gran Diavolo avanti, come tante scolaresche guidate dal maestro. Quando ci furono tutti, Lucifero tuonò: «Ascoltatemi bene, miei fedeli. Quel Dio patrigno, che c’impediva con odiosi divieti di sviluppare le nostre capacità e ci aspettava al varco con mostruosi verdetti, ha finalmente tolto gli occhi da questo nostro mondo. Io, Lucifero, e la mia sposa, l’arcangelo Michela, siamo ora gli unici signori del creato. Noi non ripeteremo gli errori di Dio. Lasceremo che ognuno di voi guidi e giudichi da se stesso le proprie azioni. Chi avrà bene congiunto la maschia energia dei desideri che salgono dal profondo con la pietà femminile per le cose, avrà in premio la fecondità delle opere; e chi invece vorrà generare da solo, castigherà se stesso con affanni inutili e lascerà dietro a sé solo il ribrezzo. A tutti è destinata la morte eterna, ma anche la forza per generare il nuovo, l’inaudito; e trasmetterlo agli altri senza limiti. Al lavoro, dunque! Cosa sono queste rovine? Cos’è questa confusione? D’ora in avanti, guai a chi non fa niente o a chi distrugge! Tutti al lavoro! Via!» E tutti obbedirono all’istante. Lucifero e Michela si ritrassero e cominciarono a scendere. Lui le chiese con tono scherzoso: «Ti è piaciuta la mia retorica?» «Certo!» rispose lei con lo stesso tono. «Chi non rimarrebbe 84 avvinto dai sofismi del Persuasore?» Risero e continuarono a scendere tenendosi abbracciati. E per due o tre volte ripeterono insieme quel ritornello che dice: La scelta d’amore, quando occhi sognanti il corpo accarezzano che con noi si profonde nel casto e ridente sentimento di eleggersi, e la concordia della natura, dove un quieto spettacolo raccoglie e distende le volontà multiformi, che da ogni essere nel tutto si placano, in noi armonizzano con l’audacia di volere la gioia di vivere. Questi sono i fatti; la prima parte dei quali l’abbiamo ricostruita leggendo meglio la Scrittura e meglio ponderando alcuni avvenimenti storici; e la seconda parte, trascritta da ispirazioni autorizzate giunteci dall’Aldilà. Non dovremmo allora essere felici e ridere e gioire anche noi teologi, che conosciamo i segreti dell’altro mondo e sappiamo cosa consigliare per compiacere ai nuovi Signori? Ora che l’arcangelo Michela si è ribellata a Dio e si è unita a Lucifero, e ora che Dio ha abbandonato questo mondo al loro dominio…… 85 Con questo discorso incompiuto termina l’ultimo scritto del grande teologo Luterlicche, il Grande Libro Ispirato su cui egli lavorava quando avvenne il fatto misterioso che ci ha lasciati tutti impauriti. Luterlicche fu visto per l’ultima volta, or è un anno, mentre entrava nel suo studio. Le stesse persone (tre suoi allievi) che l’avevano visto andare di là udirono poco dopo un suo grido acuto; subito occorsero e trovarono seduto alla scrivania, come se scrivesse, un fantoccio di panna montata, che gocciolava da tutte le parti e presto si disfece. I tre allievi hanno giurato che il fantoccio somigliava molto al grande teologo. A chi è da attribuire quella trasformazione di Luterlicche? Noi abbiamo pubblicato il suo ultimo saggio con la più scrupolosa imparzialità e non vogliamo ora entrare nella polemica sulla scomparsa del teologo. Ci limitiamo pertanto a riportare sommariamente le opinioni più diffuse al riguardo. C’è chi sostiene che Luterlicche avrebbe offeso Lucifero con la sua smania di compiacergli; e Lucifero per questo lo avrebbe trasformato in panna montata. Altri ribattono che ciò non può essere, perché Lucifero avrebbe condannato Luterlicche, quando invece aveva promesso di lasciarci giudici di noi stessi. Ci sono alcuni dell’opinione che sia stato Dio a punire Luterlicche del dubbio che Lui non abbia voluto e visto ciò che è successo tra Lucifero e l’arcangelo Michela. Per costoro gli ultimi avvenimenti rientrerebbero in un disegno divino, ignoto anche a Lucifero e a Michela, di redenzione dei dannati. C’è poi chi crede che di fronte alla nuova Duità (la divinità di Lucifero e dell’arcangelo Michela) sia sorto un nuovo Maligno, forse qualche Gran Diavolo vagabondo ribellatosi all’ordine di Lucifero di fare e operare, al quale sarebbe dovuta la scomparsa di Luterlicche, profeta della nuova divinità. Come abbiamo detto, noi non vogliamo entrare nella polemica. Ma non potrebbe darsi che la storia dell’amore di Lucifero e dell’arcangelo Michela sia un’invenzione di 86 Luterlicche, il quale sarebbe ora in qualche posto a ridersela di noi? Il nostro teologo era famoso per il sarcasmo, lo spirito mordace e gli scherzi stravaganti che escogitava. Non sarà tutto uno scherzo? 1969 87 GIOVANI DALLA LUCANIA 88 89 I Giuseppe Trallori faceva lo spazzino, a Prato. Abitava con la moglie Carmela e il figlio Luigi di ventun anni al secondo piano d’un vecchio casamento, frazionato tanti anni prima, come era stato possibile, in vari appartamenti da un vecchissimo convento. Proprio per colpa della illogica sistemazione del loro appartamento successe quel che poi successe. Come può infatti un uomo che già si avvia verso la vecchiaia, frustrato da un lavoro che lui ritiene degradante e dalla sua povertà di spirito, passare e ripassare dalla camera d’una ragazza diciottenne mentre questa è a letto e non avere delle tentazioni? La casa era composta da tre stanze di cui una serviva di passaggio fra le altre due. C’era, oltre a queste, il gabinetto che non era altro che uno sgabuzzino sul pianerottolo delle scale. Si entrava direttamente nella cucina, uno stanzone dal soffitto alto, a travi, con una sola finestra e piccola. Una porta sulla sinistra di chi entrava metteva in una camerina, dove dormiva Luigi, e per la quale appunto si passava per andare all’ultima stanza, in cui dormivano i genitori. La sistemazione non era certo comoda; e l’affitto neanche tanto basso per un appartamento come quello; ma tant’é. Giuseppe e i suoi si erano trasferiti a Prato poco dopo la guerra. Erano stati fra i primi meridionali a stabilirsi in città. E ormai erano dei vecchi pratesi al confronto degli ultimi arrivati che a centinaia, fra i più poveri e diseredati, si accalcavano nelle baracche di legno e sopramattone dietro la ferrovia. Anche per Giuseppe erano stati duri i primi tempi a Prato, quando, invogliato da un compaesano, si decise a sfuggire dalla miseria del suo paesino abbarbicato sulle montagne della Basilicata. Tutto diventò più facile quando, per un colpo di fortuna, entrò come spazzino nell’azienda municipale della nettezza urbana. Lui ne fu contento, ma anche umiliato nel suo orgoglio maschile di montanaro meridionale. Ebbe però uno stipendio sicuro, che 90 gli permise di farsi raggiungere dalla moglie e dal bambino di sei anni, che erano rimasti al paese. Il ragazzo, come tutti a quell’età, si ambientò subito. Dopo pochi mesi parlava il toscano dei pratesi e non lo si distingueva più dai suoi amici e compagni di scuola. Neanche il suo cognome, dal suono così toscano, era un segno di distinzione. Per i genitori fu più difficile. A loro non furono risparmiate le offese velate, le umiliazioni, il titolo di terrone. Ma anche loro, dopo che ebbero risistemato un po’ l’appartamento e rinnovato i vestiti, prima così vecchi e stinti, cercarono di mimetizzarsi. Si sforzarono anche di cambiare l’accento e il loro modo di parlare; ci riuscirono abbastanza bene, considerata la loro istruzione e l’età. Ormai dunque la famiglia Trallori era stata assimilata, come tante altre del resto, nell’ambiente operaio pratese. E’ vero che tutt’ e tre erano reticenti a dichiarare dove erano nati e sembrava che se ne vergognassero, ma pareva che questo fosse il tributo che ogni italiano del Sud doveva pagare agli italiani del Nord. Sta di fatto che quando giunse la lettera di Maria, la sorella di Carmela, nessuno dei tre fu molto contento, anche per la preoccupazione di dover ospitare e avviare al lavoro una ragazza chiaramente meridionale. Maria, in quella lettera, chiedeva alla sorella di cercare un lavoro qualsiasi per sua figlia Cristina, non ancora diciottenne. Pregava di ospitarla nel periodo in cui cercava un lavoro, o che imparava un mestiere. Le rammentava la miseria del paese e i quattro figli più piccoli da mantenere. Le diceva che con i guadagni la bambina le avrebbe pagato la pensione e le avrebbe anche rimborsato le spese dei primi giorni. Si lamentava sulle magre entrate di suo marito, contadino. L’assicurava sul carattere di Cristina, che era docile, lavoratrice e seria, molto seria, e che anzi era stata lei stessa ad insistere nel voler andare al Nord per lavorare. La pregava. La benediceva in nome dei genitori, morti 91 da anni. La ringraziava. La pregava di nuovo. E infine si firmava: tua affezionatissima e riconoscente sorella Maria. «Come si fa a mantenere anche lei ora.» Fu il primo commento di Giuseppe. «Ma no, Cristina viene per lavorare.» Rispose sua moglie, cercando di convincere i familiari, anche se controvoglia. «Si, ma di questi tempi è difficile trovare un posto» intervenne Luigi. «Fosse stato in maggio o in giugno, ma ora c’è anche un po’ di crisi. E poi fanno delle storie se sei meridionale.» «Non è vero. Anzi ti assumono più volentieri. Sei più modesto, con meno pretese» disse la madre. «Macché. Se si tratta di prenderti senza libretto, senza assicurazione, ti possono anche prendere per un mese o due, ma appena diminuisce il lavoro, ti mandano via subito. E quando siamo a lavorare, siamo tutti uguali; le pretese son quelle. Forse una volta i meridionali li assumevano perché non facevano mai sciopero e così via. Ma ora….» Queste parole erano di Luigi. «Potrebbe aiutarmi a spuntire le pezze» insistette Carmela. «Al lanificio dove le prendo mi conoscono e me ne danno quante ne voglio. Il lavoro è facile. Se poi lei impara a rammendarle, guadagna più a casa che ad andare in fabbrica. E senza bisogno di tanti libretti e assicurazioni; e senza far sapere chi sei.» «E poi, dove dorme?» Si preoccupò improvvisamente Luigi, con ragione. Si accordarono infatti che Cristina avrebbe dormito in camera di Luigi e che lui, con rincrescimento in verità, si sarebbe trasferito in cucina, su una brandina pieghevole che tenevano in casa per i momenti di bisogno. Fu discusso a lungo, ma la risposta era già stabilita all’inizio. Come fare a dire di no a quella lettera in cui molto si pregava, ma poco si dubitava? Partì la risposta. E dopo pochi giorni giunse un’altra lettera, con la quale, fra ringraziamenti, benedizioni e abbracci, si 92 annunziava l’arrivo di Cristina a Prato per il mercoledì della settimana successiva, con il direttissimo delle sei del pomeriggio. Maria pregava la sorella di andare alla stazione ad aspettare la bambina, così diceva, perché Cristina era sola e si sarebbe trovata smarrita per cercare la loro casa “in una grande città sconosciuta”. II Questa seconda lettera fece riflettere Luigi. Quello che per lui era una noiosa seccatura, sembrava che fosse una svolta seria e importante nella vita dei suoi zii, o di sua cugina. E tutto quel consultare orari ferroviari, il lungo viaggio di una ragazza poco più che bambina, tutta sola, dava una impressione di avventura seriamente vissuta, o meglio immaginata. “Chissà” pensò fra se, “come crede che sia Prato, questa cugina: una grande città sconosciuta!” Rise. Prato non è né grande né sconosciuta. E’ una città operaia, dove si lavora molto e molto si commercia. Una città di provincia, vecchia, e noiosa anche nelle stanche domeniche dai pomeriggi così lunghi. Il pensiero che qualcuno la potesse immaginare come una metropoli tentacolare lo fece sorridere; lui, che si può dire ci fosse nato. Luigi era un ragazzo a posto per la sua età. Lavorava in una filatura come attaccafili e guadagnava discretamente, per quanto può guadagnare un operaio. Con la parte della sua paga che tratteneva per sé (la maggior parte la dava alla madre per i bisogni della famiglia) aveva comprato da qualche tempo una vespa, che aveva finito di pagare da poco. Come tutti i giovani della sua età aveva bisogno di affermare agli occhi di tutti la sua indipendenza economica e la 93 sua personalità di maschio. Con l’acquisto della vespa aveva cercato di ottenere questi due scopi. Era un frutto del suo lavoro ad era anche il mezzo di cui si serviva per le sue avventure domenicali nelle sale da ballo dei numerosi paesi intorno a Prato o a Firenze. Il bisogno del possesso materiale, in lui come in tanti altri si mescolava a maturazioni sessuali. C’era un episodio significativo, successo quasi quattro anni prima. Una sera era andato a Firenze in una casa d’appuntamenti che alcuni amici gli avevano indicata. Gli avevano detto che era una casa senza troppe pretese, dal prezzo basso, e dove non facevano tante storie per farti passare. Se il prezzo era basso, dovette accorgersi alla prima occhiata che la merce in vendita non meritava molto di più. Era un posto laido e puzzolente. Per sua fortuna, o sfortuna, non c’erano visitatori in quel momento. Delle due puttane che tenevano bottega in quel posto si fece subito avanti la più vecchia. Lo guardò un minuto, poi gli si avvicinò. Anche lui si fece incontro. «Allora, che facciamo? Si va in camera?» chiese con voce secca la donna. «Sono qui per questo» fu la meccanica risposta. Come allucinato, e in profondo imbarazzo, la seguì in una stanza vicina. La donna si liberò con un gesto della vestaglia che l’avvolgeva. Con un altro gesto si tolse le mutande. Rimase con il solo reggipetto. Luigi, fermo, la guardava con stupore costernato. Quella si dette una manata compiaciuta su una natica e sbottò: «Allora, non ti levi i pantaloni?» Luigi obbedì. Era vergine e il suo prepuzio sforzato sanguinò abbondantemente. Aveva sentito lo strappo al primo movimento, ma non si era reso conto di quello che accadeva. Neanche la donna se ne accorse sul momento, ma dopo un po’ gli fece: «Ehi, basta! Cosa stai facendo?» Tutta la coperta sul letto ed anche la sua camicia erano 94 imbrattate di sangue. La puttana, a quella vista, cominciò a strillare e berciare. «Maledetti bambini, sempre così. Un altro l’altro giorno m’ha fatto lo stesso servizio. Io ci devo dormire in questo letto. Ma perché non state dalle vostre mamme a farvi….» L’espressione affranta di Luigi la chetò. Stava lì, tutto sudicio, con i pantaloni ciondoloni e con una mano sullo stomaco per reggersi la camicia, senza poter parlare. «Vieni qua, lavati» disse con voce più dolce la donna. Lo condusse al lavandino che era nella medesima camera e gli lavò la parte lei stessa. «Che dirà tua madre di questa camicia piena di sangue?» s’interessò. «Oh, nulla» poté dire finalmente Luigi. «Mi dispiace per la coperta. Ho solo tremila lire con me…. Per il disturbo. Mi dispiace.» «Lascia fare, ormai.» Le dette le tremila lire e fuggì via appena possibile. A casa si lavò da sé i lembi insanguinati della camicia e se la fece asciugare addosso, perché nessuno se ne accorgesse. Questa avventura non fu, per Luigi un trauma. Però era spesso assalito dal ricordo di quella vecchia prostituta che si dava delle grandi manate su una natica adiposa, sempre più adiposa, e con al centro una ferita, che sul momento aveva appena guardato, ma che con il passare del tempo si faceva sempre più evidente nella sua fantasia. Era come se le mancasse un pezzo di carne nel gran sedere. E la cicatrice che si era lì formata sembrava un morso nero nella mela tonda e bianca. Ma anche il ricordo di quella natica cava si affievolì presto nella sua mente. Luigi era un ragazzo sano e normale. Ora, quando gli capitava, suo malgrado, di pensarci, provava un senso di vergogna, ma nient’altro. Come prima cosa, dopo quell’esperienza, non aveva mai più collegato il possesso d’una 95 prostituta con l’idea dell’amore, ma con quella dello sfogo. E aveva di tanto abbassato nella sua considerazione questi sfoghi che per non mischiare le due cose, quando ritornava ( e ritornò ma non nella solita casa) a Firenze spinto da quella voglia, non usava mai la sua vespa, ma prendeva l’autobus, così anonimo e non suo. A parte questa fisima, non era che lui si facesse un feticcio di quel modesto mezzo di trasporto. Era il suo unico possedimento e lo teneva di conto, anche psicologicamente, ecco tutto. La primavera precedente, Luigi aveva conosciuto una ragazza, Luigia, che all’inizio gli aveva dato l’illusione di aver trovato quell’amore che a quell’età ci si aspetta continuamente di trovare. Invece finì tutto assai alla svelta. L’aveva conosciuta per l’Ascensione, quando lui e un gruppo di suoi amici, tutti motorizzati, erano andati a fare la tradizionale scampagnata, insieme con altre ragazze. Proprio perché si chiamavano Luigi e Luigia avevano fatto coppia sin dalla partenza. La relazione (ma non ci furono dei veri rapporti sessuali) durò qualche tempo. Poi finì. Luigi le aveva lasciato credere tacitamente di essere pratese di nascita. Lei dopo un po’ insiste perché ci fosse tra loro un fidanzamento con tutte le regole. E allora lui si rifiutò, fra l’altro anche per non presentarle i suoi genitori così meridionali in tante cose, nonostante i loro sforzi per non sembrarlo. Poi, con uno scatto di sincerità, le buttò in faccia la notizia che era nato in Lucania. Fu per la strada, un giorno. La ragazza aveva definito “terrone” un povero diavolo che aveva chiesto loro un’indicazione. «Sai dove sono nato?» le domandò allora freddamente Luigi. «In Lucania, in provincia di Potenza.» Non aveva potuto trattenersi, anche se si pentì subito di quanto aveva detto. La ragazza in verità non dette peso alla faccenda, ma la rottura comunque era segnata. Il mercoledì preannunciato nella seconda lettera, andò Luigi a 96 prendere sua cugina alla stazione. Lavorava nel turno di mattina quella settimana ed era libero nel pomeriggio; inoltre poteva portare la ragazza in vespa. III Cristina scese dal treno e tirò giù una valigetta di cartone. Mentre lei si guardava intorno ansiosa, il direttissimo era partito lasciandola sola sulla banchina. “Sono rimasta sola davvero” pensò la ragazza nel vederlo allontanarsi. E restò un attimo ferma a fissare il treno che andava via. Nel frattempo le si avvicinò un giovanotto che le chiese: «Sei Cristina vero? Io sono tuo cugino Luigi. La zia non è potuta venire a prenderti, così sono venuto io.» Cristina aveva fatto cenno di sì, con sollievo. Ma non rispose nulla: non aveva capito bene. Per la prima volta si rese conto di quante abitudini avrebbe dovuto cambiare. Quel parlare così in fretta di suo cugino la scosse. “Non riesco nemmeno a comprenderli” si disse sgomenta. E la zia, chi era la zia? Poi capì che parlava di sua zia Carmela, riferendosi a lei anziché a se stesso come figlio. Appena le passò quell’attimo di smarrimento, Cristina, con un movimento puerile, si protese verso Luigi per baciarlo e per farsi baciare sulle guance. Lui che non se lo aspettava, rimase sconcertato sul momento. Poi rispose affettuosamente all’abbraccio. «Come stanno zio Giuseppe e zia Carmela?» disse infine la ragazza. «Bene. E tu? Sei stanca? E’ stato duro il viaggio tutta sola?» «No, no, non sono stanca.» E come per dimostrarlo fece per prendere la valigia. Luigi la prevenne. 97 «Lascia stare, la porto io. Tanto giù ho la vespa.» Cristina lo seguì docilmente. Al cancello d’uscita si fermò per gettare il biglietto del treno in una cassetta. Quell’atto così semplice le fece tornare alla mente tutto quel giorno trascorso in treno. Il biglietto glielo aveva comprato quella stessa mattina alle otto suo padre, a Potenza, dove l’aveva accompagnata. Sembrava che fosse passato tanto tempo in quelle dodici ore, da quando si era alzata prima dell’alba nel suo paesino arroccato tra le rocce, laggiù, in fondo all’Italia. Tutte le facce dei familiari e delle amiche le passarono un attimo davanti agli occhi. Le si strinse il cuore. E il viaggio così lungo ed estenuante! Non era mai andata più lontano di Potenza, prima; e ora Napoli, Roma, Firenze. Erano dodici ore che non parlava con nessuno, dagli ultimi addii di suo padre. Ogni chilometro che aveva risalito lungo la Penisola era stato un legame che spezzava col suo paese, con la sua gente e con se stessa. A Roma, dove doveva cambiare treno e aspettare tre quarti d’ora per la coincidenza, era uscita di stazione ed era andata a comprarsi un paio di calze di nylon, nel negozio più vicino che aveva trovato. Alla commessa che le chiedeva cosa desiderava aveva risposto con un filo di voce: «Un paio di calze, di nylon…. che mi vadano bene.» La commessa giudicò ad occhio, con un po’ di scherno, ogni cosa: le misure, le possibilità e il gusto certo non molto raffinato. Cristina sotto il peso di quel giudizio si era fatta rossa e piccola. Pagò il prezzo e ritornò in fretta sul treno. In un gabinetto si era tolta i calzini bianchi che portava e si era infilata le calze, tirando fuori le giarrettiere che lei stessa aveva preparato di nascosto già da una settimana. Sapeva quello che aveva fatto. L’acquisto delle calze era stato per lei un atto necessario, una ricompensa che le spettava di diritto. Ed era anche l’ultimo legame spezzato. Per questo aveva speso buona parte dei pochi soldi che suo padre le aveva dato. 98 Cristina era una ragazza volitiva nonostante l’età, e decisa nelle sue azioni. Aveva quella maturità che assai presto si conquista in mezzo agli stenti, senza però esserne inaridita. Aveva anzi, molto spesso, dei tratti di carattere freschissimi ed era talvolta d’una ingenuità da stupire. Ma quando si trattava delle cose che lei riteneva essenziali nella sua vita diventava improvvisamente sicura e adulta. Aveva voluto lei quel viaggio: era un anno intero che tendeva a quello scopo. A quattordici anni, quando la sua femminilità si faceva ogni giorno più piena, si era d’un tratto convinta di non poter fondare una famiglia nei posti dove era nata. “I miei figli devono avere qualcosa di più dei miei fratelli”: questa era la giustificazione che lei stessa si dava, con uno di quei moti di crescita inconfessabili e sentiti. E così era partita. Ma ora, a Prato, non era più tanto sicura dei suoi desideri, si sentiva smarrita, tutta sola fra gente estranea. Però si fece forza ed uscì fuori dalla stazione, nella grande piazza. Luigi era già pronto a partire. «Sai» gli disse lei con tono spensierato, «è la prima volta che vado su una vespa.» «Non aver paura. Tieniti stretta a me» le raccomandò Luigi. E partirono. La posizione scomoda a causa della valigia che Cristina teneva stretta fra sé e il cugino, e il viaggiare nel traffico della città impedì loro di parlare. Lo sconforto la riprese: neanche tutto il movimento delle strade, così nuovo per lei, la poté distrarre. Quella sera, quando infine andarono tutti a letto, pianse silenziosamente sotto le coperte. E tardò molto a prendere sonno. Anche Luigi, sulla sua branda in cucina, non riusciva ad addormentarsi. Ripensava all’incontro con Cristina, del pomeriggio. L’aveva riconosciuta subito, mentre scendeva dal treno, anche se prima non aveva visto di lei che una vecchia fotografia da bambina. Se l’aspettava più bassa. Era invece 99 abbastanza alta. Lo aveva colpito una certa parvenza di eleganza che irradiava da sua cugina, benché il vestito che indossava fosse vecchio, e niente affatto elegante: era il modo con cui lo portava, pensò, a darle quell’aria. Notò che portava delle calze di nylon che davano alle caviglie un colore bruno-rossiccio di sicuro effetto per occhi maschili. Peccato che avesse delle scarpe vecchie senza tacco, dalla forma infantile, altrimenti le si potevano dare anche tre o quattro anni in più di quanti ne aveva. Un’altra impressione che lo aveva colpito era stato il bacio di Cristina sulle gote. E gli aveva tolto il desiderio che aveva nutrito in precedenza di mostrarsi indifferente e superiore con la cugina. La pelle di Cristina era liscia, molto liscia. La carne, ai bracci dove l’aveva stretta, aveva ceduto sotto le sue mani tenera e morbida. Questi contatti, insieme allo sguardo sperso della ragazza, avevano commosso Luigi che cercò di essere gentile con lei. Le prese la valigia e le indicò l’uscita, avviandosi per primo. All’uscita sulla piazza Cristina era rimasta indietro di qualche passo, ma quando aveva visto che lui la stava aspettando aveva affrettato il passo. E aveva detto la prima cosa che le era venuta in mente per nascondere gli occhi pieni di lacrime. IV La mattina dopo Cristina si alzò di buona volontà, appena sentì che sua zia stava facendo altrettanto nell’altra stanza. Erano due ore che era sveglia. L’aveva svegliata suo zio Giuseppe inciampando nella sponda del letto, mentre passava per la camera al buio, per andare a lavorare. Dopo non era riuscita a riprender sonno per l’ansia di tutti quei cambiamenti. Nei giorni che seguirono il passare e ripassare di suo zio in camera quando lei dormiva non le dette più quella noia come all’inizio, anche se 100 dopo qualche tempo suo zio prese l’abitudine di accendere la luce quando passava. Cristina dunque si alzò con la buona volontà di mettersi subito a lavorare, ma non sapeva cosa fare, così, in casa d’altri. Rifece il suo letto con sveltezza accanita; però, alla fine, si mise da una parte con le mani in mano. Poi spazzò la sua camera e la cucina. E si rifermò. Intanto sua zia le chiedeva senza grande interesse di questo o di quello, al paese. Infine, dopo che ebbero fatto colazione con un caffellatte, si misero a lavorare. Il loro lavoro consisteva nel togliere con delle pinzette i pezzetti di filo estranei che rimangono impigliati nella trama delle pezze. Facevano scivolare in tutta la sua larghezza la pezza, ancora da rifinire sopra la tavola di cucina rialzata con due zeppe da un lato. Era un lavoro semplicissimo e svelto. Guadagnavano dalle cinque alle settecento lire per pezza; però dovevano andare a prendere le pezze alla fabbrica e riportarle dopo averle lavorate. A Carmela questo servizio lo faceva un giovanotto con un carretto a mano, che le prendeva cento lire ogni pezza. Così il guadagno diminuiva di altrettanto. Per Carmela e per le altre donne che facevano il suo mestiere, questo lavoro aveva il vantaggio che nello stesso tempo potevano stare a casa e sbrigare tutte le altre faccende. Cristina, che si aspettava di andare a lavorare in grandi fabbriche dalle grandi macchine rumorose, rimase delusa di quel lavoro nella quiete noiosa della cucina, con la compagnia poco attraente di sua zia, un tipo taciturno, continuamente rosa, sembrava, da pensieri spiacevoli. Al pomeriggio però, o alla mattina, a seconda del turno in cui lavorava, Luigi le teneva compagnia mentre lei spuntiva le pezze. La ragazza si era accorta che suo cugino restava in casa proprio per lei dalla sorpresa di Carmela, che non era certamente abituata ad avere il figlio intorno continuamente. Cristina fu contenta del suo interessamento, che le rischiarava l’animo e le 101 dava quel calore di affetti che aveva perduto da così poco tempo. Piano piano, quasi inconsciamente, cercò di favorire quell’interessamento e di goderne timidamente. In fondo era inevitabile che nascesse in lei quel sentimento. Non aveva rapporti con altri all’infuori dei suoi zii e di suo cugino. La sua venuta a Prato infatti non era stata, fino a quel momento, l’ingresso nel mondo che si era aspettata. Cristina sapeva che quell’isolamento era solo una cosa momentanea, dei primi tempi. Di lì a poco sarebbe andata senz’altro a lavorare in una fabbrica, lo sapeva e lo desiderava. Ma per il momento doveva vivere e lavorare in quella grande cucina, e non si lamentava. Anzi lavorava con voglia. Fu lei a chiedere a sua zia di farle fare, oltre a spuntire le pezze, tanti lavori di casa: rigovernare, spazzare, lavare. Essere continuamente occupata le faceva passare il tempo più alla svelta. Carmela, dal canto suo, le cedette volentieri quelle incombenze. Da qualche tempo non era più lei: prima così attiva, sveglia e interessata alla sua famiglia; ora invece torpida e insolente in tutte le cose. Erano già due o tre mesi che era cominciato quel periodo triste della sua vita. E ancora non si era ripresa, adattata al nuovo ritmo. Anche suo marito si era accorto del suo travaglio e, invece di aiutarla, si era sentito come offeso e defraudato. Una notte, durante uno stanco amplesso, le aveva chiesto quasi con rabbia: « Ma sei donna? Chi ho io?» Quella frase la perseguitò non poco con le sue ripetizioni affannose. L’egoismo di suo marito le era familiare, ormai. Se fosse stata più cosciente di sé, avrebbe capito che si era prostrata tanto per l’inizio della menopausa proprio a causa della pretesa di Giuseppe, instillata in lei nel corso di tanti anni, di sentirsi uomo solo cercando l’amore in maniera cattiva. Giuseppe comunque era fatto così. Di tutte le cose del mondo, e non solo delle cose, ma anche delle persone, aveva qualche attenzione solo quando rappresentavano per lui un interesse 102 egoistico. Il suo carattere lo avrebbe portato ad essere dispotico in famiglia, se, congiunto al suo egoismo, avesse avuto una certa fermezza e forza di volontà. Invece era un pusillanime, una piccola anima vigliacca. In famiglia la volontà che contava era quella di Luigi, da quando era diventato un giovanotto formato. E lui, Giuseppe, ne era più o meno cosciente, e irritato. Una sera sua moglie gli disse con fare scherzoso: « Hai visto che da quando è arrivata Cristina, Luigi non esce più di casa?» Giuseppe si sentì come toccato personalmente dal fatto. Forse quella rivelazione di sua moglie fece nascere in lui una specie di rivalità con il figlio, o forse, semplicemente, quello fu lo spunto da cui cominciò il suo interesse per la nipote. Fatto sta che cominciò ad osservare Cristina mentre lavorava o sfaccendava in cucina. Quella vista gli dava un piacere sempre maggiore. Cristina era una donna già fatta: aveva un ventre largo e invitante; la congiunzione delle cosce al corpo doveva essere perfetta, lo si indovinava sotto la vestaglia con cui lavorava; e il giro del sedere e del pube, dal profilo così rotondo, pareva un fiore sugoso da abbracciare e stringere violentemente. Aveva, dietro gli orecchi e alla base della nuca, certi ciuffetti di capelli fini e biondicci che non rientravano nella pettinatura, ma stavano per conto loro, a carezzare la pelle liscia e diafana del collo. Era proprio il collo, ancor più del ventre o delle cosce o dei seni, che faceva in Giuseppe un effetto di libidine irrefrenabile. Fu allora che prese l’abitudine di accendere la luce, passando per la camera di Cristina la mattina alle cinque, per guardarla mentre dormiva. In quelle occasioni stava minuti interi al capezzale del letto, col fiato sospeso, gli orecchi tesi a carpire il minimo rumore e gli occhi fissi a bearsi del corpo di Cristina che si modellava sotto le coperte. Una di quelle mattine ebbe la ventura di trovare Cristina che si era scoperta fino a metà del busto, nel sonno. Le coperte 103 erano inclinate verso terra, da una parte. Giuseppe stette cinque lunghi minuti fermo, affannato, a fissare la ragazza che dormiva, ignara su un fianco. Poi non resisté più. Prese il lembo della coperta e lo tirò giù piano piano, finché il corpo addormentato non gli si offrì tutto alla vista. Nel sonno le cosce si erano svincolate dalla fasciatura della camicia da notte ed ora giacevano lì, piegate su una parte, come due tronchi di platano, lisce e odorose. Fra quelle Giuseppe intravedeva, quasi nascoste dalla camicia, le mutandine bianche, così tumide e ombreggiate. Questa visione fu solo un attimo. La tensione e la paura che Cristina si svegliasse lo sopraffecero. Rimise a posto le coperte, spense la luce e uscì. Dopo quella volta, non ebbe più occasione di rivedere Cristina completamente scoperta, fino alla sera in cui successe il fatto. Anzi, per due giorni passò dalla camera di Cristina al buio e in fretta. Gli era sembrato, quando l’aveva ricoperta quella mattina, che sua nipote si fosse mossa e forse svegliata, mentre lui fuggiva. Ma il terzo giorno riprese la sua osservazione. Non poteva farne a meno ormai. Guardare la ragazza così abbandonata, nel grande silenzio prima dell’alba, quando sembrava che non ci fosse anima viva all’intorno, era per lui come possederne il corpo. E il desiderio aumentava. Cristina, quella mattina si era svegliata davvero, ma non si era resa conto di quanto era successo. Aveva visto che la luce era accesa; e mentre questa si spengeva, aveva sentito Giuseppe uscire di camera e richiudere la porta, nient’altro. La ragazza però non dette importanza al fatto. Credette che suo zio avesse semplicemente acceso la luce per attraversare la stanza, come doveva sicuramente fare prima, quando lì dormiva Luigi. Aveva notato, sì, le occhiate profonde di suo zio, mentre lei lavorava in cucina. Il loro significato le si era affacciato alla mente, ma lo aveva respinto come incredibile in una persona anziana, e in più suo zio. Invece aveva riconosciuto e accettato 104 l’interesse di Luigi per lei: era un’altra storia, erano giovani, era naturale. Ed era anche nei suoi sentimenti. V Un pomeriggio Luigi raccontò a Cristina un intero film che aveva visto qualche tempo prima: un’allegra commedia sulla quale risero di gusto. Quando ebbe finito, in un momento in cui sua madre era andata nell’altra stanza, le propose: «Perché non andiamo al cinema, domani? Ti porto in un locale dove danno un film simile a questo. Ti divertirai.» Finalmente l’aveva detto. Erano diversi giorni che pensava di fare quell’invito. Aveva cominciato a interessarsi a Cristina più per compassione che per altro: la ragazza si doveva sentire molto sola e lui si era fatto un obbligo di tenerle compagnia. Poi, piano piano, la faccia curiosa di lei che lo ascoltava mentre parlava e il suo riso mai libero del tutto lo affascinarono e lui cominciò a dubitare che quella compassione fosse qualche cosa del tutto diversa. Non si sarebbe mai stancato di stare ad ascoltarla, quando era lei che raccontava dei fatti paesani, con una compenetrazione e un senso di importanza che lo meravigliavano e nello stesso tempo gli piacevano. «Questa storia» diceva lei, «l’ho sentito raccontare al mio paese. Successe anni fa. Una ragazza era fidanzata con un giovanotto, un tipo poco serio, che era figlio del fornaio e perciò si faceva grande con le donne; perché si sentiva uno in vista in paese. Un giorno la ragazza….» Qui aveva fatto una sosta. Aveva cominciato senza riflettere ed ora non poteva troncare a quel punto. Così continuò: «Un giorno quella povera ragazza si accorse che aspettava un bambino. Andò dal fidanzato e glielo 105 disse piangendo. Ma quello le disse con cattiveria : “E io che ho a che fare con te?” La ragazza cercò d’insistere fra i singhiozzi, ma quello la cacciò via. Lei smise di piangere. A casa prese un coltello e si nascose dietro l’angolo della chiesa, in piazza. Sulla sera, lo sapeva, doveva passare di lì il suo fidanzato; e aspettò. Quando lui arrivò insieme ad alcuni suoi amici, lei si fece avanti e gli disse:”Allora, mi sposi?” Ma il fidanzato la schernì e ne rise davanti ai suoi amici. Si era così condannato da sé. La ragazza tirò fuori il coltello e dette cinque colpi: due al ventre e tre alla gola. Infine gli amici, sbalorditi, riuscirono a fermarla. Accorse tutto il paese; e anche i fratelli della ragazza, che l’abbracciarono e la difesero, perché aveva riconquistato il suo onore e quello della famiglia.» Luigi ascoltava con piacere sua cugina quando raccontava simili storie di vendette e gelosie. Era un mondo differente da quello a lui familiare, un mondo in fondo felice, nonostante le azioni sanguinose che il più delle volte ne erano oggetto. Luigi si rendeva conto che tali fatti in realtà, si dovevano essere svolti ben diversamente e che Cristina gli riferiva vecchie tradizioni di cantastorie che dovevano essere ancora vive in Basilicata. Ma proprio per questo gli piaceva ascoltarla, non per udire dei fatti successi da tanto tempo, ma per sentir vivere quel mondo in lei, nella sua voce, nei suoi gesti, nel suo dialetto lucano corretto un po’ dall’italiano appreso a scuola e rinforzato negli ultimi giorni a Prato. Luigi voleva bene a Cristina proprio per questo, perché era la testimonianza viva di un mondo che era anche il suo, della sua infanzia almeno, di un mondo di sentimenti sempre schietti e violenti e non immiseriti dalle parole, dai soldi o dal fatto di essere nato in un posto piuttosto che in un altro. Cristina eliminava quell’ostacolo che Luigi incontrava nell’avvicinarsi a una ragazza, gli evitava il disagio inconfessato delle sue origini meridionale. E aveva cominciato a volerle bene anche per questa ragione. 106 Ora, dopo più di due settimane, aveva cercato l’occasione per invitarla ad uscire con lui, perché desiderava stare con lei, solo, fuori dalle mura uggiose di quella cucina. Aveva studiato il momento; e finalmente aveva fatto la sua proposta. Si sentiva più leggero ora. Cristina lo ringraziò dell’invito, abbassando gli occhi sulla pezza, ma rispose di no. Luigi però era preparato al rifiuto e insistette: «Vieni. Sono due settimane che sei sempre chiusa in casa, ti farà bene svagarti un po’.» «Non posso» sussurrò lei pianissimo, «non sta bene». E si fece rossa per quanto aveva fatto capire con le sue parole. «Cosa c’è di male se due cugini vanno al cinema insieme? E poi nessuno lo nota, qui in città. Ti prego!» Cristina rimase zitta a testa bassa. Luigi allora si appellò a sua madre che stava rientrando in quel momento. «Vero, mamma, che non c’è niente di male se la porto al cinema, domani? Sono venti giorni che è qui e sarà uscita due volte da questa casa: le farà bene.» «Ma sì, vai.» rispose Carmela direttamente a sua nipote, dopo averla guardata un momento. «Qui non è come da noi, dove tutti chiacchierano per delle sciocchezze. E poi, esci con tuo cugino, mica con un estraneo. Anzi, Luigi, portala a fare una passeggiata, dopo il film, così vedrà Prato.» Alla ragazza non rimase che dire di sì, e fu felice di dirlo. Da quel momento le sembrò che le ore fossero più lente a passare. L’intera serata non pensò ad altro che al giorno dopo, al cinema ed alla passeggiata che le aveva quasi imposto sua zia. Si preoccupò di quello che avrebbe dovuto indossare: una gonna larga a pieghe ed una maglia quasi nuova, questo era il suo vestito più bello, e l’unico se si escludono altre due gonne e qualche vestaglietta per la casa. Quello che le dispiaceva indossare era una giacca grossa e calda, ma lisa e antiquata. Però 107 non poteva farne a meno: era il solo indumento pesante che possedesse ed era ottobre e faceva fresco. In compenso aveva le calze di nylon, che si sarebbe rimesse per la prima volta dopo il viaggio. Se non le avesse comprate, chissà quanto si sarebbe dispiaciuta ora, ad uscire con Luigi con i calzini bianchi di cotone, come una bambina. Un altro punto dolente erano le scarpe, dalla suola spessa e piatta. “Hanno un aspetto invernale, non disdicono tanto” si consolò lei e non ci pensò più. Cristina era stata al cinematografo solo due volte in vita sua, a Potenza. L’ultima volta era stata due anni prima. Dopo di allora le era nato un altro fratello, malaticcio per di più; la situazione della sua famiglia, già cattiva, era peggiorata e suo padre non aveva avuto più né la voglia né il denaro per fare spese non necessarie. Finalmente si arrivò alla domenica, all’ora di pranzo. Giuseppe notò la fretta di Cristina nello sparecchiare e nel rassettare la cucina e l’aria di attesa impaziente di Luigi. Ne volle sapere la ragione. Quando gliela dissero, ne fu contrariato e si lasciò sfuggire la frase: «Ma come, uscite soli, voi due? Non sta bene.» A quelle parole Cristina si sentì gelare tutta, dentro. Per un attimo smise di spazzare e lanciò uno sguardo implorante a Carmela e poi a Luigi. Questi però non aveva avuto bisogno di appelli per intervenire. «Babbo», chiamandolo alla toscana invece di “papà”, come aveva preso a fare da qualche tempo, in occasioni particolari, «qui non c’è nessuno che maligna. E noi non facciamo niente di male.» La risposta ebbe un certo tono minaccioso per gli orecchi di Giuseppe, che si scoprì a tradurre: “Non c’è nessuno che maligna all’infuori di te; e noi non facciamo niente di male, ma tu…” Giuseppe non rispose; non ne ebbe il coraggio. Il rancore gli salì alla gola, ma lo trattenne. Si gingillò qualche minuto per la 108 cucina, poi prese la porta e uscì. «Sù, Cristina» la incitò Luigi, «fai alla svelta.» La ragazza riprese a spazzare in fretta. Quando ebbe finito, andò in camera sua e si cambiò velocemente, per timore che sorgesse qualche altro ostacolo. Infine, come Dio volle uscirono. All’aperto sia Luigi sia Cristina si sentirono subito calmi e tranquilli. Era una magnifica giornata di ottobre. In cielo non c’era neanche una nuvola, era tutto azzurro e giallo, giallo di sole. Il sole scaldava come d’estate e dava un profondo senso di gioia; faceva entrare voglia di camminare, liberi, a testa alta. «Perché non andiamo a Firenze?» disse Luigi allora, «invece di rinchiudersi in un cinema, con questo tempo.» «Decidi tu» rispose Cristina remissiva. Ma le dispiacque un po’: di belle giornate ne aveva viste tante, mentre di film due soli. Comunque il pensiero di visitare Firenze, una città tanto grande, la attirava. E passato il primo momento sembrò meglio anche a lei. Così andarono a prendere la vespa, al posteggio dove Luigi la lasciava di solito, e con quella si misero sulla strada per Firenze, senza fretta, godendosi la campagna assolata. Luigi si sentiva bene. Gli piaceva andare sulla Vespa con Cristina, che, con un certo imbarazzo, lo teneva abbracciato stretto per paura di cadere. Poteva dirle di usare la maniglia, che c’era, ma preferì tacere e farsi abbracciare. E così se la portò dietro, senza correre, fino a Firenze. Quando vi giunse infilò i lungarni senza passare per il centro e la condusse al Piazzale Michelangelo. La vista magnifica, che da lì si ha di Firenze affascinò Cristina appena vi arrivò. Ma dopo un po’ la folla così varia, che sempre invade il piazzale nelle belle giornate la distrasse. Non aveva mai visto tanta gente così allegra, spensierata, come quella radunata su quella collina per passeggiare, ridere e divertirsi. Che differenza col suo paese! Laggiù la gente era sempre la stessa, la 109 si era trovata nascendo o la si era vista nascere; mai nessuno che venisse da fuori. Cristina si sentì invadere anche lei dalla voglia di passeggiare e di ridere. E lo fecero, lei e Luigi. Su e giù per i viali e le scalinate, fra giardini, aiole e siepi di bosso. Luigi, dopo una mezz’ora, comprò due gelati e gliene dette uno. La ragazza si sentì felice, completamente felice, non per il gelato o per qualcos’altro di particolare, ma perché era in compagnia, all’aria aperta e perché stava bene in un posto dove tutti erano contenti e pareva avessero tutto quello che si può desiderare. Infine si stancarono, Luigi disse allora, ridendo a sua cugina: «Vieni andiamo a riposare anche noi, lassù.» Le fece salire una gradinata che portava alla Chiesa di San Miniato al Monte, tutta circondata dal suo cimitero. Sullo spiazzo antistante la facciata del tempio si fermarono. Trovarono una panchina libera e si sedettero. «Perché non entriamo a fare una visita?» chiese Cristina. «Ci entreremo dopo, ora riposati,» rispose Luigi. «Ti piace questo posto? O ti rende triste?» «No, è bello. Anche al paese il cimitero è messo come questo, in discesa. Di là si vede tutta la valle, come da questo posto. Perciò non si diventa tristi: si vede tanto mondo.» «Ti piacerebbe tornare a casa tua?» le domandò allora Luigi. La ragazza non rispose, fece solo un cenno vago col capo. «Vieni spesso a Firenze?» chiese lei a sua volta. Anche Luigi le rispose vagamente con un gesto. «Non ti piace stare a Prato, a casa mia?» insisté lui. «Ti ci trovi male?» «No, sai, i primi giorni, lontano da casa, la nostalgia. E poi….» Si fermò. Luigi la guardò, come per farla continuare. «E poi mi aspettavo di andare a lavorare in fabbrica…» «Si, ma vedi, in fabbrica bisogna conoscere un mestiere, essere pratici di qualche lavoro. Per di più, in questo periodo c’è 110 un po’ di crisi. Se tu avessi già un mestiere troveresti da lavorare anche ora. Bisognerà aspettare fino a dopo le Feste. Con l’anno nuovo il lavoro riprende ed allora ci sarà da lavorare anche per i principianti. Devi aver pazienza, per qualche mese.» Si fermò un minuto. Poi aggiunse: «Lo so, lavorare sempre chiusa in casa…» «Non è solo questo. Se vado a lavorare in fabbrica, riscuoto per conto mio. Così, dopo che vi ho ripagato di tutto, potrebbe avanzarmi del denaro; e mandarlo a casa. Ne hanno tanto bisogno.» «Ma tu lavori già. Ed è giusto che tu debba avere il tuo guadagno. Dirò alla mamma che ti dia quello che ti spetta.» «No, no, per carità» si accalorò Cristina. «E’ già troppo quello che fate per me. Non ho diritto di avere nulla: il mio lavoro non basta certo neanche per ripagarvi del mangiare che mi date. Ti prego non dire nulla.» «Ma che dici? Tu lavori anche troppo; e i tuoi hanno bisogno. L’hai detto tu stessa.» «No, per favore, ti prego: non dire nulla in casa» insisteva Cristina. «Posso aspettare quando troverò un posto in fabbrica; per favore ….» Luigi non seppe dirle di no. «Va bene, non ne parlerò, se ti fa piacere: Ma i tuoi?» «E’ tutta la vita che stiamo così. Possiamo aspettare ancora» A questo punto la ragazza sembrò distrarsi e guardare lontano. Le venne in mente l’estremo grado di miseria della sua famiglia. Il fatto che fosse venuta via era già un sollievo per loro, anche se in casa faceva tutto lei e badava ai fratelli mentre sua madre era nei campi. «Sì» ripeté con un filo di voce, «possiamo aspettare ancora.» Luigi capì il significato sordo di quelle parole e cambiò discorso. «Ti piace questo posto?» chiese. «C’ero già venuto altre volte e mi era piaciuto. Così oggi, quando siamo venuti a Firenze, ho pensato di portarti qui. Piacerà anche a te vedrai.» Si chetò. Era meglio star zitti, si disse. Si girò verso Cristina, guardandola con 111 tenerezza, allungò una mano come per accarezzarle i capelli, ma non lo fece. Poco dopo le domandò con voce nuova: «Cosa ti piacerebbe fare nella vita?» La ragazza lo guardò senza capire. «Piacerebbe anche a te fare l’attrice, o cosa?» «Non so» rispose lei, «non ci ho mai pensato. Ecco, mi piacerebbe essere milionaria e fare del bene a tutti quelli che stanno male e non hanno soldi, come me.» E rise cancellando i ricordi tristi dalla mente. «E tu cosa vorresti fare?» aggiunse. Poi continuò subito: «No, non lo dire. I desideri si realizzano solo se non si confessano. Vieni, entriamo in chiesa: andiamo a pregare perché si avverino.» Così dicendo, si era alzata e aveva teso la mano a Luigi. Lui la prese e la strinse. E tenendosi per la mano entrarono nella chiesa. Entrambi avevano paura, lasciandosi, di non poter riprendersi per mano con una mossa naturale come era stata quella. Così, ognuno per conto suo, cercarono di non dar motivo al distacco. Scesero nella cripta, tenendosi ancora per mano; là però, davanti all’altare, Cristina lasciò la stretta, s’inginocchiò e pregò Dio con tutta l’anima perché le facesse avverare il suo desiderio. Poi pregò anche per il desiderio di Luigi e sperò, in fondo al cuore, di aver pregato due volte per ottenere la stessa grazia. Luigi era rimasto in piedi. Non pregò: era tanto tempo che non lo faceva, ne aveva perso l’abitudine ormai. Però anche lui non poté fare a meno di pensare: “Se ci sei, avverale qualsiasi cosa desideri, se lo merita.” Infine tornarono fuori. Nell’uscire, Luigi tese di nuovo la mano di Cristina, che gli dette la sua. Non si guardavano. Era stato un gesto difficile a farsi, ma erano contenti di averlo fatto; e di toccarsi. Scendendo la scalinata, la ragazza si avvicinò ancora di più a suo cugino e gli disse, piano: «Sai cosa desidero? Come tutte… di essere una buona moglie, avere dei figli e che mio marito ci voglia bene; e lavori; e ci 112 protegga.» Nel dire così, si era fatta rossa, perché gli aveva aperto tutto il suo animo. Luigi non rispose niente. Le aveva solo stretto la mano con forza. E le fece così capire più di quanto potesse dire a parole. Quella sera tornando a Prato, sulla vespa, Cristina lo abbracciava con meno imbarazzo e con più calore. Due giorni dopo, la mattina alle cinque, successe il fattaccio. VI Giuseppe il lunedì mattina, guardando il corpo addormentato di Cristina, provava una specie di risentimento. Quel corpo era suo! Era sempre lì, pronto al suo sguardo, al suo desiderio, steso per accogliere lui. Si sentiva tradito. Lo tormentava la paura che qualcosa gli sfuggisse, beffandolo. Fu proprio questa paura la molla che lo fece muovere, la mattina successiva. Tutto quel giorno si arrovellò col pensiero che suo figlio, pure lui, gli sarebbe passato avanti. Perché era stato così maltrattato da tutto e da tutti nella sua miserabile vita? Per il suo egoismo? Non ci pensò neanche: la sua imbecillità, questa era la colpa di tutto, si disse. Si era ritrovato sempre male perché aveva dato retta alla sua dabbenaggine. Non aveva mai insistito e tenuto duro. Perché era venuto via dal suo paese? Solo perché aveva delle inimicizie, per delle beghe di paese. Ed era fuggito, sì, proprio fuggito, invece di far valere le sue ragioni. La fortuna gli aveva arriso una sola volta: per trovare un posto di lavoro a Prato, un posto pagato bene. Ma anche qui era stato maltrattato, anzi doppiamente maltrattato: odiava quel mestiere, se ne sentiva umiliato minuto per minuto. Non poteva vedere la divisa che indossava, col suo color merda di cavallo diceva, come quella che raccattava per strada. Eppure cosa avrebbe potuto fare? 113 Niente, solo spazzare, come una donna. Ma lui era un uomo: ah, se era un uomo! E non si sarebbe certamente fatto sopravvanzare da suo figlio. Ah, se era un uomo, lui! E quel corpo, il corpo di Cristina, era suo, non lo avrebbe ceduto a nessuno. Questi erano i ragionamenti da pazzo che gli frullarono nella testa quel giorno. La mattina seguente si alzò prima degli altri giorni, si vestì silenziosamente, al buio, e poi stette in ascolto per assicurarsi che sua moglie continuasse a dormire. Infine entrò nella camera di Cristina. Accese la luce. La ragazza dormiva profondamente. Stette un momento in ascolto: il silenzio profondo lo rassicurò. Era sua come sempre a quell’ora: nessuno poteva toccargliela. Stette un minuto a fissarla, ansimante. Poi, con gesti da automa, come in sogno, si sbottonò i pantaloni e sciorinò all’aria il pene indurito. Dapprima lo fregò su una mano di Cristina, poi sulla guancia. Quel contatto gli dette una vertigine. Non capì e non vide più nulla. Alzò le coperte e si sdraiò su Cristina ancora addormentata. Quel peso rantolante che le venne addosso svegliò d’un colpo la ragazza. Nello smarrimento, cominciò a divincolarsi e a gemere: «Che c’è? No, no!» Sentì che lui la cercava, là, al ventre. Lo sentì sibilare: «Stai buona, ti piacerà.» Cristina fu presa dal terrore e mandò fuori un grido che rintronò per tutta la casa: «No!» E gli conficcò le mani ad artiglio nel collo e dette uno strattone con tutta la sua forza. Riuscì a liberarsi. Saltò dal letto e corse verso la cucina. Non fece in tempo ad arrivarci. Luigi, sentito il grido, si era buttato giù dalla branda dove dormiva e si era precipitato nella camera accanto. Poi vide suo padre ancora steso sul letto, con i pantaloni sbottonati e il sesso scoperto. Cristina, accanto a Luigi, aveva cominciato a piangere. Intanto era entrata anche Carmela dalla porta di fronte. Luigi rimase un minuto come inebetito a guardare suo padre. Poi aprì la bocca e atteggiò gli occhi a un grande urlo di rabbia. 114 Ma non uscì un rumore. Fece un gran salto all’indietro. Si buttò sulla tavola di cucina, aprì il cassetto e prese un coltello dalla lama grossa e appuntita. Con quello in pugno rientrò in camera, chinato, pronto alla lotta. «Luigi!» fu il grido di Carmela quando lo vide. Ma lui non la sentì. Guardava suo padre che nel frattempo si era alzato e stava abbottonandosi i pantaloni. «T’ammazzo… T’ammazzo!....» diceva a denti stretti, avanzando lentamente verso di lui. Giuseppe si fece terreo. Gli cominciò a tremare la gola e la mascella. «Che fai?» seppe solo dire. Il figlio non l’ascoltava. Avanzava ansimando. Giuseppe allora cercò di girare lentamente intorno al letto per rifugiarsi in camera sua. Ma Luigi, più svelto, glielo impedì chiudendolo in un angolo della stanza. Giuseppe non aveva scampo. «Ti ammazzo…. Ti ammazzo!…. » ripeteva con voce scura il ragazzo, guardandolo dal basso. Quando gli fu tanto vicino che bastava affondare la lama, Luigi si fermò. Teneva il coltello con la punta rivolta all’insù, pericolosa. Ci fu un minuto di tensione. Infine il ragazzo cadde ginocchioni per terra. Cominciò a tirar coltellate sull’impiantito di mattoni, gridando dalla rabbia e piangendo. Giuseppe scivolò via respirando. Le donne corsero da Luigi. Carmela gli prese il coltello e Cristina gli si inginocchiò accanto, abbracciandolo e piangendoci insieme. Giuseppe sulla soglia della cucina si voltò indietro e fece per dire qualcosa a giustificazione. Poi capì cosa doveva fare: stette zitto e scappò via, fuori di casa. Luigi cessò di gridare e abbracciò con tutta la forza Cristina, che lo accarezzava come per ringraziarlo. Smise anche di piangere e si alzò. Poi sollevò Cristina, che a sua volta cercava di non piangere senza riuscirci. Tenendola per la vita la portò in cucina e la fece sedere sulla branda. Quindi la coprì sulle spalle con una coperta, perché la ragazza era percorsa da brividi 115 profondi che, insieme al singhiozzo, la scuotevano tutta. Infine le sedette vicino, la circondò con i bracci e cercò di consolarla con carezze, baci sulla fronte e parole affettuose. Carmela li aveva seguiti e continuava a guardarli, smarrita. Posò il coltello dentro il cassetto del tavolo e lo richiuse, continuando a mormorare: «Chi lo avrebbe detto? Chi lo avrebbe mai detto?». Stette un minuto a fissare i due giovani; poi si sentì imbarazzata a star lì, davanti a loro, in silenzio, in camicia da notte. Così se ne andò in camera sua per piangere e disperarsi. Cristina scoppiò di nuovo a piangere: «Cosa sarà di me ora?» «Non temere» la consolò Luigi, «ci sono io. Io….io ti voglio bene e ti proteggerò» disse infine. Cristina alzò la testa e lo guardò negli occhi. «Oh, Luigi» disse la ragazza semplicemente, fra i singhiozzi; e riprese a piangere. Luigi diventò calmo, stranamente calmo, dopo che le aveva detto che le voleva bene. Ripensò alla domenica precedente quando lei, scendendo la gradinata di San Miniato al Monte, gli aveva parlato del marito che desiderava. Adesso era come se fosse lui quel marito. “Ti proteggerò!” le aveva detto. Abbracciò Cristina con più affetto ed anche con un senso di possesso. Le baciò le gote bagnate. Poi le sfiorò la bocca. La ragazza smise di piangere e di rabbrividire. Si staccò un momento da lui, per guardarlo. E infine le porse lei stessa la bocca assecondandolo. Quel bacio lieve finì in un nuovo scoppio di pianto. «Anch’io, anch’io….» disse la ragazza. «Ma non potremo mai….» Però si accoccolò fra le sue braccia come per riscaldarsi. Quando si fu calmata e smise di piangere, Luigi le disse di andare a vestirsi. Lui fece altrettanto. Dopo poco erano di nuovo riuniti in cucina, tutti e tre. Luigi era assorto e preoccupato ora. Cristina si vergognava come non mai e teneva gli occhi sul pavimento senza alzarli su nessuno e senza parlare. Solo Carmela sembrava si fosse ripresa, non solo 116 dall’abbattimento di quella mattina ma anche, e forse più, da quello degli ultimi tempi. Dopo il pianto e la disperazione, aveva riflettuto con chiaro spirito pratico. «Ora non possiamo tenerla più con noi», disse in tono moderato a suo figlio come se Cristina non ci fosse. «Bisogna che torni al paese.» Ci fu un crollo dentro Cristina. Reclinò la testa sul petto e vide nero davanti a sé. Non pianse, non aveva più lacrime. «Mamma» scattò Luigi, «se c’è qualcuno che deve andar via è lui!» “Lui” aveva detto, non il babbo. «Lui è tuo padre. Lo so che ha sbagliato, che ha fatto una cosa orribile, ma questa è casa sua... Cos’altro possiamo fare? E lei….» Si avvicinò alla ragazza e le posò dolcemente una mano sulla spalla. «Scusalo, Cristina: è stato un momento di pazzia, ma, capisci, non puoi continuare a vivere qui, con noi, sotto lo stesso tetto, per la tua tranquillità, e anche per la nostra.» La nipote assentì con la testa, ma senza alzarla. «No!» si ribellò Luigi. «Cristina non va via. Dovrebbe tornare al paese? E la zia Maria e tutta la sua famiglia? Che cosa penserebbero di Cristina, a vederla tornare così all’improvviso, dopo solo tre settimane?» «Lo so, lo so, ma non può rimanere qui, Luigi, non può! Io ti capisco, so quello che provi, ma non c’è altro da fare.» «Cristina andrà via da questa casa, ma non da Prato. C’è la zia di uno che lavora insieme a me, un’affittacamere, che affitta soltanto a donne. E’ una vecchia zitella sola. E credo che faccia anche da mangiare. Tra poco andrò a sentire.» «E chi pagherà tutte le spese?» «Per ora le pagheremo noi, poi Cristina troverà un lavoro» disse più per convincere se stesso che sua madre. «Tu che ne dici, Cristina?» Per la ragazza, tutto quel parlare dei due sul suo destino era come un sogno, un borbottare di voci lontane. Rispose di sì e 117 aggiunse che lei avrebbe fatto tutto quello che desideravano, ma senza sapere con precisione che cosa le avevano chiesto. Era confusa. Non era solo il tentativo di Giuseppe a turbarla, ma anche il fatto che, senza sua colpa, le conseguenze di quella azione ricascavano tutte addosso a lei. Con quale coraggio si sarebbe ripresentata a casa, dai suoi genitori, dicendo: “Zio Giuseppe ha tentato…, così sono venuta via.” E cos’altro avrebbe potuto dire, se non questo? E poi il suo avvenire? I suoi sogni? Le sue speranze di lavoro e di felicità? Tutte queste domande le si accalcavano nella mente. E c’era Luigi: “Ti proteggerò io” le aveva detto. Ma cosa poteva fare lui? Le aveva confessato il suo amore, ma in quel momento tutto le sembrò diverso. Era colpa sua: lo aveva incoraggiato non c’era dubbio. Ma si sentiva così sola e aveva tanto bisogno dell’affetto di una persona cara, vicina, a cui interessare. Ed ora, ecco, lui le aveva detto di volerle bene. E lei lo aveva baciato. Quel bacio! Tante cose aveva messo in quel bacio: gratitudine, ammirazione, invocazione, paura. E amore? Si domandò se ci si potesse sposare tra cugini. Poi si scosse. Cosa stava pensando? Perché la sua mente, in quel momento di paura, si perdeva dietro a simili cose? Le domande si affollavano e la opprimevano sempre di più. Ma non poteva arrestare quel flusso ininterrotto di pensieri. Cosa stavano dicendo sua zia e Luigi? Cosa avrebbe fatto in quella camera d’affitto, in attesa di trovar lavoro? E come poteva accettare quell’offerta così gravosa per loro, smettendo inoltre di fare quel poco che già faceva? Avrebbe dovuto rifiutare, ma come poteva? Come poteva abbandonare quest’ultima speranza? “Basta” si disse, “basta. Non voglio più pensare a nulla.” «Sì» rispose, «farò qualsiasi cosa vogliate.» Sua zia sollevò diverse obiezioni. Se non trovava lavoro? Quanto tempo avrebbero dovuto mantenerla, senza che lei lavorasse? E lui, Luigi, avrebbe dovuto partire per il militare fra 118 tre o quattro mesi, perciò doveva mettere da parte quei pochi soldi che potevano avanzare. Tra parenti bisogna aiutarsi e lei lo aveva fatto volentieri, per sua sorella Maria e per i suoi bambini. Ma ora….La marea di voci, pensieri, impressioni sembrava stesse per travolgere la ragazza. Si discusse a lungo. Carmela ragionava col buon senso, sempre egoistico; Luigi col puntiglio del suo sentimento e della promessa fatta. Cristina non ragionava. Il parlare degli altri due scivolava sul suo cervello e passava via, senza che lei potesse fermarlo. La sua tensione crebbe fino al culmine e poi di colpo s’allentò. E la ragazza svenne. Luigi fece appena in tempo a sorreggerla e a tenerla ferma sulla sedia dov’era. Fu solo un attimo, poi si riebbe e si sentì meglio. «Mamma» disse serio Luigi, «Cristina resterà a Prato. E noi le pagheremo la camera fino a quando non troverà un lavoro. La colpa è sua, di lui…. E noi pagheremo.» Aveva pronunciato quelle parole con un tono a cui non c’è replica. Carmela non rispose infatti. Le era tornato in mente la scena di poco prima, col coltello. Forse lei aveva insistito anche troppo, con la sua idea di rimandarla a casa. VII Cercare un lavoro fu un continuo di umiliazioni, figuracce, lunghe attese, rifiuti sprezzanti e talvolta offensivi. Questo fu il compito che si era assunto Luigi. E lo portava avanti con impegno nel tempo libero dal lavoro. Cristina, dal canto suo, faceva il possibile, benché il fatto di non conoscere la città la ostacolasse molto. Andava in qualsiasi posto le indicasse Luigi, attendeva pazientemente e si mostrava docile e sveglia. Ma fu tutto inutile: rifiuti, vaghe promesse, possibilità per il futuro, 119 ottennero solo questo. La situazione dell’industria pratese in quel periodo era effettivamente come l’aveva descritta Luigi. Un certo sentore di crisi inclinava gli operatori piuttosto a licenziare che ad assumere nuovi operai. Il primo che disperò fu proprio Luigi che conosceva più o meno lo stato delle cose. Cristina invece aveva una qualche ingenua fiducia nelle promesse e nei “riprovi a passare la prossima settimana” che certo non mancavano. Ma dopo un mese di quella attesa anche lei era completamente sfiduciata. Aveva passato quel periodo chiusa nella camera d’affitto, quando non era in giro per le fabbriche a cercare un lavoro. E le giornate le erano sembrate lunghe come settimane. Si era confortata nel frattempo con l’amicizia della padrona di casa, che l’aveva presa a ben volere. Era questa una donna grossa e bassa, che si chiamava Lucia di nome e poteva avere più di sessanta anni. Forse perché non aveva parenti prossimi, riversava tutto il suo affetto sulle sue pensionanti, o almeno su quelle di loro che se lo meritavano. Le altre, quelle che non le andavano a genio, dopo il primo mese le sfrattava con una scusa o con un’altra. Fu proprio dopo uno di questi sfratti che Luigi, accompagnato dal suo compagno di lavoro, nipote di quella donna, andò a chiederle se poteva ospitare Cristina. Così la ragazza entrò a far parte delle sue protette più che pensionanti. Ne aveva quattro. Due dormivano in una stessa camera, Cristina e un’altra in due piccole camerette. Lucia, la padrona, dormiva su un sofà in sala da pranzo. Oltre a queste stanze c’erano la cucina e il gabinetto, senza bagno. Lucia alle sue pensionanti passava anche i pranzi che erano sostanziosi la sera, a cena, quando c’erano tutte e quattro le ragazze; a desinare, invece, erano solo lei e Cristina e mangiavano gli avanzi della sera precedente. Essendo rimasta zitella era pignola in certe cose. Era regola generale e rigorosissima che le ragazze non dovessero portare nessuno in casa e tanto meno nelle proprie camere. Con Luigi questa regola 120 dovette essere spezzata. Prima di tutto Lucia era venuta quasi subito a conoscenza di quanto lui facesse per Cristina; poi, era stato lui a venire a cercar la camera e a pagarle il primo mese di affitto; infine era sempre lui che ogni settimana pagava il vitto della ragazza. Così Luigi veniva quasi tutti i giorni a far visita a Cristina, senza che la padrona potesse fare obiezioni. Però dovevano stare in salotto, sotto gli occhi castiganti di Lucia, che si era già predisposta con benevolenza a far la guardiana. Non faceva solo questo. Si era messa anche lei a cercare un lavoro per Cristina e aveva dato incarico alle altre tre pensionanti di fare altrettanto nelle fabbriche dove lavoravano. Per un mese intero tutte queste ricerche dettero un risultato negativo. Finalmente un lavoro fu trovato e proprio per merito di Lucia. Fu all’inizio del secondo mese. Cristina, dopo che Lucia glielo aveva detto, aspettò con ansia Luigi per dargli la notizia. Si sentiva molto legata a lui. In quel mese aveva potuto rendersi conto del suo attaccamento e del suo affetto. Non solo era sempre alla ricerca di un lavoro per lei, non solo le pagava la pensione, ma veniva ogni giorno per vederla e starle vicino. La ragazza sentiva di premere a qualcuno e da ciò era confortata più di qualsiasi speranza di guadagno. Sua zia, da quando aveva lasciato la loro casa, era venuta solo due volte a trovarla e l’aveva trattata freddamente. Cristina sospettò che Carmela la ritenesse responsabile in un modo qualsiasi di quanto era avvenuto. Però non ne aveva fatto parola. Anche Luigi non le rammentò mai quella triste mattina e lei gliene fu grata. Del resto neanche in casa di Giuseppe, fu mai fatto il più piccolo accenno. Sembra che basti non dirle e tutte le cose di questo mondo pare che non esistano più. Giuseppe continuò la sua vita di sempre e sua moglie fece di tutto per fargli credere che non esistesse più neanche il ricordo della sua azione. Luigi e suo padre non si scambiavano una parola e nemmeno uno sguardo. Ma una traccia era rimasta, in Cristina. 121 La ragazza non poteva pensare ai suoi sentimenti per Luigi senza che all’affetto si mescolasse la tentazione di rompere tutti i rapporti col cugino. Lui era stato presente in quel momento di vergogna. Che rispetto e che amore per lei poteva avere? Era meglio non rivederlo più e non riprovare ogni giorno quella vergogna. E poi erano cugini: “Si possono sposare due cugini?” si chiedeva spesso in modo puerile. Non sapeva cosa rispondere e non aveva il coraggio di chiederlo a nessuno. C’erano tante ragioni per le quali i loro sentimenti non dovevano diventare troppo seri. Ma come farlo capire a Luigi che non aveva tanti dubbi e che quel famoso giorno l’aveva difesa come se fosse sua. Era meglio lasciare che le cose andassero avanti per conto loro. Luigi doveva partire per fare il militare fra pochi mesi e allora tutto si sarebbe appianato da sé. Dopotutto non c’era stato fra loro che un bacio, un solo bacio, quella mattina. E nient’altro era successo dopo. Si erano, sì, visti, tutti quei giorni e le domeniche, al pomeriggio, uscivano soli per andare a fare delle passeggiate o per andare al cinema, ma tutto finiva lì. Luigi non aveva mai chiesto altro. E così facendo aveva lasciato la ragazza nell’incertezza, combattuta com’era fra quella ripulsa, l’affetto e il bisogno d’affetto. Cristina faceva nei suoi pensieri una divisione netta tra l’affetto e l’amore. Mentre non negava di provare affetto per Luigi, la parola amore le sembrava troppo grossa se riferita al suo sentimento e anche a quello di Luigi. Comunque aveva una grande fiducia che le cose si sarebbero messe al posto giusto da sole. E aspettò gli eventi. Quello che veramente l’aveva preoccupata in quel mese era il pensiero, il timore, la paura di dover tornare a casa e di non poter più avere l’occasione d’abbandonare quei posti che riteneva ormai come morti. Ma ora, finalmente, si prospettava un lavoro per lei ed era decisa a non perderlo, anche se si era aspettata qualcosa di diverso. Aspettò Luigi con ansia e con un po’ di preoccupazione 122 in fondo al cuore. Non ebbe torto. Quando Luigi arrivò, lo accolse col sorriso sulle labbra. Anche Lucia era sorridente: era merito suo se avevano trovato una sistemazione per quella ragazza così giovane, buona, lavoratrice, che si meritava questo e altro. Fu lei a dirglielo. Avevano trovato un posto e pagavano bene. «Dove, dove?» chiese Luigi. Glielo dissero. Era un posto di cameriera presso una famiglia benestante, una vecchia famiglia di professionisti gente perbene e gentile. Le davano il vitto, l’alloggio e dodicimila lire al mese, per i primi due mesi, quindicimila lire in seguito. «Inoltre» aggiunse Lucia, «quella è una famiglia buona, la conosco. Vedrete quanti regali le faranno: vestiti quasi nuovi, un cappotto, un mucchio di roba. La terranno di conto, come una figlia.» Luigi via via che Lucia parlava si rabbuiava in volto e cercava di non guardare la donna per non offendere il suo entusiasmo. Cristina lo guardava e capiva. «Sapete com’è» concluse in buona fede l’anziana signorina «di questi tempi è difficile trovare una cameriera, le ragazze preferiscono andare in fabbrica. Tutte le cameriere di Prato oggi giorno sono del Meridione.» Fu la goccia che fece traboccare il bicchiere. Luigi la guardò torvo. E disse: «Ci scusi, dobbiamo parlare da soli.» Prese Cristina per un braccio e la condusse in camera di lei. La padrona era stata colta di sorpresa da quella reazione e non seppe fermarli. Quando furono soli in camera, Luigi esclamò: «Tu non andrai a far la serva a nessuno!» «Ma Luigi, ragiona. Io ho bisogno di lavorare. Non si può continuare così.» «Tu non farai la serva; e non andrai a vivere d’avanzi e a vestirti di cose vecchie. Lascia codesto mestiere a chi lo vuole.» «Per te è facile parlare così» rispose con forza Cristina. «Tu hai un mestiere, sei un operaio e hai il tuo lavoro. Ma io cosa ho? 123 Cosa sono? Io ho solo bisogno. E non so fare altro che le faccende di casa. Perciò lasciamelo fare.» Luigi parve sorpreso e quasi sgomento della sua uscita. Allora Cristina disse con voce persuasiva: «Luigi, ho bisogno, capisci? I miei fratelli, i miei genitori hanno bisogno del mio aiuto, anche se non mi dissero nulla quando venni via. Io devo aiutarli. Non posso restare a vostro carico per sempre. Zia Carmela ha ragione; e non voglio che lei abbia qualcosa da ridire contro di me.» «Cristina, tu non pesi a nessuno. Io sono felice di aiutarti e i miei genitori non contano in questo. Lascia perciò che ti aiuti.» E non le dette il tempo di replicare. Uscì subito come spinto da una sua determinazione. Luigi aveva uno di quei caratteri che non fanno seguire le loro azioni a riflessioni soffocanti. Come sentiva e come agiva. Così andò di corsa a vendere la sua vespa. Erano già diversi giorni però che si era deciso a quel passo ed ora era il momento giusto per farlo. C’erano state diverse discussioni fra lui e sua madre a proposito del mantenimento di Cristina. Suo padre, naturalmente, non aveva osato metter bocca su quell’argomento. Ma era stata sufficiente l’ostilità di sua madre, che tuttavia cercava di non urtarlo troppo. Carmela aveva maturato una vera ostilità per Cristina; e neanche il legame con sua sorella poteva farla cambiare d’animo. Così le sue frequenti osservazioni buttate là a caso sulla mancanza di soldi, le sue frecciate velate, i discorsi maligni avevano smussato la volontà di Luigi, che non se la sentiva, ora, di chiedere continuamente soldi per Cristina, o di trattenerli sulle quindicine che riscuoteva. Si era perciò deciso a vendere la vespa, che era sua e ne poteva disporre. Voleva bene a Cristina, si diceva, e non voleva perderla. Al confronto la vespa, che pure aveva per lui un grande valore, era ben piccola cosa. Fece la vendita senza rimpianti e alla svelta. Aveva già preso dei contatti con il compratore. Tornò da Cristina, a piedi, ma con settantamila lire in tasca. Lucia non si aspettava di rivedere il giovanotto per quel 124 giorno. E anche questa volta perse il momento buono per vietargli di andare in camera di Cristina. Del resto, da quanto aveva orecchiato prima alla porta, non c’era nulla da temere e lasciò fare. «Ecco Cristina» cominciò Luigi, «con questi potremo aspettare un altro mese o due, e cercarti un altro lavoro.» E le dette le settantamila lire. «Dove hai preso tutto questo denaro?» chiese la ragazza stupita. «Ho venduto la vespa.» disse lui. «No! Non puoi farlo! La vespa ti è necessaria. Hai fatto tanti sacrifici per comprarla. Non puoi….» «Tu hai bisogno di soldi.» rispose Luigi. «E io voglio aiutarti. Facciamo così: ventimila lire le mandi a casa, ai tuoi genitori. Col resto pagherai la camera e intanto continueremo a cercarti un lavoro, in fabbrica.» «No, Luigi» fece la ragazza pacatamente. «Non posso accettare che tu faccia questi sacrifici per me. Il denaro mettilo da parte: ti servirà per quando sarai militare. Prenderò quel posto di cameriera e aiuterò i miei col mio lavoro.» «Ma capisci che io non voglio vederti fare la serva alla gente. Io ti voglio bene: non lo sopporto!» Nel dire questo aveva afferrato Cristina per le spalle e la scuoteva come per convincerla. «Luigi, Luigi, ma noi non possiamo….» «Stai zitta!» l’interruppe lui e l’abbracciò con forza. «Tu fai parte di me ormai. Sei me. Io ti voglio bene e anche tu me ne vuoi. Aiutando te è come se aiutassi me stesso: non c’è nessuna differenza.» «No, no» ripeteva con voce malferma la ragazza. «Io prenderò quel posto, lo devo prendere.» Ma pensava già ad altro. L’abbraccio di Luigi l’aveva come intorpidita. Si guardarono un minuto negli occhi. Si baciarono. C’era una cosa che doveva 125 essere fatta, matura, voluta dai loro corpi. Cristina ora non aveva nessun dubbio su quanto sentiva. Tutto il lavorio della sua mente in quel mese le sembrò sciocco, senza senso. Tutto era talmente chiaro, ora. Si sdraiò all’indietro sul lettino. Luigi le fu sopra. Lei gli aprì le gambe per accoglierlo e l’abbracciò con amore e con tenerezza. Anche lui fu tenero. “E’ la prima volta per lei” pensò; e lo pensò anche lei. Si concessero l’uno all’altra col sentimento che solo si ha la prima volta che è amore, di dare tutto il proprio corpo, il proprio amore e qualcosa ancora di più, qualcosa di indicibile. «Luigi, Luigi, Luigi» ripeteva lei e lo baciava sugli occhi, sulle guance, sulla bocca, sul mento. Poi, quando lui lasciò perdere la tenerezza, Cristina chiuse gli occhi. E si abbandonarono entrambi al sano istinto del corpo. Dopo un tempo infinito si calmarono e ci fu una pausa di carezze, di ritegno, di pulizia e di riflessioni intime. Infine Cristina lo guardò mormorando: «Dalla prossima settimana comincerò il mio lavoro in quella famiglia.» E lui, guardandola, non poté far altro che assentire con la testa. Anche a Luigi sembrò in quel momento che tutte le sue preoccupazioni e i suoi puntigli svanissero di fronte a quel fatto misterioso, a quella unione di corpi e di anime. E gli parve bello arrendersi al volere di lei, che, secondo l’indole del suo sesso tendeva a dominarlo servendosi dell’amore, com’è giusto che avvenga perché, appunto, avviene. Intanto, fuori dell’uscio, Lucia origliava. Aveva capito quando le cose avevano cominciato ad andare come lei non desiderava. Sapeva cosa stava succedendo in quella camera. Ma non si decideva a intervenire. Cosa poteva mai dire davanti a quella scena, lei? 1961 126
Scarica