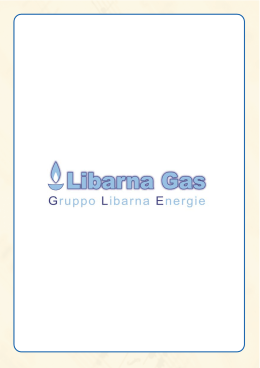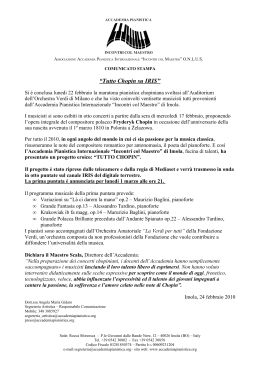Giuseppe Tavanti Il Belcanto al Pianoforte Edizioni Terzo Millennio 1 Indice Premessa pag. 3 L’utopia sonora del pianoforte pag. 4 Il Pianoforte nell’Italia del Melodramma pag. 6 Operisti italiani al Pianoforte: Bellini, Donizetti, Rossini pag. 14 Giuseppe Verdi al Pianoforte pag. 19 Catalani, Franchetti, Cilea pag. 23 Giordano, Mascagni pag. 31 Leoncavallo, Puccini pag. 36 Dal “Lied senza parole” a “L’art du Chant au Piano” Fonti e bibliografia essenziale pag. 47 2 pag. 40 Premessa La pubblicazione de Il Belcanto al Pianoforte giunge al termine di una lunga ricerca, svolta soprattutto dall’angolo visuale dell’esecutore, intorno al repertorio pianistico nato parallelamente all’opera. Un successivo approfondimento ha consentito un ampliamento dell’orizzonte d’indagine: lo stretto rapporto tra letteratura pianistica e repertorio vocale non si limita infatti al solo ambito operistico, estendendosi anche al Lied e alla musica sacra. A questo riguardo, ci sembra illuminante la consultazione dei quattro fascicoli de L’Art du Chant au Piano di Sigismund Thalberg, contenenti venticinque trascrizioni pianistiche che spaziano dal “Lacrymosa” di Mozart, ai Lieder di Schubert, senza dimenticare la celeberrima “Casta Diva” di Bellini. Se poi si considerano le ragioni culturali, musicali ed estetiche che portarono alla costruzione dei primi pianoforti, possiamo concludere che il nuovo strumento a tastiera realizzato a Firenze da Bartolomeo Cristofori ha condiviso, in un arco temporale di almeno due secoli, un percorso sinergico con la vocalità. Anzi, affermeremo in definitiva che il canto è stato da sempre un vero modello sonoro per il pianoforte. Per meglio delimitare il nostro campo di indagine, divideremo in quattro categorie il repertorio pianistico più strettamente legato al mondo vocale: - Versioni pianistiche, più o meno elaborate dal punto di vista della scrittura strumentale, di brani vocali; - Parafrasi e fantasie, di carattere generalmente virtuosistico, su temi tratti dal repertorio vocale; - Brani originali pianistici la cui scrittura strumentale richiama da vicino il canto accompagnato (es., le Romanze senza parole di Mendelssohn); - Brani originali per pianoforte di autori che nella loro attività compositiva si dedicarono prevalentemente alla musica vocale/operistica; A questo punto, il lettore potrebbe ritenere il termine “belcanto”, da noi utilizzato nel titolo di questo libro, un po’ troppo restrittivo rispetto all’ampiezza dell’argomento affrontato. Si consideri inoltre che il significato di “belcanto” è tutt’ora al centro di dispute storico musicologiche: si dibatte, in vario modo e animatamente, di “tecnica vocale belcantistica”, di “periodo storico del belcanto”, di “autori del belcanto”, ed altro ancora. In realtà, il termine in questione fu usato per la prima volta nell’intestazione di un madrigale di Jacopo da Bologna (XIV sec.), dove si legge: Per cantar forte non si canta bene, ma con soave e dolce melodia si fa bel canto, e ciò vuol dire maestria; Quest’affermazione, che conferma la nota predilezione dei musicisti dell’Ars Nova italiana per la delicata sonorità vocale, ci aiuta a comprendere cosa intendiamo, nel titolo del nostro lavoro, per “belcanto”. In queste pagine osserveremo infatti come il modello estetico musicale racchiuso nell’espressione “bel cantare” (riferito sia al repertorio operistico, cameristico o sacro) abbia influenzato per almeno due secoli la composizione della musica per pianoforte. Concludiamo specificando il carattere divulgativo di questa pubblicazione, che si rivolge a lettori non necessariamente esperti musicologi. Per questa ragione, abbiamo evitato di appesantire la lettura 3 con note in calce, citando solo in bibliografia le fonti di riferimento; ci è sembrato inoltre non opportuno ricorrere ad esempi musicali, che avrebbero messo fuori gioco quei lettori non troppo allenati a muoversi tra i pentagrammi. Anche l’antologia di ascolti proposti in allegato a queste pagine vuole essere un ulteriore aiuto, particolarmente prezioso al neofita, alla comprensione dell’argomento. L’utopia sonora del Pianoforte Egli è noto a chiunque gode della musica, che uno de’ principali fonti, da’ quali traggano i periti di quest’arte il segreto di singolarmente dilettar chi ascolta, è il piano, e ‘l forte; o sia nelle proposte, e risposte, o sia quando con artifiziosa degradazione lasciandosi a poco a poco mancar la voce, si ripiglia poi ad un tratto strepitosamente: il quale artifizio è usato frequentemente, ed a meraviglia ne’ grandi concerti di Roma con diletto incredibile di chi gusta la perfezione dell’arte. Ora di questa diversità, ed alterazione di voce, nella quale eccellenti sono tra gli altri strumenti ad arco, affatto privo è il gravicembalo; e sarebbe da chi che sia stata ripetuta una vanissima immaginazione di proporre di fabbricarlo in modo, che avesse questa dote. Con tutto ciò una sì ardita invenzione è stata non meno felicemente pensata, che eseguita in Firenze dal Sig. BARTOLOMEO CRISTOFALI, Padovano, Cembalista stipendiato del Serenissimo Principe di Toscana. Egli ne ha sinora fatti tre della grandezza ordinaria degli altri gravecembali, e son tutti riusciti perfettamente. Il cavare da questi maggiore, o minor suono dipende dalla diversa forza, con cui dal sonatore vengono premuti i tasti, regolando la quale, si viene a sentire non solo il piano, e il forte, ma la degradazione, e diversità della voce, qual sarebbe in un violoncello. Con questo articolo, comparso nel 1711 sul Giornale de’ Letterati d’Italia, Scipione Maffei annunciava l’invenzione di uno strumento a tastiera che superava tutti i limiti espressivi presenti nel vecchio clavicembalo, ossia il moderno pianoforte. Questo era in grado di realizzare, mediante modulazione del tocco dell’esecutore, differenti dinamiche sonore, che non si limitavano alle contrapposizioni tra “forte” e “piano”, ma, alla maniera di un violoncello, potevano anche dar luogo ad effetti di crescendo e diminuendo. Artefice della costruzione dei primi pianoforti, il padovano Bartolomeo Cristofori (per Maffei “Cristofali”), che, secondo i documenti ritrovati dallo studioso Mario Fabbri, aveva cominciato a costruire il primo strumento “du’ anni prima del Giubileo” (quello del 1700), ossia nel 1698. Già nel 1700 si cominciò ad averne notizia negli scritti dell’epoca, dove si accennava all’invenzione di un curioso clavicembalo capace di suonare piano o forte a piacimento. La costruzione del primo pianoforte non era però frutto esclusivo dell’ingegno di Cristofori, che, come ricorda Fabbri, iniziò a lavorare al nuovo strumento non per moto proprio, ma “per volere del Ser.mo Gran Principe Ferdinando”. Negli ambienti culturali del principe Ferdinando si animava da tempo una discussione 4 estetica e musicale, promossa da un gruppo di intellettuali, tra i quali il compositore, organista e poeta Giovanni Maria Casini. In particolare, si argomentava: il come si possa render su gli strumenti il parlar del cuore, ora con delicato tocco d’angelo, ora con violenta irruzione di passioni. Si riteneva che gli strumenti a tastiera del tempo, pur avendo il vantaggio dell’intonazione data dall’accordatura fissa, risultassero in definitiva limitati, non disponendo dell’espressività della voce umana, degli strumenti a fiato e ad arco. Il clavicembalo, macchina pur perfetta, non era considerato all’altezza per esprimere fino in fondo, e con la musica, l’animo umano. Al termine di questi ragionamenti, gli intellettuali fiorentini elaborarono una vera e propria utopia sonora, attuabile solo qualora si fosse stati in grado di costruire uno strumento musicale che avesse i vantaggi di intonazione dell’antico clavicembalo, ma che disponesse in più della capacità espressiva propria della voce umana. Il pianoforte, realizzato da Cristofori, portava in sé quelle innovazioni tecniche che, attraverso due secoli di una letteratura pianistica nobilitata dai Mozart, dai Beethoven, Chopin, Liszt e tutti gli altri, realizzeranno l’utopia sonora degli intellettuali fiorentini. Per semplicità, non ci addentreremo nel dettaglio scientifico tecnologico del pianoforte di Cristofori, ma evidenzieremo solo quelle caratteristiche che determinarono l’affermazione dello strumento. Prima di tutto, il pianoforte produce il suono mediante martelletti, collegati alla tastiera, che percuotono corde tese. La sonorità ottenuta dipende dalla velocità di impatto del martello sulla corda, che è regolata dalle modalità tocco del pianista sulla tastiera. Sul clavicembalo tutto ciò era possibile solo in minima parte, producendo i suoni con un sistema meccanico a corda pizzicata. La possibilità di dosare l’intensità di ogni suono consente al pianista un’espressività melodica assai vicina a quella della voce. L’introduzione di un pedale che sollevi contemporaneamente tutti gli smorzatori, lasciando libere di vibrare tutte le corde, conferirà al suono del pianoforte ulteriore forza espressiva, che sarà determinante per gli autori del romanticismo musicale. Da queste semplici considerazioni si può intuire che le notevoli potenzialità musicali del pianoforte non furono comprese immediatamente dai compositori. Si pensi che i primi brani espressamente destinati all’esecuzione pianistica furono composti dal frate pistoiese Lodovico Giustini nel 1732 (12 Sonate per Cimbalo di piano e forte, detto volgarmente di martelletti, op. 1), ben trent’anni dopo l’invenzione del nuovo strumento. Negli anni che seguirono, i compositori adottarono nelle loro creazioni per tastiera una prudenziale doppia destinazione (“per clavicembalo o pianoforte”). Ciononostante, non mancarono esempi di embrionale scrittura propriamente pianistica funzionale alle potenzialità “vocali” dello strumento: si veda, a riguardo, il Cantabile dalla “Sonata in sol minore W.65/11” di Carl Philipp Emanuel Bach, figlio di Johann Sebastian. Il grande Mozart, che recava dentro di sé la vocazione di compositore operistico di scuola italiana, vide spesso e volentieri nella tastiera del pianoforte la sintesi del suo universo vocale. I brani pianistici mozartiani che richiamano da vicino il canto sono innumerevoli, e il lettore non faticherà a riconoscerli. Noi citeremo, come esempio paradigmatico, l’Andante dal concerto per pianoforte ed orchestra Kv. 488, che tradisce quella struggente espressività tipica di alcune pagine delle coeve Nozze di Figaro. 5 Pianoforte costruito nel 1720 da Bartolomeo Cristofori 6 Il Pianoforte nell’Italia del Melodramma Per ben due secoli, da Pergolesi a Puccini, l’Italia musicale rivolse principalmente le sue attenzioni al melodramma, a coronamento di un percorso culturale iniziato fin dal crepuscolo del Rinascimento. Il sogno di ricreare i fasti della tragedia greca, idealizzata come arte totale e riproposta dalla “Camerata dei Bardi”, si era dapprima concretizzato in spettacoli rivolti ad una ristretta cerca di intellettuali. La nascente imprenditoria teatrale fece poi il resto: l’opera divenne un vero proprio business, che coinvolse a tempo pieno impresari, scenografi, interpreti e compositori. Al contrario dell’Italia, altri paesi europei, pur accogliendo nei propri teatri il meglio della produzione operistica, svilupparono parallelamente un forte interesse per la musica strumentale, in primis quella pianistica. Non ci stupiremo quindi se, dopo Cristofori, i più importanti costruttori di pianoforti trovarono fortuna presso quelle nazioni che maggiormente valorizzarono, a livello di movimento musicale, il nuovo strumento: Francia, Germania, Austria e Inghilterra. Nonostante ciò, colui che è ritenuto dai più il primo grande pianista della storia fu proprio un italiano, che visse però praticamente tutta la vita in Inghilterra: Muzio Clementi (1752 – 1832). Pur ammettendo che indagini storiche recenti hanno accertato che è inesatto attribuire la palma del primo pianista a Clementi, tuttavia non esitiamo ad affermare che egli, con le sue numerose composizioni e raccolte didattiche, su tutte i 100 studi del Gradus ad Parnassum, ha fondato i canoni principali della tecnica pianistica moderna. Per questo, nella lapide celebrativa posta sulla sua tomba a Westminster, viene definito con enfasi “Padre del Pianoforte”. Muzio Clementi cominciò a far parlare di sé dopo la leggendaria disfida pianistica che ebbe luogo il 24 dicembre 1781 alla corte di Vienna e che lo vide contrapposto all’idolo musicale locale, Wolfgang Amadeus Mozart. Il pubblico che assisté al memorabile evento poteva vantare le credenziali del più elevato rango: oltre all’imperatore Giuseppe II, che personalmente aveva invitato Clementi a corte, erano presenti il granduca di Russia, futuro zar Paolo I, e la granduchessa, sua promessa sposa nonché musicista dilettante, allieva di Paisiello. Il pianista italiano descrive così il suo incontro con Mozart: Dopo pochi giorni che ero a Vienna, venni invitato dall’imperatore a suonare per lui sul fortepiano. Appena entrato nella sala di musica, vi trovai un tale che per l'elegante aspetto pensai fosse un camerlengo dell’imperatore; ma, appena attaccato discorso, passò subito a questioni musicali e ci riconoscemmo come colleghi, salutandoci cordialmente. Mozart scrive così al padre: L’imperatore stabilì che avrebbe suonato per primo lui. La Santa Chiesa Cattolica! Disse, perché Clementi è romano. Egli preludiò ed eseguì una sonata. Allora l’imperatore mi disse: avanti a te! Preludiai a mia volta e suonai delle variazioni; la principessa tirò fuori delle sonate di Paisiello delle quali io dovetti suonare gli allegri e lui i rondò. Quindi ne prendemmo un tema e lo sviluppammo a due pianoforti. La cosa buffa fu che sebbene io avessi scelto il pianoforte della Contessa Thun, suonavo su quello soltanto quando ero solo; l’altro strumento era stonato e tre tasti fuori uso - ma tale era il 7 desiderio dell’Imperatore che disse : “Non importa”conoscendo la mia abilità e la mia conoscenza della musica e volendo mostrare particolare cortesia verso uno straniero. Clementi non mancò di apprezzare il genio di Mozart: Non ho mai udito fino ad oggi suonare in maniera così intelligente e aggraziata. Più di tutto mi hanno impressionato un adagio e molte delle variazioni da lui improvvisate, il cui tema, scelto dall’Imperatore, dovevamo variare a turno, mentre l’altro accompagnava. Mozart non ricambiò i complimenti del collega. Il 12 gennaio 1782, scrisse così al padre: Clementi suona bene, specialmente per quanto riguarda la mano destra. La sua maggiore abilità consiste nei passaggi di terze. A parte questo, egli vale, come gusto e sentimento, meno di un kreuzer - in breve egli è semplicemente un tecnico. In una lettera successiva, rincarò la dose, affermando: Facendo l’ipotesi che si possano suonare seste e ottave alla massima velocità (il che nessuno può fare, nemmeno Clementi) si produce un effetto tremendamente confuso e niente altro. Clementi è un ciarlattano come tutti gli italiani. Scrive Presto su una Sonata o anche Prestissimo e Alla breve, e suona Allegro in quattro movimenti. Lo so di sicuro perché l’ho sentito fare così. Spieghiamo, ai lettori che non abbiamo dimestichezza con la tecnica pianistica, che Mozart, con queste affermazioni, accusa il rivale di servirsi smodatamente di passaggi sovraccarichi di note eseguite alla massima velocità, cosa fino a quel momento inusuale e contraria a quanto raccomandato dai maestri clavicembalisti. La critica, pur tendenzialmente malevola, è in realtà motivata dall’atteggiamento tradizionalista del grande compositore salisburghese, che riconosce così implicitamente a Clementi una modernità tecnica ed espressiva a lui sconosciute. Al di là delle parole, Mozart rimase fortemente impressionato dall’esecuzione dell’italiano, prova ne è la somiglianza tra il tema della Sonata in Si bemolle op. 24 n°2 che Clementi eseguì in occasione della disfida, e il motivo principale dell’Ouverture del Flauto magico, scritto dal salisburghese dieci anni dopo. Questo plagio, abbastanza palese, non sfuggì a Muzio Clementi, che nelle successive edizioni a stampa della sua sonata aggiunse una nota dove specificava che essa era stata scritta un decennio prima del capolavoro mozartiano. Romano di nascita, Clementi cercò fortuna in Inghilterra, dove, oltre che come ottimo esecutore e compositore, si affermò anche quale editore, stimato anche da Beethoven, e costruttore di pianoforti. Nell’Italia di quei tempi, invece, il pianoforte stentava a farsi largo nel panorama musicale e a prevalere sull’antico clavicembalo, per cui ben poco spazio avrebbero trovato i grandi spiriti innovatori come Muzio Clementi. Come testimonia nella sua autobiografia Le mie memorie artistiche l’operista Giovanni Pacini (Catania, 17 febbraio 1796 – Pescia, 6 dicembre 1867), fraterno amico di Gioachino Rossini, nel primo decennio dell’800 i suoi studi strumentali a Bologna si rivolsero esclusivamente al clavicembalo, in quanto, in quella pur prestigiosa città musicale, i pianoforti erano rarissimi. Negli anni immediatamente successivi, saranno i dominatori stranieri di un’Italia ancora divisa e ben lontana dall’unificazione nazionale a proporre anche da noi un uso corrente, sia a livello didattico che concertistico, del pianoforte. All’indomani dell’occupazione napoleonica, Lucca, città da sempre votata alla tradizione organistica liturgica, si trovò nella necessità di adeguarsi alla nuova moda musicale parigina, che elevava il pianoforte a principe dell’intrattenimento salottiero. Buon per Domenico Puccini (nonno del più celebre Giacomo), la cui madre, Caterina Tesei, vantava studi pianistici in quel di 8 Bologna, rara avis in un’Italia ancora decisamente “clavicembalistica”, e ancor più rara in una famiglia che sfornava da generazioni i migliori organisti della città. Domenico divenne ben presto insegnante di pianoforte stimato ed apprezzato, un personaggio à la page che aveva cavalcato a suo vantaggio l’ascesa al potere della famiglia Baciocchi. Anche la prima scuola pianistica italiana, che sorse a Milano alla fine del XVIII secolo, ebbe impulso da suggestioni straniere. Il suo capostipite, Francesco Pollini, aveva studiato a Vienna, traendo grande insegnamento dall’arte pianistica di Mozart, dal quale si ipotizza avesse ricevuto qualche lezione. Stabilitosi a Milano, operò come pianista e didatta fino alla morte, avvenuta nel 1846 (era nato a Lubiana nel 1763). Il prestigio del caposcuola milanese era accresciuto dal fatto che Pollini oltre che con Mozart, aveva avuto contatti anche con Clementi, che soggiornò a Milano per buona parte del 1808. Con queste nobili premesse, Antonio Angeleri, allievo del Pollini, portò avanti nel migliore dei modi le sorti della scuola pianistica meneghina. Il nome di Angeleri, che fu titolare di una prestigiosa cattedra di pianoforte dal 1826 al 1870, è oggi legato indissolubilmente ad uno spiacevole “incidente di percorso”, che lo condannò per sempre di fronte al tribunale della Storia della Musica. Fu l’Angeleri, infatti, a determinare la solenne bocciatura di Giuseppe Verdi nel famigerato esame di ammissione al Conservatorio di Milano. Il severo maestro riscontrò nel giovane diciottenne molti difetti tecnici, emersi soprattutto in una maldestra esecuzione del Capriccio in la minore di Herz. Difetti, a suo dire, “incorreggibili”, vista anche la “scorretta posizione della mano”, evidente risultato di studi svolti sommariamente in provincia presso maestri poco qualificati. Insegnante severo, onesto, ma poco dotato di elasticità e lungimiranza, l’Angeleri fu autore di un trattato sulla tecnica pianistica (Il Pianoforte. Posizione delle mani. Modo di suonare), pubblicato nel 1872, ove esponeva una didattica che già allora era considerata superata almeno da un paio di decenni. Quindi, un po’ per il coraggioso operato di alcuni pionieri della cultura pianistica, ma anche per la diffusa tendenza a seguire le mode imposte da Parigi, Londra e Vienna, il pianoforte cominciò a godere di una certa considerazione anche nella quotidianità musicale dell’Italia del periodo d’oro del melodramma. Ma come ogni novità, anche il nuovo strumento ebbe i suoi detrattori, soprattutto tra coloro che non amavano per partito preso lo spirito dei tempi moderni. Al pari del treno e di altre innovazioni tecnologiche, il pianoforte fu visto con grande sospetto da Rossini, che considerava ancora il clavicembalo come l’amico inseparabile dei maestri di canto. Nonostante le pur autorevoli critiche, il pianoforte cominciò a divenire uno strumento popolare e di uso normale nelle varie riunioni musicali della borghesia italiana. Per farsi un’idea dei contesti nei quali avvenivano le esibizioni dei pianisti della prima metà dell’800, occorre premettere che i concerti propriamente detti erano ben lungi dall’essere una consuetudine. Molto più diffuse erano le “accademie”, esibizioni musicali a carattere locale e cittadino, ove cantanti e strumentisti davano vita a programmi musicali pantagruelici, compilati tenendo presente la varietà e la notorietà dei brani proposti come unico criterio estetico, nel timore di annoiare un pubblico, spesso poco numeroso e nemmeno troppo competente. Nelle accademie si esibivano dilettanti, mestieranti del luogo, ma anche giovani talentuosi, destinati ad una sicura carriera. Con modalità musicali analoghe, seppur in contesti culturalmente e socialmente più elevati, si svolgevano le serate nei salotti dell’alta società. La qualità della musica che veniva eseguita per gli invitati era direttamente proporzionale al prestigio del padrone di casa, animatore della serata. Tra i molti sodalizi del genere presenti in Italia, ricorderemo il salotto milanese di Clara Maffei, che si impose sia per l’eccellenza dei partecipanti, sia per l’intensa attività protrattasi per tutto l’arco, e anche oltre, del periodo risorgimentale. In Italia erano attivi molti altri salotti culturali e musicali, che operavano praticamente in tutte le maggiori città. Ricorderemo tra essi due che suscitano, per motivi diversi, un particolare interesse: quello pistoiese di Louisa Grace Bartolini, geniale, 9 vulcanica ed eclettica figura femminile, pittrice assai pregevole, scrittrice di talento e musicista versatile, apprezzata sinceramente da Carducci; quello di casa Ducci a Firenze, nella quale il suo animatore, Carlo, pianista di grandi capacità, fu protagonista di numerosi pionieristici concerti strumentali. La presenza del pianista nei salotti dell’alta società divenne una vera e propria moda, una specie di accessorio irrinunciabile per la riuscita di una serata. L’inflazione di esibizioni pianistiche, spesso non all’altezza della situazione, incoraggiarono i soliti maligni a ironizzare sulle tipologie di esecutori, o presunti tali, che si presentavano incautamente al cospetto dell’uditorio. In certa stampa umoristica dell’epoca, si giunse a classificare i pianisti per generi scientificamente definiti, distinguendo tra “leonini dominatori della tastiera”, “languidi poeti”, “ciarlatani impostori”, “pianisti dei tempi che furono”, “ardimentosi dilettanti”, ed altri ancora e di più bizzarri. Immancabile era la figura del “pianista polacco”, sedicente allievo o amico di Chopin, e pertanto depositario degli ultimi sospiri pianistici dello sfortunato Fryderyk. La presenza di un personaggio siffatto era l’occasione per scatenare il delirio sentimentale delle signore presenti in salotto, cui faceva eco il sarcasmo degli uomini, la maggior parte dei quali nutriva seri dubbi sia sulla reale qualità dell’esecuzione che sulla effettiva provenienza polacca dell’individuo. Di queste nostalgie del salotto musicale di Chopin troviamo una testimonianza postuma nella Fedora di Giordano, con la fugace apparizione di Boleslao Lazinski, stereotipata caricatura del pianista polacco, epigono dell’arte del grande Fryderyk. In terra italiana, molto più rari, rispetto alle accademie ed agli eventi musicali salottieri, erano i concerti pubblici. Nel caso delle esibizioni pianistiche, l’organizzazione dei cosiddetti recital, ossia concerti con un solo strumentista sulla scena, era possibile solo disponendo di un prestigioso, se non leggendario, virtuoso. Solo un interprete di straordinarie capacità avrebbe potuto riscuotere l’apprezzamento del pubblico dei teatri d’opera. Fu così che il Teatro alla Scala di Milano, per tenersi al livello di altri grandi centri musicali europei, ospitò i concerti di alcuni grandi solisti, la cui fama avrebbe richiamato, nelle previsioni degli organizzatori, un pubblico tale da giustificare l’inserimento di un recital strumentale nel tempio del melodramma italiano. Qui Liszt tenne ben tre concerti; il suo acerrimo rivale, Sigismund Thalberg, suonò, invece, una sola volta. Tuttavia, ben prima che Liszt coniasse, in occasione di un concerto a Londra il 9 giugno 1840, il termine recital, troviamo in Italia un esempio, tra i primissimi se non il primo, di concerto solistico pubblico, nell’attuale accezione. Il pianista napoletano Francesco Lanza (1783 – 1862), allievo a Londra di Field e forse anche del di lui maestro Clementi, per ben trentatre anni illustre professore del Conservatorio S. Piero a Majella, tenne un concerto nella sua città, al Teatro dei Fiorentini, il 6 aprile 1804. Cosa eseguivano i pianisti nelle accademia, nei salotti e nei recitals? Nelle accademie e nei salotti privati, dove i programmi proposti al pubblico erano vari ed assai poco organici, era richiesto al pianista eclettismo e versatilità. Egli doveva alternarsi tra la collaborazione con il cantante e il pezzo strumentale d’insieme, oppure il brano a quattro mani. Il pezzo per pianoforte solo, soprattutto nelle accademie, era assai raro. Le composizioni eseguite, per lo più brevi e di facile ascolto, risentivano della diffusa cultura operistica, presentandosi sotto forma di “fantasie”, “variazioni”, “parafrasi”, “reminescenze” su celebri arie. Nei salotti erano assai apprezzate le opere in versione pianistica: a volte, erano gli autori stessi che sottoponevano all’attenzione dei convenuti le parti salienti di lavori che di lì a poco sarebbero andati in scena per la prima volta. Queste versioni “domestiche” delle opere assumono un’importanza storica fondamentale, proponendosi come forma di diffusione e divulgazione mediatica della musica, in un epoca ancora priva di mezzi di riproduzione sonora. In Italia, inoltre, riscuotevano un buon successo i brani composti nel modello del valzer, della mazurca o del notturno di Chopin, vere e proprie miniature pianistiche etichettate, appunto, come “musica da salotto” e composte da Rossini, Donizetti, Verdi, Catalani, Puccini, Giordano, Cilea, Leoncavallo, e molti altri ancora. Nei recitals dei grandi virtuosi del tempo, i 10 programmi eseguiti erano abbastanza diversi da quelli presentati dai concertisti dei giorni nostri. Accanto alle immancabili fantasie operistiche, i pianisti eseguivano, prevalentemente musiche originali di propria creazione, e solo a volte pagine di altri compositori. Franz Liszt, nelle sue apparizioni scaligere, eseguì, cosa assai rara, qualche tempo di sonata di Beethoven. In ogni caso, i pianisti, nei loro recitals, presentavano programmi di qualità musicale e coerenza culturale più elevate rispetto ai citati salotti ed accademie. Seppur in tempi assai meno rapidi che in altre nazioni europee, anche l’Italia del melodramma vide il progressivo affermarsi dei concerti pianistici pubblici, che relegarono gli eventi dei salotti privati ad un ruolo abbastanza marginale. Anche i repertori eseguiti in Italia dai pianisti si affrancarono progressivamente dall’egemonia culturale dell’opera. Dopo l’Unità d’Italia cominciarono a fare la loro comparsa nei programmi di sala anche brani di una certa complessità di ascolto, oltreché esecutiva. A questo riguardo, proponiamo un confronto significativo. Ecco il programma di un concerto tenutosi a Napoli a casa del maestro Fischietti il 13 febbraio 1862: Cerimele: Gran fantasia per P.F. a 4 mani sul Vespro Siciliano, eseguita da’ giovani Coletti e Cirillo, alunni del R. Collegio. Verdi: Romanza dal Ballo in maschera, eseguita dal Sig. G. Ferraro. Fischetti: La preghiera, notturno per violoncello e P. F. eseguito dal Sig. Gennaro Giarritiello e dall’autore. Verdi: I masnadieri, duetto – S. T. eseguito dalla signorina Giuseppina Valenza e dal Sig. Giuseppe Pavesi. Lovreglio: Capriccio fantastico sul Rigoletto, per Flauto e P. F. eseguito dall’Autore e dal Sig. Fischetti. Guercia: Quanto era bello!, romanza per camera cantata dalla signora Carlotta Zavertali. Duetto buffo La patata, cantato dai Sig. Cacciutto e D’Agnese. Pontillo: Andante di Thalberg per P. F. trascritto e variato per clarinetto, ed eseguito dallo stesso Sig. Pontillo. Conti: A Venezia, serenata per M. S. con accompagn. di P. F. e flauto. Rossini: Terzetto del Guglielmo Tell: “Or che la sorte” eseguito dai Sigg. Lorenzo e Gennaro Ferraro e Pavesi. Giarritiello: Capriccio su motivi nazionali per Violoncello e P. F. eseguito dall’autore. Fischetti: La giubba rossa, stornello scritto per la Sig.a Giuseppina Valenza e dalla stessa eseguito. Aria buffa Signorsì avea ragione, cantata dal Sig. Urso. Fischetti: Ricordo di Napoli, melodie popolari scritte e variate per P. F. a 4 mani ed eseguite dalle signorine Luisa e Marietta Bosa. Rossini: Guglielmo Tell, coro del giuramento. Lovreglio: Trio sulla Norma per Flauto, Violoncello e P. F. eseguito dai Sig. Lovreglio, Giarritiello e Fischetti Si tratta di un vero e proprio guazzabuglio di pezzi brevi, assemblati con l’unico scopo di compiacere il pubblico intervenuto, senza impegnarlo troppo intellettivamente. Si presentavano più o meno così le accademie vocali e strumentali italiane dell’epoca. Ed ecco invece un concerto di Beniamino Cesi, tenutosi alla Società del Quartetto di Milano il 26 gennaio 1885: Rameau: Gavotta variata Gluck: Minuetto nell’Orfeo Scarlatti: Due Sonate Beethoven: Gran Sonata op. 106 Schumann: Kreisleriana Schubert-Cesi: Margherita all’arcolaio 11 Thomas: Gavotta Thalberg: Studio in La minore Chopin: Studio in Si maggiore, Polacca in Fa diesis minore Spicca e giganteggia la monumentale Sonata op.106 di Beethoven, che Cesi eseguì per primo in Italia. Notevole è anche la presenza del ciclo Kreisleriana di Schumann, anch’esso un brano di elevata difficoltà. Unica concessione alla vocalità (non italiana, tra l’altro) è il pezzo dall’Orfeo di Gluck, seguito da un lied schubertiano, rielaborato dallo stesso Cesi. 12 La tomba di Clementi a Westminster 13 Operisti italiani al pianoforte Bellini, Donizetti, Rossini In questa parte proporremo considerazioni su alcuni operisti, osservati dalla visuale del loro rapporto con il pianoforte, sia riguardo alla pratica esecutiva che alla produzione strumentale specifica. Nel caso di Vincenzo Bellini, si potrebbe essere tentati di non prendere in esame la scarsa attività compositiva che il musicista catanese dedicò alla tastiera. L’esiguo catalogo si riduce pochissime pagine: il Capriccio per pianoforte, versione pianistica della Sonata per organo, composta ai tempi degli studi presso il Real Collegio di Musica di Napoli; un Largo e Tema in fa minore, il cui materiale melodico venne riutilizzato nell’opera Bianca e Fernando; due frammenti, o meglio “idee musicali”, entrambe in Sol minore, così embrionali da non consentire un’esecuzione fruibile. Il Capriccio è un brano scolastico, dalla strumentalità elementare e che nulla aggiunge alla grandezza riconosciuta dalla storia a Vincenzo Bellini. Il Largo e Tema, pur nella sua essenzialità formale, rappresenta un buon tentativo di pianismo pre chopiniano, anticipazione della struttura melodica e armonica tipiche dei Notturni del grande compositore polacco. Occorre osservare che anche alcune pagine operistiche belliniane, se adattate per l’esecuzione al pianoforte, suonano fatalmente “chopiniane”: il caso più significativo è costituito dalla celebre aria ”Casta Diva”, che, oltre alla mera riduzione per pianoforte (che si può eseguire agevolmente e con buoni risultati), si meritò varie trascrizioni concertistiche, prima fra tutte quella di Sigismund Thalberg. Per cui, si può affermare che il canto belliniano fu fonte di ispirazione per Chopin, che concepì la sua innovativa sonorità pianistica sul modello vocale tipico del compositore catanese. Gli intellettuali romantici conobbero l’arte belliniana, oltreché all’opera, anche nelle riunioni mondane dei salotti parigini, in particolare quello della principessa di Belgiojoso, che il compositore frequentò fino alla morte. Inaugurato nel 1832, all’interno del palazzo del duca De Plaisance, il salotto della Belgiojoso divenne ben presto il luogo di ritrovo culturale più ambìto e affollato della capitale, frequentato dall’alta società, da letterati, pittori e musicisti di grido, e anche da molti italiani, tra i quali non mancavano gli esuli per cause politiche. Fra gli affezionali del salotto della Belgiojoso spiccano i nomi di Heinrich Heine, Fryderyk Chopin, Alfred De Musset, Gioachino Rossini (che Cristina aveva già conosciuto e frequentato a Milano), Franz Liszt. A fine luglio del 1833 fece la sua comparsa anche Vincenzo Bellini, astro nascente del melodramma italiano, che la principessa prese maternamente sotto la sua protezione. Le attenzioni e l’ammirazione che Cristina riservò a Bellini, che affascinava per eleganza, raffinatezza e giovanile candore, suscitarono da una parte le adulazioni delle più belle donne di Parigi, dall’altra malcelate invidie. Il poeta tedesco Heine, maliziosamente, predisse che, essendo stati gli dei così generosi nell’assegnare tante doti al meraviglioso Vincenzo, inevitabilmente, per esser caro a loro, sarebbe sicuramente morto giovane, secondo una sentenza di antica saggezza. Malauguratamente avveratasi la profezia, Heinrich Heine finì per guadagnarsi, agli occhi dei parigini, un’indelebile etichetta di menagramo. Vincenzo Bellini morì infatti il 23 settembre 1835, suscitando viva emozione e dolore profondo nella principessa. Per celebrare la grandezza del compositore prematuramente scomparso, Cristina di Belgiojoso incaricò Franz 14 Liszt di omaggiare adeguatamente tanto genio. Il grande evento musicale, estremo omaggio al musicista catanese prematuramente scomparso, si incentrava sul tema della Marcia tratta dall’opera I Puritani: "Suoni la tromba, e intrepido", che a Cristina e agli esuli irredentisti doveva suonare come un inno patriottico di riscossa per l’Italia. Liszt, insieme ad altri cinque musicisti (Fryderyk Chopin, Sigismund Thalberg, Johann Pixis, Carl Czerny, Henri Herz) furono così protagonisti di Hexaméron, Morceau de concert, six grandes variations de bravure sur la Marche des Puritans de Bellini, spettacolare brano di grande virtuosismo, vero e proprio monumento alla memoria del giovane compositore. Ognuno dei sei compositori intervenuti improvvisarono ciascuno una variazione sulla celebre marcia belliniana. Liszt, che aveva la funzione di “coordinatore artistico” della serata, si occupava anche di collegare le variazioni con passaggi e richiami al tema principale, nonché di elaborare un finale di grande virtuosismo, che concludesse la composizione con la necessaria grandiosità. La variazione composta da Chopin merita una nota particolare, in quanto si distacca dallo stile funambolico messo in atto dai colleghi: rinnegando il carattere marziale imposto dal tema, il polacco trasforma l’incedere eroico in un umbratile paesaggio notturno, omaggio all’indole squisitamente lirica dell’amico scomparso. Autore di oltre settanta opere, Gaetano Donizetti, benché non goda dell’alone di leggenda del collega Bellini, fu tuttavia maestro geniale e versatile, molto attivo anche nel campo strumentale, tanto da poter essere elevato al pari dei più celebrati autori mitteleuropei. Donizetti dedicò al pianoforte molti lavori, alcuni dei quali degni della massima attenzione. Risalgono al 1817, all’epoca degli studi a Bologna, due Sinfonie per pianoforte, probabili versioni iniziali destinate a successiva orchestrazione. Sia la Sinfonia in re maggiore “La partenza” che il Capriccio in sinfonia sono pagine gradevoli, ben strutturate e pianisticamente evolute, pervase entrambe da un inconfondibile sapore rossiniano. Troviamo sorprendente la piccola pagina Larghetto in la minore, archetipo pianistico della celebre aria “Una furtiva lagrima”, il cui manoscritto è conservato al Museo Donizettiano di Bergamo, breve aforisma pianistico dalle tipiche movenze del notturno romantico. Infine, oltre alla brillante Giuseppina polka-mazurka, dedicata alla moglie del nipote Andrea Donizetti ed evocativa dello stile popolare del polacco Stanisław Moniuszko, ricorderemo la serie dei Quattro valzer, testimonianza di un’attiva frequentazione, da parte di Donizetti, dei salotti culturali dell’epoca. Degno di nota è il Valzer n°3 in la maggiore, che presenta forti analogie tematiche con il famoso Coro della servitù dall’opera Don Pasquale. -------------------------------------------------------------------------- Al maestro Giovanni Pacini, Parigi, 8 aprile 1864 Io abbandonai la mia carriera musicale nel 1829; il lungo silenzio mi ha fatto perdere la potenza del comporre e la conoscenza degl’istrumenti. Ora sono un semplice pianista di quarta classe, e quantunque qualificatomi, come vedi, assai modestamente, i pianisti di tutte le nazioni (che mi fan festa a casa mia) mi fanno sorda ed aspra guerra (dietro le spalle) a modo che non trovo allievi, malgrado il modico prezzo delle mie lezioni di 20 soldi: né mi è dato produrmi, perché non richiesto; e vivo quindi (qual pianista) sotto il pubblico flagello … In queste poche righe, particolarmente “rossiniane”, è racchiusa l’essenza del singolare, e talvolta conflittuale, rapporto del compositore pesarese con il pianoforte. Cosa intende Rossini per “pianista di quarta classe”? Nella letteratura pianistica, e tanto meno nella didattica, non esiste una scala di valori universalmente 15 accettata che scandisca livello esecutivo dei pianisti secondo “classi”: per cui l’espressione è da considerarsi frutto di verve umoristica e pungente autoironia. In una successiva lettera, anch’essa indirizzata a Giovanni Pacini, afferma con enfasi che, tra i pianisti della quarta classe, egli non ha rivali, consigliando l’amico di unirsi anche lui alla nutrita schiera pianistica, tanto numerosa che, se riunita, compatta e armata “potrà fare la barba ai garibaldini”. Cerchiamo di interpretare perché Rossini vanti con orgoglio la sua appartenenza all’infima “quarta classe” pianistica: ma poi, chi erano questi pianisti della “prima classe”? Sicuramente appartengono a questa schiera di eletti i virtuosi dell’epoca, buoni professionisti, ma mediocri musicisti, seppur dotati della sgargiante tecnica strumentale necessaria per guadagnarsi l’apprezzamento del pubblico. Oltre a questi, non sfuggono al flagello della critica rossiniana neppure i grandi virtuosi dell’epoca, quali Chopin, Mendelsshon e Liszt, peraltro tutti conosciuti personalmente dal compositore pesarese. Premesso questo, non è difficile scorgere nel Rossini “pianista di quarta classe” un latente, ma nondimeno categorico, disprezzo nei confronti dell’ambiente pianistico dell’epoca. Egli si dissocia dalla pochezza musicale ed dal vuoto esibizionismo imperante presso la stragrange maggioranza dei pianisti dell’epoca, relegandosi volontariamente ad un basso profilo professionale, onde crearsi un “alibi” a giustificazione di tutte quelle ironiche “licenze” e “libertà creative” che saranno il Leitmotiv delle sue composizioni per pianoforte. La letteratura pianistica rossiniana si propone quindi come una specie di specchio deformante, dove vengono ridicolizzati gli stilemi affermatisi nel romanticismo pianistico ed unanimemente apprezzati dal pubblico musicofilo di quei tempi. Il rapporto di Rossini con il pianoforte nacque, in gioventù, all’insegna di quella diffidenza che il musicista riservò ad ogni altra novità o invenzione, comprese quelle tecnologiche, quali, ad esempio, il treno. Una volta abbandonate le scene, all’indomani del prematuro disimpegno operistico, il Pesarese maturò per lo strumento di Cristofori un interesse “genialmente superficiale”, che trasse ispirazione dai frequenti ritrovi salottieri da egli stesso organizzati: A Carlo Severini (Parigi), Milano, 26 novembre 1837. Do accademie, ossia esercizi musicali, tutti i venerdì in casa mia. Ho un bell’appartamento, e tutti vorrebbero assistere a queste riunioni: si passa il tempo, si mangia bene e si parla spesso di voi. Ad Antonio Zoboli (Bologna), Milano, 26 dicembre 1837. Le mie serate musicali fanno qualche sensazione qui a Milano. Dilettanti, artisti, maestri, tutti cantano nei miei cori; ho circa 40 voci di coro, senza contare tutti i soli. Madama Pasta canterà venerdì prossimo Come puoi credere, diventa questa una novità straordinaria, non volendo essa cantare in nessuna altra casa. Ho tutti gli artisti di teatri che fanno a gara di cantare e sono costretto lottare tutta la giornata per ricusare l’ammissione di nuovi satelliti. Le persone più distinte sono ammesse alle mie serate; Olimpia fa gli onori con successo e ce la passiamo bene. Perché non ho qui Tognino col suo fagotto?” Il giovane Rossini, però, finché fu sulla cresta dell’onda dei palcoscenici operistici, non vide di buon occhio il pianoforte, che all’epoca cominciava a farsi largo nel panorama musicale italiano. La lettera che citeremo ora non è lo sfogo stizzito di un vecchio musicista, sgomentato dalla barbarie delle nuove espressioni musicali, ma l’amara riflessione del venticinquenne Gioachino Rossini, confidata a Leopoldo Cicognara il 12 febbraio 1817. Altro che pianoforte! Perfino l’introduzione di qualche tasto in più aggiunto alla tastiera del vetusto clavicembalo bastava a far gridare allo scandalo l’intransigente maestro pesarese.: 16 Eccoti, caro Leopoldo, le mie idee su lo stato attuale della musica. Fin da quando furono aggiunte cinque note al clavicembalo io dissi che si preparava una rivoluzione funesta allora pervenuta alla sua perfezione, poiché l’esperienza ha dimostrato, che quanto vuolsi aggiungere all’ottimo, conduce al pessimo. Già Haydn aveva cominciato a corrompere la purità del gusto, introducendo nelle sue composizioni accordi strani, passaggi artificiosi, novità ardite; ma pure tanto egli conservava di elevatezza, e di antica venustà, che potevano sembrare scusabili i suoi errori; ma dopo di lui Cramer, e finalmente Beethoven colle loro composizioni prive di unità, e di naturalezza, ridondanti di stranezze e di arbitri, corruppero interamente il gusto della musica strumentale. (…) Quindi la misura, parte essenziale della musica, senza la quale la melodia non si intende e l’armonia cade nel disordine, viene dai cantanti trascurata e violata. Sorprendono, invece di commuovere, e, ove nei buoni tempi i suonatori si studiavano di cantare con i loro strumenti, adesso i cantanti si studiano di suonare con le loro voci. L’attività di direttore del Liceo Musicale di Bologna, successiva all’abbandono delle scene, impose a Rossini, per ragioni gestionali, una più approfondita conoscenza tecnica del pianoforte. In questa lettera, il musicista è alla ricerca di un strumento di tipo viennese, necessario per il concerto di un celebre pianista: A Lazzaro Aria, da casa, 27 novembre 1846. Il celeberrimo pianista Willemers, uso a suonare sui piano-forti di Vienna, amerebbe profittare dello strumento di vostro figlio per l’accademia che ha luogo questa sera al Comunale. Io vengo a pregarvi di accordargli questo favore; egli lo merita pel suo grande talento e per la sua amabilità. Spero pure che il buon Cesare non negherà al collega tanto bene. Il concerto in questione fu dato in onore del clarinettista Esuberanzio Belletti, reduce dalla Russia. Vi prese parte anche il pianista Rodolfo Willemers, che eseguì due proprie fantasie su Lucia di Lamermoor e Lucrezia Borgia. In queste altre righe, invece, Rossini si cimenta in considerazioni di carattere squisitamente tecnico, in vista dell’acquisto di uno strumento di un certo pregio: Al sig. Antonio Zoboli (Bologna). Firenze, 25 gennaio 1852. Sarò beatissimo di dare la commissione del sig. G. B. Spaletti relativa al miglior Pianoforte di Europa; per effettuare ciò non conosco che la fabbrica di Pleyel; i pianoforti di Herard mancano di uguaglianza di suono, difetto insopportabile. Se dunque il sig. Spaletti vuole un Pleyel, che io garantisco, io lo servirò; (…) non conosco le attualità tariffe del fabbricante, ma suppongo che il prezzo dei gran Pianoforti a coda monti a franchi 3.600 circa. I Pleyel e gli Erard (che Rossini chiama erroneamente “Herard”) erano i migliori pianoforti in commercio prima dell’avvento dei moderni Steinway. I Pleyel, preferiti da Rossini, erano anche gli strumenti prediletti da Chopin, mentre Liszt affermò più volte di trovarsi meglio sugli Erard. In una lettera successiva, inviata da Montecatini il 12 luglio 1852, Rossini si addentra in considerazioni merceologiche ancora più specifiche, lamentando che il Pleyel proposto dal rivenditore non è in palissandro, ma in mogano, e pertanto meno pregiato. Anche in altre lettere, Rossini dispensa consigli sulla scelta di pianoforti. A Liverani, nel giugno 1853, racconta di aver esaminato almeno duecento pianoforti verticali, senza trovarne neanche uno passabile. Passando all’analisi di alcuni esempi tratti dalla produzione pianistica rossiniana, che l’autore ha ordinato in raccolte da lui ironicamente denominate Péchés de Vieillesse (“Peccati di vecchiaia”), evidenzieremo alcuni brani che presentano aspetti particolarmente significativi. “Un petit train de plasir - Comique imitatif”, brano parodistico e caricaturale a danno di certe composizioni a carattere descrittivo - onomatopeico in voga presso i virtuosi dell’epoca, testimonia, anche attraverso le divertenti didascalie presenti in partitura, 17 l’avversione feroce nutrita dall’autore nei confronti del treno. Questo nuovo mezzo di trasporto, che avrebbe rivoluzionato la vita quotidiana degli Europei del XIX secolo, era visto da Gioachino Rossini con grande diffidenza, se non avversione. Oltre a ciò, si intuisce chiaramente, tra le righe delle didascalie rossiniane che contrappuntano questa curiosa composizione, un’aspra critica nei confronti dell’ipocrisia umana, particolarmente invisa al musicista pesarese: dopo lo spaventoso ed inevitabile deragliamento del treno, i fortunati eredi delle vittime dell’incidente manifestano il loro inconsolabile “dolore” intonando un saltellante e gaio motivetto. In un'altra composizione pianistica, Rossini riesce a creare sapientemente un’atmosfera mendelssohniana: ma il titolo assegnato al brano è dissacrante, “Ouf, les petits pois!” (“Uffa, i piccoli piselli”), tanto più che i piselli era una pietanza poco amata dal Pesarese. Per rimanere in tema gastronomico, citeremo anche “Cornichon” (“Cetrioli sotto aceto”), introduzione ad un tema semplicissimo, seguito da una serie di geniali variazioni. Altrettanto coerenti con l’atteggiamento ostile di Rossini nei confronti dell’ortodossia pianistica romantica ci paiono brani quali “Prélude pretentieux”, “Mon prélude hygiènique du matin”, ed altri con titoli similari. Il soprano Giuditta Pasta, nel ruolo di Norma 18 Giuseppe Verdi al pianoforte Caro Tito, ritornato da S. Agata ho trovato ieri sera la tua lettera carissima del 26 scorso e di nuovo ti ringrazio della raccolta di musica per pianoforte che m’hai mandato: la quale (a parte le mie opinioni sulla musica antica) è cosa assai ben riuscita e fa onore a coloro che così bene scelsero i pezzi ed a te che ne hai fatto un’edizione veramente bella. Fra gli altri v’è un pezzo che mi piacque, lo studio di Clementi in fa diesis minore 3/2. Non so se appartenga alla musica classica o romantica, o del passato e dell’avvenire, ma è bello molto e ben superiore al famoso preludio di Bach, su cui Gounod ha fatto la sua Ave Maria, divenuta celebre, buona nel principio, cattiva alla fine, totale mediocre. Perché non hanno fra le opere di Scarlatti messo la fuga così detta del Gatto? Era cosa buona, opportunissimo dimostrare la chiarezza dell’antica scuola napoletana. Con un soggetto così strano un tedesco avrebbe fatto un caos, un italiano ne ha fatto cosa limpida come il sole. Questa è una lettera inviata da Giuseppe Verdi da Torino il 2 novembre 1864 all’editore Tito Ricordi. Oltre ai soliti apprezzamenti anti tedeschi, osserviamo in Verdi una certa dimestichezza con il repertorio pianistico, che sottintende un rapporto quotidiano con lo strumento. Lo studio di Muzio Clementi citato nella lettera è il n°24 tratto dalla raccolta Gradus ad Parnassum, una pagina di non facile esecuzione e assai ben strutturata, sia tecnicamente che musicalmente. In effetti Giuseppe Verdi passava molte ore al pianoforte, creando alla tastiera i suoi capolavori operistici e mettendo mano all’orchestrazione solo a ridosso dell’inizio delle prove della prima rappresentazione. Così avvenne, ad esempio, con Traviata: il compositore arrivò a Venezia il 21 febbraio 1853 con l’orchestrazione dell’opera tutta da fare, ragion per cui, al suo arrivo, chiese di “un pianoforte ben accordato e buono”. Traviata andò in scena pochi giorni dopo, il 6 marzo al Teatro La Fenice. Per l’orchestrazione del Rigoletto pensò di essere ancor più rapido, come attesta una sua lettera del 29 gennaio 1851: Sono felicissimo che la Polizia abbia finalmente concesso l’approvazione a questo “Rigoletto”. In quanto a me non resta che a musicare l’ultimo duetto, e sarebbe anche questo finito se non avessi sofferto un forte mal di stomaco in questi ultimi giorni. (…) Fatto l’ultimo duetto a me non resta che il lavoro di cinque o sei giorni per l’istromentazione. L’incontro di Verdi con il pianoforte fu abbastanza tardivo. I primi strumenti a tastiera su cui poté esercitarsi da bambino furono l’organo della chiesa di San Michele Arcangelo delle Roncole, un presunto Serassi, ma in realtà opera di Ferdinando Bossi da Bergamo, e una vecchia spinetta, rimediata alla meglio dal padre Carlo. Per rendere suonabile la vecchia spinetta, probabile opera del cembalaro veneziano Marco Jadra nel lontano 1560, fu chiamato un tecnico di nome Stefano Cavalletti. Questi, ammirato dal talento del piccolo Giuseppe, non pretese alcun compenso per lavoro svolto, ritenendo il suo un doveroso contributo ai progressi di un grande talento della musica. A futura memoria del nobile gesto, fece apporre all’interno dello strumento la seguente scritta: Da me Stefano Cavalletti fu fato di nuovo questi saltarelli e impenati a corame e vi adatai la pedagliera che ci ho regalato; come anche gratuitamente ci ho fato di nuovo li detti saltarelli, vedendo la buona disposizione che il giovanetto 19 Giuseppe Verdi di imparare a suonare questo strumento, che questo mi basta per essere del tutto sodisfato. Anno domini 1821. Per amor di verità, abbiamo riportato fedelmente queste righe, senza correggere gli errori ortografici in cui incappò il pur generoso artigiano. Il primo vero pianoforte su cui Verdi poté esercitarsi con una certa continuità fu un “Fritz”, uno strumento “a coda” viennese di cui andava orgoglioso il suo benefattore e futuro suocero Antonio Barezzi. Il giovane studente non era certo un virtuoso, alla stregua di un Liszt o di uno Chopin: tuttavia, nel salotto culturale della provinciale borghesia bussetana, mieteva successi, affermandosi come brillante intrattenitore. Dell’esistenza di pagine musicali che Verdi dedicò alle riunioni musicali (all’epoca dette “Accademie”) del salotto Barezzi, abbiamo testimonianza in una lettera, del 1853, al critico milanese Isidoro Cambiasi: Dagli anni 13 alli anni 18 (epoca in cui venni a studiare il contrappunto in Milano) ho scritto una farragine di pezzi. Marce per banda a centinaia: forse altrettante piccole Sinfonie che servivano per Chiesa; pel Teatro, e per accademie: cinque o sei tra concerti e variazioni per Piano forte che io stesso suonava nelle accademie: molte serenate, cantate (arte, duetti, moltissimi terzetti) e diversi pezzi da chiesa di cui non ricordo che uno Stabat Mater. (…) Di questa produzione ci è pervenuto assai poco: ricorderemo il Valzer in fa maggiore, il cui manoscritto giunse nelle mani di Nino Rota, che lo rielaborò per piccola orchestra, inserendolo come colonna sonora della scena del ballo ne Il Gattopardo di Visconti. Altra piccola pagina salottiera è la Romance sans paroles, datata 20 novembre 1844 e dedicata ad una nobildonna, la Principessa Torlonia, nata Colonna. Il titolo di questa breve composizione sembra prendere spunto dalla celebre raccolta di Mendelssohn, senza tuttavia ricalcarne gli stilemi tipici. La Romance di Verdi si basa su una sola melodia, di carattere pregevolmente operistico, accompagnata dalla mano sinistra con semplici arpeggi. Manca un secondo elemento tematico, ovvero una sezione centrale, seguita dal tradizionale “da capo”. Il brano si conclude con una coda, fatta di passaggi “belcantistici” di ingenuo sapore chopiniano. Alla luce di queste notizie, possiamo immaginarci che il giovane pianista Giuseppe Verdi disponeva di una preparazione tecnica poco ortodossa, frutto di pratica empirica piuttosto che di studio sistematico. Questo dettaglio, tutt’altro che marginale, non poteva sfuggire ai componenti della commissione giudicatrice del famigerato esame di ammissione al Conservatorio di Milano, cui il futuro autore di Nabucco si sottopose il 9 luglio 1832. L’esame di ammissione a frequentare il prestigioso istituto milanese era la tappa obbligatoria per un giovane compositore che aspirasse ad un sicuro futuro professionale. Per questa ragione Verdi inviò questa domanda, redatta nella forma di una servile supplica: All’Imperial Regio Governo Giuseppe Verdi trovasi iniziato nello studio della musica, ma non avendo i mezzi nella propria patria di Busseto, Stato di Parma, di ottenere quel perfezionamento cui aspira, desidererebbe al tal uopo di essere ammesso nella qualità di allievo a pagamento di pensione nell’I.R. Conservatorio di Musica di Milano. Egli rivolge quindi le proprie istanze a codesto I.R. Governo confidando che negli esperimenti, cui venisse sottoposto presso il detto Conservatorio di Musica, potranno essere in lui riconosciute quelle disposizioni contemplate nell’articolo del regolamento dell’Istituto medesimo per ottenere la dispensa che a tal uopo gli occorre per la oltrepassata età normale, contando egli quella di anni 18. Si riserva poi di produrre i documenti comprovanti il concorso dei requisiti voluti per l’ammissione, che invoca nello stabilimento medesimo. Della grazia etc. Umilissimo Servitore, Giuseppe Verdi, Milano 22 giugno 1832 20 E l’umilissimo servitore Giuseppe Verdi fu solennemente bocciato. In particolare, risultarono determinanti le carenze messe a nudo nella sua esecuzione al pianoforte del Capriccio in la minore di Henri Herz. La scarsa preparazione pianistica evidenziata dal giovane scandalizzò soprattutto un membro della commissione, Antonio Angeleri (1801 - 1880), già citato quale fondatore della scuola pianistica milanese. Il severo didatta decise che un giovane dotati di una preparazione così approssimativa non fosse degno di far parte della schiera dei suoi prestigiosi allievi, tra i quali si sarebbero distinti i fratelli Andreoli e Adolfo Fumagalli. In realtà i motivi dell’insuccesso furono molteplici, e alcuni di essi non erano propriamente di natura musicale, ma squisitamente burocratica. Giuseppe Verdi, quando sostenne la prova di ammissione, aveva un’età troppo avanzata rispetto a quanto previsto dal regolamento del Conservatorio. Era consentita deroga a questa disposizione solo qualora il candidato avesse mostrato chiaramente doti musicali eccezionali. Agli occhi di una commissione di coscienziosi professori di conservatorio, Verdi non sembrò nulla di ché, almeno dal punto di vista strettamente “scolastico”. A ragione o a torto, il futuro autore di Traviata non prese bene la pur motivata decisione della commissione. Per il giovane Giuseppe la bocciatura al conservatorio fu un vero e proprio disastro, che lo avrebbe messo in grave imbarazzo nei confronti di mecenati e sostenitori bussetani, in testa il futuro suocero Barezzi. A distanza di molti anni, in una lettera del 13 ottobre 1880, egli stesso raccontò al giornalista e corrispondente parigino della Gazzetta Musicale di Milano, Jacopo Caponi, le sue disavventure scolastiche: Non nel 1833, ma nel 1832 nel mese di giugno (non aveva compito 19 anni) feci domanda in iscritto per essere ammesso come alunno pagante al Conservatorio di Milano. Di più subii una specie di esame al Conservatorio presentando alcune mie composizioni, e suonando un pezzo al pianoforte dinanzi a Basily, a Piantanida, Angeleri ed altri etc etc, più il vecchio Rolla, al quale ero raccomandato dal mio maestro di Busseto, Ferdinando Provesi. – Circa otto giorni dopo mi recai dal Rolla, il quale mi disse: “Non pensate più al Conservatorio: scegliete un maestro in città: io vi consiglio Lavigna o Negri.” Non seppi più nulla del Conservatorio. Nissuno rispose alla mia domanda. Nissuno mi parlò, né prima, né dopo l’esame, del Regolamento. E non so nulla del giudizio di Basily narrato da Fetis. Ecco tutto! Vi ho raccontato in fretta e brevemente perché voi avete premura. Vi ho però detto tutto quello che ne so. Il Caponi, il cui pseudonimo giornalistico era “Folchetto”, era stato incaricato di correggere le inesattezze presenti nella prima importante biografia verdiana, comparsa all’epoca e realizzata dal musicologo francese Arthur Pougin. A rinnovare ulteriormente l’amarezza per la vicenda dell’esame fallito ci pensò il Conservatorio di Milano, con la surreale proposta di intitolazione dell’istituto allo stesso Verdi. Queste righe testimoniano evidente rancore mai estinto, ed anche sincera incredulità: Vi ringrazio della premura dimostratami scrivendo a Gallignani. Procuriamo che quell’idea vada in fumo! Conservatorio “Giuseppe Verdi” è una stonazione! Un conservatorio ha attentato (non esagero) alla mia esistenza, ed io debbo sfuggirne fin la memoria. E se quel sant’uomo di mio suocero, sentita la sentenza dei Profeti del Conservatorio del giugno 1832, m’avesse detto: “sento che la musica non è affare per te: è inutile perder tempo e spender denari. Ritorna al tuo villaggio nativo, torna organista, lavora la terra e muori in pace.” Era naturale. Ma a parte questo, chi sa, se io approvo l’indirizzo degli studii dei nostri Conservatori? Non so nulla… Ma so che altra volta esisteva una musica che si chiama “Italiana” ammirata dal mondo intero. Ammirata pure altra musica, che si diceva “Tedesca”. Eran sole; grandi tutte due, caratteristiche, Potenti, Sincere! Che meraviglia! Ora cosa è diventata la nostra? Sarebbe troppo lungo il dirlo, e finisco dicendo che i Tedeschi ora sono in musica più Italiani degli Italiani! 21 Questa lettera, del 13 agosto 1898, era indirizzata a Giulio Ricordi. Il compositore e direttore dei Conservatori di Parma e Milano Giuseppe Gallignani (1851 – 1923) fu uno dei promotori della rigettata intitolazione. La polemica accesa da Verdi in queste righe non si limita alla vicenda personale, ma sfocia in considerazioni polemiche riguardanti la musica “italiana” e quella “tedesca”, tema particolarmente caro a Verdi nella sua ultima fase creativa. Oltre alle poche pagine “salottiere” che Verdi dedicò al pianoforte, crediamo meritevoli di esecuzione anche alcune riduzioni pianistiche tratte dai suoi capolavori operistici. Citeremo fra queste i preludi di Traviata (terzo atto), Macbeth e Rigoletto, che, nonostante si tratti di semplici “riduzioni per pianoforte”, denotano una buona fattura strumentale, tale da non sfigurare al cospetto delle coeve composizioni firmate dai più prestigiosi autori d’oltralpe. Altrettanto degno di esecuzione è il Lacrymosa tratto dal Requiem, la cui versione pianistica è frutto della collaborazione con il musicista palermitano Michele Saladino (1835 – 1912), prestigioso maestro del Conservatorio di Milano. Sarebbe ingiusto non menzionare anche le versioni a quattro mani delle più celebri pagine verdiane, alcune delle quali realizzate sotto il controllo dell’autore, ma tutte fedeli ritratti sonori delle serate musicali dei salotti culturali italiani del periodo risorgimentale. La musica di Giuseppe Verdi, come quella degli altri operisti italiani, offrì ai pianisti dell’epoca l’opportunità di elaborare parafrasi, fantasie, reminescenze e pout pourri. La lista degli autori di questo genere di rielaborazioni musicali, dove la rievocazione di un motivo popolare costituiva l’occasione per sfoggiare il più pirotecnico virtuosismo, è ben nutrita: Fumagalli, Beyer, Thalberg, Bülow, Liszt, citandone solo alcuni. A parte quest’ultimo, gli autori menzionati, nelle loro fantasie verdiane, si limitavano a proporre i motivi operistici senza alterarne la struttura musicale armonica e ritmico – melodica, aggiungendo fioriture e passaggi di difficoltà, talvolta anche notevole, e sciorinando variazioni che esaltavano l’agguerrito bagaglio tecnico del pianista professionista. In un generale grigiore creativo, che prendeva la musica di Verdi come puro pretesto per raccogliere facili consensi, si evidenziano tuttavia le fantasie di Thalberg e Liszt. Del primo, vero e proprio apostolo del “Belcanto al Pianoforte”, tratteremo più avanti. Ci soffermeremo invece sulle pagine che Liszt dedicò alla musica di Verdi, non solo per il particolare e indiscutibile pregio di queste composizioni, ma anche per il criterio estetico generale assunto. In alcune di queste, Liszt sembra voler anteporre la propria personalità creativa a quella del musicista italiano, alterando abilmente il carattere drammatico delle pagine operistiche parafrasate. A questo riguardo, ci sembrano emblematici gli esempi del “Miserere” dal Trovatore, che nella rielaborazione lisztiana assume il colore sonoro “gotico” di una ballata nordica, e la parafrasi da concerto dal quartetto del Rigoletto, che, con alcuni sapienti ritocchi, trasforma in un salottiero inno alla seduzione. Saremmo tentati di giustificare questo atteggiamento poco ossequioso come un vero e proprio pregiudizio anti verdiano, conseguenza dell’adesione all’estetica musicale wagneriana. Tuttavia, faremmo un torto all’onestà intellettuale di Franz Liszt se non riconoscessimo in lui un ravvedimento, pur tardivo, dimostrato nel misticismo “gregoriano” della versione pianistica dell’Agnus Dei, tratto dal Requiem dedicato a Manzoni, e, soprattutto, nelle Reminescenze dalla seconda versione del Simon Boccanegna, pagina di splendido colore pianistico, testimonianza di profondo apprezzamento dell’ultima fase creativa di Verdi. Su questa lunghezza d’onda, ma fortemente improntata allo sperimentalismo più delirante dell’ultimo Liszt, si colloca l’enigmatica dissertazione pianistica sulla “Danza sacra e duetto finale” dell’Aida, composizione che tutt’ora lascia attoniti sia il pubblico che gli interpreti. 22 Giuseppe Verdi suonò questo pianoforte per inaugurazione del Teatro Galli di Rimini (1857) 23 Catalani, Franchetti, Cilea Raffinato, sensibile, culturalmente elevato, Alfredo Catalani (1854 – 1893) condivise molto con Giacomo Puccini, ma, purtroppo, non la fortuna nella vita e nell’arte. Lucchese di nascita, proveniva anche lui da una famiglia di musicisti. Suo padre Eugenio, allievo del celebre operista Giovanni Pacini, assieme allo zio Felice e il nonno Domenico, lo istruirono nei primi rudimenti musicali, consegnandolo poi alle cure di Fortunato Magi (zio di Giacomo Puccini), che frequentò presso l’Istituto Musicale “Pacini” (oggi intitolato a Luigi Boccherini). Terminò gli studi nella città natale nel 1872, con esiti lusinghieri, componendo e dirigendo di persona in una pubblica esecuzione presso il Duomo di Lucca una messa per voci e orchestra. In quello stesso anno si recò al Conservatorio di Parigi, dove frequentò, seppur per breve tempo e da uditore, la prestigiosa classe di pianoforte di Antoine François Marmontel (Clermont–Ferrand 1816 – Parigi 1898). Si trattava di un’esperienza didattica non da poco: Marmontel fu un grande maestro della scuola pianistica francese, che poteva vantare tra i suoi allievi Bizet, Debussy, Diémer (il maestro di Cortot, Casella, Casadesus) ed altri illustri pianisti e compositori. Rientrato in Italia, nel 1873, Catalani studiò al Conservatorio di Milano: qui ebbe l’opportunità di proseguire gli studi pianistici con Carlo Andreoli (Mirandola, 8 gennaio 1840 – Reggio Emilia, 22 gennaio 1908), eccellente virtuoso, vero e proprio propulsore della nascente vita concertistica milanese. Andreoli proveniva dalla scuola di quell’Angeleri su cui si infransero i sogni del giovane Giuseppe Verdi. Il compositore lucchese si dimostrò un buon esecutore al pianoforte: lo troviamo sul palcoscenico dei concerti alla Sala del Conservatorio, dove, il 10 giugno 1875, eseguì la Fantasia in do minore di Johann Sebastian Bach. Troviamo notizie di Catalani al pianoforte anche nelle serate musicali del salotto di Clara Maffei, dove si recavano sovente anche gli esponenti della cosiddetta “Scapigliatura lombarda”, in particolare Franco Faccio e Arrigo Boito. Quest’ultimo fu autore del testo de La Falce, egloga araba per due voci e coro, che costituì l’esordio compositivo del giovane Catalani. Fu proprio nell’ambiente della “Scapigliatura” che il musicista affermò la fine vena artistica e la nobile espressività crepuscolare che caratterizzavano la sua personalità. Ci pare emblematica, a questo riguardo, la pagina pianistica Se tu sapessi, del 1878, tenera confessione amorosa, eco sbiadito della dissoluzione di un sogno. Il quadro L’edera, di Tranquillo Cremona, sembra ben rappresentare l’atmosfera evocata da questo brano, che l’attento ascoltatore avrà sicuramente associato, per evidente somiglianza, al Notturno op.55 n°1 di Fryderyk Chopin. L’edera, è il dramma dell’amore illusorio, del bene che sfugge inesorabilmente, del destino che toglie dopo aver dato: è il paradigma della vicenda umana ed artistica di Alfredo Catalani, che fece da modello, insieme all’ineffabile e graziosa Lisetta Cagnoli, cognata di Cremona, proprio per la realizzazione di quel dipinto. Ultima opera di Cremona, L’edera era stata commissionata dal musicista Benedetto Junck, anch’esso legato alla “Scapigliatura” e animatore di un vivace salotto culturale cui si avvicinò con entusiasmo anche il giovane Alfredo. Gli artisti che dettero vita al salotto Junck somigliano moltissimo ai protagonisti della Bohéme di Puccini: giovani, squattrinati, forti di loro ideali più o meno campati per aria, cultori dell’arte del futuro, 24 nemici delle ormai logore convenienze sociali, e, perché no, facili al litigio ed alle folgoranti passioni amorose. Qui, il tenero Catalani si innamorò di Teresa Garbagnati, moglie di Benedetto Junck, assecondando un sentimento, oltreché sconveniente, anche poco rispettoso nei confronti di un amico che lo aveva generosamente ospitato. Teresa divenne l’ispiratrice di molte pagine pianistiche salottiere, alcune delle quali furono incluse nella raccolta Impressioni, pubblicata dall’editore Ricordi nel 1888. La passione di Catalani per la Garbagnati terminò solo alla morte del musicista, avvenuta a trentanove anni il 7 agosto 1893: fu momentaneamente interrotta nel 1889 dall’infelice parentesi del fidanzamento del compositore con la cugina materna Luisa Picconi, fuoco di paglia malinconicamente spentosi dopo poco tempo. La produzione pianistica di Catalani, che conta solo di una ventina di composizioni, riluce però di affascinanti sonorità crepuscolari e di raffinate suggestioni armoniche, testimonianza di indiscutibile capacità tecnica, maturata anche grazie alle importanti esperienze di Parigi e Milano. A sera, pubblicato nel 1889 nella rivista genovese “Paganini”, ci sembra rappresentativo dell’arte del musicista lucchese: le insistite note ribattute, che sostengono una mesta melodia, ci appaiono come un pallido ricordo di un preludio chopinano, rivissuto retrospettivamente con tono di angoscioso rimpianto. Questa splendida pagina pianistica diverrà, poco dopo, il preludio al terzo atto di Wally, opera che fruttò a Catalani una certa notorietà, dopo gli scarsi successi di Elda, Dejanice, Edmea e Loreley. Con Wally si guadagnò la stima di grandi nomi della musica mondiale: Gustav Mahler la diresse ad Amburgo definendola “la migliore opera italiana”, Arturo Toscanini la propose, oltre che alla prima scaligera, anche in una memorabile serata al Teatro del Giglio a Lucca. Nell'estate del 1893, dopo l’ennesimo soggiorno in Svizzera, estremo tentativo di ristabilirsi dalla tisi che lo affliggeva da anni, Catalani si arrese. Due giorni dopo la morte venne provvisoriamente sepolto nel cimitero monumentale di Milano. Dal 16 marzo 1894 riposa a Lucca, presso il cimitero di Sant’Anna. 25 Tranquillo Cremona: L’edera (1878) 26 Per la forte suggestione evocativa esercitata dalle immagini che emergono dalle nebbie del passato, una fotografia ci appare emblematica della prorompente forza creativa e innovativa della “Giovane Scuola” operistica italiana. In essa vediamo ritratti tre giovani musicisti: l’atmosfera è da soffitta parigina, quella della bohéme. Uno di essi sta suonando un modesto pianoforte; gli altri ascoltano assorti in partecipe vicinanza spirituale. Riconosciamo tra questi Pietro Mascagni (in piedi) e Giacomo Puccini (seduto a destra). Al pianoforte siede Alberto Franchetti che, a differenza dei due colleghi, le ristrettezze de la vie de bohéme non le aveva mai conosciute direttamente. Egli era infatti un giovane dai “natali illustri, nobilissimi e perfetti”, figlio del barone Raimondo Franchetti (Livorno, 25 ottobre 1829 - Reggio Emilia, 30 ottobre 1905), ricco proprietario terriero e facoltoso azionista della Navigazione Marittima Italiana, e della altrettanto baronessa Luisa Sara Rothschild (1834 – 1924), che portava un nome di rango europeo. Fu la zia del compositore, la baronessa Julie Rothschild, che nel 1898 aveva invitato Elisabetta Wittelsbach, meglio conosciuta come “Sissi”, nella sua villa di Pregny, sul lago di Lemano in Svizzera, in quel fatale viaggio nel corso del quale fu uccisa per mano dell’anarchico Luigi Lucheni. Alberto Franchetti apprese i primi rudimenti musicali dalla madre, che pare fosse un’abile pianista. Poi, a Venezia, studiò con buoni maestri, tra i quali Fortunato Magi, zio di Giacomo Puccini, che dal 1877 fu docente di contrappunto al neonato Liceo musicale “Benedetto Marcello”. Con l’autore di Bohéme condivise, oltre che le lezioni dello zio Magi, anche la passione per le automobili. Franchetti fu infatti fondatore, nel 1897 e con Giuseppe Ricordi, Gorla e Belloni, del Club Automobilisti Italiani, sodalizio del quale diventò presidente nel 1899. La formazione di Franchetti proseguì in Germania, a Monaco e a Dresda, prestigiosi centri musicali che assicurarono al giovane una solida preparazione tecnica ed uno stile espressivo tipico degli autori tedeschi. Esempio di questa fase “europea” della produzione di Alberto Franchetti è la Sinfonia in mi minore, composta nel 1884, eseguita a Dresda nel 1886 e il 22 aprile 1888 a Milano sotto la direzione di Franco Faccio. Il successo arrivò con l’opera Asrael, rappresentata a Reggio Emilia l’11 febbraio 1888, in un allestimento finanziariamente sostenuto dal padre Raimondo. Alla prova generale dell’opera erano presenti Giacomo Puccini ed il pianista Giuseppe Martucci. Successivamente, e dopo un primo rifiuto, Franchetti accettò dal Municipio di Genova l’incarico di mettere in scena un lavoro celebrativo del quarto centenario della scoperta dell’America. A suggerire il nome di Franchetti alle autorità genovesi era stato Giuseppe Verdi, che nutriva grande stima per il giovane emergente. Il 6 ottobre 1892, al Teatro Carlo Felice, andò in scena il Cristoforo Colombo, musicato da Alberto Franchetti su libretto (non tra i più brillanti) di Luigi Illica. La non facile collaborazione con Gabriele D’Annunzio originò l’opera La figlia di Iorio, rappresentata al Teatro alla Scala il 29 marzo 1906. Parte della composizione della musica avvenne alle Terme di Montecatini, ove Franchetti soggiornò divenendo un vero e proprio personaggio dei Bagni. Le cronache termali lo ricordano sfrecciare con il suo bolide da sessanta cavalli (costato, pare, mille lire a cavallo), che conduceva con la perizia di un pilota da corsa per le colline circostanti. Si dice impiegasse tre minuti e mezzo per percorrere il tragitto dai Bagni alla piazza di Montecatini Alto, dove i giornalisti lo aspettavano per una cordiale chiacchierata ed un aperitivo a base di vermouth. La cittadina termale, frequentata a quei tempi da Toscanini e Caruso, ma anche dall’attore Virgilio Talli, protagonista della prima teatrale de La figlia di Iorio, era situata in posizione strategica per il lavoro intrapreso con D’Annunzio, poiché non era lontana dalla villa La Capponcina a Firenze. Un telefono, situato a portata di mano accanto al pianoforte, teneva in contatto costante, per ogni urgente correzione o comunicazione, Franchetti con il “Vate”. Dal 1914 fu poi membro effettivo dell’Accademia Santa Cecilia e, nel periodo dal 1926 al 1928, direttore del Conservatorio “Luigi Cherubini”. Poi si ritirò a vita privata, e le sue opere, dopo aver goduto di grande popolarità ed unanime apprezzamento, progressivamente sparirono dai cartelloni delle stagioni operistiche, uscendo di scena insieme 27 al loro creatore. Alberto Franchetti, oltreché geniale compositore, fu anche uomo dagli impeti generosi, tanto da cedere a Umberto Giordano il libretto dell’ Andrea Chénier, e da sopportare da vero gentiluomo il discutibile strattagemma con il quale Giulio Ricordi gli negò Tosca per affidarla a Giacomo Puccini. È difficile avere un’idea dell’arte pianistica di Franchetti, non avendo notizia di una sua attività di esecutore. L’eclettismo, tipico di un intellettuale della sua estrazione sociale, lo teneva lontano da quell’impegno quotidiano, tenace e costante, necessario ad ogni pianista che aspiri ad una carriera di rilievo. Anche la produzione dedicata specificamente al pianoforte è abbastanza esigua, comprendendo un Idillio campestre, pubblicato forse nel 1878 con lo pseudonimo di Alberto Aldi, un’Elegia (pubblicata intorno al 1890), Pezzo malinconico improvvisato (1891 circa), Fantasia drammatica (per orchestra con pianoforte e violoncello obbligati, del 1913), Foglio d’album (1923). Si tratta di un catalogo di modeste dimensioni, ma che può ampliarsi se consideriamo anche le versioni pianistiche delle opere di maggior respiro. Per cui ci sembrano sicuramente degne di esecuzione alla tastiera le pagine sinfoniche di Asrael e de La figlia di Iorio, per non parlare della Sinfonia in mi minore, di sicuro effetto nella trascrizione per pianoforte a quattro mani. Franchetti, Puccini e Mascagni al pianoforte 28 Nato nella terra di Antonio Manfroce, l’operista calabrese morto prematuramente a 22 anni nel 1813, Francesco Cilea decise giovanissimo di dedicarsi alla musica. Stando ai suoi Ricordi, la vocazione di compositore si manifestò in lui dopo l’ascolto del finale della Norma di Bellini, eseguito dalla banda di Palmi. Il padre Giuseppe, buon avvocato civilista e dilettante di musica, avrebbe sicuramente preferito che il figlio seguisse le sue orme. Tuttavia, papà Cilea non mancò di impartire personalmente i primi rudimenti musicali al piccolo Francesco, che amava ascoltare con emozione la zia Eleonora Grillo suonare al pianoforte il meglio del repertorio operistico. Visti i rapidi progressi, Francesco ebbe necessità di un vero insegnante di pianoforte, per cui fu affidato a Rosario Jonata, direttore della banda cittadina. A causa di una grave malattia della madre Felicia, Cilea dovette trasferirsi all’età di sette anni in un convitto privato a Napoli. Qui fu notato da Francesco Florimo (San Giorgio Morgeto, 12 ottobre 1800 – Napoli, 18 dicembre 1888), amico fraterno e biografo di Vincenzo Bellini e, pure lui, calabrese d’origine. Florimo, che ricopriva il prestigioso incarico di bibliotecario al “Reale Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella” a Napoli, dopo aver sentito il piccolo Francesco eseguire due dei suoi primi tentativi compositivi, ossia un Notturno ed una Mazurca per pianoforte, consigliò l’avvocato Giuseppe di avviarlo a studi musicali regolari. Il padre, che nutriva ancora una pallida speranza di avviare il giovane alla giurisprudenza, si decise ad assecondare il talento musicale del figlio solo nel 1878, quando Francesco aveva dodici anni. Nel conservatorio partenopeo il giovane ebbe la fortuna di frequentare maestri di prim’ordine. Per il pianoforte poté giovarsi delle lezioni di Beniamino Cesi, vero e proprio caposcuola che, nel 1885, fu chiamato da Anton Rubinstein ad insegnare al conservatorio di San Pietroburgo. In luogo di Cesi, che resterà in Russia sino al 1891, il musicista calabrese si ritrovò un altro grande della tastiera come Giuseppe Martucci. Riportiamo due entusiastiche righe tratte dai sempre dai suoi Ricordi: E dopo un anno di collegio (…) vinsi il concorso pel posto gratuito nel ramo Composizione. (…) Componevo dei pezzi; attendevo con la dovuta alacrità allo studio dell’Armonia e del Contrappunto, e seguivo anche appassionatamente le lezioni del severo Maestro Beniamino Cesi. Eseguivo, non senza bravura, le più difficili sonate dello Scarlatti, amavo Bach, mi appassionava Beethoven, mi commuoveva Chopin. Collega di studi e, come ebbe a dire Cilea stesso, “amico carissimo, compagno di scuola, di camerata, d’infermeria, d’idee e anche di costituzione fisica”, fu Umberto Giordano, anch’esso destinato ad una luminosa carriera sui palcoscenici operistici. Sui banchi del San Pietro a Majella sedevano anche altre personalità che avrebbero scritto la storia della musica italiana, e in particolare Ruggero Leoncavallo, i pianisti Florestano Rossomandi, l’italo olandese Niccolò van Westerhout (colui che suonò al pianoforte il Tristano e Isotta per un entusiasta D’Annunzio), Giovanni Anfossi (che fu maestro di Arturo Benedetti Michelangeli), Luigi Romaniello, oltre ai conterranei calabresi Alfonso Rendano e Alessandro Longo. Il giovane si distinse per diligenza e precoce ingegno, meritando una medaglia d'oro dal Ministero della Pubblica Istruzione e una nomina di "primo alunno maestrino". Il termine “maestrino”, retaggio di antichi ordinamenti conservatoriali, indicava gli allievi che erano giunti al termine del corso medio e che iniziavano a praticare l’insegnamento da assistenti “tirocinanti”, internamente al proprio istituto scolastico. Secondo le testimonianze pervenuteci, Francesco Cilea era davvero un buon esecutore al pianoforte, degno dei buoni maestri che aveva frequentato. Si racconta che, quando da Napoli tornava a Palmi per trascorrere le feste in famiglia, radunasse i conoscenti nel suo salotto per eseguire al pianoforte, con grande successo, brani operistici, soprattutto di Bellini e Verdi, accanto a composizioni tipiche 29 del repertorio tradizionale. Nei sui Ricordi, il compositore rammenta, con particolare affetto ed emozione, un concerto organizzato nella città natale in onore del padre, dove eseguì: Un programma che comprendeva Scarlatti, la Patetica di Beethoven, Chopin, alcune mie composizioni e una difficilissima trascrizione elaborata da Liszt sulla Lucia di Donizetti. Le composizioni che Cilea dedicò al pianoforte sono abbastanza numerose e pregevoli. Queste raffinate pagine testimoniano l’ottima vena pianistica dell’autore, che, unita ad un fine sentimento crepuscolare, le rende piacevoli e tutt’ora sicuramente degne di esecuzione pubblica. I brani del musicista di Palmi sono semplici nella forma, lirici nell’ispirazione, essenziali ed efficaci nella scrittura strumentale. Il collega e compagno di studi Alessandro Longo curò negli anni ’40, per la casa editrice Curci, una raccolta di dieci composizioni pianistiche di Cilea: Romanza, L’arcolaio, Gocce di rugiada, Melodia, Mazurca, Aria campestre, Serenata, Valzer, Canto del mattino, Danza. I titoli offrono un’idea precisa sulla destinazione “salottiera” di queste raffinate creazioni. Il giudizio estetico espresso da Longo nella prefazione all’edizione ci sembra particolarmente centrato: I leggiadri e fragranti pezzi che compongono questo Album sono stati scritti da Francesco Cilea nei primissimi anni della sua attività artistica, e qualcuno di essi mentr’egli era ancora alunno nel Conservatorio di Napoli. Quasi tutti ebbero pronta e larga diffusione nel campo del buon dilettantismo di un tempo: merito della sincerità melodica e della spontanea spigliatezza onde sono animati. Accetto assai volentieri l’incarico di compilare e di rivedere la nuova edizione dei pezzi riuniti in fascicolo, subito ne tenni parola al Maestro illustre – mio conterraneo e mio caro compagno di studi – e da lui ebbi l’autorizzazione di apportare eventualmente qualche ritocco nel testo: cosa ch’io ho fatto con molta discrezione, meritando il pieno consenso dell’Autore. Nel dare il via alla stampa, mando un saluto affettuoso all’amico e un augurio di buon cammino al simpaticissimo Album. Ma il vero e duraturo successo arrivò con l’opera: per cui la sua arte pianistica passò in secondo piano rispetto ai trionfi teatrali. Al termine degli studi nel 1889, il musicista calabrese presentò l'opera Gina, che fu rappresentata con successo nel teatrino del conservatorio. Questa piccola opera, in cui l'ingenuità del libretto è pari a quella della musica, fu tuttavia apprezzata dall'editore Sonzogno, che commissionò al giovane musicista un’ulteriore lavoro, di ispirazione tipicamente verista, La Tilda. L’opera che ha consacrato Cilea alla storia del melodramma è Adriana Lecouvreur, rappresentata al Teatro Lirico di Milano, il 6 novembre 1902. Da questo lavoro in quattro atti, composto su libretto di Arturo Colautti e basato su una pièce di Eugène Scribe, nasce, in forma di trascrizione, una breve pagina pianistica di particolare pregio: il soave “Intermezzo”, che alla tastiera risuona come un delicato cammeo, emblematico di quel settecento francese musicalmente ritratto nell’Adriana. Questa composizione, assieme quelle originali per pianoforte, meriterebbero a piano titolo di figurare nei programmi delle sale da concerto del terzo millennio. 30 Giordano e Mascagni OLGA (presentando a Fedora Boleslao, che si inchina profondamente) Vi presento Lazinski, il maestro polacco, nipote e successore di Chopin… un poeta del pianoforte, un principe del sentimento, un mago… (Boleslao si inchina tre volte) FEDORA (graziosamente) Vi applaudirem stasera? OLGA (con entusiasmo) Naturalmente! FEDORA Bene! Boleslao si inchina ancora grottescamente. Fedora, seguita da Loris, scompare a destra. De Siriex e Boleslao offrono entrambi il braccio ad Olga, la quale, dopo alquante moine, si decide per quello del secondo che sospira come un mantice, facendole gli occhi teneri. (…) OLGA (a Fedora) Principessa, Boleslao può cominciar? FEDORA (seccata) Cominci… (Olga risale, saltellando, al fondo) (…) Due valletti hanno scoperchiato il pianoforte. 31 Lazinski, condotto da Olga, si mette alla tastiera; la Contessa e le altre signore siedono intorno nella gran sala: i cavalieri stanno in piedi dietro le dame. Sul davanti Fedora è sempre sul canapè con Loris: il piccolo paravento li maschera di fianco, sì che gli altri nel salone possono malamente vederli. Lazinski incomincia a suonare: la Contessa ascoltandolo, esprime un’ammirazione estatica. Durante l’esecuzione del pezzo, Fedora e Loris parlano sommesso. (…) Nel salone tutti applaudiscono Lazinski, che ha terminato il primo tempo del suo pezzo: il concertista polacco si alza per ringraziare, goffamente, indi ricomincia attaccando l’allegro (…) Le signore si alzano e circondano il concertista per complimentarlo. La Contessa, raggiante, va di gruppo in gruppo per attizzar l’entusiasmo. Lazinski, squassando la sua criniera, distribuisce sorrisi e strette di mano. Il secondo atto di Fedora, che Umberto Giordano mise in scena per il Teatro alla Scala il 17 novembre 1989, ci appare come una viva testimonianza della presenza culturale del pianoforte negli ambienti socialmente elevati del XIX secolo. Siamo nel salotto parigino della principessa Fedora Romazoff, alla fine dell’800. Il pezzo forte della serata è costituito dall’esibizione al pianoforte di Boleslao Lazinski, l’immancabile polacco presunto depositario dell’arte di Chopin. Giordano ce lo dipinge con tratti talvolta grotteschi, goffi, quasi a sottolineare la scarsa attendibilità del personaggio. Boleslao è il protagonista della serata, conteso e corteggiato dalle dame presenti, rapite dalle atmosfere di languido sentimentalismo evocate dall’esecuzione del pianista. In questa curiosa situazione scenica, Giordano, con grande sapienza teatrale e pianistica, commenta in sottofondo con un nocturne à la maniere de Chopin, manieristica emulazione dello stile del polacco e severa critica al cattivo gusto che regnava sovrano nei salotti dell’epoca. Umberto Giordano era un buon esecutore al pianoforte. Aveva studiato al Conservatorio di Napoli e, come altri suoi colleghi della “Giovane Scuola”, ebbe la fortuna di incontrare un maestro di pianoforte della levatura di Beniamino Cesi, l’allievo di quel Sigismund Thalberg che rivaleggiò con Franz Liszt. Si commetterebbe, tuttavia, un torto alla verità storica se non si rammentasse colui che nella natia Foggia avviò Giordano allo studio del pianoforte, ossia il maestro Luigi Gissi, un’autorità musicale nella propria città, ma un “carneade” qualunque nel panorama pianistico nazionale. Nella Napoli dell’Unità d’Italia, la prassi delle riunioni musicali domestiche, sul modello del salon parigino, era abbastanza comune. Pertanto non è improbabile che il giovane Giordano abbia occasionalmente vestito i panni del Boleslao della circostanza, da una parte godendone dei benefici, ma dall’altro rendendosi conto della vuotezza culturale e musicale dell’ambiente in cui si esibiva. Testimonianza di questo aspetto della vita e della carriera del musicista sono le brevi pagine scritte per pianoforte, brani rievocanti lo stile post chopiniano (fra questi un manierato Valzer serenata, del 1942), a volte esplicitamente dedicate all’uditorio femminile (come Nel deserto, con il quale si rivolge alle lettrici del 32 “Secolo illustrato”) e più raramente animate da un ingenuo virtuosismo (Gerbre du feu). Un curioso episodio di cronaca, avvenuto alle Terme di Montecatini e riferito anche dai maggiori quotidiani del tempo, attesta, una volta di più, le buone capacità pianistiche di Umberto Giordano. Nell’estate del 1908, nella piccola cittadina termale della Toscana, il Teatro Olympia ospitava l’esibizione di un’apprezzata artista che, malauguratamente, si trovò impossibilitata a cantare, a causa di una grave indisposizione. Di fronte al pubblico che già affollava il teatro, si tentò di proporre una timida e giovane sostituta, che fu prontamente subissata dai fischi della platea. Un turista presente quella sera si fece avanti, dicendo di voler cantare lui. Si trattava di Enrico Caruso, che si trovava in quel momento a Montecatini in vacanza. Il leggendario tenore chiamò sul palcoscenico come accompagnatore al pianoforte un altro degli ospiti presenti in sala: l’elegante signore che si sedette al pianoforte era Umberto Giordano, anch’esso un affezionato delle terme, nonché marito di Olga Spatz, figlia del proprietario del prestigioso Grand Hotel & La Pace. Inutile sottolinearlo, la serata fu davvero memorabile. Oltre ai successi, la carriera di ogni buon pianista riserva talvolta immancabili e spiacevoli incidenti di percorso. Giunto alla notorietà con l’opera Mala vita (1892), ispirata a Scene popolari napoletane di Salvatore Di Giacomo e Goffredo Cognetti, Giordano fu invitato a suonare alcuni brani al pianoforte al “Circolo Dauno” di Foggia, la sua città. A metà del concerto, il povero compositore si accorse che l’uditorio, invece che seguire i suoi virtuosismi, era impegnato ai tavoli a giocare a carte e a discutere animatamente dei fatti propri. Profondamente offeso, Umberto decise di voltare le spalle per sempre alla natia Foggia. La città pugliese si riconcilierà con il proprio figlio solo nel 1928, quando ormai il nome del compositore era consegnato alla storia dell’opera per i successi di Fedora, Andrea Chénier, Siberia, Mese mariano. L’omaggio al celebre concittadino si manifestò pubblicamente con l’intitolazione del locale Conservatorio di Musica, del Teatro Comunale, di una piazza, dove la sua statua (soppiantando il Monumento ai Caduti), fu circondata da una corona di altre marmoree figure rappresentanti i personaggi delle sue opere. -------------------------------------------------------------------------- “Roma, S.E. Mascagni inizia il 70° anno di vita lavorando per una sua nuova opera lirica”. Questo è il titolo di un video che ritrae Pietro Mascagni al pianoforte, mentre accenna alcune idee musicali per il suo Nerone, tormentata opera che lo tenne impegnato per svariati decenni. Il pianoforte è un “verticale”, di buona marca e di notevoli dimensioni, come usava all’epoca. Mascagni aveva mani grandi, belle, adatte all’esecuzione pianistica. Nel filmato, il Maestro si ferma, porta alla bocca l’immancabile sigaro, poi continua a suonare: si ferma di nuovo, stavolta per scrivere qualche nota. Il cameraman ingrandisce l’inquadratura: il maestro livornese, con il lapis, traccia con sicurezza minuscoli segni sul pentagramma. Poi ricomincia a suonare, fino all’arrivo del nipotino che, esclamando “Auguri, nonno!”, lo interrompe definitivamente: ben lieto della sorpresa, posato il sigaro, abbraccia affettuosamente il bambino. Sono trascorsi due minuti e ventiquattro secondi, che il video ha dilatato nella nostra percezione, protesa a carpire ogni particolare, ogni indizio. Quel pianoforte, testimone del tentativo di portare avanti quel Nerone così ostico, era sicuramente uno strumento di gran lunga migliore di quello che in gioventù aveva noleggiato, in un momento di particolari ristrettezze economiche, a tre lire al mese. Sul quel modestissimo “Colombo” (probabilmente uno dei primi strumenti realizzati dalla piccola fabbrica brianzola fondata da Angelo Cesare Colombo), aveva però composto il capolavoro grazie al quale il nome di Mascagni si 33 guadagnò imperitura gloria. Per riconoscenza verso il modesto, ma fido strumento, il Maestro aveva scritto di proprio pugno al suo interno, sul telaio: Coll’aiuto di Dio e di questo pianoforte Pietro Mascagni compose la Cavalleria Rusticana a Cerignola nell’anno 1889 Esistono testimonianze sonore del Mascagni pianista. Ricorderemo in particolare un “rullo” per pianoforte automatico, dove il Maestro esegue, con buona proprietà tecnica, il suo “pezzo forte”, ossia l’Intermezzo della Cavalleria Rusticana. Pur disponendo di una dote non comune per l’esecuzione pianistica, il maestro livornese frequentò, soprattutto nei primi anni di studio, insegnanti di pianoforte di scarso livello. Per di più, al Conservatorio di Milano, Mascagni non si comportò certo da allievo modello. Si dice che fosse un alunno insofferente delle regole e di qualsivoglia imposizione. Le ripetute assenze e la scarsa applicazione dimostrata nello studio provocarono un’inevitabile rottura con gli insegnanti, per cui, nel 1885, Mascagni abbandonò il Conservatorio di Milano per girovagare al seguito delle compagnie d’operetta. Nel periodo degli studi a Milano, divise una stanza in affitto con Giacomo Puccini. L’amicizia con l’autore di Bohéme fu molto stretta e fraterna, tanto più perché nata in tempi dove la solidarietà tra colleghi era indispensabile anche solo per la quotidiana sopravvivenza. Giacomo, rispetto all’amico, era considerato più “benestante”, potendo contare su una borsa di studio di 125 lire, superiore di ben 25 lire rispetto a quella di Pietro. Per guadagnarsi qualche lira in più, l’eclettismo strumentale di Mascagni era una preziosa risorsa. Lo troviamo suonatore di contrabbasso alla “prima” al Teatro dal Verme, de Le Villi, l’opera di esordio dell’amico Puccini. Con il pianoforte il compositore livornese aveva un rapporto molto disinvolto: fu per lui agevole svolgere quotidianamente il ruolo di maestro al pianoforte nell’operetta, attività che richiedeva doti non comuni di versatilità ed estemporaneità, unite a buona padronanza della tastiera. Purtroppo il catalogo delle opere pianistiche di Mascagni non è particolarmente ricco, pur presentando pagine di un certo interesse. Fra queste, il felice aforisma di sapore partenopeo Sulle rive di Chiaja, composto forse nel 1882, ma pubblicato sul “Corriere Musicale dei piccoli” soltanto nel 1923. Questo brano, contrappuntato da tremoli evocativi del suono del mandolino, fu eseguito per la prima volta il 27 aprile 1882 al Teatro degli Avvalorati di Livorno, durante una replica della cantata Alla gioja, dal pianista Tebaldo Bronzini, e riproposto al Conservatorio “Cherubini” di Firenze l’8 febbraio 1883. Oltre al delizioso intermezzo Tomina, vivace ritratto musicale della cagnetta di casa Mascagni, sono degni di memoria e di esecuzione odierne due brani: Sunt lacrymae rerum, pensoso contributo di memoria virgiliana al King Albert’s book, pubblicato come gesto di solidarietà nei confronti del Belgio, invaso nel 1914 dalle truppe tedesche; Intermezzo, composto a Cerignola il 26 ottobre 1888, interessante archetipo pianistico della celebre pagina sinfonica centrale di Cavalleria Rusticana. 34 Ruggero Leoncavallo mentre incide un rullo per pianoforte automatico 35 Leoncavallo e Puccini Molti conoscono Ruggero Leoncavallo solamente come l’autore dell’opera Pagliacci. In tanti lo hanno definito “il musicista di un’opera”, quasi evidenziando una certa inerzia creativa, un appagamento subentrato dopo il raggiungimento del successo. La verità va ben oltre le apparenze superficiali: Leoncavallo fu per tutta la vita un personaggio vulcanico, iperattivo al limite della frenesia, traboccante di idee, sogni nel cassetto, progetti ambiziosi. Semmai peccava di incostanza, disorganizzazione del lavoro, poca concretezza, e razionalità: difetti che, uniti ad una vocazione per le imprese donchisciottesche e ad un carattere particolarmente suscettibile, causarono a Leoncavallo non poche difficoltà, che generarono un prematuro e malinconico declino artistico. Dopo il clamoroso successo di Pagliacci, pensò di ripetersi sugli stessi livelli con titoli che ispiravano particolarmente la sua fantasia. Scènes de la vie de bohème di Henry Murger sembrava offrire l’argomento ideale per un viaggio a ritroso nel libro dei ricordi, in particolare quelli della gioventù trascorsa a Parigi. Commise però l’errore di confidare l’ambizioso progetto all’amico Giacomo Puccini, che, sentito l’editore Ricordi, pensò pure lui di cimentarsi nell’impresa, per conto proprio e in concorrenza con Leoncavallo. Il resto della storia delle due Bohéme è facilmente intuibile: per una serie di circostanze e situazioni che si verificarono, prevalse quella di Puccini, condannando al dimenticatoio l’altra. A questa cocente delusione seguirono, per Leoncavallo, altre imprese fallimentari, che gettarono il povero musicista in quella rancorosa depressione che lo afflisse fino al termine dei suoi giorni. Per tutto l’arco della tormentata vicenda umana ed artistica di Ruggero Leoncavallo, il pianoforte fu per il musicista un amico fedele, discreto confidente di ogni fantasia creativa, di ogni idea melodica, di ogni intuizione armonica. Egli fu un buon pianista, versatile esecutore e anche paziente insegnante. Testimonianza dell’attività didattica del musicista è una pagina pentagrammata autografa, a noi pervenuta, contenente utili esercizi tecnici destinati a qualche discepolo alle prime armi. Leoncavallo, come ogni buon maestro, raccomandava insistentemente uno studio paziente: ”l’esercizio va eseguito lentissimo”, leggiamo nella didascalia, che il severo insegnante non mancò di rimarcare con una tripla sottolineatura. Il documento risale probabilmente agli ultimi anni del musicista, trascorsi fra mille difficoltà a Montecatini Terme. Nelle ristrettezze economiche di quei momenti, qualche lezione privata di pianoforte, seppur impartite ad allievi mediocremente dotati, non poteva che giovare alle disastrate finanze del povero Ruggero. Il pensiero, allora, correva lontano, quando, poco più che ventenne, si recò in Egitto per insegnare l’arte del pianoforte al fratello del Kedivé. Leoncavallo approdò speranzoso nella terra dei Faraoni: qui tenne con successo anche numerosi concerti, e tutto grazie allo zio materno Giuseppe D’Auria, che aveva fatto fortuna in Egitto, tanto da guadagnarsi il titolo di bey. Anche il primo insegnante di pianoforte di Leoncavallo, Luigi Siri, era stato a lungo alla corte del viceré d’Egitto, per cui è possibile che anche il maestro, assieme allo zio, abbia proposto al giovane Ruggero l’avventura in terra 36 africana. Con Due pezzi di stile arabo il compositore rievocherà, con una punta di malinconia, quell’atmosfera fiabesca ed incantata che aveva contemplato con ingenuo stupore. Leoncavallo aveva studiato a Napoli, e con buonissimi maestri. Si trattava di figure di spicco della cultura musicale partenopea, come il già citato Siri (pianista divenuto celebre per le sue funamboliche esecuzioni dell’arduo Moto perpetuo di Carl Maria von Weber, brano che faceva studiare ostinatamente anche ai discepoli), Francesco Simonetti (allievo del leggendario Francesco Lanza), e soprattutto Beniamino Cesi. Il carattere incostante e ribelle dell’autore di Pagliacci fece sì che, degli insegnamenti di questi grandi didatti, egli prendesse in considerazione solo gli aspetti più pratici e immediatamente applicabili nella pratica esecutiva, ignorando con disinvoltura quelli che gli apparivano troppo accademici e formali. Inoltre, il giovane Ruggero restò molto impressionato dall’arte esecutiva del grande pianista russo Anton Rubinstein, che ebbe modo d ascoltare in un concerto a Napoli all’Hotel De La Ville. Dopo i successi in terra d’Egitto, il pianista Ruggero Leoncavallo approdò a Parigi, senza un soldo in tasca. Nel tentativo di trovarsi un lavoro in tempi brevissimi, il 9 luglio 1882 fece pubblicare, tra gli annunci economici del giornale teatrale Le Ménestrel, due righe di presentazione: Annunciamo l’arrivo a Parigi di un giovane poeta e musicista italiano, m° Leoncavallo D’Auria, che viene a farsi conoscere dagli artisti e dai dilettanti francesi. Riuscì a procurarsi nell’immediato alcune scritture per suonare a cinque lire al giorno nei pomeriggi musicali dei caffè di terz’ordine. Grazie alla sua notevole abilità dimostrata alla tastiera, trovò una migliore sistemazione sottoscrivendo un contratto da otto franchi al giorno in un’osteria situata a Creil nell’Oise, dove, assieme ad artisti di cabaret, intratteneva i clienti. A dire il vero, in questo nuovo lavoro non disponeva di un pianoforte, ma di un armonium assai malridotto. Un destino poco gratificante, per un rampollo di Cesi che sognava di emulare le gesta di Anton Rubinstein. L’apprezzamento per il giovane napoletano crebbe, tanto da incuriosire Paul Renard, direttore dell’Eldorado, rinomato caffè concerto del Boulevard de Strasbourg. Negli anni del fatale declino, troviamo Leoncavallo protagonista al pianoforte di numerose serate, spesso a scopo benefico. Sulle pagine de Il Tettuccio - Corriere dei Bagni di Montecatini leggiamo varie testimonianze di questa attività intrapresa con entusiasmo dal musicista napoletano. Per fare un esempio, il cronista del notiziario locale ci racconta che il 4 settembre 1912 Leoncavallo prese parte attiva, insieme al cast vocale dell’imminente prima londinese della nuova opera Zingari (“accompagnati al piano dall’illustre autore”), ad un concerto benefico al Teatro delle Varietà. L’arte pianistica di Ruggero Leoncavallo è testimoniata anche dalle incisioni, pervenuteci su disco e su rullo “Welte Mignon Piano”. In un disco da 12,7 centimetri, registrato in un hotel di Milano nell’aprile del 1904, possiamo apprezzare la celeberrima Mattinata cantata da Enrico Caruso, con Leoncavallo al pianoforte. Tra le nebbie acustiche di una registrazione vetusta e scarsamente fedele, possiamo ammirare con quale arte pianistica, la stessa sperimentata con svariati cantanti negli anni della gavetta parigina, il musicista partenopeo supporti il grande Caruso. Per quanto riguarda i “rulli di pianola”, Leoncavallo ne incise almeno sei l’8 dicembre 1905 nello Schweizerisches Musik Automaten Museum di Seewen, dove sono tuttora conservati. I brani eseguiti dal Maestro e immortalati dal “Welte Mignon Piano” erano: il preludio dall’opera I Medici, l’intermezzo dai Pagliacci, il Valzer di Musetta, da Bohème, Flirt-Walzer, Romanza; Au bord du lac. Probabilmente, questi preziosi documenti non sono i soli del genere, ma semplicemente quelli di cui abbiamo notizia: ne potrebbero esistere altri, soprattutto rulli, sepolti in qualche angolo nell’oblio dei tempi che furono. Del Leoncavallo pianista ci restano inoltre le composizioni, che sono abbastanza numerose e, in alcuni casi, degne della massima attenzione. Accanto a pagine tutto sommato anonime, come il Notturno in mi bemolle 37 maggiore, lo Spanish Album-Suite de concert, ingenua emulazione dello stile di Albeniz, o il fragoroso aforisma Tema di marcia trionfale per l’eroica armata italiana di Tripoli (26 dicembre 1911), possiamo invece apprezzare brani di assoluto pregio, tutt’ora meritevoli di essere eseguite. Tra queste, Invocation à la Muse, pubblicata da Max Brockaus di Lipsia nel 1887, intensa pagina pianistica elaborata dal poema sinfonico Le nuit de mai, composto nell’anno precedente. Ricorderemo anche la magica atmosfera del paesaggio svizzero di lisztiana memoria, evocato da Au bord du lac-Rêverie, scritto a Brissago il 15 Aprile del 1904 e dedicato a Lorenzo Sonzogno, e il piglio tutto partenopeo di Nights of Italy (rifacimento di una lirica per canto e pianoforte del 1907), stampata da Enoch & Sons nel 1913. Leoncavallo dedicò “All’amico Carlo Macchi” una irresistibile Marcia Yankée, già precedentemente pubblicata a Chicago (1906) con il titolo Viva l’America e basata sul tema di Yankee Doodle, la nota canzone patriottica americana. Questa curiosa composizione risale ad un viaggio negli Stati Uniti e fu dedicata da Leoncavallo al presidente americano Theodor Roosevelt. Di questo brano, nei confronti del quale l’illustre dedicatario restò assolutamente indifferente, l’autore elaborò varie versioni, fra le quali una per pianoforte e piccola orchestra. Un discorso a parte merita il delizioso valzer Primo bacio, pagina ricavata dal motivo principale dell’operetta Il primo bacio, rappresentata a Montecatini dopo la morte dell’autore grazie alla collaborazione di Salvatore Allegra, interpellato dalla vedova per “risistemare” le carte del musicista scomparso. Anche con Ruggero Leoncavallo è opportuno allargare il catalogo delle composizioni pianistiche alle riduzioni e alle trascrizioni provenienti dal repertorio operistico. Il fatto che il Maestro abbia registrato su rullo gli adattamenti pianistici di alcuni suoi “successi”, come il celeberrimo Intermezzo da Pagliacci, attesta la dignità di queste pagine provenienti dal palcoscenico operistico, e le rende meritevoli di figurare ancora oggi sia nei programmi concertistici che nelle incisioni discografiche. -------------------------------------------------------------------------- Il giovane Puccini non ebbe insegnanti di pianoforte di chiara fama. D’altronde, Giacomo non aveva alcuna velleità virtuosistica, considerando il pianoforte solo come lo strumento indispensabile al lavoro quotidiano del compositore. Non poteva essere diversamente: nel glorioso albero genealogico della famiglia Puccini non si ricordavano pianisti, ma, ab initio, organisti di tutto rispetto: dal capostipite Giacomo (1712 – 1781), ad Antonio Benedetto Maria (1747 – 1832), a Michele (1813 – 1864), padre dell’autore di Bohéme. Il pianoforte giunse in casa Puccini per caso, quando Antonio Benedetto sposò Caterina Tesei (1747 – 1818), che, proveniente da una famiglia di musicisti bolognesi, era pianista di un certo valore, tra le prime che si ricordino in Italia. L’abate Jacopo Chelini, cronista, e buon suonatore di viola, dell’epoca, nel suo Zibaldone in dodici volumi, tra le maggiori fonti d’informazione sulle cronache lucchesi al tempo del principato Bonaparte Baciocchi, definisce Caterina Bravissima suonatrice di pian forte, fu d’essa che portò in Lucca l’arte, e la maniera, e il portamento della mano per eseguire con facilità le sonate più difficili, delle quali cose in Lucca non v’era idea alcuna. 38 Dal matrimonio nacque, il 15 aprile 1772, Domenico Vincenzo, che, avviato allo studio del pianoforte dalla madre, fu indirizzato verso una sicura carriera di musicista, formandosi in centri d’eccellenza come Bologna e Napoli. Nella Lucca napoleonica, dove i francesi portarono gli echi dei fasti parigini, e con essi l’uso salottiero del pianoforte, Domenico trovò un ambiente ideale dove proporsi anche come brillante esecutore alla tastiera. L’abate Luigi Nerici, nella sua Storia della musica in Lucca (1879), riconosce al giovane rampollo della dinastia pucciniana ottime doti di pianista, attribuendogli il merito di aver dato, con il suo operato, un notevole impulso alla divulgazione dello strumento nella cittadina Toscana. La carriera di Domenico Puccini fu notevolmente agevolata dall’adesione del musicista agli ideali napoleonici e dall’aperto collaborazionismo manifestato nei confronti dei potenti. Scorrendo nel catalogo delle sue opere, troviamo un Omaggio a Napoleone I Imperatore, encomio assai compromettente per il musicista, che, alla caduta del tiranno, precipitò in disgrazia. La morte di Domenico Puccini, avvenuta in circostanze misteriose il 25 maggio 1815, appare particolarmente sospetta e sicuramente riconducibile agli eventi che segnarono la mutata situazione politica. Giacomo Puccini, cui la madre, memore delle disavventure del nonno napoleonico, raccomandava di stare alla larga dalla politica, mantenne nei confronti del potere un atteggiamento cauto e, in definitiva, qualunquistico. Emulò invece l’avo nelle gesta di abile pianista da salotto. Pur non disponendo di una tecnica sopraffina, poteva però contare su particolari doti istrioniche di brillante intrattenitore. Puccini, al pianoforte, sapeva come farsi ascoltare, grazie ad un magico feeling con il pubblico, soprattutto con quello femminile. Giovane in cerca di gloria, partecipava con successo alle serate nei salotti culturali milanesi. Le sue esecuzioni al pianoforte lasciavano il segno, come quando, in casa del giornalista Marco Sala, eseguì alcune pagine de Le Villi, guadagnandosi sul campo i fondi necessari per l’allestimento della prima rappresentazione della sua opera di esordio. Le composizioni originali che Puccini dedicò al pianoforte sono veramente poche. Non fanno parte di questo già esiguo catalogo le tre danze, Allemanda, Corrente e Gavotta, erroneamente attribuite a Giacomo, e, in realtà, opera al padre Michele. Altre due composizioni, Foglio d’album e Piccolo tango, non convincono tutti gli esegeti, che le considerano di assai dubbia attribuzione pucciniana. I sostenitori dell’autenticità di queste pagine le fanno risalire al soggiorno a New York del 1910, al tempo della “prima” della Fanciulla del West. Dopo un lungo periodo di oblio, i due brani furono pubblicati negli U.S.A. nel 1942 dalla Edward B. Marks Music Corporation. In ogni caso, si tratta di pagine di modesto valore, che nulla aggiungono alla grandezza dell’autore di Turandot. Foglio d’album presenta un sapore vagamente scriabiniano, mentre Piccolo tango ricorda un po’ La soirée dans Grenade della serie Estampes di Claude Debussy. Di indiscutibile attribuzione sono invece un Adagio in la maggiore, che risale al periodo degli studi milanesi; la marcia Scossa elettrica, scritta nel 1896 per il Comitato dei Telegrafisti costituitosi in occasione del centenario dell’invenzione della pila di Alessandro Volta; un Piccolo valzer, pubblicato nel 1894 sulla rivista genovese “Armi ed arte”; infine un Calmo e molto lento datato Torre del Lago 1916. L’Adagio, conservato a Lucca presso la Biblioteca dell’Istituto “Luigi Boccherini”, fu riproposto, con opportune modifiche, in una pagina orchestrale dell’opera Le Villi. Ritroviamo invece il Piccolo valzer nel secondo atto di Bohéme: nella versione operistica il pezzo è universalmente conosciuto come il Valzer di Musetta. Il Calmo e molto lento, pagina di rara intensità, moderna per modello estetico e scrittura pianistica, fu scritta per una pubblicazione a scopo benefico, i cui proventi sarebbero andati a favore delle famiglie delle vittime della Prima Guerra Mondiale. Se alle poche pagine originali aggiungiamo anche alcuni adattamenti dalle opere, l’interesse per il repertorio pianistico pucciniano cresce enormemente. Di grande effetto è la versione pianistica dell’Intermezzo della Manon Lescaut, la cui strumentazione, sicuramente perfettibile, è ampiamente compensata da intensità struggente e umbratile 39 languore crepuscolare. Lo stesso si può dire di alcune pagine da Bohéme, che alcuni pianisti d’ingegno hanno provato a proporre in pubblico, previo qualche ritocco migliorativo della scrittura strumentale. Concludiamo osservando le foto e i rari filmati pervenutici e che ritraggono Puccini al pianoforte. Lo ammiriamo, in una celebre foto, seduto al suo magnifico Steinway, con la mano sinistra, bella e ampia, appoggiata sulla tastiera; lo osserviamo anche in un prezioso filmato, mentre improvvisa qualcosa di curioso ed estemporaneo su un piccolo “verticale”. In un altro video vediamo il Maestro che suona con disinvoltura: per i limiti tecnologi del film dell’epoca, non abbiamo il suono prodotto dall’esecutore, ma la gestualità ci appare sicura e tecnicamente appropriata. Puccini suona, si ferma, osserva lo spartito: riparte, un po’ corrucciato. Poi intravede il sigaro toscano posato a destra, oltre l’ultimo tasto: si interrompe per prenderlo e portarselo alla bocca. E poi ricomincia a suonare, con ispirata non chalance … Giacomo Puccini e il suo pianoforte Steinway 40 Dal “Lied senza parole” a “L’art du Chant au Piano” Fin dai tempi di Claudio Monteverdi, ossia agli albori del “Recitar cantando” e del nascente repertorio operistico, si accese, soprattutto in Italia, una vivace polemica tra i sostenitori della supremazia della musica sulle parole, e coloro che ritenevano invece che essa dovesse asservirsi al testo letterario, ponendosi in un piano subalterno. La dibattuta questione fu anche oggetto di simpatiche parodie teatrali, come Prima la musica, poi le parole (1786) di Antonio Salieri. Nel mondo germanico, la disputa assunse toni altamente filosofici. Arthur Schopenauer, nella sua opera più importante, Il mondo come volontà e rappresentazione, attribuisce alla musica un valore di assoluta supremazia rispetto alle altre arti, ponendola al vertice di esse. Il potere della musica, proprio grazie alla sua costitutiva asemanticità, si spinge ben oltre quello della parola, esprimendo l’inesprimibile, e ponendosi così come linguaggio assoluto e universale. Essa, al contrario delle arti che si servono del linguaggio parlato, oggettivizza la “Volontà” in modo immediato, consentendo di squarciare il “Velo di Maya” e catturando così la vera essenza della realtà. Schopenauer ammette la possibilità di unire musica e parola, ma a patto che il testo sia totalmente asservito all’espressione musicale. Il Lied, che costituì il genere vocale cameristico per eccellenza nella cultura germanica, con numerose importanti raccolte di canti, composti da Schubert, Schumann, Mendelsshon, Brahms e molti altri, poneva come presupposto formale l’equilibrio paritetico fra testo poetico cantato e parte pianistica di supporto. Complice l’eccelsa qualità dei testi poetici (di Goethe, Heine, Schiller), nel repertorio liederistico la parola costituiva una componente importantissima. Il pianoforte, con la sua sonorità caratteristica, assumeva, in linea con il pensiero di Schopenauer, i contorni di un personaggio metafisico, che trasfigurava, oltre la razionale percezione, i sentimenti espressi dal testo poetico. Emblematico, a questo riguardo, ci sembra, fra tanti, il Lied D. 328 Erlkönig (Il Re degli Elfi), che Franz Schubert compose nel 1815 sul testo dell’omonima ballata di Wolfgang Goethe. Parallelamente al Lied, prese campo anche un genere musicale, destinato al pianoforte solistico, che decretava la superiorità espressiva della musica “pura”rispetto a quella che supportava un testo letterario, ponendo in atto quanto espresso da Schopenauer ne Il mondo come volontà e rappresentazione: la “Romanza senza parole” (in tedesco “Lieder ohne Worte “), ossia un Lied dove il testo poetico è subliminale, ed evocato ancor più potentemente dal suono del pianoforte. Fu Felix Mendelsshon che, probabilmente ispirato dalla sorella Fanny (anch’essa compositrice), che pubblicò a Londra nel 1832 la prima raccolta di Lieder ohne Worte, precisamente l’op.19 b. Queste prime “Romanze senza parole”, composte fra il 1829 ed il 1830, si presentano come pagine di semplice esecuzione, essenziali nella forma, adatti all’esecuzione salottiera e destinati ad un pubblico del tutto simile a quello cui si rivolgeva il Lied. Se si prende in esame il primo brano di questa raccolta di esordio, appare evidente l’ispirazione vocale della melodizzazione: il pianoforte imita l’espressività della voce umana, potenziandola con quella profonda indeterminatezza che Schopenauer aveva attributo in via esclusiva alla “musica pura”. Anche alcune raccolte pianistiche di Schumann presentano le caratteristiche della “Romanza senza parole”: Waldszenen op. 82, e, soprattutto, Kinderszenen op. 15, della quali il primo brano (“Von fremden Ländern und Menschen”) denota forti analogie con la prima delle 41 “Romanze” di Mendelsshon. La fortuna della “Romanza senza parole” percorre tutto l’800, sino ad arrivare a Johannes Brahms, i cui “Intermezzi” propongono gli echi crepuscolari dei suoi struggenti Lieder. La “Romanza senza parole” per pianoforte fu apprezzata anche nell’Italia del melodramma: lo stesso Giuseppe Verdi ne compose una, intitolandola, alla francese, Romance sans paroles. Questo breve aforisma, datato 20 novembre 1844,, testimonia l’attività del giovane Verdi quale “pianista intrattenitore” in casa del suocero/mecenate Antonio Barezzi, in quelle riunioni musicali salottiere dove la provinciale Busseto emulava, in toni seppur dimessi, i costumi dell’alta società viennese. -------------------------------------------------------------------------- L’utopia sonora ideata degli intellettuali fiorentini, e che originò la costruzione del primo pianoforte della storia, si realizza pienamente nella pubblicazione, tra il 1853 ed il 1863, dei quattro fascicoli de “L’Art du Chant au Piano” di Sigismund Thalberg. “L’Arte del Canto al Pianoforte” è preceduta da un’ampia introduzione, dove l’autore premette con estrema chiarezza che, per raggiungere una qualità esecutiva al pianoforte di buon livello, è necessario ispirarsi al modello sonoro del canto. Sarà il pianista a escogitare quelle accortezze idonee affinché la meccanica dello strumento si adegui alla natura espressiva tipica della voce. A questa premessa fondamentale seguono alcuni consigli pratici destinati agli esecutori che volessero affrontare con mezzi tecnici adeguati i venticinque brani contenuti ne “L’art du Chant”. Ci pare molto interessante la scelta antologica operata da Thalberg: la raccolta di trascrizioni pianistiche comprende in prevalenza brani operistici, ma anche composizioni sacre e perfino Lieder, tracciando così un quadro totale e rappresentativo di ogni genere vocale del periodo. Tra le pagine operistiche ci piace ricordare la deliziosa “Voi che sapete” (francesizzato da Thalberg in “Mon coeur soupire”) da “Le Nozze di Figaro” di Mozart, una godibilissima “Casta Diva” di Bellini (che merita sicuramente spazio anche negli attuali programmi concertistici, cosi come “Perché mi guardi e piangi” dalla “Zelmira” di Rossini), e poi Weber, Mercadante, Grétry, Donizetti ed altri ancora. Nell’ambito sacro, troviamo la leggendaria “Aria di chiesa” di Stradella, ed una bella versione del “Lacrymosa” dal “Requiem” di Mozart, mentre il settore liederistico è ben rappresentato da “Die schöne Müllerin” di Schubert. Chi era Sigismund Thalberg? Al di là dei banali dati anagrafici, facilmente reperibili, possiamo definirlo come il pianista che rivaleggiò alla pari con Franz Liszt. L’occasione di confrontarsi fra i due contendenti si concretizzò in un evento organizzato ad arte dalla principessa di Belgiojoso. La vulcanica nobildonna, a seguito della morte della madre, aveva chiuso il suo rinomato salotto, luogo d’incontro di numerosi personaggi del mondo della cultura, della musica, della politica: tuttavia, continuò a ricevere, in forma poco più che privata e nella sua abitazione di rue d’Anjou Saint-Honoré, una ristretta cerchia di conoscenti particolarmente selezionati. Anche in questa forma ridotta, nel salotto della Belgiojoso non mancarono gli eventi memorabili. Il 31 marzo 1837, di fronte ad un piccolo uditorio di pochi privilegiati, che avevano pagato quaranta franchi a testa per assistere al memorabile evento, Franz Liszt sfidò Sigismund Thalberg in un torneo che avrebbe dovuto designare il più grande pianista del momento. L’incasso, peraltro ingente, fu devoluto dalla padrona di casa in beneficenza. Thalberg, appena giunto a Parigi, aveva mietuto clamorosi successi, minacciando di oscurare l’astro di Liszt. La 42 serata non smentì le attese: Thalberg eseguì in modo mirabile una sua fantasia sul Mosè di Rossini; Liszt improvvisò in maniera memorabile sulla Niobe di Giovanni Pacini. L’esito della sfida fu assai incerto, in quanto il pubblico si divise nel giudicare le esecuzioni: alcuni dichiararono Thalberg inarrivabile, altri non avevano dubbi sulla superiorità di Liszt. La polemica divampò, coinvolgendo anche la stampa locale. Il critico Fétis prese le difese di Thalberg, argomentando come il suo stile esecutivo aprisse le porte alla musica del futuro. Liszt rispose con un articolo nel quale metteva in ridicolo le composizioni del rivale. Dal canto suo, Cristina di Belgiojoso gongolava, sia per l’aver dato vita una serata memorabile, sia per l’aver ricavato una cifra in denaro ragguardevole, da destinare, in “beneficenza”, agli amici patrioti per finanziare i vari focolai di rivolta irredentista che divampavano in terra d’Italia. Sigismund Thalberg sposò nel 1843 la figlia del cantante napoletano Luigi Lablache. Si ritirò nel quartiere Posillipo di Napoli nel 1858, in una villa di proprietà dei Lablache, dove dispenserà saggezza pianistica ad alcuni talentuosi giovani del luogo, fra i quali spicca il nome di Beniamino Cesi. Morirà il 27 aprile 1871. -------------------------------------------------------------------------- Meno codificato a livello didattico e teorico, ma non meno esplicitamente ispirato al modello vocale, il pensiero pianistico di Fryderyk Chopin sembra legarsi indissolubilmente allo stile melodico di Vincenzo Bellini. Soprattutto in alcuni dei suoi “Notturni” (in particolare l’op. 27 n°2), ma anche in numerosi altre composizioni (emblematico l’Andante Spianato che precede la Polonaise brillante op.22), Chopin sembra imitare fedelmente la lirica flessuosità delle arie belliniane, superando i limiti imposti dalla meccanica dello strumento grazie ad una scrittura pianistica assai più sobria e moderna rispetto a quella elaborata da Thalberg. Inoltre, al contrario dell’autore de ”L’Art du Chant”, il musicista polacco rivolge le sue attenzioni unicamente all’opera italiana del tempo, ignorando il repertorio liederistico e sacro. Unico fugace contatto con il Lied è costituito dai suoi diciannove “Canti polacchi” op. 74, omaggio commosso a quel repertorio musicale popolare tanto amato in gioventù. L’amore di Fryderyk per l’opera italiana nasce prestissimo, con l’incontro a Varsavia con il celebre soprano italiano Angelica Catalani (1780 – 1849). A ricordo di questo momento, indelebile nella memoria del compositore, resterà un orologio, dono della Catalani, dove si legge la seguente dedica: “Madame Catalani a Fryderyk Chopin, di 10 anni. Varsavia, 3 gennaio 1820”. L’opera, soprattutto quella italiana, era molto apprezzata a Varsavia: il direttore d’orchestra Karol Kurpinski, proponeva a quei tempi al Teatro Nazionale vari titoli, tra i quali spiccano il “Don Giovanni” di Mozart e “Il barbiere di Siviglia” di Rossini. Il giovane Chopin si dimostrò entusiasta soprattutto nei confronti del grande musicista pesarese, del quale conosceva all’epoca ben tredici opere. Nel periodo varsaviano, Fryderyk si cimentava spesso e volentieri nell’accompagnamento al pianoforte dei cantanti. E proprio nella fase giovanile sentimentalmente più fantasiosa, coincidente con gli studi conservatoriali, Chopin fu folgorato dal fascino della cantante polacca Konstancja Gładkowska. La prima traccia di Kostancja nella vita di Chopin appare nell’autunno del 1829: Forse per la mia infelicità, ho già incontrato il mio ideale, che servo fedelmente senza parlargli, da mezzo anno. Di lui sogno le notti; esso mi ha ispirato l’adagio del mio concerto e, stamattina, questo valzer che ti mando. Attento al 43 passaggio segnato con una croce. Dico al pianoforte quello che avrei detto tanto volentieri a te, La lettera era indirizzata all’amico Tytus Woyciechowski e l’adagio in questione è il “Larghetto” del Concerto in Fa minore op. 21. Dalle lettere all’amico Tytus si intravedono squarci di vita musicale varsaviana, vissuta da Chopin con serenità e spensieratezza: Le undici e mezzo e io non sono ancora vestito, mentre mademoiselle Moriolles mi aspetta; poi la colazione da Celinski; poi ho promesso di andare da Magnuszewski. (…) Durante la prova del concerto ci saranno Kurpinski e Soliva, insomma il migliore mondo musicale, ma ho poca fiducia in questi signori, eccettuato Elsner. Sono curioso dello sguardo che l’italiano getterà sul direttore d’orchestra Kurpinski, Czapek su Kessler, Filip su Dobrzynski, Molsdorf su Kaczynski, Le Doux su Solyk e Poletyllo su tutti noi. Non è mai successo di vedere d’accordo tutti questi signori riuniti. Io ci arriverò e lo farò per realizzare un caso raro. Konstancja Gładkowska (1810-1889) era una cantante lirica (soprano) che studiò canto presso l'Istituto di Musica di Varsavia e recitazione sotto la guida di Carlo Evasio Soliva. La ragazza, che divenne “l’ideale” del giovane Chopin, debuttò il 24 luglio 1830 presso il Teatr Narodowy nel ruolo di Agnese nell’omonima opera di Ferdinando Paer (compositore italiano, che fu compagno della citata Angelica Catalani). Nonostante i sentimenti che il compositore nutriva per la giovane, il resoconto del debutto, riportato in un’altra lettera a Tytus Woyciechowski del 21 agosto, ci appare fin troppo critico e distaccato. L’onestà intellettuale tipica di Chopin prevalse dunque su ogni altra considerazione: Sono stato alla prima dell’opera “Agnese”. La Gładkowska non è stata per nulla convincente. Questa cantante risulta meglio sul palcoscenico che in sala da concerto. Non mi riferisco alla sua recitazione, che è eccellente, e su essa non c'è niente da dire: ma per quanto riguarda la sua tecnica vocale. Avrebbe un’ottima voce, se non fosse per certi difetti nei suoni acuti. Tuttavia, Konstancja ha cantato con espressione, e ciò è piaciuto molto all’uditorio, anche se in un primo momento, al suo ingresso sulla scena, la sua voce tremava: poi, dopo un inizio titubante, a preso coraggio ed è andata migliorando. Alla fine, ero contenuto: Konstancja è stata richiamata alla ribalta in un diluvio di applausi. L’incontro con Vincenzo Bellini avvenne invece negli anni parigini. Il non facile carattere di Chopin trovò nel compositore catanese una perfetta sintonia, parallela e forse complementare alla sorprendente mimesi tra il canto dell’autore di “Norma” con il fascino sonoro del pianoforte chopiniano. Ironia della sorte, i due condivisero anche il male fatale che lì condusse nella tomba. Furono entrambi sepolti, l’uno nel 1835, l’altro nel 1849, nel cimitero parigino del Père – Lachaise. 44 Il soprano Angelica Catalani, in un dipinto del 1806 45 Felix Mendelssohn a 11 anni, al pianoforte 46 Fonti e bibliografia di riferimento M. Fabbri, L’alba del pianoforte. Verità storica sulla nascita del primo cembalo a martelletti, Brescia 1968 P. Rattalino, Storia del pianoforte, Milano 2008 P. Rattalino, Da Clementi a Pollini. Duecento anni con i grandi pianisti, Firenze 1999 S. Thalberg, L’art du Chant au Piano,(4 vol.), Parigi 1853 – 1863 P. Rattalino, Le grandi scuole pianistiche, Milano 1992 D. Pizzagalli: L’amica. Clara Maffei e il suo salotto nel Risorgimento, Milano 2004 V. Heiden-Rynsch: I salotti d’Europa, Milano 1996 G. Visconti Venosta: Ricordi di gioventù: cose vedute o sapute (1847 – 1860), Milano 1906 G. Volpe: Pagine risorgimentali, Roma 1968 M. Rossi: Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso. Il pensiero politico. Brescia 2005 C. Orselli, Mascagni, Palermo 2011 M. Lubrani/G. Tavanti, Ruggero Leoncavallo, i successi, i sogni, le disillusioni, Firenze 2007 O. De Ranieri/M. Lubrani/G.Tavanti, Puccini e le donne, Firenze 2009 L. Pinzauti, Puccini: una vita, Firenze 1974 M. Morini, Umberto Giordano, Milano 1968 G. Tavanti, La Fabbrica di Gioventù, Giuseppe Verdi alle Terme di Montecatini, Montecatini Terme 2013 G. Verdi, (a cura di Michele Porzio) Lettere 1835 – 1900, Milano 2000 47
Scarica