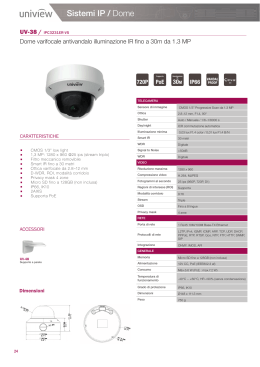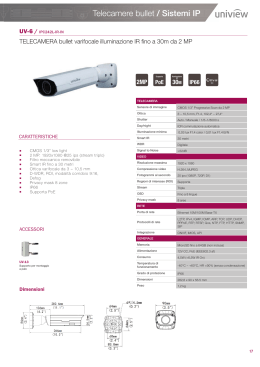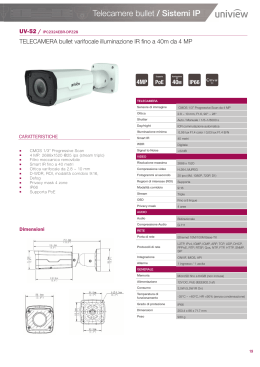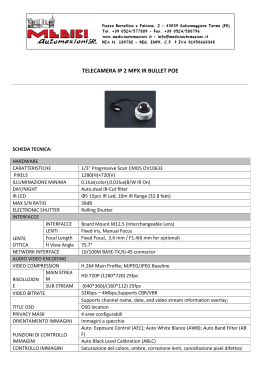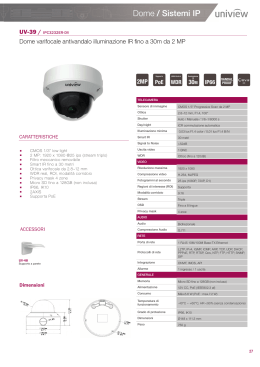MATTHEW PEARL
L'OMBRA DI EDGAR
(The Poe Shadow, 2006)
Ai miei genitori
NOTA DELL'EDITORE: Il mistero della strana morte di Edgar
Allan Poe nel 1849 viene svelato nelle pagine che seguono.
Vi rivelerò, Vostro Onore e signori della Corte, la verità sulla
morte di quest'uomo e sulla mia vita, una vicenda mai narrata finora. Per quanto sia stato privato di tutto, mi rimane ancora una
cosa: questa storia. Oggi sono presenti in aula alcuni abitanti
della nostra città che hanno cercato di farmi tacere per sempre.
Seduto qui tra voi, vi è chi ancora mi reputa un criminale, un bugiardo, un reietto, un assassino vile e scaltro. Me, Vostro Onore,
Quentin Hobson Clark, cittadino di Baltimora, membro del foro e
appassionato lettore. Ma questa storia non riguarda me. Se non
terrete conto di null'altro, vi prego di tenere conto almeno di questo. Non ha mai riguardato me; l'ambizione non c'entra. Quel che
è accaduto non è stato motivato dalla mia fortuna rispetto agli altri rappresentanti della mia classe né dalla mia reputazione agli
occhi di giudici superiori. Riguarda qualcosa più grande di me,
più grande di tutto questo, ovvero un uomo grazie al quale i posteri ci ricorderanno, sebbene voi l'abbiate dimenticato ancor
prima che la terra ricoprisse la sua bara. Qualcuno doveva pur
farlo. Non potevamo limitarci a tacere. Non potevo tacere.
Quanto segue è la pura verità. E io devo raccontarvela perché
sono il più vicino a essa. O meglio, l'unico ancora in vita.
Una delle stranezze dell'esistenza è che solitamente sono le storie
di chi non c'è più a racchiudere la verità...
Scarabocchiai queste righe sulle pagine del mio taccuino (l'ultima frase è
cancellata, al suo posto un «Retorico!» scritto a mano a mo' di commento).
Prima di recarmi in tribunale, scribacchiai queste parole nel disperato tentativo di predispormi ad affrontare i miei diffamatori, convinti che la mia
rovina fosse la loro salvezza. Poiché sono avvocato, penserete forse che la
prospettiva di ritrovarmi di fronte a un'aula di curiosi ed ex amici, oltre a
due donne che probabilmente mi volevano bene... penserete, dicevo, che
tale prospettiva non dovesse essere troppo preoccupante per un abile avvocato di Baltimora. Non è così. Per fare l'avvocato, occorre adoperarsi per
gli interessi degli altri. Questa professione non prepara a dedicarsi ai propri
interessi. Non prepara un uomo a salvare se stesso.
Libro primo
8 ottobre 1849
Capitolo 1
Ricordo il giorno in cui tutto ebbe inizio, perché aspettavo con ansia una
lettera importante. E anche perché quel giorno era previsto che mi fidanzassi con Hattie Blum. E, naturalmente, perché fu il giorno in cui lo vidi
morto.
I Blum abitavano poco lontano da casa mia. Hattie era la minore e la più
affabile di quattro sorelle, considerate forse le più graziose di Baltimora.
Ci conoscevamo da quando eravamo nati, come ci avevano spesso ripetuto
nel corso degli anni. E ogni volta che qualcuno ce lo rammentava ritengo
che sottintendesse anche: «E vi conoscerete per sempre, statene certi».
Nonostante quelle pressioni, che avrebbero tranquillamente potuto allontanarci, già a undici anni cominciai a comportarmi come un piccolo marito
nei confronti della mia compagna di giochi. Non le avevo mai fatto alcuna
dichiarazione d'amore esplicita, ma mi preoccupavo della sua felicità in
tanti piccoli modi mentre lei mi intratteneva conversando. Vi era qualcosa
di rasserenante nella sua voce, che sovente assomigliava a una ninnananna.
Crescendo, avevo sviluppato un'indole assai schiva e taciturna: quando
mi trovavo in società non di rado qualcuno mi domandava se mi fossi appena svegliato. In gruppi più ristretti diventavo invece inspiegabilmente
loquace, se non addirittura sconclusionato, nei miei discorsi. Pregustavo
dunque le lunghe e briose chiacchierate con Hattie. Vi facevo affidamento,
credo. Quando ero con lei, non avvertivo il bisogno di attirare l'attenzione
su di me; ero felice e a mio agio.
Orbene, dovrei precisare che non sapevo di dover chiedere la sua mano
proprio la sera del giorno in cui questo racconto ha inizio. Mi stavo recando dal mio studio legale all'ufficio postale poco distante, allorché mi imbattei nella signora Blum, la zia di Hattie, una donna della buona società di
Baltimora. Osservò subito che avrei dovuto affidare l'incarico di ritirare la
corrispondenza a uno dei miei assistenti più umili e meno indaffarati.
«Voi sì che siete un bel tipo, Quentin Clark!» commentò. «Vagate per le
strade quando lavorate e, quando non lavorate, avete un'espressione come
se steste lavorando!»
Era una tipica abitante di Baltimora; non sopportava un uomo senza adeguati interessi economici più di quanto sopportasse una ragazza che non
fosse bella.
Quella era Baltimora: sotto il sole come con la nebbia di quel giorno, era
un luogo assai frenetico, dove i movimenti delle persone sulle vie ben lastricate e sui gradini di marmo erano svelti e chiassosi ma privi di gaiezza.
Questa non era molto presente nella nostra intraprendente città, dove le
dimore, imponenti, s'innalzavano sopra un'affollata baia mercantile. Il caffè e lo zucchero giungevano dal Sudamerica e dalle isole delle Indie Occidentali a bordo di enormi velieri, e i barili di ostriche e farina partivano per
Filadelfia e Washington sulle rotaie ferroviarie in rapida moltiplicazione.
All'epoca, nessuno sembrava povero a Baltimora, neppure chi lo era, e i
negozi parevano, uno sì e uno no, centri di dagherrotipia pronti a immortalare quel fatto per i posteri.
In quell'occasione, la signora Blum sorrise e mi prese sottobraccio mentre percorrevamo la strada principale. «Be', è tutto pronto per questa sera.»
«Questa sera» le feci eco, cercando di indovinare a cosa si riferisse. Peter Stuart, il mio socio, aveva accennato a una cena da un conoscente comune. Ero così preoccupato per via della lettera che dovevo ricevere da essermi completamente dimenticato dell'impegno fino a quell'istante. «Questa sera, certo, signora Blum! Non vedo l'ora.»
«Sapete...» continuò «sapete, signor Clark, che solo ieri ho udito alcune
persone parlare della cara signorina Hattie in Market Street?» La sua generazione chiamava ancora Baltimore Street con il suo vecchio nome. «Sì, la
definivano la ragazza da marito più affascinante di tutta Baltimora!»
«Io oserei dire la più affascinante delle donne di Baltimora, comprese
quelle sposate» replicai.
«Senti, senti...» proseguì. «Sono commenti da farsi? Ancora celibe a
ventisette anni e... Ora non interrompetemi, caro Quentin! Un giovanotto
perbene non...»
Non capii quel che disse in seguito, perché il frastuono di due carrozze
risuonò alle nostre spalle. Se quella che sta arrivando è una vettura a nolo,
pensai, spingerò dentro la cara signora Blum e offrirò il doppio della tarif-
fa. Quando ci superarono constatai tuttavia che erano entrambe private, e
che quella davanti era un carro funebre lustro ed elegante. I cavalli tenevano la testa bassa, quasi in segno di rispetto per il loro solenne carico.
Nessun altro si voltò a guardare.
Dopo essermi congedato dalla mia accompagnatrice, mi ritrovai ad attraversare il viale successivo. Un branco di maiali mi passò accanto tra urla
bellicose, e la mia deviazione mi condusse lungo Greene Street fino a Fayette Street, dove i due veicoli che avevo visto passare poco prima erano ora
parcheggiati uno accanto all'altro.
Una cerimonia ebbe inizio e improvvisamente terminò in un tranquillo
cimitero lì vicino. Scrutai i presenti tra la nebbia. Era come vivere in un
sogno dove ogni cosa era una macchia indistinta, e scacciai la vaga sensazione che non mi sarei dovuto trovare lì. Dalla mia posizione accanto al
cancello l'orazione del sacerdote suonava attutita. Il gruppetto era così esiguo da non richiedere, suppongo, un grande sforzo alla sua voce.
Erano le esequie più tristi a cui avessi mai assistito.
Forse tale sensazione era accentuata dal tempo lugubre; oppure dallo
scarso numero di persone intervenute: quattro o cinque uomini, il minimo
indispensabile per sollevare la bara di un adulto. O forse la melanconia era
imputabile soprattutto alla conclusione fredda e sbrigativa della funzione.
Neppure il rito funebre del povero più indigente, neppure i servizi celebrati
nel camposanto degli ebrei bisognosi poco lontano da lì... neppure quelli
mostravano un'indifferenza così poco cristiana. Non vi fu nemmeno un fiore, nemmeno una lacrima.
Più tardi tornai sui miei passi solo per scoprire che l'ufficio postale era
chiuso. Nonostante non potessi sapere se vi fosse una lettera per me all'interno, feci rientro in studio e mi tranquillizzai. Presto avrei avuto sue notizie.
Quella sera, prima della cena, mi ritrovai a fare una passeggiata da solo
con Hattie Blum lungo un campo di bacche, ora dormienti per la stagione
ma memori dei ricevimenti estivi a base di fragole e champagne. Come
sempre, riuscii a parlare senza difficoltà con Hattie.
«A volte la nostra professione è interessantissima» affermai. «Credo tuttavia che dovrei scegliere i casi con maggior discernimento. Sapete, gli avvocati dell'antica Roma giuravano di non difendere mai una causa a meno
che non la ritenessero giusta. Noi, invece, accettiamo i casi se l'onorario è
adeguato.»
«Potreste modificare il ruolo che svolgete allo studio, Quentin. Dopo tutto, la targa reca anche il vostro nome e cognome. Rendetelo più simile a
voi, anziché adattarvi voi a lui.»
«Dite sul serio, signorina Hattie?»
Stava calando il crepuscolo, e Hattie divenne stranamente silenziosa, il
che significava, temo, che io ero diventato così loquace da risultare insopportabile. Studiai il suo volto, ma nulla indicava la ragione di quel comportamento distaccato.
«Ridevate al mio posto» aggiunse distrattamente, quasi sussurrando per
non farsi sentire.
«Signorina Hattie?»
Alzò gli occhi su di me. «Pensavo solo a quando eravamo bambini. Sapete che, sulle prime, vi avevo giudicato sciocco?»
«Me n'ero accorto» ridacchiai.
«Mio padre accompagnava mia madre a cambiare aria quando la sua malattia si acutizzava e allora voi venivate a giocare mentre mia zia mi accudiva. Eravate l'unico che riuscisse a farmi sorridere fino al ritorno dei miei
genitori, perché ridevate sempre delle cose più bizzarre.» Lo disse con nostalgia, sollevando l'orlo delle lunghe gonne per evitare che si sporcassero
nel terreno fangoso.
In seguito, dopo che fummo rientrati per scaldarci, Hattie prese a parlottare con sua zia, il cui atteggiamento si era irrigidito rispetto a qualche ora
prima. La donna le chiese come desiderasse festeggiare il suo compleanno.
«Già, si sta avvicinando» rispose Hattie. «Di solito non ci penso, zietta.
Ma quest'anno...» La sua voce sfumò in un mesto borbottio. A cena, non
toccò quasi cibo.
Quella situazione non mi piaceva affatto. Ebbi l'impressione di essere ridiventato l'undicenne sollecito difensore della ragazza che abitava sull'altro
lato della via. Hattie era stata una presenza così costante nella mia vita che
qualsiasi disagio da parte sua mi turbava. È probabile che io cercassi di risollevarle il morale per un puro moto egoistico, ma in ogni caso desideravo davvero che fosse felice.
Altri ospiti, come Peter, il mio socio, tentarono di rallegrarla, e li osservai uno a uno con attenzione per capire chi fosse colpevole di aver causato
in lei un attacco di depressione.
Ma, quella sera, qualcosa mi impediva di consolarla: il funerale cui avevo assistito. Non riuscivo a capire il perché, ma mi aveva completamente
destabilizzato rendendomi inquieto. Mi sforzai di rievocarne le immagini.
Soltanto i quattro uomini intervenuti avevano ascoltato l'orazione del sacerdote. Uno, più alto degli altri, era rimasto verso il fondo, lo sguardo rivolto lontano, come ansioso di essere altrove. Poi, mentre si dirigevano
verso la strada, mi avevano colpito le loro bocche arcigne. Pur non conoscendo i loro visi, non li avevo scordati. Solo uno aveva indugiato, rallentando i suoi passi con aria dispiaciuta, quasi mi avesse letto nel pensiero.
Quell'avvenimento mi sembrava indicare una perdita davvero terribile,
ma senza farle onore. In una parola, era sbagliato.
Nel torpore di quella distrazione indefinita, i miei sforzi si esaurirono
senza riuscire a restituire il sorriso a Hattie. Potei soltanto salutare con un
inchino ed esprimere il mio rammarico impotente insieme con gli altri invitati quando lei e zia Blum furono tra i primi ad andarsene. Fui lieto allorché Peter propose di imitarle.
«Ebbene, Quentin? Che cosa vi è preso?» mi domandò all'improvviso,
mentre tornavamo a casa con una carrozza a nolo.
Pensai di descrivergli la lugubre cerimonia, ma non avrebbe capito perché mi assillava tanto. Poi, dalla gravità della sua espressione, intuii che si
riferiva a tutt'altro. «Peter» lo interrogai «a cosa alludete?»
«Così avete deciso di non chiedere la mano di Hattie Blum questa sera?»
proseguì, espirando forte.
«Chiedere la sua mano? Io?»
«Compirà ventitré anni tra qualche settimana. Oggi, per una giovane di
Baltimora, equivale praticamente a essere una vecchia zitella. Non amate
nemmeno un po' quella cara ragazza?»
«Chi potrebbe non amare Hattie Blum? Ma aspettate, Peter, da cosa avete concluso che ci saremmo fidanzati questa sera? Avevo mai dato a intendere che quella fosse la mia intenzione?»
«Da cosa ho concluso...? Non sapete forse bene quanto me che oggi è la
ricorrenza del fidanzamento dei vostri genitori? Non vi è venuto in mente
neppure una volta durante la serata?»
In effetti, non mi era venuto in mente e, anche quando Peter mi rammentò quella coincidenza, non compresi i motivi della sua singolare supposizione. Zia Blum, aggiunse, aveva dato per scontato che avrei colto l'occasione del ricevimento per dichiararmi, e aveva persino creduto che vi avessi accennato nel pomeriggio, sicché aveva informato Peter e Hattie di quella possibilità affinché non restassero sorpresi. Dunque ero stato io la causa
principale e involontaria della misteriosa angoscia di Hattie. Ero stato io il
miserabile!
«Ci sarebbe forse stato momento più opportuno?» insistette Peter. «Un
anniversario così importante per voi! Quando, altrimenti? Era un'ipotesi
più che logica.»
«Non mi ero reso conto...» farfugliai.
«Come avete potuto non accorgervi che Hattie vi stava aspettando, che è
ora di dare inizio al vostro futuro? Be', eccovi arrivato. Vi auguro di dormire bene. Probabilmente, in questo istante, la povera Hattie starà inzuppando il cuscino di lacrime!»
«Non avrei mai voluto rattristarla» protestai. «Avrei solo voluto sapere
quello che, a quanto pare, tutti gli altri si aspettavano da me.» Peter borbottò qualche aspra parola di approvazione, dal momento che finalmente avevo compreso il mio madornale errore.
Certo che avrei chiesto la sua mano, certo che ci saremmo sposati! Hattie era sempre stata la mia buona stella. Mi illuminavo ogni volta che la
vedevo, e ancor più ogni volta che eravamo lontani e pensavo a lei. Da
quando ci conoscevamo, si erano verificati così pochi cambiamenti che mi
era semplicemente sembrato assurdo provocarli ora con una proposta di
matrimonio.
«Che cosa vi passa per il capo?» parve domandarmi Peter corrugando la
fronte mentre gli auguravo buona notte e chiudevo lo sportello della carrozza. Lo riaprii.
«Questo pomeriggio c'è stato un funerale» dissi, deciso a cercare di riscattarmi con una spiegazione. «Sapete, l'ho veduto passare, e suppongo
che mi abbia turbato per una ragione che non...» Ma no, non riuscivo ancora a trovare le parole per giustificare il suo effetto su di me.
«Un funerale! Il funerale di uno sconosciuto!» sbottò Peter. «Ebbene,
che cosa mai ha a che fare con voi?»
Tutto, ma allora non lo potevo sapere. L'indomani mattina scesi in vestaglia e sfogliai il giornale per distrarmi. Anche se qualcuno mi avesse
avvertito, non avrei potuto prevedere il mio sgomento di fronte a quanto
vidi, tanto che mi scordai di tutte le altre preoccupazioni. Ad attirare la mia
attenzione fu un titoletto su una delle pagine interne: Morte di Edgar A.
Poe.
Avrei lanciato il giornale e poi lo avrei recuperato, girando le pagine per
leggere qualcos'altro; poi lessi e rilessi quel titoletto: Morte di Edgar A.
Poe... illustre poeta, erudito e critico americano, all'età di trentanove anni.
No! Quaranta, calcolai, ma dotato di una saggezza che valeva cento volte tanto... «Nato in questa città.» Ancora no! Com'era tutto confuso, ancor
prima che ne sapessi di più!
Poi notai... quelle quattro parole: «Morto in questa città».
In questa città? Non era una notizia telegrafata, quindi doveva essere accaduto proprio qui a Baltimora. Morto nella nostra città, e forse anche sepolto. Poteva essere che il funerale tra Greene e Fayette Street...? No! Quel
misero funerale, quella cerimonia per nulla cerimoniosa, quella tumulazione nell'angusto cimitero?
Quel giorno, allo studio, Peter si lanciò in un altro sermone riguardo a
Hattie, ma quella notizia appresa dal giornale mi aveva incuriosito tanto
che faticai a discutere qualsiasi altra questione. Mandai a chiedere conferma al becchino, il custode del camposanto. «Povero Poe...» era stata la risposta. Sì, Poe era il morto. Mentre mi precipitavo all'ufficio postale per
verificare se fosse arrivata quella lettera, i miei pensieri vorticavano intorno a ciò di cui ero stato inconsapevole testimone.
Una formalità così spietata era stata l'addio di Baltimora al salvatore letterario della nostra nazione, al mio autore preferito, al mio (forse) amico?
Stentavo a frenare il sentimento di collera che cresceva dentro di me, una
collera tale da oscurare tutto il resto. Quello che si era spento poco lontano
da me era l'autore che prediligevo, ma già allora era molto di più. Probabilmente non riuscirò a spiegare in maniera sintetica e obiettiva il motivo
per cui quel fatto fu tanto sconvolgente per un giovanotto con prospettive
sentimentali e professionali che chiunque, a Baltimora, avrebbe reputato
invidiabili.
Forse dipese da questo: senza accorgermene, ero stato io, io, l'ultimo a
vederlo; o meglio, mentre tutti gli altri si allontanavano frettolosi, ero stato
l'ultimo a guardare la terra che tamburellava indifferente sulla sua bara,
come su tutti i cadaveri anonimi del mondo.
Avevo un morto come cliente e il Giorno del Giudizio come data dell'udienza.
Fu quello il commento beffardo di Peter quando iniziai le mie indagini
qualche settimana dopo. Il mio socio possedeva così poco il senso dell'umorismo che sarà riuscito a essere sarcastico non più di tre o quattro volte
in vita sua, sicché potete immaginare quale turbamento in realtà vi era dietro quelle parole. Peter, un uomo alto e robusto, aveva solo qualche anno
più di me, ma sospirò come un vecchio, soprattutto quando menzionai E-
dgar A. Poe.
Quando ero adolescente, due caratteristiche della mia esistenza erano già
apparse immutabili come il destino: la mia ammirazione per le opere letterarie di Poe e, come ho già più volte ripetuto, il mio affetto per Hattie
Blum.
Già da bambino, Peter aveva parlato del matrimonio fra me e Hattie con
la lucidità di un uomo d'affari. Nel suo animo assennato, quel fanciullo era
più grande di tutti gli altri ragazzi. Quando suo padre era morto, i miei genitori, tramite la parrocchia, avevano aiutato la signora Stuart, che era quasi caduta in disgrazia a causa dei debiti, e papà si era preso cura di Peter
come di un secondo figlio. Questi gli era stato così riconoscente da fare
proprie tutte le sue opinioni sulla vita con deferenza e sincerità, molto più
di quanto io fossi mai parso in grado di fare. Anzi, un estraneo avrebbe potuto credere che fosse lui il Clark legittimo, e io un mediocre pretendente a
quel cognome.
Peter aveva condiviso persino l'avversione di mio padre per le mie preferenze letterarie. «Questo Edgar Poe,» avevano continuato ad asserire entrambi «questo Poe che leggi con tanta passione è bizzarro al di là di ogni
buon gusto. Leggere per sfuggire al tedio è un semplice passatempo, non
più utile che sonnecchiare nel bel mezzo del pomeriggio. La letteratura
dovrebbe arricchire lo spirito; queste fantasie lo storpiano.»
Era così che quasi tutti giudicavano Poe, e all'inizio non avrei dato loro
torto. Ero da poco uscito dall'infanzia la prima volta che mi ero imbattuto
in un'opera di Poe, un racconto intitolato William Wilson e pubblicato sul
«Gendeman's Magazine». Confesso di non aver capito granché. Mi era
sembrato senza capo né coda, e non ero riuscito a distinguere le parti incentrate sulla ragione da quelle incentrate sulla follia. Era stato come tentare di leggere una pagina dopo averla messa davanti allo specchio. Nessuno
cercava il genio nelle riviste, e io non ne avevo scorta una maggiore quantità nel signor Poe.
Ma ero soltanto un ragazzo. Avevo cambiato parere dopo aver letto Gli
assassinii della Rue Morgue, un racconto d'investigazione appartenente a
un genere tipico di Poe. Il protagonista è C. Auguste Dupin, un giovane
francese che scopre abilmente la verità dietro l'efferato assassinio di due
donne. La prima viene rinvenuta in una dimora di Parigi, conficcata a testa
ingiù nel camino. Frattanto, l'altra vittima, sua madre, è stata sgozzata con
tanta ferocia che, quando la polizia cerca di rimuovere il cadavere, il capo
le si stacca dal busto. Nei loro alloggi vi sono alcuni oggetti preziosi in
bella vista, ma qualunque squilibrato si sia introdotto in casa non li ha
nemmeno toccati. La singolarità del crimine riempie di sconcerto la polizia
parigina, la stampa e i testimoni... tutti quanti, insomma, a eccezione di C.
Auguste Dupin.
Dupin capisce.
Capisce che è la natura insolita e straordinaria dei delitti a renderli facilmente risolvibili, giacché li differenzia immediatamente dall'accozzaglia
caotica dei crimini comuni. La polizia e la stampa hanno la sensazione che
il colpevole, per quanto irrazionale, non possa essere una persona; infatti
non lo è. Il ragionamento di Dupin segue un metodo che Poe chiama «raziocinio»: l'uso dell'immaginazione per effettuare l'analisi, e dell'analisi per
scalare le vette dell'immaginazione. Grazie a questo processo, Dupin dimostra che a commettere quelle orribili atrocità è stato un orang-outang,
incattivito dai maltrattamenti.
Se fossero usciti dalla penna di una persona comune, questi particolari
apparirebbero sciocchi e assurdi. Appena il lettore esprime incredulità di
fronte allo svolgimento dei fatti, ogni difficoltà viene eliminata da una catena di ragionamenti irreprensibili. Poe stimola la curiosità per ciò che è
possibile fino al limite, e questo trascina l'anima. Quei racconti del raziocinio (con seguiti imperniati su altri casi di Dupin) diventarono gli scritti
più popolari di Poe tra una moltitudine di lettori, ma, a mio avviso, per i
motivi sbagliati. I lettori passivi amavano assistere alla soluzione di un enigma inesplicabile, ma vi era un livello più alto di significato. Il mio oggetto finale è solamente la verità dice Dupin al suo assistente. Grazie a
Dupin avevo compreso che la verità era anche l'unico obiettivo finale di
Edgar A. Poe, ed era proprio quello il fattore che spaventava e confondeva
tante persone. Il vero mistero non era il singolo rompicapo che la mente
desiderava districare; la mente dell'uomo: era quello il mistero autentico e
durevole del racconto.
E avevo anche scoperto una cosa che, come lettore, mi era sconosciuta:
l'immedesimazione. A un tratto mi ero sentito meno solo con le sue parole
davanti a me. Forse è questa la ragione per cui la morte di Poe, che avrebbe potuto deprimere un qualsiasi altro lettore per uno o due giorni, ossessionava i miei pensieri.
Mio padre amava ripetere che la verità risiede nei professionisti onesti,
non nei racconti incredibili e nelle storie ingannevoli dello scrittore di un
periodico. Non sapeva che cosa farsene del genio. Diceva che i membri
degli eserciti dovevano adempiere ai doveri prosaici della vita, in cui la la-
boriosità e l'intraprendenza erano più utili del genio, troppo schizzinoso
verso l'ottusità degli uomini per affermarsi sulla Terra. Operava nel settore
dei conservifici, ma sosteneva che un giovanotto dovesse divenire avvocato: un'azienda completa in sé e per sé, aggiungeva con orgoglio. Peter aveva aderito a quel progetto con entusiasmo, come se si stesse imbarcando
sulla prima nave in partenza per la California attratto dalle voci sulla presenza dell'oro.
Dopo aver raggiunto la maturità, Peter aveva completato l'apprendistato
in uno studio legale di un certo prestigio, facendosi notare per la compilazione di un'opera accurata, L'indice delle leggi del Maryland, dall'anno
1834 al 1843. Ben presto mio padre gli aveva aperto uno studio tutto suo,
ed era stato chiaro che io avrei dovuto studiare e lavorare sotto la direzione
del mio amico. Era un'idea troppo ragionevole per opporvisi, e infatti non
avevo pensato di farlo, nemmeno per un istante, almeno per quanto mi ricordo.
«Siete fortunato» mi aveva scritto Peter quando frequentavo ancora l'università. «Avrete un ufficio elegante qui con me sotto gli auspici di vostro
padre e vi sposerete appena lo vorrete. A proposito, ogni fanciulla avvenente di buona famiglia vi sorride in Baltimore Street. Se fossi in voi, se
avessi un viso bello solo la metà del vostro, Quentin Clark, io saprei bene
che cosa fare con lo sfarzo e l'agiatezza in società!»
Nell'autunno del 1849, avevo un'attività così florida da non rendermene
quasi conto. Io e Peter Stuart eravamo soci eccellenti. Purtroppo entrambi i
miei genitori erano morti a causa di un incidente occorso alla carrozza su
cui viaggiavano mentre si recavano in Brasile per degli affari di mio padre.
Là dove un tempo vi era stata la sua guida, era rimasto uno spazio vuoto.
Eppure, la vita che aveva programmato per me era proseguita anche in sua
assenza. Tutti - Hattie, Peter, i clienti dagli abiti ben stirati che venivano
ogni giorno allo studio, l'imponente casa della mia famiglia, ombreggiata
da antichi pioppi e battezzata Glen Eliza, dal nome di mia madre - e tutto
ciò che mi circondava avevano seguitato a funzionare come se fossero stati
azionati da un meccanismo automatico, silenzioso e intelligente. Fino alla
scomparsa di Poe.
La debolezza giovanile mi portava a desiderare che gli altri comprendessero tutto quanto mi riguardasse e ad avvertire l'esigenza di fare in modo
che gli altri mi comprendessero. Credevo di esserne capace. Rammento la
prima volta che avevo proposto a Peter di lavorare per proteggere Edgar A.
Poe; pensavo che il mio socio avrebbe acconsentito e speravo così di poter
riferire la buona notizia al signor Poe.
La mia prima lettera a Edgar Poe, datata 16 marzo 1845, era scaturita da
un dubbio che mi aveva assalito mentre leggevo Il corvo, una poesia pubblicata da poco. Nei versi conclusivi, il corvo è posato su un busto di Pallade sopra la porta della mia stanza. In quelle ultime righe, l'uccello dispettoso e misterioso continua a perseguitare il giovane protagonista del
poemetto, forse per l'eternità:
E i suoi occhi sembrano quelli di un demone che sogna,
e la luce della lampada ne riflette l'ombra sul pavimento,
e la mia anima da quell'ombra che fluttua sul pavimento
non si solleverà mai più, mai più!
Se il corvo è sopra la porta della stanza, quale lampada alle sue spalle
può proiettarne l'ombra sul pavimento? Con l'impetuosità della giovinezza,
avevo scritto a Poe per appagare quella curiosità, giacché volevo essere in
grado di capire ogni sfumatura del testo. Oltre al quesito, avevo allegato la
quota di abbonamento per la nuova rivista «The Broadway Journal», di cui
Poe era direttore, per avere la possibilità di leggere qualsiasi cosa uscisse
dalla sua penna.
Dopo mesi senza alcuna risposta, e senza neppure un numero del
«Broadway Journal», gli avevo scritto nuovamente. Ma il silenzio si protraeva, perciò avevo inviato un reclamo a un distributore newyorkese del
giornale, pretendendo che mi risarcissero l'intero abbonamento. Non volevo più nemmeno vedere quel periodico. Ma un giorno avevo ricevuto i
miei tre dollari insieme a una lettera.
Firmata da Edgar A. Poe.
Com'era stato stupefacente, com'era stato edificante! Un visionario così
superbo che si abbassava a scrivere di persona a un modesto lettore di ventitré anni. Mi aveva persino svelato il piccolo mistero riguardo all'ombra
del corvo: «La mia idea era quella di un braccio portalampada fissato al
muro, in alto, sopra la porta e il busto, come si vede sovente nei palazzi inglesi, e persino in alcune delle migliori dimore di New York».
Ecco il perché di quell'ombra, spiegato solo per me. Poe mi aveva anche
ringraziato per le opinioni letterarie che avevo espresso, incoraggiandomi a
inviargliene altre. Aveva precisato che i finanziatori avevano imposto la
cessazione del «Broadway Journal» dopo l'ennesima sconfitta nella batta-
glia tra denaro e letteratura, e di non aver mai considerato il giornale più di
un'appendice temporanea agli altri suoi progetti. Un giorno, aveva concluso, ci saremmo potuti incontrare di persona, e mi avrebbe confidato i suoi
propositi, chiedendomi consiglio. «Sono del tutto ignorante in campo legale» aveva ammesso.
Gli avevo spedito nove lettere tra il 1845 e la sua morte, avvenuta
nell'ottobre del 1849. In cambio, avevo ricevuto quattro biglietti sinceri ed
educati scritti di suo pugno.
I suoi commenti più vigorosi concernevano le sue ambizioni riguardo a
«The Stylus», il giornale che sperava di fondare dopo aver trascorso anni a
dirigere riviste altrui. Sosteneva che il suo periodico avrebbe finalmente
consentito agli uomini di genio di trionfare sugli uomini di talento, agli
uomini che sapevano sentire di prevalere sugli uomini che sapevano pensare. Non avrebbe elogiato un autore che non lo meritasse, e avrebbe pubblicato solo opere letterarie accomunate dalla chiarezza e, soprattutto, dalla
verità. Quello era il suo sogno da molti anni. L'estate precedente alla sua
scomparsa mi aveva scritto che avrebbe atteso fino al Giorno del Giudizio,
se ciò avesse aumentato le sue probabilità di successo. Tuttavia, aveva
specificato, si augurava di far uscire il primo numero nel gennaio dell'anno
successivo.
Poe, ansioso di recarsi a Richmond per raccogliere consensi e finanziamenti, era convinto che, se tutto fosse andato come previsto, il successo finale sarebbe stato assicurato. Doveva trovare fondi e sottoscrittori. Ma la
cosiddetta stampa specializzata aveva continuato a ostacolarlo, alimentando sia i pettegolezzi sulle sue abitudini sregolate e immorali sia i dubbi
sulla sua salute mentale, sui suoi amoreggiamenti indecorosi e in genere
sui suoi eccessi. I nemici, asseriva Poe, gli davano sempre addosso perché
aveva pubblicato critiche esplicite dei loro scritti e perché aveva avuto
l'ardire di denunciare la totale mancanza d'originalità di autori illustri come
Lowell e Longfellow. Temeva che il rancore di uomini meschini avrebbe
vanificato i suoi sforzi dipingendolo come un beone, un ubriacone indegno
di qualsiasi influenza pubblica.
Era stato allora che gliel'avevo domandato. Gliel'avevo domandato con
franchezza, forse con troppa franchezza. C'era del vero nelle accuse che
udivo da anni? Lui, Edgar A. Poe, era davvero un avvinazzato che si era
abbandonato a eccessi di ogni genere?
Mi aveva risposto senza il minimo tono di offesa o di arroganza. Aveva
giurato a me (a me, un perfetto estraneo, e un presuntuoso per giunta) di
essere del tutto astemio. Qualche lettore potrebbe mettere in dubbio la mia
capacità di discernimento, ma il mio istinto parlava con assoluta certezza.
Nella mia lettera successiva, gli avevo confermato di avere piena fiducia
nella sua parola. Poi, poco prima di sigillare la busta, avevo deciso di fare
di meglio.
Gli avevo fatto una proposta. Avrei citato in giudizio qualsiasi falso accusatore intenzionato a intralciare il lancio di «The Stylus». Giacché in
passato avevamo rappresentato gli interessi di alcuni periodici locali, avevo maturato l'esperienza necessaria. Avrei fatto la mia parte per impedire
che il genio venisse calpestato. Quello sarebbe stato il mio dovere, proprio
come il suo era sorprendere il mondo con i suoi scritti.
«Grazie per la promessa in merito a "The Stylus"» aveva risposto. «Potete o volete aiutarmi? Non ho spazio per aggiungere altro. Faccio totale
affidamento su di voi.»
Tutto questo era avvenuto poco prima del ciclo di conferenze da lui tenuto a Richmond. Incoraggiato dalla sua risposta alla mia offerta, gli avevo scritto ancora, tempestandolo di domande su «The Stylus» e sugli ambienti in cui intendeva procurarsi il denaro. Speravo che mi avrebbe risposto mentre era in viaggio e pertanto mi recavo spesso all'ufficio postale e,
quando il lavoro non assorbiva tutto il mio tempo, controllavo gli elenchi
della corrispondenza giacente che il direttore pubblicava con regolarità sui
giornali.
Avevo seguitato a leggere più che mai le opere di Poe, soprattutto dopo
la scomparsa dei miei genitori. Alcuni giudicavano disgustosa la mia passione per una letteratura che si soffermava così spesso sul tema della morte. In Poe, la morte, pur non essendo piacevole, non è tuttavia un argomento proibito. E non è neppure una conclusione prestabilita. La morte è un'esperienza che i vivi possono plasmare. La teologia ci insegna che gli spiriti
continuano a vivere anche senza il corpo, e Poe ci credeva.
All'epoca, naturalmente, Peter si era ribellato con veemenza all'idea che
il nostro studio accettasse la causa di «The Stylus».
«Preferirei mozzarmi una mano piuttosto che trascorrere il mio tempo a
preoccuparmi di quelle maledette riviste di narrativa. Preferirei essere investito da un omnibus piuttosto che...» Avrete già capito dove voleva arrivare.
Forse penserete che il vero motivo dell'opposizione di Peter fosse stata
la mia incapacità di rispondere ai suoi quesiti sugli onorari. I giornali defi-
nivano regolarmente Poe uno squattrinato. Perché addossarci quello che gli
altri avrebbero rifiutato? Avevo obiettato che la fonte dei nostri pagamenti
era ovvia: la nuova pubblicazione, il cui successo era garantito.
Ecco che cosa avrei voluto dirgli: «Non avete mai l'impressione che la
vita da avvocato vi inaridisca? Dimenticate gli onorari! Non vorreste lavorare con l'unico obiettivo di proteggere qualcosa che sapete essere grande e
che tutti gli altri cercano di dissacrare? Non desiderate contribuire a cambiare qualcosa, anche a rischio di cambiare voi stesso?». Quelle argomentazioni non avrebbero sortito alcun effetto su di lui. Quando Poe morì, Peter gioì tra sé e sé, contento che la faccenda fosse conclusa.
Ma io non gioii, nemmeno un poco. Mentre leggevo gli articoli che tessevano un amaro elogio funebre di Poe, il mio desiderio di tutelare il suo
nome non fece altro che acuirsi. Bisognava fare qualcosa, ancor più di
prima. Essendo morto, non poteva più difendersi da solo. A mandarmi su
tutte le furie era soprattutto il fatto che quei vermi irriverenti non solo infioravano i racconti con gli aspetti negativi dell'esistenza di Poe, ma si affollavano anche intorno alla scena del suo decesso come piccole mosche
affamate. Ecco la prova suprema, il massimo simbolo (affermava la loro
logica) di una vita moralmente fragile. La dipartita umile e squallida di
Poe serviva a confermare l'oscurità della sua condotta e le imperfezioni
della sua produzione causate dalle inclinazioni morbose. «Pensate alla sua
triste fine», diceva in tono piagnucoloso un quotidiano.
Pensate alla sua triste fine!
Non al suo genio senza pari? Non alla sua maestria letteraria? Non al
modo in cui accendeva la vita nei suoi lettori quando costoro non la avvertivano dentro di sé? Pensate a gettare un corpo senza vita in un rigagnolo a
forza di calci e a percuoterne la gelida fronte!
«Andate a visitare quella tomba di Baltimora» suggeriva il medesimo
giornale «e capterete nell'aria circostante il terribile monito che l'esistenza
di quest'uomo rappresenta per la nostra.»
Un giorno annunciai che era venuto il momento di fare qualcosa. Peter
rise.
«Non potete citare in giudizio nessuno. L'uomo ormai è sottoterra!» esclamò. «Non avete più alcun cliente. Lasciatelo riposare in pace; lasciateci riposare.» Iniziò a fischiettare un motivetto popolare. Ogni volta che era
insoddisfatto, fischiettava, anche se era nel bel mezzo di una conversazione.
«Sono stanco di lavorare per una manciata di spiccioli e di dover dire o
fare cose diverse da quelle in cui credo, Peter. Mi ero impegnato a rappresentare i suoi interessi. Una promessa, mio caro, e non venite a raccontarmi che le promesse decadono alla morte di qualcuno.»
«Probabilmente aveva accettato il vostro aiuto solo per evitare che continuaste a tormentarlo.» Notando che quella frase mi aveva infastidito, ribadì la sua tesi con un tono più comprensivo ma saccente. «Sarebbe possibile, amico mio?»
Ripensai a una frase che Poe aveva inserito in una delle sue lettere concernenti «The Stylus»: «Questo è il grande scopo della mia vita. Sicuramente (a meno che non muoia) lo realizzerò». Nella medesima missiva aveva insistito affinché smettessi di pagare l'affrancatura anticipata per la
nostra corrispondenza. Si era firmato: «Il Vostro amico».
E così gli avevo scritto le stesse parole, le stesse tre semplici parole tracciate con un inchiostro qualsiasi, apponendo la mia firma lì sotto come avrei fatto in un giuramento solenne. Chi avrebbe mai scommesso, all'epoca, che non l'avrei mantenuto?
«No» risposi alla domanda di Peter. «Sapeva che sarei stato in grado di
difenderlo.»
Capitolo 2
La minaccia giunse un lunedì pomeriggio. Non vi furono spade, pistole
o pugnali (né avrei mai creduto che il destino li avesse in serbo per me). La
sorpresa assoluta di quella giornata si dimostrò più imprevedibile.
Le mie visite alle sale di lettura della biblioteca di Baltimora stavano diventando un'abitudine. La causa di un grosso debitore, intrapresa più o
meno in quel periodo, ci costrinse a raccogliere numerosi ritagli di giornale. Nei momenti di lavoro frenetico, Peter preferiva chiudersi in studio
giorno e notte senza vedere mai un raggio di sole, perciò toccò a me coprire la breve distanza fino alla biblioteca per svolgere le ricerche. Mentre ero
lì, avrei indagato anche su Edgar Poe e sulla sua morte.
I tipici resoconti biografici su Poe, moltiplicatisi da quando si era diffusa
la notizia della sua scomparsa, citavano alcune delle sue poesie (Il corvo,
Ulalume), il luogo in cui era stato rinvenuto (il Ryan, un hotel dotato di taverna tra High e Lombard Street, che, in quella giornata elettorale, aveva
anche funto da seggio), la data in cui si era spento (domenica 7 ottobre, in
un letto d'ospedale) e via discorrendo. Altri articoli su Poe iniziarono a
comparire nei maggiori quotidiani di New York, Richmond e Filadelfia,
che preferivano gli eventi dal sapore sensazionalistico. Riuscii a trovare alcuni di quegli accenni nella nostra sala di lettura. E che accenni!
La sua vita era stata un deplorevole fallimento. Era stato un uomo di
profonda intelligenza che aveva sprecato tutto il suo potenziale. Le sue poesie fantastiche e artificiose e i suoi racconti inquietanti erano stati contaminati troppo spesso dalla sua esistenza funesta e infelice. Aveva vissuto
da ubriacone. Era spirato da ubriacone, da essere indegno e da farabutto
che con i suoi scritti aveva leso solidi princìpi morali. Pochi avrebbero
sentito la sua mancanza (affermava un quotidiano newyorkese). Nessuno
l'avrebbe ricordato a lungo. Date un'occhiata voi stessi:
Edgar Allan Poe è morto. Non conosciamo le circostanze del decesso. È stato improvviso e, giacché si è verificato a Baltimora,
possiamo presumere che lo scrittore stesse tornando a New York.
Questo annuncio stupirà parecchie persone, ma pochissime ne
saranno addolorate.
Non potevo assistere a quella dissacrazione. Volevo distogliere lo sguardo, ma al tempo stesso mi scoprii ansioso di conoscere tutto ciò che avevano scritto su di lui, per quanto fosse ingiusto. O meglio (quanto è strana
la mente umana!), più quelle parole erano ingiuste e più avevo bisogno di
leggerle; più erano inique e più mi sembravano fondamentali.
Poi arrivò il pomeriggio freddo e piovigginoso di un giorno in cui il cielo di mezzodì era identico a quello delle sei del mattino o della sera. Una
fitta nebbia sfiorava il viso al pari di una mano e penetrava negli occhi e
giù per la gola.
Camminavo verso la biblioteca, quando un tale mi urtò. Era alto suppergiù come me e doveva avere l'età che avrebbe avuto mio padre. In condizioni normali, lo scontro non mi sarebbe parso intenzionale, se non fosse
stato per il fatto che lo sconosciuto dovette piegarsi in maniera alquanto
innaturale per allungare il gomito nella mia direzione. Non era stato uno
spintone, ma piuttosto un colpetto esitante, se non addirittura delicato. Mi
aspettavo che mi rivolgesse delle scuse e invece l'uomo pronunciò il seguente avvertimento: «Chi interferisce giacerà là in fondo, signor Clark».
Mi fulminò con un'occhiataccia che tagliò persino la fitta foschia tutt'intorno e quindi, prima che riuscissi a riflettere, svanì tra la nebbia. Mi guardai alle spalle, come se si fosse rivolto a qualcun altro.
No, aveva detto: «Clark». Io ero Quentin Hobson Clark, ventisette anni,
un avvocato che si occupava perlopiù di cause riguardanti debiti e ipoteche. Ero il signor Clark, ed ero appena stato minacciato.
Non sapevo che cosa fare. Nella confusione, avevo lasciato cadere il mio
taccuino, che si era aperto a casaccio per terra. In quell'istante, mentre lo
recuperavo prima che un tacco incrostato di fango lo calpestasse, mi resi
conto di quanto avevo investigato su Poe. Il suo nome compariva su quasi
ogni pagina della mia agenda. Compresi con chiarezza improvvisa il significato delle parole di quel tizio. Si riferivano al grande letterato.
Confesso che la mia reazione stupì anche me. Divenni calmo e controllato, così misurato che Peter mi avrebbe stretto la mano con orgoglio; se tutto ciò avesse riguardato qualsiasi altra questione, beninteso. Non sarei mai
potuto essere un avvocato come Peter, un uomo che si appassionava alle
cause e alle deposizioni più noiose, anzi soprattutto a quelle. Benché possedessi una mente abbastanza sveglia, l'abilità non sarebbe mai riuscita a
superare la passione, per quanto imparassi a memoria le pagine dei volumi
di legge di Blackstone e Coke. In quel momento avevo tuttavia un cliente e
una causa che non volevo fosse archiviata. Mi sentivo l'avvocato più brillante mai esistito sulla faccia della Terra.
Mi riscossi quanto bastava per tuffarmi fra la moltitudine di ombrelli, e
ben presto individuai la schiena dell'uomo. Aveva l'andatura rilassata di
chi se ne va a zonzo, anzi di chi si gode una passeggiata estiva. Ma mi ero
sbagliato, non era lui. Procedendo, notai che, tra i banchi di nebbia, tutti
assomigliavano più o meno all'oggetto del mio inseguimento, persino le
signore più avvenenti e gli schiavi più scuri. Quella foschia strisciante ci
avvolgeva e ci fondeva tutti insieme, disturbando l'ordinato viavai. E per di
più a me pareva che ciascuno facesse del suo meglio per camminare e tenere la testa in un'imitazione perfetta di quel tale, di quel fantasma.
Sull'angolo, il chiarore di un lume a gas emanato da una vetrina nascosta
per metà sotto il livello della strada fendeva la fitta nebbia. Proveniva dalle
lampade esterne di una taverna, e pensando che potesse essere un richiamo
per un individuo dalle intenzioni losche, corsi giù ed entrai. Mi feci largo
tra i capannelli di avventori impegnati a bere, e alla fine di una lunga fila
rie scorsi uno curvo su un tavolo. Il cappotto, un tempo elegante, era lo
stesso che avevo veduto addosso al fantasma.
Lo presi per un braccio. Levò piano il capo e sussultò vedendo la mia
espressione indagatrice.
«Uno sbaglio, signore. Signore! Un grave sbaglio da parte mia» urlò. Le
sue parole si spensero nel torpore dell'ebbrezza.
Non era nemmeno lui.
«Il signor Watchman» mi sussurrò in tono solidale un uomo ubriaco lì
accanto. «Quello è John Watchman. Bevo alla sua salute, poveraccio! E
bevo anche alla vostra, se volete.»
«John Watchman» ripetei annuendo, anche se quel nome non significava
nulla per me (se vi ero incappato nei giornali, l'avevo letto solo di sfuggita). Lasciai qualche moneta di rame affinché l'uomo potesse continuare a
indulgere al suo vizio e mi affrettai a uscire per proseguire la mia ricerca.
Distinsi il vero colpevole nel punto in cui la nebbia si diradava. A un
tratto, in preda all'angoscia, ebbi l'impressione che tutti gli abitanti della
via lo pedinassero, facendo appello al loro coraggio per dargli la caccia.
Ho già detto che il nostro fantasma era alto come me? Sì, ed era vero.
Ma ciò non significa che mi somigliasse in qualche modo. Anzi, forse ero
l'unico per la strada a non presentare una netta somiglianza con lui. Io avevo i capelli di un castano opaco pettinati accuratamente e il volto piccolo,
armonioso e ben rasato, troppo spesso definito infantile. Lui, il fantasma,
aveva un fisico dalle proporzioni diverse: le sue gambe parevano lunghe
quasi il doppio delle mie, tanto che, per quanto camminassi spedito, non
riuscivo a ridurre la distanza tra noi.
Mentre correvo nella nebbia pungente, fui assalito da pensieri frenetici e
angosciosi, che mi spaventavano al di là di ogni logica. Andai a sbattere
contro una spalla, contro un'altra, e una volta quasi contro tutto il corpo di
un robusto individuo che avrebbe potuto appiattirmi sui mattoni rossi del
marciapiede. Scivolai su un tratto sterrato, imbrattandomi di melma il fianco sinistro. Dopodiché mi ritrovai solo all'improvviso... Nessuno nei paraggi.
Rimasi immobile.
Ora che avevo perduto la mia preda (o che lui aveva perduto la sua), i
miei occhi misero a fuoco, come se avessi inforcato un paio di occhiali.
Eccomi lì, a non più di venti metri di distanza dall'angusto cimitero presbiteriano, dove le sottili lastre di pietra che sporgevano dal suolo erano solo
poco più scure dell'aria. Mi domandai se lo sconosciuto mi avesse condotto
fin lì di proposito mentre mi sfuggiva per mezza Baltimora oppure se si era
dileguato sin dall'inizio del pedinamento, prima che mi approssimassi a
quel luogo... Il luogo in cui ora Edgar Poe avrebbe dovuto riposare in pace.
Molti anni prima, quando ero soltanto un adolescente, si era verificato
un episodio che mi pare utile raccontare. Viaggiavo in treno con i miei genitori. Benché ai familiari fosse permesso sedere nel vagone riservato alle
signore, lo scompartimento era affollato, e solo mia madre aveva potuto
fermarsi. Mi ero accomodato con mio padre qualche carrozza più in là, e
percorrevamo il convoglio a intervalli regolari per andare dalla mamma,
nell'area in cui era vietato sputare e imprecare. Dopo una di quelle brevi
visite, ero tornato ai nostri posti senza papà e lì avevo trovato due uomini.
Avevo spiegato loro l'errore con cortesia. Uno dei due si era adirato, ammonendomi che sarei dovuto «passare sul suo cadavere» prima di ottenere
quel posto a sedere.
«È proprio quello che farò, se non vi spostate» avevo ribattuto.
«Come hai detto, ragazzo?»
Avevo ripetuto la stessa assurda affermazione con altrettanta calma.
Immaginatemi nei panni di un quindicenne esile... diciamo pure mingherlino. Di norma, mi sarei scusato con lui e avrei cercato con deferenza
due posti di classe inferiore. Frattanto vi sarete chiesti del secondo intruso
di questo aneddoto, l'altro ladro di sedili. Dal taglio degli occhi, si sarebbe
detto che fosse il fratello del primo; dallo sguardo vacuo e dalla testa che
andava su e giù, supposi che fosse ritardato.
Vi sarete anche meravigliati della mia reazione. La presenza di mio padre mi aveva avviluppato fino a poco prima. Papà aveva sempre il pieno
controllo su tutti coloro che lo attorniavano. Perciò, in quell'istante, era
perfettamente logico che credessi anch'io di poter piegare il mondo alla
mia volontà. Era stata quella la subdola natura dell'illusione.
Tanto vale che finisca la storia. Quel farabutto non aveva smesso di colpirmi con violenza la faccia e la testa finché mio padre era ricomparso.
Meno di un minuto dopo, lui e il controllore avevano confinato quei due
tizi in un altro vagone, che sarebbe stato sganciato alla stazione successiva.
«Ebbene, che cosa hai combinato, figliolo?» mi aveva chiesto papà in
seguito, mentre giacevo sui sedili fiacco e stordito.
«Non ho proprio potuto farne a meno, padre! Voi non c'eravate!»
«Hai provocato quei signori e loro avrebbero potuto ucciderti. Che cosa
avresti dimostrato allora, Quentin Hobson Clark?» Avevo guardato l'immagine sfocata di quell'uomo che mi faceva la ramanzina, torreggiando
sopra di me con la sua consueta compostezza, e avevo capito la differenza
tra noi.
Tornai a riflettere sul nuovo avvertimento che avevo ricevuto. «Chi interferisce...» La figura del fantasma mi attanagliava la mente accanto al
demone sul treno della mia giovinezza. Ardevo dal desiderio di parlarne
con qualcuno. In quei giorni, la mia prozia alloggiava da me per aiutarmi a
sovrintendere il governo della casa. Potevo raccontarle della minaccia?
Il suo commento sarebbe stato: «Qualcuno avrebbe dovuto prenderti da
giovane ed educarti per bene» o qualcosa del genere. Essendo una prozia
paterna, applicava la severità dei princìpi professionali di mio padre per
promuovere un comportamento assennato in tutti gli altri ambiti. Elogiava
papà per le sue «solide concezioni sassoni». Parte del suo affetto per lui
pareva essersi riversata su di me, e mi sorvegliava con zelante attenzione.
No, non feci parola dell'accaduto con lei, che di lì a poco lasciò Glen
Eliza. L'avrei riferito a mio padre se fosse stato vivo?
Avrei voluto dirlo a Hattie Blum. Aveva sempre ascoltato volentieri le
mie avventure. Dopo l'incidente occorso ai miei genitori, era stata l'unica a
parlarmi con un tono e una sicurezza capaci di sottintendere che, pur essendo morti, mamma e papà sarebbero stati sempre con me. Tuttavia, poiché non la vedevo dal giorno in cui ci saremmo dovuti fidanzare, non potevo prevedere come avrebbe giudicato il mio interesse per quella faccenda.
In un certo senso, la frase del fantasma mi incuriosiva tanto quanto mi
stupiva. «Chi interferisce giacerà là in fondo». Sebbene lo sconosciuto mi
avesse esortato a desistere, quel monito criptico ammetteva la possibilità di
«interferire» nell'opinione su Poe. In altre parole, potevo ancora modificarla. Se così si può dire, quell'avvertimento mi incoraggiò.
Mi pervase un'euforia che era solo lontanamente familiare e solo in parte
indesiderata. Era diversa da tutto ciò che avevo conosciuto nel mio lavoro.
Durante un lungo pomeriggio, sedevo in ufficio osservando la strada
dalla mia scrivania. Peter era lì accanto. Stava rimproverando il copista per
la qualità di qualche deposizione, quando mi lanciò un'occhiata. Riprese il
suo predicozzo, quindi tornò a guardarmi all'improvviso. «Tutto bene,
Quentin?»
Talvolta cadevo in una sorta di trance, fissando l'aria senza concentrarmi
su nulla in particolare. Peter era divertito, ma anche un po' spaventato in
quelle occasioni. Scosse rumorosamente il sacchetto di biscotti allo zenzero che stavo mangiando. «Tutto bene, Quentin?»
«Tutto bene» gli assicurai. «Abbastanza bene, Peter.» Intuendo che non
avrei aggiunto altro, si rivolse ancora al copista, riprendendo dal punto esatto in cui si era interrotto.
Non riuscii più a trattenermi. «Tutto bene, certo! Se si può dire che vada
tutto bene quando si viene minacciati!» esclamai a un tratto. «Tutto male!»
Peter congedò in silenzio il copista, che corse fuori con gratitudine. Quando fummo soli, gli rivelai ogni dettaglio. Rimase seduto sul bordo della sedia, ascoltando con attenzione. All'inizio riconobbe persino che l'episodio
era elettrizzante, ma ben presto tornò a essere se stesso, sostenendo che il
fantasma era soltanto un pazzo squilibrato.
Chissà perché, sentii il bisogno di difendere, e persino di avvalorare, la
tesi della minaccia. «No, Peter, non era affatto squilibrato. Nei suoi occhi
vi era una sorta di determinazione razionale... un'intelligenza fuori del comune.»
«Sembra un romanzo di spionaggio. Perché...? Perché avrebbe dovuto
prendersi il disturbo di...? Uno dei nostri casi di ipoteca?»
Reagii con una risata roca che parve offenderlo, come se negare il potenziale interesse di un presunto folle per le nostre controversie ipotecarie
sminuisse l'intera professione legale. Ma mi scusai per il tono e spiegai con
più calma che quella questione aveva qualcosa a che vedere con Edgar Poe; aggiunsi che avevo esaminato dei ritagli su Poe e avevo individuato notevoli incongruenze.
«Per esempio, compare sovente l'allusione, l'insinuazione, che Poe sia
morto della sua "fatale malattia", per usare le loro parole, ossia l'alcolismo.
Ma chi può confermarlo? Alcuni di quegli stessi giornali non avevano forse annunciato, solo qualche settimana prima, che Poe era entrato a far parte
dei Sons of Temperance di Richmond e aveva tenuto fede al giuramento?»
«Un poeta e un briccone matricolato, quell'Edgar Poe! Leggerlo è come
respirare l'aria di un ossario.»
«Avevate detto di non averlo mai letto, Peter!»
«Sì, ed è proprio questo il motivo! Non mi sorprenderebbe affatto se ogni giorno sbucassero fuori nuove persone che non l'hanno mai letto. Persino i titoli dei suoi racconti sono raccapriccianti. Solo perché piaceva a
voi, Quentin Clark, non significa che piacesse a qualcun altro, giusto? Nulla di tutto ciò ha a che fare con Poe; siete voi che desiderate che abbia a
che fare con Poe! Perdiana, questo avvertimento che credete vi sia stato rivolto non ha sicuramente alcun legame con costui, se non in qualche recesso malato della vostra mente!» Levò le mani in aria.
Forse Peter aveva ragione, il fantasma non aveva detto nulla di specifico
riguardo a Poe. Come potevo essere così certo? Eppure lo ero. Qualcuno
voleva che smettessi di indagare sulla sua morte. Sapevo che qualcuno conosceva la verità su quanto gli era accaduto a Baltimora, e probabilmente
era quello che altri temevano. Dovevo scoprirla per capire il perché.
Un giorno, mentre ero impegnato a controllare le copie di un importante
contratto redatte dal copista, un impiegato infilò la testa nel mio ufficio.
«Signor Clark. Signor Poe. Ecco qui.»
Sbigottito, gli domandai che cosa intendesse.
«Da parte del signor Poe» spiegò, agitandosi un pezzo di carta dinanzi
alla faccia.
«Oh!» Gli feci cenno di darmi la lettera. Era di un certo Neilson Poe.
Secondo quanto avevo letto sui quotidiani, era un avvocato locale che
rappresentava molti criminali, ladruncoli, debitori morosi e che, per un certo periodo, era stato amministratore del comitato della Baltimore & Ohio
Railroad. Gli avevo inviato un messaggio qualche giorno prima, chiedendogli se fosse imparentato con il poeta Edgar Poe e l'avevo pregato di fissarmi un appuntamento.
Nella risposta, Neilson mi ringraziava per l'interesse dimostrato verso il
suo familiare, ma affermava che gli impegni professionali gli avrebbero
impedito di incontrarmi per alcune settimane. Settimane! Frustrato, rammentai un articolo su Neilson Poe che avevo letto nelle ultime cronache
giudiziarie dei giornali e mi affrettai a recuperare il cappotto.
Secondo il calendario dei processi di quel giorno, in quel preciso istante
Neilson stava difendendo un tale, Cavender, accusato di aggressione e tentato stupro contro una giovane donna. L'udienza Cavender si era già conclusa quando raggiunsi il tribunale, sicché sbirciai nelle celle sotterranee. Il
secondino cui mostrai il mio tesserino mi indicò quella del signor Cavender. Nel vano, scuro e angusto, un uomo con la divisa da prigioniero parlottava con un altro tizio, che sfoggiava un completo elegante e l'espressione di calma imperturbabile tipica degli avvocati. Su un rozzo tavolino
erano posati una tazza piena di caffè e un piatto con del pane bianco.
«Giornataccia in aula?» domandai con cordialità dall'altra parte delle
sbarre.
L'uomo con il completo si alzò dalla panca. «E voi chi siete, signore?»
mi chiese.
Tesi la mano al tale che avevo veduto per la prima volta al funerale tra
Greene e Fayette Street. «Signor Poe? Sono Quentin Clark.»
Neilson Poe era un tipo basso e ben rasato, con una fronte intelligente,
larga quasi come quella raffigurata nei ritratti di Edgar, ma con lineamenti
più affilati, simili a quelli di un furetto, e vivaci occhi scuri. Immaginai che
gli occhi di Edgar Poe avessero avuto uno scintillìo più intenso, se non addirittura un bagliore indecifrabile nei momenti di creazione ed entusiasmo.
Eppure, dopo uno sguardo frettoloso in quell'ambiente mal illuminato, avrei quasi potuto scambiare il mio interlocutore per il grande poeta.
Neilson segnalò al suo cliente che sarebbe uscito dalla cella per qualche
attimo. Il carcerato, che fino a un istante prima si teneva la testa fra le mani, si alzò in piedi con improvvisa energia, guardando il suo difensore allontanarsi.
«Se non erro» affermò Neilson mentre la guardia chiudeva la porta «nel
mio biglietto vi avevo scritto di avere una notevole mole di lavoro, signor
Clark.»
«È importante, signor Poe. Riguarda vostro cugino.»
Prese alcuni documenti legali con un gesto risoluto, come per rammentarmi che aveva questioni più urgenti cui pensare.
«Questo è senz'altro un argomento di interesse personale per voi» azzardai.
Mi guardò di traverso, con impazienza.
«L'argomento della morte di Edgar Poe» precisai.
«Mio cugino Edgar girovagava con irrequietudine, cercando una vita di
autentica serenità, una vita che, per fortuna, sia voi sia io abbiamo, signor
Clark» osservò. «Lui aveva già sciupato quella possibilità molto tempo
fa.»
«Che cosa mi dite del suo sogno di creare una rivista prestigiosa?»
«Un sogno appunto...»
«L'avrebbe realizzato, signor Poe. Temeva soltanto che prima i suoi nemici...»
«Nemici!» mi interruppe, per poi zittirsi e guardarmi con gli occhi sgranati. «Signore» riprese con rinnovata prudenza «ditemi: come mai siete
tanto interessato alla faccenda da scendere in questa cella tetra per cercarmi?»
«Sono... ero il suo avvocato, signore» risposi. «Avrei dovuto difendere
la sua nuova rivista dalle accuse di diffamazione. Se aveva dei nemici, signore, gradirei molto sapere chi erano.»
Un morto come cliente... La voce di Peter mi risuonò nelle orecchie.
«Un nuovo processo, avvocato!»
Pareva che Neilson stesse soppesando le mie parole, quando il suo assistito si scagliò contro la porta. «Chiedete un nuovo processo, signor Poe!
Un trattamento equo, se non altro! Sono innocente!» urlava. «Le accuse
sono false, quella sgualdrina è una gran bugiarda!»
Dopo qualche attimo, Neilson tranquillizzò il suo assistito, promettendogli di tornare più tardi.
«Qualcuno deve difendere Edgar» continuai.
«Devo occuparmi di altre questioni ora, signor Clark.» Neilson si incamminò con andatura spedita lungo lo squallido seminterrato. Fermatosi,
si voltò nella mia direzione, aggiungendo con riluttanza: «Venite nel mio
studio, se volete parlare ancora. Vi mostrerò qualcosa che forse vi farà piacere vedere».
Percorremmo insieme St. Paul Street. Nel momento in cui entrammo nel
suo ufficio modesto e ingombro, osservò che, quando aveva ricevuto la
mia lettera di presentazione, era rimasto colpito dalla somiglianza tra la
mia calligrafia e quella del suo compianto cugino. «Per un istante ho creduto di leggere una missiva del nostro caro Edgar» affermò, spensierato.
«Un grafologo troverebbe questo fatto davvero straordinario.» Forse quelle
furono le ultime parole gentili che ebbe per il suo parente. Mi porse una
sedia.
«Edgar si è sempre comportato in modo avventato, signor Clark, fin da
ragazzo» ricominciò. «Aveva preso in moglie Virginia, la nostra splendida
cugina, quando aveva tredici anni e non era ancora uscita dall'innocenza
dell'infanzia. Povera Sissy (è così che la chiamavamo). L'aveva portata via
da Baltimora, dove era sempre stata al sicuro. La casa di sua madre in
Amity Street era piccola, ma perlomeno Sissy era attorniata da una famiglia devota. Edgar temeva che, se avesse aspettato, avrebbe potuto perdere
il suo affetto.»
«Senza dubbio Edgar teneva a lei più di tutti gli altri» replicai.
«Ecco, signor Clark, ciò che volevo mostrarvi. Forse vi aiuterà a capire.»
Da un cassetto, estrasse un ritratto che, mi spiegò, gli era stato spedito da
Maria Clemm, madre di Sissy nonché zia e suocera di Edgar. Raffigurava
Sissy, una giovane di ventuno o ventidue anni, con una carnagione perlacea e lucidi capelli corvini, gli occhi chiusi e la testa piegata di lato in una
posa pacifica ma allo stesso tempo indicibilmente triste. Osservai che
sembrava viva.
«No, signor Clark.» Neilson sbiancò. «È morta. Questa è Sissy da morta.
Dopo che era spirata, Edgar si era reso conto di non avere un suo ritratto e
aveva fatto eseguire questo. Non mi piace mostrarlo perché non cattura lo
spirito che Sissy possedeva in vita. Quel volto pallido ed esangue. Ma Edgar era affezionato oltre misura a questo dipinto. Vedete, mio cugino non
era riuscito a cederla neppure alla morte.»
L'immagine recava alcuni versi che Virginia aveva scritto a Edgar l'anno
prima della sua scomparsa, versi che accennavano alla vita in un villino
tranquillo dove i pettegolezzi di tante lingue sarebbero stati lontani. Soltanto l'amore ci guiderà quando saremo laggiù recitava quella dolce poesia.
L'amore guarirà i miei polmoni indeboliti.
Neilson accantonò il ritratto, specificando che negli ultimi anni Virginia
aveva necessitato di scrupolose cure mediche.
«Forse Edgar la amava. Ma avrebbe potuto provvedere adeguatamente a
lei? Avrebbe fatto molto meglio a trovarsi una donna benestante sin dal
principio.» A quel pensiero, tacque e parve voler cambiare argomento.
«Sapete, finché avevo circa la vostra età, anch'io dirigevo giornali e riviste
e scrivevo rubriche. Conosco la vita letteraria» dichiarò con un misto di
orgoglio e abbattimento. «Conosco il fascino che esercita su uno spirito
immaturo, signor Clark. Tuttavia, ho sempre avuto il senso della realtà, e
non sono così stupido da aspirare a una gratificazione personale perseverando in un'impresa che si è rivelata vana in partenza, come Edgar con la
scrittura. Mio cugino avrebbe dovuto smettere di scrivere. Solo così avrebbe potuto salvare Sissy e se stesso.»
Riguardo agli ultimi mesi di vita e al suo ultimo tentativo di garantirsi la
stabilità finanziaria, Neilson asserì che suo cugino intendeva raccogliere
fondi e sottoscrizioni per la tanto vagheggiata rivista «The Stylus» tenendo
conferenze e facendo visita ai membri dell'alta società di Norfolk e Richmond. Era stato in quest'ultima città che aveva rinnovato la sua amicizia
con una «signora agiata», come Neilson la definì in tono di approvazione.
«Si chiamava Elmira Shelton, una donna di Richmond di cui Edgar si
era innamorato molto tempo prima.» Da giovani, Elmira e Edgar si erano
fidanzati prima che lui partisse per frequentare l'università della Virginia,
ma il padre della ragazza disapprovava la relazione e aveva confiscato le
numerose lettere di Poe affinché sua figlia non le leggesse. Interruppi Neilson per domandargli il motivo.
«Forse» rispose «perché Edgar e Elmira erano giovani... e perché Edgar
era un poeta. Non dimenticate che probabilmente il padre di Elmira conosceva il signor Allan. Parlando con lui, avrà appreso che Edgar non avrebbe ricevuto in eredità neppure una parte del patrimonio di famiglia.»
Quando Edgar Poe era stato costretto a tornare dal college perché John
Allan si era rifiutato di saldare i suoi debiti, aveva presenziato a un ricevimento a casa degli Shelton e aveva scoperto con immenso dolore che El-
mira era stata promessa a un altro.
Nell'estate del 1849, quando si erano rincontrati, il marito di Elmira era
morto, come pure Virginia. La ragazza spensierata di tanti anni addietro
era diventata ormai una ricca vedova. Edgar aveva letto le sue poesie e ricordato con piacere il loro passato. Si era iscritto alla sezione locale di Richmond di un'associazione per liberarsi dall'alcolismo, aveva promesso a
Elmira di tener fede al giuramento. Affermando che un amore titubante per
lui non era amore, le aveva regalato un anello. Avrebbero iniziato una
nuova vita insieme.
Solo qualche settimana più tardi, Edgar Poe era stato rinvenuto al Ryan
di Baltimora ed era stato portato di corsa all'ospedale, dove sarebbe spirato.
«Non lo vedevo da qualche anno. Come potete immaginare, signor
Clark, è stato un duro colpo apprendere che era stato trovato in gravi condizioni in un seggio elettorale della città vecchia e che l'avevano condotto
all'ospedale universitario. Un mio parente, un certo Henry Herring, era stato chiamato al Ryan. Non sono riuscito ad appurare esattamente quando
Edgar fosse arrivato a Baltimora, dove fosse stato dopo il suo arrivo e in
quali circostanze.»
Non dissimulai il mio stupore. «Volete dire che avete cercato queste informazioni sugli ultimi giorni di vostro cugino ma non siete stato in grado
di reperirle?»
«Mi sono sentito in dovere di tentare, data la parentela e l'affetto che ci
legava» dichiarò. «Eravamo cugini, sì, ma anche amici. Eravamo coetanei,
e Edgar non era abbastanza vecchio da vedere la fine dei suoi giorni. Spero
che la mia morte possa essere serena e avvenire sotto gli occhi di tutta la
mia famiglia.»
«Ma dovete pur aver scoperto qualcos'altro.»
«Qualunque cosa sia capitata a Edgar, l'ha accompagnata nella tomba,
temo. Non è così che va talvolta la vita, signor Clark? La morte ingoia
completamente un uomo, tanto da non lasciarne tracce, nemmeno un'ombra, o l'ombra di un'ombra.»
«Ma non è l'unica cosa che è rimasta, signor Poe» obiettai insistente.
«Vostro cugino verrà ricordato. Le sue opere sono di rilevante importanza.»
«Possiedono una sorta di autorevolezza. Ma di solito è quella che deriva
dalla malattia. Ditemi, signor Clark, sapete qualcos'altro della fine di Edgar?»
Non gli raccontai del tizio che mi aveva esortato a non indagare oltre.
Qualcosa me lo impedì. Forse quell'esitazione fu il vero inizio dell'indagine. Forse sospettavo già che quella minaccia e Neilson Poe nascondessero
dell'altro, che non ero ancora riuscito a cogliere.
Neilson non fu in grado di aggiungere granché nemmeno sulle condizioni di Edgar dopo il ricovero. Quando era arrivato all'ospedale, i medici gli
avevano sconsigliato di entrare nella camera, affermando che il paziente
era troppo eccitabile. Aveva dunque intravisto suo cugino solo attraverso
una tenda, e da quella posizione gli era sembrato un uomo del tutto diverso, o il fantasma del corpo che aveva conosciuto. Non aveva neppure avuto
l'opportunità di vedere il cadavere prima che chiudessero la bara.
«Temo di non potervi dire altro dei suoi ultimi istanti» sospirò. Poi pronunciò un elogio funebre che non avrei mai più scordato. «Edgar era orfano in tutti i sensi. Aveva patito molte sofferenze, signor Clark, e aveva così
poche ragioni per essere soddisfatto della propria esistenza che, nel suo caso, la dipartita, la morte, non può essere definita una disgrazia.»
La frustrazione che provai di fronte all'autocompiacimento di Neilson mi
spinse a recarmi nelle redazioni di alcuni giornali con la vaga speranza di
persuaderli almeno a rendere un tributo al genio di Poe. Accennai al suo
misero funerale e ai numerosi dettagli errati contenuti nelle brevi biografie
pubblicate fino ad allora, augurandomi che li correggessero. Ma fu tutto
inutile. Negli uffici del «Patriot», un quotidiano whig, alcuni giornalisti mi
avevano sentito parlare e, ricordando che Poe aveva scritto per la stampa,
si offrirono solennemente di organizzare una colletta per acquistare una lapide commemorativa da posare sulla tomba del collega deceduto. Come se
Edgar Poe fosse stato un semplice divulgatore di notizie sensazionali! Notate inoltre che io non commettevo l'errore di chiamarlo, come avevano iniziato a fare i periodici, Edgar Allan Poe. No. Quel nome era una contraddizione, una chimera e un mostro sacrilego. John Allan aveva accolto
il poeta da bambino nel 1811, ma, in seguito ad alcune incomprensioni,
l'aveva abbandonato senza troppa generosità ai capricci del mondo.
Un tardo pomeriggio, passando accanto al cimitero presbiteriano mentre
tornavo a casa, decisi di dare un'altra occhiata al luogo in cui riposava lo
scrittore. Il vecchio camposanto era un'angusta distesa di tombe sull'angolo
tra Fayette e Greene Street. La fossa era poco distante dal ricercato cippo
del generale David Poe, eroe della guerra d'indipendenza e nonno di Edgar. Ma vi era qualcosa di sconcertante.
La tomba di Poe non era ancora stata contrassegnata. Sembrava che nessuno fosse mai stato lì a pregare.
La invisibile sventura! Non potei fare a meno di pensare alle devastazioni del «verme conquistatore», come Edgar aveva soprannominato l'ultimo
aggressore del nostro corpo. E i serafini singhiozzano ai denti del mostro
che s'imbevono di sangue umano.
Con improvvisa determinazione, mi addentrai nel cimitero. Guardandomi intorno, scorsi una lunga scala che conduceva in una delle antiche volte
sotterranee. Dopo essere sceso, incappai nel signor Spence, il becchino, assorto nella lettura di un libro sotto il basso arco di una cripta di granito. Vi
erano un tavolo, uno scrittoio, un portacatino e uno specchio di medie dimensioni. Anche quando qualche anno dopo costruirono una chiesa, circolava la voce che George Spence continuasse a prediligere quelle gallerie.
Ma all'epoca il fatto mi meravigliò.
«Non vivete qui, vero, signor Spence?» domandai.
Il mio tono lo infastidì. «Quando quaggiù fa troppo freddo, rimango di
sopra. Ma preferisco stare qui. È più silenzioso e riservato. A ogni modo,
questo tunnel è stato svuotato anni or sono.»
Parecchi decenni addietro, mi spiegò, la famiglia proprietaria della cripta
aveva trasferito le spoglie dei suoi antenati in un ambiente più spazioso.
Dopo aver aperto il sepolcro, il suo predecessore, suo padre, aveva tuttavia
scoperto che uno dei corpi aveva subito il singolare fenomeno della pietrificazione umana: si era trasformato in pietra da capo a piedi. Le superstizioni non avevano tardato a diffondersi. Da allora, nessun membro della
Chiesa aveva accettato di seppellire i suoi defunti laggiù.
«Uno spavento tremendo, incappare in un uomo di pietra quando sei soltanto un ragazzo» osservò, porgendomi una sedia.
«Grazie, signor Spence. C'è qualcosa che non va. La tomba di Edgar Poe, tumulato il mese scorso, non è ancora stata contrassegnata. È a livello
del terreno.»
Scrollò le spalle con indifferenza. «Non dipende da me, bensì dalle persone che si sono occupate della sepoltura. Neilson Poe e Henry Herring, un
cugino e uno zio di Edgar.»
«Sono passato di qui il giorno del funerale e ho notato che le persone intervenute erano pochissime. Erano presenti altri familiari oltre a loro due?»
chiesi.
«Ce n'era un altro. William Clemm, della chiesa metodista di Caroline
Street, ha celebrato la funzione, e credo che fosse un lontano parente della
famiglia. Il reverendo Clemm aveva preparato un lungo discorso, ma il
gruppo degli astanti era così esiguo che ha deciso di non leggerlo. Vi era
solo un altro uomo oltre a Neilson Poe, al signor Herring e al reverendo: Z.
Collins Lee, un compagno di classe di Edgar. Che la pace sia con le sue
ceneri!»
«Prego?»
«Ricordo che il sacerdote ha pronunciato quella frase davanti alla fossa.
"Che la pace sia con le sue ceneri." Sulle prime, la notizia della morte del
signor Poe mi ha sorpreso. Nella mia mente sarà sempre un giovanotto,
non molto più grande di voi.»
«Lo conoscevate, signor Spence?»
«Quando viveva a Baltimora, nella casetta di Maria Clemm» rispose con
espressione meditabonda. «È accaduto anni or sono. Voi sarete stato poco
più di un ragazzino. Baltimora era una città più tranquilla all'epoca; era più
facile ricordare i nomi. Di quando in quando vedevo Edgar Poe che vagava
per il cimitero.»
Aggiunse che il poeta si fermava davanti alle tombe di suo nonno e del
suo fratello minore, William Henry, da cui era stato separato quando era
bambino. Talvolta, continuò, Edgar A. Poe studiava i nomi e le date sulle
lapidi e gli domandava sottovoce quale legame di parentela esistesse tra un
defunto e l'altro. Quando incrociava Spence per la strada, a volte lo salutava con un «buongiorno» o un «buonasera» ma altre volte no.
«E pensare che un signore così distinto è arrivato alla fine in quelle condizioni.» Così dicendo, il becchino scosse la testa.
«Che cosa intendete, signor Spence?» lo incalzai.
«Rammento che è sempre stato pignolo in fatto di abbigliamento. Ma il
completo che indossava quando l'hanno trovato...» disse, come se dovessi
essere al corrente di ogni cosa. Gli feci cenno di continuare, e obbedì. «Era
logoro e sbrindellato, e non gli stava per nulla bene. Non poteva essere suo. Era forse di due taglie più grande. E in testa aveva un panama da quattro
soldi che nessuno si disturberebbe a raccattare da terra. Un infermiere
dell'ospedale ha messo a disposizione un abito nero, più decoroso, per la
sepoltura.»
«Ma com'è potuto accadere che Poe indossasse vestiti della misura sbagliata?»
«Non saprei.»
«Non le sembra assai curioso?»
«Suppongo di non averci pensato granché da allora, signor Clark.»
Quegli indumenti non erano destinati a Poe. Quella morte non era destinata a Poe, conclusi, con un'idea irrazionale e repentina. Ringraziai Spence
per avermi dedicato il suo tempo e salii rapidamente la scalinata che conduceva fuori della cripta, come se, una volta in cima, avessi qualcosa di
urgente da fare. A un tratto, colto da un presentimento, mi arrestai a metà
dei gradini, stringendo la presa sul corrimano. Fuori, il vento era aumentato, e allorché giunsi in superficie, faticai a rientrare nel mondo esterno.
Quando uscii, i miei occhi cercarono la tomba nuda di Poe per un ultimo
sguardo. Per poco non spiccai un salto. Battei le palpebre per accertarmi
che quanto vedevo fosse vero.
Era un fiore, un fiore profumato, disteso assurdamente fra l'erba e il terriccio della fossa di Edgar Poe. Un fiore che non c'era fino a pochi minuti
prima.
Chiamai il signor Spence, come se vi fosse qualcosa da fare, o come se
avesse potuto vedere qualcosa che io non avevo veduto mentre sedevamo
entrambi in quella volta sotterranea. Nella cripta, il becchino non mi sentì.
Cadendo in ginocchio, esaminai il fiore, pensando che potesse essere volato lì da un'altra tomba. Ma no. Non solo giaceva lì, ma lo stelo era conficcato con forza nel terreno.
Udii uno scalpiccio inatteso di cavalli e alcune ruote che si mettevano in
moto pian piano. Guardandomi intorno, distinsi una carrozza di medie dimensioni avvolta in una leggera foschia. Corsi verso il cancello per cercare
di vedere chi trasportasse, ma dovetti fermarmi subito. Un cane mi si fermò dinanzi con un balzo, abbaiando ferocemente all'indirizzo delle mie
caviglie. Tentai di aggirarlo, ma si spostò improvvisamente di lato, ringhiando e latrando da dietro le lapidi.
Evidentemente l'avevano addestrato per impedire ai «disseppellitori» di
Baltimora di rubare i cadaveri, e quando mi ero messo a correre, mi aveva
scambiato per uno di quei furfanti. Pescando alcuni biscotti allo zenzero
dalle tasche del cappotto, glieli offrii, e l'animale si rabbonì quasi subito.
Ma quando riuscii finalmente a raggiungere la via, la vettura era ormai
scomparsa.
Capitolo 3
L'indomani mattina, fui destato soltanto dai rumori attutiti della servitù
al piano inferiore. Mi lavai e mi vestii in tutta fretta, ma a quell'ora non
trovai vetture a nolo nelle vicinanze di Glen Eliza. Per fortuna, scorsi un
omnibus che caricava i passeggeri proprio in quell'istante.
Non avendo viaggiato con i trasporti pubblici di recente, rimasi colpito
dal numero di forestieri a bordo. Dedussi che non erano di Baltimora dal
loro abbigliamento, dalla loro pronuncia e dalla loro diffidenza verso chi li
circondava. Chissà se... Guarda caso, avevo tra i miei documenti un ritratto
di Poe ritagliato da un articolo biografico di qualche anno addietro. Alla
fermata successiva, mi spostai verso il fondo del veicolo. Quando il controllore finì di raccogliere i biglietti dei nuovi arrivati, gli chiesi se nelle ultime settimane di settembre avesse veduto l'uomo raffigurato sulla rivista.
Avevo calcolato, in base ai resoconti giornalistici più affidabili, che doveva essere quello il periodo in cui Poe era giunto a Baltimora. L'uomo bofonchiò: «Non me lo ricordo» o qualcosa di simile.
Un commento insignificante, lo so. Per cui non valeva forse la pena di
entusiasmarsi? Avvertii tuttavia una punta di soddisfazione. Con quella
piccola informazione avevo appreso che Poe non era stato su quell'omnibus durante il turno di quel controllore. Avevo scoperto una minuscola
porzione di verità dietro la sua ultima sosta a Baltimora, e ne ero lieto.
Dal momento che dovevo comunque girare per la città, non vi sarebbe
stato nulla di male nel prendere l'omnibus più spesso e, quando l'avessi fatto, nel porre quesiti di quel genere.
Avrete senz'altro notato che il soggiorno di Poe a Baltimora non sembrava premeditato. Dopo essersi fidanzato con Elmira Shelton a Richmond, il poeta aveva annunciato l'intenzione di recarsi a New York per
portare a termine i suoi progetti. Ma dove aveva alloggiato a Baltimora, e
che cosa ci era venuto a fare? Baltimora non era così indifferente da perdere un uomo come se nulla fosse, nemmeno nei suoi cantieri navali più
squallidi. Non era Filadelfia. Come mai Poe non era ripartito subito per
New York dopo aver navigato fin qui da Richmond? Cosa era accaduto nei
cinque giorni tra la sua partenza da Richmond e il suo rinvenimento a Baltimora, e che cosa l'aveva ridotto in condizioni tali da dover indossare gli
abiti di qualcun altro?
Dopo la visita al cimitero, avevo stabilito di concentrare su quegli interrogativi le mie facoltà intellettive, che, modestamente, giudicavo accomunabili a quelle di qualunque uomo, o almeno di qualunque uomo avessi
conosciuto fino ad allora (giacché la situazione sarebbe mutata).
Ma poi vi fu quel pomeriggio decisivo in cui le risposte parvero presentarsi in maniera impensata. Peter era stato trattenuto in tribunale, e le nostre scrivanie erano sgombre di nuovo lavoro. Allontanandomi dall'Hano-
ver Market, salii sul marciapiede di Camden Street con le braccia piene di
pacchi.
«Poe il poeta?»
Sulle prime, feci finta di nulla. Poi mi fermai e mi voltai lentamente,
chiedendomi se il vento avesse ingannato le mie orecchie. Se quella voce
non aveva detto spontaneamente: «Poe il poeta», aveva tuttavia pronunciato una frase assai simile.
Era il signor Wilson, il pescivendolo, da cui avevo appena fatto acquisti.
Di recente aveva incaricato il nostro studio legale di occuparsi di alcune
ipoteche. Talora era venuto nel nostro ufficio, ma preferivo incontrarlo lì,
perché così potevo anche scegliere il pesce migliore per la cena a Glen
Eliza. E la sua zuppa di granchio e ostriche era di gran lunga la più squisita.
Mi fece cenno di seguirlo verso il grande mercato. Avevo lasciato il taccuino sul suo bancone. Me lo porse dopo essersi asciugato le mani sul
grembiule macchiato. Ormai l'agenda era impregnata degli odori inconfondibili del suo negozio, come se l'avessi perduto in mare e poi ripescato.
«Non vorrete mica dimenticare il vostro lavoro. L'ho sfogliato per vedere di chi era. Ho notato che avete scritto il nome Edgar Poe.» Indicò la pagina aperta.
Riposi il libretto nella borsa. «Grazie, signor Wilson.»
«Ah, avvocato Clark, guardate qui.» Scartò un involto con entusiasmo.
All'interno vi era un pesce orrendo, impilato sui suoi fratelli identici. «Li
hanno ordinati appositamente dall'Ovest per una cena. Alcuni li chiamano
"pescecani". Ma altri preferiscono "squali del foro" per via dell'aspetto feroce e delle abitudini voraci!» Scoppiò in una fragorosa risata, temendo
subito dopo di avermi offeso. «Non come voi, naturalmente, avvocato.»
«Forse è proprio questo il problema, caro mio.»
«Già.» Esitò, schiarendosi la voce. Ora era intento a pulire i pesci senza
alzare lo sguardo dalle proprie mani o dalle teste che schizzavano via.
«Comunque... un poveretto, doveva essere, quel Poe. Ha tirato le cuoia in
quello scalcinato Washington College Hospital qualche settimana fa, ho
sentito. Il marito di mia sorella conosce un'infermiera là dentro secondo
cui - stando a un'altra infermiera che ha parlato con un medico che pensa
che fosse davvero matto da legare (sono delle maledette ficcanaso, queste
donne) -, mentre giaceva lì, il poeta ha continuato a chiamare un nome
prima di... be', ecco» passò a un sussurro carico di pathos «prima di crepare. Che Dio abbia pietà dei deboli.»
«Avete detto che continuava a chiamare un nome, signor Wilson?»
Sputacchiando, il pescivendolo borbottò qualcosa nel tentativo di ricordare. Sedette sullo sgabello e cominciò a estrarre le ostriche invendute da
un barile, aprendole tutte con cura e verificando che non contenessero alcuna perla prima di disfarsene con rammarico misto a rassegnazione. L'ostrica era il prodotto simbolo di Baltimora, non solo perché poteva essere
commerciata con profitto, ma anche perché offriva sempre la possibilità di
un tesoro ancora più prezioso all'interno. All'improvviso Wilson schioccò
le dita con aria esultante.
«"Reynolds", ecco qual era! Sì, esatto, "Reynolds"! Lo so perché mia sorella non la piantava di ripeterlo quando me l'ha raccontato a cena, e nei
piatti avevamo gli ultimi buoni granchi dal guscio molle della stagione.»
Lo pregai di pensarci bene, finché ne fosse stato certo.
«Reynolds, Reynolds, Reynolds!» ribadì, un poco offeso dal mio scetticismo. «Ecco che cosa ha gridato Poe per tutta la notte. La donna ha detto
che non riusciva a levarselo dalla testa dopo averlo sentito. Vecchio ospedale malconcio... dovrebbero bruciarlo, secondo me. Da giovane conoscevo un Reynolds che lanciava sassi contro i soldati di fanteria... era un tipaccio, senza dubbio, avvocato Clark.»
«Ma Poe aveva mai nominato questo Reynolds prima?» mi domandai ad
alta voce. «Un parente, oppure...»
Smorzato il suo entusiasmo, Wilson mi fissò. «Questo signor Poe era un
vostro amico?»
«Un mio amico» risposi «e un amico di tutti coloro che lo leggevano.»
Mi affrettai ad augurare una buona serata al mio cliente, con profonda
gratitudine per l'utile servigio che mi aveva reso. Avevo avuto la fortuna di
apprendere le ultime sillabe pronunciate da Poe su questa Terra (o almeno,
le penultime), e forse sarei riuscito a ricavarne qualcosa, una rivelazione,
un rimedio agli sfregi e alle critiche della stampa. Quell'unica parola significava che vi era qualcosa su cui indagare, una parte della vita di Poe ancora da scoprire.
Reynolds!
Trascorsi innumerevoli ore a esaminare sia le lettere che Poe mi aveva
spedito sia tutte le sue poesie e i suoi racconti alla ricerca di una qualsiasi
traccia di quel nome. I biglietti per mostre e concerti restarono inutilizzati;
se Jenny Lind, l'«Usignolo svedese», avesse cantato in città, io sarei rimasto ugualmente sepolto tra i miei libri. Mi sembrava di sentire mio padre
che mi ordinava di mettere via tutto quanto e di tornare ai miei volumi di
legge. Immaginavo che avrebbe detto: «I giovanotti come te dovrebbero
imparare che la laboriosità e l'intraprendenza sanno fare con lentezza qualunque cosa il genio faccia con impazienza... e anche molte cose che il genio non sa fare. Il genio necessita dell'industriosità quanto questa necessita
del genio». Ogni volta che consultavo un documento riguardante Poe, avevo l'immediata impressione di litigare con mio padre e mi pareva di vederlo mentre cercava di strapparmi i tomi dalle mani. Non era una sensazione
del tutto sgradevole; anzi, credo che mi abbia incoraggiato. Inoltre, con le
mie capacità da uomo d'affari, avevo promesso a Poe, un potenziale cliente, che l'avrei difeso. Forse papà mi avrebbe elogiato.
Frattanto, Hattie Blum era venuta sovente a Glen Eliza con sua zia. Qualunque biasimo il mio recente errore avesse generato in loro era svanito, o
perlomeno era stato sospeso. Hattie era più sollecita e disponibile che mai
durante i nostri colloqui. Sua zia, forse, era più sospettosa del solito e pareva aver acquisito gli occhi scuri di un agente segreto. Naturalmente, i
miei pensieri assillanti, insieme alla mia consueta tendenza a tacere quando
gli altri parlavano, facevano sì che le donne nel mio salotto discorressero
più tra loro che con me.
«Non so come facciate a sopportarlo» commentò Hattie, alzando lo
sguardo verso l'alto soffitto a cupola. «Non riuscirei a vivere da sola in una
dimora enorme come Glen Eliza, Quentin. Occorre coraggio per avere
troppo spazio a disposizione. Non ne convenite, zietta?»
Zia Blum rise, sbuffando. «La cara Hattie diventa terribilmente melanconica quando la lascio per un'ora in compagnia dei soli domestici. Sanno
essere orribili.»
Uno dei miei servitori entrò dal corridoio per versare loro dell'altro tè.
«Non è così, zietta! Ma con le mie sorelle lontane...» cominciò Hattie,
per poi interrompersi, le guance appena soffuse da un insolito rossore.
«Perché si sono sposate tutte...» aggiunse malignamente l'altra a bassa
voce.
«Certo» concordai, dopo che una lunga pausa da parte di entrambe richiedeva un mio commento.
«Con le mie tre sorelle lontane, be', la casa sembra tremendamente desolata a volte, come se dovessi difendermi ma non sapessi neppure da cosa.
Non avete mai provato una sensazione simile?»
«D'altro canto signorina Hattie,» replicai «si ha il vantaggio di una certa
pace, distanti dal caos delle strade e dalle preoccupazioni altrui.»
«Oh, zia!» esclamò Hattie con vivacità. «Forse amo troppo la confusione. Ritenete che, dopo tutto, il sangue della nostra famiglia sia troppo caldo per Baltimora?»
Desidero spendere una parola riguardo all'interpellata, zia Blum: la donna seduta su una poltrona davanti al camino come se fosse un trono, la
dama imponente con uno scialle avvolto intorno alle spalle come se fosse
il mantello di una regina. Sì, una parola in più sul suo conto, giacché la sua
influenza non diminuirà man mano che le complicazioni s'infittiranno. Era
una rappresentante di quell'energico genere di dame che paiono smarrite
tra cuffiette eleganti e impegni sociali ma che, in realtà, possiedono la dote
di scuotere il loro ascoltatore fino al midollo, con il medesimo tono frivolo
con cui criticano la tavola di una padrona di casa rivale. Per esempio, durante quella stessa visita nel mio salotto, trovò il modo di osservare con
noncuranza: «Quentin, non è una fortuna che Peter Stuart vi abbia scelto
come socio?».
«Prego?»
«Ha un tale fiuto per gli affari! È un uomo di solido discernimento, statene certo. Voi siete il fratello minore - in senso allegorico, intendo - e presto potrete vantarvi di assomigliargli sotto tutti gli aspetti.»
Ricambiai il suo sorriso.
«Be', è come con la nostra Hattie e le sue sorelle. Un giorno, avrà il loro
stesso prestigio sociale... se si mariterà in tempo, beninteso» aggiunse, bevendo un lungo sorso di tè bollente.
Notai che Hattie aveva distolto lo sguardo. Zia Blum era l'unica persona
al mondo che riuscisse a cancellare la meravigliosa sicurezza che la mia
giovane amica aveva di sé, il che mi faceva infuriare.
Posai la mano sulla poltrona di Hattie, vicino alle sue dita. «Quando arriverà quel momento, le sue sorelle impareranno da questa donna a essere
delle brave mogli e delle brave madri, ve lo assicuro, signora Blum. Ancora del tè?»
Non volevo menzionare Edgar Poe al loro cospetto, temendo che zia
Blum trovasse un pretesto per informarne Peter o spedire alla mia prozia,
con cui era diventata molto intima nel corso degli anni, una lettera preoccupata sullo stato della mia salute mentale. A essere sincero, mi sentivo
sollevato ogni volta che una conversazione con quella donna terminava
senza che avessi fatto parola delle mie indagini. Quella costrizione mi rendeva tuttavia smanioso di riprendere le mie ricerche appena le Blum si ac-
comiatavano.
Quel giorno, dopo che fui salito su un omnibus, il controllore mi chiamò
come se avessi appena sputato del tabacco masticato per terra. «Voi!»
Avevo scordato di consegnargli il biglietto. Un inizio funesto. Dopo che
vi ebbi posto rimedio, l'uomo studiò con scrupolosità il mio ritratto di Poe
prima di decidere che quel volto non gli diceva alcunché.
Quell'immagine di Edgar non era delle migliori. Ritenevo tuttavia che ne
catturasse i tratti essenziali. I baffi scuri, più diritti e curati dei capelli ricciuti. Gli occhi, limpidi e a mandorla... occhi colmi di un'irrequietezza
pressoché magnetica. La fronte, così larga e sporgente sopra le tempie che,
da certe angolazioni, il poeta poteva essere scambiato per calvo... un uomo
tutto fronte.
Quando le porte si chiusero e fui spinto su un sedile dalla fila dei passeggeri appena saliti, un tipo basso e corpulento mi strattonò il braccio con
l'estremità dell'ombrello.
«Desiderate?» urlai.
«Ecco, il tale di quell'illustrazione, credo di averlo veduto qualche tempo
addietro. Più o meno in settembre, come avete chiesto al controllore.»
«Davvero, signore?» domandai.
Prendeva lo stesso omnibus quasi tutti i giorni, mi spiegò, e ricordava di
aver incrociato qualcuno di molto somigliante all'uomo del ritratto. Era accaduto mentre scendevano dal veicolo.
«Lo rammento perché mi ha chiesto aiuto... Voleva sapere dove vivesse
un certo dottor Brooks, se non erro. Sono un ombrellaio, non uno stradario.»
Concordai senza indugio, pur non sapendo se quell'ultimo commento
fosse rivolto a me o a Poe. Il nome di N. C. Brooks mi era abbastanza familiare, e sicuramente lo era stato a Edgar Poe. Il dottor Brooks era il direttore di un giornale che aveva pubblicato alcune delle sue poesie e dei
suoi racconti più belli, contribuendo a far conoscere lo scrittore ai lettori di
Baltimora. Finalmente una prova concreta che, dopo tutto, Poe non si era
volatilizzato nell'aria della nostra città.
Il frastuono dei cavalli iniziò a diminuire, e saltai giù appena il veicolo si
approssimò alla fermata successiva.
Mi precipitai allo studio per consultare lo stradario e cercare l'indirizzo
del dottor Brooks. Dal momento che erano le sei di sera, avevo dato per
scontato che Peter fosse già rincasato dopo aver assolto i suoi impegni in
tribunale. Ma mi ero sbagliato.
«Amico mio» tuonò da sopra la mia spalla. «Parete stupito! Siete quasi
morto per lo spavento!»
«Peter.» Tacqui, accorgendomi di essere senza fiato. «È solo che... be',
stavo proprio per uscire di nuovo.»
«Ho una sorpresa» annunciò, sorridendo e sollevando il suo bastone da
passeggio come uno scettro. Mi sbarrò la strada verso la porta, la sua mano
mi afferrava saldamente la spalla.
«Questa sera, a casa mia, ci sarà un sontuoso banchetto, con molti amici
miei e vostri, Quentin. È stato organizzato da poco, perché è il compleanno
di qualcuno che è assai...»
«Ma, come vedete, ero sul punto di...» lo interruppi, spazientito, ma mi
zittii quando scorsi un luccichio indecifrabile nei suoi occhi.
«Che cosa, Quentin?» Si guardò intorno pian piano, con finta curiosità.
«Qui non c'è più niente da fare questa sera. Dovete forse correre da qualche parte? Dove?»
«No» farfugliai, arrossendo appena, «nulla che non possa rimandare.»
«Bene, allora andiamo.»
La tavola di Peter era affollata di volti familiari in occasione del ventitreesimo compleanno di Hattie Blum. Non avrei dovuto ricordarlo? Avvertii una terribile fitta di rimorso per la mia insensibilità. Avevo festeggiato
con lei ogni suo compleanno. Mi stavo forse allontanando così tanto dalla
mia strada consueta da rinunciare persino ai più gradevoli eventi mondani
e agli amici più intimi? Be', una sola visita a Brooks, e ritenevo che la mia
ossessione si sarebbe risolta felicemente.
Quella sera, erano presenti le signore e i signori più rispettabili che si
potessero incontrare a Baltimora. Eppure, in quell'istante, avrei preferito
essere nella sala degli assassini di Madame Tussaud, o in qualunque altro
posto, fuorché intrappolato in conversazioni pigre e melliflue proprio
quando avevo un compito così importante da svolgere.
«Come avete potuto?» mi chiese una robusta donna dalle guance rosee
che si materializzò davanti a me quando sedemmo per gustare quella cena
raffinata.
«Prego?»
«Oh, santo Cielo!» esclamò con un gemito umile e scherzoso. «Guardate
me, che sono vecchia e brutta, quando avete un simile esemplare di bellezza lì accanto.» Indicò Hattie.
Naturalmente, non avevo guardato la donna dalle guance rosee, o almeno non di proposito. Mi avvidi di essere caduto in un'altra delle mie trance.
«Sono circondato dalla bellezza assoluta, vero?»
Hattie non arrossì. Mi piaceva che non arrossisse per i complimenti. Mi
bisbigliò con fare confidenziale: «Fissavate l'orologio e avete trascurato la
nostra ospite più affascinante, l'anatra brasata con sedano selvatico, Quentin. L'instancabile signor Stuart non vi concede neppure una serata libera
dal lavoro?».
Sorrisi. «Non è colpa di Peter questa volta» confessai. «Ho scarso appetito in questi giorni.»
«Con me potete parlare, Quentin» disse Hattie, e in quell'istante parve
possedere un'indole più dolce di qualunque altra donna avessi mai conosciuto. «A cosa pensate ora, con quell'espressione così turbata?»
«Penso, cara signorina Hattie...» esitai prima di aggiungere «ai versi di
una poesia.» Il che era vero, perché li avevo riletti proprio quel mattino.
«Recitatemeli, Quentin, per favore.»
Nella mia profonda disattenzione, avevo bevuto due bicchieri di vino
senza mangiare abbastanza per contrastarne gli effetti sulla mente. Sicché,
dopo qualche insistenza da parte di Hattie, mi ritrovai ad accettare. Sentivo
la mia voce come fosse quella di un estraneo; era piena, audace e persino
sonora. Per farsi un'idea di quella declamazione, il lettore dovrebbe alzarsi
in piedi ovunque gli capiti di trovarsi e avere l'ardire di pronunciare quanto
segue in tono cupo e solenne. Nel frattempo, deve anche immaginare un'allegra tavolata cadere in quel silenzio brusco e stridente che accompagna le
interruzioni imposte.
Scintillava di perle e rubini
la porta del bel palazzo
e ne usciva a torrenti, a torrenti
una folla smagliante di Echi;
la cui dolce funzione era solo
di cantare cantare cantare,
con le voci più belle del mondo,
la sapienza sottile del re...
Ma genii del male, vestiti a lutto,
assalirono la casa del monarca
(ah piangiamo, piangiamo, che mai
l'indomani avrà alba per lui!),
sì che intorno alla casa, la gloria
risplendente una volta di porpora
si è mutata in oscura memoria
degli anni travolti laggiù.
Dopo aver terminato la poesia, mi sentii trionfante. Alle mie orecchie
giunsero timidi battimani sporadici, soffocati da qualche colpo di tosse.
Peter mi guardò, aggrottando le sopracciglia e lanciando contemporaneamente un'occhiata compassionevole a Hattie. Solo alcuni invitati che non
avevano ascoltato alcunché, ma che sarebbero stati riconoscenti per qualsiasi diversivo, parevano soddisfatti. Hattie continuò ad applaudire dopo che
tutti gli altri ebbero smesso.
«Sono i versi più raffinati mai uditi al compleanno di una ragazza» mi
lodò.
Poco dopo, una delle sue sorelle accettò di cantare una canzone al pianoforte. Intanto, avevo bevuto dell'altro vino. Dopo che le signore si furono
spostate in un'altra stanza e gli uomini ebbero cominciato a fumare, il cipiglio di Peter, che era comparso e scomparso più volte con un tremito durante la recitazione dei versi, divenne costante allorché mi condusse in un
angolo discreto, protetto dall'imponente camino.
«Sapevate, Quentin, che Hattie era quasi decisa a non festeggiare il suo
compleanno questa sera e che ha ceduto all'ultimo momento, quando ho
insistito per organizzare una cena?»
«Non per colpa mia, Peter?»
«Come può qualcuno convinto che tanta parte del mondo conti su di lui,
non vedere chi effettivamente conta su di lui? Non ricordavate neppure che
era il suo compleanno. È ora di finirla, Quentin. Rammentate le parole di
Salomone: "Per negligenza il soffitto crolla e per l'inerzia delle mani piove
in casa".»
«Non so dove vogliate arrivare» ribattei, irritato.
Mi guardò dritto negli occhi. «Lo sapete eccome! Questo strambo comportamento. Prima, la bizzarra ossessione per il funerale di un estraneo.
Adesso l'abitudine di viaggiare avanti e indietro sugli omnibus senza meta
come un vagabondo...»
«Ma chi ve l'ha riferito, Peter?»
E c'era dell'altro, proseguì. Mi avevano veduto una settimana prima correre per le vie con gli abiti sgualciti, impegnato a inseguire qualcuno come
se fossi un poliziotto sul punto di effettuare un arresto. Avevo anche continuato a trascorrere quantità smodate di tempo in biblioteca.
«Poi l'idea che degli sconosciuti vi minaccino per la strada a causa delle
poesie che leggete. Considerate le vostre letture così interessanti da indurre
le persone a farvi del male? E infine vagate per il vecchio cimitero presbiteriano come un miserabile disseppellitore in cerca di cadaveri da trafugare, o come la vittima di un incantesimo!»
«Aspettate» intervenni, ritrovando la calma. «Come fate a sapere, Peter,
che sono stato al vecchio cimitero l'altro giorno? Sono sicuro di non avervene accennato.» Ripensai alla carrozza che si allontanava con rapidità.
«Perbacco, Peter! Eravate voi? Mi avete seguito!»
Annuì, quindi scrollò le spalle. «Sì, vi ho seguito. E vi ho scorto in quel
camposanto. Ammetto con franchezza che ero alquanto preoccupato. Volevo sincerarmi che non vi foste cacciato in qualche guaio o che non vi foste unito a qualche fanatico millerita per attendere da qualche parte, con
indosso una tunica bianca, che il Salvatore scenda dal Cielo tra due martedì! Il denaro di vostro padre non durerà per sempre. Essere ricchi e inutili
equivale a essere poveri. Se indulgete in strane abitudini, temo che lo dissiperete o che qualche donna (una rappresentante del gentil sesso inferiore
alla signorina Blum, per l'appunto), vedendovi in condizioni tanto desolate,
lo sperperi al vostro posto. Persino un uomo con la forza di Ulisse deve legarsi all'albero della sua nave quando affronta la scaltrezza femminile!»
«Perché avete lasciato quel fiore sulla sua tomba?» domandai. «Per farvi
beffe di me?»
«Un fiore? Di cosa state parlando? Quando ho scoperto dove eravate finito, vi ho intravisto inginocchiato su quella tomba, come se adoraste un
idolo. È tutto ciò che ho veduto, e mi è bastato. Un fiore... Credete che abbia tempo per cose simili?»
Su quel punto non potei fare a meno di credergli, perché sembrava davvero che non avesse mai udito la parola «fiore» prima di allora o che non
ne avesse mai ammirato uno. «E siete stato voi a mandarmi quell'uomo?
Quell'avvertimento a non interferire? Per cercare di dissuadermi dai miei
interessi personali? Ditemelo subito!»
«Assurdo! Quentin, rendetevi conto delle assurde sciocchezze che escono dalla vostra bocca prima che qualcuno vi metta la camicia di forza! Tutti sapevano che avreste avuto bisogno di tempo dopo quanto è accaduto. Il
vostro abbattimento era...» Distolse lo sguardo per un attimo. «Ma sono
passati sei mesi.» Per l'esattezza, erano passati cinque mesi e una settimana
da quando avevo sepolto i miei genitori. «Dovete riflettere su tutto questo
sin d'ora, altrimenti...» Non completò mai quella frase, limitandosi ad as-
sentire con decisione per sottolineare il concetto. «È quell'altro mondo ciò
contro cui combattete.»
«L'"altro mondo", Peter?»
«Pensate che io voglia contrastarvi. Ma ho tentato di comprendervi meglio, Quentin. Mi sono procurato una raccolta di novelle di quel Poe. Ho
letto metà di un racconto, ma non sono riuscito ad andare oltre. Mi è parso...» Lì la sua voce si ridusse a un sussurro confidenziale. «Mentre leggevo, mi è parso che Dio fosse morto, Quentin. Sì, è quell'altro mondo che
mi fa stare in pena per voi, quel mondo di libri e scrittori capaci di invadere le menti di chi li legge. Quel mondo immaginario. No, questo è l'universo cui appartenete. Questa è la vostra classe, composta di persone serie e
assennate. La vostra società. Vostro padre diceva che il fannullone e l'uomo melanconico avrebbero peregrinato insieme per sempre in un deserto
morale.»
«So che cosa diceva mio padre!» mi indignai. «Era mio padre, Peter!
Non credete che ne conservi un ricordo vivido quanto il vostro?»
Guardò altrove. Sembrò imbarazzato dalla mia domanda, come se avessi
messo in discussione la sua stessa esistenza, mentre invece desideravo
davvero conoscere la sua risposta. «Siete stato come un fratello per me»
affermò. «Voglio soltanto vedervi felice.»
Un signore ignaro ci interruppe, ponendo fine alla nostra conversazione.
Rifiutai il tabacco che mi offrì, ma accettai un ponce caldo. Peter aveva ragione. Aveva assolutamente ragione.
I miei genitori mi avevano regalato una posizione sociale, ma ora toccava a me meritarne gli agi e le frequentazioni raffinate. Quale insidiosa irrequietezza avevo coltivato! Era per godere dei lussi e dei piaceri di quegli
ambienti eleganti che sgobbavo allo studio legale. Per godere della compagnia di una signora come Hattie, la cui amicizia e la cui incrollabile influenza non mi avevano mai abbandonato. Chiusi gli occhi e ascoltai i
suoni, quei suoni benevoli e soddisfatti che mi circondavano con calore da
ogni lato, soffocando i miei pensieri turbolenti. Là dentro le persone conoscevano se stesse, e non dubitavano nemmeno per un momento di saper
capire gli altri e di essere perfettamente capite a loro volta.
Quando Hattie tornò nella stanza, la chiamai con un gesto. Con sua sorpresa, le afferrai subito la mano e gliela baciai, quindi le diedi un bacio
sulla guancia dinanzi a tutti. Gli invitati tacquero uno dopo l'altro.
«Voi mi conoscete» le bisbigliai.
«Quentin! State male? Avete le mani calde.»
«Hattie, conoscete i miei sentimenti nei vostri confronti qualunque cosa
ne dicano le malelingue, vero? Non mi avete sempre conosciuto nonostante gli sguardi e le risatine sciocche di costoro? Sapete che sono onesto, che
vi amo, che vi amavo ieri come vi amo oggi.»
Prese la mia mano tra le sue, e fui percorso da un brivido al vederla così
raggiante solo perché avevo pronunciato qualche parola sincera. «Mi amavate ieri come mi amate oggi. E domani, Quentin?»
Alle undici di quella sera, la sera del suo ventitreesimo compleanno,
Hattie accettò la mia proposta di matrimonio con un semplice cenno del
capo. Tutti i presenti mi giudicarono un buon partito. Il sorriso di Peter era
smagliante come quello di tutti gli altri; dimenticò completamente le frasi
dure con cui mi aveva rimproverato e si assunse più di una volta il merito
di quel fidanzamento.
Alla fine della serata, non avevo quasi riveduto Hattie, tanto ci avevano
assediati da ogni lato. Avevo la mente ottenebrata dall'alcol e dalla stanchezza, e dal compiacimento di aver fatto la cosa giusta. Peter dovette depormi con cautela sul sedile di una carrozza e ordinare al vetturino di accompagnarmi a casa. Nonostante lo stordimento, tuttavia, presi da parte il
cocchiere negro prima che mi scaricasse dinanzi a Glen Eliza.
«Potete tornare domattina presto, signore?» chiesi.
Gli tesi un'altra moneta d'argento per suggellare il nostro accordo.
L'indomani era lì, sul mio vialetto. Per poco non lo mandai via. Ero un
uomo diverso dal mattino precedente. La notte mi aveva mostrato che cosa
era reale nella mia vita: sarei stato un marito. Da quella prospettiva, era palese che mi ero già spinto ben al di là dell'accettabile nell'interesse per le
ultime ore di vita di un tale la cui scomparsa aveva lasciato indifferente
persino suo cugino. E il fantasma?, mi domanderete. Be', ormai era innegabile che Peter avesse perfettamente ragione. Quel tipo era un pazzo instabile che doveva aver udito il mio nome in un'aula di tribunale o in qualche piazza pubblica e si era soltanto abbandonato a un vaneggiamento.
Nulla a che vedere né con Poe né con le mie letture private. Perché avevo
consentito a quell'episodio (e a Poe) di privarmi della serenità? Perché mi
ero esaltato tanto quando avevo creduto di poter trovare una risposta? Ora
non riuscivo quasi a pensarci. Decisi di mandare via la carrozza. Suppongo
che, se l'onesto vetturino non mi fosse sembrato così ansioso di compiacermi, l'avrei fatto; non sarei salito. Talvolta mi chiedo come sarebbero
andate le cose.
Alla fine salii. Gli fornii l'indirizzo del dottor Brooks. Quella sarebbe
stata la mia ultima incursione nell'«altro mondo». E mentre avanzavamo,
ripensai ai racconti di Poe, a come l'eroe sceglieva, quando non vi erano
più alternative valide, di individuare un confine impossibile che quasi nessuno avrebbe osato attraversare (come faceva il pescatore smarrito di Una
discesa nel Maelstrom, precipitando nel vortice dell'eternità). Non vi è la
semplicità di una storia come quella di Robinson Crusoe, che deve principalmente sopravvivere, come tenteremmo di fare tutti; vivere, sopravvivere, è soltanto l'inizio per una mente come quella di Poe. Persino il mio personaggio preferito, il grande analista Dupin, cerca di accedere, senza invito
e in maniera deliberata e sprezzante, a una dimensione che genera inquietudine. L'aspetto prodigioso non è solo la descrizione del suo ragionamento, del suo raziocinio, ma la sua stessa presenza. In una novella, Poe allude
al conflitto tra la sostanza e l'ombra dentro di noi. La sostanza, quello che
sappiamo di dover fare, e l'ombra, il pericoloso e sogghignante demone
della perversità, la conoscenza oscura di quanto dobbiamo o vogliamo fare
oppure di quanto desideriamo segretamente. L'ombra vince sempre.
Mentre percorrevamo i viali ombreggiati tra alcune delle dimore più signorili, mi sentii sbalzare in avanti all'improvviso.
«Perché ci siamo fermati?» domandai.
«Eccoci arrivati, signore.» Il cocchiere venne ad aprirmi lo sportello.
«Non può essere...»
«Prego? Signore...»
«No. Dev'essere più in là, vetturino!»
«Fayette due-sette-zero, come avete chiesto. Proprio qui.»
Aveva ragione. Allorché mi sporsi dal finestrino per osservare la scena,
dovetti tenermi forte.
Capitolo 4
Ecco che cosa avevo immaginato: una conversazione con Brooks, magari una tazza di tè. Mi avrebbe parlato del soggiorno di Poe a Baltimora, descrivendomi i suoi obiettivi e i suoi progetti. Mi avrebbe spiegato come
mai il poeta aveva cercato con tanta urgenza un certo signor Reynolds.
Forse mi avrebbe persino confessato che Poe gli aveva parlato di me, l'avvocato pronto a prendere le difese della sua nuova rivista. Mi avrebbe svelato tutti i dettagli della morte di Poe, quelli che avevo sperato di apprendere da Neilson. Avrei divulgato la storia di Brooks alla stampa, e i giorna-
listi avrebbero corretto malvolentieri i laconici resoconti pubblicati dopo la
scomparsa di Edgar.
Quello era l'incontro per cui mi ero preparato quando avevo udito il nome di Brooks per la prima volta.
Invece, l'unica persona presente nei paraggi del 270 di Fayette Street era
un uomo di colore che, solitario e determinato, smantellava un pezzo della
struttura di legno della costruzione bruciacchiata e malridotta.
Mi paralizzai davanti all'abitazione del dottor Brooks, nella speranza di
essere nel luogo sbagliato. Avrei dovuto portare lo stradario per assicurarmi che l'indirizzo fosse corretto, anche se l'avevo persino annotato su due
pezzetti di carta ora infilati in due taschini diversi del mio panciotto. Controllai il primo...
Dottor Nathan C. Brooks, 270 Fayette St.
Poi estrassi l'altro.
Dottor N. C. Brooks, 270 Fayette St.
Era quella la casa. Non c'erano dubbi.
L'odore di legno bruciato e fradicio mi procurò un accesso di tosse.
Frammenti di porcellana e brandelli carbonizzati di arazzi distrutti parevano costituire il pavimento interno. Era come se un abisso si fosse spalancato lì sotto e avesse inghiottito ogni forma di vita esistente.
«Che cosa è accaduto qui?» chiesi quando riuscii a riprendere fiato.
«Pregate Iddio» ripeteva tra sé e sé il falegname sotto voce. Grazie al
Cielo, aggiunse, i vigili del fuoco avevano evitato danni più gravi. «Se il
dottor Brooks non avesse ingaggiato un incapace» proseguì «e senza quella maledetta pioggia, le riparazioni sarebbero già state ultimate da un pezzo, e splendidamente.» Nel frattempo, il proprietario alloggiava da alcuni
parenti, ma l'operaio non sapeva dove.
Precisò inoltre che l'incendio risaliva a circa due mesi addietro. Facendo
un rapido calcolo, mi resi conto con sbigottimento cosa significava. Le
fiamme erano divampate più o meno nel periodo... proprio nel periodo in
cui Edgar Poe era arrivato a Baltimora in cerca del dottor Brooks.
«Che cosa desiderate denunciare?»
«Come vi ho detto, se foste così gentile da chiamare il commissario, gli
fornirò tutti i dettagli.» Mi trovavo alla centrale di polizia del Middle District.
Dopo vari botta e risposta di questo genere, l'agente tornò dalla stanza
accanto con un uomo dall'aria sveglia. La mia smania di saperne di più era
riemersa con tutta la sua forza, ma con uno spirito totalmente diverso.
Mentre ero in piedi dinanzi all'ispettore e gli narravo gli avvenimenti delle
ultime settimane, avvertii un'ondata di sollievo. Dopo quanto avevo veduto
a casa di Brooks, dopo aver respirato le ultime tracce di quella devastazione e aver guardato le finestre ormai vuote e sonnacchiose e i tronchi degli
alberi sfregiati, avevo capito che quella faccenda stava diventando più
grande di me.
L'ispettore esaminò i ritagli di giornale che gli porsi man mano che gli
spiegavo i punti trascurati o fraintesi dalla stampa.
«Signor Clark. Non so che cosa si possa fare. Se vi fosse motivo di credere che un atto criminoso fosse associato a questo...»
Gli afferrai la spalla come se avessi ritrovato un amico perduto. «Lo ritenete possibile?»
Mi guardò con scarsa convinzione.
«Appurare se sia stato commesso un atto criminoso...» insistetti. «È proprio questo il genere di quesiti cui dovete rispondere, mio buon ispettore.
Proprio questo! Ascoltatemi. L'hanno rinvenuto con indosso abiti della misura sbagliata. Gridava il nome di un certo "Reynolds". Non so chi possa
essere. L'edificio cui era diretto si è tramutato in un rogo, magari nel momento stesso in cui l'ha raggiunto. E credo che un uomo, un tale che non
avevo mai veduto prima, abbia cercato di intimidirmi affinché abbandonassi le indagini su questa vicenda. Ispettore, questo mistero non può essere ignorato un attimo di più!»
«Questo articolo» disse, concentrandosi ancora sul ritaglio, «afferma che
Poe era uno scrittore.»
Un passo avanti. «Il mio autore preferito. Anzi, se siete un lettore di riviste, scommetto che vi siete imbattuto nella sua produzione letteraria.» Elencai alcuni dei racconti più noti di Poe (Gli assassina della Rue Morgue,
Il mistero di Marie Roget, La lettera rubata, Sei stato tu!, Lo scarabeo d'oro), pensando che gli argomenti di quei racconti del mistero, ovvero il crimine e l'assassinio, potessero possedere un fascino particolare per un poliziotto.
«Era così che si chiamava?» L'agente che mi aveva accolto all'ingresso
mi interruppe mentre recitavo la mia lista. «Poe?»
«Poe» confermai, forse con troppa asprezza. Quella sua richiesta di conferma mi aveva infastidito. Molte delle poesie e dei racconti di Poe erano
divenuti assai famosi, ma erano riusciti a eclissare lo scrittore, privandolo
della celebrità personale che gli spettava. Quanta gente avevo incontrato
che sapeva recitare con fierezza tutto Il corvo e molte delle sue popolari
parodie (Il tacchino, per esempio), ma non rammentava il nome dell'autore? Poe attirava lettori che apprezzavano le sue opere ma si rifiutavano di
ammirarlo come autore; era come se la sua produzione letteraria lo avesse
interamente inghiottito.
Il poliziotto ripeté la parola «Poe», ridendo come se contenesse uno
spassoso doppio senso. «Ne avete letto qualcosa, ispettore White» disse al
suo superiore con fare amichevole. «Quella novella in cui i corpi vengono
rinvenuti sanguinanti e martoriati in una stanza chiusa a chiave, la polizia
parigina non riesce a scoprire alcunché, e guardate un po', emerge che il
colpevole è il maledetto scimmione di un marinaio! Figuratevi!» Come se
facesse parte della storia, prese a camminare dinoccolato come un primate.
L'ispettore White aggrottò le sopracciglia.
«Vi è quel buffo francese» continuò l'altro «che analizza i fatti con tutte
le sue strambe elucubrazioni e che intuisce subito la verità riguardo a ogni
cosa.»
«Sì, monsieur Dupin!» interloquii.
«Ora ricordo» disse White. «Ecco la mia opinione, signor Clark. Non
potreste usare le frottole sconclusionate di quei racconti neppure per acciuffare il più comune dei ladri di Baltimora.» Coronò quel commento con
una serie di risa sguaiate. L'agente, dapprima perplesso, imitò il suo esempio con un tono più alto, cosicché vi erano due uomini che si sbellicavano
mentre io ero lì immobile, sinistro come un impresario delle pompe funebri in tempo di guerra.
Non avevo il minimo dubbio che quei poliziotti avrebbero potuto imparare, o cercare di imparare, un infinito numero di finezze investigative dai
racconti di Poe. A essere sincero, il prefetto di polizia che Dupin metteva
in difficoltà nelle novelle era più sagace dei miei attuali interlocutori per la
comprensione di quanto viene definito misterioso, inspiegabile, inevitabile.
«I giornali concordano con voi sul fatto che vi sia altro da portare alla
luce?»
«Non ancora. Ho sollecitato i direttori e seguiterò a usare la mia influenza per convincerli» promisi.
Gli occhi dell'ispettore White vagarono qua e là con scetticismo mentre
gli fornivo ulteriori particolari. Meditò tuttavia sulla nostra conversazione
e, con mia sorpresa, convenne che la polizia avrebbe dovuto investigare
sulla faccenda. Frattanto, mi consigliò di dimenticarmene e di non farne
parola a nessun altro.
Dopodiché, non accadde nulla di particolare per diversi giorni. Io e Peter
facemmo buoni affari con alcuni importanti clienti che di recente avevano
richiesto i nostri servigi. Incrociavo Hattie a una cena o in Baltimore
Street, mentre passeggiava a braccetto con sua zia, e ci aggiornavamo a vicenda sulle ultime novità. Mi perdevo beatamente nella sua voce tranquilla. Poi, un giorno, mi fu recapitato un messaggio con cui White mi chiedeva di raggiungerlo. Mi precipitai alla centrale.
L'ispettore mi ricevette subito. Dal suo sorriso nervoso, si sarebbe detto
che era impaziente di comunicarmi qualcosa. Gli domandai se avesse fatto
progressi.
«Oh, parecchi. Sì, direi che possiamo definirli "progressi"!» Dopo aver
rovistato in un cassetto, mi porse i ritagli di giornale che gli avevo lasciato.
«Ispettore, forse avrete bisogno di consultarli ancora nel corso dell'indagine.»
«Non vi sarà alcuna indagine, signor Clark» annunciò, perentorio, appoggiandosi allo schienale della sedia. Solo allora notai che vi era un altro
uomo, impegnato a recuperare il cappello e il bastone da un tavolo. Mi
voltava le spalle, ma poi si girò.
«Signor Clark» mi salutò Neilson Poe a bassa voce, dopo aver battuto le
palpebre con lentezza come se si sforzasse di rammentare il mio nome.
«Ho contattato il signor Neilson Poe» spiegò White, indicando con
compiacimento il suo ospite. «È noto nelle corti di giustizia come uno dei
nostri cittadini più stimati, ed era cugino del defunto. Voi signori vi conoscete? Il signor Poe è stato così gentile da discutere dei vostri timori con
me, signor Clark» proseguì l'ispettore White. Sapevo già che cosa stava
per arrivare. «Il signor Poe ritiene che non sia necessaria alcuna inchiesta.
È soddisfatto di quanto è emerso riguardo alla prematura scomparsa di suo
cugino.»
«Ma, signor Poe,» protestai «voi stesso avete ammesso di non essere
riuscito a scoprire che cosa era capitato durante gli ultimi giorni di Edgar!
Converrete che sono avvolti da un fitto mistero!»
Neilson si stava infilando il mantello. Osservandolo, ripensai alla sua
condotta durante il nostro incontro e al suo atteggiamento verso Edgar.
«Temo di non potervi dire altro sulla sua morte» aveva dichiarato nel suo
studio. Ma, mi chiesi ora, aveva voluto dire che non sapeva nient'altro o
che non intendeva rivelarmi niente?
Mi chinai verso White, cercando di farmi udire solo da lui. «Ispettore,
non potete... Neilson crede che Edgar Poe stia meglio da morto che da vivo!» Ma mi zittì.
«E il qui presente signor Herring concorda con il signor Poe» continuò.
«Forse lo conoscete... il commerciante di legname. È uno zio acquisito del
signor Poe, ed è stato il primo parente ad accorrere alla quarta sezione elettorale, istituita presso l'hotel Ryan, nel giorno in cui il signor Poe è stato
trovato laggiù in preda al delirio.»
Henry Herring aspettava Neilson sulla soglia. Alla menzione della sua
tempestiva comparsa sul luogo del rinvenimento di Edgar Poe, abbassò il
capo. Più basso e robusto di Neilson, aveva un'espressione torva. Mi strinse la mano con un gesto rigido e senza il benché minimo interesse. Era uno
dei quattro uomini che avevo veduto allo squallido funerale di Poe.
«Lasciate riposare i morti» mi disse Neilson. «La vostra curiosità mi pare morbosa. Forse non assomigliate a mio cugino solo nella calligrafia.»
Pacato, augurò a tutti un buon pomeriggio e uscì a passo spedito.
«Che la pace sia con le sue ceneri» concluse Henry Herring con solennità, prima di raggiungere Neilson davanti all'edificio.
«A ogni modo, abbiamo già abbastanza grattacapi, signor Clark» riprese
White dopo che fummo rimasti soli. «I vagabondi, gli stranieri, le donne di
malaffare, le molestie, la corruzione, le rapine nei negozi e la depravazione
di bambini innocenti... Non abbiamo tempo per sciocchezze di questo tipo.»
Continuò a chiacchierare a vanvera e, mentre parlava, lanciai un'occhiata
fuori della finestra, seguendo con lo sguardo Neilson Poe e Henry Herring
fino a una carrozza. Quando lo sportello si aprì, scorsi una donna minuta
che li attendeva all'interno. Neilson le sedette accanto. Mi occorse un attimo per accorgermi che mi era stranamente familiare. Di lì a un istante
rammentai con un brivido nelle ossa dove avevo veduto quella signora, o
meglio una donna identica a lei. L'inquietante ritratto che Neilson Poe mi
aveva mostrato nel suo ufficio. Quella donna era quasi una sosia, una gemella, di Virginia, il giovane amore perduto di Edgar. Per quanto mi riguardava, era Virginia, la cara Sissy di Poe!
Appena ne ricordai i lineamenti, immortalati solo poche ore dopo la sua
morte, alcuni versi di Edgar Poe si insinuarono nella mia mente:
Ora giace là in fondo così bella e gentile. C'è ancora
la vita sui suoi biondi capelli, ma non nei suoi occhi;
la vita è ancora lì tra i capelli, la morte è sugli occhi.
Un momento! Stentavo a crederci. La descrizione della splendida Eleonora defunta coincideva in parte con l'avvertimento del fantasma. «Chi interferisce giacerà là in fondo.» Dunque quel monito aveva a che fare con
Poe, proprio come avevo ipotizzato. Giacerà là in fondo.
Sporgendomi dalla finestra, guardai la carrozza che si allontanava piano.
White sospirò. «Rassegnatevi, signor Clark» mi suggerì. «Non c'è altro,
signore. Vi prego di lasciar perdere queste preoccupazioni. Sembrate incline a considerare straordinari fatti che sono del tutto ordinari. Avete una
moglie, signor Clark?»
Quella domanda attirò di nuovo la mia attenzione su di lui. Esitai. «L'avrò presto.»
Rise con l'aria di chi la sa lunga. «Bene. Allora dovreste avere molte cose cui pensare senza il bisogno di rimuginare su questa triste vicenda. Altrimenti la vostra innamorata potrebbe darvi il benservito.»
La riproduzione fedele della pagina vuota di fronte a me descriverebbe
lo sconforto che provai più tardi, seduto davanti alla finestra appannata che
si affacciava sull'andirivieni dei pedoni in strada. Mi trattenni in ufficio
persino più a lungo di Peter. Avrei dovuto sentirmi tranquillo. Avevo fatto
tutto il possibile. Avevo persino parlato con la polizia. Non vi era null'altro
che potessi tentare. Un drappo di monotonia pareva stendersi dinanzi a me.
Le giornate trascorsero in quel modo. Caddi in un grave stato di tedio
che nessun intrattenimento sociale riuscì a lenire. Fu allora che qualcuno
bussò alla mia porta e mi consegnò una lettera. Era un fattorino mandato
dalla biblioteca; non avendomi veduto per qualche tempo, il bibliotecario
aveva deciso di inviarmi alcuni ritagli di giornale in cui si era imbattuto.
Ritagli di giornale risalenti a diversi anni addietro. Notando che alcuni accennavano a Edgar Poe e rammentando senza dubbio le mie ricerche, aveva pensato di allegarli alla missiva.
Uno di quegli articoli mi assorbì completamente.
Pensate un po'.
Lui era stato là fuori sin dal principio.
Capitolo 5
16 settembre 1844
Il nostro giornale è stato informato da un'«amica» del brillante
ed eccentrico scrittore Edgar A. Poe che C. Auguste Dupin, il
perspicace eroe creato dalla penna del signor Poe, ricorda da vicino un individuo in carne e ossa, a lui simile nel nome e nelle
imprese, famoso per le sue formidabili capacità analitiche. Questo rispettato signore è assai celebre nell'area di Parigi, dove la
polizia cittadina richiede spesso il suo intervento in casi ancor
più sconcertanti di quelli che il signor Poe ha narrato nei suoi originalissimi racconti incentrati sul signor Dupin, di cui La lettera
rubata è il terzo episodio (benché i direttori sperino che ne seguano altri). Ci domandiamo quante migliaia di enigmi scottanti emersi in questi ultimi anni nel nostro Paese, e quanti ancora in
avvenire, questo autentico genio parigino avrebbe potuto risolvere senza fatica.
Capitolo 6
Tenevo il ritaglio tra le mani. Leggendolo, avvertii una differenza indescrivibile in me stesso e in quanto mi attorniava. Mi sentii rapito.
Qualche minuto dopo che il fattorino fu uscito dal mio ufficio, Peter vi
fece irruzione con le braccia colme di documenti.
«Che cosa esaminate con un'euforia tanto incontenibile, Quentin?» chiese. Penso che fosse solo una domanda retorica, ma ero così entusiasta che
gli risposi.
«Peter, guardate voi stesso! Me l'ha mandato il bibliotecario con qualche
altro articolo.»
Non riesco a capire il motivo per cui non mi fossi riuscito a trattenere,
forse perché le conseguenze delle mie azioni non avevano più alcuna importanza per me.
Peter lesse il testo con lentezza, rabbuiandosi. «Che cos'è questo?» domandò a denti stretti. Non posso evitare di condividere la sua reazione di
disapprovazione: l'indomani avremmo avuto un'udienza in tribunale e Peter aveva lavorato alacremente per prepararsi al giorno dopo. E invece io
cosa avevo fatto? Avevo forse studiato i documenti per il nostro cliente? Li
avevo forse controllati per un'ultima volta alla ricerca di eventuali errori?
No.
«Esiste un vero Dupin a Parigi. Mi riferisco al personaggio di Poe, l'in-
vestigatore geniale» spiegai. «"Assai celebre nell'area di Parigi." Capite? È
un miracolo.»
Sbatté il foglio sulla mia scrivania. «Poe? È questo ciò di cui vi siete occupato per tutto il giorno?»
«Peter, devo scoprire chi è il tale menzionato nell'articolo e condurlo
qui. Avevate ragione quando avete affermato che non avrei potuto risolvere il mistero da solo. Costui può risolverlo.»
Conservavo un'edizione dei Racconti di Poe sul mio scaffale. Peter afferrò il volume e me lo agitò dinanzi alla faccia. «Credevo che questa ossessione per Poe vi fosse passata, Quentin!»
«Peter, se quest'uomo esiste, se vi è davvero un uomo con una mente
straordinaria quanto quella di C. Auguste Dupin, potrò tenere fede alla mia
promessa. Poe mi ha indicato sin dall'inizio come procedere, attraverso le
pagine dei suoi racconti. Il suo nome può essere riabilitato. Salvato da
un'eternità d'ingiustizia.»
Peter allungò ancora le dita verso il ritaglio, ma glielo strappai di mano
e, dopo averlo piegato, me lo infilai in tasca.
Il mio gesto parve adirarlo. Ora la sua grande mano scattò in avanti, annaspando come se volesse strangolare qualcosa, anche solo l'aria. Con l'altra, scagliò il libro dritto nel caminetto, le cui fiamme scoppiettanti erano
state attizzate da uno degli impiegati solo mezz'ora prima.
«Ecco fatto!» esclamò.
Il fuoco sibilò con il suo sacrificio. Credo che Peter si fosse pentito subito di quell'impeto, giacché l'ira sul suo volto si trasformò in rimorso appena le vampe lambirono le pagine. Quello non era uno dei tomi cui tenevo
per la sua rilegatura o per un particolare valore sentimentale. Non era la
copia che mi ero ritrovato a sfogliare nei giorni silenziosi dopo aver ricevuto il telegramma con la notizia della morte dei miei genitori. Eppure, d'istinto, con il movimento più fulmineo che avessi mai compiuto, tesi la mano e lo recuperai. Rimasi fermo al centro della stanza, il libro bruciacchiato tra le dita. La mia manica si tramutò in un anello rovente in corrispondenza del polsino. Ma continuai a restare immobile mentre Peter mi osservava con occhi atterriti, sgranati e soffusi di un bagliore rosso mentre registrava la scena: il suo socio che stringeva un volume in fiamme mentre il
fuoco crepitante iniziava ad avviluppargli il braccio. Strano a dirsi, più la
sua espressione diveniva delirante e più mi sentivo sereno. Non ricordavo
di essermi mai sentito così forte, così risoluto nel mio proposito come in
quell'istante. Ora sapevo che cosa dovevo fare.
Hattie era entrata nel locale per cercarmi. Mi fissò, poi fissò l'oggetto incendiato che tenevo dinanzi a me, non proprio con sgomento, bensì con un
raro lampo di collera.
Mi gettò sul braccio un tappeto che aveva trovato in corridoio e lo usò
per soffocare le fiamme. Peter si riprese quanto bastava per meravigliarsi
dell'accaduto e poi per controllare i danni al tappeto prima di consultarsi
con Hattie. I due impiegati accorsero per scrutarmi come se fossi una bestia feroce.
«Uscite! Uscite subito da questo studio, Quentin!» urlò Peter, indicando
la porta con mano tremante.
«Peter, no, per favore!» strillò Hattie.
«Molto bene» replicai.
Lasciai il mio ufficio. Hattie mi gridò di tornare, ma non mi voltai. Nella
mia mente vedevo solo cose distanti, come se si stendessero dinanzi a me
nelle diramazioni di quei corridoi: le lunghe passeggiate, il brusio dei caffè
gremiti, gli accordi musicali sognanti e imperturbabili dei balli e delle feste, la redenzione che attendeva di essere scoperta in una metropoli lontana.
Libro secondo
Parigi
Capitolo 7
Giunsi al mio primo incontro parigino in virtù di un rapimento.
Nelle nostre città americane, il forestiero viene in qualche modo abbandonato a se stesso, con un misto di profonda crudeltà e cortesia. A Parigi,
invece, lo straniero ha la costante sensazione di ricevere spinte e indicazioni da cittadini e pubblici ufficiali; se vi smarrite, il francese percorrerà
un chilometro di gran carriera per indicarvi la vostra destinazione, e non
accetterà nemmeno un grazie. Forse il rapimento è il culmine inevitabile di
questa gentilezza aggressiva.
Partii per Parigi circa un anno e mezzo dopo aver salvato quel libro dal
fuoco. Quando arrivai, ebbi la mia prima sorpresa al capolinea ferroviario,
dove le urla dei commissionnaires cercano di persuadere i turisti a soggiornare in questo o in quest'altro albergo. Cercai di evitare le loro mani
tese.
Mi arrestai quando incappai in un tale che reclamizzava a gran voce
l'Hotel Corneille, così chiamato in onore dell'illustre drammaturgo francese. Avendo letto del Corneille in un volume di Balzac (giacché mi ero portato dietro alcune opere di questo autore e della romanziera George Sand
per avere qualcosa di gradevole da leggere durante la traversata), sapevo
che veniva considerato un alloggio accogliente per chi indulgeva alle varie
branche delle discipline umanistiche. Ritenevo che i miei obiettivi avessero un certo carattere letterario.
«Siete diretto al Corneille, monsieur?»
Al mio cenno di assenso, emise un sospiro roco, quasi a ringraziare il
Cielo per avergli concesso la possibilità di riposare la gola. «Da questa
parte, prego!» Mi accompagnò alla carrozza, dove armeggiò per assicurare
i miei bagagli sul tetto, fermandosi di tanto in tanto per fissarmi con un'inconfondibile espressione di felicità all'idea di avere un passeggero proveniente dal Nuovo Mondo.
«Siete qui per lavoro, monsieur?»
Riflettei sulla risposta. «Non proprio. Sono un avvocato nel mio Paese,
monsieur. Ho tuttavia lasciato il mio studio di recente. Mi sto curando di
una faccenda del tutto diversa... A dire il vero, poiché sento già di potermi
fidare di voi, sono qui per ottenere l'aiuto di una persona che se ne possa
occupare.»
«Ah!» esclamò, senza aver ascoltato neppure una parola. «Siete amico di
Cooper, allora?»
«Prego?»
«Cooper!»
Dopo che ripetemmo quello scambio di battute, intuii che si riferiva allo
scrittore James Fenimore Cooper. Avrei scoperto che i francesi giudicavano l'America troppo intima perché due individui di quella nazione non si
conoscessero, anche se uno era uno zoticone e l'altro uno speculatore di
Wall Street. I romanzi d'avventura di Cooper godevano di un'inspiegabile
popolarità persino negli ambienti più raffinati di Parigi (portatene con voi
una copia americana, e i parigini vi reputeranno autentici eroi), e la gente
credeva che vivessimo tutti tra gli indiani nobili e selvaggi di quelle storie.
Gli dissi che non conoscevo Cooper.
«Be', il Corneille soddisferà tutte le vostre esigenze, parola mia! Niente
tende di pellirosse là dentro! Attento al gradino, monsieur. Vado dal facchino a prendere il resto delle vostre valigie.»
Le mie supposizioni sul primo mezzo di trasporto che utilizzai in quella
città si rivelarono corrette. La carrozza era più spaziosa di quelle america-
ne, e gli interni erano davvero assai confortevoli. Era la massima comodità
che riuscissi a immaginare in quel momento: sprofondare tra i cuscini di
una vettura mentre ci approssimavamo a una camera ben arredata e tutta
per me. Quella corsa, ricordate, ebbe luogo dopo due settimane in mare,
durante le quali ero partito dal porto di Baltimora, avevo sostato per una
notte a Dover prima di salpare nuovamente, e infine ero arrivato in Francia, dove avevo poi viaggiato per sei ore sul treno diretto a Parigi. Il solo
pensiero di dormire in un letto mi riempiva di gioia. Non potevo immaginare che di lì a poco sarei stato strappato dai miei nuovi agi sotto la minaccia di una spada.
La mia tranquillità venne interrotta quando la carrozza si inclinò all'improvviso in una brusca angolazione prima di arrestarsi traballando con violenza. Il commissionnaire saltò giù dalla cassetta imprecando.
«Solo un fossato!» urlò con sollievo. «Credevo che si fosse staccata una
ruota! Allora sì che saremmo...»
Dal finestrino, vidi i suoi lineamenti appiattirsi di colpo mentre cadeva
in un silenzio troppo rispettoso. Quell'espressione si mescolò alla paura
prima che l'uomo fuggisse via.
«Tornate subito qui, cocchiere!» gridai. «Monsieur, dove state andando?» Sporgendomi dal finestrino, scorsi un tipo tarchiato, con un fluttuante
soprabito blu vivace abbottonato fino al colletto. Aveva i baffi folti e la
barba appuntita con maestria. Pensai di scendere per chiedergli se avesse
veduto quale strada aveva imboccato il commissionnaire scomparso. Invece, quel tale aprì lo sportello e salì con molto garbo.
Disse qualcosa in francese, ma ero troppo frastornato per sfruttare la mia
conoscenza sempre più approfondita di quella lingua. Il mio primo istinto
fu di scivolare fuori dall'altro lato; aprendo il secondo sportello, trovai però
la via sbarrata da un altro tizio con un identico cappotto monopetto. Si scostò la falda per rivelare una sciabola che gli pendeva perpendicolarmente
dalla lucida cinta nera. La vista dell'arma che scintillava sotto il sole mi ipnotizzò. Lo sconosciuto posò le dita sull'elsa con disinvoltura mentre mi
rivolgeva un cenno del capo. «Allons donc!»
«Polizia!» esclamai, sentendomi per metà sollevato e per metà impaurito. «Voi signori siete della polizia, monsieur?»
«Sì» rispose quello accanto a me, allungando la mano. «Passaporto, prego, monsieur.»
Obbedii e, in preda alla confusione, aspettai che lo sfogliasse. «Ma chi
state cercando, agente?»
Un sorriso fugace. «Voi, signore.»
In seguito appresi che l'occhio vigile della polizia parigina si posava su
tutti i giovanotti americani (e soprattutto sui giovanotti americani celibi)
che giungevano in città da soli, perché potevano essere dei «radicali» giunti nella capitale con l'intento di rovesciare il governo. Considerando che il
governo era stato rovesciato da poco, quando re Luigi Filippo era stato sostituito da un regime repubblicano popolare tre anni addietro, quella paura
ossessiva del radicalismo appariva incomprensibile a chiunque non conoscesse bene la politica francese. Temevano forse che le masse popolari,
avendo ottenuto la loro legislatura e l'elezione regolare del loro presidente,
ed essendosi ormai annoiate della repubblica, sarebbero state istigate a ribellarsi per riavere i loro sovrani?
I gendarmi che avevano intercettato la mia carrozza si limitarono a informarmi che il prefetto di polizia mi chiedeva di recarmi da lui prima di
stabilirmi in città. Stregato e inspiegabilmente ammaliato dalle sciabole e
dalle divise eleganti, li seguii di buon grado. Un'altra vettura, con una pariglia di cavalli più veloci, ci condusse subito in Rue de Jérusalem, dove
sorgeva la prefettura.
Il prefetto, un uomo gioviale e svagato di nome Delacourt, sedette accanto a me nel suo ufficio, come aveva fatto il suo funzionario poco prima,
ed eseguì il medesimo rituale con il mio passaporto. Quest'ultimo era stato
compilato correttamente da monsieur Montor, l'emissario francese a Washington City, che aveva anche allegato una lettera attestante la mia rispettabilità. Delacourt pareva tuttavia poco interessato alle prove scritte delle
mie intenzioni innocue.
Mi trovavo lì a scopo di «affari», «studio» o «turismo»? Risposi negativamente a tutte le opzioni.
«Se non siete qui per questi motivi, allora come mai siete venuto a Parigi
quest'estate?»
«Vedete, monsieur prefetto, devo incontrare un abitante della vostra città
per discutere di un fatto importante verificatosi negli Stati Uniti.»
«E...» insistette, celando la curiosità dietro un sorriso noncurante «chi
sarebbe costui?»
Quando gli riferii il nome, si zittì, scambiando poi un'occhiata con il
gendarme seduto dall'altra parte della stanza. «Chi?» domandò dopo qualche istante.
«Auguste Duponte» ripetei. «Dunque lo conoscete, monsieur prefetto?
Ho avuto dei contatti epistolari con lui negli ultimi mesi...»
«Duponte? Duponte ha scritto a voi?» mi interruppe in malo modo l'altro
poliziotto, un vecchio tarchiato.
«No, certo che no, agente Gunner» disse il prefetto.
«No» confermai, pur essendo irritato dalla sicurezza ingiustificata di Delacourt. «Io ho scritto a Duponte, ma lui non mi ha mai risposto. Ecco perché sono venuto di persona. Sono qui per conferire con lui in privato prima
che sia troppo tardi.»
«Be', questa non sarà un'impresa facile» bofonchiò Gunner.
«Non sarà... È vivo?» domandai.
Mi parve che il prefetto dicesse: «Quasi», ma inghiottì la parola tutta intera e tornò di colpo ai suoi modi più gioviali e spontanei (in verità non mi
accorsi che la sua giovialità era diminuita fintantoché non la vidi riapparire). «Non preoccupatevi per questo» aggiunse, riferendosi al mio passaporto e porgendolo al suo collega affinché lo timbrasse con una serie apparentemente significativa di geroglifici. «Uno strumento della prossima Inquisizione, no?»
Accantonando all'improvviso l'argomento Duponte, mi diede il benvenuto a Parigi e mi assicurò che avrei potuto rivolgermi a lui se mai avessi avuto bisogno di aiuto durante il mio soggiorno. Mentre uscivo, diversi sergents de ville mi fulminarono con aspre occhiate di sospetto o antipatia, e
mi sentii pervadere dal sollievo quando raggiunsi l'anonimato della via
trafficata.
Quello stesso pomeriggio pagai a madame Fouché, la proprietaria
dell'Hotel Corneille, il corrispettivo di una settimana, benché, in realtà, mi
augurassi di portare a termine la mia missione in un tempo più breve.
Suppongo tuttavia che avrei dovuto notare alcuni segnali. Per esempio,
l'atteggiamento del custode dello sfarzoso palazzo parigino cui avevo indirizzato le lettere per Duponte. Quella fu la mia prima tappa la mattina dopo
essere arrivato. Sul portone, quando chiesi dell'investigatore, l'uomo strizzò gli occhi, scrollò il capo e domandò: «Duponte? Perché mai volete vederlo?».
Non giudicai insolito che il portiere di una persona di quel calibro dissuadesse le visite occasionali. «Necessito delle sue capacità per una faccenda di estrema importanza» risposi. Dalla bocca gli uscì un sibilo bizzarro, che si rivelò essere una risata quando mi comunicò che Duponte non
abitava più lì, che non aveva lasciato nessun altro recapito e che probabil-
mente neppure Cristoforo Colombo sarebbe riuscito a scovarlo.
Allontanandomi, ripensai al «Dupin» che conoscevo molto bene. Tramite i racconti di Poe, intendo... l'intermediario che mi aveva appassionato a
Poe, convincendomi che l'inspiegabile era tale solo perché nessuno l'aveva
ancora compreso. «Il mio eroe francese» l'aveva soprannominato l'autore
in una delle sue missive. Se solo l'avessi interrogato sull'identità del vero
Dupin, se solo avessi dimostrato un po' più di curiosità, avrei risparmiato
l'anno e mezzo che avevo impiegato per rintracciare quel singolare individuo a Parigi.
Nei suoi racconti, Poe non fornisce mai la descrizione fisica di Dupin.
Me ne ero avveduto solo dopo aver analizzato per l'ennesima volta quella
trilogia di racconti polizieschi alla ricerca di qualche dettaglio. In precedenza, se qualcuno me l'avesse domandato, forse avrei risposto: «Sono certo che Poe descrive uno dei suoi personaggi principali, il personaggio che
incarna alla perfezione i suoi scritti, e nei minimi particolari, per giunta».
Invece, vedete, l'aspetto esteriore di Dupin viene rivelato con chiarezza,
ma solo al lettore attento e onesto che si cala con entusiasmo nella storia.
Per dimostrarlo, menzionerò una novella piuttosto frivola di Poe, intitolata L'uomo finito. Tratteggia un illustre generale dell'esercito di cui tutti
ammirano la prestanza fisica. Il protagonista nasconde tuttavia un triste segreto: ogni notte il suo corpo va a pezzi per via delle vecchie ferite di guerra, e il suo servitore negro è costretto a ricomporlo prima di colazione.
Credo che quello fosse stato il rimprovero di Poe agli scrittori meno autorevoli, mere macchioline tra le fitte ombre del suo genio, che scorgevano
nella descrizione delle fattezze umane uno strumento efficace per infondere la vita ai loro personaggi. Allo stesso modo, molto tempo addietro, C.
Auguste Dupin era entrato nella mia coscienza grazie al suo animo inenarrabile, e non alla foggia del suo panciotto.
Allorché il bibliotecario di Baltimora mi aveva spedito il ritaglio che accennava al vero Dupin, avevo cercato invano di scoprire il nome dell'investigatore tramite il quotidiano newyorkese in cui era comparso l'articolo.
Poche settimane di ricerche tra periodici e stradari francesi avevano tuttavia prodotto una lista abbastanza nutrita di possibili modelli per l'eroe di
Poe.
Tutte le loro storie personali corrispondevano in qualche modo alle due
fonti: la descrizione del ritaglio e i tratti del personaggio di Poe. Uno dei
possibili aspiranti era un famoso matematico parigino, autore di testi uti-
lizzati per risolvere vari problemi scientifici; poi vi era l'avvocato, cui talvolta veniva attribuito il titolo di barone, che aveva fatto assolvere persone
accusate dei crimini più efferati e che nel frattempo si era trasferito a Londra; un altro era un ex ladro che aveva lavorato come agente segreto della
polizia parigina prima di dedicarsi alla gestione di una cartiera a Bruxelles.
Avevo esaminato ciascuna di queste e altre opzioni con imparzialità e obiettività, e con la speranza che una spiccasse fra le tante come ispirazione
inequivocabile per la figura di Dupin.
Intanto era trascorso un anno e mezzo dal principio di quelle ricerche. La
corrispondenza tra le due sponde dell'Atlantico si era dimostrata lenta e inutile. I candidati promettenti si erano moltiplicati in fretta prima di cadere
uno alla volta in un pozzo di dubbi dopo ulteriori indagini e scambi epistolari.
Fino a una tersa giornata primaverile del 1851. Era stato allora che avevo scoperto il nome di Auguste Duponte nel giornale francese «La Presse». Ovviamente aveva attirato la mia attenzione, ma non era stato solo il
suono a evocarmi una netta somiglianza con il C. Auguste Dupin di Poe.
Quel tale, Auguste Duponte, era diventato una celebrità in Francia grazie
al sensazionale caso di monsieur Lafarge, un uomo di robusta costituzione
fisica e di un certo prestigio sociale che era morto nella sua abitazione in
circostanze misteriose. Dopo alcune vane iniziative della polizia parigina,
un ispettore aveva pregato un conoscente, il giovane precettore Duponte,
di tradurre la testimonianza di un turista spagnolo (anche se, alla fine,
quella pista si era rivelata infruttuosa).
Dieci o dodici minuti dopo aver appreso i fatti dall'ispettore, si diceva,
Duponte aveva dimostrato in maniera inconfutabile che l'uomo era stato
avvelenato dalla moglie al termine di un pasto. Madame Lafarge era stata
incriminata per l'omicidio del marito. In seguito, la clemenza dei giudici le
aveva risparmiato la condanna a morte.
Quando il giornale francese «La Presse» gli aveva chiesto che cosa ne
pensasse della commutazione della pena, Duponte aveva dichiarato: «Assolutamente nulla. La punizione ha poco a che vedere con la realtà del
crimine, e niente a che vedere con l'analisi dello stesso».
La notizia dell'impresa di Auguste Duponte si era sparsa per tutta la
Francia. La polizia, i funzionari governativi e i cittadini di Parigi avevano
richiesto il suo intervento per la soluzione di altri casi enigmatici. Il suo
rapido imporsi all'attenzione pubblica, avevo appurato con immensa soddisfazione, risaliva a qualche anno prima che Gli assassinii della Rue
Morgue comparissero in un numero del 1841 di un giornale americano. La
descrizione dell'ascesa di Dupin alla fama, fornita da Poe nel secondo racconto della trilogia, potrebbe essere utilizzata con altrettanta efficacia per
riassumere la vera storia di Auguste Duponte: Accadde così che gli occhi
della polizia volgessero, come su un astro, su di lui; e in non pochi casi la
prefettura ebbe a tentare di accaparrarsi i suoi servigi.
La mia certezza di aver individuato l'uomo giusto si era rafforzata ulteriormente allorché avevo conosciuto un sagace francese che viveva in America da alcuni anni (dal rovesciamento di re Luigi Filippo) come membro di un corpo diplomatico della nuova repubblica. Si trattava di Henri
Montor. Stavo conducendo delle ricerche su Auguste Duponte nella biblioteca di Washington City, quando aveva notato con interesse che faticavo a
decifrare alcuni quotidiani francesi. Dopo avergli esposto il mio obiettivo,
gli avevo domandato se conoscesse Duponte.
«Ogni volta che veniva commesso un reato clamoroso» aveva risposto
con vivacità «i parigini interpellavano Duponte e, per la strada, il criminale
malediceva l'anno in cui Duponte era nato. Una perla di Parigi, quel Duponte, monsieur Clark.»
Durante le mie visite successive, Henri Montor mi aveva dato lezioni di
francese a cena e mi aveva impegnato in lunghe ore di conversazione, confrontando il governo e il popolo francesi con quelli americani. Giudicava
Washington City alquanto desolata rispetto a Parigi, e l'aria assai insalubre
e soffocante.
All'epoca avevo già scritto a Duponte, riassumendo le circostanze della
morte di Poe e sottolineando l'esigenza immediata di risolvere la questione
prima che la reputazione già malandata dello scrittore subisse ulteriori
scossoni. Di lì a una settimana gli avevo spedito altre due lettere, entrambe
con il timbro «urgente», contenenti aggiunte e altri dettagli della storia non
scritta di Poe.
Benché la nostra amicizia fosse recente, Montor mi aveva invitato ad accompagnarlo a un ballo in maschera cui sarebbero intervenute centinaia di
ospiti, un evento organizzato in una lussuosa dimora nei pressi di Washington City dove avrei potuto incontrare numerosi signori e signore francesi.
Quasi tutti si fregiavano di un titolo nobiliare e, per mia gioia, alcuni avevano assecondato il mio francese approssimativo, che mi ero sforzato di
perfezionare il più possibile. Vi era anche Jérôme Bonaparte, nipote di Napoleone Bonaparte e figlio di un'americana che il fratello minore dell'imperatore, Jérôme, aveva conosciuto quasi cinquant'anni addietro mentre era
in viaggio negli Stati Uniti. Il rampollo reale mi si era parato dinanzi con
un appariscente costume da turco, e due spade ricurve che gli pendevano
dalla cinta. Dopo che ci avevano presentati, mi ero complimentato per il
travestimento.
«Lasciamo perdere i "monsieur", signor Clark. Siamo in America!» aveva osservato, gli occhi scuri che gli brillavano per l'allegria. Quella frase
aveva suscitato una punta di irritazione in Henri Montor. «Quanto a questa
mostruosità» aveva proseguito Bonaparte con un sospiro «è stata una bella
idea di mia moglie. È da qualche parte nella stanza qui accanto.»
«Oh, credo di averla incrociata. È vestita da struzzo?»
Aveva riso. «Indossa delle piume. La vostra ipotesi sul tipo di animale è
fondata quanto la mia!»
«Il mio amico americano» aveva interloquito Montor, prendendomi sottobraccio, «cerca di esercitarsi nella nostra lingua madre per le sue ricerche
private. Siete tornato a Parigi di recente, mio caro Bonaparte?»
«Mio padre tentava di persuadermi a vivere laggiù, sapete. Non riesco
tuttavia a immaginare neppure per un attimo di stabilirmi lontano dall'America, Montor, giacché vi sono troppo affezionato e assuefatto per trovare
l'Europa di mio gradimento.» Aveva dato un colpetto a un'elaborata tabacchiera d'oro e ce l'aveva offerta.
Una donna era venuta verso di noi dal punto in cui il padrone di casa
suonava il violino con l'accompagnamento di un'orchestra. Aveva chiamato Bonaparte con un soprannome, e per un istante avevo creduto che fosse
la sua consorte abbigliata da struzzo, finché mi ero accorto che portava i
gioielli e le vesti fluttuanti di una regina. «Quella è Elizabeth Patterson, la
madre di Jérôme» mi aveva bisbigliato Montor. Il suo sussurro era stato
così discreto che avevo capito di dover prestare attenzione.
«Cara madre» aveva detto Bonaparte con formalità «questo è Quentin
Clark, un intellettuale di Baltimora.»
«Senti senti» aveva replicato la finta sovrana che, pur non essendo affatto alta, pareva torreggiare sopra tutti noi.
«Signora Patterson.» Mi ero inchinato.
«Madame Bonaparte» aveva precisato, correggendomi su entrambi i
punti e allungandomi la mano. Il suo viso e i suoi occhi limpidi possedevano una bellezza inesprimibile, quasi tragica. Avevo avuto l'impressione
che non si potesse fare altro che innamorarsi di lei. Mi aveva guardato con
palese disapprovazione. «Non siete travestito, giovanotto.»
Montor, che indossava un favoloso costume da pescatore napoletano,
aveva attribuito la colpa del mio abbigliamento poco consono al suo invito
inatteso. «Sapete, sta studiando le usanze francesi.»
Gli occhi di madame Bonaparte mi avevano fulminato. «Studiate con
impegno.»
Una volta giunto a Parigi, mi sarei reso conto che la finta regina non si
era sbagliata riguardo alla mia comprensione delle consuetudini francesi.
Inoltre, osservando la splendida stanza affollata di visi mascherati e camuffati, avevo capito che quello era, in un certo senso, ciò che volevano Peter
e zia Blum. Vi era qualcosa là dentro, qualcosa al di là dei servitori in livrea e delle composizioni floreali, qualcosa di irresistibile che aveva solo
un tenue legame con il denaro, qualcosa che Baltimora desiderava aggiungere ai suoi trionfi commerciali.
Dopo l'episodio del libro bruciato, ero tornato allo studio legale per sbrigare alcune pratiche rimaste in sospeso. Peter non mi aveva degnato neppure di uno sguardo. Frustrato e contrariato, aveva fischiettato intere strofe
di canzoni su e giù per le scale. Avevo quasi desiderato che si rimettesse a
sbraitarmi contro, perché così avrei almeno potuto reagire descrivendogli i
progressi fatti.
Seguendo il suo esempio, Hattie mi aveva cercato sempre meno, ma si
era data molta pena per convincere sua zia e la sua famiglia a essere pazienti verso il nostro fidanzamento e a concedermi un poco di tempo. Avevo fatto del mio meglio per rassicurarla, ma avevo iniziato a temere di dire
troppo e a considerare persino la devozione assoluta di Hattie come parte
del loro arsenale, l'ennesimo strumento per soffocare le ambizioni che mi
animavano. Ai miei occhi, anche il suo volto aveva cominciato ad assomigliare di più al viso di quella ficcanaso di sua zia. Apparteneva a una Baltimora incapace persino di riconoscere che la verità dietro la morte di un
grand'uomo era importante. Hattie, perché non avevo confidato nella vostra infallibile capacità di vedermi con maggiore chiarezza di quanto avrebbe potuto fare uno specchio?
Settimane dopo il ballo in maschera, non avevo ancora ricevuto alcuna
risposta da Duponte. Non tolleravo la lentezza delle comunicazioni postali.
Poteva accadere che la corrispondenza venisse rubata, oppure distrutta, per
caso o di proposito. Avevo scoperto l'identità del vero Dupin, probabilmente l'unica persona in tutto il mondo conosciuto capace di colmare il
vuoto circa gli ultimi giorni di Edgar Poe. Arrivato a quel punto, non avrei
vanificato con l'inazione i passi avanti che avevo compiuto. Non avrei aspettato che tutto ciò andasse perduto. Nel giugno del 1851 avevo ultimato
i preparativi ed ero partito per Parigi.
Ora mi trovavo in un altro mondo. Persino le case parevano di colori e
materiali totalmente diversi, e disposte in modo inconsueto, ai miei occhi,
lungo gli ampi viali. Parigi aveva un che di reticente, eppure l'intera esistenza si conduceva all'esterno, all'aria aperta.
Gli stradari più aggiornati che consultai al mio arrivo non contenevano
alcun Duponte, e mi accorsi che quelli che avevo sfogliato a Washington
City risalivano a qualche anno addietro. Negli ultimi tempi, nemmeno i
giornali che in passato avevano parlato senza posa dell'investigatore avevano avuto granché da riferire.
A Parigi, l'ufficio postale recapitava le lettere direttamente a casa dei destinatari (una pratica appena adottata anche in alcune città americane mediante accordi privati), sebbene, secondo le voci in circolazione, quel servizio non fosse utile tanto ai parigini quanto al governo, che così si garantiva un maggior controllo sulla cittadinanza. Speravo che i postini non avessero seguitato a consegnare la corrispondenza di Duponte all'indirizzo
sbagliato. Per via di un'altra stranezza delle regole parigine, mi vidi rifiutare (con intransigenza e cortesia, com'era consuetudine dei francesi) un colloquio con i direttori dell'ufficio postale, cui avrei voluto domandare l'attuale domicilio di Duponte. Avrei prima dovuto chiedere il permesso al ministero competente, mi dissero. Dopo aver scritto la lettera con l'aiuto di
madame Fouché, la spedii (quella era un'altra regola, benché il ministero
fosse soltanto tre vie più in là). «Riceverete sicuramente l'autorizzazione
entro uno o due giorni» osservò la proprietaria dell'hotel. «Ma potrebbe
occorrere molto di più se un funzionario commettesse un errore, cosa che è
terribilmente comune.»
Mentre aspettavo qualche segno di progresso nella ricerca dell'indirizzo
di Duponte, scrissi a Hattie. Ricordando il dolore che provavo quando la
vedevo triste, avvertii un profondo rimorso al pensiero che la mia impresa
le avesse cagionato anche la più lieve sofferenza. Nelle mie missive, le
promisi che avrei rimandato i nostri progetti il meno possibile, e frattanto
la supplicai di raggiungermi a Parigi, sebbene le mie attuali occupazioni
fossero tediose e richiedessero soltanto un breve soggiorno. Nulla le avrebbe fatto più piacere di intraprendere un simile viaggio, mi rispose, ma
doveva aiutare ad accudire i due nuovi bambini che si erano aggiunti da
poco alle famiglie delle sue sorelle.
Peter, dal canto suo, mi scrisse una lettera di addio, affermando che ave-
vo rovinato la mia vita, e per poco anche la sua, cedendo alla decadenza e
all'indecenza dell'Europa.
Non aveva idea di quanto fosse diversa la realtà laggiù, nella mia camera.
Gli sfrenati divertimenti notturni dell'estate parigina penetravano dalla
finestra: i balli eleganti, le orchestre all'aria aperta, i teatri che ospitavano
centinaia di spettatori soddisfatti. Io, invece, aprivo e chiudevo i miei due
cassettoni e fissavo l'orologio sulla mensola del caminetto, aspettando.
Un giorno, madame Fouché entrò nella mia stanza e si offrì di legarmi
una striscia di crespo nero intorno al braccio. Infastidito da quell'interruzione ai danni della mia eccessiva pigrizia, acconsentii.
«Le mie più sentite condoglianze» disse.
«Grazie. Ma perché?» domandai, subito allarmato.
«Non siete in lutto per la morte di una persona cara?» sbottò in tono
pomposo, come se la sua compassione scarseggiasse e io l'avessi sprecata.
«Altrimenti perché siete caduto in uno stato tanto melanconico?»
Esitai, guardando con aria corrucciata il tessuto nero avvolto intorno alla
mia manica.
«Sì, madame, qualcuno è morto. Ma non è questa la causa principale del
mio turbamento. È l'indirizzo, quel maledetto indirizzo! Perdonate il mio
linguaggio, madame Fouché. Se non scoprirò entro breve il domicilio di
monsieur Auguste Duponte, dovrò lasciare Parigi a mani vuote, e i miei
amici giudicheranno le mie azioni ancora più folli. Ecco perché voglio parlare con i direttori dell'ufficio postale.»
L'indomani, madame Fouché mi portò la colazione di persona anziché
mandare il solito cameriere. Faticando a trattenere un sorriso, mi tese un
biglietto con qualche parola scritta sopra.
«Che cos'è, madame?»
«Be', è l'indirizzo di Auguste Duponte, naturalmente.»
«Grazie infinite, madame! È meraviglioso!» Balzai subito in piedi e corsi fuori. Ero troppo emozionato persino per appagare la mia curiosità riguardo al modo in cui se l'era procurato.
La casa, distante meno di quindici minuti, era una costruzione tinteggiata di un giallo che un tempo era stato brillante, connessa a un fabbricato
blu e scarlatto eretto intorno a un cortile, un ottimo esempio dell'architettura e dei colori pretenziosi di Parigi. Il quartiere era più lontano dai caffè e
dai negozi rispetto al primo palazzo che avevo visitato... una tranquillità
consona alle esigenze del raziocinio, ipotizzai. Il custode, un tipo robusto
con orrendi baffi a manubrio, mi indicò l'appartamento di Duponte. Mi
fermai ai piedi delle scale, quindi tornai dal portiere.
«Vi chiedo scusa, monsieur. Non sarebbe più in sintonia con i gusti di
Duponte se prima mi annunciaste?»
Si offese, forse perché il mio suggerimento aveva messo in dubbio la sua
professionalità, ó forse perché l'idea di annunciare un visitatore degradava
il suo ruolo a quello di un domestico. «Quanti ospiti credete che riceva?»
intervenne sua moglie, scrollando le spalle. Parlò con una nota di commiserazione, rivolgendo uno sguardo verso l'alto, a Dio o al piano superiore.
Quella bizzarra conversazione contribuì senza dubbio al farneticamento
nervoso in cui mi lanciai quando vidi per la prima volta l'investigatore sulla soglia del suo alloggio. Il ricorso alle sue doti era ancor più raro ed esclusivo di quanto avessi immaginato. A giudicare dal commento della
moglie del custode, i parigini pensavano che non valesse più la pena nemmeno cercare di ottenere il suo aiuto.
Quando Duponte aprì l'uscio, farfugliai una presentazione. «Ho spedito
al vostro precedente indirizzo alcune lettere dagli Stati Uniti (tre, per la
precisione) e un telegramma. Le lettere parlavano dello scrittore americano
Edgar A. Poe. È indispensabile indagare sulle circostanze della sua morte.
Ecco perché sono qui, monsieur.»
«Vedo» disse Duponte, facendo una smorfia e indicando qualcosa dietro
di me, «che quella lampada non funziona. È stata sostituita più volte, ma la
fiamma è spenta.»
«Prego? La lampada?»
Ecco come iniziò la nostra conversazione. Una volta dentro, ripetei il
contenuto delle mie missive, insistendo sulla necessità di agire subito ed
esprimendo il desiderio che mi accompagnasse in America appena gli fosse stato possibile.
Le stanze erano assai disadorne e, strano a dirsi, prive di libri, a eccezione di qualche volume insignificante. Benché fosse estate, faceva molto
freddo. Duponte si appoggiò allo schienale della poltrona. A un tratto, come se avesse capito solo allora che discorrevo con lui anziché con la parete
nuda alle sue spalle, domandò: «Perché mi avete raccontato tutto ciò, monsieur?».
«Monsieur Duponte» risposi, esterrefatto, «voi siete un famoso genio del
raziocinio. Siete l'unica persona a me nota, forse l'unica persona del mondo
conosciuto, in grado di risolvere questo mistero.»
«Vi sbagliate di grosso» replicò. «Siete pazzo.»
«Io? Voi siete Auguste Duponte!» ribattei in tono accusatorio.
«Vi riferite a molti anni or sono. La polizia mi pregava di esaminare i
suoi dossier di tanto in tanto. Temo che i giornali parigini abbiano gonfiato
le notizie e che, in alcuni casi, mi abbiano attribuito determinate qualità
per stuzzicare gli appetiti dell'immaginazione pubblica. Diffondevano
quelle storie...» Non vi fu, nei suoi occhi, un baluginio di orgoglio mentre
pronunciava quelle frasi? Senza battere le palpebre né respirare, cambiò
argomento di punto in bianco. «Ciò di cui dovreste informarvi, se posso
permettermi, sono le numerose escursioni interessanti che Parigi offre in
estate. Dovreste assistere a un concerto nei Giardini del Lussemburgo. Potrei indicarvi dove ammirare i fiori più belli. E siete stato alla reggia di
Versailles? Vi piacerà...»
«La reggia di Versailles? Versailles, avete detto? Per favore, Duponte! È
una questione di estrema importanza! Questa non è una visita di cortesia.
Ho attraversato quasi mezzo mondo per rintracciarvi!»
«Dovreste riposare, allora» mi consigliò, annuendo con fare comprensivo.
L'indomani, mi destai dopo un sonno profondo e agitato. La sera prima
ero rientrato al Corneille in uno stato di torpido stupore per l'accoglienza
riservatami da Duponte. Quel mattino, tuttavia, la mia delusione svanì, attutita dal pensiero che forse era stata la spossatezza a offuscare il nostro
primo colloquio. Ero stato sciocco e maleducato ad aggredirlo in quel modo, stanco e impaziente, tutto scarmigliato, senza neppure una lettera di
presentazione.
Questa volta consumai una colazione tranquilla, che a Parigi assomiglia
a una cena senza la minestra e inizia persino con le ostriche (anche se
nemmeno Georges Cuvier avrebbe inserito quegli affanni azzurri e acquosi
in una classe di vere ostriche adatte ai palati della Baia di Chesapeake) .
Dopo essere tornato al palazzo di Duponte, indugiai vicino alla guardiola e
scoprii con piacere che il custode era fuori per sbrigare alcune commissioni. Quella chiacchierona di sua moglie e una bambina paffuta erano impegnate a rammendare un tappeto.
La donna mi offrì una sedia. Arrossì subito dinanzi al mio sorriso, sicché
cercai di sorridere sovente nelle pause tra una parola e l'altra per assicurarmi la sua collaborazione. «Ieri, madame, avete asserito che Duponte non
riceve molti ospiti. Non c'è nessuno che gli faccia visita per motivi profes-
sionali?»
«Non in tutti gli anni che ha vissuto qui.»
«Non avevate sentito parlare di Auguste Duponte in passato?»
«Ma certo!» esclamò, come se la domanda avesse messo in discussione
la sua salute mentale. «Ma non pensavo che potesse essere lo stesso. Si
mormora che quell'uomo sia stato di grande aiuto alla polizia; il nostro inquilino invece è un tipo innocuo, ma quasi sempre stordito, un uomo privo
di vitalità. Credevo che fosse un fratello o un lontano parente. No, suppongo che non abbia molti conoscenti pronti a fargli visita.»
«E nessuna amica» borbottò sua figlia, annoiata, e non la udii dire altro
per tutti e due i mesi che trascorsi a Parigi.
«Capisco» dissi, ringraziandole prima di salire fino all'uscio di Duponte.
Arrossirono entrambe quando mi inchinai.
Qualche ora prima avevo riflettuto sui racconti di Poe incentrati sulla figura di C. Auguste Dupin. Nel primo, l'analista annuncia all'improvviso
che investigherà sugli efferati omicidi perpetrati in una casa della Rue
Morgue. Un'inchiesta potrà procurarci qualche distrazione, dice all'amico
stupito. Facciamo un esame da noi. Cercava il divertimento. Fra tutti i dettagli che avevo snocciolato il giorno prima senza quasi prendere fiato, non
avevo addotto neppure un motivo valido per cui Duponte avrebbe dovuto
concentrare il suo genio sul caso della morte di Poe. Forse, negli ultimi
anni, quelli in cui Duponte sembrava essersi impigrito, non era emersa alcuna vicenda degna del suo interesse, e di conseguenza si era abbandonato
a quella che pareva un'apatia insensata.
Quando bussai alla sua porta, Duponte non mi cacciò, bensì mi invitò a
fare una passeggiata. Camminai accanto a lui per il caldo e affollato Quartiere latino. Dico «accanto» anche se i suoi passi erano cauti e lenti fino
all'inverosimile, un piede si posava a stento dinanzi all'altro; ciò comportava che, cercando di mantenere la sua andatura, a tratti avevo l'impressione
di danzare in semicerchio. Come il giorno precedente, parlò di argomenti
banali. Questa volta lo impegnai in chiacchiere futili prima di fare un nuovo tentativo di persuasione.
«Ma non provate il desiderio di dedicarvi a occupazioni più stimolanti,
monsieur Duponte? Mentre io raccoglievo tutti i dettagli disponibili sulla
scomparsa del signor Poe, altri sfruttavano l'ambiguità delle informazioni
pubbliche per sputare sulla sua tomba. Credo che l'indagine su una questione tanto delicata e urgente potrà procurarvi qualche distrazione.» Ripetei quelle parole, giacché, la prima volta, il baccano di un pesante carro le
aveva soverchiate. Duponte non batté ciglio. Evidentemente non credeva
di aver bisogno di altri divertimenti, e fui costretto ad arrendermi di nuovo.
Durante una successiva visita al suo appartamento, lo trovai a letto, impegnato a fumare un sigaro. Pareva che usasse il letto per fumare e scrivere. Detestava scrivere, precisò, perché quell'attività gli impediva invariabilmente di riflettere. Per l'occasione, avevo riletto Il mistero di Marie Roget, il seguito degli Assassinii della Rue Morgue, e avevo meditato sulla
generosa proposta che la polizia fa a C. Auguste Dupin per convincerlo a
risolvere il caso di una giovane commessa rinvenuta morta tra i boschi.
Benché le mie lettere a Duponte avessero senz'altro sottinteso una congrua
ricompensa, ora gli assicurai espressamente, in omaggio alle parole del
racconto, che gli avrei versato «una generosa somma per la vostra attenzione incondizionata al decesso di Poe, a partire da questo istante». Staccando un assegno, accennai a una cifra ragguardevole, e poi ad altre ancor
più considerevoli.
Invano. Pareva che Duponte non fosse per nulla attratto dal denaro nonostante le sue condizioni non fossero proprio agiate. Di fronte a quei tentativi di suscitare il suo interesse verso la mia missione, mi prendeva per il
gomito indicando una stranezza architettonica, elogiava profusamente le
estati parigine per la loro dolcezza oppure evitava di rispondere chiudendo
gli occhi per qualche secondo. Talvolta sembrava quasi un idiota quando
puntava il suo sguardo placido sui negozi, sui fiori sbocciati e sugli alberi
del giardino («Gli ippocastani!» esclamava a un tratto), o magari era uno
sguardo colmo di tristezza.
Un pomeriggio, dopo l'ennesimo incontro con Duponte, superai un
gruppo di poliziotti intenti a mangiare un gelato intorno ai tavoli all'aperto
di un caffè gremito. Erano una macchia minacciosa di baffi, barbette appuntite e cappotti monopetto blu.
«Monsieur! Monsieur Clark, bonjour!»
Era il giovane agente tarchiato che aveva requisito la mia carrozza quando ero arrivato a Parigi. Imputai l'entusiasmo con cui mi aveva chiamato al
buonumore della compagnia.
Gli altri si alzarono uno alla volta per salutarmi.
«Questo signore è un erudito che è venuto dall'America per incontrare
Auguste Duponte.» Dopo un istante di silenzio attonito scoppiarono tutti a
ridere.
Quella reazione al nome di Duponte mi sbalordì. Sedetti mentre il gen-
darme continuava: «Vi sono molte storie da narrare su Duponte. Era un
grande genio. A quanto si mormora, sapeva che un ladro stava per rubarvi
i gioielli prima che entrasse in azione».
«Era un grande genio, avete detto?» domandai.
«Oh, sì. Molto tempo fa.»
«Mio padre era nella polizia quando i prefetti ingaggiavano monsieur
Duponte» interloquì un altro, con un cipiglio che sarebbe potuto essere
permanente. «A suo avviso, Duponte era un giovanotto astuto che creava
difficoltà per far credere di essere in grado di superarle.»
«In che modo?» gli chiesi, allarmato.
Si grattò vigorosamente il collo con le unghie troppo lunghe, un'abitudine che aveva reso quel lato della sua gola rosso e infiammato. «È quello
che ha sentito dire mio padre» borbottò.
«Pare che Duponte sapesse giudicare con esattezza la moralità di un uomo solo guardandolo» proseguì il suo collega, più amabile. «Una volta si è
offerto di passeggiare per le vie nel giorno di una festa pubblica e di indicare alla polizia gli individui pericolosi che sarebbe stato opportuno allontanare dalla società.»
«L'ha fatto?» volle sapere un altro.
«No... Altrimenti la polizia non avrebbe più avuto niente da fare.»
«Ma che cosa gli è accaduto?» chiesi. «Che cosa mi dite delle indagini
che conduce oggi?»
Intervenne un poliziotto che sembrava più riflessivo e taciturno degli altri. «Sembra che monsieur Duponte abbia fallito... che la donna di cui era
innamorato sia stata impiccata per omicidio e che le sue capacità analitiche
non siano servite a salvarla. Che non sia più riuscito a svolgere delle inchieste...»
«Inchieste!» si intromise il Grattatore. «Certo che non possono essercene
altre. A meno che non le esegua da fantasma. È stato ucciso da un prigioniero che gli aveva giurato vendetta perché l'aveva fatto arrestare.»
Aprii la bocca per correggerlo, ma ci ripensai. La sua voce esprimeva un
astio profondo che era meglio non risvegliare.
«No, no» dissentì uno degli altri. «Duponte non è morto. Alcuni sostengono che ora abiti a Vienna. Si è stancato dell'ingratitudine. Quante storie
potrei raccontarvi! A ogni modo, di questi tempi, non esistono uomini come quello a Parigi.»
«Il prefetto Delacourt non lo permetterebbe» aggiunse il tipo tarchiato, e
gli altri scoppiarono in una serie di risatine roche.
Ecco uno degli aneddoti che mi narrarono i gendarmi.
Una sera, anni addietro, Duponte si era ritrovato nel cabinet, o stanza
privata, di una taverna parigina, seduto di fronte a un evaso che solo tre
giorni prima aveva sgozzato un secondino. Tutti gli agenti della polizia di
Parigi lo braccavano da quando era fuggito, compresi alcuni di quelli seduti con me al caffè. Sfruttando le sue note capacità, Duponte aveva intuito
qual era il luogo che probabilmente quella canaglia avrebbe scelto come
nascondiglio più insospettabile della città. Così, eccoli lì insieme nel
cabinet.
«Non mi acciufferanno» aveva dichiarato l'assassino, fiducioso. «Corro
più veloce di tutti loro e, se necessario, potrei sconfiggerli in uno scontro
armato. Sono al sicuro fintantoché non incontro quel miserabile di Duponte. È lui il vero criminale di Parigi.»
«Credo che lo riconoscereste se lo incrociaste» aveva commentato Duponte.
Il furfante aveva riso. «Riconoscerlo...? Santo Cielo!» Poi aveva vuotato
la sua bottiglia di vino tutta d'un fiato. «Non avete mai avuto a che fare con
quel farabutto di Duponte, vero? Non indossa mai lo stesso abito due volte.
La mattina, sembra una persona qualsiasi, come voi. Poi, un'ora dopo, è
così mutato che neppure sua madre lo riconoscerebbe e, la sera, nessun
uomo o demone ricorderebbe mai di averlo veduto in passato. Sa dove vi
trovate e prevede dove andrete in seguito.»
Quando quella canaglia ebbe bevuto più di quanto avesse voluto, Duponte era sceso al piano di sotto per comprare un'altra bottiglia di vino e
quindi era tornato nel cabinet con perfetta calma. Aveva riferito all'evaso
che la barista aveva scorto Auguste Duponte nella taverna, impegnato a
controllare le stanze private. Il criminale si era adirato all'udire quella notizia, e l'investigatore gli aveva consigliato di nascondersi nell'armadio per
poi uscire all'improvviso e ammazzare Duponte appena fosse entrato.
Quando questi aveva obbedito, Duponte aveva chiuso a chiave l'armadio e
aveva chiamato la polizia.
Quello era dunque il Duponte di un tempo. Era quello il Duponte che
dovevo portare in America, tanto più che la nostra breve frequentazione mi
aveva fornito qualche dimostrazione delle sue doti. Un pomeriggio, durante una passeggiata, la calura era divenuta insopportabile, e l'avevo persuaso
a dividere una carrozza con me. Dopo che avemmo viaggiato un poco per
Parigi in silenzio, aveva indicato un cimitero fuori del finestrino. «Quello»
aveva detto «sull'altro lato del muro, è il piccolo camposanto della vostra
gente, monsieur Clark.»
Avevo scorto un cartello che, in francese, segnalava il cimitero ebraico.
«Sì, in effetti è assai piccolo...» Mi ero zittito, lasciando la frase a metà.
Ripensando a quello che mi aveva appena detto, mi ero voltato, sorpreso.
«Monsieur Duponte!»
«Sì?»
«Che cosa avete affermato un attimo fa? Riguardo a quel camposanto?»
«Che vi sono sepolte le persone della vostra fede, o forse parzialmente
della vostra fede.»
«Ma, monsieur, che cosa vi induce a credere che io sia ebreo? Non ve ne
ho mai fatto parola.»
«Non lo siete?» aveva chiesto, stupito.
«Be'» avevo risposto, senza fiato, «mia madre era ebrea mentre mio padre era protestante. Ma da cosa l'avete dedotto?»
Vedendo che insistevo, aveva spiegato: «Alcuni giorni or sono, quando
ci siamo approssimati a una certa pensione di Montmartre, avete rammentato i resoconti dei giornali che la indicavano come il posto in cui una
bambina era stata brutalmente uccisa». Effettivamente, gli articoli riguardanti quell'atroce omicidio avevano invaso ogni giorno i quotidiani parigini che leggevo per migliorare il mio francese. «Avvertendo che era una
sorta di luogo sacro, il luogo di una morte recente, avete allungato la mano
verso il cappello. Tuttavia, anziché levarvelo, come fanno automaticamente i cristiani quando entrano in chiesa, ve lo siete calcato sulla testa, come
gli ebrei nella sinagoga. Poi avete indugiato per un altro istante, non sapendo se toglierlo o premerlo sul capo. Ciò mi ha indotto a ipotizzare che
aveste pregato un poco in chiesa e un poco in sinagoga» aveva aggiunto
Duponte.
Aveva ragione. Quando si era maritata, mia madre non aveva rinunciato
alla sua eredità ebraica nonostante le pressioni compatte della famiglia di
mio padre, e allorché a Baltimora era stata completata la sinagoga di Lloyd
Street, mi ci aveva condotto.
Duponte si era richiuso nel suo consueto silenzio. Avevo tenuto per me
il mio entusiasmo. Stavo cominciando ad abbattere le sue mura difensive.
Con delicatezza, tentai di ricavare da Duponte altri fatti del suo passato,
ma la sua espressione si irrigidiva ogni volta. Scivolammo in una piacevole consuetudine. Bussavo alla sua porta ogni mattina. Se era steso sul letto
con il giornale, mi invitava a entrare per un caffè. Di solito manifestava
l'intenzione di fare una passeggiata, e io gli chiedevo il permesso di accompagnarlo, richiesta cui acconsentiva ignorando la mia domanda.
Possedeva un'impenetrabilità, un'invisibilità morale che mi faceva venire
voglia di osservarlo in tutte le possibili varianti di sfumature che la vita offre, di vederlo innamorato, impegnato in un duello, o, al ristorante, nella
scelta di quali piatti avrebbe ordinato. Bramavo di conoscere i suoi pensieri e desideravo che volesse saperne di più sul mio conto.
Talvolta gli portavo un oggetto legato al mio obiettivo originale, nella
speranza di risvegliare la sua curiosità. Per esempio, adocchiai una guida
di Baltimora su una delle tante bancarelle di libri sparse per Parigi e gliela
mostrai.
«Vedete, all'interno vi è una carta piegata... e questa parte della città è
quella in cui Edgar Poe viveva quando ha vinto il suo primo premio giornalistico per un racconto intitolato Manoscritto trovato in una bottiglia.
Questa è la zona di Baltimora in cui l'hanno rinvenuto privo di sensi.
Guardate qui, monsieur; questo è il cimitero dove riposa.»
«Monsieur Clark» replicò «temo che simili dettagli non mi interessino
granché.»
Ora sapete come stavano le cose. Tentai in ogni modo di riscuoterlo dal
suo torpore apatico. Per esempio, mentre attraversavamo uno dei ponti sulla Senna durante una giornata torrida, decidemmo di spendere dodici sous
ciascuno in uno degli stabilimenti galleggianti lungo il fiume per fare il
bagno sotto un tetto di tela. Ci tuffammo nell'acqua fresca l'uno di fronte
all'altro. Duponte chiuse gli occhi e si stese all'indietro, e io lo imitai. I nostri corpi venivano cullati su e giù dagli allegri schizzi dei bambini e dei
ragazzi.
Quentin Clark: «Monsieur, conoscete senza dubbio l'importanza dei racconti di Poe incentrate sul personaggio di C. Auguste Dupin. Ne avrete
sentito parlare. Sono comparse sui giornali francesi».
Auguste Duponte (con aria distratta, una domanda o un'affermazione?):
«Ah, sì».
QC: «Le vostre doti analitiche hanno ispirato la figura del protagonista
con tutti i suoi talenti. Questo deve pur significare qualcosa per voi! Quelle
imprese sfociano in portentosi trionfi della ragione, assai complessi e apparentemente impossibili».
AD: «Non credo di averli letti».
QC: «Non avete letto la letteratura della vostra vita? Quella che vi ren-
derà immortale? Come può essere?».
AD: «Non mi interessa granché, monsieur».
Dovrei aggiungere un punto esclamativo a quest'ultimo commento? Forse uno studioso di grammatica saprebbe rispondere. Duponte lo pronunciò
con enfasi, ma non a voce più alta di quella del cameriere di un ristorante
che ripete l'ordinazione al suo cliente.
Di lì a qualche giorno si verificò una svolta fondamentale nella mia amicizia con Duponte. Avevamo visitato il Jardin des Plantes, dove, in estate,
era possibile ammirare non solo le più belle specie vegetali, ma anche una
delle migliori collezioni zoologiche di Parigi. Dopo che una coltre di nubi
si fu addensata sopra gli alberi, ci stavamo dirigendo verso l'uscita, quando
un tale ci raggiunse di corsa. Dal tono in cui parlò, si sarebbe detto che
fosse assai turbato.
«Gentili signori» esordì, ansimando, «avete veduto qualcuno con la mia
torta?»
«Torta?» ripetei. «Che cosa intendete, monsieur?»
Si era concesso il raro capriccio di acquistare dai venditori ambulanti un
dolce aromatizzato con semi di carvi, ci spiegò, con l'intenzione di assaggiarlo durante quella che, fino a poco prima, era stata una bella giornata di
sole. L'aveva posato accanto a sé sulla panchina aspettando di digerire bene il pranzo. Notando il temporale in arrivo, si era voltato solo per un istante a raccogliere l'ombrello da terra. Tuttavia, quando si era rigirato, finalmente pronto a gustarsi quella leccornia, il pacchetto era svanito, e non
vi era nessuno nei paraggi.
«Magari l'ha presa un uccello, monsieur» suggerii, tirando Duponte per
il braccio. «Venite. Sta iniziando a piovere, monsieur Duponte, e non abbiamo l'ombrello.»
Ci congedammo dal nostro amico, ma Duponte si voltò dopo qualche
passo, richiamando l'uomo avvilito.
«Monsieur» gli disse «posizionatevi dove sono io ora, e probabilmente il
vostro dolce ricomparirà in un arco di tempo compreso tra due e sette minuti. Pressappoco.» La sua voce non manifestava compiacimento né particolare interesse per la questione.
«Davvero?» strillò l'altro.
«Sì. Penso proprio di sì» confermò Duponte, ricominciando a camminare.
«Ma... come?» volle sapere lo sconosciuto.
L'affermazione di Duponte aveva sbalordito anche me, e il mio accompagnatore se ne avvide.
«Imbecilli!» mormorò.
«Prego?» fece l'altro, offeso.
«Come avete detto, monsieur Duponte?» interloquii, altrettanto indignato.
«Vi dimostrerò la mia teoria» annunciò, ignorandomi. Noialtri aspettammo con trepidazione, ma lui si limitò a restare immobile. Dopo circa
tre minuti e mezzo, udimmo uno scalpiccio ritmico e frettoloso poco distante, ed ecco che (non posso negarlo) un pezzo di torta si materializzò da
dietro l'angolo, schizzando nell'aria proprio dinanzi al naso del legittimo
proprietario.
«Il dolce!» esclamai, indicandolo.
L'involto, attaccato a una cordicella, volava dietro a due bimbi che correvano a perdifiato attraverso i giardini. L'uomo inseguì uno dei ladruncoli
e recuperò il pacchetto, per poi tornare da noi in tutta fretta.
«Be', gentilissimo monsieur, avevate assolutamente ragione! Ma come
avete fatto a capire?» Per un attimo, guardò Duponte con sospetto, come se
l'analista fosse coinvolto in un complotto di qualche sorta. Intuendo che
non avrebbe avuto pace se non avesse fornito una spiegazione, Duponte
fornì questa semplice descrizione dell'accaduto.
Tra le attrazioni più popolari delle collezioni naturali custodite al Jardin
des Plantes vi erano gli orsi. Prima che lo sconosciuto ci interpellasse, Duponte aveva notato per caso che si avvicinava l'orario in cui di solito gli animali si svegliavano dal loro sonno. Lo sapevano anche i numerosi amanti
locali di quelle bestie, molti dei quali cercavano tutti i giorni di indurle a
eseguire varie acrobazie e ad arrampicarsi su un apposito palo, un'impresa
che richiedeva sovente di far penzolare del cibo sopra la loro gabbia con
una funicella o un pezzo di spago. Gli ambulanti accanto al cancello vendevano infatti tante merci destinate a quello scopo quante ne vendevano
per i visitatori. Giacché tra gli appassionati che percorrevano parecchi chilometri per godersi quello spettacolo vi erano molti ragazzi, e giacché quasi tutti quei gamins non avevano sous da spendere per simili prelibatezze,
Duponte aveva concluso che, quando l'uomo si era voltato per raccogliere
l'ombrello al primo accenno di pioggia, un bambino aveva agguantato la
torta mentre si recava dagli orsi. Poiché la panchina era piuttosto alta, e il
bimbo era basso, l'uomo, rigirandosi, non aveva veduto nessuno nei dintorni e aveva pensato che il colpevole del furto fosse fantomatico.
«Benissimo. Ma come facevate a sapere che il dolce sarebbe ricomparso,
e in questo punto preciso?» domandò l'altro.
«Entrando nei giardini» proseguì Duponte, parlando più con se stesso
che con noi due, «avrete notato che vi era un gruppo di custodi più nutrito
del consueto nei paraggi delle attrazioni zoologiche. Forse rammentate di
aver letto che "Martin", uno degli orsi, ha recentemente sbranato un militare colpevole di essersi sporto troppo e di essere caduto nella gabbia.»
«Sì! Ricordo» convenne quel tizio.
«I custodi sono stati senz'altro incaricati di impedire a bimbi e ragazzi di
arrampicarsi sui parapetti e avvicinarsi alle belve.»
«Sì! Probabilmente avete ragione, monsieur!» L'uomo era rimasto a
bocca aperta.
«Allora era logico pensare che, se era stato davvero un bambino a impossessarsi della vostra torta, quei custodi scrupolosi l'avrebbero dissuaso
dal suo piano entro pochi minuti dal risveglio delle creature, e il ladro si
sarebbe diretto per la via più breve (che attraversa la zona in cui ci troviamo ora) verso un'altra attrazione, seconda soltanto agli orsi per questo tipo
di spettatore, ossia la gabbia delle scimmie. Alla vista di un poco di cibo o
di un pezzo di stoffa variopinta, queste ultime danno luogo, presumo, a inseguimenti spassosi quasi quanto le arrampicate degli orsi sul palo. Nessuno degli altri animali interessanti, per esempio i lupi o i pappagalli, si esibirebbe in un simile spettacolo per un dolce.»
Soddisfatto di quella spiegazione come se fosse stata sua, l'uomo ci offrì
una fetta di torta con magnanimità e riconoscenza, benché l'involto fosse
stato dapprima tra le mani sudicie del bambino e poi sotto la pioggia. Io rifiutai con garbo, ma Duponte, dopo un attimo di esitazione, accettò e sedette con lui su una panchina. Mangiarono di gusto mentre io li riparavo
con l'ombrello.
Quella sera, incontrai il medesimo individuo in un caffè affollato vicino
all'hotel. Le intense luci dell'interno producevano un effetto abbagliante.
Era intento a disputare una partita di domino con un amico, che congedò
appena mi vide entrare.
«Magnifica interpretazione, monsieur» mi congratulai con allegria.
«Bravissimo!»
L'avevo conosciuto il giorno prima al Jardin des Plantes. Era uno degli
chiffoniers di Parigi, uomini la cui occupazione consisteva nel frugare tra i
mucchi di spazzatura dinanzi alle abitazioni. Usavano ceste e bastoni con
grande perizia per raccogliere qualunque cosa avesse la minima utilità.
«Ossa, tela, lino, vetri rotti, frammenti di carta, pezzi di ferro, cocci di porcellana, turaccioli di bottiglie...» aveva elencato. Quei tali non erano vagabondi; anzi, erano registrati presso la polizia per la loro attività.
Gli avevo chiesto quanto guadagnasse.
«Sotto re Filippo» aveva risposto «trenta sous al giorno. Ma ora, con la
repubblica, solo quindici. Adesso la gente butta via meno ossa e carta.
Quando non c'è lusso, noi poveri non riusciamo a sbarcare il lunario» spiegò con una punta di nostalgia per il regime monarchico.
Nei mesi a venire, il ricordo delle sue parole avrebbe risuonato nella mia
testa con maggiore chiarezza.
Dal momento che poteva esercitare legalmente il suo mestiere solo tra le
cinque e le dieci del mattino e mi era parso ansioso di raggranellare qualche soldo, avevo pensato che avrebbe acconsentito a un piano di mia invenzione. Quando mi avesse veduto passeggiare con il mio compagno il
pomeriggio successivo, avrebbe dovuto rivolgersi a noi lamentando la perdita di un oggetto di valore e pregando Duponte di aiutarlo. In tal modo,
l'avrebbe forse appassionato a un piccolo mistero.
Ora, al caffè dove avevamo concordato di incontrarci, rispettai la mia
parte dell'accordo informando il cameriere che avrei pagato il pasto del
mio complice. E che pasto! Chiese il tout ensemble della casa: ragù, cavolfiore, fricassée de poulet, bonbon, meloni e formaggio fresco. Com'era
consuetudine in Francia, ciascuna portata venne servita su un nuovo piatto,
perché i francesi aborrivano l'abitudine americana di mescolare i sapori
(per esempio, le verdure e gli intingoli della carne). Guardai il suo banchetto con gioia, giacché ero molto soddisfatto della recita ai giardini.
«Sulle prime, ho temuto che la torta non avrebbe funzionato» ammisi.
«Mi è sembrata una scelta bizzarra. Eppure siete stato assai convincente
con quel bambino.»
«No, no, monsieur!» mi contraddisse. «Non ho avuto nulla a che fare
con quel ragazzino. Mi aveva davvero rubato il dolce!»
«Come sarebbe a dire?» domandai.
Mi raccontò che aveva programmato di osservare il nostro patto nascondendo l'ombrello da qualche parte e denunciandone la scomparsa a Duponte. La torta era svanita mentre cercava un nascondiglio per l'ombrello vicino alla panchina.
«Come faceva a sapere che cosa era successo?» chiese. «Avevate detto
al vostro amico di spiarmi per tutto il tempo?»
«Certo che no!» Scrollai il capo. «Volevo vedere se avrebbe risolto l'enigma, e avvertendolo avrei rovinato l'esperimento, non vi pare?»
Evidentemente l'episodio l'aveva colpito. «È un individuo stravagante.
Ma quando si è affamati, non si hanno alternative, suppongo.»
Dopo essermi accomiatato, riflettei su quell'ultimo commento. Mi ero
entusiasmato così tanto per la reazione promettente di Duponte da non interrogarmi sul motivo per cui l'investigatore aveva accettato di portare a
termine quel compito analitico. Forse, avendo saltato il pranzo, aveva soltanto avuto voglia di assaggiare il dolce, la sua parte del bottino, sin dal
principio.
Quello non fu l'ultimo dei miei tentativi finalizzati a incoraggiare Duponte a rievocare le sue capacità. Avevo portato dall'America il libretto
The Prose Romances of Edgar A. Poe e, dopo aver contrassegnato la prima
pagina degli Assassinii della Rue Morgue, gli lasciai il volume, sperando
che attirasse la sua attenzione. Esultai quando parve che le mie tattiche avessero sortito un effetto. Il primo vero indizio della sua straordinaria trasformazione arrivò una sera in cui lo seguii fino al Café Belge, dove si accomodava su una panca due o tre volte la settimana, ignorando il chiacchiericcio intorno a lui e le partite di biliardo, beatamente smarrito tra gli
alterchi e la tremenda confusione tutt'intorno. L'avevo già pedinato fin lì in
altre occasioni. Questa volta notai qualcosa di diverso appena lo scorsi. Il
suo sguardo appariva meno vacuo.
Lo persi di vista dopo che fu entrato nel piccolo e angusto caffè. Gli
specchi alle pareti moltiplicavano il caos all'interno. Quello era il luogo in
cui si riunivano i migliori giocatori di biliardo della città. Vi era un tale
dall'aria furfantesca che, a quanto si mormorava, era il più abile di tutti. Un
rosso intenso pervadeva il suo corpo: i capelli, la fronte, la pelle irritata e
butterata. Giocava quasi sempre da solo, forse perché era troppo abile per
gli altri, che si recavano nel locale soltanto per rilassarsi e divertirsi. Si
congratulava con se stesso per i colpi buoni e si malediceva senza pietà
quando sbagliava.
Il Café Belge era l'unico bar della città che consentisse alle donne di cimentarsi nel biliardo, sebbene (cosa che sorprenderà molti di coloro che
non hanno visitato Parigi) non fosse l'unico a permettere loro di fumare sigarette. Già, l'americano ignaro potrebbe sbiancare solo passando accanto
a molte delle illustrazioni esposte nelle vetrine dei negozi di stampe, o dopo aver assistito a scene di attività materne, solitamente confinate alla
nursery, esibite sotto gli occhi di tutti nel bel mezzo dei giardini delle Tuileries.
Mentre cercavo Duponte, una giovane posò la mano sulla mia.
«Monsieur, desiderate disputare una partita con noi?»
«Mademoiselle?»
Indicò le altre tre fanciulle al suo tavolo. «Vorrete giocare a biliardo,
suppongo. Coraggio, ecco una stecca. Siete inglese?»
Mi spinse dinanzi al tavolo. «Non agitatevi. Nessuno gioca per denaro a
Parigi, solo per qualche drink!»
«Vedete» mi chinai per parlare il più piano possibile «non sono sposato.» Secondo quanto mi avevano riferito, mostrarsi in compagnia di uno
scapolo rappresentava un notevole rischio per la reputazione di una nubile
francese; in compenso, le donne coniugate potevano mostrarsi senza problemi in qualsiasi atteggiamento.
«Ah, benissimo» mi rassicurò con un sussurro udibile e pieno di fumo.
«Io sì.» Lei e le sue amiche risero, e il loro francese divenne troppo rapido
perché riuscissi a seguirlo. Mi feci largo attraverso la sala, urtando i gomiti
di alcuni degli uomini intenti a giocare.
Dopo qualche istante, notai un'altra ragazza che si teneva in disparte.
Benché sembrasse appartenere alla medesima classe modesta delle altre,
aveva un contegno elegante che la distingueva dalle sue pari. E che, se è
per questo, la distingueva dalle «bellezze senza eguali» che sfilavano lungo Baltimore Street. Era più bassa di me, e i suoi occhi infossati parvero
quasi prevedere il mio percorso attraverso la stanza. Portava un cesto di
fiori sbocciati e restava immobile, in silenzio. Un avventore alzava la mano, e lei gli si avvicinava, al che il cliente le gettava una o due monete di
rame nel paniere.
Mentre mi frugavo in tasca alla ricerca di qualche spicciolo da regalare a
quell'incantevole visione, andai a sbattere contro il tavolo successivo, investendo un tizio impegnato in un tiro.
«Che cosa diavolo...?» Era il rosso dall'aria furfantesca. Il miglior giocatore dell'arrondissement. Accanto a lui vi era una bruna avvenente ma
smunta, che lo consolò accarezzandogli il braccio.
Le fanciulle di prima mi indicarono ridacchiando dall'altra parte del locale. «Monsieur inglese!» continuavano a ripetere.
«Mi avete rovinato la partita» disse l'uomo. «Vi spacco la testa! Tornatevene in Inghilterra.»
«A dire il vero, monsieur, sono americano. Vogliate accettare le mie
scuse.»
«Uno "yankee", dunque? Credete forse di essere tra gli indiani, allora?
Che cosa ci fate qui? Cercate rogne?»
Mi spinse più volte con violenza. Per poco non caddi all'indietro, ritrovando appena l'equilibrio. A un certo punto di quella disavventura (in quel
momento o nelle fasi successive, ancor più penose), il mio cappello scomparve. Dopo un altro spintone vacillai, caddi contro un tavolo e mi guardai
ruzzolare sul pavimento negli specchi alle pareti.
Nel mio ricordo successivo, sono steso sulla schiena. Alzando gli occhi
verso il soffitto, dove il fumo stantio si raccoglieva piano prima di continuare all'infinito negli specchi come una bruma che si propaga sopra l'oceano, pensai che fosse meglio rimanere a terra.
Due braccia sfondarono la coltre di fumo e mi rimisero in piedi. La sala
sembrava più calda, più piccola, più chiassosa. Urla e risa risuonavano in
lontananza, benché il vocìo fosse cagionato in parte da una delle fanciulle,
che, su un tavolo, si stava scatenando in una danza. Le grida imbaldanzirono il furfante rosso, la cui bocca bavosa abbozzò un sorriso ripugnante
proprio dinanzi alla mia faccia.
Il suo alito era così acre da essere insopportabile. «La mia partita migliore in assoluto» affermò in tono minaccioso. O almeno, qualunque cosa avesse detto, aveva un suono minaccioso, giacché non posso essere certo
delle parole (naturalmente parlava francese, ma trovavo la sua pronuncia
pressoché incomprensibile). Speravo che la ragazza elegante con il cesto di
fiori non stesse guardando.
Poi udii una voce alle mie spalle. «Monsieur, con il vostro permesso.»
Il furfante alzò lo sguardo.
«Vi sfido a una partita di carambola, monsieur» aggiunse la stessa voce.
«E scommetteremo la somma che desiderate.»
Il furfante rosso parve scordarsi del tutto di me e spinse via la sua accompagnatrice, che, allarmata dall'accaduto, si voltò e lo tirò per il gomito.
«Al mio tavolo?» chiese la canaglia, indicando il punto in cui ci eravamo scontrati.
«Nessun altro sarebbe più adatto» rispose Duponte, inchinandosi con
cortesia.
Concordarono una cifra. La scena non tardò ad attirare i curiosi, non solo perché un giocatore sconosciuto aveva avuto l'ardire di sfidare il campione, ma anche perché la posta in palio era costituita da un bel po' di soldi
anziché dai soliti drink.
Come se quello potesse essere un secondo Duponte, mi guardai intorno
per accertarmi che l'originale non fosse altrove. Pur sentendomi pervadere
dal sollievo per essere scampato al pericolo, intuii subito il suo errore. Innanzi tutto, grazie alle mie osservazioni, sapevo che Duponte non avrebbe
avuto il denaro necessario qualora avesse perduto. Inoltre, vi era il talento
dell'altro per il gioco del biliardo. Quasi per rammentarmelo, uno degli
spettatori dietro di me bisbigliò a un amico: «Furfante rosso è uno dei migliori giocatori di Parigi». L'uomo lo chiamò con il suo vero nome, che,
per via della confusione di eventi, non ricordo più.
Furfante rosso gettò i quattrini su una sedia. Duponte era occupato a
scegliere la stecca.
«Monsieur?» lo chiamò l'altro, battendo tre volte sulla sedia.
«Il denaro è la mia ricompensa» spiegò Duponte. «Non la vostra.»
«E se vincessi?» sbraitò il suo avversario, il viso che passava dal rosso al
viola.
Duponte mi chiamò con un cenno. «Se sarete il vincitore dell'incontro
senza pegno» replicò «allora potrete riprendere indisturbato la vostra controversia con questo signore.»
Con mio profondo sconforto, il briccone si voltò verso di me e parve
pregustare la barbara licenza che la vittoria gli avrebbe concesso. Offrì a
Duponte persino l'onore di tirare per primo. Cercai disperatamente di ricordare se i racconti di Poe accennavano all'abilità dell'investigatore nel biliardo, ma Dupin professava un'avversione per i giochi matematici, tra cui
gli scacchi, e sosteneva la superiorità delle semplici partite di whist come
banco di prova delle effettive capacità di raziocinio.
Duponte partì con un colpo così disastroso che parecchi spettatori risero.
Furfante rosso divenne assai serio, e persino aggraziato, man mano che
colpiva la palla con disinvoltura volta dopo volta. Se avevo rovinato la sua
partita migliore in assoluto, quello era senz'altro il suo secondo incontro
più spettacolare. Mi aggrappai alla speranza che Duponte diventasse bravo
a un tratto o rivelasse che la sua inettitudine era soltanto uno stratagemma.
Non fu così; la sua tecnica peggiorò. E poi rimasero solo tre o forse quattro
tiri a Furfante rosso prima che la gara si chiudesse a suo favore. Mi frugai
nelle tasche con l'intenzione di pagare la mia parte della puntata con monete d'argento, ma non avevo con me più di qualche franco.
L'aspetto più sorprendente fu che Duponte non perdette la calma neppure per un attimo. Nonostante i tiri pessimi, la sua espressione restò perfet-
tamente serena e fiduciosa. Ciò divenne sempre più irritante per l'altro uomo, pur non sortendo il benché minimo effetto sul suo stile impeccabile.
Una delle soddisfazioni del trionfo è assistere alla mortificazione del perdente. E Duponte si rifiutava di dargliela. Credo che Furfante rosso abbia
persino ritardato la propria vittoria per cercare di produrre la giusta umiliazione.
Alla fine, si girò verso il tavolo con rinnovata rapidità e con un lampo di
rabbia nei confronti di Duponte. «Abbiamo finito» dichiarò, fulminandomi
con un'occhiata carica d'odio.
«Sì? Benissimo, allora.» Con mio orrore, Duponte scrollò le spalle.
Impaurito com'ero, in un primo momento non udii neppure il trambusto
all'ingresso. Anzi, lo scompiglio non attirò la mia attenzione fintantoché
scorsi varie persone che indicavano dalla nostra parte. A quel punto comparve un uomo che, a parte la folta barba arancione e la corporatura assai
più robusta, assomigliava a Furfante rosso. Vedendo la faccia avida e arrossata di quest'ultimo che si tingeva di un pallore patetico, capii che qualcosa non andava. Avevo ritrovato il mio francese quanto bastava per comprendere che, secondo quell'individuo inviperito, Furfante rosso aveva mostrato una passione romantica per la sua amante, la ragazza che stava nervosamente in piedi accanto al tavolo. Ora la giovane implorò il tipo più
corpulento di perdonarla, e Furfante rosso si dileguò tra le vie.
Quando mi riscossi, Duponte aveva già recuperato i quattrini dalla sedia
e si stava allontanando.
Se sarete il vincitore senza pegno... Quelle parole mi vorticarono nella
testa. Pegno. Aveva previsto sin dal principio come sarebbero andate le
cose. Lo seguii sulla strada.
«Monsieur, avrei potuto rimetterci la pelle! Non avreste mai vinto!»
«Certo che no!»
«Ma come diavolo facevate a sapere che sarebbe arrivato quel tale?»
«Io non lo sapevo. In precedenza, la ragazza al braccio di Furfante rosso
aveva continuato a guardare fuori della vetrina a intervalli di qualche minuto, ma, se avete notato, sempre tenendosi lontana dal vetro per non essere veduta. Inoltre, non si limitava a cingere il braccio del Rosso, ma lo
stringeva, come se volesse proteggerlo, e quando l'ho sfidato, l'ha supplicato di andare via... di sicuro non perché temesse che qualcuno potesse
sconfiggerlo in quel gioco infantile. Era lei a sapere che l'altro suo amante
la stava cercando, perché l'aveva già veduto in preda all'ira qualche ora prima, o magari perché aveva dimenticato una delle lettere di Furfante rosso
sul comò. Mi sono limitato a osservarla, contando sul fatto che quel tale
non avrebbe tardato ad arrivare. Quando qualcun altro sa qualcosa, di solito non è necessario scoprirlo da soli. Non vi era nulla di cui preoccuparsi.»
«E se fosse comparso soltanto dopo la vostra sconfitta?»
«Noto che siete di indole assai impressionabile.»
«Il vostro avversario non avrebbe commesso qualche atroce violenza nei
miei confronti?»
«D'accordo» concesse dopo un istante «sarebbe stato molto sgradevole
per voi, monsieur. Dobbiamo essere grati che non sia accaduto.»
Un mattino, i miei colpi alla porta di Duponte non ottennero alcuna risposta. Provai la maniglia, e l'uscio si aprì. Pensando che non mi avesse
udito, entrai e lo chiamai.
«Una passeggiata, oggi, monsieur?» Tacqui, guardandomi intorno.
Duponte era curvo sul letto come se pregasse, la mano gli stringeva la
fronte in una morsa. Approssimandomi, vidi che leggeva con insolita concentrazione.
«Che cosa avete fatto?» domandò.
«Sono soltanto venuto a cercarvi, monsieur. Ho pensato che magari oggi
sarebbe stato piacevole passeggiare lungo la Senna. O andare alle Tuileries
ad ammirare gli ippocastani» risposi, attonito.
I suoi occhi fissarono i miei, colmandomi di inquietudine.
«Come vi ho spiegato, monsieur Clark, non mi dedico alle occupazioni
che immaginate. Sembrate non aver capito questo semplicissimo concetto.
Insistete nel confondere la vostra letteratura e la mia realtà. Ora fatemi la
cortesia di lasciarmi in pace.»
«Ma monsieur Duponte... per favore...»
Solo allora vidi che cosa leggeva con tanta attenzione: Gli assassinii della Rue Morgue. Il libretto che gli avevo lasciato. Poi mi spinse sul pianerottolo tenendomi per il braccio e chiuse la porta. Mi sentii subito mancare.
Premetti l'occhio contro la fessura tra l'uscio e lo stipite. Duponte sedeva
sul letto. La sua sagoma divenne assai eloquente man mano che leggeva. A
ogni pagina che girava, pareva che la sua postura mutasse un tantino, e la
sua ombra sembrò dilatarsi.
Attesi per qualche istante in un silenzio sconcertato. Poi bussai piano e
tentai di farlo ragionare.
Bussai sempre più forte, quindi scossi la maniglia finché il custode comparve e mi strappò dall'uscio, minacciando di chiamare la polizia. A Wa-
shington, monsieur Montor mi aveva raccomandato di non farmi mai sorprendere dagli agenti in un atteggiamento contrario all'ordine pubblico.
«Non sono affatto come i poliziotti americani» aveva affermato. «Quando
prendono di mira qualcuno... sono guai.»
Per il momento mi arresi e permisi al portiere di trascinarmi giù per le
scale.
Parlare attraverso finestre e serrature, picchiare alla porta, infilare biglietti nell'appartamento... furono quelle le attività delle lunghe e penose
giornate che seguirono. Pedinavo Duponte mentre passeggiava per Parigi,
ma lui mi ignorava. Una volta, quando lo seguii fino all'ingresso della sua
abitazione, si fermò sulla soglia e ordinò: «Non permettete di nuovo l'accesso a questo giovanotto impertinente».
Pur guardando me, aveva parlato con il custode. Si voltò e salì i gradini.
Studiai gli orari in cui il portiere era solito uscire e imparai che sua moglie era lieta di lasciarmi entrare senza fare domande in cambio di qualche
sous. «Non vi è tempo da perdere» scrissi a Duponte in uno dei messaggi
che gli passai sotto la porta e che lui ributtava puntualmente sul pianerottolo senza leggerli.
In quel periodo, ricevetti un'altra missiva di Peter. Il suo tono era assai
meno contrariato, e mi esortava a rientrare immediatamente a Baltimora,
dove sarei stato accolto a braccia aperte dopo aver sfogato i miei bollori
giovanili. Inviò persino una lettera di credito a una banca francese per una
somma generosa, cosicché potessi organizzare il viaggio di ritorno senza
indugio. Ovviamente gli restituii subito il denaro, rispondendogli che intendevo portare a compimento la mia missione. Alla fine, sarei riuscito a
riscattare Poe da chi voleva distruggerlo e avrei consolidato il prestigio del
nostro studio legale raggiungendo l'obiettivo prefissato.
In seguito, Peter mi scrisse che stava prendendo in seria considerazione
l'idea di recarsi a Parigi per rintracciarmi e riportarmi a casa, anche se avesse dovuto trascinarmi con le sue mani.
Continuavo a raccogliere articoli sulla morte di Poe nelle biblioteche che
conservavano i giornali americani. In generale, le descrizioni del poeta erano peggiorate. I moralisti usavano il suo esempio per porre rimedio
all'indulgenza mostrata in passato verso gli uomini di genio che erano stati
elogiati dopo la loro scomparsa pur avendo condotto una «vita dissoluta».
Un nuovo scossone si verificò allorché uno spietato scribacchino, un certo
Rufus Griswold, diede alle stampe una maligna biografia colma di astio e
di calunnie per guadagnare qualche spicciolo grazie allo scandalo. La reputazione di Poe subì un ulteriore declino, fino a essere del tutto infangata.
Talvolta, in quella folle corsa a sezionare la vita di Poe, emergeva un
nuovo e importante dettaglio capace di far luce sulle sue ultime settimane.
Per esempio, qualcuno aveva dimostrato che Edgar intendeva partire per
Filadelfia poco prima che lo rinvenissero al Ryan. Avrebbe dovuto ricevere cento dollari per curare un volume di poesie su richiesta di una certa signora St. Leon Loud. Quell'informazione provocò tuttavia le consuete mistificazioni da parte della stampa, giacché nessuno sapeva se fosse andato
a Filadelfia oppure no.
Ancora più bizzarra era la lettera mostrata ai reporter da Maria Clemm,
l'ex suocera di Poe, lettera che il poeta le aveva scritto subito prima di lasciare Richmond, accennando anche al viaggio a Filadelfia. Era stata l'ultima missiva di Poe alla sua amata protettrice. «Non ho neanche un dollaro
da potervi spedire, ma non perdetevi d'animo. Spero che i nostri guai stiano per finire» dicevano le tenere parole dello scrittore. «Rispondete immediatamente e indirizzate a Filadelfia.» Poi aggiungeva: «Poiché temo di
non ricevere la lettera, non firmatela e indirizzatela all'Egr. Sig. E. S. T.
Grey. Che Dio vi benedica e vi protegga, mia carissima Muddy». Firmato:
«Il vostro Eddy».
Signor E. S. T. Grey? Perché Poe aveva usato un nome falso nelle settimane precedenti la sua morte? Perché aveva tanta paura che la lettera di
Muddy non gli venisse inoltrata a Filadelfia? E. S. T. Grey. I quotidiani
che riportavano la notizia parevano ridere dell'apparente assurdità della situazione.
Le mie indagini sembravano più urgenti che mai, ma ero a Parigi, e Duponte si rifiutava persino di rivolgermi la parola.
Capitolo 8
Che fosse stato tutto un tremendo errore, il prodotto della smania delirante di votarmi a qualcosa di diverso dal mio solito ambiente e dalle mie
solite responsabilità? Se solo mi fossi accontentato dell'amore e dell'affidabilità di Hattie e Peter! Non vi era forse stato un periodo della mia infanzia in cui avevo avuto bisogno soltanto del caminetto scoppiettante di
Glen Eliza e dei miei fidati compagni di gioco? Perché consegnare il mio
cuore e i miei progetti a un uomo come Duponte, rinchiuso tutto solo in
una prigione morale così lontana dal mio mondo?
Decisi di combattere l'umor tetro e di tenermi occupato recandomi nei
luoghi che, secondo i consigli della mia guida turistica, «il forestiero deve
assolutamente vedere».
Innanzi tutto, visitai il palazzo sugli Champs-Élysées, dove Luigi Napoleone, presidente della repubblica, viveva nello sfarzo. Nell'enorme ingresso dell'edificio, un massiccio servitore dalla livrea ornata di galloni prese il
mio cappello, porgendomi in cambio un gettone di legno.
In uno dei primi appartamenti aperti al pubblico, era possibile vedere
Luigi Napoleone, il principe in persona. Non era la prima volta che intravedevo il presidente della repubblica e il nipote del grande imperatore, che
era ancora il simbolo preferito dal popolo francese. Qualche settimana addietro, Luigi Napoleone aveva cavalcato lungo Avenue de Marigny, passando in rassegna i suoi soldati vestiti di rosso. Duponte l'aveva osservato
con interesse, e giacché allora sopportava ancora la mia presenza, l'avevo
accompagnato.
La folla lungo la strada aveva applaudito, e coloro che indossavano gli
abiti più costosi avevano gridato con fervore: «Vive Napoleon!». In quei
momenti, in cui il presidente era solo una sagoma indistinta sul suo cavallo
attorniato di guardie, era facile notare una somiglianza, seppur lieve, con
l'altro Napoleone, che aveva sfilato tra le acclamazioni di quarant'anni addietro. Secondo alcuni, era stato soltanto il nome di Luigi Napoleone a determinare la recente elezione del principe presidente. I braccianti analfabeti
delle aree rurali più povere, si diceva, avevano creduto di votare per il Napoleone Bonaparte originale (ormai morto da circa trent'anni).
Tuttavia, avevo veduto anche una ventina di uomini con le mani, il volto
e il collo imbrattati di fuliggine che ripetevano lo slogan: «Vive la république!» in un coro inquietante. Tra la calca, uno dei miei vicini aveva affermato che erano stati mandati dal «partito rosso» per protestare. Come il
grido «Lunga vita alla repubblica» potesse essere considerato una protesta
o un insulto in una repubblica ufficiale sfuggiva alla mia comprensione
dell'attuale stato politico. Suppongo che fosse il tono a rendere minacciose
le loro parole e a far diventare spaventoso il termine «repubblica» per i seguaci del presidente, come se, in realtà, il significato di quelle urla fosse:
«Questa non è una repubblica, giacché costui l'ha tramutata in una finzione, ma un giorno la rovesceremo e avremo una vera repubblica senza di
lui».
Lì, nel suo palazzo, Luigi Napoleone pareva un tipo più contemplativo,
mite, pallidissimo e assai signorile. Era inebriato dalla soddisfazione di es-
sere circondato da una folla di individui perlopiù in uniforme, molti dei
quali avevano il petto che scintillava di splendide medaglie dorate. Nondimeno osservai anche un doloroso senso di goffaggine suscitato dalla riverenza con cui il principe presidente veniva trattato: ora da monarca, ora
da presidente eletto.
Proprio in quell'istante, il prefetto di polizia Delacourt entrò dalla sala
attigua e cominciò a confabulare con Napoleone. Mi stupii notando che mi
lanciava un'occhiata assai scortese.
Quell'attenzione indesiderata mi spinse ad allontanarmi dagli ChampsÉlysées prima del previsto. Dovevo ancora vedere la reggia di Versailles, e
sebbene la mia guida consigliasse di mettersi in viaggio di prima mattina,
decisi che non era troppo tardi per concedermi una visita completa ai sobborghi della città. Inoltre, Duponte mi aveva suggerito di andare a Versailles. Forse, se avesse saputo che gli avevo dato ascolto, sarebbe stato più
disposto a parlarmi.
Una volta che le rotaie ferroviarie lasciavano Parigi, la metropoli svaniva di colpo, cedendo il passo a un'aperta campagna vasta e ininterrotta.
Donne di tutte le età, che indossavano cuffiette rosa e faticavano nei campi, incrociarono per un attimo il mio sguardo mentre il treno sferragliava
loro accanto.
Ci fermammo alla stazione di Versailles. Per poco la ressa non mi travolse e non mi trascinò in una fiumana di cappelli e cuffiette decorate di
nastri che finiva sotto il cancello del grande castello di Versailles, dove si
udiva l'acqua corrente che giocava nelle fontane.
Ripensandoci, suppongo che tutto sia cominciato mentre gironzolavo per
gli appartamenti del palazzo. Avvertii il pungolo di un vago disagio, come
quando si indossa un cappotto un po' troppo leggero per la prima giornata
invernale. Imputai il mio fastidio alla torma di gente tutt'intorno. La folla
che aveva cacciato la duchessa d'Angoulême da quelle stanze non era certo
stata turbolenta come questa. Mentre il mio cicerone elencava le battaglie
raffigurate nei vari dipinti, mi distrassi sentendo diversi occhi puntati su di
me.
«In questo salone» spiegò l'uomo «Luigi XIV sfoggiava tutta la magnificenza della regalità. La corte era così fastosa che i cortigiani dell'epoca
dovevano accalcarsi intorno al re persino in questo enorme locale.» Eravamo nel sontuoso salone di Luigi XIV, dove diciassette finestre ad arco
affacciate sui giardini si riflettevano in altrettanti specchi lì di fronte. Mi
domandai se l'idea di monarchia fosse più allettante ora che la recente rivoluzione l'aveva sconfitta.
Credo che il cicerone, ingaggiato per un franco l'ora, si fosse stancato
della mia distrazione nel corso del pomeriggio. Pensò, temo, che ignorassi
gli aspetti più raffinati dell'arte e della storia. La verità era che la netta sensazione di essere osservato era cresciuta senza posa, e ogni punto di quel
salone degli specchi era prodigo di sguardi.
Cominciai a concentrarmi sugli individui in cui continuavo a imbattermi
nei vari appartamenti. Avevo convinto il mio accompagnatore a modificare
il percorso attraverso l'edificio, un'idea che, senza dubbio, lo ripugnava.
Frattanto, l'uomo non favorì la mia tranquillità quando affrontò l'argomento degli stranieri a Parigi.
«Sapranno bene come trascorrete il vostro tempo qui... giacché siete un
giovanotto attivo» commentò, forse cercando un modo per inquietarmi.
«Chi, monsieur?»
«La polizia e il governo, naturalmente. A Parigi non accade nulla senza
che qualcuno lo sappia.»
«Ma, monsieur, temo di non essere abbastanza interessante.»
«Verranno a conoscenza di ogni cosa dai proprietari del vostro hotel, dai
commissionnaires che vi vedono andare e venire, dai cocchieri delle vetture di piazza, dagli osti e dagli erbivendoli. Già, monsieur, suppongo non vi
sia nulla che possiate fare senza che loro lo scoprano.»
Nel mio stato di agitazione, quella frase non contribuì certo a rassicurarmi. Gli pagai il dovuto e lo congedai. Senza di lui, potevo muovermi più
in fretta, zigzagando tra i lenti capannelli di gente in ogni sala. Notai un
certo scompiglio alle mie spalle, uomini che sbuffavano e donne che si indignavano per il disturbo. A quanto sembrava, alcuni turisti si lamentavano
di qualcuno che si faceva largo con maleducazione tra la folla. Svoltai nella stanza successiva senza aspettare di vedere chi fosse il responsabile di
quella confusione. Nel frattempo, schivai ogni figura e ogni arredo costoso
sul mio cammino, fino a raggiungere gli immensi giardini del castello.
«Eccolo! È il tizio che si faceva strada a gomitate!» Quando udii quella
voce, una mano mi afferrò per il braccio. Era una guardia.
«Io?» protestai. «Ma io non ho spinto nessuno!» Dopo che qualcuno ebbe affermato di aver scorto il colpevole alle nostre spalle, il gendarme mi
liberò, ma mi affrettai a mettere una distanza tra noi nell'eventualità che
cambiasse idea. Di lì a poco avrei rimpianto di essermi allontanato dalla
sicurezza che mi conferiva la sua vicinanza. Rammentai che madame Fou-
ché mi aveva messo in guardia dalle aree pericolose di Parigi. «Vi sono
uomini e donne pronti a derubarvi e a gettarvi nella Senna» aveva dichiarato. Era tra quella gentaglia che i rivoluzionari del marzo 1848 avevano reclutato quasi tutti i loro «soldati» per costringere re Luigi Filippo ad abdicare e fondare la repubblica nel nome del popolo. Un vetturino mi aveva
raccontato che, durante quella sommossa, aveva veduto uno di quei farabutti, attorniato dalla polizia, urlare: «Je suis bien vengé!» ed estrarre
quindici o sedici lingue umane dalle tasche. Le aveva lanciate in aria prima
di morire e quelle erano atterrate sulle spalle e sui cappelli dei gendarmi, e
persino nella bocca di un agente, che si era spalancata per l'incredulità di
fronte alla scena disgustosa.
Mi trovavo nel lussuoso paradiso degli impeccabili giardini di Versailles, non in uno di quei quartieri di taglialingue. Avevo tuttavia l'impressione che qualcuno spiasse ogni mio passo. Gli alberi e le siepi appuntite rivelavano frammenti di volti. Oltrepassando file di vasi, statue e fontane, sostai dinanzi ad Apollo, una spaventosa divinità che si ergeva da una fontana zampillante di delfini e mostri marini. Sarei stato molto più al sicuro
negli appartamenti del palazzo, circondato da orde di visitatori e da quel
ficcanaso del mio cicerone. Fu allora che un tale si materializzò dinanzi a
me e mi ghermì il braccio.
Ecco che cosa ricordo di quanto avvenne in seguito. Ero a bordo di una
carrozza sgangherata che correva tra i sassi. Accanto a me vi era l'ultima
faccia che avevo veduto prima di perdere i sensi nei giardini del palazzo,
una faccia rigida e impenetrabile scolpita sotto una fronte aggrottata e impassibile. Un volto che avevo notato anche in molti dei saloni di Versailles. Era stato quel tizio a pedinarmi. Mi leccai i denti e le gengive, constatando che c'era ancora; la mia lingua, intendo.
Riflettei prima di allungare la mano verso lo sportello? Non lo so. Mi
gettai da quella parte e ruzzolai sulla strada. Quando mi rialzai, un'altra
carrozza si precipitò nella mia direzione. Sbandò e si infilò a malapena tra
me e il veicolo da cui ero sceso. «Gare!» ringhiò il cocchiere, di cui intravidi soltanto una nutrita serie di denti ingialliti, un cappello floscio e un
colletto cascante. Un cane magro latrò dal finestrino.
Mi lanciai verso i campi che declinavano dalla via e oltre i quali vi era
l'aperta campagna.
Poi il mio rapitore balzò fuori della vettura e sfrecciò verso di me a una
velocità impressionante per un uomo così corpulento. Sentii un colpo rapi-
do e deciso alla testa.
Avevo le mani immobilizzate dietro la schiena. Mi guardai intorno... o
forse dovrei dire guardai insù. Al mio risveglio, mi ritrovai in un ampio
fossato profondo circa sei metri. Più in alto vi erano mura torreggianti, per
nulla simili alle aggraziate serie di dimore ed edifici di ogni via parigina.
Era come se mi avessero condotto in un altro mondo, e un silenzio raggelante si stendeva tutt'intorno come nel deserto più sterminato.
«Dove sono? Esigo saperlo!» urlai, pur non vedendo nessuno contro cui
urlare.
Udii una voce che borbottava qualcosa in francese. Allungai il collo, ma
non riuscii a muovermi abbastanza per girarmi. Solo un'ombra si allungò
su di me, e credetti che fosse quella del mio sequestratore.
«Dove siamo, canaglia?» chiesi. Senza dare segno di aver sentito, si limitò a restare fermo, in attesa. Solo quando il mio rapitore comparve sul
lato opposto, mi accorsi che l'ombra apparteneva a qualcun altro.
Alla fine, l'ombra si spostò e mi si parò dinanzi. Ma non era quella di un
uomo.
Eccola, con indosso una linda cuffietta bianca e un vestito sobrio, colei
che sarebbe stata perfetta in uno dei giardini di Parigi. Si arrestò davanti
alla mia sedia e si chinò su di me con quello che sembrava un atteggiamento premuroso e protettivo, scrutandomi con occhi talmente infossati che
parevano raggiungere il retro della testa. Non sembrava più grande di una
ragazzina.
«Smettete di strillare.»
«Chi siete?» sussurrai, roco per via delle grida.
«Bonjour» disse, prima di voltarmi le spalle e allontanarsi subito.
Risposi al saluto pur giudicando assurdo qualsiasi tentativo di cordialità
in quelle circostanze.
«Idiota» mi insultò il mio sequestratore. «È così che si chiama. Bonjour!»
«Bonjour?» ripetei. Quindi mi ricordai di averla già incontrata, in una situazione altrettanto pericolosa. «Al Café Belge! Vi ho veduta laggiù, con
un cesto di fiori! Perché eravate là?»
«Eccoci qui!» tuonò una nuova voce in inglese, con un lievissimo accento francese ma per il resto perfettamente scorrevole. «È davvero necessario
tenere il nostro gradito ospite statunitense legato in questo modo?»
La risposta fu abbastanza umile da identificare il nuovo arrivato come il
capobanda. Il mio rapitore gli si avvicinò e gli parlò in tono confidenziale,
come se a un tratto avessi perduto l'udito. «È svenuto a Versailles e poi è
fuggito dalla carrozza, saltando fuori dello sportello come un pazzo. Si è
quasi ammazzato...»
«Non importa. Qui siamo tutti al sicuro. Bonjour, ti dispiace?» La ragazza sciolse le corde con destrezza, liberandomi i polsi.
Fino a quel momento non ero riuscito a vedere il secondo uomo, bensì
soltanto frammenti di un lungo mantello bianco e di pantaloni chiari e attillati. Con le mani libere, mi alzai per fronteggiarlo.
«Le mie scuse per aver fatto ricorso a simili mezzi, monsieur Clark» esordì, agitando le dita ingioiellate tutt'intorno, come se l'intera faccenda
fosse solo un incidente. «Temo tuttavia che queste lugubri fortezze siano
tra i pochi luoghi nei dintorni di Parigi in cui possa ancora viaggiare con
una certa tranquillità. Cosa più importante...»
Lo interruppi. «Ora statemi a sentire! Il vostro tirapiedi mi ha malmenato, e adesso... Ma innanzi tutto desidero sapere con esattezza dove mi avete
fatto condurre e perché...!» Le parole mi morirono in gola, e lo fissai con
una scintilla di consapevolezza improvvisa.
«Cosa più importante, dicevo» continuò con calore, un sorriso che gli si
disegnava sul volto olivastro, «finalmente ci conosciamo di persona.»
Mi prese la mano, che si afflosciò quando intuii la verità.
«Dupin!» esclamai, incredulo.
Capitolo 9
Ricorderete che avevo preso in seria considerazione altri cinque o sei
possibili ispiratori del personaggio di Dupin prima di scartarli a favore di
Duponte.
Tra loro figurava un certo barone Claude Dupin, un avvocato francese
che, si mormorava, non aveva mai perduto una causa e vantava una remota
discendenza regale, da cui il dubbio titolo di «barone». Per molti anni era
stato tra i legali più illustri di Parigi, reputato un eroe per aver difeso con
successo molti criminali colpevoli ma capaci di suscitare la compassione
dei giudici. Un tempo, era stato persino candidato al ruolo di avvocato generale, e il suo distretto l'aveva quasi mandato alla camera dei rappresentanti durante uno degli sconvolgimenti del governo francese. Alcuni avevano insinuato che usasse tattiche subdole, e ben presto aveva rinunciato
del tutto al suo lavoro per andare a Londra e dedicarsi ad altre occupazioni.
Mentre si trovava lì, aveva prestato giuramento come tutore volontario
dell'ordine in un periodo in cui si era diffusa la paura di una sommossa, e
si era dimostrato tanto coraggioso che gli avevano concesso di mantenere
quella carica in via onorifica.
Avevo raccolto tutte quelle informazioni poco per volta, durante le mie
meticolose ricerche nei periodici francesi. Prima della mia partenza per Parigi, vi era stato un momento in cui avevo maturato la certezza assoluta che
Claude Dupin fosse il modello di C. Auguste Dupin, e avevo spedito diverse lettere al barone chiedendogli ulteriori dettagli sulla sua storia e descrivendo la preoccupante situazione verificatasi a Baltimora. Di lì a poco
mi ero tuttavia imbattuto negli articoli riguardanti Auguste Duponte e avevo modificato la mia teoria. Quando Claude Dupin mi aveva risposto, gli
avevo inviato una lettera di scuse spiegandogli di aver sbagliato persona.
Uno dei giornali francesi che avevo sfogliato conteneva un ritratto del
barone Dupin, che avevo studiato con attenzione. Riconobbi dunque il tale
che mi stringeva la mano come se fossimo vecchi amici. Fu allora che, allarmato e stupefatto, esclamai: «Dupin!... Voi siete Claude Dupin!».
«Vi prego, chiamatemi barone» mi corresse, magnanimo.
Ritrassi la mano, cercando con gli occhi la via di fuga più semplice e
immediata. La carrozza che mi aveva condotto fin lì aspettava in una breccia improvvisata nella muratura, ma non credevo che sarei riuscito a requisirla, giacché il mio primo rapitore era tornato verso il veicolo e attendeva
laggiù.
La trincea intorno a Parigi faceva parte della fortificazione inespugnabile
costruita per bloccare eventuali assalti alla città. Una recinzione ininterrotta circondava la periferia della capitale, con terrapieni per l'artiglieria, attorniati da buche e fossati.
Ora, in quel posto deprimente, Dupin mi garantì che ero al sicuro e iniziò a spiegarmi che il suo complice, Hartwick (quello era il nome del mio
rapitore, colui che mi aveva afferrato a Versailles e mi aveva caricato sulla
carrozza), aveva soltanto voluto condurmi sano e salvo a quel colloquio.
«Hartwick sa imprecare peggio di Satana, e una volta ha quasi staccato il
braccio di un uomo a morsi, ma, tutto sommato, non è di indole cattiva.
Perdonatelo.»
«Perdonarlo? Perdonare questa aggressione? Dubito di poterlo fare, Dupin!» sbraitai.
«Sapete, è già un grande sollievo conoscervi» proseguì. «Dopo aver vis-
suto così tanto a Londra, temo che sia trascorso parecchio tempo da quando qualcuno ha pronunciato correttamente il mio nome, alla francese.»
«Ascoltate, monsieur» lo rimbeccai, pur apprezzando quel raro complimento alla mia pronuncia. «Non lusingatemi. Se desideravate parlare con
me, perché non scegliere un luogo civile in città?»
«Sarebbe stato un piacere bere una tazza di caffè con voi, monsieur
Clark, ve lo assicuro. Ma posso chiamarvi Quentin?» La vivacità del suo
modo di esprimersi indicava un notevole ardore.
«No!»
«Calma, calma. Lasciate che mi spieghi meglio, buon Quentin. Vedete,
vi sono due tipi di conoscenze a questo mondo: gli amici e i nemici. A Parigi, li ho entrambi. Temo che uno di quei gruppi voglia tagliarmi la testa.
Forse ho avuto a che fare con la gente sbagliata alcuni anni or sono e ho
promesso somme di denaro che, al termine di una valutazione matematica
accurata e inesorabile, non possedevo. Ero povero in canna. Per fortuna,
pur essendo in difficoltà, a Londra godo di una protezione sufficiente a evitare troppe scocciature. Vedete dove sono costretto a rintanarmi quando
desidero visitare Parigi» aggiunse, agitando la mano verso le fortificazioni.
«Voi siete così fortunato da possedere un vostro patrimonio, credo, carissimo Quentin. Frutto del vostro lavoro? Oppure siete nato con la camicia?
Non fa differenza, immagino.»
Fu sorprendente, e un poco inquietante, vederlo estrarre le mie lettere dal
cappotto. Se descrivessi l'aspetto fisico del barone in questa sede, capireste
come mai mi risultò difficile rifiutarmi di parlargli nonostante il trattamento imperdonabile a cui mi aveva sottoposto. Indossava abiti costosi: un
completo bianco appariscente, quasi pretenzioso, e guanti vistosi, con un
fiore che gli spuntava dall'occhiello, i capelli ben pettinati e i baffi curati.
Aveva minuscoli brillanti sullo sparato della camicia, sul taschino dell'orologio e su due o tre anelli alle dita, ma a onor del vero devo ammettere che
non si dava la pena di ostentarli. Gli stivali erano stati lucidati con tanta
scrupolosità che parevano assorbire tutta la luce del sole. Insomma era teatrale e seducente; sembrava appena uscito da una rivista di moda.
Soprattutto, i suoi manierismi emanavano un eccesso di cortesia e filantropia. Per filantropo, intendo il genere d'uomo che salverebbe le prostitute
dalla strada portandosene a casa una o due. Benché mi tenesse prigioniero
in una fortezza deserta, mi ritrovai a sforzarmi di non apparire sgarbato in
sua presenza. Gli domandai con pacatezza come mi avesse rintracciato a
Parigi.
«Fra coloro che considero ancora amici vi sono vari membri della polizia incaricati di osservare con attenzione i visitatori provenienti dall'estero.
La vostra ultima missiva diceva che intendevate trovare Auguste Duponte... e ne ho semplicemente dedotto che l'avreste cercato qui. Bonjour mi
ha confermato che eravate nei paraggi.» Sorrise alla bellissima fanciulla,
ora intenta a fumare una sigaretta, che mi aveva seguito fino al Café Belge
la sera della rischiosa partita di biliardo disputata da Duponte.
«Per quale motivo si chiama Bonjour?» chiesi a bassa voce, quasi volessi evitare che la giovane mi sentisse. Confesso che quell'interrogativo mi
assillava nonostante la situazione. Mi ignorarono.
Mi domando se sia stato soltanto il nome ad affascinarmi. No, non penso. Era splendida grazie all'espressività della bocca piccola e degli occhi
grandi. Non mostrava particolare interesse né per me né per la conversazione, ma ciò non diminuì la mia curiosità.
«Ora sono certo che potremo definire il nostro accordo, carissimo Quentin» dichiarò il barone, riscuotendomi dalla mia trance. Spiegò le mie lettere e me le mostrò.
«Accordo?»
Mi rimproverò aggrottando le sopracciglia con aria delusa. «Monsieur.
L'accordo mediante il quale chiariremo insieme il mistero della morte di
Edgar Poe!»
L'incisività della sua affermazione mi fece quasi dimenticare la ragione
per cui non avrei potuto accontentarlo. «Qui c'è un errore» dissi. «Temo
che, in realtà, non siate l'ispiratore del personaggio di Poe, come avevo ipotizzato una volta. Ho trovato il vero Dupin... Auguste Duponte. L'avete
letto nella mia ultima missiva?»
«Era questo il suo significato? Credevo che i vostri discorsi su Duponte
fossero soltanto una burla. Allora monsieur Duponte ha iniziato la sua analisi della scomparsa iniqua e sbalorditiva dell'amatissimo Poe, suppongo?
È determinato a sviscerarla?»
«Ecco... abbiamo avviato delle indagini segrete. Non posso rivelarvi altro.» Mi voltai con rinnovata inquietudine, ma non trovai ancora nessun
luogo in cui fuggire. Ammetto che, per qualche motivo irragionevole, volevo allo stesso tempo andarmene e rimanere. Era emozionante sentire
qualcuno che parlava con calore della morte di Poe. Ne avevo discusso per
molto tempo con Duponte senza ottenere nulla in cambio.
«Direi, monsieur Quentin, che vi siete messo in una posizione imbarazzante» continuò Dupin. Premette le mani tra loro come se pregasse, quindi
le serrò entrambe a pugno. «Ma sono io il vero Dupin... Sono io colui che
cercavate sin dal principio.»
«Che pretesa!»
«È questo che pensate? In Inghilterra, sono un tutore volontario dell'ordine. Qual è il mio compito se non quello di salvaguardare la verità? Non
ho perduto una sola causa quando facevo l'avvocato... Quel primato è inflessibile come il ferro. Che cos'è un avvocato se non un assertore della verità? Chi è il vero Dupin se non il difensore della verità? Io e voi siamo
avvocati, monsieur Clark; l'intero mondo della giustizia è il nostro territorio. Se vivessimo nell'epoca in cui Enea discese nell'Averno, l'avremmo
accompagnato sottoterra solo per presenziare a un'udienza di Minosse, non
è vero?»
«Suppongo di sì» concessi. «Sebbene di solito mi occupi di ipoteche e
faccende simili.»
«È ora di esaminare le condizioni economiche che mi avete proposto
nella vostra lettera in cambio dei miei servigi e di metterci al lavoro. Tutti
quanti trarremo profitto da questa vicenda.»
«Non farò nulla del genere. Ve l'ho detto: sono fedele a Auguste Duponte. È a lui che credo.»
Bonjour mi lanciò una rapida occhiata di avvertimento.
Dupin sospirò, incrociando le braccia. «Duponte ha perduto il suo smalto molto tempo fa. Soffre della malattia acuta che possiamo chiamare "pedanteria", e grava ogni suo gesto di un peso morto. Insomma, è come un
vecchio pittore moribondo che può soltanto illudersi di essere ancora l'artista di una volta. Un burattino del suo cervello.»
«Presumo che siate interessato a questa faccenda per via del denaro, cosicché possiate pagare i vostri debiti» ribattei, indignato. «Auguste Duponte è il "Dupin" originale, monsieur barone, per quanto voi osiate coprirlo di
improperi. Siete fortunato che non sia presente.»
Il barone mi si avvicinò, scandendo con lentezza le parole successive. «E
che cosa farebbe il vostro Duponte se fosse qui ora?»
Avrei voluto rispondergli che gli avrebbe spaccato il cranio in due, ma
non ricordavo i vocaboli francesi necessari né riuscivo a convincermi che
fosse vero. Claude Dupin, i baffi che gli brillavano quanto i gioielli, sorrise
mentre ordinava a Bonjour di accompagnarmi alla carrozza.
La giovane mi stupì afferrandomi il braccio con una presa forte quanto
quella di Hartwick e mi scortò lungo la trincea. A Parigi, gli uomini non
erano indispensabili per far funzionare la società. Ormai avevo veduto
donne che, senza l'aiuto dell'altro sesso, facevano le lattaie, le macellaie, le
cappellaie, le cambiavalute, le orditrici di intrighi, le cocchiere di carri enormi e persino le cameriere nei bagni pubblici. Una volta, a Baltimora,
avevo udito un sostenitore dei diritti femminili dichiarare che se le donne
avessero svolto le professioni degli uomini sarebbero state più virtuose.
Ecco lì una ragazza che forse sarebbe stata felice di dissentire.
Ci eravamo allontanati abbastanza perché il barone non ci udisse. Mi rivolsi a Bonjour. «Perché vi piegate ai suoi desideri?»
«Vi ho forse detto di parlare?»
Mi meravigliai di sentire quella frase da una giovane donna che sembrava avere qualche anno meno di Hattie, con una voce roca come quella di
un vecchio decrepito e dotata di un fascino singolare. «Credo di no, ma
Bonjour... signorina... mademoiselle. Mademoiselle Bonjour, dovreste
mettervi al sicuro da quel tizio.»
«Desiderate solo salvarvi la pelle.»
Quella sarebbe stata la cosa più saggia da fare, suppongo, ma l'autoconservazione non era il mio primo pensiero. Nello scintillio dei suoi occhi
avevo scorto un'innegabile libertà di spirito verso cui, dal primo istante,
provavo un'incredibile attrazione. L'unico difetto del suo volto liscio era
una cicatrice - o, per essere più precisi, una sorta di ammaccatura - che le
attraversava le labbra in senso verticale, allungandosi sopra e sotto la bocca e formando una croce incantevole con il suo sorriso.
«Avanzano in fretta!» annunciò dall'alto una voce in francese. Hartwick
correva verso il suo padrone con un cannocchiale allungato in mano.
«Ci hanno trovati!» urlò Dupin. «Montate in carrozza!»
A quanto sembrava, alcuni dei suoi amici meno cordiali erano venuti a
cercarlo. Tutto il gruppetto si scagliò verso la vettura.
«Sbrigatevi, idiota, basta con le chiacchiere!» mi esortò Dupin, superandomi.
Vidi Hartwick, in piedi vicino al veicolo, cadere a terra al suono di uno
sparo, incespicando con goffaggine tra le rocce. Aveva fatto per gridare:
«Dupin», ma la parola gli era morta in gola. Quando uno degli altri lo rigirò sul fianco, constatammo che aveva perduto un orecchio, sostituito da un
cerchio rosso scuro.
Mentre i miei occhi registravano quell'orrore, e il sentiero verso la vettura diveniva più ripido, inciampai e ruzzolai giù per il fianco del fossato.
Suppongo che sarebbe potuta sembrare una mossa strategica, finalizzata a
separarmi dai miei rapitori. In realtà, era stata la vista della pistola estratta
dal barone Dupin a farmi perdere l'equilibrio. Bonjour fece una deviazione
per riacciuffarmi.
«Lascialo!» le ordinò Dupin. Poi, a me: «Forse, la prossima volta, ci incontreremo in un luogo più adatto ai nostri interessi comuni, senza tanto
trambusto! Nel frattempo andate a cercare la gloria, carissimo Quentin!».
Sì, lo so. Ai lettori parrà bizzarro che Dupin abbia pronunciato quelle
frasi mentre si arrampicava su per la scarpata sotto il fuoco nemico subito
dopo l'uccisione del suo fidato scagnozzo, ma sto solo raccontando come si
sono svolti i fatti.
Allungai la testa per guardare. A un tratto mi sentii agguantare e trascinare con forza verso il basso. Il mio corpo si afflosciò, e quando alzai gli
occhi, vidi che Bonjour mi era saltata addosso e mi teneva per un braccio.
Immaginando che Hattie mi guardasse, e avvertendo una fitta di rimorso e
tentazione, cercai di divincolarmi, ma invano. Non potei fare a meno di
rabbrividire dinanzi alla leggerezza ma anche all'immobilità del suo corpo.
«State giù» disse. «Anche dopo che me ne sarò andata. Capito?»
Annuii.
Quindi si rialzò e seguì il barone verso il veicolo senza voltarsi. I cavalli
si lanciarono lungo il sentiero tra le fortificazioni. Dopo qualche istante,
un'altra carrozza passò fra uno strepito di ruote e zoccoli. Esplosero altri
colpi in direzione dei fuggiaschi. Mi coprii il capo con le braccia e non mi
mossi mentre le schegge di roccia mi piovevano addosso da tutte le parti.
La mia liberazione avvenne per opera di alcuni turisti tedeschi che giunsero su una vettura a nolo per ammirare le fortificazioni e furono tanto
gentili da permettermi di tornare a Parigi con loro.
Naturalmente, una parte di me voleva correre subito da Duponte e riferirgli l'accaduto. Ma sarebbe stato inutile. Se l'incontro con Dupin mi aveva insegnato qualcosa, era che tutta la questione era ingarbugliata. Il vero
analista si rifiutava di aiutarmi in cambio di qualsiasi somma, e un ciarlatano come il «barone» era fin troppo ansioso di fingersi disposto ad aiutarmi per poco denaro. Tanto valeva non vedere mai più Auguste Duponte.
Constatai che il cicerone di Versailles aveva ragione riguardo ai controlli
effettuati dalla polizia sul mio domicilio parigino. Poco dopo quell'episodio, la mia riserva di contanti si ridusse, e mi trasferii in una pensione meno costosa. Al mio arrivo, trovai due gendarmi assai compiti che mi aspettavano per registrare il mio nuovo indirizzo.
Soltanto due giorni dopo, mentre mi facevo lucidare gli stivali, mutai pa-
rere riguardo alla decisione di evitare Duponte. Con il tipico garbo francese, il proprietario del negozio mi aveva fatto un lieve inchino, avvisandomi
che avevo le calzature impolverate. Avevo preso un giornale, e giacché vi
era un grande specchio proprio dietro la panca, l'uomo poteva vedere la
pagina mentre lavorava. Avevo sentito dire che, nel corso degli anni, alcuni lustrascarpe parigini avevano imparato a leggere al contrario per ingannare la noia. Non credevo che qualcuno potesse acquisire la capacità di
comprendere le parole capovolte. Almeno non fino a quel giorno.
Sfogliai velocemente il quotidiano, ma fui interrotto da quel tale.
«Tornate indietro di una pagina, gentile monsieur. Claude Dupin è di
nuovo a Parigi? Qui viene braccato con maggiore accanimento di un animale nella foresta. O almeno, così si mormora.»
A quelle parole, girai i fogli fino a un articolo sconcertante, un annuncio
a pagamento:
Il celebre avvocato e procuratore legale Claude Dupin, che non
ha mai perduto una causa nella sua carriera, è stato ingaggiato
da alcuni dei più eminenti cittadini americani [suppongo si riferissero a me] per risolvere il mistero che avvolge la morte di Edgar A. Poe, il brillante creatore di molte opere letterarie, amatissimo in quel Paese. Claude Dupin è inoltre l'ispiratore e l'omonimo del famoso personaggio «Dupin», protagonista di alcuni
racconti del signor Poe, tra cui Les crimes de la Rue Morgue, assai conosciuto sia in inglese sia in francese. Sentendosi in dovere
di onorare quel legame, Claude Dupin è partito per gli Stati Uniti, ed entro due mesi esatti da oggi, nell'anno 1851, avrà appurato
le oscure circostanze della scomparsa di Poe in maniera inconfutabile e definitiva. Monsieur Dupin rientrerà a Parigi, la sua città
natale, dove sarà festeggiato e ricompensato generosamente come nuovo eroe del Nuovo Mondo...
Sentii un nodo alla gola. Dovevo andare immediatamente da Duponte.
Non potevo abbandonare il continente lasciando Duponte nella convinzione che l'avessi tradito ingaggiando Claude Dupin, come avrebbe
senz'altro concluso se avesse letto quel comunicato. Anzi, non avrebbe potuto fare a meno di collegare la faccenda a me. Persino alcune delle frasi
pubblicate nel giornale erano mie, giacché il barone le aveva copiate diret-
tamente dalle mie lettere. Speravo solo che Duponte non avesse veduto
l'annuncio. Chiesi al vetturino di condurmi al suo alloggio e varcai il cancello di corsa, oltrepassando la guardiola.
«Ehi, voi! Fermo!» Il custode fece per colpirmi, ma mi mancò. Salii i
gradini due alla volta. Trovai l'uscio di Duponte spalancato, ma nessuno
all'interno.
Il lume a gas sopra il letto odorava come se l'avesse spento da poco, e al
centro del materasso vi era un quotidiano. Era «La Presse», un giornale diverso da quello che avevo letto dal lustrascarpe, ma era aperto sul medesimo annuncio. Altri oggetti, documenti e articoli erano stati spinti in fondo
al letto. Immaginai che Duponte si fosse seduto con lentezza, liberando la
superficie perennemente ingombra della trapunta con una mano e stringendo la pagina nell'altra, con gli occhi colmi di... cosa? collera? amarezza?...
mentre apprendeva del reclutamento del barone Dupin. Mi aveva già accusato di tradimento.
«Monsieur!» Il portiere si era materializzato sulla soglia.
«Voi! Non voglio sentire una sola parola!» urlai, infervorato dalla rabbia
che provavo verso il barone. «Lascerò Parigi oggi stesso, ma devo prima
trovare Auguste Duponte e lo troverò. Ditemi subito dove è andato, altrimenti dovrete vedervela con me!»
Scrollò il capo in segno di diniego, e per poco non gli sferrai un pugno
prima che si spiegasse. «Non è qui» ansimò. «Monsieur Duponte è partito,
con i suoi bagagli.»
Dopo qualche altra domanda, scoprii che solo pochi minuti prima il custode aveva aiutato Duponte a portare le valigie in cortile. Questo dopo
che Duponte aveva letto il velenoso comunicato del subdolo barone. Il tradimento di cui si era senz'altro ritenuto vittima l'aveva gettato in una depressione così profonda che non era più riuscito a restare nel suo appartamento. Prima di scendere, guardai fuori delle finestre alla ricerca di eventuali segni della sua presenza.
Una carrozza con il tetto carico di bagagli si stava allontanando dalla
pensione. Gridai invano al vetturino di fermarsi, ma potei solo alzare mollemente le mani mentre imboccava la strada. Che sorpresa quando non trovai traccia della mia vettura e del mio cocchiere, cui avevo ordinato di aspettare! Infuriandomi per quell'ultimo insulto, mi stupii vedendo il veicolo di Duponte che tornava indietro... e di notare che non era affatto il veicolo di Duponte; insomma, lui sedeva all'interno, e i suoi bagagli vacilla-
vano in cima, sicché adesso era suo, ma prima era stato mio.
I cavalli si arrestarono pesantemente dinanzi a me.
«Volevo solo girare la carrozza per andarcene più in fretta, monsieur»
mi disse il vetturino «in modo da non perdere tempo.» Smontò e aprì lo
sportello sul lato libero, ma prima dovevo vedere Duponte. Girai intorno al
veicolo e spalancai il battente. L'analista sedeva immobile con lo sguardo
fisso. Che le false rivendicazioni del barone Dupin sul personaggio di C.
Auguste Dupin l'avessero finalmente colpito come non erano riusciti a fare
i miei allettamenti e le mie ricompense?
«Monsieur Duponte, questo significa... che voi...?»
«Arriverete in ritardo per il treno, signori» gridò il cocchiere. «Perderete
la nave. Salite, salite!»
Duponte assentì. «È giunto il momento» affermò.
Capitolo 10
L'Humboldt, il piroscafo della Cunard diretto in America, ospitava un
equipaggio di sessantotto persone tra ufficiali e marinai nonché un numero
di alloggi (anguste cabine cui si accedeva dai lati della sala principale, ricca di lussuosi tappeti) sufficiente per oltre cento passeggeri. Vi erano anche un labirinto di locali accessori (i salotti, la biblioteca e le sale da fumo)
e i recinti coperti per il bestiame.
Io e Duponte eravamo stati tra i primi viaggiatori a salire su quel palazzo
galleggiante e, guardando l'enorme nave che ci avrebbe condotti nel Nuovo Mondo, mi ero sentito pervadere dalla trepidazione. Duponte si immobilizzò appena raggiunse il ponte superiore. Mi raggelai anch'io. Immaginai che fosse stato assalito da un dubbio improvviso, da una premonizione,
e che avesse cambiato idea riguardo alla traversata.
«Monsieur Duponte?» dissi con sollecitudine, sperando di sembrare servizievole. «Tutto bene?»
«Monsieur Clark, pregate l'assistente di bordo di riferire al capitano che
vi è un clandestino su questa nave. Armato» rispose, prendendomi per il
gomito.
La mia ansia si dissolse in puro stupore. Quando ebbi ritrovato la tranquillità necessaria, chiesi un colloquio con l'assistente di bordo in un angolo appartato.
«Signore, vi è un clandestino sulla nave» sussurrai con concitazione
«probabilmente armato.»
Chinò la fronte verso di me senza mostrare alcuna preoccupazione.
«Come fate a saperlo?»
«Che importanza ha?»
«Abbiamo già controllato le stive e le cabine, signore, come sempre.
Avete veduto qualcuno a bordo?»
«No» risposi. «Ci siamo appena imbarcati.»
Annuì, convinto di aver dimostrato la sua tesi.
Guardai Duponte dall'altra parte del ponte. Non potevo deluderlo così
presto, non dopo tutti gli sforzi che avevo dovuto compiere per persuaderlo. Volevo avesse l'impressione che ogni suo desiderio venisse esaudito
appena espresso. «Signore, sapete qualcosa del raziocinio?» domandai
all'assistente.
«Sì. È un mostro marino, signore, con seicento zampe e la schiena curva.»
Lo ignorai. «È la rara dote di conoscere, mediante un processo di ragionamento che non usa soltanto la logica, ma che sfrutta anche quella superiore, ovvero l'immaginazione, quanto è al di fuori delle capacità intellettive di quasi tutti gli individui normali. Sulla nave vi è un clandestino armato e assai pericoloso, ve lo assicuro. Vi suggerisco di informarne il capitano al più presto e di controllare con maggiore attenzione.»
«Avrei dato un'altra occhiata comunque» replicò in tono altezzoso, incamminandosi con deliberata lentezza.
Qualche minuto dopo chiedeva, o meglio strillava, al suo superiore di
recarsi nel locale della posta. Di lì a poco lui e il vecchio capitano atticciato trascinarono sul ponte un uomo che urlava e si dimenava.
Il furfante spinse i gomiti all'infuori, liberandosi e mandando l'assistente
dritto per terra. I pochi passeggeri che gironzolavano qua e là si allontanarono di corsa, temendo per la loro vita, o almeno per i loro gioielli. Altri,
tra cui me e Duponte, si raggrupparono per osservare la scena. Vi fu un attimo di silenzio quando il capitano si parò dinanzi all'intruso.
«Cercavate di rubare la posta?» abbaiò. Il nostro piroscafo, come quasi
tutti quelli che attraversavano l'oceano, arrotondava in gran parte le sue risorse finanziarie trasportando la corrispondenza.
Per un istante, il clandestino, robusto e con le guance arrossate, sembrò
un fantasma arrivato da un altro mondo. Forse, guardandolo, il capitano
ebbe la medesima impressione, perché levò le mani in un gesto conciliatorio. «Calma» disse.
«Prima o poi desidererete sapere quello che so io!» lo ammonì la cana-
glia, guardando oltre il suo interlocutore, verso i passeggeri, come se stesse
valutando chi di noi prendere come prigioniero. Indietreggiammo tutti di
un passo, a eccezione di Duponte.
Il capitano non reagì a quella dichiarazione, ma quello stolto dell'assistente si lasciò incuriosire dal bluff. «Che cosa sarebbe?» domandò. «Che
cosa mai saprete voi?» L'uomo scivolò su alcune tavole bagnate, e gli altri
due tornarono alla carica, sopraffacendo la loro vittima. Dopo alcuni goffi
tentativi, lo sollevarono oltre la murata tra le acclamazioni di qualche
viaggiatore.
Il capitano si sporse oltre il fianco della nave e osservò il malintenzionato, la cui calvizie scintillava ormai sotto il sole perché il cappello gli era
volato via. Mi precipitai anch'io verso il parapetto e rimasi a guardare per
un bel pezzo. Non potei fare a meno di provare un poco di compassione
per quel manigoldo impaurito che agitava le braccia e le gambe. Il capitano, credendo che fosse stato il membro dell'equipaggio a fare la scoperta,
strinse la mano del suo sottoposto, forse con più calore di quanto avesse
mai fatto prima.
Qualche ora più tardi, dopo che avemmo preso il largo, l'assistente mi
sorprese da solo e mi chiese con impertinenza: «Come diavolo facevate a
saperlo?».
Tacqui.
«Come diavolo faceva qualcuno a sapere che vi era un clandestino dopo
essere appena salito in coperta? Come è possibile? Come vi siete procurato
questo ran-zion-ci-nio?»
Avrebbe attuato la sua meschina vendetta assegnando a me e a Duponte
i posti peggiori a tavola. Quel giorno non riuscii tuttavia a trattenermi dallo
sfoderare un sorriso beffardo, che ricomparve ogni volta che lo incrociai
durante tutte e tre le settimane della traversata verso l'America.
Libro terzo
Baltimora, 1851
Capitolo 11
Raziocinio, s. m., atto del ragionare in maniera intenzionale e calcolata mediante l'intelletto e l'immaginazione; osservazione e previsione minuziosa della complessità dell'attività umana, e in particolare della frequente semplicità di tale attività. Termine non in-
tercambiabile con il mero «calcolo» o la mera «logica».
All'inizio, mi sforzai di evitare qualunque errore potesse deviare il percorso del raziocinio di Auguste Duponte (quella riportata sopra è la mia
definizione, che Webster e altri editori potrebbero usare per correggere le
loro, e che compilai osservando Duponte durante il nostro viaggio transatlantico). Volevo aiutarlo senza essergli d'intralcio. Avevo tuttavia commesso il mio primo sbaglio molto prima che cominciassimo.
Sedevo di fronte a lui nella mia biblioteca la terza mattina dopo il nostro
arrivo a Baltimora. Aveva scelto la poltrona più comoda. Vidi l'analista in
uno stato di assoluto riposo. Dire «riposo» evoca un'impressione erronea,
perché si teneva costantemente impegnato. I suoi sforzi erano tuttavia calmi e pacifici.
Aveva letto tutti gli articoli che avevo raccolto riguardo alla morte di
Poe. Gli avevo fornito anche altro materiale sul poeta: incisioni, note biografiche tratte da riviste e quotidiani, nonché la mia corrispondenza personale con l'autore. Sfogliava le pagine come il governatore di uno Stato sfogherebbe il giornale a colazione, stringendole con tanta forza da indicare di
averne il pieno controllo.
Quel giorno, quando si avvide della mia presenza dall'altro lato della
stanza, fece un movimento così fulmineo della testa che mi aspettai quasi
di sentirlo esporre la sua teoria sulla morte di Poe.
«Mi servirà il resto» dichiarò.
«Sì.» Esitai. Credetti di aver compreso la sua richiesta e la madornale
svista da cui era scaturita, ma non volevo sembrare scoraggiante. «Monsieur Duponte, a giudicare dalle farneticazioni della stampa, è improbabile
che siano stati pubblicati molti altri pezzi sul decesso di Edgar Poe.»
Mi porse il mio taccuino, quindi diede dei colpetti alla grande cartella
colma di ritagli. «Monsieur Clark, non necessito soltanto di questi articoli,
ma anche dei giornali da cui provengono. E magari dei numeri di quei
giornali usciti la settimana precedente e seguente ciascun pezzo.»
«Ma, ogni volta che mi è stato possibile, ho esaminato l'intera pubblicazione alla ricerca del più piccolo riferimento al poeta, persino la semplice
menzione del suo nome nel trafiletto più nascosto. Vi assicuro che questi
erano tutti gli articoli reperibili riguardo a Poe.»
«Idiota!» sbottò, sospirando.
È impossibile capire questo aspetto di Duponte senza conoscerlo di persona, immagino, ma mi ero abituato alle frequenti esclamazioni di quel
genere, e non mi parevano più offensive.
«I ritagli non sono sufficienti, monsieur. Ciò che circonda le informazioni è prezioso quanto le informazioni stesse. Saltate i temi che fanno battere il cuore del popolino per l'emozione... Leggete tutto all'infuori di quelli, e apprenderete molte cose. Avete sacrificato gran parte dei ragguagli di
ogni articolo separandolo dalla sua pagina» continuò.
A essere sincero fino in fondo, trovavo difficile dissimulare l'impazienza
dinanzi alla flemma di Duponte. Avrei dovuto prevederla, suppongo. Poe
aveva descritto i ritmi di un'intelligenza tanto sofisticata. Nei suoi racconti,
C. Auguste Dupin esamina con meticolosità i servizi giornalistici relativi
ai diversi crimini prima di tentare di risolvere i vari casi.
Nella sequenza temporale, era tuttavia quella la differenza tra i racconti
letterari di Poe e la nostra impresa: noi non eravamo soli. In un recesso
della mia mente, vi era sempre l'immagine spettrale del mio rapitore, Dupin (rileggendo quest'ultima frase, mi rendo conto di non dover scrivere
«Dupin» in quel modo, altrimenti penso automaticamente al C. Auguste
Dupin delle storie di Poe. A costo di consumare più inchiostro, opterò per
«Claude Dupin» o «barone Dupin»). Talvolta credevo addirittura di intravedere il suo sorriso beffardo oltre la finestra aperta di un edificio o tra la
folla di Baltimore Street. Il barone era davvero venuto in America, oppure
il suo annuncio era stato una montatura per depistare i creditori parigini?
Cominciai a raccogliere tutti i giornali che Duponte mi aveva chiesto.
L'imponente sede del «Baltimore Sun» era stata la prima struttura in ferro
della città. Sebbene alcuni giudicassero bellissima quella costruzione di
cinque piani, «bellissima» non era l'aggettivo adatto. Maestosa: ecco che
cosa veniva in mente attraversando la redazione, con i torchi e le macchine
a vapore che ronzavano nel seminterrato e il crepitio dei telegrafi che filtrava dal soffitto. Ci si trovava al centro di qualcosa di solenne, qualcosa
che era stato preteso dalla massa dei nostri cittadini.
Visitando anche i concorrenti del «Sun», ossia il «Patriot» e
l'«American» (due quotidiani whig), il «Clipper» e il «Daily Argus» (giornali noti per le loro inclinazioni democratiche), a poco a poco procurai a
Duponte tutti i particolari divulgati dalla stampa di Baltimora. Quindi mi
avviai verso la biblioteca per rintracciare i dati provenienti da altri Stati ed
eventuali nuovi articoli su Poe.
Non avevo ancora avvertito Hattie e Peter del mio rientro. Zia Blum a-
veva proibito alla nipote di scrivermi per il resto del mio soggiorno a Parigi. Nelle sue ultime lettere, Peter aveva accennato di rado a Hattie o a
qualsiasi altra faccenda interessante, ma aveva menzionato alcune delicate
questioni di lavoro di cui avrebbe voluto discutere con me. Avevo un intenso desiderio di rivedere entrambi. Ma era come se il mondo estraneo al
mio rapporto con Duponte fosse sospeso, come se fossi intrappolato in un
universo costituito solo dalla mente e dalle idee di Duponte e non potessi
tornare nella mia dimensione abituale fintantoché non avessi portato a termine il mio compito.
Pur essendomi trattenuto all'estero solo per pochi mesi, notai con chiarezza ciascuno dei cambiamenti subiti da Baltimora. La metropoli cresceva
di giorno in giorno, o almeno così sembrava. Vi erano scale, travetti, calcinacci e arnesi da costruzione disseminati ovunque. Magazzini di cinque
piani avevano superato i palazzi antichi. Tutto ciò che era nuovo fiammante, come la polvere dei cantieri edili, proiettava un pallore opaco sulla città.
Ma vi era qualcos'altro, anche se non saprei come definirlo. Un fermento.
Una cupa impazienza. Era questa la sensazione che provavo camminando
per le strade.
Nella sala di lettura, mi accomodai a un tavolo con il mio taccuino e aprii un giornale. Studiai le colonne, soffermandomi più volte su accadimenti di rilievo che si erano verificati durante la mia assenza. Poi lo vidi. Il
mio cuore accelerò per... lo stupore, l'euforia, la paura. Non avrei saputo
dire quale dei tre. Passai al quotidiano successivo, quindi a un terzo. Non
vi era solo un accenno fortuito nelle ultime pagine di un periodico. No! Vi
erano accenni dappertutto. Ogni giornale conteneva un articolo sulla morte
di Poe. Vi erano ancora molti dettagli da appurare riguardo alle misteriose
circostanze della scomparsa del poeta, scriveva il «Clipper».
Il principale argomento di conversazione negli ambienti letterari
è la dipartita di quell'uomo melanconico, Edgar A. Poe. Nel complesso, era un tipo eccentrico e inquietante.
I pezzi non contenevano quasi alcun fatto concreto. Piuttosto, ciascuna
pagina era come uno strillone che annunciava all'infinito un'impiccagione
sensazionale senza precisarne le ragioni.
Mi precipitai verso la parte anteriore della stanza, dove sedeva l'anziano
bibliotecario. Un altro frequentatore della sala di lettura era in piedi dinanzi alla scrivania, ma giacché non stava parlando con il vecchio, mi sentii
libero di passargli davanti.
«Che cosa sono tutti questi servizi su Edgar Poe? Com'è capitato?» domandai.
«Signor Clark» replicò quello con un'espressione assai incuriosita «siete
stato via a lungo.»
«Mio buon signore, fino a pochi mesi or sono non vi era quasi alcun interesse per la morte di Edgar Poe» osservai. «Ora ne parlano le pagine di
ogni giornale.»
Stava per rispondermi, quando fummo interrotti.
«Già, già!»
Ci voltammo entrambi verso il tale che avevo sgarbatamente superato.
Era un tizio corpulento con le sopracciglia ispide. Si soffiò il grosso naso
con un fazzoletto prima di proseguire.
«L'ho letto anch'io» aggiunse in tono amichevole, dandomi di gomito
come se avessimo appena fiutato dalla stessa tabacchiera.
Gli rivolsi un'occhiata vacua.
«Della scomparsa di Poe» spiegò. «Non è un fatto meraviglioso?»
Lo studiai. «Meraviglioso?»
«Certo» confermò con aria sospettosa. «Considerate Poe un genio, signore?»
«Del massimo grado!»
«Pensate senz'altro che non esista prosa migliore al mondo dello Scarabeo d'oro?»
«Soltanto Una discesa nel Maelstrom» affermai.
«Be', allora è meraviglioso che riceva finalmente l'attenzione di cui è
degno dai direttori dei giornali, vero? Il triste e doloroso trapasso di Poe,
intendo.» Si accomiatò dal bibliotecario sfiorandosi il cappello prima di
uscire.
«Orbene, dicevate... che cosa vi ha colpito tanto?» mi domandò il vecchio.
«I giornali, perché...» I miei pensieri si smarrirono nel ricordo di quanto
aveva appena asserito l'altro uomo. Indicai la porta. «Chi era quel signore?»
Il bibliotecario non lo sapeva. Mi scusai e corsi fino all'angolo di Saratoga Street, ma non vi era traccia dello sconosciuto.
Ero così stupito da quell'insieme di fenomeni (i quotidiani, il bizzarro
appassionato di Poe, l'impazienza che sembrava essere calata sulla città)
che, sulle prime, non feci molto caso a una donna dalle guance paffute e
dai capelli color argento, seduta su una panchina non troppo distante dalla
biblioteca. Leggeva un libro di poesie di Edgar A. Poe. Da quel punto di
vista, devo ammetterlo, godevo di un notevole vantaggio. Avendo acquistato ogni volume pubblicato delle opere del mio autore preferito, ero in
grado di riconoscere le edizioni da lontano grazie a piccoli dettagli esteriori, per esempio la grandezza o le incisioni che ornavano ciascun tomo.
Suppongo che la mia vanteria debba essere ridimensionata dal modesto
numero di collezioni esistenti. Poe non amava le poche che erano state date
alle stampe. «Gli editori sono degli imbroglioni» si era lamentato in una
lettera. «Essere controllati equivale a essere rovinati. Voglio essere l'editore di me stesso.» Ma non ci sarebbe riuscito. Le sue finanze erano dissestate, e i periodici erano sempre stati avari nel retribuirlo per i suoi scritti.
Mi fermai accanto alla panchina, osservando la signora che voltava le
pagine macchiate e sgualcite infilandovi il dito in mezzo. Era tanto assorta
nel finale del racconto, nel sublime crollo della Rovina della casa degli
Usher, che non mi notò. Prima che me ne accorgessi, aveva chiuso il tomo
con un'espressione assai soddisfatta e si era allontanata in tutta fretta, come
se fuggisse dalle rovine sgretolate degli Usher.
Decisi di interrogare un libraio dei dintorni per vedere se avesse seguito
il nuovo dibattito pubblico su Poe. Era uno dei venditori meno inclini a riempire i suoi scaffali con scatole di sigari, ritratti di indiani e oggetti che
non fossero libri, abitudine ormai diffusa tra quella categoria di negozi,
giacché un numero sempre maggiore di persone comprava volumi per abbonamento. Ero fermo nel vestibolo, quando scorsi un'altra donna, intenta
a commettere un crimine tra i più singolari.
Era in piedi su una delle scale usate per esaminare i ripiani più alti. Il
crimine, se così si può chiamare, non consisteva nel rubare un volume, il
che sarebbe stato già di per sé alquanto bizzarro e degno di nota, bensì nel
collocare sulla mensola un libro estratto dalle pieghe del suo scialle. Quindi salì sul piolo successivo per aggiungere un altro tomo alla raccolta del
negozio. La sua sagoma era oscurata dai raggi che filtravano attraverso
l'ampio lucernario, ma notai che indossava un cappello e un vestito elegante; non era una delle farfalline pacchiane che passeggiavano in Baltimore
Street. Intravidi una striscia di pelle dorata in corrispondenza del collo, e
un'altra all'altezza del polso, dove terminava il guanto. Scese dalla scala e
percorse una fila di scaffali. Camminai parallelamente lungo il corridoio
attiguo e la trovai ad aspettarmi in fondo.
«Fissare qualcuno è da maleducati» disse in francese, corrucciando le
labbra attraversate da una cicatrice.
«Bonjour!» La mia ex carceriera della fortezza di Parigi, la complice del
barone Dupin, era in piedi dinanzi a me. «Vi porgo le mie scuse. Vedete,
talvolta cado in una sorta di trance.» Ma quello non era stato uno dei miei
attimi di estraniamento. La sua bellezza micidiale era tornata subito ad
ammaliarmi, e guardai altrove per sottrarmi al suo potere. «Che cosa stavate facendo?» bisbigliai dopo essermi ripreso.
Sorrise come se fosse ovvio.
Salii qualche piolo della scala su cui l'avevo veduta arrampicarsi ed estrassi il volume che aveva posato sul ripiano. Era un'edizione dei racconti
di Poe.
«È il contrario della mia consuetudine. Portare oggetti preziosi in un
luogo.» Rise con allegria infantile a quell'idea. Quando sorrideva, assomigliava a una bambina, soprattutto ora che aveva i capelli più corti.
«Preziosi? Questi sono preziosi solo per i lettori in grado di apprezzare
Poe» ribattei. «E perché metterli così in alto, dove sono difficili da vedere?»
«La gente ama allungare le mani verso le cose, monsieur Quentin» disse.
«L'avrete fatto dietro ordine del barone Dupin. Dov'è?»
«Ha intrapreso la missione di indagare sulla morte di Poe» rispose. «E la
concluderà con un trionfo.»
Mi pulsava la testa. «Il barone non c'entra nulla con quella faccenda!
Non c'entra nulla qui!»
«Consideratela una svolta propizia» replicò, criptica.
«Non considero propizio il fatto che il barone Dupin usi una questione
così seria per divertirsi.»
«Se non altro ha trovato un'attività più proficua della vostra uccisione.»
«La mia uccisione? Questa è bella!» Cercai di sembrare sprezzante.
«Perché dovrebbe uccidermi?»
«Quando gli avete scritto quelle lettere, vi siete dilungato sulla necessità
impellente di far luce sulla dipartita dell'amatissimo signor Poe. "Il più
grande genio noto alle riviste letterarie americane, che piangeremo all'infinito e per sempre" e via discorrendo.»
Era una descrizione fedele delle mie opinioni.
«Immaginate la sorpresa del barone, allora, quando siamo giunti qui a
Baltimora qualche settimana fa. Nessuna donna che si disperava a causa
dell'autopsia del povero Poe. Nessuna sommossa che chiedeva giustizia
per il poeta. Pochissime delle persone che abbiamo interpellato sapevano
con esattezza chi fosse Edgar Poe a parte l'autore di alcune fantasie volgari
e stravaganti. Anzi, quasi nessuno era al corrente che monsieur Poe fosse
passato a miglior vita.»
«È vero» ammisi in tono di sfida. «Molti individui, mademoiselle, guardano il genio con gelosia e indifferenza, e Poe era un bersaglio perfetto per
via della sua unicità. E con ciò?»
«Il barone Dupin era venuto qui per soddisfare la curiosità riguardo alla
morte di Poe. E qui non vi era alcuna curiosità!»
Tacqui. Suppongo di non essere riuscito a condannare la frustrazione del
barone perché ne avevo provata una identica.
«Avrà incolpato me» borbottai.
«Be', non illudetevi che il mio padrone si sia sentito molto indulgente
nei vostri confronti. Anzi, scoprendo che avevamo affrontato un viaggio
tanto lungo e costoso per nulla, si è adirato molto, e molto in fretta.»
Credo di aver manifestato una certa apprensione, perché sorrise.
«Nulla da temere, monsieur Quentin» mi tranquillizzò. Chissà come, il
suo sorriso mi impaurì ancora di più. Forse dipendeva dalla cicatrice che le
divideva la bocca in due. «Non penso che siate in pericolo... per il momento. Senza dubbio, da allora, avrete notato che cosa è accaduto alla notorietà
di Poe nella vostra città.»
«Sui giornali, intendete?» Cominciai a mettere insieme i tasselli. «Ci siete voi dietro tutto questo?»
Mi spiegò ogni cosa. Dapprima il barone aveva pubblicato annunci in
tutti i quotidiani di Baltimora, offrendo generose ricompense in cambio di
«informazioni salienti» sulla «misteriosa e infelice scomparsa» del poeta
Poe. Non aveva sperato che gli eventuali testimoni si facessero subito avanti. Piuttosto, le inserzioni erano servite al loro vero scopo: suscitare
scalpore. Fiutando lo scoop, i direttori dei giornali avevano seguito quella
pista. Ora i lettori chiedevano a gran voce altre delucidazioni su Poe.
«Contribuiamo a stimolare l'immaginazione del pubblico» proseguì
Bonjour. «Credo che ora i libri di Poe andranno a ruba.»
Ripensai alla donna sulla panchina... al fanatico di Poe nella sala di lettura... e ora a Bonjour che disseminava volumi affinché altre persone li
trovassero.
Si voltò per andarsene, ma la afferrai. Se qualcuno avesse veduto la mia
mano stretta intorno al polso guantato di una giovane donna, sarebbe scop-
piato un piccolo scandalo che sarebbe subito giunto alle orecchie della zia
Blum con la rapidità di un telegramma. A Baltimora, le fredde brezze del
Nord incontravano la rigida etichetta del Sud e i pettegolezzi che la accompagnavano.
Era stato un duplice impulso a indurmi a ghermirle il polso. Primo, ero
stato stregato ancora una volta dalla sua avvenenza incurante, così strana
nella nuova cornice di Baltimora, così diversa dal consueto aspetto delle
ragazze del posto, che parevano appena uscite da una rivista femminile.
Secondo, forse aveva già scoperto qualcosa riguardo alla morte di Poe.
Terzo (giacché suppongo che quell'impulso debba essere definito triplice),
sapevo che, a Parigi, toccare la mano di una signora era un gesto di poco
conto, e questo mi aveva infuso coraggio. Ma i suoi occhi mi fulminarono,
e ritrassi subito il braccio.
Mi risulta difficile descrivere la sensazione che mi pervase quando sfiorai quella donna, anche se solo per un istante. Fu la sensazione di poter essere trasportato da un momento all'altro in qualsiasi luogo del mondo, nella
vita di chiunque, come se non fossi più costretto nel mio corpo. Fu una
sensazione spirituale, in un certo senso, quasi fossi leggero come una stella
del cielo.
Con mia sorpresa, appena la lasciai, le sue mani schizzarono verso le
mie tra gli scaffali e me le strinsero con molto più vigore di quanto io avessi trattenuto lei. Non riuscii a liberarmi, e rimanemmo uno dinanzi
all'altra per un lungo attimo.
«Signore! Lasciatemi, per favore!» strillò con voce indignata, verginale.
Il suo grido attirò gli sguardi curiosi dei clienti della libreria, a ogni tavolo e su ogni panchina. Dopo che ebbe allentato la stretta, cercai di simulare un normale interesse verso i volumi più vicini. Quando gli altri smisero di fissarmi, era già svanita. Mi precipitai sulla strada e la scorsi, la nuca
ora schermata da un ombrellino a righe.
«Fermatevi!» gridai, affrettandomi ad affiancarla. «So che le vostre intenzioni sono buone. Mi avete salvato dalla sparatoria alle fortificazioni.
Vi devo la vita.»
«Sembrava che voleste aiutarmi quando avete affermato che il barone mi
obbligava a servirlo. Mi è parso...» si infilò il labbro inferiore sotto i piccoli incisivi per cercare la parola giusta «... insolito.»
«Dovete sapere che questa è una faccenda troppo importante per scatenare la stampa periodica con tattiche da quattro soldi. Non ne verrà nulla di
buono. Il genio di Poe merita di più. Dovete smetterla subito.»
«Credete di poterci dissuadere dalla nostra missione con tanta facilità?
Ho letto qualche opera del vostro amico Poe. Sembra soprattutto che dica
cose semplici in maniera da renderle quasi incomprensibili, e cose banali
in una forma tanto enigmatica da farle suonare sibilline.» Si arrestò per un
secondo, guardandomi. Mi fermai anch'io. «Siete innamorato, monsieur
Clark?»
Mi ero distratto. Il mio sguardo indugiò poco distante, dove una donna
percorreva il marciapiede a lunghi passi. Era una signora sulla quarantina,
abbastanza attraente. I miei occhi la seguirono mentre procedeva lungo la
via.
«Siete innamorato, monsieur?» ripeté Bonjour con dolcezza, adocchiandola.
«Quella donna... L'ho veduta con Neilson Poe, il cugino di Edgar, sapete, e assomiglia moltissimo a...»
Non avrei voluto lasciarmelo sfuggire.
«Sì?» mi incoraggiò Bonjour. La gentilezza del suo tono mi costrinse a
finire la frase.
«A un ritratto di Virginia Poe, la defunta moglie di Edgar.» Il fatto era
che il solo vedere quella signora pareva avvicinarmi di più alla vita di Poe.
La folla mi coprì ben presto la visuale. Allora mi accorsi che Bonjour
non era più accanto a me. Guardandomi intorno, vidi che si stava accostando alla sconosciuta (alla sosia di Virginia Poe) e mi arrabbiai con me
stesso per averle fatto quella rivelazione.
«Signorina!» chiamò Bonjour. «Signorina!»
L'altra si girò. Rimasi in disparte, credendo che non mi avesse veduto alla centrale di polizia, ma preferendo evitare qualsiasi rischio.
«Oh, mi dispiace» si scusò Bonjour con un convincente accento meridionale che doveva aver imparato da alcune delle fanciulle udite in città.
«Assomigliate così tanto a una signora di mia conoscenza... ma mi sono
sbagliata. Forse è solo per via di quella graziosa cuffietta...»
L'altra abbozzò un sorriso cordiale e fece per voltarsi.
«Eppure assomigliava così tanto a Virginia!» insistette Bonjour, come se
parlasse tra sé e sé.
La donna si girò ancora. «Virginia?» chiese con evidente interesse.
Scorsi un'espressione compiaciuta sul viso di Bonjour, che aveva intuito
di aver raggiunto il suo scopo. «Virginia Poe» specificò, assumendo un'aria triste.
«Capisco» disse piano la signora.
«L'ho incontrata una sola volta, ma neppure le acque del Lete la cancelleranno dalla mia memoria» esagerò Bonjour. «Siete bella quanto lei.»
L'altra abbassò gli occhi al complimento.
«Sono la moglie di Neilson Poe» si presentò. «Josephine. Temo che nessuna sarà mai bella quanto la mia cara sorella quando era ancora in vita.»
«Vostra sorella, signora?»
«Sissy. Virginia Poe, intendo. Era la mia sorellastra. Era piena di fiducia
e coraggio persino nei momenti di maggiore debolezza. Ogni volta che vedo il suo ritratto...!» Tacque, incapace di continuare.
Questo spiegava tutto. Neilson aveva sposato la sorella della compianta
moglie di Edgar Poe. Dopo qualche parola di cordoglio, si avviarono insieme, e Josephine rispose sommessamente alle domande di Bonjour riguardo a Sissy. Le seguii per origliare.
«Una sera, mentre Edgar e Sissy vivevano felicemente a Filadelfia, in
Coates Street, la cara Virginia stava suonando il suo amato pianoforte,
quando le si è rotto un vaso sanguigno. Si è accasciata nel bel mezzo della
canzone. Abbiamo vissuto nel timore di perderla da un momento all'altro.
Soprattutto Edgar. Nell'inverno in cui è morta, erano così poveri che le uniche cose che la riscaldassero in quelle stanze gelide erano il cappotto di
Edgar e un gatto steso sul petto.»
«Che cosa ne è stato di suo marito da allora?»
«Di Edgar? Restare in bilico tra la speranza e la disperazione per così
tanti anni l'aveva fatto uscire di senno, credo. Necessitava della dedizione
di una donna. Diceva che non avrebbe resistito un altro anno senza un amore tenero e sincero. Si mormora che, dopo la dipartita di Sissy, sia corso
varie volte qua e là per il Paese alla ricerca di una moglie, ma penso che il
suo cuore sanguinasse ancora per lei. Si era fidanzato solo poche settimane
prima di morire.»
Scambiarono qualche altra parola prima che Josephine si allontanasse
con un saluto cortese. Bonjour si voltò verso di me con un risolino infantile. «Peccato che siate contro il barone in uno dei suoi complotti, monsieur
Clark. Vedete, noi non ci nascondiamo tra le ombre, indugiando sui piccoli
dettagli.»
«Mademoiselle, per favore! Qui, a Baltimora, in America, non dovete
mantenere il vostro rapporto con il barone e le sue macchinazioni! Io lo
abbandonerei subito. Qui non esistono vincoli!»
Sgranò gli occhi con interesse. «Non c'è la schiavitù?»
Era scaltra.
«Per l'appunto!» esclamai. «Non esiste alcun vincolo per una francese
libera. Non avete alcun dovere verso il barone.»
«Non ho alcun dovere verso mio marito?» ribatté. «Dovrò tenerlo a
mente.»
«Il barone... vostro marito?»
«Siamo a buon punto, e a partire da ora lavoreremo senza tregua. Se fossi in voi, monsieur Clark, non cercherei di ostacolarci.»
In qualunque parte del mondo vi rechiate, troverete lo stesso modesto
numero di specie d'avvocato, come un naturalista trova erbe ed erbacce in
ogni regione. Il primo tipo di avvocati considera le complessità delle norme legali come idoli, oggetti degni di una venerazione profonda e incrollabile. Esiste però un'altra classe di avvocati, una classe carnivora che caccia
le sue prede fra la prima varietà e che, invece, vede nelle norme il principale intralcio al successo.
Claude Dupin era un esemplare così rappresentativo della seconda categoria che il suo scheletro potrebbe essere appeso nella sezione di anatomia
comparata delle Tuileries. I codici legali erano l'arsenale che utilizzava per
ingaggiare le sue battaglie; erano le sue pistole e le sue sciabole, nulla di
più sacro. Quando si era trovato in condizioni di dover prendere tempo,
non aveva esitato a porre fine a un appuntamento o persino a un processo
sgattaiolando fuori da una finestra dell'anticamera. Quando quei metodi disonesti non erano bastati, aveva fatto ricorso a pistole e spade vere tramite
le sue reti di furfanti per procurarsi le informazioni o le confessioni necessarie. Il barone era un avvocato, sì, ma solo in via accessoria; era innanzi
tutto uno zelante impresario teatrale travestito da avvocato. Un imbonitore
sul suo palco, un istrione della legge.
Un giorno, durante il nostro viaggio transatlantico, Duponte mi aveva
raccontato la storia di Bonjour, sebbene avesse trascurato di accennare al
suo matrimonio. In Francia, mi aveva spiegato, esiste un tipo di criminale
denominato bonjourier che mette in pratica le sue criminose macchinazioni nel seguente modo: il ladro, vestito con eleganza, entra in una casa, oltrepassando i servitori come se fosse lì per un incontro importante, trafuga
qualunque oggetto gli capiti tra le mani ed esce dritto dal portone. Ma se
un domestico o un altro membro della famiglia lo nota fra l'ingresso e l'uscita, si inchina dicendo: «Bonjour!» e chiede del proprietario della dimora
vicina, di cui in precedenza si è premurato di sapere il nome. I servitori
pensano, naturalmente, che abbia sbagliato porta e lo accompagnano fuori
senza sospetti e con tutti i preziosi che è riuscito a rubare. La giovane che
avevo conosciuto alle fortificazioni era il migliore bonjourier di Parigi,
sicché era diventata famosa semplicemente come Bonjour.
Si diceva che fosse cresciuta in un villaggio rurale della Francia. Sua
madre, una svizzera, era morta qualche mese prima che compisse un anno.
Suo padre, un fornaio francese e un grande lavoratore, si era preso cura di
lei. Aveva però trascorso quasi tutte le notti a piangere, e la piccina si era
stancata ben presto del suo dolore inconsolabile. Ciò, insieme all'assenza
di un modello materno, aveva prodotto una ragazza focosa e indipendente
quanto un uomo. Di lì a poco il padre era stato arrestato e portato via sotto
i suoi occhi nel caos di una delle rivoluzioni meno violente del Paese. Bonjour si era trasferita a Parigi per vivere da sola ed era sopravvissuta grazie
alla sua intelligenza e alla sua forza fisica. Quando era ancora una ladra inesperta, aveva subito molte aggressioni, una delle quali le aveva procurato quella vistosa cicatrice sul viso.
«Ma come può accadere che una donna così incantevole continui a essere una comune ladra?» avevo domandato a Duponte una sera, mentre sedevamo al lungo tavolo del piroscafo.
Duponte aveva inarcato un sopracciglio alla mia domanda e, all'inizio,
era parso intenzionato a non rispondere. «Non ha continuato a fare la ladra,
in realtà, e non è mai stata comune. È da molti anni un'assassina di
prim'ordine. Si dice che, per via della sua precedente occupazione, abbia
l'abitudine di gridare: "Bonjour" prima di conficcare un coltello nella gola
di un uomo. Tuttavia, queste sono mere congetture, perché nessuno è
scampato per confermarlo.»
«Eppure, alle fortificazioni, è stata abbastanza femminile e coraggiosa
nei miei confronti» avevo osservato. «Credo che la povertà e la salute cagionevole generino simili lacune nel carattere delle donne.»
«Allora dev'essere stata assai povera» avevo replicato.
Un inverno, Bonjour, arrestata dalla polizia parigina dopo un furto improvvisato che si era concluso con l'omicidio di un tale nel suo salotto, aveva rischiato la pena di morte, perché le autorità volevano trasformarla in
un esempio per la categoria sempre più numerosa delle ladre. Il barone
Dupin, all'apice della sua fama, l'aveva difesa con alacrità. Aveva dimostrato con abilità che la polizia aveva commesso il madornale errore di vittimizzare Bonjour, una creatura delicata e angelica il cui aspetto fisico, l'esile corporatura da bambina e l'avvenenza avevano contribuito molto all'effetto generale sugli osservatori.
Ormai, dopo questo aneddoto, avrete capito come il barone si circondasse di furfanti fedeli. Quando ne otteneva la scarcerazione, come nel caso di
Bonjour, quelli contraevano un debito che saldavano con la lealtà. Penserete che sia una contraddizione, ma tutti hanno bisogno di regole per vivere,
e i criminali riescono a rispettarne solo alcune. La lealtà è quella che prediligono. Il barone era già stato sposato, ma, stando ai pettegolezzi, le sue
mogli erano state spinte da motivi che spaziavano dal semplice amore alla
grande agiatezza (in un periodo della sua vita). Lascio a voi decidere se
l'amore di Bonjour fosse nato con la sua lealtà, se uno avesse soppiantato
l'altra o se si fossero mescolati in una spietata combinazione.
Capitolo 12
A Glen Eliza, dopo avergli riferito tutto ciò che mi aveva detto Bonjour,
Duponte si limitò a commentare che i maneggi del barone Dupin avrebbero complicato la vicenda. Naturalmente, ero giunto alla medesima conclusione, e questo mi rendeva ancor più ansioso di continuare a seguire i frutti
della campagna di Claude Dupin che avevo cominciato a notare in città.
Ero spesso fuori per sbrigare delle commissioni, e Duponte sedeva quasi
sempre nella mia biblioteca. Di solito era taciturno. Talvolta, senza volerlo, mi ritrovavo a imitare la sua postura o l'espressione del suo volto, per
vincere la noia oppure nel tentativo di assicurarmi che il mio ospite fosse
davvero lì.
Un giorno, Duponte, impegnato a esaminare alcuni giornali, esclamò:
«Ah, sì!».
«Scoperto qualcosa, monsieur?» domandai.
«Ho ritrovato solo adesso il pensiero su cui rimuginavo ieri, mentre eravate fuori, quando è arrivata la vostra visitatrice.»
«Visitatrice?»
«Oh sì, la sua intrusione è stata estremamente fastidiosa e, che ci crediate oppure no, ho ripreso il filo del mio ragionamento soltanto ora.»
Vedendo che Duponte non intendeva aggiungere altro sull'argomento,
interrogai le cameriere. Non avevano pensato di informarmi dell'ospite
perché era stata ricevuta da Duponte. In realtà, come emerse dalle loro varie descrizioni, la donna in questione era zia Blum, comparsa con uno
schiavo che le teneva l'ombrello sopra la testa. Sebbene i domestici discordassero su alcuni dettagli, questo è il resoconto più accurato che riuscii a
ricostruire della conversazione verificatasi nella mia biblioteca.
Zia Blum: «Il signor Clark non c'è?».
Auguste Duponte: «Esatto».
ZB: «Esatto? Come sarebbe a dire, "esatto"?».
AD: «Avete indovinato. Il signor Clark non c'è».
ZB: «Ma io non... Voi chi siete, allora?».
AD: «Sono Auguste Duponte».
ZB: «Oh? Ma...».
AD: «Mademoiselle...».
ZB (allarmata dal francese): «Madem-mois...?».
AD (alzando lo sguardo per la prima volta): «Madame».
ZB: «Madame?».
AD (Duponte aveva detto qualcosa in francese che, nonostante una lunga riflessione, nessun servitore riuscì a rammentare e che purtroppo possiamo solo supporre.)
ZB (di nuovo allarmata): «Sapete di essere in America, signore?».
AD: «Ho notato che le persone posano i tacchi su sedie e tappeti, versano le uova nei bicchieri e sputano tabacco sulle vetrine. So di essere in
America, madame».
ZB: «Insomma... Voi chi siete?».
AD: «Sembra che la menzione del mio nome non vi sia servita ad alcunché prima. Benché sia assai occupato e abbia poca voglia di mettermi al
vostro servizio, madame, cercherò di farlo al posto di monsieur Clark. Forse, anziché domandare chi sono io, sarebbe più illuminante per voi domandare chi è il signor Clark».
ZB: «Il signor Clark! Ma lo conosco benissimo! Lo conosco praticamente da quando era in fasce! Anzi, ho appena saputo del suo ritorno dall'Europa e desidero vederlo».
AD: «Ah».
ZB: «Benissimo. Starò a questo gioco sebbene siate uno sconosciuto e
un insolente. Chi è il signor Clark, signore?».
AD: «Date le attuali circostanze, il signor Clark è il mio socio».
ZB: «Siete avvocato, dunque?».
AD: «Santi numi!».
ZB: «Allora a quali circostanze vi riferite?».
AD: «Le circostanze che assorbivano tutta la mia attenzione finché siete
entrata, intendete?».
ZB: «Sì... Sì, ma... Avete intenzione di accendere quel sigaro, signore,
qui dentro? Così, mentre sono qui dinanzi a voi?».
AD: «Penso di sì. Sempre che riesca a trovare dei fiammiferi; in caso
contrario, ne farò a meno».
ZB: «Il signor Clark verrà informato di questo trattamento! Il signor
Clark...».
AD: «Ecco! Ecco qui un fiammifero, finalmente, madame».
Spronato in parte dall'orribile riassunto della visita di zia Blum, lasciai
un messaggio per Peter, e dopo vari incontri mancati fissammo un appuntamento nel suo ufficio. Si mostrò assai fraterno. Quando ci fummo accomodati, si guardò intorno, assumendo a un tratto un'aria addolorata.
«Ecco, forse questo è il luogo meno adatto per discuterne... ma, Quentin,
ritengo sia meglio parlare apertamente.» Trasse un profondo sospiro. «Innanzi tutto, se mai mi sono adirato con voi, l'ho fatto nella speranza di aiutarvi e di agire come avrebbe voluto vostro padre.»
«Impudente!»
«Come, Quentin?» Era del tutto sbigottito.
Mi avvidi che le inusitate abitudini linguistiche di Duponte mi avevano
contagiato. «Intendevo dire che capisco perfettamente, Peter» mi affrettai
ad aggiungere.
«Be', meglio così. Giacché siete stato lontano da Baltimora, e le cose
cambiano, sapete. Quentin...»
Mi piegai in avanti con interesse.
«Devo dirvelo, sebbene non sia facile...»
«Peter?»
«Ho proposto a un tale di Washington di sostituirvi qui» riuscì a farfugliare. «È un bravo avvocato. Mi ricorda voi. Comprendete, Quentin, sono
semplicemente oberato di lavoro.»
Tacqui, sorpreso... non perché Peter volesse assumere un altro avvocato,
bensì perché, nonostante tutta la mia smania di lasciare quello studio, avvertivo una punta di tristezza.
«È una buona notizia, Peter» replicai dopo un istante.
«L'attività è in pericolo... Vi sono state alcune noie finanziarie, e navighiamo in cattive acque. È andato tutto a rotoli, e potrebbe sgretolarsi nel
giro di un anno se non facciamo qualcosa per l'azienda che vostro padre
aveva creato per noi.»
«So che ce la farete» osservai con una lieve esitazione nella voce che
parve indurlo a perorare la sua causa.
«Dovete tenere presente, Quentin, che potete riavere il vostro lavoro.
Oggi, in qualsiasi momento, se desiderate. Siamo tutti contenti che siate
tornato. Soprattutto Hattie... Sapete, dovete affrontare subito quella situazione. Sua zia le ha praticamente costruito intorno una fortezza per impedirvi di vederla.»
«È naturale: sta solo cercando di proteggerla. Ora che mi ci fate pensare,
zia Blum è passata a casa mia... Tuttavia, sono certo di poterla smuovere
da qualsiasi rancore.»
Espresse il suo dissenso con un'occhiata torva.
In effetti, sapevo che, fintantoché fossi stato assorto nella mia missione,
qualsiasi tentativo di riconciliarmi con la famiglia di Hattie, per quanto efficace, avrebbe soltanto sortito l'effetto contrario qualora non avessi dedicato l'attenzione necessaria ai vari preparativi per il futuro. Avrei dovuto
aspettare ancora un poco prima di sanare quei rapporti. Interruppi il mio
colloquio con Peter, promettendo di spiegargli il resto in un secondo momento.
Frattanto, frequentavo le sale di lettura, dove il medesimo chiacchierone
che avevo incrociato in precedenza, il misterioso appassionato di Poe, continuava a comparire con regolarità, leggendo i giornali ed esaltandosi per
gli sciocchi articoli pubblicati sul poeta.
Un mattino, sedetti sui gradini di pietra della biblioteca prima che aprissero e aspettai che togliessero il chiavistello. Una volta dentro, scelsi una
sedia di fronte alla posizione preferita di quel tale, per poterlo osservare
con maggiore attenzione. Quando arrivò, apparentemente ignaro dei miei
propositi, si accomodò tuttavia a un altro tavolo. Non volendo dare l'impressione di seguirlo, mi tenni a distanza. L'indomani, indugiai accanto alla scrivania del bibliotecario per vedere dove si sarebbe seduto. Dopo essermi sistemato lì vicino, potei studiare ogni suo movimento.
L'allegria che mostrava leggendo della morte di Poe era assai irritante.
«Ah, avete veduto questo?» Si voltò verso una donna al tavolo accanto,
sollevando un quotidiano. «Si chiedono che cosa ne sia stato di tutto il denaro che aveva racimolato durante le conferenze di Richmond. Se ce l'aveva addosso, dov'è finito? Questa sì che è una bella domanda. I direttori dei
giornali sono perspicaci.» Scoppiò a ridere come se avesse udito una facezia spassosissima.
Perspicaci, aveva detto. «Signore, come mai ridete in quel modo?» domandai, sapendo che invece avrei dovuto stare sulle mie. «Non pensate che
sia un argomento della massima serietà, degno di un decoro maggiore?»
«Altroché se è serio» ammise, le sopracciglia ribelli che si raddrizzavano
a comando. «Serissimo. Ma è altrettanto importante che ci rivelino appieno
quanto gli è capitato.»
«Perché non valutate questi resoconti con un briciolo di buonsenso?
Credete che ogni pezzo che leggete proclami la verità, come un profeta del
Vangelo?»
Rifletté con gravità sulla sua dabbenaggine. «Perché sprecherebbero tanto inchiostro prezioso, caro amico, se non fosse vero? Non voglio pensarla
come gli ebrei, e non voglio credere che i testamenti più recenti siano anche i più corretti, inseguendo invece tutti i falsi Messia con un "Guardate
qui, guardate là!".»
In preda all'agitazione, lasciai la biblioteca e non vi feci ritorno per il resto della giornata. Mi auguravo che la curiosità smodata di quel seccatore
si placasse in fretta, e salutavo con sollievo i giorni in cui non si presentava, anche se ricompariva l'indomani. Talvolta, quando qualcosa gli rammentava una certa poesia di Poe, si alzava e ne recitava spontaneamente i
versi alla sala. Per esempio, un pomeriggio, la campana di una chiesa suonò a morto per un funerale, e quel tizio balzò in piedi con le parole di Poe
sulle labbra:
Senti? Suonano a martello
qual novello di terror racconto fanno.
Di solito sedeva tra i giornali, smettendo di leggere solo per soffiarsi il
naso con energia col suo fazzoletto o con quello preso a prestito da un altro
lettore sfortunato. Divenni assai cordiale con gli estranei che incrociavo in
biblioteca, solo perché possedevano la virtù di non essere quel tipo rumoroso e arrogante.
Mi lagnai con il bibliotecario, camminando su e giù dinanzi alla sua
scrivania. «Perché è tanto interessato agli articoli su Poe?» chiesi.
«Chi, signor Clark?»
Battei le palpebre in direzione di quel vecchietto gentile. «Chi? Perché
quell'uomo che viene quasi tutti i giorni...»
«Ah, credevo parlaste del tale che mi aveva dato quei ritagli su Edgar
Poe qualche tempo fa» affermò. «Quelli che vi avevo fatto recapitare.»
Mi paralizzai, ripensando alla busta di articoli che avevo ricevuto prima
di decidere di partire per Parigi, una collezione che conteneva il primo accenno al vero Dupin in cui mi fossi mai imbattuto. «Avevo dato per scon-
tato che li aveste raccolti voi.»
«No, signor Clark.»
«Ma chi ve li ha dati?»
«Ormai devono essere trascorsi circa due anni» calcolò. «In quale scomparto del cervello l'avrò mai cacciato?» rise.
«Per favore, cercate di ricordare. Vorrei tanto saperlo.» Promise che me
l'avrebbe detto se gli fosse venuto in mente. Presumevo fosse stato qualcuno che si era interessato a Poe prima dello scalpore morboso e della volgare curiosità suscitati dalle manipolazioni di Claude Dupin. Prima di uomini come il fanatico che ormai sedeva sempre dinanzi a me nella sala.
Duponte mi consigliò di ignorarlo. Ora che avevo incontrato Bonjour in
libreria, osservò, il barone Dupin avrebbe avuto molti occhi incaricati di
sorvegliarmi (proprio come li aveva avuti a Parigi) per intuire la natura
della nostra attività. Dovevo fingere che non ci fosse, come se non esistesse.
«Oh, guardate qui. Presto ci saranno delle novità.» Fu quello il commento dell'uomo dai capelli ispidi un mattino in biblioteca.
Mi sforzai di tacere prima di ritrovarmi a replicare dal tavolo accanto.
«Signore? Che cosa intendete quando dite che presto ci saranno delle novità?»
Strizzò gli occhi come se non mi avesse mai veduto prima. «Ah, proprio
qui, caro amico» rispose, indicando un punto della pagina. «Ecco. Negli
ambienti più raffinati della società si mormorerebbe che il "vero Dupin"
sia venuto a Baltimora e stia per scoprire che cosa è capitato a Poe. Vedete?»
Guardai il foglio e individuai l'articolo.
«Il direttore l'ha sentito con le sue orecchie. C. Auguste Dupin è...» proseguì, quindi si fermò per soffiarsi il naso. «C. A. Dupin è l'affascinante
investigatore di alcuni racconti di Poe, non lo sapete? Risolve alcuni enigmi assai ingarbugliati. È un vero genio, senza dubbio.»
Avrei voluto riferire tutto a Duponte, principalmente per sfogare la mia
contrarietà, ma quel pomeriggio non lo trovai al solito posto in biblioteca. I
quotidiani erano sparpagliati sul tavolo e sulla scrivania come sempre, segno che aveva lavorato fino a poco prima.
«Monsieur Duponte?» La mia voce riecheggiò inutilmente lungo i corridoi e per le scale di Glen Eliza. Interrogai i domestici, ma nessuno lo vedeva da qualche ora. Fui pervaso da una paura sinistra. Urlai abbastanza
forte da essere udito nelle abitazioni vicine. Probabilmente Duponte aveva
iniziato a sentirsi soffocare dopo essere rimasto rinchiuso a leggere per
tanto tempo. Forse era ancora nei paraggi.
Non trovai tuttavia alcuna traccia dell'analista nella proprietà e nella valle sotto la casa. Ben presto raggiunsi la via e noleggiai una carrozza.
«Sto cercando un amico, cocchiere... Facciamo un giro, il più in fretta
possibile.» Giacché Duponte non aveva abbandonato Glen Eliza da quando
eravamo arrivati, avevo cominciato a sospettare che avesse trovato qualcosa di emozionante su cui indagare.
Percorremmo i viali intorno al monumento dedicato a Washington, attraversando il Lexington Market e le viuzze affollate sui lati delle banchine
sorvegliate dai velieri. L'affabile vetturino tentò a più riprese di intavolare
una conversazione, una volta lungo il tratto di strada accanto al Washington College Hospital.
«Sapevate, vossignoria» gridò nella mia direzione «che quello è il luogo
in cui è morto Edgar Poe?»
«Fermatevi!» ordinai.
Obbedì, felice di aver attirato la mia attenzione. Salii in cassetta.
«Che cosa avete detto riguardo a quel posto, cocchiere?»
«Vi stavo solo indicando i dintorni. Non siete un forestiero? Anziché
correre in cerchio, posso condurvi a un ottimo ristorante in men che non si
dica, se desiderate, vossignoria.»
«Chi vi ha raccontato di Poe? L'avete letto sui giornali?»
«È stato un tale che ha viaggiato nella mia carrozza a parlarmene.»
«Che cosa ha detto?»
«Che Poe era il più grande poeta maledetto americano. Ma aveva appreso che l'avevano lasciato morire sul pavimento sudicio di una bettola in
circostanze poco chiare. Ha aggiunto di aver letto tutto sui giornali. Tipo
socievole, quello... Il mio cliente, intendo.»
Non rammentava l'aspetto di quell'uomo, sebbene fosse palese che ne
rimpiangesse la loquacità, molto maggiore della mia.
«È salito sulla mia carrozza non più di tre giorni fa. Sapete, starnutiva
senza sosta.»
«Starnutiva?» domandai.
«Sì, ha preso a prestito il mio fazzoletto e l'ha imbrattato terribilmente.»
Guardai il pomeriggio che sfumava nel crepuscolo, sapendo che al tramonto avrei perduto ogni speranza di rintracciare Duponte. L'illuminazio-
ne stradale di Baltimora era tra le più inadeguate di qualsiasi città, e talvolta rincasare dopo il calare delle tenebre era difficile anche per gli abitanti.
Avevo concluso che la cosa più saggia da fare era rientrare e aspettarlo a
Glen Eliza.
Ormai i maiali riempivano la via. Benché vi fossero state richieste sempre più numerose di carri pubblici che rimuovessero la spazzatura e i rifiuti
dalle strade, quelle creature ingorde erano ancora lo strumento più usato a
tale scopo, e a quell'ora colmavano l'aria di grugniti soddisfatti mentre divoravano qualunque avanzo riuscissero a trovare.
Poco dopo aver ordinato al vetturino di riaccompagnarmi a casa, scorsi
dal finestrino Duponte che procedeva con il suo consueto passo misurato.
Pagai il cocchiere e smontai con un balzo, come se il francese potesse svanire nel nulla.
«Monsieur Duponte, dove state andando?»
«Osservo lo spirito della città, monsieur Clark» rispose, come se fosse la
cosa più ovvia del mondo.
«Ma monsieur, non capisco perché avete lasciato Glen Eliza da solo...
Sarei sicuramente stato un'ottima guida.» Per dimostrarglielo, presi a descrivere le nuove officine di produzione del gas che si intravedevano in
lontananza, ma levò una mano per zittirmi.
«Riguardo a certi fatti» dichiarò «gradirò molto le vostre accurate nozioni. Ma ricordate, monsieur Clark, che voi conoscete Baltimora da residente. Edgar Poe ha vissuto qui per qualche tempo, ma molti anni or sono... quindici, se non erro. Nei suoi ultimi giorni, sarà venuto quaggiù da
turista, guardando la città e la sua popolazione come fa un forestiero. Mi
sono già fermato in alcuni negozi di grande interesse e in un nutrito numero di mercati, deducendo solo quanto dedurrebbero i visitatori studiando le
insegne e i comportamenti degli abitanti.»
La sua mi parve una tesi ragionevole. Nell'ora successiva, mentre passeggiavamo verso est, gli spiegai che cosa avevo appreso dal giornale e
che cosa mi aveva riferito il cocchiere. «Monsieur» chiesi «non dovremmo
fare qualcosa? Il barone Dupin ha pubblicato annunci offrendo denaro in
cambio di informazioni riguardo alla morte di Poe. Dobbiamo senz'altro
neutralizzarlo prima che sia troppo tardi.»
Prima che potesse rispondere, la nostra attenzione fu attirata da una figura che scendeva su un marciapiede lì di fronte. Strizzai gli occhi. Un lampione emanava un bagliore così tenue che forse sarebbe stato più facile vedere se non vi fosse stata alcuna luce.
«Monsieur» bisbigliai. «Perbacco, stento a crederci, ma quello è lui, il
tale che occupa una sedia della sala di lettura quasi ogni giorno! Qui, dinanzi a noi!»
Duponte seguì il mio sguardo.
«Quello è il tizio che ho conosciuto in biblioteca!»
In quell'istante, scorsi gli occhi scuri di Bonjour. Teneva le mani nascoste sotto lo scialle e pedinava l'uomo ignaro con aria minacciosa. Ripensai
alle storie che Duponte mi aveva narrato sulla spietatezza di quella donna.
Fremetti al vederla, e tremai per l'uomo che le camminava dinanzi.
L'appassionato di Poe si era voltato all'improvviso e si dirigeva dalla nostra parte.
Duponte gli rivolse un cenno del capo. «Dupin» disse, sfiorandosi il
cappello.
L'altro rispose soffiandosi sonoramente il naso, la cui punta bulbosa rimase nel fazzoletto. Poi Claude Dupin si tolse le sopracciglia finte. Il suo
accattivante accento anglofrancese ricomparve. «Barone» lo corresse. «Barone Dupin, prego, monsieur Duponte.»
«Barone? Ah, sì, d'accordo. Anche se forse è un poco formale per l'America» commentò Duponte.
«Non direi.» L'altro sfoderò il suo sorriso smagliante. «Tutti adorano i
baroni.»
Bonjour raggiunse il suo padrone nel cerchio di luce. L'uomo le impartì
alcuni ordini e la ragazza si dileguò.
Il mio sgomento davanti alla vera identità del fanatico di Poe venne subito superato da una seconda consapevolezza. «Voi e il barone Dupin vi
conoscevate già?» domandai a Duponte.
«Ci siamo incontrati molti anni or sono, monsieur Clark, a Parigi» interloquì Claude Dupin con un sorriso enigmatico, scuotendo la parrucca e levandosela insieme al cappello. «In circostanze assai meno promettenti.
Spero, signori, che la vostra traversata da Parigi sia stata gradevole almeno
la metà della nostra. Nessuno vi ha importunati sull'inaffondabile Humboldt, mi auguro?»
«Come fate a sapere su quale...» Ero esterrefatto. «Il clandestino! Ci
avete fatti seguire da quel manigoldo calvo, monsieur? Era alle vostre dipendenze?»
Scrollò le spalle con aria candida. I capelli neri, che erano appena umidi
e sembravano incerati, gli ricaddero sulle spalle in lunghi ricci. «Quale
manigoldo? Mi limito a informarmi sulle liste dei passeggeri che sbarcano
al porto. Leggo i giornali, come ben sapete, monsieur Clark.»
Si tolse il ruvido cappotto imbottito che aveva completato il suo rudimentale costume insieme al naso, la parrucca e le sopracciglia. Provai disgusto all'idea di essermi lasciato ingannare da quel travestimento.
Tuttavia, non voglio soltanto giustificarmi aggiungendo che il barone
possedeva l'inquietante capacità di modificare la voce, l'andatura e, a quanto sembrava, persino la forma e l'aspetto della sua testa, tanto da poter mettere in difficoltà anche il frenologo più rispettato; mediante un complesso
posizionamento della mascella, delle labbra e dei muscoli del collo riusciva inoltre a camuffarsi meglio di quanto avrebbe fatto con una maschera.
Ogni espressione pareva fatta d'acciaio, con l'anima di cento esseri umani
in attesa lì sotto. Anche la sua voce aveva una flessibilità innaturale, e
sembrava mutare completamente a seconda di cosa diceva. Per quanto Duponte sapesse controllare quello che osservava negli altri, il barone Dupin
pareva capace di controllare l'osservazione cui gli altri sottoponevano lui.
«Desidero conoscere tutti gli altri trabocchetti che avete utilizzato in
questa vicenda, monsieur!» esclamai, cercando di dissimulare un impeto di
mortificazione.
«Quando accetto il caso di un imputato oppresso per conto della classe
sofferente, faccio sì che il mondo se ne interessi. La sfortuna di quell'imputato è la sfortuna del mondo; il suo destino, il destino del mondo. Ecco
perché io, il barone Dupin, non ho mai perduto una causa. Nemmeno la
causa dell'uomo o della donna più umili. Più gridiamo nel difendere la giustizia e più la gente insisterà per ottenerla.
«Il trucco principale» proseguì «è non dire al pubblico ciò che dovrebbe
incuriosirlo, bensì fingere di soddisfare le curiosità che ardono già nel suo
petto. Ora l'ho fatto anche per Poe. I direttori dei giornali hanno iniziato a
ricercare nuovi dettagli su Poe, come avete potuto constatare. I librai fanno
presente la necessità di nuove edizioni, e un giorno Poe sarà su ogni scaffale del Paese, nella biblioteca di ogni famiglia, letto dai vecchi e dai giovani e conservato da questi ultimi accanto alla Bibbia. Passeggio per la
strada... o talvolta io passeggio per la strada.» Si accostò il naso finto al viso e, con sorprendente prontezza, prese a simulare un accento americano.
«E parlo della scomparsa di Poe nei ristoranti, nelle chiese, ai mercati, nelle vetture a nolo» fece una pausa «e nelle sale di lettura della biblioteca...
Ormai tutte le classi sofferenti credono, tutte dubitano e chiederanno la verità a gran voce, in città e in campagna. Chi gliela darà?»
«Mirate soltanto a destare scalpore per il vostro profitto. Non vi importa
scoprire la verità, monsieur Dupin; siete venuto solo per tentare la fortuna
a Baltimora!» lo rimbeccai.
Si finse offeso, ma, devo riconoscerlo, lo fece con un'espressione così
convincente da farmi sentire in colpa. «La verità è l'unica cosa che mi stia
a cuore. Ma... la verità va strappata e trascinata fuori dalla testa delle persone. Avete un senso dell'onore donchisciottesco, carissimo Quentin, e lo
ammiro. Ma la verità non esiste, mio ingenuo amico, fintantoché non la
trovate. Contrariamente a quanto sostengono alcuni, non ci viene riversata
addosso da qualche divinità benevola.» A quel punto, cinse le spalle di
Duponte con il braccio e gli lanciò un'occhiata obliqua. «Ditemi, Duponte,
che cosa avete fatto in questi anni?»
«Ho aspettato» rispose l'altro con pacatezza.
«L'abbiamo fatto tutti e ce ne siamo stancati, suppongo» commentò il
barone. «Ma il vostro intervento qui giunge con troppo ritardo, monsieur
Duponte.» Tacque. «Come di consueto.»
«Credo che resterò comunque, se al momento non avete obiezioni» replicò Duponte, calmo.
Il barone corrugò la fronte con aria accondiscendente, ma parve lusingato da tanta deferenza. «Devo raccomandarvi di rimanere fuori da questa
faccenda e di tenere al guinzaglio il vostro grazioso cagnolino americano,
giacché sembra avere la lealtà di una scimmia capricciosa. Ho già iniziato
ad appurare quanto è accaduto a Poe. Ascoltatemi ora, Duponte, e nessuno
vi torcerà nemmeno un capello. Devo avvertirvi: la mia cara mogliettina
taglierà la gola a chiunque cerchi di ostacolarmi. Ma non è forse amore,
questo? Non parlate con nessuna delle parti in possesso di informazioni
sull'argomento.»
«Dove volete arrivare?» sbottai, sentendomi arrossire, forse per lo sdegno provocato da quell'intimazione, o forse per l'umiliazione di essere stato definito un cagnolino. «Come osate rivolgervi a Auguste Duponte con
quel tono? Ci reputate così smidollati?»
La risposta di Duponte al barone mi innervosì tuttavia ancor più della
minaccia.
«Andrò oltre i vostri desideri» disse Duponte. «Non parleremo con nessun testimone.»
Il compiacimento del barone per quella vittoria fu intollerabile. «Vedo
che finalmente avete capito che cosa è meglio fare, Duponte. Questo sarà il
più grande interrogativo letterario moderno, e io ne sarò il giudice. Sto
cercando di scrivere le mie memorie. Si intitoleranno Memorie del barone
Claude Dupin, propugnatore della giustizia per Edgar A. Poe e autentico
ispiratore del personaggio di C. Auguste Dupin nei "Delitti della Rue
Morgue". Giacché siete un estimatore della letteratura, gradirei sapere se
vi sembra idoneo, carissimo Quentin.»
«Gli assassinii della Rue Morgue» lo corressi. «Ed ecco, qui dinanzi a
voi, Auguste Duponte, il vero modello dell'eroe di Poe!»
Scoppiò a ridere. Vi era una vettura a nolo che lo attendeva, e un giovane servitore nero gli teneva aperto lo sportello come se fosse davvero un
aristocratico. Il barone fece scorrere un dito sul battente e sulle spirali che
decoravano il legno.
«Bella carrozza. Le comodità della vostra città, carissimo Quentin, sono
difficili da superare, come avviene in tutte le metropoli più immorali del
mondo.» Mentre pronunciava quelle parole, la sua mano si spostò per afferrare quella di Bonjour, che si era già accomodata nel veicolo.
Il barone tornò a voltarsi verso di noi. «Dimentichiamo il rancore. Comportiamoci almeno da persone civili. Andiamo da qualche parte, anziché
rimanere qui a brancolare nel buio. Prenderei io stesso le redini, ma, dopo
tutti gli anni trascorsi a Londra, mi dimentico sempre di rimanere sul lato
destro della strada. Vedete, non siamo bifolchi; non è necessario che fingiate di non conoscerci. Salite.»
«Mi è venuta un'idea» affermò all'improvviso Duponte con il tono di chi
ha avuto un'illuminazione, destando l'interesse del nostro interlocutore.
«Che cosa ne dite di duca? Pensateci: se amano un barone, a maggior ragione dovrebbero amare un duca. "Duca Dupin" ha un che di solenne grazie all'allitterazione.»
Il barone tornò ad assumere un'espressione dura prima di chiudere lo
sportello con violenza.
Rimasi disorientato per diversi minuti dopo che la carrozza si fu allontanata. Duponte guardava con gli occhi bassi nella direzione da cui era venuto Claude Dupin.
«Si è adirato perché non abbiamo accettato il suo invito. Credete che volesse condurci da qualche parte per farci del male?» domandai.
Duponte attraversò la strada e studiò un vecchio edificio con una rozza
facciata di semplici mattoni. Nel frattempo, mi accorsi che eravamo nel
medesimo isolato di Lombard Street in cui sorgeva il Ryan, dalla cui taverna provenivano i suoni attutiti delle baldorie notturne. Raggiunsi Du-
ponte, che ormai era di fronte all'hotel.
«Forse il barone non si è adirato perché voleva condurci da qualche parte, ma perché il suo scopo era portarci via da un certo luogo» osservò. «È
questo il fabbricato da cui sono usciti lui e la giovane donna?»
Sì, era quello, ma non seppi rispondere allorché Duponte mi chiese
qualche precisazione sul proprietario e sulla natura di quello stabile. E
questo dopo avergli offerto i miei competenti servigi come guida di Baltimora! L'edificio, gli spiegai, confinava con la rimessa delle autopompe
della Vigilant Fire Company, una delle società cittadine che offrivano servizi di sorveglianza antincendio, e probabilmente apparteneva all'azienda.
Il portone da cui erano sbucati il barone e Bonjour era pesante ma non
era chiuso a chiave. Si affacciava su un corridoio buio che si inclinava verso un'altra porta. Un uomo robusto, forse un vigile del fuoco, la aprì
dall'interno. Dalla lunga rampa di scale alle sue spalle giungevano fugaci
urla di gioia. O di terrore, era difficile stabilirlo.
Il buttafuori ci sbarrò l'ingresso con la sua mole, fissandoci con aria minacciosa. Mi imposi di restare fermo e zitto, ritenendo opportuno avanzare
solo quando ci chiamò con un cenno della mano.
«Parola d'ordine» disse.
Preoccupato, mi girai verso Duponte, che teneva gli occhi puntati a terra.
«Parola d'ordine per salire» ribadì l'altro con un bisbiglio finalizzato a
spaventarci, cosa che gli riuscì benissimo.
Duponte era caduto in una sorta di trance, con lo sguardo che gli scivolava sul pavimento, sulle pareti, sulle scale e persino sul buttafuori. Bel
momento per distrarsi! Intanto, dalla gola dell'omone uscì un ringhio canino, come se il gigante fosse intenzionato a colpirci appena ci fossimo mossi.
Mi afferrò il polso con un violento strattone.
«Ve lo chiedo per l'ultima volta, damerini. Non sto scherzando. Parola
d'ordine!» Ebbi l'impressione che l'osso mi si sarebbe spezzato se avessi
tentato di divincolarmi.
«Lasciate il giovanotto, buon signore» mormorò Duponte alzando gli
occhi «e vi dirò la parola d'ordine.»
L'altro batté qualche volta le palpebre con freddezza, quindi mollò la
presa. Ritrassi subito il braccio. Il colosso ripeté: «Parola d'ordine» come
se non avesse mai pronunciato quelle sillabe in passato, e come se non intendesse pronunciarle ancora senza uccidere qualcuno. Fissammo entrambi
Duponte con scetticismo.
Il mio compagno raddrizzò la schiena dinanzi al suo avversario e articolò due vocaboli.
«Dio rosato.»
Capitolo 13
Nonostante la mia fede incrollabile nelle capacità analitiche di Duponte,
nonostante gli stupefacenti resoconti dei suoi successi che avevo appreso
dai giornali, dai commissionnaires dai gendarmi di Parigi, nonostante la
scena cui avevo assistito al Jardin des Plantes e la scoperta del clandestino
sul piroscafo, nonostante la consapevolezza che lo stesso Poe aveva presentato il francese come un genio fuori del comune in tutti i suoi racconti...
nonostante tutto questo stentavo a credere a quanto era accaduto in quel
corridoio umido. Il buttafuori ci aveva fulminati con un'occhiata, si era
spostato, quindi ci aveva fatto segno di entrare.
Quel «Dio rosato», il segnale che ci aveva garantito l'ingresso come la
parola magica di una fiaba, l'avevo udito qualche volta per la strada come
designazione colloquiale del vino rosso. Quale straordinario simbolo presente sul pavimento, sulle pareti, sui gradini, sul volto o sui vestiti dell'omone aveva permesso a Duponte di decifrare il codice d'accesso a quel covo segreto e ben sorvegliato, una parola d'ordine che poteva mutare a seconda della stagione o dell'orario?
«Come avete fatto?» domandai, arrestandomi a metà della scala cigolante. «Monsieur, la parola d'ordine...»
«Fatevi da parte! Fatevi da parte!» Un tale ci passò accanto scendendo
con andatura barcollante. Duponte accelerò il passo. Le urla roche divennero più vicine.
Il piano superiore era una saletta piena di fumo e chiasso. Vigili del fuoco e attaccabrighe vacillanti sedevano ai tavoli da gioco e chiedevano altri
drink a bariste discinte, gli indumenti coprivano a malapena il candore lattiginoso dei loro colli. Un tipaccio atterrò su un letto di gusci d'ostrica acuminati mentre uno dei suoi compagni lo spingeva verso sinistra con un
calcio, assicurandosi una posizione più vantaggiosa per una partita di biliardo.
Duponte trovò un tavolino sgangherato più o meno al centro del locale,
sotto gli sguardi di tutti. Occhiate torve ci seguirono fino alle sedie malconce. Duponte sedette e rivolse un cenno del capo a una cameriera, come
se fossimo entrati in un caffè rispettabile lungo i marciapiedi di Parigi.
«Monsieur» sussurrai accomodandomi «dovete dirmelo subito. Come
facevate a conoscere la parola d'ordine?»
«La spiegazione è semplicissima: non la conoscevo.»
«Mio caro Duponte! È stato come dire "Apriti Sesamo"! Se foste vissuto
due secoli or sono, vi avrebbero bruciato sul rogo. Non sto più nella pelle
dalla curiosità.»
Si sfregò un occhio come se si fosse appena destato. «Monsieur Clark.
Perché siamo venuti qui?» domandò.
Recitare la parte dello studente non mi pesava, purché servisse a fornirmi la risposta. «Per vedere se ci era venuto anche il barone Dupin e, in tal
caso, per scoprire che cosa cercava questa sera prima che lo incrociassimo.»
«Esatto. Molto bene. Ora, se foste a capo di un'associazione segreta o
clandestina, sareste più propenso a conversare con un visitatore che pronunciasse la parola d'ordine corretta, come avranno fatto tutti i beoni e gli
imbecilli che vedete in questa bettola» disse quella frase senza abbassare il
tono della voce, inducendo alcune teste a girarsi, «oppure a discorrere con
l'unico sconosciuto che giungesse inaspettatamente e, con molta sfrontatezza, recitasse una parola d'ordine del tutto sbagliata?»
Riflettei. «Con il secondo, suppongo» ammisi. «Intendete dire che avete
inventato una parola d'ordine pur sapendo che era errata, e che siamo entrati subito proprio perché era errata?»
«Giusto. "Dio rosato" era idonea come qualunque altra. Avremmo potuto scegliere qualsiasi espressione purché ci mostrassimo altrettanto interessati. Avrebbero capito che non facevamo parte della loro solita cerchia, ma
avrebbero intuito che desideravamo davvero entrare. Orbene, dando per
buone queste congetture, se avessero giudicato le nostre intenzioni aggressive o addirittura violente, come devono aver fatto al principio, avrebbero
preferito vederci quassù, circondati dai loro amici nerboruti e da qualunque
arma conservino qui dentro, piuttosto che al piano di sotto, dove, avranno
immaginato, potevamo avere dei complici nascosti fuori del portone. Non
la pensereste così anche voi? Naturalmente, non cerchiamo alcuno scontro
violento. La nostra sosta qui sarà breve, e ci basterà qualche istante per
farci un'idea degli scopi del barone.»
«Ma chi ci condurrà dal proprietario?»
«Se ho ragione, sarà lui a venire da noi» rispose.
Dopo qualche minuto, un tale dall'aria paterna e dalla barba bianca ci si
parò dinanzi. Il buttafuori minaccioso si piazzò rumorosamente sull'altro
lato, accerchiandoci. Ci alzammo. Il primo uomo, con un tono più duro di
quanto lasciasse supporre il suo aspetto, sì presentò soltanto come il presidente dei whig della quarta sezione elettorale e ci chiese perché ci trovassimo lì.
«Solo per aiutarvi, signore.» Duponte si inchinò. «Credo che un gentiluomo abbia cercato di entrare qui nell'ultima ora, probabilmente offrendo
denaro al vostro buttafuori in cambio di informazioni.»
Il proprietario si voltò verso l'altro uomo. «È vero, Tindley?»
«Mi ha sventolato davanti un bel po' di quattrini, signor George.» L'omone annuì, imbarazzato. «Ma ho cacciato via quel balordo, signore.»
«Che cosa voleva sapere?» interloquì Duponte. Benché il mio accompagnatore non avesse alcuna autorità là dentro, Tindley parve dimenticarsene
e rispose.
«Era impaziente di sapere se avessimo interferito con le elezioni dell'ottobre di due anni fa, organizzando brogli e cose simili. Gli ho detto che
siamo un circolo whig privato e che avrebbe fatto bene a dirmi la parola
d'ordine o a sloggiare.»
«Hai accettato il suo denaro?» intervenne il suo superiore, severo.
«Certo che no! Me ne sono guardato bene, signor George!»
Udendo di nuovo il proprio nome di battesimo, l'altro gli lanciò un'occhiata stizzita. «Voi due che cosa c'entrate? Vi mandano i democratici?»
Notai che Duponte era soddisfatto di quanto ci avevano rivelato con tanta celerità: che tipo di associazione era quella, che cosa voleva il barone e
il nome del capo di quel circolo. Ora una nuova idea gli illuminò il viso.
«Vivo lontano dall'America e non saprei distinguere un whig da un democratico. Siamo venuti unicamente per portarvi un avvertimento amichevole» spiegò in tono rassicurante. «Il signore che è stato qui prima non si
accontenterà della risposta del vostro buttafuori. Credo di potervi aiutare a
rintracciare il colpevole di questa bricconeria. Intende litigare con voi riguardo ai princìpi morali del vostro circolo.»
«Davvero?» fece il proprietario in tono riflessivo. «Be', molte grazie per
la vostra sollecitudine. Ora alzate i tacchi prima che qui dentro ne scoppi
davvero uno, di litigio.»
«Servo vostro, signor George» concluse Duponte con un inchino.
Capitolo 14
L'indomani, domandai a Duponte perché avesse acconsentito con tanta
facilità alla richiesta del barone, promettendo di astenersi dal parlare con i
testimoni. Ora sarebbe iniziata una corsa alle informazioni, e non potevamo permetterci alcun impedimento. Ero curioso di sapere come volesse
contrastare il nostro avversario.
«Intendete ingannarlo, suppongo? Naturalmente, interpellerete le persone che sanno qualcosa a proposito dell'ultima visita a Baltimora da parte di
Poe?»
«Rispetterò appieno il mio impegno. No, non interrogherò i testimoni.»
«Perché? Il barone Dupin non ha fatto alcunché per meritare la vostra
lealtà. E nemmeno per rivendicare i testimoni come suoi. Come potremo
capire che cosa è accaduto a Poe se non parliamo con coloro che l'hanno
veduto di persona?»
«Sarebbe inutile.»
«Ma i loro ricordi non sarebbero vividi, giacché la morte di Poe risale
soltanto a due anni or sono?»
«Ormai, monsieur, i loro ricordi non sono più genuini perché sono influenzati dalle fanfaluche del barone. Quest'ultimo ha infettato i giornali e i
pettegolezzi di Baltimora con i suoi raggiri e le sue astuzie. Anche se li
rintracciassimo, tutti i testimoni effettivi sarebbero ormai stati contaminati,
sempre ammesso che non lo siano già.»
«Credete che mentirebbero?»
«Non di proposito. I loro ricordi autentici di quegli avvenimenti, e le storie che sono in grado di narrare sulla base di quei ricordi, rispecchierebbero immancabilmente la versione del barone. Ormai quei testimoni sono
suoi come se li avesse reclutati per un processo e pagati per deporre. No,
non ricaveremmo granché a parte i dettagli fondamentali rammentati da
quelle persone, e confido di apprendere quei particolari grazie al corso naturale degli eventi.»
Probabilmente avrete dedotto che Duponte era un tipo formale. Avete
insieme torto e ragione. Non osservava le regole del galateo e i convenevoli senza senso. Fumava sigari in casa a prescindere da chi fosse presente
nella stanza. Era incline a ignorarvi se non aveva nulla da dire e a rispondere a monosillabi quando riteneva che fosse sufficiente. Era, in un certo
senso, un amico affidabile, giacché entrava in confidenza con voi senza le
imposizioni o i rituali consueti dell'amicizia. Tuttavia, si inchinava sempre
e sedeva con una postura impeccabile (benché, quando stava in piedi, mostrasse una vistosa pendenza delle spalle). Ed era assai serio e rigoroso nel
suo lavoro. Anzi, interromperlo quando era occupato vi colmava di disagio. Poteva trattarsi del compito più banale che si possa immaginare, per
esempio mescolare la zuppa d'avena, ma sembrava assai più importante di
qualunque cosa aveste potuto dire per deconcentrarlo qualora l'edificio
stesse per rovinargli addosso.
Cominciò tuttavia ad apprezzare le frivolezze più stravaganti. Mentre
passeggiava per le vie della città, un signore distinto, con un elegante fazzoletto da collo annodato in pieghe voluminose, lo definì ad alta voce il
più singolare esemplare d'uomo che avesse mai veduto. Senza offendersi,
Duponte invitò quel tale, che era un pittore di una certa fama qui a Baltimora, a dividere un tavolo con noi in un ristorante poco lontano.
«Narratemi la vostra storia, caro signore» disse lo sconosciuto.
«Lo farei volentieri, monsieur» replicò Duponte in tono di scusa «ma poi
correrei il rischio di dover udire la vostra.»
«Affascinante!» esclamò l'altro, imperturbato.
Quel tizio espresse il desiderio di dipingere Duponte, e ben presto concordarono che sarebbe venuto a Glen Eliza per iniziarne il ritratto. Considerate le nostre altre occupazioni, mi parve un'idea del tutto assurda, ma
non obiettai perché Duponte ne sembrava entusiasta.
A casa, anziché venirmi a cercare quando aveva qualcosa da comunicarmi, Duponte mi mandava sovente un servitore con un biglietto. Glen
Eliza era grande ma non così sconfinata da costringervi a inviare un messaggero lungo i suoi corridoi. Allorché un domestico mi porse il primo foglietto, non sapevo che cosa pensare, non sapevo se quel gesto fosse scaturito da un picco di neghittosità o da un eccesso di concentrazione.
Nelle occasioni in cui ci avventuravamo fuori della proprietà ed entravamo nei locali pubblici, Duponte si rifiutava di farsi servire dagli schiavi
senza regalare loro una modesta somma. Nel corso degli anni, avevo osservato quell'atteggiamento nei visitatori giunti a Baltimora dall'Europa,
sebbene, durante i soggiorni prolungati, la forza dell'abitudine logorasse la
loro sensibilità delicata, e quel vezzo sparisse poco per volta. Credo tuttavia che il comportamento di Duponte non fosse dettato dal sentimentalismo né da una questione di principio, giacché, a suo parere, esistevano
molti schiavi che non si accorgevano di esserlo, e alcuni erano molto più
asserviti dei neri del nostro Sud; non li pagava per ragioni umanitarie, mi
spiegò, ma perché un servigio gratuito non sarebbe mai stato proficuo per
nessuna delle due parti. Molti schiavi si mostravano assai riconoscenti, altri titubanti, e altri ancora stranamente ostili alle sue mance.
A Glen Eliza, avevamo qualche difficoltà con i servitori che avevo assunto al mio ritorno da Parigi. Per loro, la nostra bizzarra consuetudine di
spedirci lettere dal salotto alla biblioteca costituiva senza dubbio una fatica
in più, sebbene quello non fosse l'unico motivo del loro scontento. Molti
dei miei domestici si ribellarono subito a Duponte. In particolare, una ragazza di colore, una negra libera di nome Daphne, si rifiutava talora di servirlo. Quando le domandai il perché, rispose che lo considerava assai crudele. L'aveva maltrattata? Rimproverata per un errore, forse? No. Non le
aveva quasi rivolto la parola, e quando l'aveva fatto, era stato assai cortese.
Aveva qualcosa che non andava, commentò tuttavia la giovane. «È crudele. Si vede.»
Tra un grattacapo e l'altro, mi recai più volte da Hattie, ma invano. Le
osservazioni pessimistiche di Peter sulla possibilità di recuperare il mio
rapporto con lei mi avevano colmato d'ansia. La madre di Hattie, che era
sempre stata di salute cagionevole e restava a letto quando non cercava di
rimettersi in forze soggiornando in campagna o presso una sorgente termale, era peggiorata ulteriormente durante l'estate. Ora, reduce da una permanenza al mare, rimaneva perlopiù in camera sua, il che comportava ulteriori responsabilità per Hattie, e conferiva anche maggiore potere a zia Blum
sulla famiglia. Ogni volta che passavo di lì, un servitore mi informava che
la signorina e zia Blum non c'erano. Finalmente, un giorno, riuscii a parlare con Hattie mentre montava in carrozza dinanzi alla casa.
«Cara Hattie, non avete ricevuto i miei messaggi?»
Si guardò intorno e rispose con aria furtiva, allontanandomi dal cancello.
«Non dovreste essere qui, Quentin. Le cose sono assai diverse ora che la
mamma si è aggravata. Le mie sorelle e mia zia hanno bisogno di me.»
«Capisco» dissi, temendo che i miei tentativi avessero soltanto appesantito il fardello ricaduto sulle sue povere spalle. «Riguardo ai nostri progetti... mi serve solo un altro po' di tempo...»
Scosse il capo, zittendomi. «Le cose sono diverse» ripeté. «Non possiamo discuterne ora, ma ne discuteremo. Verrò da voi appena potrò, caro
Quentin. Ve lo prometto. Non parlate con mia zia. Aspettate che sia io a
cercarvi.»
Dall'edificio provennero alcuni rumori. Hattie mi pregò di tornare verso
la strada e di affrettarmi a uscire. Obbedii. Udii zia Blum (e per poco non
udii anche arruffarsi le grandi piume d'uccello di cui immaginavo fosse ornato il suo cappellino) domandare con la sua voce tonante: «Chi era, mia
cara?». Allungai il passo senza voltarmi, con la netta impressione che, se
mi fossi girato, la signora più anziana dentro la carrozza avrebbe ordinato
al cocchiere di investirmi.
A Glen Eliza, Van Dantker, il ritrattista, sedeva di fronte a Duponte con
il suo assortimento di tele e pennelli sparpagliato su un tavolo. Duponte
aveva seguitato a mostrarsi euforico all'idea di quella creazione artistica.
L'irascibile Van Dantker lo esortava con severità a restare immobile, sicché l'analista muoveva soltanto la bocca mentre discorreva con me. Quando osservai che quello non era un modo molto educato di sostenere una
conversazione, obiettò che era tutt'orecchi e che voleva vedere se fosse capace di dividere la sua mente in scomparti di concentrazione. Talvolta era
come chiacchierare con un ritratto vivente.
«Che cosa credete che sia la verità per il barone, monsieur Clark?» mi
domandò Duponte una sera con un tono pungente.
«Che cosa intendete?» chiesi.
«Gli avete domandato se fosse alla ricerca della verità. Sicuramente la
verità non è la medesima per tutti, giacché quasi tutti credono di possederla, o desiderano possederla, ma le guerre esistono ancora, e vi sono professori che rovesciano ogni giorno le ipotesi dei loro colleghi. Perciò che cosa
sarà per luì, per il nostro amico barone?»
Ci riflettei su. «È un avvocato. Suppongo che, in ambito legale, la verità
sia una questione pratica, pertanto si adotta la politica della difesa indiscriminata a prescindere da chi sia il cliente.»
«D'accordo. Se Gesù Cristo avesse avuto un avvocato al suo fianco, forse Ponzio Pilato si sarebbe persuaso che il suo giudizio avrebbe potuto essere capovolto per un difetto di forma, e dunque avrebbe optato per una
sentenza più lieve, interrompendo così il rinnovamento della razza umana.
Benissimo. Allora, se il barone Dupin parla la lingua della legge, la verità
non è ciò che è più verosimile, bensì ciò di cui egli riuscirà a dimostrare la
verosimiglianza. Non è la stessa cosa. Anzi, i due aspetti non hanno quasi
alcun legame e non dovrebbero mai essere assimilati.»
«Come potremo capire se il barone sta adducendo prove false riguardo
alla morte di Poe?»
«Potrebbe cercare di fabbricarle, certo, ma probabilmente con un piccolo
fondo di verità. Se, come ha accennato, intende pubblicare un resoconto
divulgativo delle sue indagini sulla scomparsa di Poe, e aspira ad arricchirsi tenendo conferenze sull'argomento, non può permettersi di cadere nel
discredito con tanta facilità usando menzogne campate per aria, monsieur
Clark. Dopo tutto, abbiamo appreso dai giornali parigini che voleva comunicare ai creditori il suo proposito di tornare con risorse finanziarie sufficienti a liberarsi della loro attenzione. Fa affidamento su questo per proteggersi dai loro complotti. Necessiterà dei fatti, anche se alcuni saranno
frutto della sua fantasia.»
Duponte continuò a trascorrere la maggior parte del suo tempo a Glen
Eliza, spesso bisticciando con Van Dantker, che lo accusava di non restare
abbastanza fermo. Sfoderava per l'artista uno stranissimo abbozzo di sorriso, con punte affilate come coltelli scolpite agli angoli della bocca.
Talvolta uscivo per sbrigare una commissione, e quelle passeggiate erano soprattutto offerte sacrificali ai miei nervi. Qualche mese addietro, l'ufficio postale aveva cominciato a consegnare la corrispondenza in cambio
di una quota aggiuntiva di due centesimi, sicché non avevo più bisogno di
andarci di persona. Descrissi il funzionamento del nostro servizio postale a
Duponte, che parve assai interessato all'argomento per qualche istante, ma
poi tornò quasi subito ad assumere la sua aria distratta. Controllare la corrispondenza era sempre la prima azione che compivo, alla ricerca di qualcosa di inatteso: magari persino un'ultima lettera di Poe, che poteva essere
stata smarrita o recapitata all'indirizzo sbagliato e quindi ritrovata. Duponte, invece, non riceveva mai nulla.
Tuttavia in una mattinata indimenticabile, mentre stavo per uscire, un
fattorino consegnò un baule che, per tipo e colore, era identico a uno di
quelli che il mio ospite si era portato da Parigi. Mi meravigliai, perché avevo creduto che tutti i suoi bagagli fossero a casa mia. Duponte sembrava
però aspettarne l'arrivo e mi fece cenno di ritirarlo.
Leggevo i giornali ogni mattina prima di aggiungerli alla sua collezione.
Nonostante tutto l'interesse improvviso per la morte di Poe, i quotidiani
non contenevano nulla di simile a una vera indagine, soltanto aneddoti e
pettegolezzi. Un articolo proponeva una nuova spiegazione per i vestiti logori e troppo grandi con cui il poeta era stato rinvenuto.
«Il direttore di questo giornale ha saputo (dal barone Dupin, non ho
dubbi) che gli indumenti inusitati di Poe costituivano una sorta di travestimento!»
«Certo, monsieur» disse Duponte, mettendosi il monocolo ma senza
quasi degnare il pezzo di un'occhiata.
Ero allibito. «Eravate già giunto a questa conclusione?»
«No.»
«Allora perché mi rispondete dicendo: "Certo"?»
«Intendevo dire: "Certo è che il quotidiano ha commesso un errore madornale".»
«Ma come fate a saperlo?» insistetti.
«I quotidiani commettono quasi sempre errori madornali» spiegò. «Se
doveste trovare uno dei dogmi della vostra religione stampato sulla pagina,
probabilmente sarebbe ora di riconsiderare la vostra fede.»
«Ma monsieur! Avete trascorso gran parte di ogni giornata leggendo periodici al tavolo della mia biblioteca! Perché sprecare tutto quel tempo?»
«Occorre notare i loro sbagli, monsieur Clark, per avanzare verso la verità.»
Lo fissai finché proseguì.
Inarcò le sopracciglia in un modo tipicamente francese. «Una dimostrazione. Prendete questa faccenda dei vestiti del signor Poe citata dal vostro
quotidiano. Di recente l'"Observer" di Richmond ha scritto che, qualche
giorno prima del suo arrivo a Baltimora, Poe aveva inavvertitamente scambiato il suo bastone da passeggio con la canna di Malacca di un certo dottor John Carter, un suo amico di Richmond. Nel medesimo giornale leggiamo una teoria ridicola, un poco diversa dalla tesi altrettanto erronea del
travestimento: gli indumenti di Poe sarebbero stati rubati e sostituiti durante una rapina a Baltimora. Mettere i vestiti in una posizione preminente,
poiché sono visibilissimi a coloro che hanno rinvenuto Poe, equivale a sottomettere la ragione alla fantasia.»
«Come fate a escludere, senza ulteriori informazioni, che gli abiti siano
stati trafugati in quella maniera?»
«Avete mai sentito parlare di un ladro che ruba i vestiti di qualcuno (cosa alquanto rara) per poi rimpiazzarli con altri abiti? Un'idea che potrebbe
venire soltanto a chi non è un ladro. I direttori dei giornali si sono limitati a
scegliere una rapina, la situazione negativa più frequente in cui potrebbe
incappare un turista, e l'hanno modificata in maniera che il risultato finale
combaciasse, senza tener conto della verosimiglianza. A ogni modo, basta
la natura particolare della canna presa a prestito per dimostrare che si tratta
di un'ipotesi assai inverosimile.»
Nell'articolo cui Duponte si riferiva, l'«Observer» affermava che Poe aveva fatto visita al dottor Carter e che, dopo aver giocherellato con la sua
canna di Malacca, se n'era impadronito senza volerlo. Carter aveva anche
asserito che Poe aveva lasciato nel suo studio un'edizione delle Melodie irlandesi di Thomas Moore del 1819. «Ma ciò non dice alcunché riguardo
alla canna, a eccezione che era "di Malacca". Come fate a dedurne che aveva una natura particolare?»
Duponte aveva già cambiato argomento. «Vi dispiacerebbe portarmi il
baule che è arrivato stamani?» disse.
Ero perplesso, e un poco irritato, perché quella richiesta avrebbe interrotto il nostro discorso, e soprattutto perché avevo già riposto il baule nei
suoi appartamenti. Salii al piano di sopra e quindi lo spinsi fino in biblioteca. Duponte mi ordinò di sollevare il coperchio. Obbedii. Sgranai gli occhi
dinanzi al contenuto.
Chinandomi, allungai il braccio con riverenza. Sul fondo, vi era un unico
oggetto. «Questa è...?»
«La canna di Poe. Sì.»
La raccolsi delicatamente con entrambe le mani e chiesi, con rinnovato
stupore verso il mio ospite: «Duponte, come diavolo...? Com'è accaduto
che la canna di Poe finisse nel vostro baule?».
«Non è proprio quella che lo scrittore aveva al momento del suo decesso, bensì una del medesimo genere, possiamo esserne certi. Il fatto che la
canna presa a prestito da Poe sia stata definita "di Malacca", come avete
appena letto, rivela molto più del genere di legno utilizzato. Ho immaginato che, in America, si vendesse un modesto numero di canne ricavate da
quella particolare palma che cresce sulle coste della penisola malese, in regioni isolate. Durante la mia camminata dell'altro giorno, ricorderete che vi
ho detto di essermi fermato in alcuni negozi. Dopo aver parlato con alcuni
venditori di bastoni da passeggio, mi sono reso conto che la mia ipotesi era
esatta: vi sono soltanto quattro o cinque categorie di canne di Malacca a
Baltimora, e probabilmente anche a Richmond. Ne ho acquistata una per
tipo. Quindi ho vuotato uno dei miei bauli e le ho inviate con un fattorino
al Washington College Hospital, dove Poe si è spento, insieme a un biglietto per il dottor Moran, il medico che l'ha curato. Il messaggio precisava che una spedizione diretta a Richmond si era mescolata con altre canne
e gli chiedeva gentilmente di individuare quella usata da Poe e di rispedirla
qui» spiegò.
«Ma come facevate a sapere che il dottor Moran aveva spedito il bastone
a Carter?»
«Oh, non credevo che l'avesse fatto, ecco perché non avrebbe giudicato
bizzarra la mia richiesta. Era più probabile che il dottor Moran avesse inviato tutti gli effetti personali a uno dei parenti di Poe, magari a Neilson, il
vostro conoscente. Costui, a sua volta, avrebbe cercato di restituire gli og-
getti ai rispettivi proprietari. In segno di gratitudine per il suo favore, ho
scritto al dottor Moran che poteva tenere le altre tre canne di Malacca.
Come speravo, Moran me ne ha rispedita una. Notate qualcosa di speciale
nella canna, monsieur Clark?»
«Se Poe fosse stato aggredito durante una rapina» risposi, avvedendomi
dell'importanza di quel dettaglio, «i ladri si sarebbero senz'altro impadroniti di un bastone tanto pregiato.»
«Siete arrivato più vicino alla verità scoprendo ciò che è falso.» Duponte
annuì con aria di approvazione. «E ora questa canna è vostra.»
La mia successiva commissione in città (non ricordo dove) fu anche un
ottimo pretesto per usare il mio nuovo bastone da passeggio. Era un ornamento assai elegante. Mi indusse persino a prestare maggior cura al mio
abbigliamento, e impiegai la ponderatezza di uno statista nella scelta di un
cappello e di un panciotto adatti al nuovo accessorio. Diverse rappresentanti del gentil sesso, sia tra le signore più giovani sia tra le loro chaperon,
mi guardarono con visibile ammirazione mentre attraversavo la città vecchia.
Ah già, la commissione. Dovevo recarmi da due tizi noiosi che mi avevano pregato di passare da loro per discutere di alcuni investimenti lasciatimi in eredità da mio padre. Il ritardo nella costruzione del prolungamento
della Baltimore & Ohio Railroad fino al fiume Ohio aveva danneggiato
molti interessi, e mi avevano affibbiato una spessa cartella di documenti
che richiedevano la mia attenzione. Naturalmente, con tutte le altre cose
che stavano capitando, avevo avuto poco tempo per leggere quelle carte
con meticolosità.
Quel pomeriggio, mi ritrovai nel quartiere in cui Poe era stato rinvenuto
nell'ottobre del 1849. Decisi di andare all'hotel Ryan, il luogo in cui il poeta si era presentato in condizioni deplorevoli. Mi domandai che cosa sarebbe stato possibile fare o dire (per salvare Poe, o almeno per rassicurarlo) in quei momenti cruciali di due anni addietro.
Le mie melanconiche fantasticherie furono interrotte da alcune urla che
provenivano da dietro l'angolo. Non vi era nulla di insolito nei rumori sporadici lungo le vie di una città come Baltimora, dove il vociare e lo sferragliare delle autopompe proseguivano anche durante la notte, sfociando talvolta in risse tra caserme di pompieri rivali o aggressioni a gruppi di forestieri. Quello strillo solitario, crepitante come l'aria della morte in un'opera,
mi fece tuttavia venire i brividi.
«Reynolds...!»
«Reynolds!»
Quello era il nome che Poe aveva pronunciato prima di spirare.
Orbene, rammentate dove udii quell'urlo. Dinanzi all'hotel in cui avevano trovato Poe prima di trasferirlo all'ospedale. Immaginate il mio disorientamento, come se fossi appena entrato nella vita di qualcun altro... nella morte di qualcun altro.
Avanzai con circospezione. Il grido riecheggiò ancora.
Dopo aver svoltato nella strada successiva, mi addentrai fra le ombre di
un angusto passaggio tra due edifici, seguendo i suoni. Un uomo basso con
gli occhiali e una giacca a coda di rondine mi oltrepassò, costringendomi a
spiccare un salto indietro, e ora riconobbi la voce del tale che gli stava alle
costole.
«Suvvia, signor Reynolds!» tuonò l'inseguitore.
«Lasciatemi in pace, siate gentile» replicò Reynolds.
«Buon signore» protestò Claude Dupin «devo rammentarvi che sono un
tutore volontario dell'ordine.»
«Un tutore volontario dell'ordine?» ripeté Reynolds, scettico.
«Per la Corona britannica» specificò il barone, patriottico.
«La Corona britannica!» esclamò Reynolds. «Perché questo dovrebbe
autorizzarvi a infastidirmi? Al diavolo la Corona, allora!»
«Un profondo interessamento può forse essere considerato un fastidio?
L'uno è l'esatto opposto dell'altro. Desidero soltanto conoscere tutta la storia, per la vostra incolumità.» Il barone sorrise. Parlava con la sua consueta
vivacità, e questa volta non indossava la sua ispida parrucca.
«Ma non ho nessuna storia da raccontare!»
«Non vi siete ancora reso conto di averne una. Mio caro Reynolds, vi
sono persone assai interessate agli accadimenti di quel giorno, come avrete
constatato di recente leggendo i giornali. La vostra reputazione, la vostra
attività di falegname e il buon nome della vostra famiglia potrebbero essere in pericolo se la verità non verrà prima sviscerata a sufficienza. Quel
giorno eravate al Ryan. Avete veduto...»
«Non ho veduto alcunché» dichiarò Reynolds. «Nulla che fosse fuori
dell'ordinario. Era una giornata elettorale. La corruzione dilagava, naturalmente! L'anno prima era scoppiato un violento tafferuglio per l'elezione
dello sceriffo... Entrambe le parti con i loro sostenitori. Le giornate elettorali sono piuttosto turbolente a Baltimora, signor barone.»
«"Barone" è sufficiente, caro amico. Poe ha chiamato "Reynolds" a gran
voce mentre giaceva in punto di morte nella sua stanza d'ospedale.» Dunque Claude Dupin aveva scoperto anche quello. «Non ritenete che sia fuori
dell'ordinario? Anzi, che sia straordinario? Poe aveva qualche motivo per
ricordarsi di voi nelle sue ultime ore?»
«Non ricordo di aver conosciuto alcun Poe là dentro. Potete chiedere agli altri segretari di seggio. Vi chiedo ancora di scusarmi.»
Dopo che Reynolds si fu allontanato, mi sporsi dal muro dietro cui mi
ero nascosto quanto bastava per vedere l'espressione del barone. Rimase
immobile. Aveva un sorriso obliquo, come se avesse assaggiato qualcosa
di acido o avesse appena rubato il portafoglio a Reynolds (ci sarebbe stato
da meravigliarsi se l'avesse fatto?). Qualunque cosa facesse, il barone appariva compiaciuto e trionfante. Benché fosse un avvocato in disgrazia che
fuggiva dai creditori (e benché ora Reynolds non volesse avere nulla a che
fare con lui), in genere aveva fiducia nelle sue possibilità.
Da solo sulla strada, si passò più volte la lingua sul labbro inferiore,
quasi si stesse preparando per un nuovo discorso. Il suo volto e il suo portamento parevano privi di vita quando non aveva nessuno da lusingare o
contro cui sbraitare. Le sue pompe e i suoi ingranaggi dovevano muoversi
senza posa. La scintilla del suo intelletto si riaccese quando pronunciò
un'unica parola tra sé e sé: «Dupin!».
Ringhiò «Dupin» come se fosse una bestemmia. È senz'altro strano che
un uomo disprezzi il proprio nome in quel modo, quasi quanto lo sarebbe
se si sferrasse un pugno al mento. È meno strano, forse, se non lo considerasse il suo nome, bensì l'eredità e il patrimonio che disapprovava. Il barone era tuttavia il tipo da reputarsi il culmine, e non la propaggine, di tutto
quanto l'aveva preceduto. Se qualcuno gli avesse domandato chi fossero i
suoi avi, probabilmente avrebbe risposto: «Un avo sono io», come l'imperatore Napoleone ai potentati reali.
No. La sua imprecazione, «Dupin», non era diretta a se stesso né alla sua
famiglia. Il barone non intendeva evocare nient'altro che la figura di C.
Auguste Dupin. Il personaggio di cui voleva rivendicare la paternità, l'autorità. Perché borbottava in quella maniera riguardo al Dupin letterario?
L'illusione cui si aggrappava sin dal nostro primo incontro a Parigi, la convinzione di essere il vero Dupin, era ormai un'ossessione troppo potente
per lui, e se mai fosse riuscito ad ammetterlo, l'avrebbe fatto soltanto
quando fosse stato completamente solo, come credeva di essere in quel
momento nella via. Non poteva argomentare, intimidire o spacciarsi per il
vero Dupin, com'era avvezzo a fare nella vita e in tribunale. O lo era o non
lo era. La scena aveva un che di disperato, di volgare. Pensai che forse sarebbe stato disposto a qualche concessione, che si stesse apprestando a cedere. Mi sbagliavo.
Mi appoggiai a un palo che sosteneva la tenda di un centro di dagherrotipia. Di lì a poco comparve una carrozza dall'aria familiare. Era la medesima vettura a nolo che aveva aspettato il barone e Bonjour qualche sera
addietro. Potevo solo immaginare come Claude Dupin avesse blandito o
minacciato il cocchiere per assicurarsi l'uso esclusivo del veicolo. Bonjour
smontò. In cassetta, sedeva il nero snello e dalla pelle chiara che avevo veduto durante il nostro precedente incontro. In seguito, venni a sapere che il
barone aveva ingaggiato Newman, quell'esile schiavo ancora adolescente,
affinché guidasse la carrozza e consegnasse messaggi per suo conto. Gli
aveva promesso che, se si fosse comportato bene, l'avrebbe riscattato dal
suo padrone.
In francese, Bonjour sussurrò a suo marito che «lo incontreremo al cimitero di Baltimora» al calar delle tenebre. Non udii altro.
Tornato a Glen Eliza, estrassi lo stradario dallo scaffale. Il barone Dupin
aveva affermato che Reynolds era un falegname. Accanto all'ingannevole
cognome abbinato a quell'occupazione e a un indirizzo poco distante dal
luogo in cui avevo veduto i due uomini, lessi:
REYNOLDS, HENRY, CARPENTIERE,
ANGOLO TRA FRONT E LOW STREET
Che cosa mai poteva aver avuto a che fare con Poe l'anonimo falegname
che avevo scorto nel vicolo? Dopo tutto, le uniche persone che non necessitano mai di un falegname sono i turisti, come Poe lo era stato a Baltimora. Questo fatto potevo dedurlo senza l'aiuto del raziocinio. E quel particolare signor Reynolds aveva negato di aver veduto il poeta.
Ripensai ai commenti del barone Dupin. Aveva insinuato che Henry Reynolds era stato con Poe al Ryan, che avesse assistito a qualcosa. Rimasi
seduto domandandomi con gravità perché quel Reynolds fosse stato con
Poe in quel momento infelice e come Claude Dupin ne fosse venuto a conoscenza.
Reynolds aveva accennato alle elezioni («Le giornate elettorali sono
piuttosto turbolente a Baltimora, signor barone») e agli altri «segretari di
seggio». Forse era andato al Ryan per via delle elezioni, giacché quel giorno l'hotel era stato utilizzato come sede della quarta sezione. Frugai tra la
nostra collezione di giornali. Mi fermai quando trovai il «Sun» del 3 ottobre 1849, la data in cui avevano rinvenuto Poe al Ryan di Baltimora in
«condizioni spaventose», come riferiva un quotidiano.
Lì, sulla pagina politica, compariva il nome «Henry Reynolds», accompagnato da un lungo elenco dei segretari di seggio di Baltimora, uomini
che facevano giurare gli elettori e sorvegliavano le procedure. Reynolds
era uno dei segretari della quarta sezione, che aveva sede al Ryan. Quello
era il suo seggio locale, il che spiegava perché il barone l'aveva braccato
così vicino all'hotel: il falegname abitava poco lontano.
Ero impaziente di confidare a qualcuno la mia scoperta. Ma se l'avessi
rivelata a Duponte, mi avrebbe sicuramente rimproverato. Mi avrebbe
rammentato con atteggiamento filosofico il suo precedente impegno a non
interpellare i testimoni. «Possiamo dedurre tutto quel che ci serve indirettamente» avrebbe affermato. Inoltre, avrebbe aggiunto, il barone Dupin
aveva già interrogato Reynolds; aveva contaminato il carpentiere, se non
addirittura quasi tutta la popolazione di Baltimora.
Mi ripetei in silenzio che Duponte era il più illustre analista del mondo,
che il mio contributo non sarebbe dovuto andare oltre la soddisfazione dei
suoi bisogni. Ormai non riuscivo tuttavia a smettere di chiedermi chi fosse
il misterioso uomo che, secondo quanto avevo origliato, il barone e Bonjour avrebbero dovuto incontrare quella sera nella pericolosa zona del cimitero di Baltimora. Non potevo fare a meno di domandarmelo, e di chiedermi se il loro appuntamento avesse qualche legame con Reynolds.
Quando calò la sera, uscii con il pretesto di andare a prendere una boccata
d'aria.
Dopo aver noleggiato una carrozza, percorsi le strade verso un quartiere
nord-orientale della città dove sarebbe stato preferibile recarsi durante il
giorno. Nei pressi del camposanto, la vettura si arrestò bruscamente. I cavalli tremarono e tirarono il morso.
«Avete perduto il controllo degli animali?» chiesi.
«No, signore, credo di no.»
«Fermatevi qui! Vado a piedi.»
«Qui, signore? Volete andare a piedi da qui?»
Mi sarei posto il medesimo quesito se non fossi stato tanto ansioso di
saperne di più su Claude Dupin. Varcai con esitazione il cancello del cimi-
tero e rimasi sul bordo, il più vicino possibile al lampione tra Fayette e
Broadway Street.
Distinsi la vettura del barone dinanzi a me e mi tenni abbastanza lontano
da nascondermi nel buio. Vidi che trasferivano un pesante involto sul veicolo, quindi un'altra figura si dileguò nell'oscurità. Pur sforzandomi di non
dare nell'occhio, fui assalito da un'ondata di panico quando la carrozza ripartì. Non avevo alcuna voglia di restare solo in quel regno di morti durante la notte (nessun abitante di Baltimora ne avrebbe avuta), e zampettai via
con la rapidità di un roditore.
Affrettandomi ora verso la destra del cimitero, seguii il rumore della vettura in direzione del Washington College Hospital. Quel grande edificio di
mattoni, con due torri severe che si stagliavano in alto, non era meno tetro
del camposanto poco distante. Infatti, di recente, il corpo docenti dell'università aveva deciso che quella sede era troppo lontana dal centro di Baltimora e ora la costruzione veniva usata come ospedale solo raramente.
Dopo aver dato fondo alle sue risorse finanziarie per il trasferimento in un
nuovo fabbricato, l'università stava cercando di vendere quella lugubre
struttura e il terreno circostante.
La carrozza del barone era parcheggiata lì accanto. Il cancello era chiuso.
«Basta corpi!» mi gridò una voce da una delle finestre anteriori.
Ignorando quella bizzarra esclamazione mi stavo apprestando a esaminare di nuovo il cancello, quando il custode riapparve in preda all'agitazione.
«Non ci servono altri corpi! Ne è appena arrivato uno!»
I medici utilizzavano i cadaveri da poco deceduti per iniziare i loro allievi alla chirurgia. I profanatori di tombe si intrufolavano furtivamente nei
cimiteri e impiegavano un'asta di ferro con un gancio all'estremità per praticare un foro nella bara. Quei pescatori di corpi afferravano il defunto da
sotto il mento e lo estraevano dalla sua fossa, talvolta solo qualche ora dopo che aveva ricevuto una sepoltura dignitosa. Anche tra i più coraggiosi
abitanti di Baltimora pochissimi si avventuravano nei pressi del cimitero e
del Washington College Hospital durante la notte, giacché si mormorava
che, quando non erano disponibili nuovi corpi, i passanti venivano aggrediti, uccisi e poi usati per il medesimo scopo, con la consueta ricompensa
di dieci dollari per i rapitori.
«Avete capito adesso? Basta corpi.» La faccia mi guardò strizzando gli
occhi dalla sua posizione dietro la finestra.
«Le mie scuse, signore» dissi.
Si ritirò all'interno. Camminai lungo la recinzione finché ne trovai una
parte che giaceva tra il fango e la scavalcai. Il portone dell'ospedale era ancora aperto dopo il recente ingresso del barone Dupin e di Bonjour.
Quell'ala dell'edificio sembrava deserta. Faceva molto più freddo dentro
che fuori, come se la vecchia costruzione solidificasse e congelasse l'aria.
Sussultavo ogni volta che udivo un rumore, temendo che il custode mi avesse sentito entrare e stesse per sorprendermi, ma ben presto mi avvidi
che le porte e le finestre di tutta la gigantesca struttura sbattevano a causa
del forte vento.
Mi inerpicai su per le scale con circospezione e, dopo aver raggiunto il
terzo piano, percepii alcune voci confuse che provenivano dall'alto. Sembrava che il barone e Bonjour discorressero con qualcuno in un'aula del
quarto piano. I gradini curvavano tuttavia proprio accanto al locale, e poiché l'uscio era aperto, non avrei potuto oltrepassarlo senza che mi vedessero. Allo stesso tempo, captavo solo frammenti della loro conversazione.
«Ve l'ho già detto» affermò una voce sconosciuta.
Mi guardai intorno. Se non fossi riuscito a salire in fretta servendomi di
un mezzo diverso dalle scale, avrei fallito nel mio intento. Pareva che non
vi fosse una rampa posteriore. Vi era tuttavia uno sgabuzzino pieno di fusti. Spostando due coperchi alla ricerca di qualche attrezzo utile, trasalii
quando scoprii che erano colmi fino all'orlo di ossa umane.
Avvilito per essere andato fin lì per nulla, individuai ben presto un vano
cavo nella parete, una sorta di montavivande molto spazioso. Benché l'interno fosse buio, a eccezione della luce che filtrava da ciascun piano, mi ci
infilai dentro e mi accorsi che vi erano un argano e una carrucola. L'apparecchio saliva da sotto e proseguiva verso l'alto, proprio fino all'aula. Un
bel colpo di fortuna!
Constatando che il mio corpo entrava con sorprendente facilità in quel
vano, posai il cappello sul pavimento, strinsi le gambe il più possibile intorno alla fune e mi issai tirando l'estremità opposta della corda. L'aria era
viziata e maleodorante. Mi sforzai di non guardare giù mentre mi approssimavo al quarto piano. Le frasi diventavano via via più chiare.
Lo sconosciuto aveva una voce tonante, teatrale quasi quanto quella del
barone.
«E ora i giornali mi perseguitano. Non capisco perché dobbiamo discuterne ancora.»
«I dettagli» spiegò Bonjour con calma. «Ci servono tutti i dettagli.»
«Vedete» intervenne Claude Dupin, completando il pensiero di Bonjour,
«siamo vicini a comprendere con esattezza che cosa è capitato a Poe nella
singolare giornata in cui l'hanno condotto da voi. Voi, caro Moran, sarete
l'eroe in una storia d'ingiustizia.»
Una pausa carica di curiosità. Frattanto, esaminai il tunnel buio e angusto che mi circondava. Quando tastai la parete alla ricerca di un appiglio,
sentii che era fredda e viscida. Poi due occhi rossi si materializzarono in
una fessura, e un ratto, allarmato dalla mia mano sul suo nascondiglio, si
allungò nella mia direzione. «Shh» lo supplicai. Il suo spaventoso sguardo
color sangue mi fece quasi scivolare verso il basso, ma il desiderio di carpire qualcos'altro mi spinse a salire ancora.
L'accenno alla possibilità di divenire un eroe parve conferire vivacità alla voce di Moran quando riprese a parlare. «Edgar Poe è stato portato qui
un mercoledì pomeriggio, intorno alle cinque, con una vettura a nolo. Il
cocchiere mi ha aiutato a scaricarlo. L'ho pagato personalmente.»
«Non c'era nessun altro sulla carrozza, a parte Poe e il cocchiere?» domandò il barone.
«No. Vi era soltanto un biglietto del dottor Snodgrass, il famoso editore,
secondo cui l'uomo all'interno era Edgar Poe e necessitava di assistenza.
Gli abbiamo assegnato una camera assai comoda al secondo piano della
torre, con una finestra affacciata sul cortile. Era del tutto assente: non sapeva chi l'avesse condotto qui o con chi fosse stato in precedenza.»
«Che cosa ha detto il signor Poe? Ha pronunciato il nome Grey o E. S.
T. Grey?»
«Grey? No. Ha parlato, ma si trattava di conversazioni insensate con oggetti immaginari sulle pareti. Era pallido, ricordo, e madido di sudore. Abbiamo cercato di tranquillizzarlo. Naturalmente, ho tentato di strappargli
altre informazioni. È riuscito a farfugliare che aveva una moglie a Richmond. In seguito, ho appreso che non erano ancora sposati; aveva senza
dubbio la mente confusa. Non sapeva quando fosse giunto a Baltimora né
come ci fosse arrivato. Allora gli ho assicurato che presto l'avremmo rimesso in condizione di godere della compagnia dei suoi amici.»
Mentre Moran raccontava, mi arrampicai quasi fino all'aula. La mia mano tesa tastò l'oscurità e atterrò su un materiale solido. Tela, si sarebbe detto. Strizzai gli occhi per vederci meglio. Doveva essere la borsa che avevo
visto caricare sulla vettura del barone al cimitero. La sua porzione inferiore
era ormai a livello della mia testa. Dandole dei colpetti con la mano, mi
accorsi di aver afferrato un piede umano di un morto. All'improvviso capii
che cosa Claude Dupin aveva portato dal camposanto e intuii che quello
non era un montavivande. Il tunnel che avevo scalato serviva per issare i
cadaveri fino agli obitori dei vari piani.
Avevano spostato il corpo dalla corda cui ero aggrappato a un gancio
dentro il vano, e sbirciando nella stanza, compresi perché non l'avevano
trasferito all'interno. Sul tavolo al centro del locale vi era già il cadavere, o
parte del cadavere, di un uomo, coperto con un telo bianco. Poco distante
pendevano dei grembiuli, alcuni puliti e altri insanguinati. Non sarebbero
potuti passare al nuovo soggetto fintantoché non si fossero sbarazzati di
quello vecchio.
Rabbrividii nel vedere quella scena e all'idea di essere così vicino a un
morto. Respirai più in fretta per tentare di calmarmi, ma così facendo avvertii un tanfo rivoltante che prima non avevo notato. La mia presa si allentò.
Sdrucciolai rapidamente giù, sempre più giù, quasi di un intero piano.
Agitando le gambe verso la parete, cercai di ritrovare l'equilibrio per non
precipitare verso una fine certa fra le impenetrabili tenebre sottostanti.
«Che cosa è stato?» chiese Bonjour. «Quel rumore. Viene da dentro il
muro. Il pozzo di sollevamento.»
Tenendomi forte, rimasi immobile come il cadavere che ormai era diversi metri sopra di me.
«Magari il nostro piccolo regalo si è risvegliato, dottor Moran.» Il barone rise come forse nessun uomo aveva mai fatto nelle vicinanze di due
morti. Si sporse nell'apertura e scrutò il vano. Ora mi trovavo al centro del
passaggio buio, e per fortuna la borsa con il cadavere mi nascondeva alla
sua vista. Si ritrasse.
«Non preoccupatevi» li tranquillizzò Moran «qui dentro assicuriamo le
porte e le finestre con funi, e sembra che l'edificio faccia più rumore di
quanto ne abbia mai fatto qualsiasi paziente.»
Poi vidi Bonjour che prendeva il posto di Claude Dupin dinanzi all'apertura e mi sentii pervadere dall'ansia. Si sporse senza paura nello spazio ripugnante.
«Fate attenzione, signorina!» le raccomandò Moran.
Ora Bonjour si gettò nel pozzo, e per un istante ebbi la certezza che sarebbe atterrata su di me. Invece, strinse la corda prima con una mano, e poi
tra le ginocchia per avere maggiore stabilità. Di sopra, Moran doveva aver
protestato, giacché udii il barone che tentava di calmarlo. Mi aggrappai al
muro con tutte le mie forze e pregai per un miracolo. Percepii quasi gli occhi di Bonjour che penetravano il buio proprio sopra la mia testa scoperta.
Si calò verso di me centimetro dopo centimetro, sollevando il mio lato
della fune cosicché mi avvicinassi a lei senza volerlo.
Con gli occhi serrati, ignorando le gocce di sudore freddo, aspettai che
mi scoprisse. Un terribile grido inumano interruppe la mia concentrazione.
A un tratto, un esercito di voraci ratti neri corse su per le pareti del tunnel.
Gli animali si lanciarono in massa verso Bonjour, come se la giovane li
avesse attirati involontariamente. Alcuni mi saltarono sulle spalle e sulla
schiena, le zampe energiche si attaccavano al mio cappotto e mi sfidavano
a non urlare.
«Soltanto topi» borbottò Bonjour dopo un attimo, sferrando calci ad alcune delle creature e rispedendole verso il basso. Il barone allungò una
mano per aiutarla a rientrare nell'aula.
«Santo Cielo» ansimai con gratitudine all'indirizzo dei roditori, scacciandone due che mi erano rimasti appollaiati sul dorso.
Giacché udivo ancora gran parte della conversazione, decisi di issarmi
soltanto di qualche centimetro e di tenermi in una posizione più sicura.
«Siate così gentile da continuare con i dettagli, dottore» lo esortò il barone. «Avete detto a Poe che gli avreste portato i suoi amici.»
Moran tacque, esitante. «Forse dovrei consultare i congiunti del signor
Poe prima di discuterne ulteriormente con voi. Mentre lo curavamo, si sono presentate alcune persone: se non erro, un certo signor Neilson Poe e un
amico, un avvocato, il signor Z. Collins Lee...»
Claude Dupin emise un sonoro sospiro.
«Vediamo che cosa c'è sul tavolo del dottore» intervenne Bonjour in tono vivace. Percepii il fruscio del telo bianco sul cadavere nudo.
«Inaudito!» esclamò Moran con palese imbarazzo. «Che cosa state facendo?»
«So com'è fatto un uomo» rispose Bonjour, allegra.
«Non scandalizzare il giovane medico, mia cara!» strillò il barone.
«Forse dovremmo portarci a casa questo gentiluomo defunto per esaminarlo» continuò Bonjour, spingendo il tavolo. Moran protestò con vigore.
«Suvvia, dottore. Niente compromessi. L'ho trovato e me lo tengo. Inoltre,
barone, mi domando se la famiglia della ragazza che abbiamo issato in
quel vano sarebbe interessata a sapere che il suo corpo è scomparso dalla
tomba e si trova qui, in attesa di essere fatto a pezzi da un medico azzimato» proseguì Bonjour.
«Interessatissima, direi, tesoro» replicò il barone.
«Che cosa? Ma lo facciamo per imparare a salvare delle vite! Siete stati
voi a condurre qui l'altro cadavere!»
«Dietro vostra richiesta, dottore» precisò Bonjour «e voi l'avete accettato
in cambio delle informazioni che il mio padrone desidera.»
«Come potete vedere, avete fatto i conti senza l'oste, dottore» bisbigliò
Claude Dupin, chinandosi verso Moran.
La spavalderia nella voce del medico scomparve. «Adesso capisco il
nocciolo della questione. Benissimo. Torniamo a Poe, allora. Tentando di
confortarlo, gli ho detto che presto avrebbe goduto della compagnia dei
suoi amici. Con molta veemenza, rammento, ha replicato: "La cosa più
bella che il mio miglior amico potrebbe fare sarebbe farmi saltare il cervello con una pistola". Quando si è reso conto delle sue condizioni, ha dichiarato di voler andare al Creatore e cose del genere, come accade quando si è
di umore depresso. Quindi è scivolato in un violento delirio fino a sabato
sera, quando ha cominciato a chiamare "Reynolds" senza sosta, per sei o
sette ore fino al mattino, come vi ho raccontato l'altro giorno. Indebolito
per lo sforzo, ha aggiunto: "Che il Signore aiuti la mia povera anima" e si è
spento. Ecco tutto.»
«Vorremmo sapere» riprese il barone «se Poe fosse stato indotto ad assumere qualche tipo di stimolante artificiale, una droga (l'oppio, magari)
che potesse averlo ridotto in quello stato.»
«Non lo so. La verità, signore, è che le condizioni di Poe erano assai tristi e singolari, ma, che io ricordi, la sua persona non emanava alcun odore
di alcol.»
Durante quel colloquio, oscillai tra l'attenzione scrupolosa alle loro parole e i tentativi disperati di calmare il mio cuore martellante e la mia respirazione affannosa, dovuti al fatto di essere stato quasi scoperto da Bonjour.
Quando il dialogo si concluse con soddisfazione del barone, e i loro passi
mi diedero la certezza che avevano lasciato il quarto piano, mi arrampicai
oltre il corpo e mi sollevai attraverso l'apertura nella parete. Controllai che
la via fosse libera e mi lasciai cadere nell'aula. Appiattendomi sul pavimento, espulsi l'aria dei morti e inspirai in rapidi ansiti riconoscenti.
Forse mi giudicherete con asprezza perché non narrai subito le mie avventure a Duponte, eppure avete veduto con i vostri occhi la frequente inflessibilità delle sue elucubrazioni. Io non possiedo un'indole particolarmente filosofica. Duponte era un analista, un ragionatore per natura; io, un
osservatore. Pur occupando solo uno dei gradini più bassi sulla scala della
saggezza, l'osservazione richiede senso pratico. Forse Duponte, e le nostre
indagini in generale, necessitavano di una lieve spinta verso il pragmatismo.
Prima, mentre cercavo qualche accenno a Henry Reynolds, avrei dovuto
spiegare com'era possibile che avessi libero accesso ai giornali della biblioteca senza che Duponte se ne avvedesse. Sin dal primo giorno in cui
eravamo sbarcati a Baltimora, l'analista aveva tramutato quella stanza nel
suo rifugio e ne aveva sorvegliato l'intero contenuto. Tuttavia, quando leggeva altre cose, si trasferiva da quel locale, sempre più ingombro, in sale e
camere da letto di Glen Eliza di cui avevo scordato l'esistenza. Sceglieva
un volume a casaccio dal mio scaffale, uno degli atlanti di mio padre dedicato a un'oscura provincia del mondo oppure un libello francese che mia
madre aveva portato dall'estero. Leggeva anche Poe, una consuetudine che
non sfuggì alla mia attenzione.
Talvolta la concentrazione con cui leggeva Poe mi rammentava il nutrimento che i racconti dello scrittore mi aveva fornito per tanti anni. Di solito, tuttavia, il suo atteggiamento era molto più simile a quello di un erudito. Duponte leggeva con meccanicità, come un critico letterario. Il critico
non permette mai alla lettura di sopraffarlo; non si avvicina mai le pagine
al volto in maniera casuale e non desidera mai penetrare nei recessi della
mente dell'autore, giacché un simile viaggio lo costringerebbe a rinunciare
al controllo sull'opera. Così, dopo aver già letto il libro, il lettore, ansioso
di udire altri pareri, incappa sovente nella recensione del critico in una rivista e pensa: «Questo non può essere il testo che ho letto. Deve esserci
un'altra versione in cui tutto è cambiato, e devo procurarmela anch'io».
Ritenevo che un esame imparziale degli scritti di Poe da parte di Duponte potesse essere assai utile. Ora credo che gli abbia offerto intuizioni essenziali sulla personalità di Poe e sulle misteriose circostanze su cui avevamo iniziato a investigare.
«Se solo sapessimo su quale nave Poe è giunto a Baltimora» osservai un
pomeriggio.
Duponte si entusiasmò subito. «I quotidiani locali parlano di dettagli
sconosciuti inerenti al suo arrivo. Il fatto che loro non li conoscano, monsieur, non li confina certo nell'ambito dell'ignoto. La risposta è formulata
con chiarezza negli articoli dei giornali di Richmond pubblicati negli ultimi mesi della sua vita.»
«Mentre Poe teneva conferenze su vari argomenti di poesia e letteratura.»
«Esatto. Come accenna anche nelle lettere indirizzate a voi, monsieur
Clark, le teneva per raccogliere denaro destinato a "The Stylus", la rivista
che voleva fondare. Forse non sappiamo su quale nave Poe sia partito da
Richmond per Baltimora, ma non è questo l'importante, e non contribuisce
a rendere oscuro lo scopo del viaggio. Il motivo della sua venuta a Baltimora è facilmente intuibile da chiunque faccia uso della ragione. Stando
alle voci diffuse dai quotidiani nei due anni precedenti al suo decesso, Poe
aveva stretto varie unioni sentimentali dopo la scomparsa di sua moglie. In
quell'ultimo periodo, si era appena fidanzato con una donna abbiente di
Richmond, sicché è probabile che non sia venuto a Baltimora per un interludio romantico. Orbene, considerando che i direttori di tutti i periodici sapevano che la sua promessa sposa, una certa signora Shelton, era benestante, e naturalmente che lo sapevano anche tutti gli altri, giacché di rado i direttori dei giornali sanno qualcosa che la marmaglia non sappia per prima... considerando, dicevo, che la ricchezza della signora Shelton era di
dominio pubblico, forse Poe aveva avvertito la comprensibile esigenza di
smentire il sospetto che volesse sposarla perché era "un buon partito".»
«Non si sarebbe sicuramente sposato per soldi!»
«Le sue intenzioni in questo senso, e la vostra indignazione dinanzi a tale ipotesi, sono del tutto ininfluenti, poiché il risultato è lo stesso. Ciò
semplifica la nostra indagine. Se Poe avesse voluto sposarla per denaro,
avrebbe avuto una ragione in più per smentire quei sospetti: evitare di rovinare il fidanzamento qualora la signora avesse avuto qualche dubbio. Se
le sue motivazioni erano pure, come credete voi, il suo obiettivo sarebbe
stato il medesimo: raccogliere fondi, questa volta per provvedere alle proprie spese anziché attingere ingiustamente al patrimonio della sua futura
moglie. In un modo o nell'altro, avvedendosi di non aver guadagnato quanto sperava a Richmond, sarebbe venuto a Baltimora per assicurarsi un poco
di sostegno professionale e qualche sottoscrittore per "The Stylus", consolidando così le sue prospettive finanziarie a prescindere da quelle della signora Shelton.»
«Il che spiega perché è andato innanzi tutto da Nathan Brooks, giacché
costui è il direttore di alcune riviste famose. Solo che, come ho potuto constatare di persona» aggiunsi con mestizia «la casa del dottor Brooks è stata
distrutta da un incendio.»
«Poe è venuto qui, monsieur Clark, accarezzando alcuni progetti che gli
avrebbero consentito di rifarsi una vita. Scopriremo, credo, che è morto
pieno di speranza, non in preda alla disperazione.»
Ricordai tuttavia l'affermazione del dottor Moran: Poe non sapeva quan-
do fosse giunto a Baltimora e come vi fosse arrivato. Come collimava tutto
ciò con i dettagli appena emersi?
Quella conversazione con Duponte si svolse qualche giorno dopo la mia
visita segreta all'ospedale. Frattanto, recandomi alle sale di lettura o sbrigando qualche commissione in città, mi sentii addosso un numero sempre
maggiore di occhi. Forse, pensai, quella sensazione era il prodotto inconscio del senso di colpa che provavo per aver nascosto a Duponte le mie
precedenti scoperte, oppure del mio turbamento ogni volta che rammentavo l'angoscia di Hattie durante il nostro ultimo incontro davanti al cancello
di casa sua.
Vi era un uomo in particolare, un nero libero sulla quarantina, che scorsi
vicino a me in più di un'occasione tra la folla per strada o dal finestrino
della carrozza in cui viaggiavo. Aveva lineamenti assai spigolosi e una
corporatura massiccia. Di solito era facile distinguere i neri liberi da quelli
asserviti grazie all'abbigliamento signorile, e sovente molto ricercato dei
primi, sebbene alcuni schiavi di città indossassero vestiti eleganti per non
stonare accanto ai loro padroni.
Ripensai al fantasma che mi aveva pedinato un tempo, molto prima che
mi sognassi di rintracciare un tipo come Duponte o di nascondermi da un
tipo come Claude Dupin; ripensai anche allo sguardo spento di Hartwick,
il tirapiedi del barone, mentre mi seguiva tra i corridoi di Versailles, apprestandosi a rapirmi. Una volta, avvistai il nuovo inseguitore sul lato opposto
della via mentre passeggiavo in Baltimore Street. Non mi stupì che quel
presunto uomo libero stesse parlottando con il barone. Quest'ultimo lo prese a braccetto con entusiasmo.
Quella sera, Duponte stava leggendo Ligeia, un racconto di Poe, su un
sofà del salotto. Van Dantker se n'era andato con i suoi pennelli qualche
ora addietro in uno stato di profonda irritazione. Duponte aveva annunciato che non voleva più vedere lo sguardo fisso dell'artista ogni volta che alzava gli occhi e l'aveva pregato di sedere alle sue spalle. Naturalmente,
Van Dantker aveva obiettato che non poteva dipingere una schiena, ma
Duponte si era rifiutato di discutere, e ben presto aveva ideato un sistema
che prevedeva la collocazione di uno specchio dinanzi a sé e il posizionamento di Van Dantker dietro di sé. Poi aveva posto un altro grande specchio accanto al cavalletto, di fronte al primo, per ripristinare il corretto orientamento del riflesso originale. Avevo pensato che fossero entrambi
pazzi. Mordicchiando la sua olycoke, la strana torta fritta nel lardo che portava sempre con sé, Van Dantker aveva tuttavia proseguito a lavorare al
suo progetto.
Mi tenevo occupato leggendo una copia delle Melodie irlandesi di Thomas Moore, che avevo acquistato da una bancarella. Il dottor Carter, l'amico di Poe a Richmond, aveva comunicato al quotidiano locale che lo scrittore aveva letto le poesie di Moore quando si era recato nel suo studio. Si
mormorava anche che, durante il soggiorno a Richmond, Poe avesse recitato questo verso di Moore a una giovane signora con cui aveva fatto amicizia: Mi sento come qualcuno / che percorre da solo / una sala dei banchetti deserta.
Le mie riflessioni volarono all'angoscioso pensiero di Hattie. «Mi domando una cosa» dissi, interrompendo la lettura di Duponte.
«Sì?»
«Ecco, mi domando se, quando una donna afferma che le cose sono "diverse", intenda che le sue emozioni, ossia i suoi affetti, siano mutati, oppure se si riferisca ad altre questioni, meno profonde.»
«State chiedendo la mia opinione in merito, monsieur?» disse Duponte,
accantonando il volume.
Esitai, augurandomi di non avergli dato l'impressione di voler indirizzare
le sue capacità di raziocinio verso una faccenda puramente personale, sebbene fosse proprio quanto stavo facendo.
Continuò senza aspettare la mia risposta. «Pensate, monsieur Clark, che
le sue parole si riferissero al problema maggiore o minore?»
Ci riflettei su. «Be', qual è il problema maggiore, e quale il minore?»
chiesi.
«Ottima domanda, monsieur. Per coloro che non sono i destinatari diretti
degli affetti di questa signora, la questione del suo stato emotivo sarebbe
quella minore; le condizioni del tetto della sua dimora o il prestito che forse ha ottenuto da una banca, e la possibilità che siano diversi dalla situazione precedente, sarebbero la questione maggiore e principale. Per chi
cerca o ha cercato i suoi affetti, quelle emozioni sarebbero di gran lunga la
questione più importante da chiarire, mentre se il tetto di casa sua crollasse, farebbe poca differenza per il pretendente. Pertanto, la mia opinione è
che il significato delle sue parole varierebbe molto a seconda dell'interlocutore.»
Allibito dalla freddezza dei consigli di Duponte sull'amore, se così si potevano chiamare, non approfondii l'argomento.
Finalmente il campanello suonò. I domestici avevano la giornata libera,
e io ero al piano di sotto. Dopo diversi istanti, Duponte chiuse il libro di
scatto, si alzò con un sospiro e scese fino al portone. Sulla soglia vi era un
tale basso e occhialuto che sbirciava dentro con trepidazione.
«Che cosa desiderate da me, signore?» chiese lo sconosciuto con cortesia.
«Non siete stato voi a venire qui?» ribatté Duponte. «Penso che vi porrei
il medesimo quesito se fossi interessato alla risposta.»
«Ma...?» fece il visitatore, nervoso. «Be', sono Reynolds. Henry Reynolds, posso entrare?»
Assistetti alla scena dal corridoio della cucina. Dopo aver trovato un posto per il cappello, il signor Reynolds mostrò a Duponte il biglietto che aveva ricevuto da me qualche ora prima.
Avevo ipotizzato che forse Duponte avrebbe mostrato maggiore interesse se, dovendo accogliere inaspettatamente Reynolds sull'uscio, avesse potuto attribuirsi il merito della scoperta e, non riuscendo a resistere alla tentazione, gli avesse strappato tutte le informazioni possibili.
Sarebbe andata diversamente. Duponte, con i racconti di Poe stretti tra le
mani, augurò una buona serata allo sconosciuto e mi oltrepassò, dirigendosi verso le scale. Gli corsi dietro.
«Ma dove andate?»
«Monsieur. Avete visite, un certo monsieur Reynolds, credo» rispose.
«Suppongo che voi signori desideriate restare soli.»
«Ma...!» Tacqui.
«Qualcuno mi ha mandato a chiamare?» urlò Reynolds, spazientito, dal
fondo delle scale. «Ho anche altri appuntamenti. Uno di voi due è Clark?»
Raggiunsi Duponte con una scrollata di spalle imbarazzata. «So che avrei dovuto riferirvi di aver lasciato un messaggio a Reynolds perché passasse di qui. Ho veduto il barone Dupin che parlava con quel tale e ho scoperto che era uno dei segretari del seggio elettorale in cui hanno rinvenuto
Poe. Tuttavia quell'uomo non ha fornito alcun ragguaglio al barone. Rimanete solo per un momento. Venite in salotto. Pensavo che, sulle prime, avreste rifiutato, ed è questo il motivo per cui ho agito di nascosto. Ritengo
sia fondamentale interrogarlo.»
Restò impassibile. «Che cosa desiderate che faccia?»
«Sedete nella stanza. Non dovrete dire neppure una parola.»
Naturalmente, speravo che Duponte, incuriosito dai dettagli di cui il falegname era a conoscenza, avrebbe non solo detto qualche parola, ma si
sarebbe anche lanciato in un interrogatorio particolareggiato una volta che
io avessi intavolato la conversazione. Acconsentì a seguirmi in salotto.
«Allora, come stiamo oggi?» Reynolds abbozzò un sorriso cordiale mentre si guardava intorno nel locale gigantesco e alzava gli occhi verso l'imponente cupola che saliva fino al terzo piano. «Intendete ristrutturare la
vostra dimora, signor Clark? La sua bellezza è un poco decadente, se posso
prendermi la libertà di dirlo. Quest'anno ho accresciuto il valore di non pochi palazzi con qualche restauro.»
«Che cosa?» sbottai, allarmato, dimenticando per un attimo la sua professione.
Duponte si accomodò nella poltrona d'angolo accanto al camino. Appoggiò la testa sulla mano, e le dita gli si allargarono in una ragnatela sulla
guancia. Si succhiò la lingua, come era sua consuetudine.
Anziché sentirsi costretto a intervenire per via della situazione, diresse lo
sguardo oltre me e Reynolds, verso un punto indefinito sull'orizzonte della
stanza, mostrando tuttavia un'espressione di divertimento distratto dinanzi
allo sviluppo della conversazione.
«Non ho bisogno di un falegname» confessai.
«Niente falegname? Allora perché avete richiesto la mia presenza, signori?» Reynolds aggrottò le sopracciglia, quindi si infilò in bocca un poco di tabacco, come a dire che, se non vi era alcun lavoro da eseguire, tanto valeva masticare.
«Ecco, signor Reynolds, se posso...» Avevo la bocca asciutta, e le parole
mi uscirono con esitazione.
«Se sono venuto fin qui per divertire voi signori...» cominciò, indignato.
«Abbiamo bisogno di alcune informazioni» spiegai. Mi sembrava un
buon inizio. Le labbra di Duponte si contrassero, e aspettai che parlasse,
ma era uno sbadiglio. Scavallò e riaccavallò le gambe.
La voce di Reynolds soverchiava la mia. «Be', spero di non dovermi ritrovare a pensare di aver sprecato il mio tempo. Sono una figura chiave per
il futuro decoro di Baltimora. Ho contribuito a erigere la biblioteca, ho partecipato alla costruzione del Maryland Institute e ho sovrinteso alla creazione del primo edificio in ferro della città per il "Sun" di Baltimora.»
Cercai di pilotarlo verso l'argomento principale. «Nel 1849 avete fatto il
segretario al seggio elettorale della quarta sezione presso l'hotel Ryan, vero?»
Ora Duponte teneva gli occhi puntati nel nulla. Talvolta i gatti si acciambellano in quella posizione comoda e noncurante come per sprofondare nel sonno, ma dimenticano di chiudere gli occhi. Così appariva Duponte
in quel momento.
«Come dicevo» seguitai a farfugliare «riguardo alle informazioni che
cerco, quella sera, al seggio... alla quarta sezione, intendo, vi era un uomo
di nome Poe...»
«Non credo alle mie orecchie» mi interruppe Reynolds. «Avete qualcosa
a che fare con quel tipo, il barone Tal dei Tali, che continua a tempestarmi
di lettere e messaggi, giusto?»
«Per favore, signor Reynolds...»
«Cianciando di Poe, Poe, Poe! A ogni modo, che cosa c'entra tutto questo con Poe?»
«Come sottintende il signor Reynolds» intervenne Duponte, placido «è
vero che la scomparsa di una persona interessante agli occhi del pubblico
viene guardata per la persona, non per la morte, e così si punteggia di un
maggior numero di errori e percezioni sbagliate. Molto bene, Reynolds.»
Ciò non fece altro che confondere le idee al nostro ospite. Reynolds agitò un dito nella mia direzione, e poi in quella di Duponte, come se l'analista fosse colpevole quanto me di aver organizzato quell'incontro. «Non
credo alle mie orecchie.» Pronunciò quelle parole con tanto veleno da
schizzare saliva nera per tutta la stanza. «Questo è il colmo! Me ne infischio se l'altro tizio è un barone, o se voi siete un re e un lord. Non ho
niente da dirgli e ho molto da fare! Non ho niente da dire nemmeno a voi
due! Capito? Ebbene, miei cari principi, vi prego di non mandarmi mai più
a chiamare o mi rivolgerò alla polizia.»
Il mattino dopo, quando scesi per la colazione, trovai un biglietto in cui
Duponte mi chiedeva di raggiungerlo in biblioteca a mezzogiorno. Non mi
aveva detto una sola parola prima di accomiatarsi per la notte. Con mia
sorpresa, non era interessato tanto al fatto che avessi contattato Reynolds
di nascosto quanto al fatto che avessi veduto Claude Dupin.
«Dunque» esordì quando ci rivedemmo «vi siete ritrovato a seguire il
barone Dupin.»
Gli raccontai tutto quanto era accaduto tra il barone e Reynolds e ciò cui
avevo assistito al cimitero e all'ospedale, giustificandomi per aver voluto
incontrare il carpentiere. «Sapete, monsieur. Poe ha chiamato "Reynolds"
senza tregua prima di morire. Quel giorno, Henry Reynolds era uno dei segretari assegnati al seggio della quarta sezione, al Ryan, dove hanno rinvenuto Poe! Non pensate che sia una coincidenza troppo strana?» Risposi al
suo posto: «È troppo strana per essere ignorata!».
«È tutt'al più secondaria e, in misura minore e più probabile, fortuita.»
Secondaria! Fortuita! Poe che aveva chiamato Reynolds in punto di morte, e un Henry Reynolds che era stato nel medesimo luogo di Poe solo
qualche giorno prima. Duponte possedeva una personalità convincente anche quando era laconico. Se avesse affermato che le cattedrali di Baltimora
erano secondarie per i cattolici della città, l'ascoltatore sarebbe stato incline a trovare un motivo per concordare.
Accettò il mio invito a fare una passeggiata. Speravo che lo rendesse più
disponibile a riflettere sulle mie ultime supposizioni. Ero assai preoccupato
per la nostra indagine, e non solo a causa del suo rifiuto di prendere in
considerazione Reynolds come aveva fatto il barone. Avevo la sensazione
che, isolati come eravamo, forse ci stessimo lasciando sfuggire molti altri
particolari, per esempio la possibilità che Poe avesse viaggiato da Baltimora a Filadelfia e che fosse stato in quella città prima di morire. Accennai a
quell'ipotesi mentre camminavamo.
«Non è così.»
«Intendete che non era stato a Filadelfia nella settimana in cui l'hanno
trovato?» domandai, stupito dalla sua sicurezza. «I giornali hanno seguito
ogni pista per cercare di scoprirlo.»
«La risposta è sotto il loro naso, troppo accessibile per menti affannose
come quelle della stampa popolare, che non perdono mai la fiducia nella
loro capacità di individuare qualche dettaglio veritiero, purché remoto. Si
meravigliano di tutto, quando invece non dovrebbero meravigliarsi di niente. Se un fatto viene descritto una volta, possiamo prestare attenzione, ma
se un fatto viene citato a ogni piè sospinto, ignoratelo, perché, lungo la
strada, la sua ripetizione ha bloccato ogni forma di pensiero.»
«Ma come facciamo a saperlo con certezza? Dopo la visita mancata al
dottor Brooks, non sappiamo alcunché del periodo trascorso da Poe a Baltimora finché l'hanno veduto al Ryan quasi cinque giorni dopo. Come facciamo a escludere che, tra quei due momenti, Poe abbia preso il treno per
Filadelfia? E, in tal caso, come possiamo scartare la possibilità che laggiù,
in quella città, vi siano gli indizi principali per la corretta comprensione
degli eventi successivi?»
«Plachiamo le vostre preoccupazioni in merito. Ricordate le ragioni per
cui monsieur Poe aveva deciso di recarsi a Filadelfia, suppongo» disse.
Le ricordavo, e gliele ripetei. Poe era stato incaricato di curare le poesie
della signora Marguerite St. Leon Loud, lavoro per cui l'agiato marito della
donna gli avrebbe pagato la cifra di cento dollari. Secondo i quotidiani,
Poe aveva accettato quell'accordo proficuo durante le sue ultime settimane,
quando il signor Loud, un fabbricante di pianoforti, era andato a Richmond. Poe aveva persino pregato Muddy Clemm di scrivergli laggiù, a
Filadelfia, sotto l'enigmatico pseudonimo di Egr. Sig. E. S. T. Grey, aggiungendo: «Spero che i nostri guai stiano per finire».
«Cento dollari avrebbero fatto un'enorme differenza per Poe, giacché
aveva molto bisogno di denaro per se stesso e per la sua rivista» osservai.
«Cento dollari per curare un libretto di poesie. Poe, che aveva diretto ben
cinque periodici, mansione per cui aveva ricevuto un compenso appena
sufficiente a sfamare la sua famiglia, avrebbe potuto svolgere quell'incarico a occhi chiusi. Ma, senza prove contrarie, come facciamo a sapere
quando Poe si è recato per l'ultima volta a Filadelfia?»
«Tramite la signora Loud, naturalmente.»
Corrugai la fronte. «Temo che non ci sarà di alcun aiuto. Le ho spedito
alcune lettere, ma non ho ricevuto risposta.»
«Mi avete frainteso. Non intendo scrivere alla signora Loud. Data la natura della sua condizione, aspirante poetessa e moglie di un marito facoltoso, probabilmente in questa stagione sarà al mare o in campagna, sicché la
corrispondenza non servirebbe ad alcunché. Non abbiamo bisogno di importunare quella povera donna per ascoltarla.»
Estrasse un sottile volume finemente stampato dall'interno della giacca.
Wayside Rowers: A Collection of Poems, by Mrs. M. St. Leon Loud, pubblicato da Ticknor, Reed and Fields.
«Che cos'è quello?» domandai.
«È il medesimo libro di poesie, possiamo presumere, che Poe aveva accettato di curare e che è comparso di recente con scarso clamore... per fortuna.»
Lo aprii alla pagina dell'indice. Ho qualche dubbio sull'opportunità di riprodurlo. I Wooed Thee, To a Friend on the Birth of a Son, The Dying Buffalo, Invitation to a Prayer Meeting, It Is I: Be Not Afraid, On Parting with
a Friend, On Seeing a Monument, The First Day of Summer e, naturalmente, The Last Day of Summer. Il sommario proseguiva per intere pagine.
Duponte mi spiegò che aveva ordinato il testo da uno dei librai locali.
«Sappiamo che monsieur Poe non è mai arrivato a Filadelfia per curare
le poesie di madame Loud» dichiarò.
«Come, monsieur?»
«Perché è evidente che nessuno le ha curate, a giudicare dal numero
sproporzionato dei componimenti. Se qualcuno le ha curate (che Dio lo
perdoni), non era di certo un poeta d'esperienza e di solide convinzioni riguardo alla brevità e all'armonia del verso, come sappiamo essere stato
monsieur Poe.»
Sembrava una tesi fondata. Ora mi accorsi dei risultati concreti che Duponte aveva ottenuto trascorrendo ore in salotto con le strofe di Poe.
Avevo tuttavia un dubbio sulle sue conclusioni. «E se, monsieur Duponte, Poe fosse andato a Filadelfia, avesse cominciato a curare le poesie e avesse semplicemente avuto un diverbio con la poetessa, o avesse esitato di
fronte alla qualità della sua opera e fosse tornato a Baltimora?»
«Quesito intelligente, seppur disattento. È possibile che Poe sia giunto
nella proprietà dei Loud per adempiere al suo impegno e, una volta lì, non
abbia accettato le condizioni definitive del pagamento o qualche altro piccolo punto dell'accordo. Nondimeno, ci basta valutare brevemente questa
possibilità per escluderla.»
«Non vedo il perché, monsieur.»
«Consultate di nuovo l'indice. Sono sicuro che questa volta saprete dove
fermarvi.»
Ormai avevamo occupato il tavolo di un ristorante. Duponte si chinò
verso di me, guardando il titolo indicato dal mio dito. «Molto bene, monsieur. Ora leggete i versi di quelle pagine, se non vi dispiace.»
La poesia si intitolava The Stranger's Doom, la fine dello sconosciuto.
Iniziava così:
Si riunirono attorno al suo capezzale,
i suoi occhi spenti erano vitrei e offuscati;
ma fra i tanti curiosi, non vi era
nessuno che piangesse o si desse pensiero per lui.
Oh! Che cosa triste, spaventosa,
morire attorniati soltanto da estranei;
non vedere nella stanza buia
alcun sembiante, alcuna forma, alla memoria cara!
«Assomiglia molto all'episodio verificatosi all'ospedale universitario
mentre Poe si stava spegnendo.»
«Già, come la immagina la nostra autrice. Continuate, per favore. Mi
piace molto la vostra recitazione. È briosa.»
«Grazie, monsieur.» I versi successivi descrivevano la dipartita solitaria
del protagonista senza alcuna mano da stringere, alcun bacio d'addio. Il
componimento proseguiva con la scena della morte:
Eppur così spirò, lungi da tutti coloro
che avrebbero potuto pianger la sua fine prematura!
Mani sconosciute le sue palpebre abbassarono,
e lo condussero verso una tomba senza nome.
Lo deposero dove gli alti alberi della foresta
proiettavan le loro ombre scure sul suo giaciglio,
e in fretta, in silenzio, ammucchiarono
le zolle erbose sopra il suo capo.
Nessuno pregò, nessuno pianse, quando tutto fu finito,
né indugiò accanto a quel luogo sacro;
ma si volsero ancora verso il mondo,
e presto persino il suo nome scordarono.
«Una tomba senza nome... le zolle erbose della tomba che dovrebbe essere sacra... la sepoltura frettolosa durante la quale nessuno indugiò... questo è senz'altro il funerale di Poe al cimitero di Westminster! Descritto
proprio come l'ho veduto io!»
«Abbiamo già ipotizzato che madame Loud sia un'amante dei viaggi,
teoria corroborata dai temi di molte delle sue poesie, sicché ora deduciamo
da questi versi che è venuta a Baltimora negli ultimi due anni, dopo la
morte di Poe. Avvertendo una curiosità naturale verso l'uomo che avrebbe
dovuto incontrare suppergiù nel periodo della sua scomparsa, si è procurata questa descrizione delle esequie, così simile al vostro ricordo, visitando
il cimitero e interrogando il custode o il becchino, e magari anche qualcuno dell'ospedale.»
«Straordinario» commentai.
«Possiamo leggere con maggiore attenzione e trarre varie conclusioni.
Possiamo asserire che condivide la vostra stessa prospettiva, monsieur
Clark, biasimando coloro che non l'hanno onorato. Il componimento non
precisa granché riguardo al luogo in cui Poe si trovava prima di spegnersi
o alla sua condotta. Sappiamo pertanto che madame Loud ha seguito le notizie riguardanti il suo decesso da lontano, non come qualcuno che si era
appena separato da Poe con il privilegio di essere stato messo a parte dei
suoi progetti. Inoltre, la fine è quella di uno sconosciuto, come specifica il
titolo, non di una persona che l'autrice conosceva. Siamo dunque ancora
più sicuri che Poe non aveva incontrato madame Loud a Filadelfia, come
si era riproposto di fare. Questa sarà soltanto la nostra prima prova del fatto che Poe non si era recato in quella città.»
«La prima, monsieur Duponte?»
«Sì.»
«Ma perché Poe avrebbe chiesto alla suocera di scrivergli sotto un falso
nome, E. S. T. Grey?»
«Forse questa sarà la nostra seconda prova» rispose, pur parendo ansioso
di accantonare momentaneamente l'argomento.
Duponte riprese a fare passeggiate. Poté allontanarsi da Glen Eliza
quando, dopo molti bisticci e molte proteste contro le sue stravaganti pretese, Van Dantker decise che avrebbe potuto completare il dipinto anche
senza altre sedute. Non desiderando che quell'uomo ci procurasse ulteriori
distrazioni, gli comunicai che sarei stato io a saldare il conto, ma replicò
che qualcun altro l'avrebbe pagato per il suo lavoro quel pomeriggio. Giacché quella frase non aveva alcun senso, mi recai all'atelier dell'artista, solo
per vedere il barone Dupin che ne usciva, sfiorandosi il cappello e sorridendomi.
Fuori di me, riferii l'accaduto a Duponte, che reagì con una risata all'idea
che Van Dantker fosse una spia.
«Monsieur Duponte, può aver ascoltato ogni nostra parola mentre sedeva lì fingendo di essere concentrato sul dipinto!»
«Quell'imbecille di Van Dantker? Ascoltare ogni parola? Che assurdità!» Fu tutto quello che riuscii a fargli dire in proposito.
Tramutandosi in un osservatore dello «spirito della città», Duponte avanzava a passi lenti come aveva fatto a Parigi. Di solito lo accompagnavo
durante quelle camminate, non volendo perderlo come era accaduto in passato. Quei vagabondaggi si verificavano spesso la sera. Potrei quasi affermare, come afferma il narratore degli Assassinii della Rue Morgue riguardo a C. Auguste Dupin, che cercavamo la nostra quieta osservazione in
mezzo alle luci e ombre della popolosa città. Eccezion fatta per le luci. Ho
già precisato che, a differenza di Parigi, Baltimora mette a dura prova la
vista dopo il calare del buio.
Anzi, rammento che una volta, nella semioscurità, urtai con forza un
passante azzimato. «Le mie scuse» dissi, alzando lo sguardo. Era infagot-
tato in un cappotto nero dal taglio fuori moda. La sua reazione mi rimase
impressa per il resto della serata: abbassò gli occhi e si allontanò senza aprire bocca.
Duponte non era infastidito dall'illuminazione insufficiente di Baltimora.
«Vedo durante il giorno» ripeteva «ma guardo durante la notte.» Era un
gufo umano: le sue uscite mentali erano cacce notturne.
In due occasioni, compresa la volta che mi scontrai con quello sconosciuto, ci imbattemmo in Claude Dupin e in Bonjour. Baltimora era una
metropoli in continua crescita, con oltre centocinquantamila abitanti; le
probabilità che due persone passassero nello stesso punto nel medesimo
momento erano matematicamente modeste. Vi era un magnetismo di intenti che attirava i nostri gruppi l'uno verso l'altro, suppongo. Oppure il barone si avventurava fuori della sua zona per schernirci. Aveva iniziato ad avere un aspetto diverso, sulle guance e un po' intorno agli occhi. Mi domandai se avesse acquistato peso o se magari ne avesse perso.
Amava ostentare l'«immensa» quantità di dettagli che aveva raccolto riguardo alla morte di Poe.
«Che bel bastone da passeggio» commentò una volta. «È l'ultima moda?»
«È una canna di Malacca» risposi con orgoglio.
«Di Malacca? Come quella di Poe quando l'hanno trovato. Oh sì, sappiamo già tutto ciò che avete scoperto, miei cari amici. Per esempio, perché usava il nome E. S. T. Grey. E per quanto concerne gli abiti troppo
grandi? Avete letto sui giornali che erano un travestimento? Già, ma non
per scelta di Poe...» Poi si interrompeva a metà frase con fare enigmatico
oppure scoppiava a ridere insieme a Bonjour. Quest'ultima fissava me e
Duponte, senza aderire alla politica di falsa cortesia adottata da suo marito.
Quindi il barone aggiungeva: «Quali incredibili scoperte ci attendono, amici miei! Questa faccenda ci fornirà il passaporto per la gloria!». Amava
esagerare.
«Mio carissimo Duponte» disse Claude Dupin al mio compagno durante
una passeggiata mattutina, stringendogli la mano con vigore, «è un immenso piacere vedervi in ottima salute. Quando tornerete a Parigi, la traversata sarà tranquilla, posso assicurarvelo. Abbiamo fatto enormi progressi e stiamo per completare tutto il lavoro necessario quaggiù.»
Duponte fu garbato. «Allora mi sarò goduto un gradevole soggiorno a
Baltimora.»
«Potete dirlo forte! Credo di non aver veduto da nessun'altra parte tante
donne incantevoli» aggiunse il barone con un sussurro udibile, girando la
testa con un gesto vistoso.
Il suo tono mi fece trasalire. Bonjour non era con lui in quell'occasione,
ma avrei voluto che fosse presente.
Dopo che ci fummo congedati dal barone, Duponte si voltò verso di me.
Posandomi una delle sue pesanti mani sulla spalla, rimase immobile per un
poco senza parlare. Fui attraversato da un brivido.
«A cosa siete preparato, monsieur Clark?» mi chiese a bassa voce.
«Che cosa intendete?»
«Vi state avvicinando al centro dell'indagine, siete sempre più vicino
ogni giorno che passa.»
«Monsieur, desidero aiutarvi come posso.» La verità è che non mi sentivo affatto vicino al centro dei progetti o delle investigazioni di Duponte.
Anzi, mi sentivo a malapena sul bordo, e di sicuro avevo l'impressione che
fossimo soltanto ai margini della verità sulla morte di Poe.
Duponte scrollò il capo con espressione rassegnata, come se ormai avesse rinunciato alla speranza che comprendessi. «Voglio che continuiate a
tenere d'occhio le manovre di Claude Dupin, se siete d'accordo.»
Totalmente sbalordito, lo invitai a spiegarsi meglio.
«Ci sarebbe d'aiuto conoscere le tattiche utilizzate dal barone» proseguì.
«Proprio come quando avete rintracciato monsieur Reynolds.»
«Ma avete disapprovato con veemenza i miei contatti con Reynolds!»
«Avete ragione, monsieur. La vostra scoperta di Reynolds è stata del tutto insignificante. Ma come ho già accennato, occorre conoscere tutto quanto è insignificante per capire il significato che abbiamo circoscritto.»
Non sapevo con esattezza che cosa volesse dire Duponte quando mi
chiese a cosa fossi preparato. Non lo sapevo, e allo stesso tempo lo sapevo.
Vi era il fatto innegabile che, pedinando il barone, sarei stato esposto a un
maggior numero di rischi.
Ma non credo che fosse tutto qui. Duponte voleva sapere se, finita quella
storia, avrei reclamato la vita che avevo prima. Se avessi saputo che cosa
stava per capitare, l'avrei forse rispedito a Parigi con il primo piroscafo, mi
sarei voltato e avrei scelto il tranquillo rifugio di Glen Eliza?
Libro quarto
Fantasmi eternamente inseguiti
Capitolo 15
Fu così che divenni il nostro agente segreto.
Il barone Dupin cambiava hotel a intervalli di qualche giorno. Quegli
spostamenti, immaginai, erano dettati dal costante timore che i suoi nemici
di Parigi lo rintracciassero anche qui, benché mi paresse inverosimile. Ma
poi cominciai a notare due uomini che sembravano osservarlo senza sosta.
Naturalmente, lo osservavo anch'io, sicché mi risultava difficile, al tempo
stesso, controllare quei tizi con attenzione. Erano vestiti come se fossero in
uniforme: pantaloni blu, antiquate marsine nere, bombetta inclinata a coprire loro il volto. Sebbene non mostrassero alcuna somiglianza fisica, avevano entrambi il medesimo sguardo assente, come gli occhi sprezzanti
delle statue romane che avevo visto al Louvre. Quegli occhi erano sempre
puntati sullo stesso oggetto: il barone. Dapprima pensai che forse lavorassero per lui, ma mi avvidi che Claude Dupin faceva il possibile per non
avvicinarsi a loro. Dopo averli incrociati sovente, rammentai dove ne avevo scorto uno. Era capitato durante una delle mie passeggiate con Duponte. L'avevo urtato vicino al luogo di uno dei nostri incontri con il barone.
Forse era stato suppergiù nel periodo in cui avevano individuato il loro
bersaglio.
Ormai non erano le uniche persone di Baltimora interessate ai movimenti del barone Dupin. Vi era anche il buttafuori del circolo del «Dio rosato»,
il covo della quarta sezione whig dove avevamo conosciuto il signor George, il presidente di quel gruppo. L'omone cominciò a pedinare Claude
Dupin quando quest'ultimo indossava il suo travestimento, quello che avevo veduto per la prima volta nella sala di lettura della biblioteca. Neppure
il barone avrebbe sfidato apertamente quello scagnozzo dei whig, Tindley,
un nome fin troppo carino per un simile mostro. Chiunque pareva un nano
al suo confronto.
«Che cosa volete, buonuomo?» domandò Claude Dupin al suo molestatore.
«Che voi damerini la smettiate di parlare della nostra associazione» rispose Tindley.
«Caro signore, che cosa vi fa credere che sia interessato alla vostra associazione?» chiese il barone, magnanimo.
Tindley tenne la bocca aperta mentre infilava l'indice tra le pieghe della
fluente cravatta nera del barone. «Ci hanno messi in guardia da voi dopo
che avevate cercato di corrompermi per entrare nel locale. Ora vi tengo
d'occhio.»
«Ah, vi hanno messi in guardia, dunque» disse il barone Dupin con noncuranza. «Allora temo che quel monito vi abbia terribilmente depistati.
Ebbene, chi mai vi avrebbe messi in guardia?» domandò, tentando in tutti i
modi di dissimulare la sua preoccupazione.
Tindley non ebbe bisogno di pronunciare il nome di Duponte (non lo
conosceva nemmeno), perché l'altro ci arrivò da solo. «Un francese alto e
sciatto dalla testa ovale? È stato lui? È un imbroglione, caro signore» affermò. «È più pericoloso di quanto possiate immaginare.»
Che vano lampo di rabbia negli occhi del barone, mentre rimaneva lì
immobile, maledicendo in silenzio il trionfo di Duponte per tutto il tempo!
Tallonato da Tindley ovunque andasse, ben presto dovette rinunciare al
camuffamento dell'uomo con il raffreddore e agli informatori che aveva
trovato grazie a esso. Una piccola vittoria per noi, pensai con gioia maligna, dopo la sua efficace infiltrazione a Glen Eliza tramite il ritrattista olandese.
A proposito dell'aspetto del nostro barone Dupin in quei giorni, che mutamenti stava subendo sotto i nostri occhi! In un capitolo precedente, ho
accennato alla sua capacità di modificare il proprio aspetto fisico con straordinaria facilità. Di recente, vedendolo per la strada, avevo notato una
nuova trasformazione nel suo viso e nel suo corpo in generale, senza riuscire a individuare con esattezza che cosa era cambiato. Non si trattava di
una parrucca e di un finto naso bulboso, quel vecchio costume era degno
dei più dozzinali attori estivi sulla Rue Madame di Parigi. Ora tutto il suo
volto sembrava diverso, e al tempo stesso così familiare da essere sorprendente e inquietante.
Una sera, gettai alcuni ceppi nel caminetto del salotto. Duponte mi assicurò che non era necessario. Si dice che, a Parigi, i camini non fumino
neppure nelle più rigide nottate invernali. Noi americani siamo un poco
troppo sensibili al caldo e al freddo, mentre nel Vecchio Mondo sembrano
non accorgersene neppure, ma non mi sarei avvolto nelle coperte come avrebbe preferito fare un francese. Quella stessa sera, ricevetti un messaggio.
Era di zia Blum. Lo aprii con una certa esitazione. Si augurava che avessi licenziato il mio maleducato cuoco francese (ossia Duponte), e soprattutto desiderava informarmi, in onore della sua lunga amicizia con gli abitanti di Glen Eliza, che ora Hattie era fidanzata con un altro uomo, industrioso e affidabile.
Sulle prime, la notizia mi sbalordì. Era possibile che Hattie avesse trovato qualcun altro? Era possibile che avessi perduto Hattie, una donna meravigliosa, facendo contemporaneamente quel che mi pareva giusto e indispensabile?
Poi capii. Ripensai al saggio monito di Peter, secondo cui non sarebbe
stato semplice placare zia Blum, e intuii che la lettera poteva essere uno
stratagemma adottato da quella donna astuta per spingermi a profondermi
in scuse e ammissioni di colpa con sua nipote.
Non mi sentivo al di sopra né al di sotto di quella subdola manovra.
Seduto sul sofà, mi domandai se, data la natura della mia attuale impresa, avessi rinunciato a tutti i doverosi rapporti con la società. Dopo tutto,
ora mi trovavo in compagnia di uomini di grande ardore come Duponte e il
barone, che sfidavano le convenzioni sociali e cercavano risultati impossibili da ottenere mediante la normale cortesia.
Quando le fiamme cominciarono a correre fulminee lungo il ceppo, e io
presi a meditare su quelle questioni, ebbi una visione improvvisa di Claude
Dupin, come se il suo viso fosse riflesso nel fuoco. Capitò mentre tentavo
di immaginarlo senza avere l'originale dinanzi a me.
Nessun pittore o esperto di dagherrotipia avrebbe potuto rendergli giustizia per via delle continue modifiche subite dai suoi lineamenti. Anzi, se
qualcuno ci avesse provato, probabilmente il barone sarebbe divenuto simile al ritratto più di quanto il ritratto fosse simile a lui. Sarebbe stato necessario sorprenderlo nel sonno per coglierne le vere fattezze.
«Monsieur Duponte» esclamai, balzando in piedi mentre il fuoco si ravvivava crepitando e scoppiettando. «Ma siete voi!»
Alzò gli occhi a quell'affermazione concitata.
«Lui è voi!» Agitai le mani prima in una direzione, poi nell'altra. «Ecco
perché ha tramato affinché Van Dantker venisse qui!»
Mi occorsero tre o quattro tentativi per spiegare il significato della mia
illuminazione: il barone Dupin si era impossessato dei tratti di Auguste
Duponte. Aveva irrigidito i muscoli del volto, curvato gli angoli della bocca e, per quanto ne sapevo, utilizzato un incantesimo per rendere più spigolosi i contorni della testa e regolare la propria statura. Aveva anche scelto vestiti analoghi a quelli di Duponte nei colori spenti e nel taglio morbido del tessuto. Aveva abbandonato gli anelli e i monili con cui era solito
agghindarsi e si era lisciato i ricci ribelli. In maniera subdola, usando l'osservazione e studiando gli schizzi e il ritratto di Van Dantker, si era tramutato in un sosia di Duponte.
Il motivo, presumevo, era semplice. Irritare il suo avversario, vendicare
la provocazione di Tindley, dileggiare il nobile essere che osava competere
con lui in quella missione. Ogni volta che incappava in Duponte per la
strada, Claude Dupin non riusciva a parlare senza scoppiare in una risata
per l'ingegnosità della sua nuova burla.
Un illusionista, un impostore, un individuo abietto... mascherato da
grand'uomo.
Chissà come, aveva anche... ve lo giuro... aveva anche trasformato il tono e il timbro della propria voce. Per scimmiottare con precisione quella di
Duponte. Persino l'accento era un'imitazione perfetta. Se fossi stato in un
locale buio e avessi ascoltato un monologo di quel mistificatore, mi sarei
tranquillamente rivolto a quel demonio come se fosse il mio vero compagno.
Il meschino camuffamento del barone mi perseguitava. Mi ossessionava.
Mi colmava d'ira. Non penso che Duponte ne fosse altrettanto infastidito.
Quando mi lagnai di quella manovra, la sua bocca si allungò in un arco enigmatico, come se giudicasse quella burla spassosa quanto un gioco infantile. E quando incontrava il suo concorrente, Duponte si inchinava come prima. Lo spettacolo era sbalorditivo, soprattutto durante la notte, vedendoli insieme. Alla fine, l'unico modo sicuro per distinguerli era l'identità dei loro fedeli accompagnatori, io da una parte e mademoiselle Bonjour
dall'altra.
Finalmente, un giorno, affrontai Duponte. «Quando quel farabutto si fa
beffe di voi e vi schernisce, perché gli consentite di continuare indisturbato?»
«Che cosa mi suggerireste di fare, monsieur Clark? Di sfidarlo a duello?» domandò, con maggiore indulgenza di quanta, probabilmente, ne avrei meritata.
«Sicuramente di dargli un ceffone!» esclamai, anche se suppongo che io
non l'avrei fatto. «Come minimo di adirarvi con lui.»
«Capisco. Ciò aiuterebbe la nostra causa?»
Ammisi di no. «Non importa. Gli ricorderebbe, direi, che non è il solo a
giocare questa partita. Nella fallacia infinita del suo cervello, crede di aver
già vinto, monsieur Duponte!»
«Allora ha maturato una convinzione errata. La situazione è del tutto
opposta. Il barone, temo per lui, ha già perduto. È arrivato alla conclusione, come me.»
Mi piegai in avanti, incredulo. «Intendete...?»
Si riferiva al nostro obiettivo, alla soluzione del mistero della morte di
Poe.
Mi rendo conto di aver corso troppo, come tendo a fare sovente. Prima
di riprendere il dialogo qui sopra, dovrò tornare sui miei passi. Avevo iniziato a descrivere la mia vita da spia, dettata dal desiderio di Duponte di
conoscere i piani e i segreti del barone.
Come ho accennato prima, quest'ultimo cambiava spesso hotel per eludere gli inseguitori. Mi tenni al corrente dei suoi spostamenti pedinando i
facchini stanchi che ne affidavano i bagagli alla custodia dei loro colleghi.
Non so come il barone giustificasse l'abitudine inusitata di mutare continuamente alloggio quando firmava ogni nuovo registro. Se mai mi fossi ritrovato a fare la stessa cosa e non avessi potuto spiegarne il vero motivo
(«Vedete, signore, i creditori vorrebbero tagliarmi la testa»), avrei affermato che stavo scrivendo una guida turistica di Baltimora e dovevo fare un
confronto tra i vari alberghi. I proprietari mi avrebbero coperto di premure.
Era un'idea così buona che ero tentato di suggerirla a Claude Dupin scrivendogli un biglietto anonimo.
Frattanto, Duponte mi ordinò di procurarmi altre informazioni su Newman, lo schiavo assunto dal barone, sicché, un pomeriggio, attaccai discorso con il ragazzo nel foyer.
«Lascerò Baltimora dopo che mi libererà» mi disse. «Ho un fratello e
una sorella a Boston.»
«Perché non fuggi ora? Gli Stati settentrionali ti proteggeranno» osservai.
Indicò un manifesto stampato. Vietava a qualsiasi persona di colore,
«schiava o libera», di lasciare la città senza prima aver consegnato i documenti e aver trovato un bianco che le facesse da garante.
«Non sono negro stupido» ribatté «da essere braccato e morto. Tanto vale andare da mio padrone e supplicarlo di spararmi.»
Aveva ragione; l'avrebbero stanato anche se il proprietario non ne avesse
rimpianto particolarmente la perdita.
Per evitare qualsiasi perplessità, aggiungerò una precisazione riguardo al
linguaggio del giovane schiavo. Tra gli africani degli Stati meridionali e
settentrionali, fossero essi liberi oppure no, la parola «negro» non aveva
alcuna connotazione razziale. Ho udito neri che denominavano così un mulatto e che chiamavano persino i loro padroni «quei negri bianchi». I neri
usavano quel termine per indicare un individuo abietto di qualsiasi tipo,
classe o colore. Ciò ridefinisce in maniera assai acuta quell'orribile vocabolo, che prima o poi scomparirà sicuramente dal nostro vocabolario.
Menziono questa peculiarità per coloro che avessero mai dubitato dell'intelligenza di quella razza bistrattata, e mi domando se i bianchi avrebbero
avuto la stessa idea.
«E che cosa mi dici dell'altro negro?» chiesi.
«Chi?»
«L'altro nero ingaggiato dal barone» risposi. Lo sconosciuto che avevo
veduto una volta con Claude Dupin era stato incaricato di osservarmi, di
spiarmi mentre io spiavo il nostro rivale, ormai ne ero pressoché convinto.
«Non c'è nessun altro, signore, nero o bianco. Quel barone non volere
troppa gente intorno.»
Durante i miei inseguimenti, rimasi piacevolmente stupito nel constatare
una diminuzione nella spavalderia ostentata da Claude Dupin. In diverse
occasioni, udii Bonjour che gli poneva un quesito alquanto elementare sulle sue conclusioni riguardo a Poe; il barone esitava. Ciò riaccese le mie
speranze di successo. Ma mi riempì, suppongo, della paura negativa e inquietante che anche Duponte giungesse a un punto morto, come se tra i
due esistesse un legame mistico. Forse, nella mia mente, quella era una
conseguenza impercettibile della nuova e sconcertante somiglianza tra
Claude Dupin e Auguste Duponte, quasi uno fosse reale e l'altro il riflesso
in uno specchio, come nell'ultimo fatale incontro del William Wilson di
Poe. Altre volte pareva che fossero entrambi immagini speculari del medesimo individuo.
I loro comportamenti, tuttavia, erano assai diversi.
Il barone non interruppe le sue chiassose e riprovevoli allocuzioni pubbliche. Cominciò a raccogliere sottoscrizioni per un giornale che intendeva
pubblicare e per una serie di conferenze che voleva tenere sui veri e sensazionali dettagli della morte di Poe. «Venite, riunitevi, riunitevi intorno a
me, signori e signore, non crederete mai cosa è accaduto proprio sotto il
vostro naso!» urlava in bar e taverne, come un imbonitore o un ciarlatano.
Devo ammettere che, a un livello superficiale, era convincente, quasi un
secondo signor Barnum. Per poco non vi aspettavate di sentirlo annunciare
alla folla che ora avrebbe trasformato quel sacco di crusca in un... porcellino d'India... vivo.
E il denaro lo seguiva ovunque andasse! Non riuscivo a calcolare il nu-
mero degli abitanti di Baltimora disposti a depositare cifre esagerate tra le
mani di quel contafrottole; abitanti di Baltimora, aggiungo con tristezza,
che non accennavano a fare lo stesso per un volume delle poesie di Poe.
Davano tuttavia molto credito all'idea secondo cui Claude Dupin avrebbe
scoperto gli accadimenti delle ultime e più oscure ore di quello stesso poeta su questa Terra. Apprezzavano la cultura purché fosse accompagnata da
una qualche forma di conflitto. Ricordai la volta che, a Baltimora, due attori avevano interpretato contemporaneamente Amleto su due palcoscenici
vicini, e tutti avevano sostenuto con passione il loro preferito, non per la
recitazione in sé e per sé, ma per il senso di antagonismo.
La conferenza si sarebbe tenuta nelle aule per convegni del Maryland Institute. Il barone cominciò a spedire telegrammi per annunciarne altre a
New York, Filadelfia, Boston... I suoi piani si ampliavano, e i nostri sembravano confondersi sempre più nella sua ombra.
Così facendo, Claude Dupin aveva aperto ancora di più il vaso di Pandora dei pettegolezzi nella stampa.
Alcuni esempi: Poe era stato derubato e trovato da una guardia in un rigagnolo; l'avevano rinvenuto in fin di vita su alcuni barili del Lexington
Market, interamente coperto di mosche; no, affermava un altro giornale,
Poe aveva incontrato alcuni ex cadetti di West Point (dove lo scrittore aveva imparato a usare moschetto e munizioni), ora assegnati a un'operazione
governativa segreta che l'aveva coinvolto in un pericoloso intrigo e che
probabilmente era legata al periodo della sua sregolata giovinezza in cui, si
diceva, aveva combattuto per l'esercito polacco e con i russi; non era vero:
Poe era andato incontro a una fine insulsa a causa di una sbornia durante la
vivace e sfrenata festa di compleanno di un amico; oppure si era suicidato.
Una conoscente asseriva che, dall'aldilà, il fantasma di Poe le aveva inviato alcune poesie in cui spiegava di essere stato colpito da un pugno fatale
durante il tentato furto di certe missive. Frattanto, un quotidiano locale aveva ricevuto un telegramma dal periodico di una lega antialcolica newyorkese convinta di conoscere una persona che aveva assistito alla tremenda sbronza di Poe il giorno prima del suo rinvenimento al Ryan, il che avrebbe dimostrato all'arbitro del Giudizio finale che era tutta colpa del
poeta.
Mentre esaminavo quegli articoli seduto nella sala di lettura, il vecchio e
fidato bibliotecario mi si avvicinò.
«Oh, signor Clark! Sto ancora pensando a chi mi ha dato quei ritagli sul
vostro signor Poe. A dire il vero, rammento con chiarezza che quel tale mi
aveva pregato di consegnarveli.»
All'improvviso persi ogni curiosità verso i giornali lì davanti. «Prego, signore?» Non mi era mai venuto in mente che qualcuno avesse potuto dargli quei ritagli con l'ordine specifico di recapitarli a me. Gli chiesi se avessi
capito bene.
«Sì.»
«È incredibile!» esclamai, pensando a come l'unico articolo che accennava al «vero» Dupin avesse cambiato radicalmente il corso degli eventi.
«Perché?»
«Perché qualcuno...» Non finii la frase. «È fondamentale che mi diciate
di più su questa persona, chiunque essa sia. Sono molto indaffarato in questi giorni, ma tornerò. Sforzatevi... per favore, sforzatevi... di ricordare.»
Quella nuova rivelazione aveva infiammato la mia fantasia. Nel frattempo, trovai un'occupazione meno speculativa decidendo di sistemare le cose
con Hattie. Le scrissi una lunga lettera, ammettendo che lo stratagemma di
zia Blum, crudele ma escogitato a fin di bene, mi aveva incoraggiato, e
proponendole di riprendere i preparativi per il matrimonio appena mi avesse risposto.
Capitolo 16
Ricostruendo le manovre del barone Dupin mediante interrogatori e inseguimenti segreti, appresi che, quasi una settimana addietro, Bonjour si
era spacciata per una cameriera e si era infiltrata nella dimora del dottor
Joseph Snodgrass, l'uomo che, secondo Moran, aveva chiamato la carrozza
incaricata di portare Edgar Poe dal Ryan all'ospedale. In precedenza, Claude Dupin aveva fatto visita a Snodgrass per scoprire i dettagli di quel piovoso pomeriggio d'ottobre, ma il dottore si era rifiutato categoricamente di
alimentare l'industria dei pettegolezzi intorno alla morte dell'illustre poeta.
Di lì a poco, Bonjour si era assicurata un posto tra la servitù della casa e,
particolare stupefacente, ci era riuscita senza che vi fosse alcun posto vacante. Si era presentata con abiti lindi e sobri sulla soglia dell'elegante edificio di mattoni al 103 di North High Street. Una serva irlandese aveva aperto il portone.
Supponendo giustamente che quella fosse la cameriera del piano di sotto, e ritenendo probabile che fosse in competizione con l'attuale collega del
piano di sopra, Bonjour aveva affermato di aver sentito dire che cercavano
una nuova domestica.
«Davvero?» aveva replicato l'altra. «Io non ne sapevo nulla.» Bonjour si
era scusata, spiegando che la cameriera del piano di sopra aveva rivelato a
un'amica l'intenzione di andarsene senza dare alcun preavviso ai padroni, e
aggiungendo di essere ansiosa di far presente la propria disponibilità.
Poco dopo, la serva, che aveva una figura sgraziata ed era invidiosa delle
donne più avvenenti, aveva riferito il dialogo agli Snodgrass, che si erano
sentiti autorizzati a licenziare la cameriera del piano di sopra nonostante le
proteste dell'interessata. Avendo impedito l'inevitabile sconvolgimento del
loro ménage familiare, Bonjour era diventata l'eroina di quel dramma domestico e, quando si era ripresentata al momento opportuno, era apparsa la
sostituta più ovvia. Benché fosse assai più bella della sua collega gelosa, il
fatto che fosse troppo magra per i gusti predominanti e che avesse il labbro
attraversato da una brutta cicatrice la rendeva più accettabile.
Non ebbi difficoltà a scoprire tutto ciò dall'ex cameriera del piano di sopra, che, dopo essersene andata, era impaziente di parlare dell'ingiustizia
subìta. Una volta che Bonjour si fu insediata dentro la casa, ebbi tuttavia
poche opportunità di raccogliere ulteriori dettagli sulla sua missione.
«Lasciatela alla famiglia Snodgrass, allora, e limitate le vostre osservazioni al barone» suggerì Duponte.
«Non si tratterrebbe così a lungo se non vi fossero informazioni da ottenere. Sono trascorse più di due settimane, monsieur!» ribattei. «A ogni
modo, il barone è perlopiù impegnato a vendere sottoscrizioni per la sua
conferenza sulla morte di Poe.»
«Forse le informazioni ottenute da mademoiselle non sono tanto numerose quanto lente» replicò.
«Potrei avvertire il dottor Snodgrass che Bonjour non è una vera cameriera ma una spia.»
«A che pro, monsieur Clark?»
«A che pro?» ripetei, incredulo. Mi pareva logico. «Per impedirle di raccogliere informazioni per il barone!»
«Verremo immancabilmente a conoscenza di ciò che apprenderanno» mi
assicurò, anche se non riuscii a seguire il filo di quel ragionamento.
Nel corso dei miei resoconti, Duponte mi chiedeva con regolarità di descrivergli la condotta e l'atteggiamento di Bonjour nei confronti del lavoro
e del resto del personale.
Bonjour usciva ogni giorno per incontrare Claude Dupin. Una sera, mentre si recava a uno di quegli appuntamenti, la pedinai fino alla zona del
porto. Non era raro che un uomo venisse buttato fuori da un locale, e la
scelta era tra scavalcarne il corpo oppure incespicare e cadergli addosso.
Laggiù, le vie erano piene di bar, sale da biliardo e odori umani stantii.
Bonjour aveva un abbigliamento adeguato: capelli arruffati, cuffietta malamente calzata e abito in disordine. Si cambiava spesso (a seconda che la
commissione da sbrigare per il barone Dupin richiedesse l'aspetto di un
membro dell'uno o dell'altro ceto), ma non subiva trasformazioni demoniache come quelle di suo marito.
La osservai mentre si approssimava a un gruppo di tipacci, intenti a ridere e a urlare smodatamente. Uno di loro la indicò.
«Guardate lì» disse con voce roca «una puttanella! Una sgualdrinella
niente male!»
Bonjour li ignorò. L'uomo allungò il braccio a mo' di barriera. Era grande quasi il doppio di lei. Fermatasi, la giovane abbassò lo sguardo sull'avambraccio nerboruto, su cui la manica era rimboccata in maniera indecorosa.
«Che cos'è questa, bambola?» Le strappò un pezzo di carta dalle dita.
«Una lettera d'amore, immagino. Che cosa dice? "Vi è un uomo, piuttosto
malconcio..."»
«Giù le mani» gli intimò Bonjour, avanzando di un passo.
Quel tizio sollevò il foglio fuori della sua portata, tra l'ilarità eccessiva
dei suoi compagni. Un tipo basso e tarchiato sghignazzò e, impietosito, gli
gridò di darci un taglio, al che il capobanda gli sferrò un pugno, definendolo un vero idiota.
Bonjour si avvicinò con un lieve sospiro, gli occhi che arrivavano a malapena al collo dell'omone. Dopo avergli posato un dito sul muscolo del
braccio alzato, ne seguì la linea. «Il braccio più poderoso che abbia veduto
a Baltimora, signore» sussurrò, abbastanza forte perché la udissero anche
gli altri.
«Ebbene, non intendo abbassarlo per qualche lusinga, mia cara.»
«Non voglio che lo abbassiate, signore. Voglio che lo alziate di più...
Ecco, così.»
L'altro obbedì, forse senza volerlo. Bonjour si chinò fin quasi all'incavo
del suo collo.
«Oh, oh, guardate» disse il colosso ai suoi amici in tono allegro «la
sgualdrinella ha intenzione di saltarmi addosso per un bacio!»
Risero. Anche l'uomo eruppe in una risatina nervosa come quella di una
ragazzina.
«Non dovreste sottovalutare le sgualdrinelle» lo rimbeccò Bonjour. Con
un sol gesto, più veloce del fulmine, si passò la mano dietro la testa fino a
raggiungere il lato del collo del suo aggressore. Il braccio dello sconosciuto, sollevato da quella parte, non poté fare alcunché per fermarla.
La camicia e la giacca di quel tale, lacerate con precisione in corrispondenza dei bottoni, caddero a terra. Gli spettatori piombarono in un grave
silenzio. Bonjour si rinfilò una lama sottile quanto uno spillo tra la chioma
ormai scompigliata. Il gigante si tastò il collo per accertarsi di avere ancora
tutta la sua carne, quindi, non trovando neppure un graffio, indietreggiò
barcollando. Bonjour raccolse il biglietto da terra e proseguì il suo cammino. Forse lo immaginai, ma prima di allontanarsi, lanciò un'occhiata nella
mia direzione, dall'altra parte della strada, e il suo volto parve assumere
un'aria confusa dinanzi alla mia espressione: quella di qualcuno pronto a
correre in suo aiuto.
Seguitai a bazzicare nei dintorni di casa Snodgrass. Una mattina, dopo il
mio arrivo, scorsi Duponte che si avvicinava con indosso la cappa, il mantello e il consueto completo nero.
«Monsieur?» lo salutai in tono interrogativo. Negli ultimi tempi, vederlo
durante il giorno era un evento pressoché straordinario. «È accaduto qualcosa?»
«Oggi ci attende una visita, nell'interesse della nostra indagine» rispose.
«Dove dobbiamo andare?»
«Siamo già qui.»
Oltrepassò il cancello e percorse il vialetto anteriore verso la dimora degli Snodgrass. «Coraggio» mi esortò quando mi fermai.
«Monsieur, gli Snodgrass sono fuori a quest'ora. E, come sapete, Bonjour potrebbe vederci!»
«È quello che mi auguro» ribatté.
Afferrò il batacchio argentato, che fece comparire subito la cameriera
del piano di sotto. Duponte si guardò intorno, constatando con compiacimento che Bonjour sbirciava dalla cima delle scale, come faceva probabilmente con ogni ospite del dottor Snodgrass.
«Siamo qui per il dottor Snodgrass, signorina» esordì l'analista. «Sono...» A quel punto fece una pausa, con un lieve cenno del capo verso il
pianerottolo. «... il duca Duponte.»
«Duca! Ebbene, il dottore non c'è, signore.» Il suo sguardo scivolò con
lentezza sul mio cappello e sul mio cappotto, spingendomi a togliermeli.
«Certo che no, giacché è un uomo molto impegnato. Tuttavia, credo ab-
bia lasciato detto alla cameriera del piano di sopra che avremmo dovuto attenderlo nel suo studio a quest'ora» replicò Duponte.
«Perbacco! Che strano!» esclamò la ragazza, la cui invidia verso Bonjour parve sollevarsi come un oggetto visibile dinanzi ai nostri occhi.
«Se questa giovane donna è in casa, signorina, forse sarà in grado di
confermare i dettagli del nostro invito.»
«Perbacco!» ripeté l'altra. «È tutto vero?» urlò in direzione di Bonjour.
«Il dottore non mi ha detto nulla.»
Sorridendo, Bonjour rispose: «Naturalmente, il dottore non vi dice nulla
di quanto accade al piano di sopra, signorina. E il suo studio è al piano di
sopra».
Si avvicinò, salutandoci con un inchino. Mi meravigliai di vedere che
assecondava il raggiro di Duponte, ma, una volta superato quel primo
momento di sorpresa, cominciai a capire. Se Bonjour avesse denunciato la
falsità delle parole di Duponte, noi avremmo potuto smascherare con altrettanta facilità le menzogne che aveva raccontato per ottenere il lavoro.
Era un accordo tacito e automatico.
«Il dottor Snodgrass vi prega di seguirmi» annunciò Bonjour.
«Nello studio, credo che abbia detto» ribadì Duponte, seguendola su per
le scale e facendomi cenno di imitarlo.
Bonjour ci fece accomodare nel locale con un sorriso, offrendosi di
chiudere la porta alle nostre spalle affinché potessimo stare tranquilli. «Voi
signori sarete assai lieti di sapere che lo stimato dottore rientrerà tra poco»
disse. «Oggi torna presto. Mi assicurerò di portarlo subito qui appena arriva.»
«Non ne dubitiamo, signorina» disse Duponte.
Quando restammo soli, mi voltai verso di lui. «Che cosa potremo mai
apprendere da Snodgrass? La nostra messinscena non lo contrarierà? E,
monsieur, non mi avete ripetuto cento volte che non abbiamo ragione di
parlare con i testimoni?»
«Pensate sia questo lo scopo per cui siamo venuti? Per incontrare Snodgrass?»
Un poco irritato, decisi di non rispondere.
Duponte sospirò. «Non siamo qui per vedere il dottor Snodgrass; leggeremo ciò che desideriamo sapere nei suoi documenti. È senz'altro questo il
motivo per cui il barone ha mandato qui Bonjour e per cui quest'ultima ha
fatto astutamente in modo di diventare la cameriera del piano di sopra: per
avere libero accesso allo studio senza essere tenuta d'occhio. È sembrata
alquanto divertita dalla nostra presenza, e assai disinvolta con la serva più
anziana, il che indica che ha quasi portato a termine la sua impresa qui.
Non crede neppure che avremo tempo sufficiente per scoprire qualcosa di
importante tra tutte quelle carte.»
«In tal caso, ha ragione!» esclamai, notando che la stanza era zeppa di
fogli, impilati e accatastati sul ripiano della scrivania, dentro i suoi cassetti
e tutt'intorno.
«Rivedete le vostre conclusioni. Mademoiselle Bonjour è qui ormai da
diverse settimane, e pur essendo una ladra esperta, non vorrà correre il rischio che il dottor Snodgrass si avveda della scomparsa di qualche scartoffia, il che le precluderebbe ulteriori ricerche. Pertanto avrà copiato di nascosto e di suo pugno ogni documento interessante, rimettendo a posto gli
originali e offrendoci la possibilità di individuarli.»
«Ma come riusciremo a trovare in pochi minuti le carte che lei ha trascritto nel corso di settimane?»
«Proprio perché lei le ha rinvenute per prima. Avrà dovuto spostare qualunque foglio o dossier abbia suscitato il suo interesse, forse più di una
volta. Certo, nessuno noterebbe la differenza per puro caso, ma sapendo
come cercare, non dovremmo avere difficoltà nel recuperare e copiare quei
documenti in particolare.»
Ci mettemmo subito al lavoro. Io mi concentrai su un lato della scrivania. Sotto la guida di Duponte, cercai angoli piegati e allineati male, sbavature d'inchiostro, piccoli strappi e orecchie, sgualciture e altri segni di recente manipolazione tra i mucchi e le cataste di pagine e servizi giornalistici di
vario argomento, alcuni dei quali risalivano a ben venticinque anni prima.
Insieme, individuammo molti riferimenti a Poe che Bonjour doveva aver
esaminato durante il periodo trascorso in quella dimora, compresa una serie di pezzi sul decesso di Edgar che, pur non essendo completa quanto la
mia collezione, era comunque ragguardevole. Euforico e inorridito, trovai
alcune carte ancor più straordinarie: tre delle lettere (di cui riconobbi subito la calligrafia) che Poe aveva scritto al dottor Snodgrass diversi anni addietro.
Nella prima, Poe offriva a Snodgrass, che allora dirigeva la rivista «The
Visiter», i diritti per la pubblicazione del secondo racconto di Dupin. «Naturalmente non posso permettermi di farvene un vero e proprio regalo, ma
se siete intenzionato ad accettarlo, proporrò quaranta dollari» aveva scritto
il poeta con decisione. Ma Snodgrass aveva rifiutato, e Poe aveva ricevuto
una risposta negativa anche dal «Graham's» prima di pubblicare altrove Il
mistero di Marie Roget.
Nella seconda missiva, lo scrittore chiedeva al dottor Snodgrass di pubblicare una recensione favorevole della sua produzione nella rivista diretta,
all'epoca, da Neilson Poe, sperando che quest'ultimo lo aiutasse in nome
della loro parentela. Il tentativo era fallito, e Poe aveva risposto in tono disgustato. «Sentivo che N. Poe non avrebbe pubblicato il pezzo» dichiarava. «Vi confido che lo considero il peggior nemico che io abbia al mondo.»
Mi affrettai a mostrare quelle righe a Duponte. «Neilson Poe, monsieur!
Edgar lo definisce il suo peggior nemico... Avevo ragione riguardo al suo
ruolo in questa faccenda!»
Poiché non avevamo abbastanza tempo per discutere di ogni documento,
Duponte mi ordinò di trascrivere velocemente sul mio taccuino tutte le informazioni che mi parevano importanti e, se era per questo, aggiunse dopo
averci pensato su, anche quelle che non mi parevano importanti. Annotai
con diligenza la data della missiva di Poe su Neilson: il 7 ottobre 1839,
dieci anni esatti prima della sua morte.
«La cosa più spiacevole in tutto questo» proseguiva Poe «sono le sue solenni professioni di amicizia.» E Neilson non aveva forse professato le
medesime fandonie quando l'avevo conosciuto? «Non eravamo solo cugini, ma anche amici, signor Clark» mi aveva detto. Neilson Poe, con il cuore che palpitava per la propria fama letteraria, con la mano posata su quella
di una moglie che era la sorella e quasi la sosia di quella di Edgar... aveva
forse desiderato vivere la vita dell'uomo che aveva denigrato così apertamente?
Quelle non erano le uniche parole che Poe aveva scritto a Snodgrass riguardo ai suoi parenti di Baltimora. Il poeta aveva definito Henry Herring
(il suo primo congiunto ad arrivare al Ryan) «un uomo senza scrupoli».
Duponte, intento ad aprire ogni singolo cassetto del locale, si paralizzò.
«Scrutate le strade dall'altro lato dell'edificio, monsieur Clark. Sinceratevi che non arrivi la carrozza del dottor Snodgrass. Quando tornerà, dovremo andarcene subito, assicurandoci che la domestica irlandese non faccia parola della nostra visita.»
Lo fissai in volto per capire come avremmo raggiunto il secondo obiettivo. Entrai in una stanza che si affacciava sul davanti della costruzione.
Guardando dalla finestra, notai una vettura che passava lì accanto, ma dopo aver rallentato per un attimo, i cavalli proseguirono lungo High Street.
Voltandomi di nuovo verso lo studio, mi ritrovai dinanzi Bonjour, china
sul caminetto in modo che le fiamme paressero irradiarsi dal suo grembiule e dal suo vestito nero.
«Tutto bene, signore? Posso esservi utile in qualcosa mentre aspettate il
dottor Snodgrass?» mi domandò, imitando la cameriera del piano di sotto e
parlando abbastanza forte da farsi sentire. Abbassando la voce, aggiunse:
«Il vostro amico è soltanto un avvoltoio che sfrutta l'indagine del mio padrone, ormai l'avrete capito».
«Sto benissimo qui, signorina, grazie, stavo solo guardando quelle nubi
minacciose» dissi ad alta voce, e poi, più piano: «Auguste Duponte non
imita nessuno. Risolverà la questione in una maniera degna di monsieur
Poe. Può aiutare anche voi, se lo desiderate, più di quel ladro, mademoiselle, il vostro cosiddetto marito e padrone».
Dimenticando le costrizioni della sua recita, Bonjour sbatté la porta.
«Non penso proprio. Il ladro patentato è Duponte, monsieur Clark... Ruba i
pensieri delle persone, i loro errori. Il barone è un grand'uomo perché è
sempre se stesso. La massima libertà che possa avere è quella di cui godo
stando con lui.»
«Credete che, garantendo la vittoria del barone, ripagherete il debito
contratto allorché vi ha fatta scarcerare, e sarete libera dal matrimonio che
vi ha imposto?»
Rovesciò il capo, divertita. «Be', avete preso un abbaglio. Vi consiglio di
non giudicarmi mediante l'analisi matematica. State diventando troppo simile al vostro amico.»
«Monsieur Clark!» chiamò Duponte con voce roca.
Nervoso, spostai il peso del mio corpo da un piede all'altro.
Bonjour si avvicinò, scrutandomi. «Non avete moglie, monsieur Clark?»
I miei pensieri si incupirono. «La avrò entro breve» risposi senza troppa
fiducia. «E la tratterò bene, assicurando la felicità di entrambi.»
«Monsieur, una ragazza francese non ha alcuna libertà. In America, una
giovane è libera e onorata per la sua indipendenza finché si sposa. In Francia, la situazione è capovolta. È libera soltanto dopo essersi sposata... e allora ha una libertà che non aveva mai immaginato. Una moglie può avere
un numero di amanti pari a quello del marito.»
«Mademoiselle!»
«Talvolta un parigino è assai più geloso dell'amante che della moglie, e
una donna è più fedele all'amante che al marito.»
«Ma perché continuare a fare la ladra per lui, mademoiselle?»
«A Parigi, dovete ottenere ciò che volete dagli altri con le buone o con le
cattive, altrimenti gli altri otterranno prima ciò che vogliono da voi.» Tacque. «Il vostro padrone vi chiama, monsieur.»
Mi avviai verso la porta. Bonjour indugiò per un attimo prima di scostarsi con un inchino beffardo. Quando rientrai nello studio, Duponte annunciò: «Monsieur, qui c'è un biglietto che forse ci dice più di qualsiasi altra cosa, quello di cui avete udito leggere un frammento al porto. Scrivete
ogni parola e ogni virgola sul vostro taccuino. E sbrigatevi: mi pare di sentire le ruote di un'altra vettura che percorre il vialetto. Scrivete, dunque:
"Egregio Signore, vi è un uomo, piuttosto malconcio, alla quarta sezione
elettorale del Ryan..."».
Quando avemmo completato le trascrizioni, Bonjour ci condusse rapidamente al pianterreno.
«C'è un'entrata secondaria?» bisbigliai.
«Il dottor Snodgrass è nella rimessa delle carrozze.» Ci voltammo tutti.
Era la cameriera del piano di sotto, che si era materializzata lì accanto
all'improvviso. «Il duca non vorrà andarsene proprio ora?»
«Temo di avere un altro appuntamento» dichiarò Duponte. «Dovrò incontrare il dottor Snodgrass un'altra volta.»
«Allora non mancherò di informarlo che siete venuto» replicò la giovane, asciutta «e che siete rimasto seduto nel suo studio da solo tra le sue cose personali per quasi mezz'ora.»
Quella minaccia raggelò me e Duponte, e lanciai un'occhiata interrogativa a Bonjour, che sarebbe stata senza dubbio coinvolta.
Bonjour fissò la collega con un'aria quasi sognante. Quando tornai a girarmi verso Duponte, vidi che stava parlottando con la ragazza irlandese e
le sussurrava qualcosa con gravità. Al termine del colloquio, lei annuì appena, un lieve rossore cremisi le chiazzava le guance.
«L'altra porta, allora?» domandai, notando che sembravano aver raggiunto un accordo.
«Da questa parte» disse la cameriera con un cenno. Attraversammo il
corridoio posteriore mentre gli stivali del dottor Snodgrass salivano i gradini fino al portone. Frattanto che scendevamo sul vialetto, Duponte si voltò, sfiorandosi il cappello per salutare le due signore. «Bonjour» disse.
«Monsieur, come avete fatto a persuadere la cameriera del dottore a collaborare affinché Bonjour non venisse sbugiardata?» chiesi mentre camminavamo lungo la strada.
«Innanzi tutto, siete sulla pista sbagliata. Primo, non l'ho fatto per il bene
di Bonjour, come supponete voi. Secondo, ho spiegato alla domestica che,
in tutta onestà, non avevamo nessun altro appuntamento.»
«Davvero? Le avete detto la verità, allora» commentai, sorpreso.
«Le ho spiegato che il suo interesse, o la sua infatuazione, per voi era del
tutto fuori luogo, e che desideravo uscire con discrezione e in silenzio prima che il suo padrone tornasse e se ne avvedesse di persona.»
«Infatuazione per me?» ripetei. «Come vi è venuta un'idea simile, monsieur? Aveva forse detto qualcosa che mi è sfuggito?»
«No, ma ci ha sicuramente riflettuto dopo la mia allusione e, credendo
che la sua espressione dovesse aver tradito qualcosa in tal senso, ha pensato che dovesse essere vero. Non accennerà alla nostra visita, ve lo assicuro.»
«Monsieur Duponte! Non riesco proprio a comprendere questa tattica!»
«Siete il modello del giovanotto avvenente» replicò, aggiungendo poi:
«Almeno secondo i criteri di Baltimora. Il fatto che non ve ne rendiate
quasi conto permette a questo elemento di balzare con maggior decisione
all'occhio delle giovani donne. La cameriera se n'è senz'altro accorta al nostro arrivo; sta di fatto che ha iniziato subito a farvi gli occhi dolci. Sebbene non se ne sia resa conto fintantoché vi ho alluso».
«Ma, monsieur...»
«Non parliamone più, monsieur Clark. Dobbiamo continuare il nostro
lavoro in relazione al dottor Snodgrass.»
«Ma che cosa intendete per "non l'ho fatto per il bene di Bonjour"?»
«Bonjour non ha bisogno del nostro aiuto e, se ne avesse l'opportunità,
non esiterebbe neppure a metterci i bastoni tra le ruote. Fareste bene a ricordarlo. L'ho fatto per il bene dell'altra ragazza.»
«Come sarebbe?»
«Se la cameriera avesse cercato di accusare Bonjour di cattiva condotta,
suppongo che la poveretta non l'avrebbe spuntata contro mademoiselle. È
certamente saggio salvare una vita ogni volta che è possibile.»
Meditai per un istante sull'ingenuità con cui avevo interpretato la situazione.
«Dove andiamo adesso, monsieur?»
Indicò il mio taccuino. «A leggere, naturalmente.»
Frattanto, ci attendeva un nuovo ostacolo. Mentre eravamo fuori, la mia
prozia era giunta a Glen Eliza. Lo scopo della sua visita non era un mistero: avendo saputo che ero tornato a Baltimora, era venuta a controllare
come mai non mi fossi sposato dopo il mio famigerato viaggio. Una solida
amicizia (una sorta di cospirazione) la legava alla zia di Hattie Blum, e
probabilmente aveva udito le mezze verità che l'altra donna aveva raccolto
sui miei comportamenti.
Dopo che fummo rincasati, trascorsero quasi due ore prima che venissi
informato della sua presenza. In seguito alla nostra avventura in casa Snodgrass, ci eravamo recati nella sala di lettura per confrontare alcuni dei dettagli di cui eravamo venuti a conoscenza con gli articoli comparsi sulla
stampa. Avevamo proseguito a Glen Eliza, immersi in una puntigliosa
conversazione incentrata sulle ultime novità. Poiché io e Duponte stavamo
riassumendo le informazioni apprese nello studio del dottore, diedi ordine
che nessuno ci interrompesse. Il tavolo della biblioteca era ormai ingombro di liste, giornali e appunti, sicché rimanemmo nell'ampio salotto, che
occupava oltre metà del secondo piano. Finalmente, verso il crepuscolo,
passai nell'altro lato della costruzione per consultare un documento, ma
Daphne, la mia cameriera migliore, mi fermò.
«Non potete entrare, signore» esordì.
«Non posso entrare nella mia biblioteca? E perché?»
«La signora non vuole essere disturbata, signore.»
Ubbidiente, lasciai la maniglia della porta. «Signora? Quale "signora"?»
«Vostra zia. È arrivata a Glen Eliza con i suoi bagagli mentre eravate
fuori, signore. Era esausta per il viaggio, perché faceva un freddo tremendo e i facchini le avevano quasi smarrito le valigie alla stazione.»
Ero sconcertato. «Sono rimasto finora in salotto senza saperne nulla.
Perché non me l'hai detto?»
«Ancor prima di varcare la soglia, avete affermato in tutta fretta di non
voler essere disturbato per nessun motivo, o sbaglio, signore?»
«Devo salutarla come si conviene» dissi, raddrizzandomi il fazzoletto da
collo e lisciandomi il panciotto.
«Be', fate piano... Ha bisogno di assoluto silenzio per guarire dalle emicranie cui è soggetta, signore. Sono sicura che l'altra intrusione l'ha infastidita molto.»
«L'altra intrusione, Daphne?» Poi rammentai che, non più di un'ora addietro, Duponte era andato a prendere un volume in biblioteca. Che la mia
fedele cameriera avesse fatto valere gli ordini imperiosi della prozia anche
contro Duponte?
«Il signore non ha voluto ascoltarmi! È entrato subito...» spiegò Daphne
con disapprovazione concitata e con una rinnovata ondata di antipatia ver-
so Duponte.
Ripensai all'incontro di alcune settimane prima tra Duponte e zia Blum,
e l'idea della reazione della mia prozia a una conversazione analoga mi fece pulsare la testa. Ora mutai parere sulla mia intenzione di salutarla, soprattutto dato lo stato d'animo in cui doveva trovarsi una donna della sua
età, fra i ritardi ferroviari e monsieur Duponte. Tornai in salotto. La presenza della prozia sarebbe stata un intralcio non trascurabile. In quel momento non potevo prevedere l'influenza che la mia anziana parente avrebbe
esercitato sull'intera faccenda.
Il successivo vivido ricordo che ho di quella serata è il momento in cui
mi destai. Ero caduto in un sonno agitato su uno dei lunghi sofà del salotto.
Le carte che stavo esaminando si erano sparpagliate sul tappeto. Era trascorsa circa un'ora dall'imbrunire, e Glen Eliza era immersa in un silenzio
sinistro. A quanto sembrava, Duponte si era ritirato nelle sue stanze al terzo piano. Un violento colpo mi risvegliò del tutto. Il vento soffiava fra le
tende fluttuanti, e una sensazione di profonda ansia mi attanagliò lo stomaco.
I corridoi su quel lato dell'edificio erano deserti. Rammentando la mia
prozia, salii la scala a chiocciola e strisciai accanto agli appartamenti che i
domestici dovevano averle assegnato, ma trovai l'uscio aperto e le coperte
intatte. Tornando subito verso la biblioteca, spinsi adagio le porte della
stanza mal illuminata.
«Prozia Clark» mormorai «spero che non siate ancora sveglia dopo una
giornata tanto difficile.»
Nel locale non c'era nessuno, ma era stato messo a soqquadro: documenti e libri sparsi ovunque. Nessuna traccia però della mia anziana parente.
Nell'andito, scorsi una figura vestita di scuro che mi sfrecciava accanto ad
andatura spedita. Ne inseguii l'ombra attraverso gli interminabili corridoi
di Glen Eliza. La sagoma si tuffò attraverso una finestra aperta del primo
piano, vicino alla cucina, e corse verso un sentiero nell'area boscosa dietro
la casa.
«Al ladro!» urlai. «Zietta» ansimai, pervaso da un improvviso terrore.
Seguendo la piccola valle che si allungava accanto alla dimora in direzione della strada di ghiaia, l'intruso rallentò per decidere da che parte andare, rendendosi del tutto vulnerabile. Dopo essergli piombato addosso, lo
atterrai.
«Non riuscirai a sfuggirmi!» gridai.
Ruzzolammo uno sopra l'altro, e lo girai per guardarlo in faccia, serran-
dogli il polso con la mano e sforzandomi di sollevargli il cappuccio del
mantello di velluto. Ma non era un uomo.
«Voi? Come? Che cosa avete fatto della prozia Clark?» domandai.
Quindi mi resi conto della mia stupidità. «Eravate voi sin dal principio,
mademoiselle? Mia zia non è mai arrivata?»
«Forse verrebbe, se le scriveste più spesso» mi rimproverò Bonjour.
«Credo che Duponte, il vostro padrone, abbia scovato letture assai più interessanti nella vostra biblioteca che in tutti i racconti del vostro monsieur
Poe.»
«Eravate ancora dagli Snodgrass quando ce ne siamo andati!» Quindi
rammentai la nostra puntata alla sala di lettura.
«Sono stata più veloce. È questo il vostro difetto: esitate sempre. Non
adiratevi, monsieur Quentin. Ora siamo pari. Voi e il vostro padrone avete
voluto invadere il mio territorio dagli Snodgrass, e adesso io ho invaso il
vostro. Anche questa scena mi sembra un déjà vu.» Si dibatté sotto la mia
stretta, come avevo fatto io alle fortificazioni di Parigi, anche se allora le
posizioni erano invertite. Il velluto del suo mantello e la seta del suo abito
frusciarono contro la mia camicia.
Allentai la stretta. «Sapevate che non avrei potuto chiamare la polizia.
Allora perché siete scappata?»
«Mi piace vedervi correre. Sapete, monsieur, non siete affatto lento senza l'intralcio di un cappello elegante.» Mi passò la mano tra i capelli con
un gesto scherzoso.
Con il cuore colmo di sconcerto, mi ricomposi da quella posizione aggrovigliata balzando in piedi.
«Santo Cielo!» esclamai, guardando la strada che avevo dinanzi.
«Tutto qui?» rise Bonjour.
Vi era una piccola vettura appostata sul lato collinoso della via. Hattie
era in piedi lì davanti, calma. Non sapevo quando fosse arrivata e non riuscivo a immaginare che cosa avesse creduto di vedere.
«Quentin» mi chiamò, muovendo un passo prudente. Le tremava la voce. «Ho chiesto a uno degli stallieri di accompagnarmi. Ero già passata
qualche volta, ma non vi avevo mai trovato.»
«Sono uscito spesso» replicai scioccamente.
«Ho pensato che le tenebre avrebbero garantito la riservatezza al nostro
incontro.» Lanciò un'occhiata a Bonjour, che indugiò sull'erba fredda prima di alzarsi. «Quentin? Chi è questa?»
«Questa è Bon...» Mi interruppi, accorgendomi che quel nome sarebbe
parso una mia trovata stravagante. «Un'ospite parigina.»
«Avete conosciuto questa giovane signora a Parigi, e ora lei è venuta a
farvi visita?»
«Non a me in particolare, signorina Hattie» protestai.
«Siete innamorato, dopo tutto, monsieur Quentin. È bellissima!» Bonjour scosse la testa. Si chinò come se stesse sbirciando una nuova figliata
di gattini. Hattie sussultò dinanzi all'intervento della sconosciuta, stringendosi nello scialle.
«Ditemi, com'è stata la sua proposta di matrimonio?» domandò Bonjour
a Hattie.
«Per favore, Bonjour!» Quando le voltai le spalle per ammonire la ladra,
Hattie montò in carrozza e ordinò al cocchiere di partire. «Hattie, aspettate!» implorai.
«Devo rientrare, Quentin.» Inseguii la vettura e chiamai Hattie prima
che i cavalli si addentrassero nella foresta e mi distanziassero troppo.
Quando mi girai verso Glen Eliza, anche Bonjour era svanita, ed ero solo.
Il mattino successivo, rimproverai con asprezza la cameriera che aveva
agevolato l'inganno di Bonjour.
«Non venire a raccontarmi, Daphne, di aver creduto che quella giovane
donna, a malapena dell'età giusta per essere mia moglie, fosse davvero la
mia prozia!»
«Non ho detto "prozia", signore, bensì solo zia, come aveva affermato
lei. Indossava uno scialle e un cappello graziosissimo, signore, perciò non
ho fatto caso all'età. Nemmeno l'altro gentiluomo l'ha interrogata al proposito quando è entrato là dentro. E inoltre, signore, nelle famiglie numerose
si possono avere molte zie di tutte le età. Conoscevo una ragazza di ventidue anni la cui zia non ne aveva ancora compiuti tre.»
Mi soffermai sulla sua obiezione più saliente: Duponte. Forse era possibile che, nel bel mezzo della sua consueta concentrazione imperturbabile, e
con i vetri colorati che immergevano la biblioteca nell'oscurità anche durante il giorno, avesse notato soltanto una sagoma femminile seduta al tavolo quando era andato a cercare il suo libro. Tuttavia, sembrava improbabile. Affrontai l'argomento con Duponte, senza riuscire a frenare la collera.
«Ora il barone possiede quasi metà, se non di più, delle informazioni che
abbiamo raccolto! Monsieur, non avete veduto Bonjour proprio dinanzi a
voi quando siete entrato nella biblioteca ieri?»
«Non sono cieco» rispose. «Tanto meno di fronte a una splendida ragaz-
za. È una stanza buia, ma non così buia. L'ho veduta con chiarezza.»
«Per l'amor di Dio, perché non mi avete chiamato? La situazione è molto
compromessa!»
«La situazione?» ripeté Duponte, forse avvertendo che la mia ira non
scaturiva solo dall'intromissione di Bonjour nella nostra indagine. In effetti, mi domandavo se sarei stato ancora la stessa persona agli occhi di Hattie.
«Tutti i particolari che noi avevamo scoperto e loro no» spiegai in tono
fermo e più pacato.
«Ah. No, monsieur Clark. La nostra percezione degli accadimenti verificatisi intorno all'ora della morte di monsieur Poe dipende soltanto in minima parte dall'apprendimento di fatti e dettagli, che sono invece la linfa
dei giornali. Non è quello il nocciolo delle nostre conoscenze. Non fraintendetemi: i dettagli sono fondamentali, e talora difficili da appurare, ma
non sono illuminanti in sé e per sé. Occorre saperli leggere adeguatamente
per individuarne il contenuto di verità... e la lettura del barone Dupin non
ha nulla a che vedere con la nostra. Se temete che daremo un vantaggio al
barone, non preoccupatevi, giacché è il contrario di quanto credete. Se la
sua interpretazione è errata, più resoconti dovrà leggere e più resterà indietro.»
Capitolo 17
Egregio Signore,
vi è un uomo, piuttosto malconcio, alla quarta sezione elettorale
del Ryan, che va sotto il nome di Edgar A. Poe e che sembra in
condizioni assai gravi. Sostiene di conoscervi, e Vi assicuro che
necessita di aiuto immediato.
Walker, un tipografo della città, aveva firmato quel biglietto con uno
scarabocchio frettoloso, forando quasi la carta ruvida con la matita. Il messaggio era datato 3 ottobre 1849 e indirizzato al dottor Joseph Snodgrass,
residente nei pressi del Ryan.
Qualche giorno dopo che io e Duponte ci eravamo introdotti nello studio
di Snodgrass e che Hattie era rimasta sbalordita vedendomi avvinghiato a
un'altra donna, Claude Dupin tornò dal dottore.
Lo stavo spiando, quando si bloccò di colpo a un angolo di Baltimore
Street come se avesse dimenticato di fare qualcosa di estremamente impor-
tante. Sull'altro lato della strada, tentavo di confondermi tra la folla di pedoni diretti verso ristoranti o alberghi per il pranzo e tra gli alti cesti in bilico sulle teste di schiavi e braccianti. Dopo aver atteso per un periodo interminabile che il barone facesse qualcosa, fui distratto dal fragore di una
carrozza che sbandò all'improvviso accanto a me.
Dall'interno, giunse una voce: «Che cosa combinate? Cocchiere! Perché
vi siete fermato qui?».
Dopo essermi accertato che il barone non si fosse mosso, decisi di indagare sull'identità del passeggero spazientito. Avvicinatomi alla vettura, mi
paralizzai. Riconobbi subito uno degli uomini che avevo veduto per la
prima volta al cimitero tra Greene e Fayette Street. In quell'occasione, aveva assistito con irrequietezza alle esequie di Edgar Poe, spostandosi senza sosta da un piede all'altro.
«Mi avete sentito, cocchiere?» continuò a lagnarsi. «Cocchiere?»
Lì, per virtù di un bizzarro ordinamento dell'universo, quel tale era uscito da un oscuro paese dei sogni, un luogo di fango e nebbia, ed era venuto
dritto da me alla luce del giorno. Dopo i miei incontri con Neilson Poe e
Henry Herring, ora mi trovavo al cospetto del terzo dei quattro tizi presenti
al funerale. Restava soltanto il quarto, Z. Collins Lee, un compagno di università di Poe che, come avevo appreso di recente, era stato nominato
procuratore distrettuale degli Stati Uniti.
Mi trasferii sul lato della carrozza. Ormai l'uomo era tuttavia scivolato
dall'altra parte, sbraitando all'indirizzo del vetturino e armeggiando con la
maniglia per aprire lo sportello. Stavo per attirare la sua attenzione chiamandolo dal finestrino, quando il battente si spalancò.
«Il dottor Snodgrass!» tuonò una voce.
Mi ritrassi, nascondendomi accanto ai cavalli.
Era il barone.
«Ancora voi!» sbottò Snodgrass, sdegnoso, mentre smontava. «Che cosa
ci fate di nuovo qui?»
«Assolutamente nulla» rispose Claude Dupin con candore. «E voi?»
«Con il vostro permesso, signore. Ho un altro appuntamento. E questa
canaglia di cocchiere...»
Chinandomi, scorsi Newman seduto in cassetta, e capii. Il barone non
stava bighellonando lì di fronte, bensì aspettava che gli portassero il dottore. Senza dubbio aveva ordinato allo schiavo di appostarsi in un punto in
cui Snodgrass avrebbe sicuramente cercato una vettura a nolo. La prima
volta che avevo origliato il dottore e Claude Dupin, avevo veduto il viso di
Snodgrass solo di profilo. Ora il barone estrasse il biglietto di Walker dalla
tasca del cappotto e lo mostrò al suo interlocutore.
Snodgrass era esterrefatto. «Chi siete?» domandò.
«Quel giorno avevate l'incarico di curare il benessere del signor Poe. Se
volessi, questo messaggio potrebbe essere stampato sui giornali come prova della vostra responsabilità. Alcuni, non sapendo come stanno davvero le
cose, potrebbero ipotizzare che stiate nascondendo qualcosa, sia perché
non vi siete fatto avanti onestamente con ulteriori dettagli, sia perché, cosa
ancor peggiore, avete mandato il signor Poe all'ospedale da solo.»
«Sciocchezze! Perché dovrebbero pensarlo?» chiese Snodgrass.
Il barone scoppiò in una risata bonaria. «Perché è quello che riferirò ai
giornali.»
Snodgrass esitò, oscillando tra la rabbia e la sottomissione. «Vi siete intrufolato in casa mia, signore? Se avete rubato quel foglietto, signore...»
Ora Bonjour si materializzò accanto a suo marito.
«Tu! Tess!» Quello era stato il nome falso adottato dalla ragazza nella
dimora degli Snodgrass. «La mia cameriera?» Il dottore non poté fare a
meno di scegliere la rabbia. «Chiamo subito la polizia!»
«Potreste fornire loro le prove di un furtarello. Ma vi sono anche prove...
be', devo forse continuare?» intervenne il barone, portandosi un dito alle
labbra per trattenersi. «Ecco, devo forse aggiungere che ci siamo imbattuti
in altri documenti confidenziali...? Oh, il pubblico e tutti i vostri illustri
comitati, associazioni e via discorrendo sarebbero assai interessati se dovessimo sollevare un polverone... Non credi anche tu... Tess, mia cara?»
«Un ricatto!» Snodgrass si frenò di nuovo, indignato ma anche titubante.
«Faccenda sgradevole, ne convengo.» Claude Dupin liquidò l'argomento
agitando la mano. «Ma torniamo a Poe. Vedete, è questo che ci preme
davvero. Se il pubblico conoscesse la vostra storia, se credesse che avete
cercato di salvargli la vita... sarebbe diverso. Ma noi dobbiamo sentire la
vostra storia per primi.»
Il barone Dupin possedeva l'astuta capacità di passare senza fatica dalle
minacce alle moine. Aveva adottato il medesimo trucco con il dottor Moran, all'ospedale in cui Poe si era spento.
«Venite ora. Di nuovo in carrozza, dottore... Facciamo un salto al
Ryan.»
O almeno, credo siano state queste le sue parole successive mentre Snodgrass, sconfitto, rifletteva su come rispondere, e io mi ero già incamminato per trovare un posto discreto in cui aspettarli all'albergo, intuendo che
quella era la loro destinazione.
«Una volta ricevuta quella lettera dal signor Walker, mi sono rifugiato in
questa bettola (taverna è una denominazione troppo nobile) e, infatti, eccolo lì» proseguì Snodgrass, accompagnando il barone all'interno.
Sedevo a un tavolo in un angolo del locale, protetto dal buio e schermato
anche dall'ombra delle scale che salivano fino alle stanze in affitto, spesso
utilizzate dagli avventori troppo sbronzi per ritrovare la strada di casa.
«Poe» interloquì il barone.
Snodgrass si arrestò davanti a una poltrona sudicia. «Sì, sedeva qui con
la testa ciondoloni. Era nelle condizioni descritte fin troppo fedelmente nel
messaggio del signor Walker... che, ribadisco, non avevate il diritto di leggere.»
Claude Dupin reagì a quel rimprovero con un semplice sorriso. Snodgrass continuò, abbattuto.
«Era così differente dall'uomo brioso ed elegante cui ero abituato che ho
faticato a distinguerlo tra la folla di avvinazzati riuniti qui per le elezioni.»
«Questa stanza era un seggio elettorale quella sera?» domandò il barone.
«Sì, per la sezione locale. Ricordo bene tutta la scena. Il volto di Poe era
macilento, per non dire gonfio» aggiunse Snodgrass, senza curarsi degli
aggettivi contraddittori. «Sporco, scarmigliato, il corpo ripugnante. La sua
fronte, meravigliosamente ampia, e quegli occhi tondi e caldi ma profondi... spenti e vacui.»
«Avete guardato bene il suo abbigliamento?» Il barone scribacchiava a
tutta velocità sul suo taccuino.
Snodgrass parve sbalordito dal suo stesso ricordo. «Non vi era nulla di
bello da vedere, temo. Indossava un panama scolorito, sbrindellato, senza
nastro e quasi senza tesa. Una giacca di alpaca nero, logora e malridotta,
strappata in corrispondenza di diverse cuciture, lurida e sbiadita, e pantaloni di tessuto laminato cascanti e mezzo consunti. Non portava il panciotto né il fazzoletto da collo, e lo sparato della camicia era sgualcito e costellato di macchie. Ai piedi, lo rammento bene, aveva stivali di cuoio grezzo,
che parevano non essere stati lucidati da tempo.»
«Che cosa avete fatto, dottor Snodgrass?»
«Sapevo che Poe aveva diversi parenti a Baltimora. Così gli ho prenotato subito una camera. Ho seguito un cameriere al piano superiore e, dopo
aver scelto una stanza adeguata, stavo scendendo di nuovo al bar per ordinare che l'ospite venisse trasferito di sopra, cosicché potesse stare tranquil-
lo fintantoché avessi informato i suoi familiari.»
Avanzarono verso le scale, Snodgrass che indicava la camera di Poe
dall'altra parte dei gradini. Feci del mio meglio per confondermi con l'oscurità.
«Dunque avete scelto una stanza per il signor Poe e poi avete mandato a
chiamare i suoi congiunti?» domandò il barone.
«È questo il particolare strano. Non è stato necessario. Allorché sono
giunto di nuovo in fondo alle scale, sono incappato nel signor Henry Herring, un parente acquisito di Poe.»
«Prima di mandare a chiamarlo?» chiese il barone. Anch'io giudicai bizzarro quel dettaglio, e tesi le orecchie per udire la risposta di Snodgrass.
«Esatto. Era sul posto, forse con un altro dei familiari di Poe; non ricordo.»
Ecco un'ulteriore stranezza. Neilson Poe mi aveva riferito di essere venuto a conoscenza delle condizioni di Edgar quando quest'ultimo si trovava in ospedale. Se vi era un altro parente con Henry Herring, e non era
Neilson, chi era?
Snodgrass proseguì. «Ho domandato al signor Herring se volesse portare
Poe a casa sua, ma ha rifiutato con decisione. "In precedenti occasioni,
quando era ubriaco, Edgar è stato assai offensivo e sgradevole" mi ha
spiegato. Ha affermato che l'ospedale sarebbe stato un luogo più idoneo
dell'hotel. Abbiamo incaricato un messaggero di trovare una carrozza per il
Washington College Hospital.»
«Chi ha accompagnato il signor Poe all'ospedale?»
Snodgrass abbassò lo sguardo, imbarazzato.
«L'avete mandato da solo, dunque» dedusse il barone.
«Non riusciva a stare seduto, sapete, e non vi era più spazio nella vettura
una volta che l'abbiamo steso sui sedili. Non era in grado di camminare.
L'abbiamo trasportato come se fosse un cadavere, sollevandolo per depositarlo nel veicolo. Ha opposto resistenza, borbottando qualcosa, ma nulla di
intelligibile. In quell'istante non immaginavamo che fosse gravemente malato. Ahimè, era intontito dall'alcol. È stato quello il suo ultimo demone.»
Snodgrass sospirò.
Conoscevo già l'opinione del dottore sul presunto alcolismo di Poe. Tra i
documenti conservati nel suo studio, Duponte era incappato in alcuni versi
sulla morte di Edgar. Oh! Che triste spettacolo, recitavano i ritornelli di
Snodgrass,
Il tuo fiero giovane cuore e il tuo nobile cervello
immersi nel liquido demoniaco - la tua mente
non più acconcia allo sforzo
del pensiero melodioso e sublime.
«Questo è tutto per quanto riguarda la morte di Poe» concluse ora Snodgrass, accigliato. «Spero che siate soddisfatto e che non miriate a gettare
altra luce sul peccato di Edgar. Le sue debolezze sono già state deplorate
abbastanza in pubblico, e per il momento ho fatto il possibile per non aggiungere altro.»
«Sotto questo aspetto, dottore, non avete nulla di cui preoccuparvi» gli
assicurò il barone. «Poe non aveva bevuto alcunché.»
«Come sarebbe a dire? Non ho dubbi. È stata una sbornia, signore, a uccidere Poe. La sua malattia era la mania a potu, come hanno affermato i
giornali. Io sono a conoscenza dei fatti.»
«Avete assistito ai fatti, e forse ne siete persino a conoscenza, ma temo
che non siate a conoscenza della verità» replicò Claude Dupin con un sorriso, levando la mano per zittire le proteste di Snodgrass. «Non dovete cercare di difendervi, dottor Snodgrass. Avete fatto del vostro meglio. Ma non
siete stato voi, signore, né alcun genere di alcol ad ammazzare Edgar Poe.
Quel giorno vi erano forze molto più diaboliche all'opera contro il poeta.
Ma verrà riabilitato.» Ora il barone parlava più con se stesso che con Snodgrass.
Il dottore agitò tuttavia la mano nell'aria, come se l'avessero gravemente
insultato. «Signore, sono un esperto in materia. Dirigo da lungo tempo i
comitati per la disintossicazione da alcol di Baltimora. Sono in grado di riconoscere un... un... ubriacone quando ne vedo uno, non credete? Che cosa
state cercando di fare? Tanto vale che tentiate di raddrizzare le gambe ai
cani!»
Il barone ripeté le sue ultime parole con lentezza, girando in cerchio, le
narici che si dilatavano come quelle di un cavallo da guerra. «Edgar Poe
verrà riabilitato.»
Capitolo 18
«Poe non aveva bevuto alcunché, ha asserito il barone, e non è stato l'alcol a cagionarne la morte, contrariamente a quanto sostengono i giornali.»
Ora sedevo di fronte a Duponte nella mia biblioteca, appollaiato sul bor-
do della sedia.
Ovviamente, non volevo sembrare troppo contento per la conversazione
tra il barone e Snodgrass. Non intendevo abbandonarmi a elogi eccessivi
per Claude Dupin. Dopo tutto, era il nostro principale concorrente e ostacolo.
«Oh, l'espressione sul volto del dottor Snodgrass!» mi lasciai sfuggire.
«Dupin avrebbe dovuto sferrargli un bel pugno alla mascella.» Risi. «Snodgrass, quel finto amico, se lo meritava, se volete il mio parere.»
Mi venne in mente un pensiero, o meglio un quesito, che non c'entrava
nulla. Nei racconti di Poe, mi domandai, c'era forse qualche accenno al fatto che C. Auguste Dupin avesse fatto l'avvocato? Non riuscii a trattenermi.
Quell'interrogativo mi ronzava nella testa senza darmi l'opportunità di
scacciarlo.
«Qualcos'altro?»
«Prego?» Mi riscossi, accorgendomi che vi era stata una pausa di silenzio impacciato.
«Avete osservato qualcos'altro oggi, monsieur?» chiese Duponte, ruotando la sedia per metà verso la scrivania ingombra di quotidiani.
Gli elencai gli altri elementi interessanti, in particolare la presenza improvvisa e inspiegabile di Henry Herring al Ryan prima che Snodgrass avesse avuto il tempo di mandarlo a chiamare, e la descrizione particolareggiata degli abiti in disordine di Poe. Badai a non ripetere più il nome del
barone Dupin, sia per il mio bene sia per quello di Duponte.
«Neilson Poe, Henry Herring! E ora Joseph Snodgrass!» esclamai, disgustato.
«Che cosa intendete, monsieur?» volle sapere Duponte.
«Erano tutti al funerale di Poe... uomini che avrebbero dovuto onorarlo.
Invece, Snodgrass lo dipinge come un ubriacone. Neilson Poe non muove
un dito per difendere la reputazione di suo cugino. Henry Herring si precipita al Ryan ancor prima che Snodgrass lo contatti, e soltanto per spedire il
suo parente gravemente ammalato tutto solo all'ospedale con una vettura a
nolo.»
Schioccando la lingua, Duponte si passò una mano sul mento con aria
meditabonda, quindi girò la sedia fino a darmi le spalle.
Pressappoco in quel periodo, avevo cominciato a maturare la convinzione che, incoraggiando il mio ruolo di spia, Duponte avesse perlopiù voluto
tenermi occupato. Dopo l'inquietante conversazione riportata sopra, gli ri-
volsi la parola solo per riferirgli le mie ultime scoperte, che di solito ascoltava con placida indifferenza; certe sere, se si era già ritirato quando rientravo a Glen Eliza, gli lasciavo una breve lettera per raccontargli le novità
della giornata. Non riuscivo inoltre a dimenticare che la rassegnazione apatica che aveva dimostrato nello smascherare il tiro mancino di Bonjour aveva condotto alla scena imbarazzante tra me e Hattie. Suppongo che si
fosse accorto della mia freddezza, ma non fece mai alcun commento in
merito.
Un giorno, a colazione, dissi: «Sto pensando di scrivere una missiva. Al
giornale della lega antialcolica newyorkese secondo cui Poe, al momento
della sua morte, era ubriaco. Ci ho riflettuto molto. Qualcuno dovrebbe
pretendere che divulgassero il nome e il resoconto di questo cosiddetto testimone».
Sulle prime, Duponte non rispose. Poi alzò lo sguardo velato.
«Che cosa ne pensate dell'articolo pubblicato sul periodico della lega antialcolica, monsieur Duponte?»
«Che quello è il periodico di una lega antialcolica» rispose. «La loro aspirazione ufficiale è l'eliminazione universale del consumo di liquori, ma
hanno un'esigenza diversa, anzi opposta, monsieur: una riserva affidabile
di individui stimati e rovinati dall'alcol, per mostrare ai lettori come mai il
loro giornale debba restare in vita. Poe era diventato uno di loro.»
«Allora non credete che il testimone della rivista sia reale?»
«Ne dubito.»
Questo alimentò le mie speranze e, per un attimo, ripristinò del tutto la
mia amicizia con Duponte. «E voi, monsieur, avete raccolto le prove che
potremmo usare per sbugiardarli. Siamo in grado di dimostrare che Poe
non aveva bevuto mentre era qui?»
«Non ho mai detto di credere che non l'avesse fatto.»
Per un attimo, lo sgomento mi paralizzò tanto da impedirmi di replicare.
La sua affermazione non scaturiva da una certezza assoluta, ma temevo di
averla interpretata fin troppo bene come l'esatto contrario della frase pronunciata dal barone al Ryan. I miei pensieri cercarono un altro argomento
di conversazione. Non volevo ascoltarlo.
«Anzi» riprese, apprestandosi a confermare la mia paura, «sono quasi sicuro che avesse bevuto.»
Avevo sentito bene? Duponte aveva fatto tanto solo per decretare la
condanna di Poe?
«Ora, parlatemi delle sottoscrizioni che il barone sta raccogliendo» mi
esortò.
Ero così scombussolato che avrei preferito affrontare qualsiasi altro discorso. Claude Dupin aveva continuato ad ammassare denaro per tutta Baltimora. Da solo, in un ristorantino, aveva intascato con soddisfazione i
contributi di dodici individui impazienti di ascoltarlo. Il proprietario, infastidito dalle interruzioni, mi aveva ripetuto il contenuto dei suoi discorsi.
«Tra due settimane, signori» aveva detto il barone «udirete il primo resoconto veritiero della morte di Poe.» Una volta, rivolgendosi a Bonjour, aveva asserito: «Quando la notizia del mio successo raggiungerà Parigi, allora, allora...». Aveva lasciato la frase a metà; nella sua insaziabile fantasia, quel successo gli schiudeva ogni tipo di possibilità.
Qualche giorno dopo, Claude Dupin apparve nella hall del suo hotel con
un'aria un poco afflitta. In seguito, corruppi un facchino e gli chiesi che
cosa fosse accaduto. Il barone aveva mandato a chiamare il suo schiavo di
colore, disse, e aveva scoperto che se n'era andato. Dopo parecchie urla e
parecchio scompiglio, le autorità civili avevano appurato che Newman era
stato affrancato. Il barone sapeva di essere stato raggirato, e da chi. Era
scoppiato a ridere.
«Perché ridete?»
«Perché, mia cara» aveva detto a Bonjour «avrei dovuto capirlo subito.
Certo che è stato affrancato.»
«Volete dire che è stato Duponte? Ma come?»
«Non conosci Duponte. Ma lo conoscerai meglio.»
La descrizione della sua frustrazione mi fece sorridere.
Il giorno prima, su ordine di Duponte, avevo scoperto il nome del proprietario di Newman. Necessitava di quattrini con urgenza per saldare i
suoi debiti, sicché aveva accettato di affittare il ragazzo al barone per un
periodo di tempo indeterminato. Non sapeva che Claude Dupin avesse promesso a Newman di comprargli la libertà. Era anche inorridito quando l'avevo informato che, a differenza di quanto gli avevano fatto credere, il nero non era andato a lavorare per «una famigliola», e si era infuriato quando
gli avevo svelato l'inganno. Non si era adirato abbastanza, tuttavia, da rifiutare il mio assegno in cambio dell'affrancamento dello schiavo. Lavorando allo studio legale, avevo maturato una notevole esperienza nel trattare con le persone oberate di debiti senza urtare la loro sensibilità e senza
trascurarne le necessità impellenti.
Avevo persino accompagnato il giovane alla stazione affinché partisse
per Boston. Quando si affrancava uno schiavo, era obbligatorio allontanarlo rapidamente dallo Stato cosicché non esercitasse un'influenza negativa
sui neri che erano ancora asserviti. Newman era apparso felicissimo mentre camminavamo, ma mi era sembrato assai preoccupato, come se il terreno potesse crollarci sotto i piedi prima che lui arrivasse sano e salvo oltre il
confine. Non era lontano dalla sua meta. Distavamo solo qualche metro
dalla stazione, quando un frastuono assordante ci aveva raggiunti da dietro,
spingendo tutti i pedoni, noi compresi, a fuggire dalla strada.
Si erano avvicinati tre omnibus gremiti di uomini, donne e bambini neri.
Dietro i veicoli vi erano diversi tizi a cavallo. Ne avevo riconosciuto uno,
alto e dai capelli argentei: Hope Slatter, il più potente schiavista, o «negriero», di Baltimora. I maggiori mercanti di schiavi della città erano soliti
alloggiare i neri che acquistavano dai venditori nelle loro prigioni private,
quasi sempre un'ala delle loro abitazioni, fino a radunarne un numero sufficiente per riempire una nave e giustificare i costi di una spedizione a
New Orleans, il fulcro del traffico meridionale. Ora Slatter e i suoi assistenti erano diretti al porto con una decina di schiavi in ciascun omnibus.
Ai lati dei veicoli aspettavano altri neri, che si fermavano di continuo per
levare le braccia verso i finestrini, e quindi correvano per tenere dietro alle
carrozze, tentando di accarezzare gli occupanti o di parlare con loro per
l'ultima volta. Era impossibile stabilire se venissero versate più lacrime
dentro o fuori. Dall'interno, una voce femminile lanciava urla isteriche,
abbastanza forti da essere udite da chiunque. La donna cercava di chiarire
che il suo padrone l'aveva venduta a Slatter con la condizione esplicita che
non venisse separata dalla sua famiglia, cosa che invece il negriero stava
per fare.
Avevo allontanato Newman, ma la scena, forse l'ultima di quel genere
che avrebbe veduto prima di partire per il Nord, l'aveva sprofondato in un
pericoloso stato d'animo.
Slatter e i suoi aiutanti avevano messo mano alle fruste, intimando ai neri che circondavano gli omnibus di non intralciare il loro cammino. Un
uomo si era arrampicato verso un finestrino e vi si era aggrappato, chiamando la moglie, che non riusciva a vedere. Lei si era fatta largo tra gli
schiavi a bordo della vettura.
Slatter, accorgendosene, aveva girato intorno alla carrozza sull'altro lato.
«Smettila!» gli aveva ordinato.
L'altro l'aveva ignorato, allungando le braccia per stringere la donna.
Slatter aveva estratto il bastone, la cui cinghia era avvolta strettamente
intorno al suo polso. Aveva colpito il nero prima alla schiena e poi allo
stomaco, quindi l'aveva lasciato a contorcersi per terra. «Via, brutto cane,
prima che ti faccia arrestare! Quello che ti succederebbe in seguito non sarebbe di tuo gradimento!»
Mentre guidava il cavallo in maniera da schivare il malcapitato, i suoi
occhi si erano posati su di me, o meglio sul giovane nero accanto a me.
«Chi è quello?» aveva domandato in tono grave dall'alto della sua sella,
approssimandosi con il bastone puntato verso Newman.
Le labbra del ragazzo erano attraversate da un tremito incontrollabile;
aveva tentato di rispondere, ma invano. Mi ero augurato che Slatter si limitasse a concludere il suo ripugnante compito, ma non sarebbe andata così.
Con il bastone, aveva indicato la bocca di Newman e poi tutto il suo
corpo, come se stesse tenendo una lezione alla facoltà di medicina. «Un
negro niente male, vero? Bella bocca, denti abbastanza sani, nessuna frattura ossea visibile. Ottimo cocchiere, scommetto, o cameriere, se sa essere
attento e onesto.» Rivolgendosi a me, aveva aggiunto: «Potrei venderlo per
almeno seicento dollari, con una percentuale per me, amico mio».
«Non sono il suo padrone» avevo replicato. «E non è neppure in vendita.»
«Allora è forse il vostro bastardo?» aveva ribattuto con sarcasmo.
«Sono Quentin Clark, un avvocato di questa città. Il giovane che vedete
è stato affrancato.»
«Sono un uomo libero, capo» aveva detto finalmente Newman con un filo di voce.
«Oh?» aveva fatto Slatter con aria pensierosa, girando il cavallo e abbassando ancora lo sguardo su di lui. «Vediamo i certificati, allora.»
A quel punto, Newman, che aveva ricevuto tutti i documenti necessari
quel mattino, era riuscito soltanto a tremare e a balbettare.
«Forza» aveva insistito Slatter, conficcandogli la punta del bastone nella
spalla.
«Lasciatelo in pace» avevo urlato. «L'ho liberato di persona, è un uomo
con più libertà di voi, signor Slatter, giacché sa che cosa significa non averla.»
Slatter stava per colpire con maggior violenza la spalla di Newman,
quando avevo levato il mio bastone per bloccare il suo. «Ditemi, signor
Slatter» avevo continuato «poiché siete così interessato ai documenti, mi
domando se gradireste che le autorità perquisissero i vostri schiavi
sull'omnibus e si assicurassero che siano tutti conformi agli atti di vendi-
ta.»
Mi aveva rivolto un sorriso cupo. Aveva ritirato il bastone con accondiscendenza e, senza dire altro, aveva affondato i tacchi nei fianchi del cavallo per raggiungere la fila di veicoli diretti al porto. Newman aveva il respiro affannoso.
«Perché non gli hai mostrato le carte?» gli avevo chiesto, incuriosito.
«Le hai portate con te, vero?»
Si era indicato la testa, coperta da un cappello sbrindellato: le aveva cucite nella tesa. Poi mi aveva spiegato che molti schiavisti come Slatter pretendevano di esaminare i certificati di emancipazione e, una volta che li
avevano in mano, li distruggevano. Quindi nascondevano nei loro recinti
gli uomini e le donne legittimamente affrancati prima di venderli in un altro Stato, lontano da qualunque prova potesse dimostrare che non erano
schiavi bensì uomini liberi.
Capitolo 19
«Monsieur Duponte, devo domandarvi subito una cosa.»
Lo dissi dopo una delle nostre recenti cene silenziose nell'ampia sala da
pranzo rettangolare di Glen Eliza.
Duponte assentì.
«Quando il barone terrà la sua conferenza sulla morte di Poe, potrebbe
inquinare irreparabilmente i fatti. Forse, mentre pronuncerà il suo discorso,
dovrei attirarlo fuori dell'aula, e voi potreste salire sul palco e rivelare la
verità al pubblico» continuai.
«No, monsieur» obiettò, scrollando il capo. «Non faremo nulla del genere. La posta in gioco è più alta di quanto crediate.»
Annuii con mestizia e non toccai più cibo. Era stato una specie di test.
Duponte non l'aveva superato. Si richiuse nel suo impassibile silenzio.
Ero totalmente assorto nelle mie riflessioni. Con mio palese fastidio, i
noiosi tizi che supervisionavano alcuni degli investimenti di mio padre si
presentarono alla porta, ma li mandai via all'istante. Non ero in vena di
pensare a cifre e resoconti annuali.
La lettera rubata, il secondo seguito degli Assassinii della Rue Morgue.
Ecco su cosa rimuginavo con aria tanto melanconica. C. Auguste Dupin
scopre il nascondiglio segreto della missiva trafugata dal ministro D... e
occultata in maniera assai ingegnosa, perché riposta proprio sotto gli occhi
di tutti. È la banalità del luogo a ingannare tutti a eccezione di una persona.
L'analista chiede a un complice anonimo di sparare un colpo di pistola per
creare scompiglio nella via. Il diversivo gli consente di recuperare la lettera e sostituirla con un falso.
Ve l'ho raccontato per illustrarvi una teoria. C. Auguste Dupin si fida del
suo collaboratore, e inoltre nutre una fiducia sempre maggiore nell'operato
del suo fedele assistente in tutta la trilogia.
Tuttavia, Auguste Duponte, il mio amico, non dava alcun credito al mio
ruolo di complice e liquidava tranquillamente le mie numerose idee e suggerimenti, che si trattasse di interrogare Henry Reynolds (proposta per cui
si era fatto beffe di me) o di interrompere la conferenza del barone. Al contrario, Claude Dupin era sempre disposto ad appoggiarsi ai suoi complici
in ogni circostanza.
Non bisognava poi dimenticare la sua interessante predisposizione per i
travestimenti e le trasformazioni. Si poteva notare una somiglianza con il
Dupin letterario, che, nella Lettera rubata, usa un paio di occhiali verdi per
ingannare il suo brillante rivale, il ministro D...
E per quanto concerneva la precedente professione di Claude Dupin?
Negli ultimi giorni, avevo cominciato a sottolineare alcune righe della trilogia. In alcuni passi fondamentali, Il mistero di Marie Roget rivela al lettore attento che C. Auguste Dupin ha molta dimestichezza con la legge, alludendo forse al suo vecchio lavoro di avvocato. Proprio come nel caso del
barone.
Poi vi era quell'iniziale, così insignificante per l'occhio non informato:
C. Auguste Dupin. C. Dupin. Non poteva rammentare al lettore un certo
Claude Dupin? E, a partire dal secondo racconto, il geniale analista di Poe
non assume forse l'onorato titolo di «Cavaliere»? Cavaliere C. Auguste
Dupin. Barone C. Dupin.
E quanto alla fredda inclinazione del barone Dupin per il denaro?, mi
domandai. Ahimè, ricorderete che C. Auguste Dupin pretende un profitto
monetario per l'impiego delle sue capacità in tutti e tre i racconti.
E soprattutto, Claude Dupin aveva affrontato Snodgrass, negando con
coraggio l'idea secondo cui Poe era deceduto a causa di una volgare sbornia. Mentre, in quello stesso giorno, a Glen Eliza, Auguste Duponte aveva
ammesso la plausibilità di quella tesi ignobile. Il suo commento noncurante riguardo all'alcolismo di Poe aveva seguitato a risuonarmi nella mente
finché l'amarezza e il rimpianto si erano impadroniti di me. «Non ho mai
detto di credere che non l'avesse fatto.»
Intravidi i semi della mia idea e permisi loro di germogliare: e se, per
tutto quel tempo, Claude Dupin fosse stato il vero Dupin? E Poe non aveva
forse adorato quel furfante allegro, filosofico e truffaldino che tanto mi aveva emozionato e tormentato? In una lettera, il poeta mi aveva scritto che
i racconti dedicati a Dupin erano ingegnosi non solo per il loro metodo, ma
anche per la loro «sembianza di metodo». Il barone non aveva forse compreso l'importanza delle apparenze per ottenere il rispetto di chi lo circondava, mentre Duponte ignorava e alienava tutti inutilmente? Quale profondo e inusitato sollievo mi infusero quei pensieri! Avevo fatto male i miei
calcoli sin dal principio.
Benché fosse tarda notte quando quelle considerazioni mi sopraffecero,
scesi le scale senza far rumore e sgattaiolai fuori da Glen Eliza. Raggiunsi
la camera d'albergo del barone mezz'ora dopo e mi fermai davanti all'uscio. Avevo il fiato grosso, troppo grosso, il mio respiro era un'eco dei
miei pensieri convulsi. Bussai, troppo elettrizzato e impaurito per essere
coerente. Un fruscio provenne dall'altro lato della porta.
«Forse mi sono sbagliato» bisbigliai. «Poche parole, per favore, solo
qualche istante.» Mi voltai per sincerarmi che nessuno mi avesse seguito.
L'uscio si socchiuse, e infilai il piede nella fessura.
Avrei avuto a disposizione solo pochi attimi per esporre la mia posizione. «Barone Dupin, per favore! Dobbiamo parlare subito. Credo... So che
siete voi quello vero.»
Capitolo 20
«Barone? In questo hotel alloggia un vero barone?»
Sulla soglia, vi era un uomo dalla barba folta, in pantofole e camicia da
notte, con una candela in mano.
«Questa non è la stanza del barone Dupin?»
«Noi non l'abbiamo veduto!» rispose quel tale, deluso, guardandosi sopra la spalla come se sotto la sua trapunta potesse esserci un barone cui
non aveva fatto caso. «Ma siamo arrivati solo oggi pomeriggio da Filadelfia.»
Dopo aver bofonchiato delle scuse, tornai in tutta fretta nell'atrio e sulla
strada. Claude Dupin aveva cambiato di nuovo alloggio e, nella mia disattenzione, non me n'ero accorto. Quando uscii dall'albergo, nella mia mente
vorticavano pensieri rapidi e contrastanti. Avvertendo subito uno sguardo
sulla mia testa, rallentai il passo. Non dipendeva soltanto dall'eccitabilità
del mio stato d'animo. Sotto il lampione, vi era il bel nero che avevo già
veduto, le mani affondate nelle tasche del cappotto. Oppure mi sbagliavo?
Restò sotto la luce solo per un attimo; poi lo persi di vista. Voltandomi
dall'altra parte, credetti di scorgere uno dei due uomini dagli abiti fuori
moda che tallonavano il barone. Il cuore mi batté forte alla vaga sensazione di essere circondato. Mi allontanai il più in fretta possibile, quasi andando a cozzare contro una vettura a nolo, cui ordinai di riaccompagnarmi
a Glen Eliza.
L'indomani, dopo una notte insonne durante la quale le immagini di Duponte e di Dupin si erano alternate e sovrapposte nella mia mente alle soavi note della vivace risata di Hattie, ricevetti un messaggio da parte del bibliotecario. Riguardava il tizio che gli aveva dato gli articoli su Poe, il
primo accenno all'esistenza del vero Dupin. Il vecchietto aveva rammentato, anzi aveva riveduto, quell'individuo, e gli aveva chiesto il biglietto da
visita per inviarmelo.
L'uomo che gli aveva consegnato i ritagli era il signor John Benson, un
nome che non mi diceva alcunché. Il biglietto decorato a smalto veniva da
Richmond, ma recava un indirizzo di Baltimora scritto in una calligrafia
maschile. Qualcuno aveva forse voluto che rintracciassi il vero Dupin?
Qualcuno aveva forse avuto motivo di desiderare che lo portassi a Baltimora per indagare sulla morte di Poe? Quel qualcuno mi aveva forse scelto
per quell'incarico?
A dire la verità, tuttavia, le mie speranze di ottenere una spiegazione erano scarse. Giudicavo probabile che l'anziano bibliotecario, seppur animato da buone intenzioni, avesse semplicemente confuso quell'uomo con lo
sconosciuto che aveva incontrato per pochi istanti due anni addietro.
Ripensai alle figure che si erano materializzate nell'oscurità intorno a me
la notte precedente. Quel giorno, prima di avventurarmi in città, recuperai
un revolver che mio padre aveva conservato in una scatola e portato con sé
durante i suoi viaggi d'affari nei Paesi meno civili che commerciavano con
Baltimora. Dopo essermi infilato l'arma nella tasca del cappotto, mi incamminai verso l'indirizzo stampato sul biglietto di Benson.
Attraversando Baltimore Street, da lontano intravidi Hattie dinanzi
all'insegna di un negozio elegante. Le rivolsi un timido cenno, non sapendo se avrebbe semplicemente preferito andarsene senza parlarmi.
Si lanciò in avanti con grande repentinità, abbracciandomi con calore.
Pur gioendo di quell'espansività e della consolazione di starle ancora vicino, immaginai con ansia e tormento sinceri che avrebbe potuto sfiorare la
pistola e sarebbe stata assalita di nuovo dai dubbi riguardo al mio comportamento. Si ritrasse con la stessa velocità con cui mi si era accostata, come
se avesse paura di sguardi indiscreti.
«Cara Hattie» esordii «non aborrite il solo vedermi?»
«Oh, Quentin. So che avete trovato nuovi mondi per voi stesso, nuove
esperienze oltre a quelle che avremmo potuto vivere insieme.»
«Non sapete chi è quella donna. È una ladra, una criminale! Per favore,
devo persuadervene. Parliamo in un luogo più tranquillo.»
La presi a braccetto, ma si liberò con dolcezza.
«Ormai è troppo tardi. Quella sera ero venuta a Glen Eliza solo per spiegarvi la situazione. Vi avevo detto che le cose sono assai diverse.»
Non poteva essere! «Hattie, ho dovuto fare quel che mi sembrava giusto.
Ma presto tutto tornerà alla normalità.»
«Mia zia desidera che non pronunci mai più il vostro nome e ha ordinato
a tutti i nostri amici di non accennare mai più al fidanzamento.»
«Ma non sarà difficile convincere zia Blum... Ciò che ha scritto nella lettera riguardo al fatto che avete trovato qualcun altro... non è vero?»
Assentì appena. «Sposerò un altro uomo, Quentin.»
«Non dipende da quanto avete veduto a Glen Eliza?»
Scosse la testa, il viso immobile e ambivalente.
«Chi?»
In quell'istante comparve in carne e ossa la risposta alla mia domanda.
Peter uscì dal negozio, contando le monete che la commessa gli aveva
dato di resto. Vedendomi, si voltò con aria colpevole.
«Peter?» urlai. «Non è possibile...»
Lasciò che il suo sguardo vagasse senza meta. «Salve, Quentin.»
«State per... maritarvi con Peter!» Avanzai e sussurrai all'orecchio di
Hattie in modo che il mio ex socio non potesse udirmi. «Cara signorina
Hattie, Hattie, ditemi solo una cosa: siete felice? Ditemi soltanto questo.»
Tacque, quindi assentì con vigore, tendendomi la mano.
«Quentin, discutiamone tutti insieme» propose Peter.
Ma non aspettai. Mi lanciai in avanti, superandolo senza neppure sfiorarmi il cappello. Desiderai che scomparissero entrambi.
«Quentin! Per favore!» gridò Peter. Mi seguì per qualche metro, ma rinunciò quando si avvide che non mi sarei fermato, o forse quando si avvide della rabbia che mi lampeggiava negli occhi.
Il peso mortale di quella nuova scoperta, per poco non mi fece dimenti-
care quello del revolver che tenevo nascosto nel cappotto. Recandomi dal
signor Benson, percorsi alcune delle vie più raffinate e trafficate di Baltimora.
Dopo che mi fui definito un estraneo ansioso di discutere brevemente di
una faccenda con il padrone di casa, e che mi fui scusato per non aver portato una lettera di presentazione, un domestico di colore mi accompagnò
fino a un sofà del salotto. I locali erano meno ingombri di quanto prescrivesse la moda dell'epoca, con una stravagante carta da parati di gusto orientale che faceva da sfondo a tante piccole sagome; l'unico ritratto di
grandi dimensioni si profilava dietro il divano, e all'inizio non mi sembrò
degno di nota.
Non so se, in termini scientifici, i sensi riescano a percepire lo sguardo
di un quadro, ma mentre attendevo il signor Benson, avvertii una curiosa
sensazione che mi indusse ad allungare il collo. Le lampade proiettavano
una luce vivida intorno al ritratto. Mi alzai quando gli occhi dipinti incrociarono i miei. Il volto era pieno, affaticato ma ancora colmo di vivacità,
come se appartenesse a un passato ideale. Gli occhi, tuttavia... No, che stupido. Ero impressionabile a causa degli accadimenti degli ultimi giorni. Il
viso in ombra era più avvizzito, i capelli più bianchi, il mento squadrato,
mentre il suo era scarno e quasi aguzzo. Ma gli occhi! Era come se qualcuno li avesse strappati dalle orbite scure del fantasma, il tale la cui immagine invadeva ancora la mia mente a intervalli regolari, il tizio che mi aveva
consigliato di non interferire e che, con quel suo ammonimento, aveva
quasi dato il via a tutta l'indagine. Mi affrettai a scacciare quella malsana
sensazione di déjà vu, ma rimasi comunque scombussolato. Continuando
ad aspettare, rammentai la scarsa fiducia che avevo nell'utilità di quella visita, e giudicai soffocante l'atmosfera formale della stanza. Decisi di lasciare il mio biglietto da visita e di tornare a Glen Eliza.
Ma, udendo qualcuno che arrivava, mi fermai.
Passi lenti scesero i gradini, e il signor Benson comparve da dietro la
curva delle scale.
Trasalii. «Il fantasma!»
Eccolo lì. Il tipo singolare che tanti mesi addietro mi aveva intimato di
non intromettermi nel caso di Poe. Una versione più giovane degli occhi
sulla parete dietro di me. Il tale che si era dissolto tra il fumo e la foschia
mentre ne inseguivo l'ombra per le strade. Senza pensarci, senza riflettere
su cosa avrei potuto fare dopo, infilai la mano nella tasca del cappotto, e le
mie dita trovarono il calcio della rivoltella.
«Prego?» domandò, voltando un orecchio verso di me con aria dubbiosa.
«Fenton, avete detto? Benson, signore, John Benson...»
Immaginai di puntargli la pistola alla bocca. Quella, dopo tutto, era la
bocca che mi aveva indotto a indagare su Poe, che aveva cagionato tutto
questo, il disinteresse verso i miei amici, il tradimento irreparabile di Hattie e Peter.
«No, non Fenton.» Non so quale bisogno irragionevole mi costrinse a rivelargli che era il mio acerrimo nemico. Digrignai i denti ripetendo la parola: «Fantasma».
Mi studiò con attenzione, portandosi un dito alle labbra per meditare sulla mia risposta. «Ah.» Quindi, alzando gli occhi per ricordare alcuni versi,
recitò:
«Quel dramma così scomposto - oh! state certi non sarà mai dimenticato!
Col suo Fantasma eternamente inseguito
da una folla che non lo raggiunge mai.
«Il signor Clark, vero? Questa sì che è una sorpresa.»
«Perché mi avete mandato quell'articolo? Volevate che trovassi Dupin?
Che razza di pazzo... Fin da principio ha architettato un piano. Non è così?» chiesi.
«Signor Clark, ammetto di essere confuso» rispose John Benson. «Se
posso farvi una domanda a mia volta, che cosa vi conduce qui?»
«Mi avete raccomandato di non interferire con la questione del decesso
di Poe. Non potete negarlo, signore!»
Si appoggiò allo schienale con un sorriso mesto. «Devo dedurre dal vostro atteggiamento che non mi avete dato ascolto?»
«Esigo delle spiegazioni!»
«Volentieri. Ma prima...» Mi tese la mano. Esitando per un istante dinanzi a quel gesto, estrassi la mia dalla tasca, lasciando il revolver e guardandogli le dita come se potesse strangolarmi. «Lieto di fare la vostra conoscenza come si deve, signor Clark. Vi spiegherò senz'altro il motivo per
cui avete attirato la mia attenzione. Ma svelatemi la risposta a un quesito
che mi sono posto all'epoca del nostro primo incontro: qual è la ragione del
vostro interesse per Edgar Poe?»
«Intendo proteggere il suo nome dai parassiti e dai finti amici» risposi,
scrutandolo con sospetto in attesa di una reazione.
«Allora avevamo davvero un obiettivo comune, signor Clark. Quando
abbiamo parlato quel giorno vicino a Saratoga Street, ero giunto da poco a
Baltimora. Vivo in Virginia, sapete. A Richmond, sono un direttore dei
Sons of Temperance. Come forse saprete, quell'estate Edgar Poe era stato a
Richmond e aveva conosciuto alcuni dei nostri membri allo Swan Inn, l'albergo dove alloggiava, tra cui un certo signor Tyler, che l'aveva invitato
per il tè.»
Ripensai al ritaglio di giornale che accennava all'ingresso di Poe nella
lega antialcolica. «Ne facciamo menzione, confidando che i sostenitori della temperanza saranno lieti di apprendere che un gentiluomo con le raffinate capacità e i rari successi del signor Poe ha sposato la causa.» Era accaduto solo un mese e tre giorni prima che si presentasse al Ryan in condizioni pietose.
«Il signor Poe aveva giurato di non bere mai più. Si era accostato alla
scrivania e aveva apposto la sua firma con inconsueta determinazione. Era
l'ultimo iscritto, un iscritto che eravamo fieri di avere tra i nostri "figli".
Alcuni erano scettici. Io no. Ho sentito dire che il comitato di vigilanza aveva constatato la sua onestà dopo averlo seguito di nascosto per qualche
giorno a Richmond. Non molto tempo dopo la partenza del signor Poe verso la fine di quel mese, siamo rimasti esterrefatti dinanzi alla notizia della
sua morte in un ospedale di questa città, e ancor più esterrefatti dinanzi
all'ipotesi secondo cui il decesso era imputabile a una sbornia che aveva
preso dopo essere arrivato qui. Noi della lega antialcolica abbiamo cercato
di appurare i fatti da Richmond, e nulla faceva credere che avesse bevuto.
Ma eravamo troppo lontani per influenzare l'opinione pubblica.
«Giacché avevo soltanto qualche anno meno di Poe e l'avevo incontrato
qualche volta, e dal momento che apprezzavo molto i suoi scritti, il consiglio mi aveva pregato di recarmi qui per investigare sulle circostanze della
sua morte. Sapete, sono nato a Baltimora e ho vissuto qui finché ho compiuto ventun anni, perciò ritenevano che avrei avuto più probabilità degli
altri membri di scoprire che cosa era accaduto. Ero deciso a condurre
un'indagine scrupolosa e a tornare a Richmond con la verità sulla morte di
Poe.»
«Che cosa avete scoperto, signor Benson?»
«Dapprima ho parlato con un medico dell'ospedale in cui Poe si era
spento.»
«John Moran?»
«Già... Moran.» Mi guardò, forse un poco sorpreso di vedermi così informato. «Il dottore ha ammesso di non poter affermare che Poe avesse
bevuto, ma il suo paziente era in uno stato così agitato e delirante che non
poteva neppure asserire il contrario.»
Moran aveva riferito la stessa cosa al barone, il che mi infuse maggiore
fiducia nel resoconto di Benson. «Quando gli avete fatto visita, signor
Benson?»
«Una settimana dopo il trapasso di Poe, forse.»
Iniziai a capire che quel tale, l'ambiguo fantasma di tanti mesi addietro,
era entrato in quel mistero ancor prima di me.
«I giornali» sospirò. «Il modo in cui condannavano Poe. Le calunnie che
stampavano. Le leghe antialcoliche di Baltimora e New York erano ansiose di sfruttare l'accaduto. Forse avete veduto gli articoli. Come se infangare un morto per diffondere un insegnamento fosse un trionfo. Ebbene, signor Clark, credendo che Poe fosse innocente e conoscendo il suo genio,
mi sono sentito davvero...»
«Furibondo» suggerii.
Assentì. «Per abitudine sono un tipo calmo e riservato, ma è vero, ero
fuori di me. Ho sparso la voce che desideravo scoprire i dettagli degli ultimi giorni di Poe per dimostrare che aveva tenuto fede all'impegno preso
con i Sons of Temperance. Un pomeriggio, mentre svolgevo qualche ricerca nella sala di lettura, vi ho udito chiedere al bibliotecario di conservare
tutti gli articoli sulla dipartita di Poe. Ho immaginato che foste fra coloro
che traevano piacere dalla consultazione di quei resoconti velenosi sulla
presunta depravazione e sul presunto peccato del poeta. Ho domandato il
vostro nome al bibliotecario, e altri mi hanno riferito che eravate un avvocato della città, dotato di una mente brillante ma soggetto all'influsso di
persone più decise di voi. E che in passato avevate rappresentato alcuni periodici locali. A quel punto, ho sospettato che foste stato ingaggiato dalla
stampa antialcolica di Baltimora, ansiosa di dipingere Poe come un ubriacone per impartire una lezione morale contro l'alcolismo. Ho ipotizzato
che vi avessero pagato per neutralizzare la mia missione e vanificare gli
sforzi dei Sons of Temperance di Richmond. Così, in un'altra occasione,
allorché vi ho veduto mentre vi stavate dirigendo verso la biblioteca, vi ho
consigliato di non interferire.»
«Credevate che fossi corresponsabile della diffamazione di Poe?» domandai, stupefatto.
«All'epoca, pareva che io fossi l'unico a non esserlo, signor Clark. Sape-
te che effetto fa? Ho provato ad andare nelle redazioni di alcuni quotidiani
locali. Non ne hanno voluto sapere di rettificare le informazioni fuorvianti
che stavano stampando. Ho raccolto una serie di articoli positivi su Poe risalenti agli anni passati, in cui venivano elogiati i suoi scritti, e li ho consegnati ai direttori per cercare di persuaderli che il compianto signor Poe
meritava più rispetto. Allo stesso scopo, ho affidato alcuni di quei ritagli
anche al bibliotecario affinché ve li recapitasse. Credo che comprendessero
il servizio cui avete accennato prima.»
«Volete dire che li avevate scelti a casaccio?» chiesi.
«Suppongo di sì» confermò, non comprendendo il motivo della mia profonda incredulità.
«Non erano destinati a cagionare o provocare alcuna azione particolare?»
«Speravo che le lodi tributate a Poe in un periodo meno assetato di sangue avrebbero prodotto una maggiore considerazione verso il suo valore e
la sua produzione letteraria. Sono rientrato a Richmond di lì a poco. Dopo
essere tornato a Baltimora per qualche tempo come ospite dei miei parenti,
ho avuto occasione di imbattermi nel bibliotecario, che mi ha chiesto con
insistenza un biglietto da visita per poterlo dare a voi, signor Clark.»
«Quando mi avete fermato per la strada, mi avete detto: "Chi interferisce
giacerà là in fondo".»
«Davvero?» Batté le palpebre con aria meditabonda, quindi abbozzò un
sorriso.
«È una citazione tratta da una poesia di Poe, dedicata a Eleonora, una
giovane sospesa tra la vita e la morte che ora giace così bella e gentile.»
«Può darsi» fu l'esasperante commento di Benson.
«Quel monito non aveva un significato preciso? Non era una sorta di
messaggio cifrato? Non vorrete farmi credere, signor Benson, di aver scelto a casaccio anche quello?»
«Siete un uomo di indole assai nervosa, vedo, signor Clark.» Non pareva
intenzionato ad aggiungere altro, invece continuò. «Quando cominciate a
leggere Poe, è difficile, anzi impossibile, impedire alle sue parole di influenzarvi. A lungo andare, l'uomo o la donna che legge Poe con eccessiva
frequenza crede, a mio giudizio, di trovarsi in una delle sue sorprendenti e
sconcertanti creazioni. Quando sono venuto a Baltimora, la mia mente e
ogni mio pensiero erano imbevuti di Poe; riuscivo a leggere soltanto i vocaboli usciti dalla sua penna. Ogni frase che pronunciavo rischiava di essere la sua voce, e non apparteneva più al mio intelletto e al mio linguaggio.
Mi crogiolavo nei suoi sogni e in quella che pensavo essere la sua anima.
Ciò è sufficiente per schiacciare un uomo soggetto all'insidia della sete di
scoperte. L'unica soluzione è smettere definitivamente di leggerlo, come
ho deciso di fare io. L'ho bandito dalla mia memoria, anche se forse non
del tutto.»
«Ma che cosa mi dite della vostra indagine sulla sua morte? Siete stato
tra i primi, o forse il primo, ad avviare un'investigazione. Eravate nella posizione migliore per appurare la verità!»
Scrollò il capo.
«Dovete pur aver appreso qualcos'altro!» esclamai.
Esitò, quindi riprese a parlare come se gli avessi posto un quesito diverso. «Sono un contabile, signor Clark. L'avevo dimenticato per un attimo iniziando a danneggiare i miei interessi economici trattenendomi qui, lontano dal mio lavoro a Richmond. Immaginate, un uomo che tiene i libri
contabili in perfetto ordine sin da quando aveva vent'anni e che trascura
completamente le sue finanze. Anzi, il declino è arrivato a un punto tale
che ora devo lavorare per una parte dell'anno nell'azienda di mio zio qui a
Baltimora, come sto facendo proprio in questo periodo.» Era quello zio,
così somigliante a Benson, a essere raffigurato nel dipinto sopra di noi.
«La vostra città è eccellente sotto molti aspetti, anche se molti cocchieri
bevono liquori quando invece dovrebbero avere il controllo dei cavalli.»
Notando il mio disinteresse verso quell'argomento, si fece più insistente.
«È un pericolo tremendo per la società, signor Clark!»
«C'è ancora molto da fare, Benson» osservai. «Riguardo a Poe, intendo.
Potete esserci d'aiuto...»
«Esserci? Sono coinvolte altre persone?»
Duponte? Il barone? Non ero sicuro della risposta. «Potete essere d'aiuto. Possiamo collaborare, signor Benson; possiamo trovare la verità che
cercavate indagando sulla fine di Poe.»
«Non posso fare altro. E voi, avvocato Clark, non siete già abbastanza
indaffarato?»
«Ho preso un'aspettativa dal mio studio» mormorai.
«Capisco» replicò con l'aria di chi la sa lunga e con una certa soddisfazione nella voce. «Signor Clark, la tentazione più pericolosa della vita è
dimenticare di badare alla propria attività. Bisogna imparare a rispettarsi
abbastanza da curare i propri interessi. Se concentrarvi sulle cause altrui
(anche in campo benefico) vi impedisce di essere felice, non vi resterà alcunché.
«Il popolino desidera vedere Poe come vuole vederlo, martire o peccatore; nessuna delle vostre iniziative lo dissuaderà» proseguì. «Forse non ci
importa di quel che è accaduto a Poe. L'abbiamo immaginato morto per i
nostri scopi. In un certo senso, è ancora vivo. Lo trasformeranno senza tregua. Anche se, in qualche modo, doveste scoprire la verità, si limiterebbero a negarla a favore di un'altra ipotesi. Non possiamo immolarci sull'altare
degli errori di Poe.»
«Non crederete ai membri della lega antialcolica che vi hanno contrastato? Non penserete che Poe abbia cagionato tutto questo per un vizio insignificante?»
«Niente affatto» mi assicurò con un lieve tono di sfida. «Ma se fosse stato più prudente, se avesse usato le sue passioni per pensare alle rivendicazioni del mondo anziché solo a quelle del suo intelletto superiore, forse
tutto ciò non sarebbe dovuto accadere... e il fardello intorno al suo collo
non sarebbe mai divenuto il nostro.»
Dopo quel colloquio avvertii una sorta di sollievo: qualcun altro aveva
tentato di appurare la verità dietro la scomparsa di Poe. L'iniziativa di Benson aveva dimostrato che Peter Stuart e zia Blum avevano torto. Non ero
l'unico a essermi imbarcato in una ricerca folle. Eccone un altro, un contabile.
Il sollievo mi pervase anche da un altro fronte, in relazione al barone e a
Duponte. Per poco non avevo tradito la mia alleanza con Duponte a favore
di un criminale, di un finto imbonitore. Per cosa? Una serie di analogie tra
Claude Dupin e C. Auguste Dupin? Avevo perduto Hattie per sempre, e
non avrei mai trovato nessuno al mondo che mi conoscesse quanto lei. Lo
studio legale che il buon nome di mio padre aveva contribuito a costruire
stava per crollare. La mia amicizia con Peter non esisteva più. Se non altro,
non avevo commesso un terribile errore anche con Duponte. Rincasando,
mi sentii come se mi fossi appena destato da un sonno profondo.
Quanta fiducia, quanta speranza, quanto tempo avevo investito in Duponte e nelle sue somiglianze con i racconti di Poe! Se solo si fosse opposto con maggior vigore alle attività del barone Dupin, se solo mi avesse dato più motivi per pensare che facesse progressi quanto Dupin, se solo non
si fosse limitato a essere un pigro spettatore degli sproloqui del barone... se
solo avesse adottato queste misure, sarei riuscito senza dubbio a scacciare
quelle insidiose elucubrazioni dalla mia mente.
Lo osservai mentre sedeva nel mio salotto. Fissandolo, lo interrogai sulla
sua crescente sottomissione all'aggressività di Claude Dupin. Gli domandai
perché restasse a guardare mentre il nostro rivale riportava la vittoria in
quella competizione. Avevo iniziato a riferire questa conversazione anzitempo in uno dei capitoli precedenti, lo ricorderete. Rammenterete che gli
avevo suggerito di dare un ceffone al barone Dupin, ma aveva obiettato
che non avrebbe giovato alla nostra causa.
«Non importa. Gli ricorderebbe, direi, che non è il solo a giocare questa
partita. Nella fallacia infinita del suo cervello, crede di aver già vinto,
monsieur Duponte!»
«Allora ha maturato una convinzione errata. La situazione è del tutto
opposta. Il barone, temo per lui, ha già perduto. È arrivato alla conclusione, come me.»
Fu allora che i miei timori svanirono. «Che cosa intendete?»
«Poe beveva» rispose Duponte. «Ma non era un ubriacone. Anzi, era l'esatto contrario. Possiamo essere sicuri che, in media, consumava meno alcol di un uomo qualunque.»
«Sì?»
«Non era sregolato, ma era intollerante, per costituzione, agli alcolici, in
un grado estremo mai sperimentato da gran parte delle persone comuni.»
Raddrizzai la schiena. «Come fate a saperlo, monsieur Duponte?»
«Se solo la gente guardasse, anziché vedere e basta. Rammenterete
senz'altro uno dei pochi necrologi scritti da un conoscente, anziché da un
reporter, affermava che, dopo un unico bicchiere di vino, "l'indole di monsieur Poe mutava totalmente". Molti ne avranno dedotto che Poe era alticcio per abitudine, un ubriacone incallito e sconsiderato. In realtà, è vero il
contrario. I detrattori hanno dimostrato troppo da questo punto di vista, e
pertanto non hanno dimostrato alcunché. È probabile (anzi, quasi certo)
che Poe presentasse una rara sensibilità all'alcol, capace di trasformarlo e
paralizzarlo quasi istantaneamente. In uno stato di confusione mentale, e in
compagnia di gente volgare, talvolta alzava il gomito, soprattutto quando
si trovava nel bel mezzo della vostra aggressiva convivialità meridionale,
che impone di non rifiutare simili offerte. Quest'ultimo particolare è tuttavia irrilevante per noi. Era il primo bicchiere, se non addirittura il primo
sorso, a scatenargli un attacco di intolleranza. Non una follia dovuta al
consumo eccessivo di alcolici, bensì una follia temporanea dovuta all'impossibilità di bere quanto i suoi commensali.»
«Dunque, monsieur, ritenete che avesse bevuto il giorno in cui è stato
rinvenuto al Ryan?»
«Forse un bicchiere per debolezza. Non come lo descriverebbero gli
scrittori delle leghe antialcoliche, che giudicano le azioni umane in base alla loro moralità. Vi illustrerò come operano, o meglio come hanno operato
proprio nel periodo che ci interessa.»
Dopo aver rovistato tra una delle sue pile di giornali ordinati secondo
criteri incomprensibili, recuperò una copia del «Sun» del 2 ottobre 1849, il
giorno precedente al ritrovamento di Poe.
«Avete mai sentito il nome John Watchman, monsieur Clark?»
Non conoscevo nessuno che si chiamasse così, risposi di primo acchito.
Poi un vago ricordo prese forma, e mi corressi. Il pomeriggio in cui mi ero
lanciato all'inseguimento del fantasma (il signor Benson dei Sons of Temperance di Richmond), l'avevo cercato in una delle squallide bettole della
città, sotto il livello della strada. «Sì, avevo creduto che quel Watchman
fosse il fantasma perché indossava un cappotto simile al suo. Un altro avventore mi ha informato che Watchman era ubriaco fradicio.»
«Non mi sorprende. Le speranze di monsieur Watchman, i suoi sogni di
gloria, si erano infranti da poco. Ecco qui: un annuncio che forse avrebbe
destato poco interesse da parte vostra due anni or sono, ma che potrebbe
essere molto prezioso ora.»
Mi indicò un articolo. La legge che limitava la vendita di alcolici la domenica era stata un argomento centrale delle elezioni statali del 1849, sebbene, come aveva ipotizzato Duponte, non vi avessi dato molto peso all'epoca. I casi di alcolismo cui avevo assistito erano bastati per indurmi ad
abbracciare la causa antialcolica. Sembrava tuttavia difficile investire tutte
le proprie energie in un unico ideale come la temperanza, a detrimento di
tutti gli altri princìpi morali.
I Friends of the Sunday Law, un'organizzazione che comprendeva i
leader delle più autorevoli leghe antialcoliche di Baltimora, avevano presentato il loro candidato alla Camera dei delegati per sostenere la battaglia
a favore di una legge che arginasse la vendita di liquori nei giorni di festa:
il signor John Watchman. Ma ben presto qualcuno aveva tuttavia veduto
Watchman che beveva in varie taverne della città, e il 2 ottobre i Friends
l'avevano privato del loro supporto. Un elemento assai interessante era il
nome del tale che, nell'articolo, parlava in difesa del loro comitato: il dottor Joseph Snodgrass.
«È accaduto solo un giorno prima che Snodgrass venisse chiamato al
Ryan per assistere Poe!» esclamai.
«Ora comprenderete lo stato d'animo in cui doveva essere Snodgrass.
Essendo il leader di una fazione antialcolica, aveva appena subìto un'umiliazione personale per colpa del suo candidato. Monsieur Watchman si era
mostrato debole, su questo non ci piove. Quasi sicuramente i Friends of the
Sunday Law hanno sospettato, tuttavia, che Watchman fosse stato tentato
di proposito dai loro avversari politici. Ora vi pregherò di dare un'occhiata
anche all'"American and Commercial Advertiser" di una settimana prima
per farvi un'idea più chiara del Ryan nei giorni precedenti l'incontro tra
Snodgrass e Edgar Poe.»
Il primo ritaglio che mi indicò accennava a
[...] un affollato ed entusiastico convegno dei whig appartenenti
alla quarta sezione della città, tenutosi presso l'hotel Ryan.
«Allora il Ryan non era solo un seggio elettorale, ma anche il punto d'incontro dei whig di quella sezione» affermai. «E il luogo destinato a essere
l'ultima dimora di Poe prima del letto d'ospedale» aggiunsi con un sospiro.
Ripensai al gruppo di whig che io e Duponte avevamo osservato nel nascondiglio sopra la Vigilant Fire Company, vicino all'hotel. Quello era il
loro covo segreto, mentre, a quanto pareva, il Ryan era il locale che utilizzavano per le riunioni pubbliche.
«Facciamo un altro passo indietro» proseguì Duponte «fino ad arrivare a
diversi giorni prima, quando è stata annunciata la riunione dei whig della
quarta sezione. Leggete ad alta voce. E notate soprattutto la firma.»
Obbedii.
Un raduno popolare dei whig della quarta sezione si svolgerà
martedì presso l'hotel Ryan, in Lombard Street, di fronte alla rimessa delle autopompe della Vigilant.
Geo. W. Herring, presidente.
Un altro articolo pubblicizzava un convegno fissato per il 1° ottobre, due
giorni prima delle elezioni, alle 19.30, ancora una volta presso l'hotel
Ryan, di fronte alla rimessa delle autopompe, partecipate numerosi. Anche quello era firmato Geo. W. Herring, presidente.
«George Herring, presidente» lessi di nuovo. Ricordai Tindley, il buttafuori corpulento, che rispondeva al suo superiore con fare ossequioso: signor George... signor George. «Il tale con cui abbiamo parlato, il presidente... George era il suo nome di battesimo, non il suo cognome... George
Herring. Dev'essere parente di Henry Herring, lo zio acquisito di Poe,
l'uomo che è corso per primo da Poe, dopo Snodgrass, e che si era rifiutato
di ospitarlo a casa sua.»
«Ormai avrete compreso che la presunta sbornia di Poe è solo una piccola parte di quanto è successo nei suoi ultimi giorni, ma è un particolare importante per mettere tutti gli altri tasselli al giusto posto. È un'informazione
utile ora che conosciamo l'intera sequenza dei fatti.»
«Monsieur Duponte» replicai, posando il giornale «intendete dire che
ora conoscete l'intera sequenza dei fatti? Che siamo pronti ad annunciarla
al mondo prima che il barone Dupin tenga la sua conferenza?»
Alzatosi, si diresse verso la finestra. «Tra non molto» rispose.
Capitolo 21
Considerata la frenesia delle sue recenti attività, era sorprendente che il
barone fosse divenuto così tranquillo. Era scomparso; probabilmente si
stava preparando per la conferenza, prevista di lì a due giorni. A Baltimora
non si parlava d'altro. Feci varie passeggiate tortuose per la città, tentando
di scoprire in quale hotel si fosse trasferito, quando qualcuno mi diede un
colpetto sulla spalla.
Era uno dei tizi che avevo veduto tante volte seguire Claude Dupin. Al
suo fianco vi era un altro uomo con un cappotto quasi identico.
«Che cosa ci fate qui?» domandò il primo, cercando di camuffare il suo
accento. «Chi siete?»
«Perché volete saperlo?» lo rimbeccai. «Potrei farvi la stessa domanda.»
«Non è il momento di essere sfacciato, monsieur.»
Monsieur. Erano francesi, dunque.
«Vi abbiamo veduto nelle ultime settimane. Sembra che siate sempre
fuori del suo albergo» spiegò con aria sospettosa, le sopracciglia che si
muovevano in quel modo tipicamente francese, come facevano talvolta anche quelle di Duponte.
«Sì, ecco, non vi è nulla di strano. Non si fa spesso visita a un amico?»
Un uomo che in passato mi aveva rapito, ingannato e minacciato... e io l'avevo definito un amico!
Intrappolato nel loro silenzio, cominciai a temere le conseguenze della
mia frettolosa dichiarazione. A quanto sembrava, i miei pedinamenti avevano trasformato i nemici del barone in miei nemici. «Non so nulla dei
suoi debiti né dei suoi creditori, e non ho il minimo interesse per simili
questioni» aggiunsi.
Quei due si scambiarono una rapida occhiata.
«Allora diteci in quale hotel alloggia ora.»
«Non lo so» dissi, sincero.
«Avete idea, monsieur, della portata dei suoi guai? Se cercherete di aiutarlo, diventeranno i vostri. Non proteggetelo.»
Mi affrettai a voltarmi e ripresi a camminare.
«Non abbiamo finito con voi, monsieur» mi gridò lo sconosciuto.
Mi guardai sopra la spalla; mi stavano seguendo. Mi domandai se mi avrebbero imitato qualora mi fossi messo a correre. Allungai il passo per
verificarlo.
Attraversando Madison Street, mi avvicinai al monumento a Washington, dove era riunito un gruppetto di turisti. L'imponente colonna marmorea, del diametro di sei metri, si innalzava dal basamento, sostenendo l'enorme statua del generale George Washington sulla sommità. La struttura
risaltava non solo per le sue dimensioni, ma anche per il suo candore che
spiccava sull'ammattonato della strada. In quell'istante mi parve il luogo
più sicuro di Baltimora.
Entrando nel basamento, mi unii ad altre persone in attesa di salire la
scala che si allungava a spirale nello spazio cavo. Dopo essermi arrampicato su per la prima rampa, mi fermai nei pressi di una curva, illuminata soltanto da una piccola apertura quadrata, e osservai alcuni bambini che mi
sfrecciavano accanto. Sorrisi tra me e me, contento che quei farabutti si
fossero arresi o non mi avessero veduto entrare, ma proprio mentre mi
congratulavo con me stesso in silenzio, udii lo scalpiccio di due paia di stivali pesanti.
«Il est là!» urlò una voce.
Senza aspettare che comparissero, mi girai e mi lanciai su per i gradini.
Il mio unico vantaggio era il fatto di conoscere lo spazioso interno del monumento sin da quando ero ragazzo. Forse i francesi erano più forti e veloci, ma erano forestieri. Anzi, suppongo che abbiano fatto un confronto tra
quella scala angusta e la maggiore ampiezza dell'Arco di Trionfo a Parigi.
Entrambi i luoghi offrivano la medesima ricompensa ai visitatori più atletici (una magnifica vista della città dall'alto), ma commemoravano conquiste differenti. L'arco parigino, l'impero di Napoleone. La colonna marmorea, il momento in cui Washington si era dimesso dalla carica di comandante dell'esercito, rifiutando di usare la sua posizione per ottenere il potere permanente di un despota.
Suppongo che nulla di tutto ciò sia venuto in mente ai miei inseguitori,
che sembravano intenzionati a buttarmi giù dalla cima del monumento. Si
muovevano più in fretta persino del gruppo di bambini, che, a metà strada,
si erano stancati di rincorrersi. Alla fine, i due uomini raggiunsero la galleria d'osservazione sulla sommità e percorsero la piattaforma circolare, facendosi largo fra i turisti intenti ad ammirare il Chesapeake in lontananza,
oltre il fiume Patapsco. Pur scrutando i volti sotto la tesa di ogni cappello e
sbirciando tra i vestiti ornati di balze, non videro la loro preda da nessuna
parte.
Io, invece, vedevo loro. Mi ero già nascosto trentasei metri più in basso,
nella porzione inferiore delle scale, vicino al punto in cui uno stretto uscio
senza targa si apriva su una sporgenza utilizzata da coloro che erano incaricati di tenere pulita ogni fessura della costruzione. Era un passaggio usato soltanto da chi sentiva il bisogno di prendere un poco d'aria durante la
salita. Rimasi su quell'aggetto per assicurarmi che entrambi i furfanti comparissero sulla piattaforma della galleria molto più in alto e avere così la
certezza che nessuno dei due fosse in agguato di sotto.
Ora, accorgendosi di essere stati gabbati, si sporsero dal parapetto e mi
avvistarono. Sorrisi e li salutai prima di filare verso la porta.
La mia gioia fu breve. L'uscio non si apriva.
«Santi numi!» Lo presi a calci.
Chissà come, il chiavistello all'interno si era bloccato dopo che ero uscito. Tempestai di pugni la porta massiccia affinché qualcuno la aprisse da
dentro.
Osservando l'accaduto dalla sua posizione vantaggiosa, uno dei francesi
tornò verso le scale, mentre l'altro aspettava, tenendomi d'occhio dal suo
trespolo onniveggente. Se il primo fosse arrivato fino all'uscio, sarei stato
in trappola. Allungai il collo con la fioca speranza che la comitiva di signore anziane sui gradini ne ritardasse la discesa abbastanza a lungo da
permettermi di escogitare un qualche piano miracoloso per la mia liberazione.
Il suo complice faceva la guardia affacciandosi dalla balaustra e tenendomi gli occhi puntati addosso. Dopo un altro vano tentativo di attirare
l'attenzione di qualcuno dall'altra parte dell'uscio, tornai verso la ringhiera
e guardai giù per valutare la possibilità di saltare tra gli alberi. In quell'istante, scorsi un volto familiare più in basso.
«Bonjour!» la chiamai.
La giovane alzò lo sguardo verso di me, e quindi verso il cielo, dove
quella canaglia non mi staccava gli occhi di dosso. «Indietreggiate verso la
porta» mi consigliò.
«È sprangata dall'interno. Dovete aprirmela, mademoiselle!»
«Indietreggiate! Ancora... ancora, monsieur...»
Obbedii, allontanandomi dalla ringhiera. Il tale sopra di me si allungò di
più oltre la balaustra per non perdermi di vista.
Dopo aver tratto un respiro, Bonjour strillò: «Vuole buttarsi!». Indicò
con gesti isterici il francese, che ormai era quasi appeso al parapetto a
un'altezza di cinquantacinque metri. L'uomo sbiancò quando udì le grida
che provenivano dalla galleria. Cercando di aiutarlo, i visitatori gli si accalcarono intorno con tanta foga che per poco non lo spinsero giù. Frattanto, i curiosi che erano corsi su per assistere alla tragedia umana costrinsero
il suo compagno, che era appena riuscito a imboccare la scala, a tornare
sulla piattaforma.
«Ingegnoso, mademoiselle! Ora, se poteste aprire questa porta...»
Bonjour salì i gradini, e di lì a poco udii il chiavistello che scorreva. Felicissimo, spalancai l'uscio per ringraziare la mia salvatrice, forse l'unica
donna che tenesse ancora a me.
Varcò la soglia, la bocca di una piccola rivoltella puntata nella mia direzione. «È ora che veniate con me, monsieur.»
Bonjour non disse altro lungo il tragitto verso l'albergo. Quando arrivammo al Barnum, mi slegò le braccia e le gambe e mi spinse nella hall
senza attirare l'attenzione. Parlò dopo che avemmo raggiunto le loro camere, dove ci aspettava Claude Dupin. «Era con loro, e filavano d'amore e
d'accordo» spiegò al barone. «Li ho separati, ma si sono scambiati dei segnali.»
«Chi?» chiesi, confuso. «Quei due mascalzoni? Non vorrei mai avere
nulla a che fare con individui come quelli.»
«Molto intimo per incontrarsi, quel monumento.»
«Mi stavano pedinando, mademoiselle! Voi mi avete salvato!»
«Non ne avevo alcuna intenzione, monsieur!» mi assicurò. «Magari Duponte tiene al guinzaglio anche loro.»
Il barone pareva agitato. «Lasciaci soli, mia cara.»
Bonjour mi rivolse un'occhiata compassionevole prima di sparire.
Claude Dupin sollevò un bicchiere di sherry ghiacciato. «In questo hotel,
la dose di sherry è decisamente inferiore a quella di ghiaccio. Ma, se non
altro, i letti hanno le tende, un lusso abbastanza raro in America. Non fate
caso a mademoiselle. Crede di dipendere da me perché l'ho salvata, ma, in
realtà, è vero il contrario. Se mai dovesse darmi il benservito, o se mai dovesse capitarle qualcosa, ne sarei distrutto. Non sottovalutate le sue doti.»
Sulla scrivania, avevo notato pile di fogli costellati di scarabocchi.
«Lì» proseguì il barone con un sorriso orgoglioso e maligno, accorgendosi della mia curiosità, «lì sono racchiuse tutte le risposte che cercate, carissimo Quentin, scritte nero su bianco. Naturalmente, non ho ancora completato la mia presentazione, ma la completerò, statene certo. Nel frattempo» e così dicendo si chinò verso di me «temo tuttavia di dovermi assicurare che nessuno mi ostacoli prima che la renda pubblica. Ebbene, chi sono
gli uomini con cui vi ha veduto Bonjour? Perché lavorano con voi e Duponte?»
«Barone Dupin» risposi, esasperato. «Non li conosco, non desidero conoscerli, e di certo non sono legato a loro in alcun modo.»
«Ma li avete veduti, come li ho veduti io» ribatté, altezzoso. «Mi spiano.
Hanno la morte negli occhi. Sono pericolosi. Li avrete senz'altro notati
mentre mi tallonavate anche voi.»
Feci per protestare, ma mi aveva colto alla sprovvista.
«Lo so» continuò, interpretando il mio silenzio come un'ammissione.
«Da quando ho appreso che Bonjour si era imbattuta in voi al molo, mentre le stavate alle costole. Non credo che quello sia il luogo in cui trascorrete il vostro tempo libero, tra ubriaconi e mercanti di schiavi. Ma forse»
scoppiò a ridere «siete ancora in grado di stupirmi, Quentin Clark.»
«Allora perché non mi avete fermato, se lo sapevate?»
Roteò il bicchiere. «Non è ovvio? Non avete imparato nulla dal vostro
padrone? È stata una misura disperata: Duponte sapeva che stava perdendo, perciò ha mandato voi. Ciò mi ha dimostrato che non avevo bisogno di
difendermi da lui. Inoltre, osservare ciò che cercavate di spiare mi ha permesso di capire che cosa gli interessava maggiormente... Spiare significa
sempre essere spiati, monsieur.»
«Se siete onnisciente, barone, immagino che abbiate già scoperto chi sono quei due francesi e chi li manda.»
Tacque, sempre più nervoso. «Sono francesi, dunque?»
«A giudicare dal loro accento e dalle loro parole, sì. Forse li convincerete ad aiutarvi, come avete fatto con il dottor Snodgrass.» Volevo riequilibrare un poco il colloquio, dimostrandogli che anch'io avevo le mie fonti.
«Se servono alcune potenti fazioni che si sono schierate contro di me per
i miei interessi pecuniari a Parigi, temo che non sia così semplice.»
Parlava con quel suo tono franco, come se fossi fermamente schierato
dalla sua parte, il che mi aveva indotto a dimenticare per qualche istante di
non esserlo affatto. Dovette scostarsi dagli occhi alcune ciocche di capelli
unti e sottili.
«Vedete, carissimo Quentin, come un uomo può essere obbligato a vivere dietro una maschera, nella costante impossibilità di essere se stesso. E io
sono assai bravo a essere me stesso, sì, monsieur. Bravissimo! In tribunale,
tutti gli occhi, anche quelli degli avvocati miei rivali, mi guardano cercando la verità. Sono felice là dentro. Non sono pronto ad appendere la toga al
chiodo, non ancora.»
«Eppure insistete nella vostra messinscena da quattro soldi per intimorirci» protestai. «Perché tentate di assomigliare a Auguste Duponte?»
Notai un dipinto di Duponte appoggiato in un angolo. Avendo veduto
l'opera di Van Dantker in varie fasi di produzione, riconobbi quella tela
come sua. Non potei fare a meno di convenire che il quadro finito sembrava completo, come se l'avesse completato lo stesso Duponte. Ne catturava
i lineamenti esatti, ma anche più dei lineamenti.
Il barone rise con fare bonario. «Duponte ha apprezzato la mia ironia,
carissimo Quentin? Una piccola burla all'interno di una faccenda seria, ecco tutto. Duponte non sa che cosa significhi portare una maschera. Crede
di restare aggrappato alla realtà evitando di indossarne una. Invece, senza
maschera, Duponte non è... noi non siamo... nessuno.»
Ripensai al sorriso pungente e singolare che Duponte aveva sfoderato
durante le sedute con Van Dantker e che gli aleggiava sul volto nel ritratto.
Un sorriso che non era davvero suo... Forse, dopo tutto, Duponte sapeva
che cosa significava portare una maschera. Afferrato il quadro, me lo infilai sotto il braccio.
«Questo lo prendo io, barone; non è di vostra proprietà.»
Scrollò le spalle.
«Sapete... dovete sapere... che Duponte risolverà questo mistero. È lui il
vero modello di Dupin» proseguii, forse sperando di produrre una reazione
più forte.
«Credete che gliene importi?»
Inclinai la testa, curioso. Non era la risposta che mi aspettavo.
«Duponte vi ha raccontato come ci siamo conosciuti?» Il barone mi
guardò con espressione grave. «Naturalmente no» aggiunse, scuotendo il
capo con l'aria di chi la sa lunga. «No, vive troppo dentro di sé. Duponte
ha bisogno di sentire che gli altri si interessino ancora a lui, ma trova trop-
po stancante parlare di sé. Eravamo entrambi a Parigi. Vi era una signora
di nome Catherine Gautier, accusata di omicidio, una signora che stava
molto a cuore al vostro amico.»
Rammentai il poliziotto che, al caffè parigino, aveva accennato ai cambiamenti subìti da Duponte quando la donna di cui era innamorato era stata
impiccata per omicidio e lui non era riuscito a impedirlo. «La amava, vero?»
«Questo è niente! La amavo anch'io. Oh, non guardatemi così, come se
fossimo in un romanzo frivolo; non intendevo quello che state pensando.
No, io e Duponte non eravamo in competizione per il suo affetto. Ma era
abbastanza graziosa e sagace da ammaliare qualunque uomo la conoscesse.
Com'è possibile, vi chiederete, che vivessimo in un mondo in cui una donna simile poteva essere accusata di aver ucciso sua sorella a randellate? È
un'idea assurda.»
Catherine Gautier, mi spiegò, era povera, ma virtuosa e nota per la sua
intelligenza. Era l'amica più intima di Duponte e, secondo alcuni, anche
l'unica. Un giorno avevano trovato sua sorella atrocemente ammazzata, e i
sospetti erano ricaduti subito su di lei. Giacché la polizia era nemica di
Duponte da quando quest'ultimo l'aveva messa in imbarazzo risolvendo
crimini che gli agenti non erano riusciti a sbrogliare, molti avevano creduto che le accuse contro Catherine fossero una rivalsa nei confronti dell'analista.
«Era innocente, allora?»
«Abbastanza innocente» fu la curiosa risposta del barone dopo una pausa.
«Dunque la conoscevate?»
«Caro amico, davvero non ve ne ha mai parlato? È vostro socio ormai da
parecchi mesi. Sì, la conoscevo.» Scoppiò a ridere. «Ero il suo avvocato,
caro mio! L'ho difesa contro quell'orribile accusa di omicidio.»
«Voi?» domandai. «Ma è stata giustiziata. Voi non avete mai perduto
una causa.»
«Sì, è vero. Suppongo che quel primato sia stato, per così dire, offuscato
da mademoiselle Gautier.»
Abbassai lo sguardo, riflettendo sul fallimento di Duponte. «Duponte
non è riuscito a liberarla. Ma riconquisterà la sua gloria» affermai, usando
la parola preferita di Claude Dupin. «Ora, con Poe.»
«Non è riuscito a liberarla!» rise il barone. «Non è riuscito a liberarla?»
Il suo scherno mi imbestialì. Sapevo che Duponte aveva cercato di inda-
gare sulla faccenda quando mademoiselle Gautier era stata arrestata, ma,
disperato, si era arreso. Ripetei quella storia al barone.
«Ha cercato di indagare, è questo ciò che vi ha detto? Be', monsieur, il
carissimo Duponte ha indagato sulla faccenda. Non si è mai arreso. È stato
abile come sempre.»
«Abile? Come? Intendete che, dopo tutto, Catherine non è stata giustiziata?»
«Rammento bene la mia prima visita nell'appartamento di Auguste Duponte a Parigi» iniziò a raccontare.
Il barone Dupin aveva trovato da solo un posto per il cappello e il bastone, giacché Duponte non si era offerto di riporglieli. L'avvocato avrebbe
desiderato un'illuminazione migliore, perché considerava la luce un vantaggio quando spiegava, tramite i gesti convulsi delle mani e le espressioni
esagerate del viso, per quale motivo Duponte avrebbe dovuto collaborare
con lui. Naturalmente, non aveva rinunciato a usare le argomentazioni
consuete per persuadere Auguste Duponte, ma le circostanze non sarebbero potute essere più gravi. La sua carriera era a un bivio insidioso. Inoltre,
era in gioco la vita di una donna.
Claude Dupin non era mai andato a trovare Auguste Duponte prima di
allora. Come tutte le persone informate di Parigi, e come tutte quelle che
avevano intenzioni criminose, ne aveva tuttavia sentito parlare. Nel suo lavoro, si era imposto una regola severa: non avrebbe mai accettato il caso di
un delinquente che fosse stato incriminato e arrestato grazie al raziocinio
di Duponte. Il motivo di quella scelta non era il più ovvio, cioè la convinzione automatica che qualunque individuo accusato da Duponte fosse colpevole, ma piuttosto il fatto che la reputazione di Duponte era troppo solida all'epoca. Appena un giudice apprendeva che era stato l'analista a formulare le accuse, sarebbe stato pressoché impossibile ottenere un proscioglimento.
Ora il barone aveva intravisto un'opportunità. Avrebbe potuto usare l'affetto cieco di Duponte verso Catherine Gautier per vincere la sua causa più
importante. Riteneva che ogni causa fosse la più importante, ma quella era
speciale: era una causa che sembrava impossibile a qualsiasi avvocato. Il
che aveva accresciuto la sua determinazione.
«Stiamo preparando una difesa inattaccabile» aveva riferito a Duponte.
«Miriamo a restituire la libertà a mademoiselle» aveva aggiunto con spavalderia. «Il vostro aiuto, monsieur Duponte, sarebbe preziosissimo... anzi,
essenziale. Sareste l'eroe della sua assoluzione.» Il barone non ci credeva
davvero, giacché sapeva che l'eroe sarebbe stato lui.
Duponte sedeva immobile su una poltrona accanto al caminetto spento.
«Il mio aiuto confermerà che deve essere condannata» aveva risposto con
aria quasi assente.
«Non è detto, monsieur Duponte» aveva obiettato Claude Dupin, emozionato. «Stando a quel che si dice, voi vedete cose che gli altri non riescono a vedere. Se gli altri vedono soltanto la sua colpevolezza, voi potete
usare le vostre doti, il vostro genio, per vedere la sua innocenza. La Sacra
Bibbia afferma che siamo tutti colpevoli, monsieur, ma non ne consegue
che siamo anche tutti innocenti?»
«Non sapevo che foste un esperto di religione, monsieur Dupin.»
«"Barone", se non vi dispiace.»
Duponte l'aveva fissato senza battere le palpebre.
Il barone si era schiarito la gola. «Vi propongo una scelta, monsieur, che
il vostro buonsenso non potrà rifiutare. Potete sfruttare il vostro genio per
strappare qualcuno che amate, e che vi ha amato, a un destino dalle tinte
più fosche. Oppure potete restare pigramente seduto nel vostro lussuoso alloggio e lasciarvi morire nella solitudine. È scontato... insomma, anche
uno stolto saprebbe che cosa scegliere. Quale sarà il vostro destino?»
Di solito il barone non era incline a discutere in termini profondi, ma
non per questo ne era incapace. Mademoiselle Gautier si era riabilitata dopo essere stata l'amante di un facoltoso studente parigino che l'aveva lasciata. In simili circostanze, quasi tutte le ragazze sarebbero cadute nella
prostituzione, ma lei era riuscita a evitarlo. Non si poteva tuttavia dire lo
stesso di sua sorella, nonostante le suppliche di Catherine. La rovina di sua
sorella sarebbe stata anche la sua, perché non erano accomunate soltanto
dal cognome, ma anche da una somiglianza tale che conoscenti, negozianti
e poliziotti le confondevano per la strada. Catherine aveva dunque un motivo valido per voler cancellare quell'onta dalla sua identità. Eppure, Claude Dupin aveva raccolto testimonianze secondo cui era assai improbabile
che l'accusata avesse commesso un'azione disonesta, e aveva scoperto i
nomi di molti furfanti che la vittima aveva frequentato esercitando la sua
nuova professione e di cui si sarebbe potuta facilmente dimostrare la colpevolezza con prove secondarie.
«Se investigherò sulla morte della ragazza» aveva dichiarato Duponte, e
il barone si era elettrizzato all'udire quelle parole, «se lo farò, non voglio
che nessun altro sappia del mio coinvolgimento.»
Il barone aveva promesso di non farne menzione con la stampa.
Duponte aveva indagato sulla morte della giovane, come concordato.
Ben presto aveva scoperto senza ombra di dubbio la sequenza dei fatti che
avevano condotto all'assassinio. Secondo le sue conclusioni, l'omicida poteva essere soltanto la sua amante, Catherine Gautier. Aveva riferito quelle
informazioni al prefetto, esibendo un testimone che la polizia non aveva
individuato e distruggendo tutte le possibilità del barone di vincere con altri mezzi. Quella svolta aveva gettato Claude Dupin in una disperazione
ancora più profonda. Era troppo orgoglioso per accettare la sconfitta con
eleganza. Aveva speso molti favori (e molte migliaia di franchi, che erano
andate ad accrescere un debito già ingente) per manipolare la causa. Ma
non era servito a nulla. Le prove di Duponte erano troppo convincenti per
essere contestate. Le finanze e la reputazione del barone erano ormai rovinate.
Frattanto, l'ispettore Delacourt, ansioso di fare carriera nella prefettura,
aveva assicurato a Duponte e Catherine che, date le nuove prove (secondo
cui la giovane era pazza e sconvolta ma per nulla diabolica), e dato il sesso
dell'imputata, la sentenza sarebbe stata clemente. Eppure, Catherine era
stata impiccata di lì a qualche mese, dinanzi a Dupin e Duponte oltre che a
tre quarti di Parigi.
«Innanzi tutto» commentai «Duponte ha sofferto più di voi per via di
questa faccenda. Non ha perduto solo la capacità di sfruttare il suo genio,
ma anche l'unica donna che amava... e ha fatto tutto con le sue stesse mani!
Ora non vendicherete il vostro disonore tormentando Duponte. Non potete
usare la morte di Poe a questo scopo. Non starò a guardare!»
«Ricordate l'elegante assioma legale super subjectum materiam: nessuno
può essere considerato professionalmente responsabile di opinioni fondate
su fatti riferitigli da altri» mi rimbeccò il barone, torreggiando sopra la mia
sedia. «Non sono stato io a cominciare, monsieur, bensì voi. Siete stato voi
a esortarmi a investigare sul declino di Poe. Vi siete dato la zappa sui piedi, ve ne rendete conto? Su col morale, carissimo Quentin! Mi avete aiutato a capire che potevo riscattarmi. Detrattori e diffamatori calpestavano il
mio nome perché l'ombra del mio genio era divenuta troppo grande e si era
rifiutata di conformarsi alla loro piccola vita, perciò gli occhi puntati su di
me tramutano ogni peccatuccio in peccato mortale pur di fermarmi... Be',
come con il nostro caro Poe.»
«Volete davvero paragonarvi a Poe?» chiesi con palese sbigottimento.
«Non ne ho bisogno, giacché l'ha già fatto lui. Perché credete che abbia
scelto il personaggio di Dupin come il suo eroe più acuto? Aveva scorto
nel genio dell'analista la propria capacità divina di penetrare misteri che gli
dei e gli uomini non sarebbero mai riusciti a sondare. E con quale ricompensa? È il prefetto della polizia, non l'eroe Dupin, a ricevere gli elogi di
tutti. Mentre altri scrittori che non erano bravi neppure la metà di Poe guadagnavano soldi a palate grazie alle riviste, Edgar ha lottato ancora una
volta per superare le avversità, ha lottato fino all'ultimo, fintantoché è stato
separato... dall'esistenza.»
«Pensate davvero, monsieur, di essere un modello plausibile per Dupin?»
«Voi lo pensavate, prima di avere la sventura di trovare Duponte e lasciarvi sedurre da doti che costui utilizza soltanto per i propri interessi.
Duponte è un anarchico. Da quando lo conoscete non avete mai dubitato
che... forse...» Strascicò le parole. «Forse saprete che esiste un'altra ragione per cui vi ho permesso di spiarci, amico mio. Affinché constataste di
persona, carissimo Quentin, di esservi lasciato sfuggire qualcosa a Parigi,
alle fortificazioni, quando avete preferito lui a me.»
Mi domandai se sapesse... se avesse incaricato qualcuno di pedinarmi
quando, nel cuore della notte, mi ero recato in quello che credevo essere il
suo hotel. Quel nero affrancato che avevo intravisto sotto il lampione?
«Duponte è il vero Dupin. Voi non reggete il confronto» ribattei. Non potevo concedergli la vittoria mentale di sapere quanto ero andato vicino a
perdere la fiducia in Duponte solo qualche giorno addietro. Penso tuttavia
che la mia espressione fosse trasparente.
«Be'» riprese, abbozzando un sorriso «solo Edgar A. Poe potrebbe rivelarci chi è l'autentico Dupin, ma è morto. Come si fa a risolvere un enigma
quando la soluzione è irraggiungibile? Il vero Dupin è chiunque convinca
il mondo di essere tale; sarà lui a vincere.»
Capitolo 22
Mi ritrovai per la prima volta ad avere paura di Duponte. A chiedermi se
le sue doti, lasciate libere e senza freni, potessero avere effetti disastrosi,
come era accaduto con mademoiselle Gautier. Non potei fare a meno di
rammentare il finale dello Scarabeo d'oro, la caccia al tesoro descritta da
Poe in un avvincente racconto. La conclusione trionfante - in cuor mio, ne
ero sempre stato convinto - indicava che Legrand, quel geniale pensatore,
era sul punto di ammazzare il suo servitore e il suo amico dopo che questi
ultimi avevano portato a termine la loro missione. Le ultime sinistre parole
del racconto («Chi può dirlo?») mi riecheggiavano nella testa.
Ripensai a una bizzarra serata durante il mio soggiorno a Parigi. Avevo
seguito Auguste Duponte fino a un quartiere che madame Fouché aveva
definito poco raccomandabile durante la notte. «Le vostre grida» mi aveva
avvertito «non richiameranno la polizia, che spesso è in combutta con i
malviventi.» La mia attenzione, ricordo, era stata attirata da un oggetto che
pareva muoversi da solo nella vetrina di un negozio. Vi era un cerchio di
mascelle finte che rappresentavano ogni possibile condizione della bocca
umana: una coppia con gengive di un rosso vivace e denti di un immacolato bianco latte, un'altra con gengive marce e vizze, e via discorrendo. Ciascuna ruotava, aprendosi e chiudendosi a diverse velocità grazie a un congegno meccanico invisibile. Sopra le mascelle vi erano teste di cera rotanti
che mostravano prima un volto sdentato e scavato, e poi un altro che sfoggiava una bocca sana e impeccabile dai denti scintillanti, probabilmente
aggiustata da un dentista nello studio dietro la vetrina.
Prima di allontanarmi da quella scena ipnotica, avevo avvertito una pressione sulle orecchie. Ogni cosa si era tinta di nero. Qualcuno mi aveva calcato il cappello sugli occhi per accecarmi, e avevo sentito delle mani che
mi frugavano nel cappotto da dietro. Chiamando aiuto, ero riuscito a sollevare un poco la cupola del copricapo. Avevo veduto una vecchietta dagli
abiti cenciosi e dai denti guasti. Dopo aver cercato di derubarmi, era indietreggiata e ora si limitava a tenere gli occhi puntati davanti a sé. Avevo seguito il suo sguardo fino a Duponte, che era in piedi a pochi metri di distanza. Dopo che era corsa via, mi ero voltato con riconoscenza verso di
lui. Che cosa l'aveva spaventata tanto? Se l'analista lo sapeva, non me l'aveva mai rivelato.
Ora ritenevo che quella sventurata doveva averlo riconosciuto. La donna, in passato, poteva essere dotata di un'intraprendenza criminale cui Duponte doveva aver messo i bastoni tra le ruote - magari, un tempo, aveva
fatto parte di un grande complotto omicida (si mormorava infatti che, all'apice del suo successo, Duponte avesse mandato a monte più di un piano finalizzato a uccidere il presidente francese) - e, a causa del suo acume di
tanto tempo prima, ora era ridotta a una disperazione animale. Non era stata la paura fisica di Duponte a mettere in fuga la ladra. Avrebbe potuto
conficcarmi un coltello nel cuore dieci volte prima che lui la fermasse
(sempre ammesso che fosse quella la sua intenzione). Non era stata la pau-
ra della sua forza o della sua agilità. Era stata la paura spontanea e impulsiva del suo semplice intelletto, la paura del suo genio.
Dopo aver lasciato l'hotel del barone, trovai Duponte seduto accanto
all'enorme finestra del salotto di Glen Eliza, impegnato a fissare la porta
con intensità. Cominciai a riferirgli tutto quanto era accaduto al Barnum.
«Prendete questo» mi interruppe, porgendomi una piccola sacca di pelle.
«Portatelo all'indirizzo segnato qui.» Mi allungò un foglietto.
«Monsieur, non mi avete ascoltato? Il barone Dupin...»
«Dovete uscire subito, monsieur Clark» insistette. «È giunto il momento.»
Abbassai lo sguardo sull'indirizzo e non lo riconobbi. «Benissimo... Che
cosa devo dire una volta arrivato?»
«Lo capirete da solo.»
Ero così assorto nei miei pensieri da non avvedermi che era tre volte più
buio di quanto sarebbe dovuto essere a quell'ora. Quando cominciò a piovere, ero già troppo lontano da casa per tornare a prendere l'ombrello. Gli
scrosci si intensificarono lungo il tragitto finché l'acqua mi lambì le caviglie. Continuai ad arrancare, la tesa del cappello inclinata il più possibile
per ripararmi il viso.
Pur avendo percorso un tratto di strada in omnibus, quando giunsi a destinazione ero completamente fradicio. L'indirizzo corrispondeva a un ufficetto dove un uomo spediva telegrammi da dietro una scrivania. «Signore?» mi chiese.
Non sapendo che cosa dire, mi limitai a domandargli se fosse il luogo
che cercavo.
«Di sotto» rispose, asciutto.
Scesi i gradini fino all'insegna successiva, che grondava acqua. Era un
negozio di abbigliamento. Perfetto! Era quella la missione urgente? Ritirare un cappotto di Duponte che aveva bisogno di un rammendo? Entrai, sopraffatto dalla stizza.
«Ah, siete venuto nel posto giusto.»
Era un uomo con una pancia prominente strizzata in un vivace gilet di
raso.
«Io? Ci conosciamo, signore?»
«No, signore.»
«Allora come fate a sapere che sono nel posto giusto?»
«Guardatevi!» Allargò le braccia con fare teatrale, come se fossi il figliol prodigo appena tornato. «Bagnato fino al midollo. Vi buscherete un
brutto raffreddore. Ora, ho proprio l'abito adatto.» Rovistò dietro il bancone. «Avete trovato il posto giusto per scambiare i vostri vestiti.»
«Vi sbagliate. Ho una cosa da darvi.»
«Davvero? Non aspetto niente» replicò con avidità.
Posai il sacchetto su una sedia e lo aprii, estraendone soltanto un giornale ripiegato, una copia del «Sun» di Baltimora. Le gocce di pioggia chiazzarono la pagina cadendomi dai capelli e dalla fronte.
Me lo strappò di mano mentre il suo volto cordiale si inaspriva. «Per
Giove! Credo di potermi comprare un giornale, giovanotto. Questo non è
neppure di quest'anno. È forse uno scherzo? Che cosa dovrei farmene, vorrei sapere?» Mi fulminò con un'occhiata di rimprovero. Ero stato declassato da «signore» a «giovanotto». «Se non intendete acquistare nulla da me
questa sera...» Agitò la mano.
Alla parola «acquistare» accennò alle insegne sulla parete per indicare la
sua. «Boutique di abiti e accessori eleganti. Camicie, colletti, canottiere e
mutandoni, calzini, calzetteria e fazzoletti da collo - Uguali in tutto e per
tutto ai migliori capi su misura.»
«Un attimo! Perdonatemi, signore» mi affrettai a scusarmi. «Mi piacerebbe molto fare quello scambio di vestiti, dopo tutto.»
Si illuminò. «Eccellente, eccellente, una scelta saggia. Vi procureremo
un abito di ottima qualità e fattura.»
«È questo che fate, signore? Scambiare vestiti?»
«All'occorrenza, certo. È un servizio indispensabile per i gentiluomini
appiedati come voi, caro signore. Sono così tanti quelli che dimenticano
l'ombrello persino in autunno e hanno un solo completo nel baule. Soprattutto i forestieri. Siete un turista, immagino?»
Feci un gesto vago. Cominciavo a capire meglio il lavoro di quel tale, e
quello di Duponte...
Il negoziante mi portò una manciata di indumenti. Che razza di abiti!
Ribadì che erano di ottima qualità sebbene fossero assai trasandati e non
fossero affatto della mia misura. Il cappotto e il suo colletto di velluto grigiastro si abbinavano quasi a una gamba dei pantaloni (quella meno scolorita), e nessuno dei due si intonava al panciotto. Erano tutti troppo piccoli
di diverse taglie, ma l'uomo assunse un'espressione di profondo orgoglio
mentre mi definiva molto «elegante» e sollevava uno specchio affinché potessi gloriarmi della mia immagine.
«Ecco, caldo e asciutto! Davvero uno scambio equo, per voi» osservò.
«E ora questo» aggiunse, raccogliendo il mio bastone. «È uno degli esem-
plari più belli che abbia mai veduto. Pesante, tuttavia, per un pellegrino
come voi. Un fardello. Intendete separarvene? Ve lo posso pagare bene, e i
miei prezzi sono i più vantaggiosi del quartiere.»
Prima di uscire, per poco non scordai il giornale che Duponte mi aveva
dato. Guardai la data in cima al foglio. 4 ottobre 1849. Il giorno successivo
a quello in cui avevano rinvenuto Poe al Ryan con indosso vestiti troppo
grandi. Diedi una scorsa alle pagine, soffermandomi sulle previsioni meteorologiche del giorno prima. Il giorno, insomma, in cui avevano trovato
Poe. «Freddo, rigido e nebbioso.» «Umido e piovoso.» «Raffiche di vento
violente e costanti dal nord-est.»
Proprio come quella sera. Quando ero entrato nella biblioteca, Duponte
mi aspettava accanto alla finestra, non fissando il vuoto con espressione
assente, come avevo creduto, bensì scrutando il cielo e le nuvole. Aveva
atteso una giornata corrispondente alla descrizione di quel fatidico 3 ottobre per mandarmi fin laggiù.
«Prendo tutto, signore» dissi con cortesia, recuperando la canna di Malacca. «Mi dispiace, ma da questa non mi separerò mai.» Prima di andarmene, estrassi alcune monete da cinque centesimi e le barattai con un ombrello appoggiato accanto al tavolo.
Fuori, scoprii che i miei passi erano incerti a causa dei pantaloni stretti
intorno alle gambe. Sostai sotto la tenda per aprire l'ombrello.
«Stasera piove a catinelle.»
Trasalii, spaventato dalla voce roca. Tra la cortina di pioggia scura, faticai a distinguere la sagoma di un uomo.
Strizzai gli occhi quando si girò verso di me. Un'altra figura si materializzò lì accanto.
«Cercavate di nascondervi da noi, vero, monsieur Clark?»
I due delinquenti francesi.
«Vestiti come questi» intervenne l'altro, abbassando lo sguardo sui miei
abiti striminziti, «non serviranno a camuffarvi.»
«Signori... monsieurs... non so come chiamarvi. Non li indosso per nascondermi da voi. Non so perché seguitiate a infastidirmi.»
Non era il momento adatto, lo so. Ma i miei occhi, che, chissà perché, si
sentivano liberi dalle preoccupazioni del mio cervello, furono attirati inspiegabilmente da un volantino sul lampione, che svolazzava tra le folate
di vento. Non riuscivo a leggerlo, ma l'istinto mi suggeriva, suppongo, che
conteneva qualcosa di assai interessante.
«Guardateci in faccia quando vi parliamo!»
Lo sconosciuto mi assestò un ceffone. Non fu troppo forte, ma l'estrema
fulmineità di quel gesto mi lasciò di stucco.
«Non è possibile proteggere a lungo un condannato a morte. Abbiamo
ricevuto degli ordini.»
Il suo complice tirò fuori una pistola dal cappotto. «Adesso sì che siete
nei guai. Un amico andrebbe scelto con maggiore accuratezza.»
«Amico? Non è vero!»
«Allora la sua sgualdrina vi ha aiutato per puro sollazzo nel monumento
a Washington?» ribatté il farabutto.
«Lo giuro! Non è mio amico!» urlai, la voce che mi tremava alla vista
dell'arma.
«No... non più.»
Capitolo 23
«Signore! Signore! Avete scordato...»
Il negoziante mi aveva rincorso con il sacchetto che avevo dimenticato
dentro. Si arrestò quando vide l'atteggiamento minaccioso dei due mascalzoni. Uno di loro mi aveva cinto un braccio con il suo.
L'uomo gesticolò con rabbia all'indirizzo della canaglia. «Che cosa sta
succedendo? Lasciate stare quel signore!»
Quando avanzò di un passo, l'altro aggressore si voltò e gli assestò un
ceffone più forte di un pugno, facendolo ruzzolare con violenza oltre la
tenda.
Cadendo a terra, il malcapitato emise un gemito acuto, quasi felino.
Sfruttando quel diversivo, mi divincolai, gettandomi l'ombrello alle spalle
e scagliandomi attraverso uno scroscio di pioggia che sembrava un muro
di mattoni contro il mio corpo. I due assalitori si lanciarono all'inseguimento.
Svoltai nella prima via, sperando che l'oscurità mi nascondesse. Ma i
due sconosciuti coprirono la distanza quasi subito. Girando la testa per
guardarli, incespicai in una buca. Anche se riuscii a mantenere l'equilibrio,
ormai erano pericolosamente vicini, e uno dei due mi sfiorava il cappotto
con la mano. Non osai voltarmi ancora.
Dinanzi a noi, una mandria di maiali divorava la spazzatura di quella sera. Il nostro arrivo li disturbò, inducendoli a sparpagliarsi. Un fulmine
squarciò il cielo, illuminandoci tutti. Ansimante, mi ritrovai ad aspirare l'aria con avidità. Mi stavano alle calcagna, e senza dubbio mi avrebbero rag-
giunto di lì a qualche metro. Udendo alcuni rintocchi di campane in lontananza, notai la strada in cui stavamo per sbucare. Mi venne un'idea. Dopo
aver fatto un rapido dietro-front, corsi verso i miei inseguitori. Procedevano così spediti che impiegarono un momento per fermarsi sul terreno scivoloso.
Sapevo che, in Europa, le rotaie ferroviarie iniziavano in periferia, e in
vita mia avevo conosciuto molti turisti stranieri sorpresi che i nostri treni
partissero dal pieno centro della città, prima trainati da una pariglia dei cavalli più robusti e poi attaccati a una locomotiva. Allorché i furfanti si precipitarono di nuovo verso di me, li guidai accanto al cartello: FATE ATTENZIONE ALLA LOCOMOTIVA. Perplessi, obbedirono, guardando in
tutte le direzioni.
Filavo a più non posso. Finalmente rallentai, scrutando la via alle mie
spalle. Nessuno. Persino la pioggia era diminuita. Mi arrestai. Ero al sicuro.
Poi ricomparvero, fianco a fianco, come diavoli usciti dall'inferno.
Proprio quando mi sentii pervadere da una terribile disperazione, un'altra
figura si materializzò dinanzi a me. Allorché si avvicinò, riconobbi con
sgomento l'uomo di colore che avevo veduto con il barone e che mi aveva
pedinato durante le mie passeggiate. Poiché Newman mi aveva assicurato
che Claude Dupin non aveva altri neri al suo servizio, ero giunto alla conclusione che quel tale potesse essere un complice dei due francesi. Ed eccolo che veniva nella mia direzione.
Non potevo andare da nessuna parte: ero braccato dai tre uomini. Decidendo che avrei avuto maggiori possibilità contro un solo avversario, mi
tuffai verso di lui. Quando cercai di oltrepassarlo, mi tirò afferrandomi per
un braccio.
«Da questa parte!» gridò, vincendo la mia resistenza.
Gli consentii di condurmi in una viuzza più buia e angusta; ormai avanzavamo l'uno accanto all'altro. Mi posò la mano sulla schiena, incitandomi
a proseguire.
Gli altri due ci stavano ancora addosso. All'improvviso il mio compagno
cominciò a zigzagare lungo il vicolo.
«Fate come me!» mi urlò.
Comprendendo le sue intenzioni, lo imitai. Tra la pioggia e l'oscurità, i
due farabutti non sarebbero riusciti a distinguerci.
Poi il nero schizzò via, e uno dei manigoldi lo rincorse dopo un attimo di
esitazione e confusione. L'altro seguitò a tallonarmi con rinnovato vigore.
Perlomeno, il numero di mani pronte a strangolarmi da un momento all'altro si era dimezzato. Non ebbi neppure il tempo di domandarmi come mai
il nero che avevo considerato un nemico mi avesse aiutato contro quegli
assassini.
Avevo guadagnato un poco di vantaggio, ma dovevo agire in fretta. Girandomi, vidi il mascalzone che si arrestava per sollevare una pistola. Lo
sparo esplose come un tuono. Il proiettile mi trapassò il cappello, che volò
via. La collera nei suoi occhi e i suoi grugniti intensi e furibondi mi spaventarono più della rivoltella. La canna di Malacca, bagnata, mi scivolò
più volte tra le dita e per poco non mi cadde, ma non la lasciai.
Quando l'acquazzone si fu placato, il terreno divenne fangoso. Scivolai e
slittai lungo le strade, braccato dal furfante solitario. Tentai di chiamare aiuto, ma le parole mi morirono in gola e, sebbene il suolo accidentato ostacolasse entrambi, se mi fossi fermato avrei corso un rischio maggiore. Inoltre, con quei vestiti fradici e sgualciti e il capo scoperto, sembravo un
mendicante pazzo, l'incubo degli abitanti di Baltimora. Questa volta, nessuno sarebbe venuto in mio soccorso. Cercando un riparo nel quartiere
commerciale della città, intravidi la porta di un grande deposito, spalancata
dal vento. Rifugiatomi all'interno, scorsi una scala.
Sbucando al piano superiore, urtai una ruota appena verniciata, che mi
arrivava quasi al collo. Capii dove mi trovavo.
Ero circondato da assi, ruote, calessi e corregge: ero finito nella fabbrica
di carrozze Curlett in Holliday Street. Al pianterreno, vi era un locale in
cui gli ultimi modelli venivano esposti per la vendita. Come le fabbriche di
pianoforti a qualche isolato di distanza, quell'edificio incarnava una nuova
idea: costruire, conservare e vendere, tutto nel medesimo luogo.
«È arrivata la vostra ora, eroe» disse una voce, in francese. Il furfante
comparve sulla soglia. Il suo respiro affannoso e sibilante si tramutò in
sogghigno, e mi guardò con ferocia. «Non avete via di scampo. A meno
che non vogliate saltare dalla finestra.»
«Non voglio nulla del genere. Desidero parlare da persone civili. Non
intendo impedirvi di riscuotere i vostri debiti dal barone.»
Si avvicinò, e io indietreggiai. Mi fissò con espressione interrogativa. «È
questo che credete, monsieur?» Scoppiò in una risata sinistra. «Pensate che
siamo qui solo per sollecitare un debitore in arretrato di qualche migliaio
di franchi?» domandò, offeso. «Vi è molto di più. È in gioco la pace futura
della Francia.»
Il barone Dupin? Un avvocato in disgrazia? Capace di influenzare l'avvenire della Francia?
La mia faccia tradì il mio profondo sbalordimento, e lo sconosciuto mi
guardò con impazienza rabbiosa.
Con un gesto fulmineo, agguantai l'enorme ruota accanto a me, spingendola con tutte le forze che mi rimanevano. Allungò la mano e lo stivale per
bloccarla, al che l'oggetto cadde su un fianco, inerte e innocuo.
Mi addentrai di più nella stanza, pur sapendo che aveva ragione: non avevo via di scampo. Anche se non fossi stato esausto e gocciolante, il deposito sarebbe stato solo un gigantesco spazio disseminato di pezzi di carrozze. Tentai di superare con un balzo il telaio di un calesse, ma lo stivale
mi si impigliò nella struttura, e ruzzolai tra il riecheggiare di una risata
malvagia.
Precipitando, non ero atterrato sul pavimento. Molto peggio. Ero rimasto
aggrovigliato in una fune che, sulla parte posteriore del veicolo, teneva insieme i componenti non ancora assemblati. Tirando e scalciando, mi ritrovai con il collo intrappolato in uno stretto cappio. Tenendo il bastone con
una mano, ne usai la punta per aggrapparmi alla carrozza, cercando disperatamente di sciogliere l'intrico di nodi intorno alla mia gola. Ma la corda
si stringeva di più a ogni mio movimento.
I passi lenti del francese si approssimarono. Entrò nella vettura, che non
aveva ancora il tetto. Torreggiando sopra di me con un sorriso, sferrò un
calcio rapido e sicuro alla canna di Malacca. Benché ne impugnassi ancora
un'estremità, l'altra, quella che avevo utilizzato per attaccarmi al calesse, si
spostò, e cominciai a penzolare. Ogni volta che tentavo di afferrare il retro
del veicolo con la mano o con il bastone, il manigoldo era ben contento di
darmi un calcio più forte. Sentendomi soffocare da quell'orribile stretta,
appoggiai il gancio della canna nel punto più largo tra la corda e il mio
collo, agitando le gambe allo stesso tempo. Nulla valse tuttavia a ridurre i
pochi centimetri fra i miei piedi e il pavimento.
Morire impiccato a una carrozza! Riuscivo quasi a condividere il sorriso
spettrale dell'assassino dinanzi alla mia sorte.
Mentre dondolavo in quel modo, agguantai il bastone con entrambe le
mani in una specie di preghiera mesta e disperata. Lo strinsi al punto che,
in seguito, i pori del legno mi avrebbero lasciato una striscia bianca sui
palmi umidi. A un tratto, chiudendo gli occhi, mi meravigliai di sentire che
la canna cedeva, come se le mie dita avessero la forza di quattro uomini.
La parte centrale si staccò. Come intuii ben presto, l'oggetto si componeva
di due segmenti separati, uniti nel mezzo. Nella cavità, intravidi lo scintillio di un acciaio luccicante.
L'intera metà superiore, scoprii tirando con più energia, era una guaina,
che scivolò via immediatamente. Nascosta lì sotto vi era una spada. Una
spada che, sfoderata, era lunga sessanta, anzi, settantacinque centimetri.
«Poe» sussurrai con quello che sarebbe potuto essere il mio ultimo respiro.
Tagliai la fune senza indugio, gettandomi verso il lato posteriore del veicolo, cui mi attaccai con la mano libera.
La prima cosa che vidi alzando lo sguardo fu il francese appollaiato in
cima alla vettura, intento a sbirciarmi con curiosità. Stupito per la comparsa dell'arma, aveva lasciato che la pistola gli penzolasse sul fianco. Con
uno strillo assordante, mi sollevai la lama sopra la testa, colpendolo al
braccio. Quindi, con gli occhi chiusi, la ritrassi e vibrai un altro fendente.
L'uomo lanciò un urlo acuto.
Caddi per terra, supino. Il mio stivale era rotolato sul fondo della carrozza. Il furfante, pallido e fuori di sé, impegnato a gridare per la ferita, sgranò gli occhi allorché spinsi forte con le gambe. Il veicolo rotolò attraverso
il locale e gli piombò addosso come una lapide massiccia, una delle ruote
che scivolava fuori del suo asse. Un pezzo del veicolo tranciò uno dei tubi
poco distanti, producendo un'esplosione di vapore che sibilò tra il caos.
Rialzatomi, rinfoderai la spada. L'intensa euforia del trionfo non bastò
tuttavia per sostenermi o condurmi fino a casa; il dolore alla gamba si unì
alla stanchezza, impedendomi di allontanarmi per più di tre metri dall'edificio prima di accasciarmi al suolo. Appoggiai tutto il mio peso sul bastone
che mi aveva salvato la vita, temendo che l'altro farabutto mi trovasse in
quella condizione di debolezza.
Qualcuno bussò alla porta del deposito, che avevo chiuso solo qualche
attimo prima, e udii un gemito agghiacciante.
«Clark!» Tra la nebbia dello stordimento, sentii qualcuno che gridava il
mio nome. Pareva che la voce giungesse da lontano, ma sapevo che era vicina.
Forse dipese dalla paura tremenda, dal tremito del mio corpo o dalla
spossatezza che mi assalì; forse dipese da una combinazione di tutti e tre i
fattori. Allorché una mano mi toccò, mi arresi quasi con tranquillità, avvertendo un violento colpo alla tempia.
Capitolo 24
I suoni di una conversazione informale si fondevano in un ronzio distante. Poi la scena divenne più nitida: i presenti bevevano vino e birra, e l'odore del tabacco masticato mi colmava le narici di un tanfo acre. Cercando di
raddrizzarmi, sentii un peso intorno al collo. La stanza pareva identica alla
taverna del Ryan nel pomeriggio in cui vi si era recato Poe. Ripensando
agli sguardi ostili dei whig della quarta sezione di fronte all'hotel, mi rizzai
a sedere nonostante un attacco di vertigini.
Quando un gruppetto di avventori passò accanto ad alcune candele, notai
che erano tutti di colore. In effetti, la bettola era gremita di neri (uomini e
alcune giovani donne dai vestiti sgargianti), e ora mi resi conto che le vetrine erano disposte diversamente da quelle del Ryan. La disinvoltura con
cui i sessi si mescolavano mi rammentò più Parigi che Baltimora. Intorno
alle spalle, immobilizzate come se indossassi una sorta di camicia di forza,
avevo una pila di coperte calde e pesanti.
«Signor Clark. Mi sembra che stiate meglio.»
Voltandomi, vidi l'estraneo che aveva distratto uno dei due francesi durante l'inseguimento.
«Chi sei?»
«Mi chiamo Edwin Hawkins.»
Mi pulsavano le tempie. «È stato uno di loro a colpirmi?» domandai, tastandomi quel lato della testa.
«No, nessuno vi ha colpito, anche se probabilmente avete avuto
quell'impressione. Fuggendo dalla fabbrica, siete stramazzato al suolo dopo aver percorso pochi metri. Avete sbattuto il capo sul marciapiede prima
che riuscissi ad agguantarvi. Vi ho portato qui affinché non vi trovassero.
Quello che mi ha rincorso si è arreso dopo che siamo passati sotto un lampione e si è accorto di aver seguito l'uomo sbagliato, ma scommetto che vi
sta ancora cercando.»
«Ho ucciso il tale nel deposito?» chiesi, ricordando gli eventi con orrore
raggelante.
«È uscito a cercarvi, ma è caduto anche lui. Aveva un gran brutto taglio.
Ho mandato a chiamare un medico. Non vorrete essere accusato di omicidio?»
Mi guardai intorno con circospezione. La taverna era situata sul retro di
una drogheria nera. Era il genere di locale che, in zone della città vecchia
come Liberty Alley, la stampa accusava sovente di incoraggiare condotte
dissolute e di esercitare una cattiva influenza sui ceti più poveri. Due neri
dalla pelle chiara confabulavano in un angolo, e di tanto in tanto uno lanciava occhiate nella mia direzione. Mi girai dall'altra parte, senza domandarmi quando avessi veduto sguardi più sospettosi. Non ero l'unico bianco,
giacché diversi bianchi delle classi più umili dividevano i tavoli con i braccianti di colore, ma era evidente che mi ero cacciato in un guaio.
«Siete al sicuro, signor Clark» riprese Edwin con straordinaria pacatezza. «Vi farà bene stare all'asciutto per un poco.»
«Perché hai rischiato la vita per me? Non mi conosci neppure.»
«Avete ragione, signor Clark. Ma non l'ho fatto per voi. L'ho fatto per
qualcuno che conoscevo» rispose. «L'ho fatto per Edgar Poe.»
Studiai i bei tratti spigolosi del viso dinanzi a me. Forse Edwin aveva
superato la quarantina da qualche anno, e aveva abbastanza rughe da sembrare più vecchio, ma negli occhi gli brillava una luce più giovane, o almeno più irrequieta. «Conoscevi Edgar Poe?»
«Prima che mi liberassero, sì.»
«Eri uno schiavo?»
«Sì.» Mi scrutò, annuendo con espressione meditabonda. «Lo schiavo
del signor Poe.»
Più di vent'anni addietro, Edwin Hawkins era stato il domestico di un
parente di Maria Clemm. La signora Clemm, detta Muddy, era la zia di
Edgar Poe, e in seguito, quando lo scrittore aveva sposato sua figlia Sissy,
ne era divenuta anche la suocera. Alla morte del padrone di Edwin, la proprietà dello schiavo era passata a Muddy, che allora risiedeva a Baltimora.
Più o meno nello stesso periodo, Edgar Poe si era dimesso dal grado di
sergente maggiore dell'esercito a Fort Monroe, in Virginia, poiché ormai,
dopo aver completato il poemetto epico Al Aaraaf in caserma, era intenzionato a diventare poeta. La lotta per ottenere il congedo era stata lunga e
frustrante, perché lo scrittore aveva avuto bisogno del consenso di due
fronti, entrambi severi: John Allan, il suo tutore, e i suoi superiori. Dopo
aver finalmente raggiunto il suo scopo, aveva vissuto per qualche tempo a
Baltimora con zia Muddy e la sua famiglia allargata. Eddie, come lo chiamavano quasi tutti all'epoca, si era arruolato come Edgar A. Perry (il giovane schiavo l'aveva udito raccomandare a Muddy di prestare attenzione
alla corrispondenza indirizzata a quel nome), giacché, inizialmente, aveva
sperato di troncare qualsiasi rapporto con il signor Allan, che si era rifiuta-
to di assecondare il suo desiderio di pubblicare dei versi.
Ora, pur essendosi liberato dalle imposizioni del signor Allan e del servizio militare, Edgar non aveva denaro né aiuto per fare strada nel mondo.
Muddy, che allora era una quarantenne alta e affettuosa, l'aveva accolto
come un figlio. Edwin aveva avuto l'impressione che Eddie fosse il tipo da
apprezzare esclusivamente la compagnia delle donne. Gravata dalle malattie che avevano colpito alcuni dei suoi congiunti, Muddy aveva chiesto al
nipote di prendere lo schiavo appena ereditato e di fungere da intermediario per la sua vendita. Di lì a poco, Poe aveva preso accordi per cedere
Edwin alla famiglia di Henry Ridgeway (una famiglia nera) al prezzo di
quaranta dollari.
Quelle condizioni mi stupirono. Per uno schiavo giovane e forte, Edgar
avrebbe potuto chiedere cinque o seicento dollari, forse anche di più.
«La nostra assemblea legislativa cerca di intralciare l'affrancamento tramutandolo in una procedura costosa, cosicché non sembri che gli schiavi
interferiscano con l'economia nazionale. Il signor Poe e sua zia non avevano molto denaro. Ma non esiste una legge che impedisca a una famiglia
nera libera di acquistare uno schiavo, e non esiste una legge che stabilisca
un prezzo minimo di vendita. Vendere uno schiavo a un nero libero per
una cifra modesta, magari equivalente all'onorario dell'avvocato, era un altro modo per emanciparlo... per emancipare me, come ha fatto il signor
Poe con quell'accordo. Significava anche che sarei potuto rimanere a Baltimora, non una città perfetta, ma pur sempre casa mia. Tra la mia gente, vi
sono uomini che sono proprietari delle loro mogli e dei loro figli, per la
stessa ragione» spiegò Edwin.
«Poe non ha scritto granché sulla questione della schiavitù» commentai.
«Non era uno scrittore favorevole alla causa abolizionista.» Anzi, avevo
sempre avuto l'impressione che, giudicando qualsiasi causa automaticamente ipocrita, non ne avesse mai sposata alcuna. «Eppure ha compiuto
questo gesto per te, rinunciando a centinaia di dollari, in un momento in
cui era indigente e del tutto privo di appoggi.»
«L'importante non è ciò che un uomo scrive. Soprattutto un uomo che
scrive per guadagnarsi da vivere, come stava cominciando a fare Poe.
L'importante è ciò che un uomo fa per rivelare quello che è. Avevo solo
vent'anni, come il signor Poe, soltanto che lui aveva qualche mese in più di
me. Qualunque cosa pensasse della schiavitù, non ne ha parlato nel breve
periodo della nostra frequentazione. A essere sincero, non ha parlato
nemmeno di altre cose. Era un uomo con pochi conoscenti, e i pochi che
aveva non erano amici. Ha scorto qualcosa di se stesso in me, e ha deciso
che, se avesse potuto, mi avrebbe liberato» replicò Edwin.
«Non l'ho più riveduto, ma non dimenticherò mai ciò che ha fatto. Gli ho
voluto bene e gliene voglio ancora, anche se abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto solo per poco. Dopo essere stato affrancato, ho cominciato a lavorare per le redazioni di vari quotidiani locali. Ora aiuto a incartare i giornali da consegnare in diversi quartieri della città. È stato in una di quelle redazioni, poco dopo la morte di Poe, che vi ho udito lamentarvi con i direttori perché la stampa l'aveva calunniato e la sua tomba non era neppure
stata contrassegnata. Fino ad allora non sapevo dove fosse sepolto. Quel
giorno, dopo il lavoro, ci sono andato e ho lasciato un segno nel luogo che
avevate descritto.»
«Il fiore? Sei stato tu a lasciarlo?»
Annuì. «Ricordo che Eddie era sempre vestito di tutto punto e talvolta
portava un fiore bianco all'occhiello.»
«Ma dove sei fuggito dopo averlo depositato?»
«Quello non è un cimitero per negri, sapete, e avrei destato dei sospetti
gironzolando lì la sera. Mentre ero inginocchiato sulla tomba, ho sentito
una carrozza che si avvicinava rapidamente e mi sono affrettato a uscire.»
«Era Peter Stuart, il mio socio, che voleva scoprire dove fossi finito.»
«Poi, ogni giorno, mentre preparavo i quotidiani per la consegna, ho
scorto altri articoli poco lusinghieri sulla persona di Poe. Giacché i Ridgeway mi hanno insegnato a leggere anni or sono mediante il sillabario Webster, riuscivo a decifrare tutte quelle cattiverie. I vivi amano dimostrare di
essere migliori dei morti, mi sembra. Dopo parecchio tempo, un altro tale,
un forestiero, ha iniziato a battere le redazioni, cianciando di Poe. Sosteneva di volergli rendere giustizia, ma a me pareva che volesse solo suscitare
un volgare scandalo.»
«Quello è il barone Dupin» affermai.
«Ho parlato con lui più di una volta, pregandolo di rispettare la memoria
di Poe. Ma mi ricordava un proverbio: can che abbaia non morde. Si è limitato a liquidarmi o a cercare di convincermi che avrei potuto guadagnare
un bel po' di quattrini aiutandolo.» Rammentai il giorno in cui avevo veduto Claude Dupin con Edwin sottobraccio e avevo pensato che stessero tramando qualcosa.
«È stato più o meno in quel periodo che vi ho riveduto, signor Clark. Ho
scorto voi e il barone, come lo chiamate, che litigavate per Poe. Ho deciso
di informarmi sul vostro conto e vi ho seguito. Vi ho veduto accompagnare
il giovane schiavo alla stazione e tener testa a quel negriero, Hope Slatter.»
«Conosci Slatter?»
«È stato lui a vendermi al mio secondo padrone. All'epoca, non biasimavo Slatter in particolare, giacché ero solo un ragazzo, e quella era la vita
che conoscevo. Faceva il suo lavoro. Ma una volta, anni dopo, sono tornato al suo recinto per chiedergli chi fossero i miei genitori... perché li aveva
venduti e ci aveva separati sebbene avesse promesso a tutti i proprietari
che non avrebbe mai diviso le famiglie. Slatter era l'unico che potesse rivelarmi quei nomi, ma si è rifiutato di rispondermi e mi ha cacciato via con il
suo bastone. Da allora non riesco mai ad alzare gli occhi quando lo vedo
per la strada con i suoi omnibus sferraglianti, impegnato a portare i neri alle navi. È strano, ma nella mia mente lo associo sempre a Poe. Non conoscevo bene nessuno dei due, immagino, ma so che uno mi ha messo in catene e che l'altro mi ha liberato.
«Vi ho veduto mentre vi opponevate a Slatter. Ho avuto la sensazione
che aveste bisogno di aiuto, così, quando mi sono imbattuto in voi questa
sera durante il temporale, vi ho pedinato di nuovo.»
«Probabilmente mi hai salvato la vita, Edwin.»
«Parlatemi di quegli uomini.»
«Furfanti di prima categoria. Il barone deve ingenti somme di denaro a
potenti organizzazioni parigine. Ecco perché indaga sul mistero di Poe...
per soldi.»
«E voi che cosa c'entrate, signor Clark?»
«Io non ho nulla a che fare con i tizi che volevano mandarmi al Creatore.
Qualunque idea abbia preso forma nella loro mente è errata. Hanno preso
lucciole per lanterne.»
«Che cosa c'entrate in tutto questo, intendevo. Dite che questo barone
indaga sul mistero di Poe per arricchirsi indebitamente. Benissimo. Voi
perché lo fate?»
Ripensai alle reazioni passate, agli sguardi delusi degli amici perduti, a
Peter Stuart e Hattie Blum, ed esitai a rispondere. Non sembrava tuttavia
che Edwin volesse giudicarmi. La sua schiettezza mi aveva messo a mio
agio. «Suppongo che i miei motivi non siano molto diversi da quelli che ti
hanno spinto ad aiutarmi questa sera. Poe mi ha liberato dall'idea che l'esistenza dovesse seguire un percorso prestabilito. Incarnava l'ideale americano... un'indipendenza che si sottraeva a ogni controllo, anche quando una
forma di controllo gli avrebbe giovato. In qualche modo, la verità su Poe è
una faccenda assai personale per me, e assai importante.»
«Allora, sbrigatevi, signore. Può darsi che abbiate ancora molto da fare
per questa buona causa.» Rivolse un cenno al cameriere, che mi servì una
tazza di tè fumante. Non credo di aver mai assaggiato qualcosa di altrettanto delizioso.
Capitolo 25
Il mio rientro a casa fu più tranquillo di quanto potreste pensare dopo
una serata come quella. Mi sentii pervadere dal sollievo. Avevo lasciato i
miei due inseguitori in un quartiere lontano di Baltimora. A procurarmi
quella nuova sensazione era tuttavia qualcos'altro, qualcosa che andava
persino oltre la generosità di Edwin.
Era stata una giornata lunga. Bonjour mi aveva condotto nella stanza del
barone Dupin, avevo udito il doloroso segreto del passato di Auguste Duponte, gli abiti e la canna di Malacca mi avevano fornito, riguardo a Poe,
indizi di cui la mia mente stava ancora elaborando il significato generale.
Era accaduto anche qualcos'altro. Mentre camminavo per le vie, sotto una
pioggia che ormai era soltanto un'acquerugiola intermittente, scorsi di
nuovo il volantino... un volantino giallo stampato in nero che pendeva dai
tabelloni e dai pali dei lampioni di tutta la città. Alcuni galleggiavano nelle
pozzanghere lasciate dal temporale. Un mendicante ne studiava uno sotto il
chiarore fioco di un lume a gas, le mani affondate nelle tasche del completo cencioso.
Lo raggiunsi, sfiorando il foglietto per assicurarmi che fosse reale. Notando che il vagabondo tremava, mi tolsi il soprabito, che l'uomo si avvolse intorno alle spalle con un cenno riconoscente.
«Che cosa dice?» domandò, levandosi il cappello storto e dalla cupola
ammaccata. Capii che non sapeva leggere. «Qualcosa di straordinario» risposi, e lessi ad alta voce con un'intensità che avrebbe eguagliato una delle
allocuzioni di Claude Dupin.
Che impressione dovevo fare! Con il vestito lacero, fradicio, scompagnato e striminzito, senza cappotto, a capo scoperto, con i capelli scompigliati nel mezzo e con le membra esauste che si appoggiavano alla canna di
Malacca, preziosa ma malridotta. Il mio riflesso nello specchio dell'ingresso di Glen Eliza sembrava appartenere a un altro mondo. Salendo le scale,
sorrisi a quell'idea.
«Poe non era stato derubato» annunciai a Duponte ancor prima di salu-
tarlo. «Ora capisco che cosa intendevate. Il suo bastone da passeggio, simile al mio, aveva una spada nascosta all'interno. Secondo la stampa, Edgar
aveva "giocherellato" con la canna di Malacca del dottor Carter a Richmond. Ciò significa che sapeva dell'arma. Se gli avessero rubato gli abiti, o l'avessero aggredito, avrebbe tentato di usarla.»
Assentì. Volevo mostrargli un'altra cosa.
«E gli indumenti. I suoi indumenti, Duponte, sarebbero stati zuppi di
pioggia. In tutta la città, vi sono negozianti che sarebbero stati disposti a
barattare il suo completo con un altro.»
«I vestiti sono una merce unica» convenne. «Sono uno dei pochi beni
che possono essere allo stesso tempo preziosi e privi di valore. Un abito
bagnato non ha alcun valore per chi lo indossa; ma l'esperienza ci insegna
che prima o poi si asciugherà, e allora sarà prezioso quanto un abito analogo e asciutto agli occhi del negoziante, per cui acquisterà valore solo al
momento della vendita.»
Sul tavolo, vi era una pila dei volantini gialli che avevo veduto fuori. Ne
presi uno.
«Siete pronto» affermai. «Siete pronto! Quando li avete fatti stampare,
monsieur?»
«Prima abbiamo altro da fare» rispose. «Domattina.»
Rilessi il foglietto. Duponte comunicava che avrebbe tenuto una conferenza per rivelare le circostanze della morte di Edgar A. Poe.
L'ispiratore del celeberrimo personaggio di Dupin, l'illustre analista di Parigi che ha acciuffato lo scellerato assassino di monsieur Lafarge - la vittima di un clamoroso avvelenamento - pronuncerà un discorso spiegando tutto quanto è capitato a Edgar A.
Poe il 3 ottobre 1849 nella città di Baltimora. Tutte le prove sono
state raccolte mediante l'osservazione e la riflessione personale.
Ingresso gratuito.
Il mattino successivo, il giorno della conferenza di Duponte, uscii prima
che il mio ospite si destasse per distribuire altri volantini. Li affissi su pali,
vetrine e cancelli. Avevo mandato a chiamare Edwin, che, dopo aver saputo di Duponte, accettò di aiutarmi a diffondere i foglietti in vari quartieri
della città durante la consegna dei giornali. Li porgevo ai passanti, osservandone l'espressione interessata mentre leggevano.
Quando una mano si allungò per prenderne uno, alzai lo sguardo verso
la faccia severa dinanzi a me. Afferrò il pezzo di carta.
Henry Herring mi guardò da sopra il foglio, strizzando gli occhi. «Signor Clark. Che cosa significa tutto questo?»
«Ora il mistero del decesso di vostro nipote verrà svelato» spiegai.
«Se devo essere sincero, mi considero a malapena suo parente.»
«Allora non avete nulla di cui preoccuparvi» lo rimbeccai, strappandogli
il volantino. «Tuttavia, vi consideravate suo parente quanto bastava per assistere al suo funerale.»
Serrò le labbra. «Voi non lo conoscevate.»
«Chi? Poe?»
«Sì» borbottò. «Sapevate che, quando abitava qui a Baltimora, prima di
sposare Virginia, Eddie aveva corteggiato mia figlia? Sapevate della sua
condotta riprovevole? Le aveva scritto delle poesie, una dopo l'altra, per
dichiararle il suo amore» raccontò, disgustato. «Alla mia Elizabeth!»
Ma ormai mi ero distratto. Pieno di euforia per gli eventi di quella giornata, avevo immaginato la faccia che avrebbe fatto il barone leggendo il
foglietto, ammettendo che i due furfanti francesi non l'avessero ancora catturato. Henry Herring aggiunse che trovava disgustoso dissotterrare le malefatte di un defunto da una tomba disonorevole.
Fissai il ramo di un albero che ondeggiava al vento. Guardandomi intorno, notai un tripudio di volantini gialli a ogni angolo, constatazione che mi
gettò nel panico.
Se il barone avesse saputo della conferenza, non avrebbe, come minimo,
affidato a Bonjour e a tutti i bricconi che fosse riuscito a ingaggiare il
compito di strappare i manifesti di Duponte o coprirli con i suoi? Dal suo
punto di vista, sarebbe stato equo, tuttavia nemmeno uno era stato toccato.
Claude Dupin l'avrebbe consentito? Si sarebbe arreso con tanta facilità? A
meno che...
«Il barone!» esclamai.
«Dove diavolo state andando?» mi gridò Herring mentre mi mettevo a
correre.
«Monsieur? Monsieur Duponte!»
Lo chiamai mentre stringevo ancora il chiavistello del portone. Attraversai l'ingresso a tutta velocità, salendo le scale e facendo irruzione in biblioteca. Non c'era. Intuii che era capitato qualcosa.
No, non Duponte.
Udii i passi leggeri di Daphne, che camminava lungo il corridoio con
un'altra domestica. Dopo averla raggiunta, le domandai dove fosse Duponte.
Scrollò il capo. Pareva spaventata, o forse soltanto confusa. «I suoi amici l'hanno portato via, signor Clark.»
No, no, pensai, le parole che mi opprimevano il petto.
Un giovanotto aveva bussato all'uscio annunciando che vi era un visitatore per il signor Duponte; ma, aveva precisato, era zoppo, perciò Duponte
sarebbe dovuto andare fino al cancello, dove lo aspettava la carrozza. Sarebbe stato meglio che l'ospite venisse alla porta, come accadeva di consueto, aveva replicato Daphne. Ma il cocchiere aveva insistito. La cameriera
aveva avvisato Duponte, che, dopo averci riflettuto su per un poco, era uscito.
«E poi?» la incalzai.
Daphne sembrava essersi addolcita nei confronti di Duponte, giacché
aveva gli occhi lucidi e se li asciugò prima di continuare. «Un tale sedeva
nella vettura come un re... Non credo fosse zoppo, perché si è alzato e ha
preso il signor Duponte per il braccio. E... signore...»
«Sì?»
«Era identico al signor Duponte! Come se fossero gemelli, parola d'onore» giurò. «Il vostro ospite è montato in carrozza, ma con un velo di tristezza sul viso. Come se sapesse di aver abbandonato qualcosa per sempre.
Avrei tanto voluto che foste qui, signor Clark!»
Ero stato un idiota, un imbecille. Claude Dupin non aveva eliminato i
volantini della conferenza perché avrebbe eliminato direttamente il conferenziere.
Non vi era traccia del barone negli alberghi che cominciai a perlustrare
di persona dopo essermi recato dalla polizia per denunciare la scomparsa
di Auguste Duponte e consegnare il ritratto ufficiale di Van Dantker che
avevo preso nella camera di Claude Dupin. Consegnai anche un mio schizzo frettoloso del barone e dei suoi complici, tra cui i vari cocchieri, facchini e messaggeri che avevo veduto con lui di volta in volta. Più tardi, ricevetti una convocazione alla centrale.
Lo stesso ispettore White con cui avevo parlato all'epoca della morte di
Poe mi attendeva alla sua scrivania, le mani giunte dinanzi a sé.
«L'avete trovato? Avete trovato Duponte?»
«O Dupin?» chiese. «I ritratti che ci avete fornito ci saranno utili, signor
Clark. Ma abbiamo interrogato i receptionist degli hotel, e tutti affermano
che Duponte non è Duponte, bensì Dupin. Non notate le somiglianze persino tra il vostro schizzo e il quadro?»
Faticavo a reprimere l'agitazione. «Il motivo per cui si assomigliano è
che il barone Dupin ha cercato appositamente di assumere le fattezze di
monsieur Duponte con un travestimento, e l'artista, Van Dantker... l'ha aiutato!»
Si schiarì la voce, separando le mani.
«Duponte fingeva di essere Dupin?»
«Che cosa? No, no. L'esatto contrario, ispettore White. Dupin vuole dimostrare di essere il vero ispiratore del personaggio di Poe...»
«Di nuovo Poe! Orbene, che cosa c'entra con questa faccenda?»
«C'entra eccome! Vedete, Auguste Duponte è il modello per il personaggio di C. Auguste Dupin; ecco perché è venuto a Baltimora. Per risolvere il mistero del decesso di Poe. Ha lavorato all'indagine alloggiando a
casa mia; ecco perché non l'ha veduto quasi nessuno. Per giunta, preferisce
uscire la sera... come anche il francese di Poe. Nel frattempo, il barone ha
sostenuto di essere lui il modello di Dupin, imitando contemporaneamente
Duponte.»
Levò una mano per interrompermi. «Date per scontato che Duponte sia
Dupin.»
«Sì! Ebbene, è assai più complicato di così, vero? Il barone Dupin sta
cercando di trasformarsi in C. Auguste Dupin. Ora l'essenziale è semplicemente trovare l'uomo di cui vuole sbarazzarsi.»
«Forse, se posso permettermi, avete soltanto veduto questo tale, Dupin, e
l'avete scambiato per qualcun altro.»
«Scambiato per...» ripetei, cogliendo l'allusione. «Non ho immaginato
l'esistenza di Auguste Duponte, signore. Non ho immaginato qualcuno che
vive, mangia e si rade in casa mia!»
Scrollò il capo, abbassando gli occhi sul pavimento.
Continuai in tono cupo e grave. «Dupin è colui che tira le fila di questa
faccenda. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi! È pericoloso, ispettore White!
Ha rapito un genio raro e forse ha già attentato alla sua incolumità. Diffonderà una versione falsa degli accadimenti riguardanti la morte di Poe. Tutto questo non vi preoccupa?»
Evidentemente no, e per il momento non vi era altro da fare se non proseguire la mia ricerca con ostinazione.
Mi domando che cosa sarebbe potuto succedere se, all'epoca, fossi stato
più consapevole della cattiveria umana. Se fossi riuscito a intuire quei piani segreti e ripugnanti, se avessi capito di dover stare vicino a Duponte in
ogni istante, magari di doverlo addirittura accompagnare di persona fino
alla sala delle conferenze. Nonostante tutte le sue doti, non avrebbe potuto
fare alcunché se Claude Dupin e Bonjour avessero tentato di ucciderlo, e lo
immaginai mentre li seguiva senza opporre la benché minima resistenza,
come mi aveva riferito la mia cameriera. Quali conseguenze avrebbe avuto
il suo discorso di quella sera sull'eredità di Poe? Ma un simile quesito è pura speculazione.
L'ora fissata per la conferenza si avvicinava. Percorrendo la strada con
aria afflitta, giacché volevo rimuginare nel posto adatto, mi meravigliai di
scorgere la folla accalcata all'ingresso del salone. Sfiorando il braccio di
uno degli uomini in coda, gli chiesi il motivo di tanta ressa.
«Gli organizzatori non hanno annullato la conferenza di questa sera?»
«Neanche per sogno!»
«Questa è la conferenza in programma, allora? Quella sulla vera morte
di Poe?»
«Certo!» confermò. «Credevate forse che Emerson fosse arrivato in città?»
«Duponte» mormorai. «Che sia fuggito? Che si sia presentato?»
«Ma» continuò lo sconosciuto «c'è stata una variazione. Ora devono far
pagare il biglietto.»
«Impossibile!»
Annuì, rassegnato. «Non importa. È il "Dupin" originale, sapete. Vale la
pena spendere un dollaro e mezzo.»
Lo fissai. Mi mostrò con orgoglio una copia dei racconti di Poe. «Sarà
un grande evento» osservò.
Raggiungendo l'inizio della coda, mi feci largo fino all'interno, superando il buttafuori che pretendeva di vedere il mio biglietto.
Lì, dietro il palco, sedeva la figura eretta di Auguste Duponte, che aspettava in solitaria contemplazione. Lo guardai con trionfo, reverenza e rinnovata fiducia.
«Come...?» Mi approssimai.
«Benvenuto» mi salutò, lanciandomi un'occhiata equivoca, per poi guardarsi intorno come se attendesse qualcosa di più importante. «Sono lieto,
carissimo Quentin, di sapere che sarete un testimone della storia.»
Non era Duponte.
Per quanto la sua imitazione fosse stata convincente in passato, ora la
terribile metamorfosi era completa. Persino gli occhi avevano qualcosa
dell'ardore di Duponte.
«Barone! Non permetterò che tutto questo accada, statene certo.» Agitai
la canna di Malacca.
«E che cosa farete?» Mi guardò senza scomporsi. «Voi e Duponte mi
avete fatto un favore, sapete. Ho già raccolto le quote di sottoscrizione per
la conferenza che terrò fra qualche giorno, e intascherò anche quelle di oggi.»
Una volta che la mia mente ebbe metabolizzato le circostanze, mi stupii
di non vedere traccia di Bonjour. Che Claude Dupin avesse rinunciato alla
sua protezione? Supposi che qualcuno dovesse sorvegliare Duponte, a meno che non l'avessero... No, nemmeno il barone ne sarebbe stato capace.
Non un uomo disarmato.
«Vi rivelerò la verità, la verità nuda e cruda, carissimo Quentin. Prima di
oggi, ci sono stati istanti in cui ho pensato che il divertimento fosse finito.
Che Duponte fosse troppo intelligente per me. La vostra espressione mi dice che stentate a crederci. Sì, di tanto in tanto ho pensato che, in un modo
o nell'altro, avrebbe vinto. Ha perduto la sua ultima occasione, e ora tanto
vale che si distenda e muoia.»
«Dov'è?» chiesi. «Che cosa gli avete fatto?»
Sfoderò un ghigno diabolico. «Che cosa intendete?»
«Vi metterò la polizia alle costole! Non la passerete liscia!» Decisi di
provare a strappargli qualche informazione, e anche di fiaccare la sua baldanza. «Sapete, ovunque l'abbiate portato, e in qualunque condizione lo
teniate, Duponte troverà una via d'uscita. Vi si scaglierà addosso come una
furia. Vi fermerà all'ultimo momento; sarà lui a vincere.»
Scoppiò in una risata sommessa, ma una contrazione del labbro rivelò la
sua insicurezza. «Monsieur Clark, sapete quanti ostacoli ho superato per
arrivare a questa giornata? La polizia di Baltimora non mi crea alcun problema. Oggi bisogna porre fine a tutto questo. A meno che non mi fermiate, giacché ormai siete l'unico in grado di farlo... no, ma chiaramente non
lo farete. Non vivrò più nella clandestinità, né all'ombra dei miei nemici o
di Auguste Duponte. Vi sono occasioni in cui il genio, anche quello di Duponte, deve inchinarsi dinanzi all'astuzia. Questa giornata sarà il mio nuovo passaporto per la gloria.»
Claude Dupin seguì il direttore della sala conferenze sulla piattaforma e
fino al podio. Mi guardai intorno, disperato, cercando di pensare al da farsi, ma mi ritrovai in un'impasse mentale. Alla fine, mi feci strada fino alla
pedana e tentai almeno di trascinare il barone giù dal palco. Poi vidi il pubblico (anzi, diciamo pure la folla urlante, la distesa infinita e informe dei
loro occhi) e compresi perché Claude Dupin non aveva bisogno di Bonjour
al suo fianco. Era al sicuro tra la gente. Stava per riacquistare la sua legittimità agli occhi del mondo.
In fondo al locale, un tizio era intento a riparare una lampada, che oscillava in maniera fastidiosa, confondendo ancora di più i miei sensi nella sala buia. Potei soltanto chiedere a gran voce che la conferenza venisse interrotta, suscitando una serie di gemiti stizziti.
Avevo perduto la capacità di esprimermi, di formulare ragionamenti logici. Gridai qualcosa riguardo alla giustizia. Tirai e sferrai calci, ricevendo
in cambio alcuni spintoni. A un certo punto, tra la nebbia dei ricordi, rammento di aver scorto il viso di Tindley, il buttafuori dei whig, che spiccava
fra la calca. Un ombrellino rosso vorticò al limite del mio campo visivo.
Intravidi dei volti: Henry Herring e Peter Stuart, che sgomitavano tra gli
ascoltatori impazienti per raggiungere la prima fila. Vi erano anche il vecchio bibliotecario, rannicchiato sulla sua sedia, e i direttori dei giornali più
importanti. A un tratto, fra il chiarore vacillante, lo vidi: il sorriso, lo strano sorriso malizioso e affilato come un rasoio che Duponte aveva sfoderato per Van Dantker, ora riprodotto fedelmente sulla faccia del barone. Poi
vi fu il rumore, l'unico rumore che avrebbe potuto soverchiare le veementi
proteste provocate dal mio strepito. Assomigliava a una cannonata. La
prima mandò in frantumi le luci del palco, sprofondando il salone nell'oscurità. Poi ve ne fu un'altra.
Udendo gli spari, trasalii fra il mare di urla e strilli femminili. Mi sentii
attraversare da un brivido improvviso e, obbedendo a un istinto macabro,
mi posai la mano sul petto. Dopodiché, ricordo solo immagini frammentarie: il barone Dupin sopra di me, ed entrambi che ruzzolavamo in un groviglio insanguinato, rovesciando il podio... la sua camicia con una grossa
macchia ovale, il cui bordo scuro e appiccicoso aveva il colore della morte... lui che si lamentava, aggrappandosi con furia e veemenza al mio colletto... un orribile peso sopra il mio corpo.
Poi, noi due che precipitavamo nell'oblio.
Libro quinto
Il diluvio
Mi sento come qualcuno
che percorre da solo
una sala dei banchetti deserta
Thomas Moore
Capitolo 26
Non nutrii alcun sospetto allorché l'ispettore White si offrì di accompagnarmi dalla sala delle conferenze a Glen Eliza con la sua carrozza. Rifletteteci. Conoscevo meglio di chiunque altro la complessa situazione che si
era appena verificata. Pur non avendo una fiducia illimitata nelle capacità
dei poliziotti di Baltimora, credevo che, con il mio aiuto, avrebbero trovato
Duponte... e che il francese avrebbe scoperto la verità di cui loro non riuscivano a venire a capo.
White entrò nel mio salotto con il suo assistente e altri agenti che non
avevo mai veduto. Presi a rivelargli tutte le informazioni di cui ero in possesso, dall'arrivo del barone Dupin a Baltimora alla violenta scena di cui
ero appena stato testimone. Udendo i suoi interventi, cominciai tuttavia a
domandarmi con quanta attenzione mi stesse ascoltando.
«Dupin sta morendo» seguitava a ripetere, accentuando ogni volta una
parola diversa. «Dupin sta morendo.»
«Sì» gli spiegai di nuovo «per mano dei due farabutti che ieri mi hanno
inseguito per la città, pensando che intendessi ostacolare la loro meschina
vendetta contro il barone.»
«E poi ne avete veduto uno che gli sparava nella sala delle conferenze?»
chiese l'ispettore, appollaiato sul bordo di una poltrona. L'assistente rimase
per tutto il tempo in piedi dietro di me, senza aprire bocca. Non mi è mai
piaciuto sentirmi osservato, e continuavo a voltarmi con il malcelato desiderio che mi facesse almeno la cortesia di sedersi.
«No» risposi «non ho veduto nulla dal palco, con il bagliore delle luci
che si accendevano e si spegnevano, e tutta quella folla. Qualche viso... Ma
è ovvio, dev'essere stata opera loro.»
«I due farabutti cui avete accennato... nomi?»
«Non li conosco. Ieri uno di loro mi ha quasi ammazzato. La pallottola
mi ha trapassato il cappello. Sarà senz'altro rimasto ferito, perché sono riuscito a procurargli un taglio. Non so come si chiamino.»
«Ditemi ciò che sapete, signor Clark.» Aveva un tono distante.
«Che erano francesi, è sicuro. Il barone Dupin era indebitato fino al col-
lo. Un creditore parigino non rinuncerà mai a minacce e solleciti, neppure
a Baltimora.» Non sapevo se quella regola valesse per tutti i creditori parigini, ma, date le circostanze, ritenni opportuno tramutarla in un assioma.
L'ispettore si limitò a fare un cenno con la testa, come si farebbe con un
bambino farneticante.
«Claude Dupin andava fermato... per il bene di Poe» osservò.
Quella piega della conversazione mi meravigliò parecchio. «Esatto»
confermai.
«Qualche ora fa avete asserito che andava fermato "a tutti i costi".»
«Sì, ispettore.» Esitai prima di riprendere. «Sì, vedete, intendevo dire
che...»
«Senza dubbio è conciato male, quel Dupin» commentò l'assistente alle
mie spalle. «Conciato per le feste.»
«Conciato per le feste, signore?» domandai.
«Signor Clark» proseguì White «volevate impedire il suo discorso nella
sala delle conferenze. Me l'avete confessato alla centrale, quando siete venuto a cercare il vostro amico francese.»
«Già...»
«Il ritratto che ci avete fornito, firmato da un certo Van Dantker, era del
barone. Lo raffigura fin nei minimi particolari. Perché avete commissionato quel quadro?»
«No, non è lo stesso uomo! Io non ho commissionato alcunché!»
«Clark, più avanti potrete cianciare e blaterare finché vorrete, ma basta
con le fandonie, per oggi! A quanto si mormora, prima che gli sparassero,
il barone sfoderava un sorriso bizzarro, identico a quello rappresentato in
questo ritratto! Un sorriso inconsueto!»
La pelle iniziò a formicolarmi, e il mio corpo fiutò il pericolo prima che
riuscissi a comprendere che cosa stava accadendo. Tacqui allorché notai la
mia camicia macchiata del sangue di Claude Dupin. Poi mi avvidi che i
domestici percorrevano i corridoi a passo nervoso e strascicato, lontano
dalle loro solite postazioni. I tre o quattro poliziotti che avevano accompagnato White erano spariti dalla stanza, e altri agenti vi sfilavano attraverso,
abbastanza numerosi da costituire un esercito permanente. Sentii delle persone che salivano le scale e si muovevano nelle camere da letto al piano di
sopra. Stavano perquisendo Glen Eliza mentre io ero seduto lì. Ebbi la sensazione che le pareti mi crollassero addosso, e mi sovvenne l'immagine
della dimora incendiata del dottor Brooks.
«Avete afferrato il barone quando stava per rivolgersi al pubblico...»
«Ispettore! A cosa alludete?» Ormai le nostre voci si sovrapponevano.
«Non avete un alibi... e non vi è traccia del vostro amico, questo "signor
Duponte", da nessuna parte.»
«Ispettore, state insinuando qualcosa... Potete definirmi un bugiardo se
volete...!»
«... Poe vi ha rovinato una volta per tutte.»
«Che cosa? A cosa vi riferite?»
«Alla vostra frequentazione maniacale dei suoi scritti, signor Clark. Avreste fatto qualsiasi cosa per impedire al barone Dupin di parlare della
morte del signor Poe, vero? Avete ammesso di aver aggredito e "inferto un
taglio" a un altro francese. Volevate essere l'unico a parlare di Poe. Mi
domando se, qualora qualcuno fosse davvero coinvolto nella morte del signor Poe, quell'individuo avrebbe mostrato segni di ossessione... il che mi
spinge a interrogarmi sulle vostre attività nel periodo in cui Edgar Poe è
deceduto.»
Mentre protestavo con tutte le mie forze, l'assistente mi si parò dinanzi e
mi prese per il braccio, pregandomi con pacatezza di alzarmi e di non opporre resistenza.
Capitolo 27
All'inizio, mi assegnarono una delle celle di fronte all'ufficio dell'ispettore White, nella centrale del Middle District. Al suono di ogni passo, nasceva in me una trepidazione quasi disperata. La prigionia, vorrei aprire una
breve parentesi per sottolinearlo, non vi fa semplicemente sentire soli. Tutta la storia della vostra solitudine riemerge a poco a poco, finché la cella
diviene il castello della vostra tribolazione mentale. I ricordi della solitudine travolgono tutti gli altri pensieri legati al presente o al futuro. Siete abbandonati a voi stessi. È così che funziona; nessun poeta del sistema penale potrebbe inventare qualcosa di più crudele.
Chi aspettavo con il cuore che mi batteva all'impazzata? Duponte? Hattie? Magari l'espressione corrucciata ma risoluta sul volto di Peter Stuart?
Claude Dupin, accompagnato dai medici, in condizioni di accusare il vero
colpevole e liberarmi? Avevo nostalgia persino dei rimproveri della mia
prozia. Di qualunque cosa mi rammentasse che qualcun altro si interessava
al mio destino.
Frattanto, non avevamo notizie di Duponte. Temevo che gli fosse toccata una sorte peggiore della mia. L'avevo piantato in asso. Ero venuto meno
all'impegno di proteggerlo mentre il suo genio era in azione.
Tra gli altri privilegi che White concedeva ai prigionieri istruiti, vi era la
distribuzione di alcuni quotidiani e periodici. Li accettai, ma finsi di sfogliarli mentre, in realtà, mi dedicavo a testi molto più importanti, che avevo portato con me di nascosto. Quando mi ero azzuffato con il barone Dupin nella sala delle conferenze, gli avevo strappato di mano, quasi senza
accorgermene, gli appunti del suo discorso. Senza neppure pensare al loro
significato, me li ero infilati nel cappotto prima di seguire l'ispettore alla
centrale.
Li studiavo finché avevo a disposizione una candela accesa, celandoli in
una rivista. «Edgar Poe non se n'è andato, ma l'hanno condotto via», asseriva il discorso del barone, che, pur non potendo aspirare ad alcun merito
letterario, nel complesso non era inelegante. Lo imparai a memoria, immaginando che Duponte lo leggesse da sopra la mia spalla. «Possiamo pervenire alla verità solo osservando ciò che è falso.»
Una volta, mentre esaminavo quei fogli, fui interrotto dall'arrivo di un
visitatore. La figura dinoccolata di un uomo si materializzò nel corridoio,
scortata dall'assistente di White. Era uno sconosciuto con un viso inespressivo. Dopo aver appoggiato l'ombrello alla parete, si scrollò l'acqua dagli
stivali giganteschi, che sembravano inghiottire metà della sua statura.
«Che puzza, qui dentro...» esordì, annusando l'aria.
Dalle celle delle donne, provenne il canto di una detenuta ubriaca. Quel
tale si limitò a restare immobile, in silenzio. Non notando in lui alcuna benevolenza particolare, lo imitai.
Mi sorpresi quando gli si accostò una giovane spaventata, avvolta in un
mantello.
«Oh, caro Quentin, guardate dove vi hanno rinchiuso!» Hattie mi fissò
con compassione. Era sull'orlo delle lacrime.
«Hattie!» Allungai il braccio per afferrarle la mano. Mi pareva impossibile che fosse reale, nonostante il calore dei suoi guanti di pelle. Ricordando la presenza dell'estraneo, la mollai. «Peter non è con voi?»
«No, non voleva che venissi. Si rifiuta di parlare della situazione. Quando si è recato alla conferenza era furibondo. Riteneva di dover fare qualcosa per fermarvi. Credo sia ancora vostro amico.»
«Deve sapere che sono innocente! Come potrei essere coinvolto nell'attentato al barone? Il barone aveva rapito il mio amico per metterlo a tacere...»
«Il vostro amico? Vi riferite all'amico che vi ha cacciato in questo guaio,
signor Clark?» interloquì il tizio al suo fianco, voltandosi nella mia direzione con un cipiglio simile a quello di Peter.
Dopo avergli fatto segno di aspettare, Hattie si rivolse ancora a me.
«Questo è il marito di mia cugina, Quentin. Uno dei migliori avvocati di
Washington per questo genere di faccende. Può aiutarci, ne sono certa.»
Nonostante la disperazione per la mia situazione attuale, mi sentii pervadere dal sollievo all'udire il verbo «aiutarci».
«E il barone?» chiesi.
«È spacciato» sbottò il mio nuovo legale.
«Ho scritto alla vostra prozia pregandola di venire subito; ci darà una
mano ad aggiustare le cose» continuò Hattie, come se non avesse sentito
quelle parole terribili. Se quanto aveva affermato suo cugino era vero, se
Claude Dupin era in fin di vita, sarei stato un assassino agli occhi del mondo.
Qualche giorno dopo, mi trasferirono dalla centrale di polizia al penitenziario della città e della contea di Baltimora, sulle sponde del Jones Falls.
L'atmosfera alimentò il mio sconforto; le celle circostanti erano gremite di
uomini accusati di reati atroci, oltre a persone che attendevano la data del
processo con scarsa speranza, o l'impiccagione con ostinata impazienza.
Il mattino prima, mi avevano incriminato ufficialmente per il tentato omicidio del barone. Le mie dichiarazioni, secondo cui Claude Dupin andava fermato, erano state ampiamente citate, insieme alla mia comparsa sul
palco del salone. Il cugino di Hattie aveva scosso la barba con riprovazione
all'idea che uno stimato ispettore di polizia testimoniasse contro di me. Durante la perquisizione di Glen Eliza, gli agenti avevano trovato anche una
pistola, l'arma di cui mi ero munito per precauzione allorché mi ero recato
da John Benson e che, distrattamente, avevo lasciato in bella vista.
Ogni giorno imperversavano temporali. La pioggia non accennava a cessare. Ogni volta che si placava, riprendeva con maggiore violenza, come se
avesse soltanto tirato un poco il fiato. Secondo quanto si diceva, a Broadway, poco distante da Gay Street, l'acqua aveva spazzato via un ponte, che
ne aveva investito un altro, cosicché le due strutture avevano galleggiato
per mezza Baltimora, seguendo la corrente e strappando interi edifici dagli
argini. In carcere, frattanto, persino l'aria sembrava diversa... carica di tensione e angoscia. Vidi un prigioniero che lanciava urla spaventose e si
premeva il capo tra le mani come se qualcosa cercasse di uscire scavandosi
un cunicolo nella sua testa. «È arrivato!» gridava in tono apocalittico. «È
arrivato!» Per via delle condizioni atmosferiche o di altre ragioni a me ignote, si inasprirono anche gli scontri fra i secondini e alcuni dei detenuti
più agitati. Attraverso le sbarre della mia finestra, intravedevo la riva del
Jones Falls che si arrendeva pian piano allo strato gorgogliante di acqua
piovana. Avevo l'impressione di fare lo stesso.
Il mio avvocato tornò, ogni volta con altre cattive notizie dall'esterno. I
quotidiani, che leggevo solo con indolenza, erano entusiasti di proclamare
la mia colpevolezza. Ormai scrivevano che il francese gravemente ferito e
ricoverato in ospedale era l'ispiratore dei racconti basati sul raziocinio di
Poe e che avevo tentato di eliminarlo per invidia, a causa di un'ossessione
morbosa verso il poeta. Chissà perché, i giornali whig giudicavano eroico
il mio gesto. Quelli democratici, invece, forse in reazione alle affermazioni
degli avversari, erano convinti che fossi malvagio e codardo. Entrambi i
fronti avevano tuttavia deciso che ero io l'assassino. I periodici neutrali,
ossia il «Sun» e il «Transcript», temevano che l'episodio avesse ripercussioni disastrose sui rapporti del nostro Paese con la giovane repubblica
francese e il suo presidente, Luigi Napoleone.
Ribadii con veemenza che il barone Dupin non era affatto l'ispiratore del
vero Dupin, anche se credo che il cugino di Hattie considerasse irragionevoli quelle obiezioni. Edwin venne a trovarmi più volte, ma la polizia, sospettosa verso qualunque negro avesse a che fare con me, cominciò ben
presto a tempestarlo di domande, sicché lo invitai ad astenersi da quelle visite per risparmiarsi gli interrogatori. Anche John Benson, il mio benevolo
fantasma, mi raggiunse in quel luogo squallido. Gli strinsi la mano con calore, contento di avere un alleato.
L'ombra delle sbarre gli oscurò il volto smunto. Mi spiegò che sfacchinava quasi senza sosta sui libri contabili di suo zio. «Sono esausto, non c'è
dubbio. Nemmeno il diavolo in persona è mai stato così oberato di lavoro»
affermò. Mi lanciò un'occhiata obliqua attraverso l'inferriata, quasi le nostre posizioni potessero invertirsi se non avesse prestato attenzione alle parole che sceglieva.
«Forse dovreste confessare, signor Clark» mi consigliò.
«Confessare cosa?»
«Che Poe vi assillava. Che, per così dire, vi aveva annientato.»
Avevo sperato che mi offrisse un aiuto più efficace. «Benson, avete scoperto qualcos'altro riguardo al suo decesso?»
Avvilito, sedette su uno sgabello e, facendo penzolare le gambe, ripeté
che avrei dovuto prendere in considerazione l'idea di una confessione
completa. «Non pensate più alla faccenda di Poe, signor Clark. Ormai è
impossibile scoprire la verità dietro la sua scomparsa. Ve ne renderete conto anche voi.»
Hattie veniva da me nei giorni in cui riusciva a evitare sia zia Blum sia
Peter, portandomi cibo e piccoli doni. Nel mio stato confuso e sconvolto,
trovavo a malapena le parole per esprimerle la mia gratitudine.
Mi narrò storie della nostra infanzia per calmarmi i nervi. Sostenemmo
conversazioni sincere su ogni argomento. Mi descrisse il suo stato d'animo
mentre ero a Parigi.
«Avevo capito che i vostri erano sogni ambiziosi, Quentin.» Sospirò.
«So che non avremmo potuto renderci felici a vicenda. Nondimeno non
dovete pensare che fossi arrabbiata o depressa perché eravate partito, o
perché non mi avevate rivelato null'altro. Se mi sono rattristata, è accaduto
perché non avevate intuito, non avevate compreso con chiarezza, che avreste potuto confidarmi qualsiasi dettaglio e che avreste ricevuto in cambio
la mia amicizia incondizionata.»
«Peter aveva ragione. È stato l'egoismo a mettere in moto ogni cosa.
Forse ho fatto tutto questo non per ciò che gli scritti di Poe avrebbero significato per il mondo, ma per ciò che significavano per me. Forse tutto
questo esiste solo nella mia mente.»
«Ecco perché è importante» replicò Hattie, prendendomi la mano.
«Perché non me ne sono accorto?» Fremetti di nervosismo. «Mi sono
concentrato solo sulla sua morte, a scapito della sua vita. Proprio quel che
temevo facessero gli altri. A scapito anche della mia, di vita.»
Dopo qualche giorno la pioggia e gli allagamenti impedirono a chiunque
di raggiungere la prigione dagli altri quartieri della città. Isolato da Hattie,
non avevo altra compagnia a parte i detenuti. Non mi ero mai sentito così
solo, intrappolato e condannato.
Una volta, durante una notte in cui il sonno era stato tanto generoso da
sopraffarmi, udii dei passi leggeri che si avvicinavano. Hattie. Era tornata,
nonostante i temporali e le inondazioni sempre più impetuose. Attraversò
il corridoio con rapidità ed eleganza, il mantello scarlatto che la proteggeva dal sudiciume del carcere. Ma, strano a dirsi, non era accompagnata da
alcun secondino, e (me ne avvidi quando mi riscossi dal mio torpore) quello non era l'orario delle visite. Sbucando dalle ombre delle altre celle, allungò le braccia e mi afferrò i polsi con tanta forza da immobilizzarmi.
Non poteva essere Hattie.
Sotto la luce fioca, ora la pelle dorata di Bonjour mostrava un pallore
spettrale. Sgranò gli occhi come se volesse guardare contemporaneamente
in tutte le direzioni.
«Bonjour! Come avete fatto a superare le guardie?» Se esisteva qualcuno capace di entrare e uscire liberamente da un penitenziario, supposi, tuttavia, che quel qualcuno era proprio Bonjour.
«Dovevo vedervi.»
Mi strinse più forte, e a un tratto mi sentii pervadere dalla paura. Era venuta a uccidermi per vendicare suo marito. Avrebbe potuto tagliarmi la gola senza esitazione e, trovandomi senza testa, nessuno avrebbe saputo che
era stata lì.
«So che non avete sparato voi al barone» disse, interpretando correttamente il mio sguardo inorridito. «Dobbiamo scoprire chi è stato.»
«Non lo sapete bene quanto me? I creditori... quei manigoldi che lo seguivano ovunque andasse.»
«Non li ha mandati nessun creditore. Il barone ha saldato i suoi debiti
settimane or sono, subito dopo aver raccolto le sottoscrizioni per la conferenza su Poe. La cifra che ha racimolato era al di là delle nostre aspettative. Quegli assassini non volevano il suo denaro.»
Ero esterrefatto. «Allora chi sono?»
«Lo appurerò. Lo devo al barone. E voi lo dovete alla donna che amate.»
Abbassai gli occhi sui piedi nudi. «Non è più innamorata di me.»
Quando alzai lo sguardo, vidi che aveva la bocca aperta, le labbra che
formavano un cerchio interrogativo. Lasciò cadere l'argomento. «Dov'è il
vostro amico? Deve aiutarci a trovare la risposta.»
«Il mio amico?» chiesi, sorpreso. «Duponte? Aspetto da tempo di porre
a voi questa domanda! Ho pensato al peggio dopo che voi e il barone l'avevate rapito.»
Appresi che Duponte non aveva subito alcuna violenza, almeno non per
mano di Bonjour. Con mio stupore, la giovane l'aveva liberato poco dopo
averlo prelevato da Glen Eliza. Claude Dupin le aveva ordinato di rilasciarlo all'ora fissata per l'inizio del suo fatale discorso. Il barone non aveva alcuna intenzione di uccidere Duponte, o meglio, aveva intenzione di
ucciderne solo l'orgoglio. Aveva ipotizzato che Duponte si sarebbe precipitato nella sala delle conferenze e che sarebbe arrivato in tempo per assistere al trionfo del suo rivale, amplificandone la vittoria con la sua umiliazione. Ma l'analista si era tuttavia risparmiato quella mortificazione, perché
non si era presentato... e se si era presentato, nessuno l'aveva veduto.
«Duponte ha cercato di fuggire quando l'avete sequestrato? Ha opposto
resistenza?»
Bonjour tacque, non riuscendo a decidere se la risposta mi avrebbe deluso. «No. È stato abbastanza saggio da non ribellarsi, giacché il barone era
determinato ad attuare il nostro piano. Dove potrebbe essere Auguste Duponte ora, monsieur Clark?»
«Sono rimasto chiuso qui dentro, Bonjour. Non ho la benché minima idea di dove sia.»
I suoi occhi incrociarono i miei con tanta intensità da colmarmi di imbarazzo. Non riuscii a frenare i miei pensieri: con Hattie in procinto di sposare Peter, quali speranze sentimentali mi restavano? Quanto coraggio mi avrebbe infuso... che cosa avrei dato, in quell'istante, per il più semplice gesto d'affetto! Forse le mie riflessioni erano facilmente intellegibili, perché
ora Bonjour mi si avvicinò. Distolsi lo sguardo per sottrarmi a qualsiasi
accusa di condotta disdicevole. Ma mi posò una mano sulla spalla, e quando tornai a guardarla, accostò il mio viso al suo attraverso le sbarre, in un
lungo attimo che mi elettrizzò più per la meraviglia che per il calore della
sua bocca. La cicatrice sulle sue labbra parve imprimere un solco corrispondente sulla mia faccia, e una scarica di adrenalina si diffuse nel mio
corpo ghiacciato. Mi sentii rinascere. Quando il bacio terminò, ebbi la sensazione che anche lei ne fosse in qualche modo estasiata.
«Dovete pensare a come rintracciare Duponte» mi sussurrò in tono categorico. «Lui riuscirà a stanare l'assassino.»
Per qualche giorno, cercai davvero di risolvere quell'enigma. Ma alcune
notti dopo la visita di Bonjour, la tetraggine e la solitudine inesorabile della cella ricominciarono a opprimermi.
Una volta, destandomi da uno dei miei lunghi momenti di incoscienza,
trovai un libro sul mio tavolino di legno. Non sapevo da dove venisse né
chi me l'avesse lasciato. Sulle prime, chiusi gli occhi e mi girai, pensando
che appartenesse a un sogno generato dal mio cervello per aggravare ancora di più le mie pene.
Era uno dei tomi di Griswold. Era il terzo (e ultimo), quello di cui sopportavo a stento la vista. I primi due contenevano un'antologia poco curata
ma accettabile delle prose e delle poesie di Poe, ma per il terzo volume, il
signor Rufus Griswold, quel curatore sconsiderato, aveva scritto un vero e
proprio saggio diffamatorio.
Durante l'inverno successivo alla morte di Poe, la stampa aveva pubbli-
cato annunci in cui Griswold chiedeva ai corrispondenti dello scrittore di
inviargli copie delle lettere in loro possesso da inserire nell'opera. Tuttavia,
avendo già letto il suo necrologio di Poe, costellato di menzogne assurde,
non ero neppure stato sfiorato dall'idea di accontentarlo. Gli avevo scritto
subito comunicandogli che disponevo di quattro missive compilate personalmente dal poeta ma spiegandogli le ragioni per cui non gliele avrei mai
mostrate, mai, a meno che non si impegnasse ad adottare un approccio diverso al suo solenne compito. Non aveva avuto la compiacenza di rispondermi.
Mi ero augurato, però, che Griswold avrebbe compreso le sue responsabilità di esecutore letterario (e non di carnefice letterario) dopo la pubblicazione dei primi volumi. Ma quando avevo avuto tra le mani il terzo tomo, dopo aver dato una scorsa alla prima pagina della maligna biografia
dedicata dall'autore al suo vecchio amico, l'avevo posato e non l'avevo più
degnato di uno sguardo. Anzi, avevo giurato a me stesso di bruciarlo.
Nel corso della sua indagine, tuttavia, Duponte aveva esaminato le lettere riprodotte nel libro. E ora l'opera era comparsa nella mia cella. Quando
chiesi delucidazioni, il secondino affermò che i suoi superiori erano preoccupati per il mio stato di salute e, notando che la mia apatia morale mi impediva di leggere giornali e riviste, ma rammentando la mia passione per
lo scrittore Poe, avevano prelevato dalla mia biblioteca quel testo, che recava il nome del poeta scritto a caratteri cubitali sulla copertina, e l'avevano posato lì.
Ciò nonostante, non avevo dubbi che dietro quella storia si nascondesse
l'ispettore White. Un tentativo di tormentarmi e di obbligarmi a confessare
il mio crimine, a deplorare il mio gesto scellerato. In quello spazio minuscolo, non avevo via di scampo; se distoglievo lo sguardo dal libro durante
la notte, la mia mano vi cadeva sopra nei parossismi di un sonno malsano.
Di giorno, lo infilavo sotto il tavolaccio per non vederlo, solo per urtarlo
con il piede appena mi muovevo per rizzarmi a sedere, il tomo assillante
che rispuntava scivolando fuori dall'altra parte. Lo lanciavo in corridoio
scagliandolo tra le sbarre, felice di essermene liberato, ma al mio risveglio
ricompariva, appoggiato con cura accanto alla caraffa d'acqua o in fondo al
letto, collocato lì da una guardia o, per quanto ne sapevo, da un altro prigioniero desideroso di torturarmi.
Alla fine, non riuscii più a trattenermi. Iniziai a leggere. Saltando gli insulsi commenti di Griswold, mi concentrai sulle missive che l'autore aveva
sparpagliato tra le notizie biografiche. Poco dopo, quando scoprii che cosa
conteneva il volume, mi domandai se White avesse una vaga idea dell'abisso in cui quella lettura mi avrebbe gettato.
Sfogliando l'opera (rabbrividisco al solo ricordo), scoprii che Poe mi aveva nominato in una missiva tra i possibili sostenitori della sua rivista,
«The Stylus», nella città di Baltimora. Griswold gli aveva risposto chiedendogli ulteriori informazioni su di me. Poi, in una lettera in cui Poe si dilungava sulla mia identità, trovai queste righe: «Il Clark di cui mi avete
domandato è un giovanotto arricchitosi senza fatica, che, essendo al corrente della mia estrema indigenza, mi importuna da anni con lettere non affrancate».*
Ogni giorno, in uno dei miei rari attimi di lucidità, rileggevo quella pagina per assicurarmi che non fosse frutto della mia spossatezza mentale.
Lettere non affrancate! Stentavo a crederci. Poe aveva insistito (ma lo sapete già) affinché non pagassi più l'affrancatura anticipata per la nostra
corrispondenza, come se quello fosse un insulto alla nostra amicizia. Mi
aveva pregato di aiutarlo («Potete o volete aiutarmi?»). Era stato lui a
chiedere il mio intervento («Mi importuna»?).
Non riuscivo a smettere di ripetermi le sue parole e, ancor peggio, udivo
la voce stanca di mio padre che le pronunciava. Un giovanotto arricchitosi
senza fatica. La ricchezza che papà mi aveva lasciato con tanta laboriosità
e assennatezza.
Se solo avessi saputo com'era la voce di Poe, cosicché la mia mente potesse cancellare l'altra. In quegli istanti, tuttavia, non riuscivo neppure a
immaginare come Poe potesse aver parlato. Forse aveva davvero la voce di
mio padre.
Non avevo più energie sufficienti ad alzarmi dal tavolaccio. La mia debolezza era palese, e non ero in condizioni di parlare. Dopo non aver dormito per diversi giorni, scivolai in una sonnolenza ininterrotta, e non fui
più in grado di distinguere il sonno dalla veglia. Ricordo pochissimo di
quel periodo, a eccezione del sottofondo prodotto dai tuoni e dagli scrosci
di pioggia intermittenti che ormai seguitavano da giorni.
Non vi furono altri visitatori per me oltre a secondini e poliziotti. Anche
se, una volta, ebbi la certezza di aver scorto un uomo che conoscevo
dall'altra parte del corridoio. Il clandestino dell'Humboldt, il teatro della
vittoria segreta di Duponte. Lì, nella squallida prigione di Baltimora, tra la
nebbia dei miei sogni, credetti di vederlo nuovamente, intento a spiarmi,
ma questa volta non vi era un capitano pronto a immobilizzargli le braccia.
Vi furono anche altri momenti, in cui avevo la sensazione che ogni centimetro della mia pelle fosse coperto di mosche e scarafaggi (un giornale
aveva descritto così il cadavere di Poe) e in cui sfuggivo agli incubi solo
quando mi destavo, madido di sudore freddo.
Torturato dalla prospettiva dell'impiccagione, ripetevo spesso nella mia
mente la storia che il barone mi aveva raccontato riguardo a Catherine
Gautier... anche se il suo volto pallido e sereno, che penzolava dall'alto
della forca, assomigliava ora a quello della dolce Hattie, ora a quello di
Bonjour, la malvagità si insinuava nei suoi lineamenti.
Frattanto, il direttore del carcere effettuò delle ispezioni e, dopo aver
stabilito che il mio mutismo e il mio stato di incoscienza non erano frutto
di una finzione, ordinò che mi trasferissero in un letto al primo piano
dell'edificio. A quanto mi hanno riferito, quando qualcuno mi toccava, reagivo soltanto con un tremito, e urla o scossoni non servivano a riscuotermi.
Mi svegliai nel mio nuovo alloggio, scoprendo di essere l'unico occupante di una stanza dove nemmeno i prigionieri volevano andare, perché,
pur essendo più confortevole delle celle, era il luogo in cui le persone venivano mandate a morire. I medici non riscontrarono alcun disturbo fisico,
ma conclusero che il mio sonno vacillante dimostrava che ormai il dado
era tratto. Quando gli agenti mi rivolsero alcuni semplici quesiti per testare
la mia lucidità, rimasi in silenzio o bofonchiai qualcosa di inintelligibile.
In seguito appresi che, allorché mi avevano domandato quando fossi nato,
avevo balbettato senza posa: «8 ottobre 1849», la data del funerale di Poe.
Non solo non ero venuto alla luce in quel giorno, ma se così fosse stato,
avrei avuto due anni.
Dal canto mio, rammentavo solo frammenti fugaci di innumerevoli sogni. Quando avevo ricevuto la notizia della morte dei miei genitori, ero rimasto seduto per molti giorni nella mia camera, in preda a malessere e a
brividi in tutte le membra. Nel mio torpore, avevo avuto visioni chiarissime di conversazioni con mio padre e mia madre, conversazioni che non erano mai avvenute ma che erano reali quanto tutte quelle cui avevo preso
parte nella mia vita, o forse di più. Durante quei colloqui, mi ero scusato
più volte per aver sprecato tutto quanto, per non aver ascoltato i loro anni
di consigli come invece aveva fatto Peter. Poi mi risvegliavo. Il libro, il
volume di Griswold, non mi aveva seguito dalla cella all'infermeria, e ne
ero felice. Ridacchiavo tra me e me, come se quello fosse finalmente il mio
grande trionfo.
Non vi era molta luce in quella stanza dalle finestre sudicie e opache.
Persino la mattina in cui la pioggia cessò, un unico raggio di sole filtrò attraverso i vetri. Le guardie erano tutte indaffarate a spostare i detenuti qua
e là per il fabbricato, perché alcuni locali avevano cominciato ad allagarsi.
Fino ad allora, l'infermeria non era stata danneggiata, ma quella notte mi
destai con un sussulto, udendo alcuni rumori.
«Chi è là?» chiesi, assonnato.
L'aria si raggelò all'improvviso, e quando posai i piedi nudi sul pavimento, un ruscello d'acqua fredda mi si increspò intorno alle dita. Tornai a rannicchiarmi nel letto, cercando una candela a tastoni. Ebbi la sensazione di
aver aperto gli occhi per la prima volta dopo anni.
L'acqua aveva riempito la fogna e si era riversata all'interno sfondando
la parete. Rizzandomi a sedere, intravidi l'oscurità dell'angusto passaggio
aperto nel muro. Sapevo che lo scolo correva sotto l'alta e immensa recinzione del penitenziario, sbucando nel Jones Falls. Non vi era neppure il più
piccolo ostacolo a sbarrarmi il cammino. Giacché non mi esponevo alla luce da giorni, i miei occhi valutarono subito le circostanze nonostante il buio.
La mia mente si riscosse, pronta e vivace. Una nuova energia mi strappò
dalla tetra indolenza in cui ero sprofondato. Un'idea vaga, una certezza, mi
spinse verso il punto in cui l'acqua putrida mi sommerse le caviglie, la vita
e infine le spalle. Sebbene la corrente mi rallentasse, ebbi l'impressione di
muovermi con maggiore rapidità, finché spuntai dove le austere torri del
carcere si stagliavano sull'orizzonte lontano.
Mi s'insinuò una nuova idea: Edgar Poe era ancora vivo.
Non ero impazzito, come forse penserete. Non avevo perduto il senno
nonostante il lungo travaglio della prigionia che mi aveva condotto a quella consapevolezza, a quell'idea vaga. Edgar Poe non era mai morto.
Quando i miei occhi si posarono sul mondo esterno per la prima volta
dopo quelli che mi parevano mesi o anni (se allora qualcuno mi avesse detto che era trascorso tanto tempo, gli avrei creduto), tutte le informazioni
riguardanti la scomparsa del poeta assunsero una forma nuova e stupefacente nel mio cervello.
Forse, in quell'istante, avrei dovuto cercare aiuto, riposo o rifugio. Forse
non avrei mai dovuto varcare i confini della prigione, dove, strano a dirsi,
ero al sicuro da quanto mi aspettava fuori. Ma voi che cosa avreste fatto?
Sareste rimasti a letto, fissando il baluginio delle stelle? Coraggio, riflettete su come vi sareste comportati se foste stati investiti dalla convinzione
improvvisa che Edgar Poe fosse in vita.
Duponte non se n'era forse avveduto? Non aveva forse preso in considerazione quella possibilità durante la sua indagine?
«Forse non ci importa di quel che è accaduto a Poe. L'abbiamo immaginato morto per i nostri scopi. In un certo senso, è ancora vivo» aveva detto.
Mi sovvenne che Benson aveva affermato la stessa cosa, o almeno qualcosa di assai simile, durante il nostro primo incontro. Mi era sembrato che
sapesse più di quanto fosse disposto a dirmi. Era forse al corrente anche di
questo? Durante la sua investigazione iniziale, aveva forse scoperto qualcosa che non poteva rivelare, e mi aveva forse dato un suggerimento, un
indizio su quella verità segreta?
Vidi i volti degli uomini al funerale come se un dagherrotipo li avesse
impressi nella mia mente, li vidi ancora mentre venivano nella mia direzione con i passi frettolosi e attutiti di quel giorno.
Pensa... pensa alle prove. George Spence, il custode del camposanto,
non vedeva Edgar Poe da molti anni, e aveva sottolineato che gli era parso
un estraneo quando gliel'avevano portato per la sepoltura. Neilson Poe aveva scorto suo cugino solo attraverso una tenda all'ospedale universitario,
e nel suo studio non mi aveva forse riferito che il paziente gli era sembrato
un uomo del tutto diverso?
Inoltre, la funzione cui avevo assistito era stata celebrata molto velocemente ed era durata tre minuti al massimo, con pochissimi testimoni, era
stata una cerimonia anonima e silenziosa come non se n'erano mai vedute.
Anche Snodgrass, l'intransigente dottor Snodgrass, aveva manifestato timore, rimorso e apprensione per la fine di Poe e per l'ultimo saluto al poeta. Ripensai ai versi che avevamo trovato sulla sua scrivania, versi che non
solo esprimevano la sua opinione sull'alcolismo dello scrittore, ma commemoravano anche il giorno delle esequie.
Ma quella scena tetra seguita a ossessionarmi!
Nella vergogna e nella melanconia ripercorro
la tua sepoltura - la più triste che mai si sia osservata in quel sepolcro dimenticato!
Qualcuno che avesse incontrato Poe negli ultimi anni ne aveva forse veduto il cadavere prima che la bara venisse sotterrata? E quasi tutti i testi-
moni (Neilson Poe, Henry Herring, il dottor Snodgrass) si rifiutavano di
parlare del funerale, come se vi fosse qualcosa da nascondere. Sapevano
qualcos'altro? Sapevano che, in realtà, Poe era ancora vivo e vegeto? Oppure era stato occultato da agenti esterni nel tentativo di insabbiare qualcosa? O ancora, era stato lui, Edgar Poe, a voler giocare al mondo quell'ultimo tiro mancino?
Noterete che i miei ragionamenti (generati, lo ammetto, in uno stato di
considerevole agitazione) non erano folli né sconclusionati. Avrei dimostrato che Poe non era ancora deceduto, e la situazione che si era venuta a
creare si sarebbe ribaltata all'istante. Dopo essere uscito dalla fogna, mi incamminai subito verso il vecchio cimitero presbiteriano di Westminster.
Essendo situato vicino al centro della città, lontano dai maggiori specchi
d'acqua, si era salvato, come le vie circostanti, dalle conseguenze più gravi
dell'inondazione, sebbene alcuni rivoli scorressero ancora sul terreno erboso, e alcuni angoli e fessure contenessero pozze più profonde.
Avrei parlato con Spence, insistendo affinché mi fornisse risposte esaurienti. Ma quando oltrepassai il cancello, mutai proposito. Nonostante l'oscurità, ci vedevo bene grazie al mio lungo soggiorno nelle celle buie della
prigione. Infatti, mi bastò il fulmine di un altro temporale in avvicinamento per individuare il luogo esatto della tomba di Edgar Poe, che, per quanto
fosse vergognoso, non era ancora stata contrassegnata. Che cosa c'era là
sotto?
Dopo aver spostato i rami e gli altri rifiuti che la coprivano, iniziai a
scavare tra l'erba a mani nude. Ogni zolla che rimuovevo dal centro produceva un ruscelletto zampillante. Provai lungo il bordo, ma non ebbi fortuna. In alcuni punti, il suolo era così duro che mi si spezzarono le unghie, il
sangue macchiava i grumi di fango e terriccio.
Rendendomi conto che in quel modo i progressi sarebbero stati lentissimi, attraversai il camposanto e, grazie al Cielo, scorsi una piccola vanga,
con cui cominciai a tracciare un solco intorno alla tomba. Attorniato da
mucchi di melma, conficcavo l'arnese nel terreno con alacrità. Quel lavoro
estenuante mi assorbì a tal punto che, sulle prime, non prestai attenzione al
rumore improvviso che si approssimava. Ero distratto da ciò che intravedevo nella buca.
Era una semplice bara di pino. Allungando la mano, ne sfiorai la fredda
superficie di legno liscio. Spazzando via la terra che la imbrattava, le mie
dita trovarono il punto in cui il coperchio incontrava la cassa, ma proprio
quando feci per sollevarlo, dovetti fermarmi.
Il cane di Spence si avventò su di me con ferocia. Si arrestò a qualche
metro di distanza, e per un attimo pensai che si fosse bloccato perché si era
ricordato che avevamo già fatto amicizia. Non era così. O, qualora se ne
fosse ricordato, era ancor più furioso perché avevo tradito la nostra fiducia
reciproca. Era convinto che stessi cercando di rubare un corpo dal suo territorio (è l'esatto contrario, bestia coraggiosa! Non vi è alcun corpo da rubare!). Ringhiando, spalancò la bocca fra le lapidi, e il panico mi indusse a
credere di aver veduto le tre teste di Cerbero. Tentai di scacciarlo con la
vanga, ma si limitò ad accovacciarsi, pronto ad azzannarmi da un momento
all'altro.
Ora, tenendo in mano una lanterna, il custode sbucò dalla volta sotterranea in cui avevamo chiacchierato un tempo. L'aria era così nera e compatta
che faticavo a vederlo. Sembrava tutto dello stesso colore. Lo immaginai
nei panni del tale che si era tramutato in pietra in quella stessa cripta.
«Non sono un disseppellitore di cadaveri!» urlai. Anche se suppongo
che quell'affermazione non suonasse molto persuasiva, giacché agitavo
una vanga, avevo le mani e i vestiti infangati e insanguinati, e avevo parzialmente dissotterrato una bara. «Guardate dentro! Guardate dentro!»
«Chi c'è? Chi è là? Sailor, prendilo!»
Non avevo scelta. Rivolgendo uno sguardo carico di desiderio al legno
sotto di me, gettai la vanga e mi misi a correre, con l'uomo e il cane alle
costole.
Non ero ancora sconfitto. Dopo aver seminato i miei inseguitori al cimitero, mi rifugiai in un vicolo. Impiegai quasi mezz'ora per riprendermi dalla fatica della mia missione fallita prima di prefiggermi un nuovo obiettivo. Ormai era probabile che Spence si fosse messo di guardia sulla tomba
di Poe. Con incrollabile determinazione, attraversai tuttavia la città, rammentando l'indirizzo dell'ultima residenza di Edgar a Baltimora (in Amity
Street, tra la Lexington e la Saratoga), che avevo scoperto durante le mie
lunghe ricerche.
Avrei potuto chiederlo a lui. Perché? Caro Poe, perché scrivere quella
lettera? Perché affermare che sono un giovanotto ozioso, un seccatore?
Avevate scordato che andavamo d'accordo?
All'età di ventidue anni, Poe si era appena ritirato da West Point, quando, ripudiato da John Allan, che si era rifiutato di saldare i suoi debiti, era
giunto in quella modesta dimora per vivere con la zia (Maria Clemm), la
cugina (Virginia, all'epoca una bimba di otto anni), il fratello (William
Henry) e una nonna malaticcia. Gli altri cadetti dell'accademia gli avevano
regalato un dollaro ciascuno per la pubblicazione della sua prima raccolta
di poesie, e lo scrittore sognava di farsi un nome grazie a quel volume.
Sicuro di aver individuato il posto giusto in un angusto edificio tra Lexington e Saratoga Street, e senza nemmeno prendere in considerazione la
possibilità di un piano più razionale, salii di corsa i gradini fino al portone
e, ritrovandomi ai piedi di una stretta scala, mi precipitai di sopra. Forse,
se il poeta fosse stato ancora vivo, sarebbe tornato lì, nella sua ultima casa
di Baltimora, e mi avrebbe lasciato un indizio riguardo la sua destinazione
successiva. Quasi non mi avvidi delle due donne (una dai capelli bianchi,
l'altra giovane e avvenente) che lanciarono uno strillo allorché feci irruzione nella minuscola stanza in cui sedevano dinanzi al caminetto. Probabilmente ero un'apparizione spaventosa, l'uniforme da detenuto ormai sbrindellata, gocciolante e macchiata di terra e sangue. In un'altra camera, una
soffitta in cima alla costruzione, un tipo segaligno si sporse dalla finestra
affacciata su Amity Street, gridando «Al ladro! All'assassino!» e altre esclamazioni. Ormai le due donne correvano qua e là per la casa, e le pareti
riecheggiavano di urla inintelligibili.
Indietreggiai dinanzi a tutto quel trambusto e, notando che lo sconosciuto afferrava un piede di porco, filai giù per le scale, accanto alla giovane
terrorizzata, attraverso il vestibolo, fino al portone. Procedevo a una velocità tale che non riuscii a fermarmi finché giunsi al centro della via, dove,
al chiarore incerto di un lampione distante, intravidi una carrozza e un cavallo gigantesco che avanzavano nella mia direzione, senza concedermi il
tempo di tuffarmi verso un punto in cui avrei potuto evitare di finire direttamente sotto quella massa di ruote e zoccoli. Non avendo alcuna possibilità di sottrarmi a quel destino raccapricciante, mi schermai gli occhi con il
braccio per proteggermi dalla vista della morte.
Con un gesto provvidenziale, qualcuno mi trascinò di peso verso il cordone del marciapiede, lontano dalla vettura. Stringendomi forte il polso, il
mio salvatore si sforzò di tirarmi più vicino a sé. Avevo chiuso gli occhi
con apatica rassegnazione, e ora li aprii con prudenza, come se fossi certo
di vedere un fantasma venuto dall'aldilà anziché un essere umano. Dopo
aver sollevato le palpebre, mi accorsi di fissare il volto di Edgar A. Poe.
«Clark!» disse a bassa voce, rafforzando la presa, la bocca che si contraeva in una linea sottile e nervosa sotto i baffi scuri. «Dobbiamo portarvi
via di qui.»
Tacqui, guardai di nuovo, tesi la mano verso il suo viso, e in quell'istante
ogni cosa tremò e fu inghiottita dalle tenebre.
Ripresi i sensi per un breve attimo, in una stanza buia e umida. Sentii
che mi depositavano da qualche parte e combattei contro lo strano presagio
di un pericolo mortale. Socchiudendo gli occhi, e alzando la testa per
quanto mi fu possibile, scorsi con chiarezza un unico oggetto che si profilava sopra di me, formando il limite del mio campo visivo.
Era una tavola rettangolare con un'iscrizione: HIC TANDEM FELICIS
CONDUNTUR RELIQUAE.
Trasalii quando capii che era una lapide, e con orrore tradussi il suo macabro epitaffio dei miei ventinove anni «Qui, finalmente, riposa felice».
* Giacché le righe riprodotte sopra appartengono a un testo stampato, il
confronto preliminare, effettuato da un esperto, tra la biografia di Rufus
W. Griswold e gli originali a noi pervenuti delle missive di Poe ha rivelato
che questa frase, come moltissime altre, era stata inventata dall'autore nel
tentativo di dimostrare la scarsa gratitudine del poeta verso i suoi amici.
Purtroppo, non ebbi modo di entrare in possesso di queste conoscenze durante la mia detenzione nel penitenziario del Maryland.
Capitolo 28
Precipitai di nuovo nell'oblio. Allorché mi destai dalla mia trance, in
preda a una frenesia improvvisa, mi rizzai a sedere e ansimai per l'intensa
sete che mi bruciava la gola. Pur essendo conscio di battere le palpebre,
non vedevo alcunché, e i miei pensieri oscillavano tra la convinzione che
mi avessero bendato e la semplice certezza di essere in uno spazio o in un
locale buio. In quel momento, una lampada si approssimò dall'altra parte
della stanza.
«È sveglio» annunciò una vocetta lì accanto. Distinguendo una ciotola
piena d'acqua, tesi le dita in quella direzione.
«No» intervenne un'altra voce, perentoria. «Quella è per la mano.»
In effetti, me n'ero ferita una al camposanto.
«Tenete.»
Ora comparve un piccolo cerchio luminoso, e fui affiancato da due bambini scalzi, un maschietto e una femminuccia che, in quel chiarore, apparivano così pallidi da sembrare verdi come spiritelli. Quando alzarono la
fiammella, notai che la bimba mi allungava un bicchiere d'acqua, aspettan-
do, con pazienza e con un'espressione di dolcezza assoluta, che lo prendessi. Bevvi con avidità.
«Dove...» balbettai, prima di guardare di nuovo la lapide spaventosa.
Adesso, sotto la luce, mi avvidi che era il disegno grande e particolareggiato di una lapide, e riuscii a leggerne l'iscrizione per intero. HIC TANDEM
FELICIS CONDUNTUR RELIQUAE EDGAR ALLAN POE e, più in
basso, OBIIT OCT. VII 1849.
Mi voltai verso la piccina, grato per la sua gentilezza. A un tratto mi sentii protettivo nei confronti dei due fanciulli. «Non avete paura?»
«No» rispose la bambina. «Siamo solo preoccupati per voi, signore. Eravate in condizioni pietose quando papà vi ha condotto qui.»
Respiravo senza difficoltà per la prima volta dopo mesi. Mi accorsi di
indossare abiti puliti e di essere sdraiato su una tavola posata su due sedie,
una sorta di giaciglio improvvisato.
«Temo, signor Clark, che i letti per gli ospiti siano rari in una casa con
sei piccoli Poe e uno neonato. Speravo comunque che riusciste a riposare
un poco.»
Il tale che aveva parlato era quello che mi aveva salvato nella via, solo
che non era Edgar, bensì Neilson Poe. Pareva diverso dall'ultima volta che
ci eravamo incontrati, alla centrale di polizia. Era più magro e portava baffi che, di primo acchito, lo trasformavano in una copia pressoché perfetta
dei ritratti di suo cugino.
«William. Harriet.» Guardò con aria severa i due bimbi, che erano rimasti fedelmente al mio fianco. «A nanna.» I piccini esitarono.
«Mi siete stati di grande aiuto» sussurrai loro. «Ora obbedite a vostro
padre.»
Uscirono senza far rumore.
«Perché sono qui?» chiesi al padrone di casa.
«Forse voi saprete rispondere a questa domanda meglio di me» rispose
Neilson, turbato, sedendo lì di fronte.
L'avevano informato, mi spiegò, che qualcuno aveva cercato di dissotterrare la bara di Edgar al cimitero di Westminster, e sebbene fosse tardi,
aveva noleggiato una carrozza e si era avviato immediatamente verso il
camposanto. Le strade, tuttavia, erano impraticabili a causa della pioggia, e
aveva dovuto fare una deviazione attraverso Amity Street, dove aveva udito un gran trambusto che, gli era sembrato, proveniva dalla vecchia casa
della sua parente, Maria Clemm, in cui anche Edgar aveva abitato quindici
anni addietro.
Giudicando quella coincidenza assai bizzarra e inquietante, aveva ordinato al vetturino di tornare indietro. Smontando, aveva cominciato a curiosare, ma, ricordando che avrebbe dovuto proseguire verso il cimitero per
indagare su quegli accadimenti misteriosi, aveva chiesto al cocchiere di girare la carrozza per risparmiare tempo. A quel punto, mi aveva veduto uscire dal portone e, notando che ero proprio sulla traiettoria del veicolo e
stavo per essere investito, mi aveva tirato verso il marciapiede, dove ero
svenuto.
Osservando lo strato di fango sui miei vestiti mentre mi adagiava sul sedile, aveva intuito che la segnalazione ricevuta da Spence doveva avere un
qualche legame con la mia presenza in Amity Street.
Non sapendo quanto avrei potuto rivelargli, tacqui. Neilson continuò.
«Vi ho condotto subito qui, signor Clark, e il mio fattorino mi ha aiutato
a distendervi su questa tavola. Poi è andato nella via qui accanto per chiamare un medico, che vi ha visitato e se n'è andato solo poco tempo fa. Al
piano di sopra, mia moglie ha pregato affinché recuperaste le forze. Vi eravate introdotto nel cimitero di Westminster questa sera, signore?»
«Che cos'è quello?» domandai, indicando lo schizzo. Giaceva con aria
del tutto innocua su una mensola tra altri libri e documenti, ma poiché,
all'inizio, un raggio di luce l'aveva rischiarato, era stato l'unico tetro oggetto della mia attenzione quando avevo ripreso i sensi per qualche istante.
«L'ha fatto il tizio che ho incaricato di scolpire una lapide decorosa per
la tomba di mio cugino. Forse dovremmo discuterne più tardi. Sembrate
esausto.»
«Non ho più voglia di dormire» gli assicurai. Avevo infatti la sensazione
che il breve sonno mi avesse ristorato rapidamente. Vi era anche dell'altro.
Benché Neilson Poe nutrisse qualche dubbio sulla mia condotta, e io sulla
sua, mi aveva protetto... i suoi figli mi avevano protetto. Mi sentivo al sicuro. «Ringrazio la vostra famiglia per l'aiuto che mi ha offerto questa sera, ma terno di sapere più di quanto crediate. Avete detto a me e alla polizia che Edgar Poe non era solo vostro cugino, ma anche vostro amico,
nondimeno so come vi considerava.»
«Ossia?»
«"Il peggior nemico che io abbia al mondo."»
Aggrottò le sopracciglia, accarezzandosi i baffi e annuendo con calma,
senza scomporsi. «È vero. Insomma, era famoso per i commenti di quel
genere, sul mio conto e su quello di altre persone che gli volevano bene.»
«Che cosa l'avrà indotto a esprimere quel giudizio su di voi, signor Po-
e?»
«Vi è stato un periodo, quando il suo affetto per la giovane Virginia era
appena sbocciato... Avevo sposato mia moglie, Josephine, la sorellastra di
Virginia, e ritenendo che, a tredici anni, mia cognata fosse troppo piccola
per partire con lui, mi sono offerto di provvedere alla sua istruzione e di
pensare al suo debutto in società qualora fosse rimasta con noi a Baltimora. Edgar l'ha interpretato come un insulto. Ha dichiarato che non avrebbe
potuto vivere un'altra ora senza di lei. Credeva che cercassi di rovinare la
sua felicità e che gli avrei impedito di rivedere la sua Sissy. Non sapeva
comportarsi con dignità quando era afflitto dal dolore.»
«Che cosa mi dite dell'accenno al vostro rifiuto di favorire la sua carriera
letteraria, contenuto in una lettera al dottor Snodgrass?»
«Edgar pensava che fossi geloso, suppongo» rispose con franchezza.
«Come vi ho già raccontato, anch'io avevo provato a intraprendere la carriera letteraria in gioventù. Mio cugino ha dunque concluso che ero invidioso dell'attenzione, positiva e negativa, che provavo per i suoi scritti.»
«Lo eravate?»
«Invidioso? Non nel modo che intendeva Edgar. Non mi reputavo alla
sua altezza. O meglio, se mai sono stato geloso, è accaduto perché ho notato che i suoi scritti possedevano un genio, una naturalezza, che i miei non
avevano nonostante la meticolosità con cui vi lavoravo.»
«Non riesco a dimenticare» aggiunsi con fermezza «che avete impedito
alla polizia di indagare sulla scomparsa di vostro cugino, signor Poe.»
«È questo che pensate?» Restò imperturbabile. «Capisco perché vi siete
fatto questa idea. Tuttavia, prima che arrivaste alla centrale, l'ispettore
White aveva insistito in tono perentorio sull'inutilità di un'inchiesta, giacché, sapete, la polizia di Baltimora è solita immaginare che non vengano
commessi crimini nella nostra città, soprattutto contro i turisti. Nella mia
professione, rappresento spesso individui accusati di piccoli reati, e faccio
molto affidamento sulla polizia affinché sia ragionevole con determinati
delinquenti, perciò ho pensato di non avere altra scelta se non assecondare
i desideri di White. Ho intuito che era abituato a vendicarsi su chi cercava
di dimostrare che a Baltimora vengono commessi più reati di quelli già noti, sicché, quando vi ho incrociato alla centrale, ho fatto del mio meglio per
dissuadervi dal continuare, ma solo per il vostro bene. Talvolta penso che
la nostra giustizia non sia molto diversa dai tempi della stregoneria: i crimini vengono denunciati solo quando fa comodo agli accusatori.» Si avviò
verso la porta. «Vedo che mi avete giudicato assai ostile verso mio cugino
durante i nostri primi incontri. Seguitemi, signor Clark.»
Passammo in biblioteca. La sua collezione delle opere di Poe eguagliava
quasi la mia. Meravigliato, la esaminai, estraendo un libro o una rivista
mentre li oltrepassavo.
Neilson si avvide che la sua innegabile passione per gli scritti di Poe mi
aveva sorpreso. «Ero furioso con Edgar negli ultimi anni della sua vita, e
anche dopo la sua morte, giacché sapevo che si era considerato migliore di
me sin dall'inizio. Reputava disastrose le mie qualità artistiche. In breve,
ero convinto che lui mi odiasse da molti anni. Ma ho capito di non averlo
mai odiato. Ho capito, inoltre, che Edgar rappresentava se stesso mediante
la sua produzione letteraria e che quest'ultima lo rispecchiava più del carattere e dell'aspetto fisico, più di qualunque lettera potesse scrivere in un accesso di rabbia o di qualunque commento potesse fare al cospetto di un
conoscente in un attimo di agitazione. La sua arte non è mai stata destinata
a essere popolare, non era destinata ad avere un principio o un senso morale, ma era la sua vera forma d'essere» spiegò, sorridendo.
Così dicendo, si piazzò in un angolo della stanza e, quando girò la sedia
per prendere una copia dei Racconti del grottesco e dell'arabesco, contrasse un lato della bocca come era avvezzo a fare Edgar. Per non dargli l'impressione di spiarlo, tolsi dallo scaffale il «Graham's» del 1841 che conteneva Gli assassinii della Rue Morgue, il primo racconto di Dupin. Lo tenni
tra le mani con reverenza, ripensando alla mia biblioteca, alla mia collezione, alla mia casa, Glen Eliza, che la polizia aveva senz'altro devastato e
messo a soqquadro durante le varie perquisizioni volte a trovare le prove
delle mie manie e soprattutto della mia colpevolezza.
«Sapevate che l'avevano pagato solo cinquantasei dollari per il primo
racconto di Dupin?» riprese Neilson, vedendo l'oggetto del mio interesse.
«Dopo la sua morte, ho veduto la stampa che lo diffamava e lo infangava.
Ho veduto quel biografo infame e ingiusto che lo trasformava in ciò che
voleva. Ricordate che questo è anche il mio cognome, signor Clark. Poe è
il cognome di mia moglie, e dei miei figli... e anche i figli dei miei figli si
chiameranno così. Io sono Poe. Negli ultimi mesi, ho letto e riletto quasi
tutti gli scritti di mio cugino, avvertendo a ogni pagina un'affinità sempre
maggiore, un'empatia del massimo grado, come se le parole che era riuscito a cavare dal nostro sangue comune potessero essere uscite da me. Ditemi, signor Clark, l'avevate conosciuto?» mi chiese di punto in bianco.
«No.»
«Bene» commentò. Notando la mia perplessità, continuò. «Intendo solo
che è meglio così. Cercate di conoscerlo attraverso le parole che ha pubblicato. Il suo genio apparteneva a una classe tanto rara, tanto difficile da accettare in questo universo di scribacchini, da spingerlo a credere che, con il
tempo, persino gli amici e i parenti si sarebbero tramutati in nemici. La sua
percezione, spaventata e angosciata a tale riguardo, derivava da un mondo
ostile alle ambizioni letterarie, un'avversione che io avevo subìto di persona in gioventù. L'esistenza di Edgar è stata una serie di esperimenti sulla
sua natura, signor Clark, che l'ha condotto lontano dai movimenti della nostra dimensione, verso la conoscenza esclusiva della perfezione letteraria.
Non possiamo conoscere Edgar Poe come uomo, ma possiamo conoscerlo
bene come il genio che era. Ecco perché nessuno è riuscito a leggerlo con
imparzialità prima che morisse... né io né voi.» Tacque. «Vi sentite meglio
adesso, signor Clark?»
Pensavo con maggiore lucidità e mi ero sbarazzato del vortice di emozioni che prima mi aveva logorato. Rammentavo le mie ultime azioni come se fossero soltanto un sogno, o un ricordo lontano. Ripensando alle
condizioni in cui Neilson mi aveva trovato, arrossii un poco per l'imbarazzo. «Sì, molte grazie. Temo di essere stato in preda alla confusione quando
mi avete scorto in Amity Street.»
«Per favore, signor Clark» ridacchiò, stupito «non potete incolpare voi
stesso per essere stato avvelenato.»
«Come sarebbe a dire?»
«Il medico è sicuro che siate stato vittima di un lieve avvelenamento. Ha
riscontrato tracce di polvere bianca in fondo alla vostra bocca, una sapiente
miscela di varie sostanze chimiche. Non preoccupatevi. Mi ha garantito
che gli effetti stavano per esaurirsi e che dosi così modeste non avrebbero
prodotto danni permanenti.»
«Veleno? Ma chi...» Mi interruppi, intuendo la risposta con improvvisa
chiarezza. I secondini che, con estrema scrupolosità, sostituivano di continuo le caraffe d'acqua sul tavolo della mia cella. Probabilmente era stato
l'ispettore White a impartire quegli ordini, frustrato dai miei ripetuti dinieghi durante gli interrogatori. Voleva ottenebrarmi la mente quanto bastava
per estorcermi una qualche ammissione della mia responsabilità, una confessione delle mie malefatte. In effetti, come mi aveva appena confidato
Neilson Poe, White aveva insabbiato l'indagine che gli avevo chiesto di
avviare. Avrebbe seguitato ad avvelenarmi fintantoché avessi confessato o
fossi morto, oppure mi fossi suicidato. La mia evasione fortuita mi aveva
salvato la vita.
Tutte le follie che avevo compiuto nelle ore successive alla fuga dal penitenziario mi tornarono in mente, colmandomi di vergogna. Mi ero messo
a cercare Poe, scavando nella sua tomba persuaso che fosse vivo, facendo
irruzione nella sua dimora di tanti anni addietro. Non essendo più la persona che aveva compiuto quelle azioni, ora vedevo tutto con maggiore obiettività e comprendevo che cosa era accaduto.
Per un istante, Neilson parve meditabondo e, forse, preoccupato. «Credo
abbiate bisogno di altro riposo, signor Clark.»
«Il fattorino» dissi a un tratto. «Il fattorino cui avete accennato, quello
che vi ha aiutato a trasportarmi e che poi è tornato con il medico. Dov'è?»
Nella casa, non avevo veduto nessuno all'infuori dei bambini.
Neilson esitò. Udii un nuovo suono, inconfondibile e sempre più vicino.
Cavalli che percorrevano di gran carriera le strade bagnate, seguiti dagli
schizzi delle ruote di una carrozza.
Il mio ospite alzò la testa. «Sono un membro del foro, signor Clark» affermò. «Vi siete sottratto alla giustizia, e io ho fatto il mio dovere informando la polizia della vostra presenza. Ho una responsabilità. Tuttavia,
chissà perché, ho la netta impressione che soltanto voi siate in grado di riscattare il mio nome e la memoria del mio sfortunato parente. Se vorrete,
sarò lieto di difendervi in tribunale.» Mi paralizzai. «Ricordate, signor
Clark, anche voi eravate un avvocato. Avete un dovere a cui far fede.»
Si piazzò con lentezza dinanzi alla porta, ed ero così debole che probabilmente mi avrebbe sopraffatto prima che il fattorino arrivasse con la polizia.
«I bambini» aggiunse all'improvviso. «Non giudicatemi troppo severo,
signor Clark, ma devo controllare che stiano dormendo.»
«Capisco» replicai, annuendo con gratitudine.
Quando imboccò il corridoio verso le scale, mi precipitai fuori della
stanza senza voltarmi.
«Che Dio vi protegga» mi urlò.
La mia missione era chiara. Avrei cercato Auguste Duponte. Soltanto lui
avrebbe potuto fornire le prove inequivocabili della mia innocenza. Ora
che Bonjour mi aveva rivelato di non avergli fatto alcun male, il solo pensiero di quanto potesse essere vicino mi infuse una sensazione di invincibilità che mi spinse rapidamente attraverso le vie allagate di Baltimora. Forse Duponte aveva già cominciato a indagare sulla sparatoria ai danni del
barone. Forse si era persino recato nella sala delle conferenze quella sera,
prima che scoppiasse il caos, aveva assistito al tentato omicidio ed era
scappato, immaginando i guai che ne sarebbero scaturiti.
Dovevo innanzi tutto riabilitarmi agli occhi di Hattie, giacché aveva continuato a offrirmi la sua amicizia per tutto il periodo della detenzione, mentre gli altri mi avevano abbandonato. Magari vi sembrerà una cosa di poco
conto rispetto al fatto che sarei potuto finire sulla forca e che, in ogni caso,
lei stava per sposare un altro uomo, ma ora il mio obiettivo era riabilitarmi
ai suoi occhi.
Non mi sarei asciugato del tutto per giorni; le mie orecchie, i miei polmoni e le mie viscere seguitarono a sciaguattare per molto tempo dopo
che, arrancando, ebbi guadato le insidiose strade di Baltimora. Era come se
l'Atlantico fosse straripato e si apprestasse a congiungersi con il Pacifico.
Rintracciai Edwin, che mi fornì un cambio di biancheria e un abito modesto. Espresse il desiderio di darmi una mano a nascondermi dalla polizia.
Aveva portato fagotti di vestiti in un conservificio deserto che una volta
apparteneva alla società di mio padre, dove mi rifugiai ricordando che il
cardine di una porta era rotto da anni.
«Mi hai aiutato abbastanza, Edwin» dissi «e non voglio mettere ulteriormente a repentaglio la tua sicurezza. Ho procurato a tutti guai sufficienti per una vita intera.»
«Avete fatto quello che ritenevate giusto, avete messo in gioco la vostra
esistenza» replicò. «Poe è morto. Hanno sparato a un uomo. Il vostro amico è scomparso. E tante persone hanno sofferto. Dovete restare incolume
almeno voi, cosicché vi sia qualcuno che conosca la verità.»
«Non voglio che ti accusino di aver commesso un crimine per avermi
aiutato» insistetti. Era una questione seria. Se un nero libero veniva incolpato di un reato grave, le autorità potevano punirlo nel modo peggiore che
si potesse immaginare: rigettarlo in schiavitù.
«Non sono tanto pauroso da farmela addosso per così poco.» Scoppiò in
una delle sue risate rassicuranti. «Inoltre, penso che neppure Baltimora abbia mai punito qualcuno per aver regalato qualche vecchio straccio a un
uomo cencioso. Ora, ve la sentite di trascorrere la notte qui?»
Continuò a farmi visita con regolarità allo stabilimento. Benché la tentazione fosse forte, rinunciai a contattare Hattie, temendo di metterla in pericolo. Uscivo molto di rado, e non mi arrischiavo ad avvicinarmi a Glen
Eliza per paura che qualcuno mi vedesse. Avevo ancora con me il «Graham's» del 1841 che tenevo in mano allorché ero fuggito dalla dimora di
Neilson Poe, il giornale in cui Dupin aveva fatto la sua prima comparsa
negli Assassinii della Rue Morgue. Lo conservavo come se fosse un amuleto. Rileggevo il racconto, domandandomi che cosa Duponte potesse aver
scoperto riguardo al tentato omicidio del barone. Per il momento, quella
rivista era tuttavia l'unica cosa che avessi da leggere. Perciò lessi anche le
altre pagine, sebbene il periodico fosse vecchio di dieci anni.
Una volta, Edwin si presentò all'ora concordata e mi trovò intento a fissare il «Graham's».
«Tutto bene, signor Clark?»
Non riuscivo a smettere di leggere quelle righe, di leggerle e rileggerle.
Non so come descrivere la mia straziante scoperta di quella sera. Mi riferisco alla verità sul conto di Duponte... o meglio, di Dupin (vedete, stento a
credere a ciò che appresi, non so da dove cominciare), al fatto che Duponte
non era mai stato il vero Dupin.
Dopo aver letto più volte gli appunti del barone durante la mia permanenza alla centrale del Middle District, e aver imparato a memoria ogni
singola parola, avevo gettato le pagine nel fuoco che riscaldava il corridoio
tra le celle degli uomini e quelle delle donne. Non avevo assassinato Claude Dupin, ovviamente, ma ero stato felice di uccidere la sua opera. Dopo
tutto quanto era accaduto, la possibilità che le sue frottole sulla morte di
Poe si diffondessero era un rischio inaccettabile.
Non che le sue frasi non fossero convincenti: in verità lo erano eccome,
ma non erano la verità. L'esatto contrario di Poe, che scriveva soltanto la
verità, anche quando pochi erano disposti a credergli. Ma torneremo più
tardi alle teorie del barone sul decesso del poeta. Nelle sue annotazioni,
Claude Dupin aveva anche colto l'occasione per ribadire di essere il vero
Dupin.
Ecco qui un esempio: «Conoscete il Dupin di questi racconti come un
individuo schietto, sagace, temerario. Il signor Poe, devo ammetterlo, ha
riscontrato quelle doti osservando le mie umili incursioni nella proclamazione della verità [...]. Infatti, è questo che Dupin fa veramente, giusto? In
un mondo in cui la verità viene nascosta da ciarlatani e imbroglioni, da
lord e re, Dupin la scopre, la conosce e la dice. Ma coloro che dicono la
verità, amici miei, si scontreranno sempre con lo scherno, l'indifferenza e
la morte. Ecco dove abbiamo trovato Edgar... no» qui avevo immaginato il
barone che scrollava il capo con mestizia, magari con una lacrima melanconica che gli sgorgava dall'angolo dell'occhio, «ecco dove abbiamo perduto Edgar Poe. Edgar Poe non se n'è andato, ma l'hanno condotto via...».
Orbene, prima dell'arrivo di Edwin, mentre sedevo nella piccola pozza di
luce del magazzino deserto, avevo raccolto la copia del «Graham's». Che
fortuna, per la rivista, collaborare con Poe all'epoca, avevo pensato, perché
non solo vi pubblicava i suoi racconti, ma ne era anche il direttore. Poi il
mio pollice si era fermato su una pagina in particolare. Avevo aguzzato la
vista. Non era nemmeno una di quelle che avevo intenzione di leggere.
Nello stesso numero in cui erano comparsi Gli assassinii della Rue
Morgue, in quello stesso numero dell'aprile 1841, il direttore del periodico,
ossia Poe, aveva recensito un volume intitolato Sketches of Conspicuous
Living Characters of France, una collezione di bozzetti biografici incentrati su una serie di illustri personalità francesi. Il saggio che aveva attirato
la mia attenzione era quello dedicato a George Sand, la celebre romanziera. Non so come mi fosse tornato in mente (forse l'avevo letto tempo addietro in un articolo o in un libro), ma, chissà come, mi era sovvenuto che
il nome della scrittrice, tramutato nel maschile George Sand per consentirle di pubblicare le sue opere senza esporsi ai pregiudizi, era Amandine Lucie-Aurore Dupin. Nella recensione, Poe si era divertito a descrivere una
scena in cui madame Sand/Dupin si era travestita da uomo, indossando una
finanziera e fumando un sigaro.
Mi ero soffermato su un altro nome presente nell'articolo: Lamartine.
Forse non vi dirà nulla, giacché dubito che ricordiate la sua reputazione di
poeta e filosofo parigino. Ma guardate qui. Tornai agli Assassinii della Rue
Morgue:
Siamo arrivati al vicoletto detto Lamartine, che è stato pavimentato, per fare una prova, con un sistema nuovo di blocchi incastrati e inchiodati.
Era forse una coincidenza che Poe avesse usato il nome di un altro eminente scrittore francese sia nel suo primo racconto del raziocinio sia nella
recensione? Non fermatevi. Continuate a leggere la Rue Morgue, concentrandovi sulla descrizione che il narratore fornisce di uno dei testimoni degli efferati omicidi:
Paul Dumas, medico, depone di essere stato chiamato all'alba per
esaminare i cadaveri.
Quel Dumas non dovrebbe forse rievocare Alexandre Dumas, il fanta-
sioso creatore francese di storie sentimentali e avventurose? E poi vi era
questo:
Isidoro Muset, gendarme, depone di essere stato chiamato verso
le tre del mattino.
Già, un nome molto simile a quello di Alfred de Musset, poeta francese
e intimo compagno di George Sand.
Probabilmente avrete già intuito la conclusione ormai ovvia. La mia
mente aveva preso a vorticare senza posa. In realtà, Gli assassinii della
Rue Morgue (riesco quasi a udire Poe che ridacchia furbescamente all'idea
del vero segreto di quel racconto) erano stati concepiti come allegoria
dell'attuale stato della letteratura francese. Le allusioni a George Sand (anche conosciuta come Dupin), Lamartine, Musset e Dumas erano le più palesi di una rete di riferimenti discreti e ingegnosi.
Se era così - e all'improvviso ne avevo avuto la certezza -, Poe non aveva preso spunto da alcun investigatore in carne e ossa per inventare il suo
eroe, non si era ispirato a Auguste Duponte né al barone Claude Dupin,
bensì aveva usato solo la sua fantasia e le sue riflessioni sulle diverse personalità letterarie. Quando me n'ero avveduto, avevo trovato il coraggio di
recarmi a una bancarella e fare incetta di libri; avevo scoperto non solo che
il mio ricordo riguardo al vero nome di George Sand era corretto, non solo
che il suo vero nome era Dupin, ma anche che, da piccola, aveva perduto
un fratello che si chiamava (sì, ma probabilmente l'avrete già indovinato)
Auguste Dupin. Poe era a conoscenza di quel dettaglio? Quale messaggio
aveva voluto trasmetterci? Aveva ricreato il compianto fratello della scrittrice sotto forma di un genio che sfidava la morte e la violenza. Il povero
Edgar aveva forse pensato a suo fratello, William Henry, da cui era stato
diviso quando era solo un bambino?
Rileggendo con foga la Rue Morgue, avevo colto un nuovo significato
nelle parole con cui il narratore descrive la sua convivenza con C. Auguste
Dupin: Non ammettevamo visite. Avevamo anzi tenuto segreto il ricovero
alle mie conoscenze di prima; quanto a Dupin egli aveva da molti anni
cessato di frequentare gente, e non era più conosciuto a Parigi. Esistevamo per noi soli. Poe non aveva forse tentato di suggerircelo? Lo straordinario analista era esistito soltanto nell'immaginazione del poeta.
Il nostro giornale è stato informato da un'«amica» del brillante
ed eccentrico scrittore Edgar A. Poe che C. Auguste Dupin, il
perspicace eroe creato dalla penna del signor Poe, ricorda da vicino un individuo in carne e ossa, a lui simile nel nome e nelle
imprese, famoso per le sue formidabili capacità analitiche [...].
Con la vista annebbiata e un fremente disprezzo, avevo ripensato a quel
servizio giornalistico, quello che John Benson aveva consegnato al bibliotecario e che quest'ultimo aveva poi spedito a me. Com'erano vaghe quelle
frasi, quei pettegolezzi volubili che mi avevano ingannato. Chi era
quell'«amica» di Poe? Come facevano a sapere che era affidabile? Era esistita davvero? Mi ero arrovellato alla ricerca delle risposte a quei singolari
quesiti, ma, per tutto il tempo, l'innegabile realtà mi aveva posseduto come
uno spirito maligno. «Duponte non era altro che un'invenzione, Poe è morto, e morirai anche tu. Salirai la scala della forca e morirai per aver desiderato più di quanto avessi già» mi era parso che dicesse.
Duponte non esisteva più.
«Clark, state male? Forse dovrei accompagnarvi da un dottore.» Edwin
cercava di riscuotermi dalla mia trance.
«Edwin» ansimai, riuscendo a balbettare solo questo commento bizzarro: «Sono quasi morto».
Dovrei aggiungere qualcos'altro, a mo' di intermezzo, riguardo all'accadimento che aveva dato inizio a ogni cosa: la scomparsa di Poe. Sostengo
da diversi capitoli di conoscere per intero il testo della conferenza di Claude Dupin sull'argomento, e sarebbe gretto, da parte mia, nasconderlo ulteriormente al lettore. Come ho detto, ricordo ogni parola dei suoi appunti.
«"Reynolds! Reynolds!" Questo grido ci risuonerà nelle orecchie fintantoché rammenteremo Edgar Poe, giacché quella fu la sua parola d'addio.
Tanto valeva che dicesse semplicemente: "Ecco come sono morto, signore.
Ecco come sono morto, amici che soffrite come me su questa Terra. Ora
scoprite il perché...".»
Anche se il resoconto del barone sarebbe stato deleterio per la verità, in
un certo senso rimpiango che non abbia pronunciato pubblicamente la sua
allocuzione. Ora, infatti, non potrete farvi un'idea precisa di come sarebbe
stato: Claude Dupin che andava avanti e indietro sul palco come, in tempi
migliori, aveva fatto nelle aule di tribunale. Immaginate il barone che sfoderava il suo consueto sorriso smagliante, allargando le mani e annunciando la soluzione del mistero.
Capitolo 29
Poe era giunto a Baltimora nel momento sbagliato. Non era sua intenzione visitare la città, giacché era deciso ad andare a prendere la sua povera suocera nella casetta di New York e a cominciare una nuova vita. Durante il viaggio in nave da Richmond a Baltimora, alcuni furfanti lo avevano tuttavia aggredito, e probabilmente anche derubato, sicché Poe aveva
perduto il treno diretto a nord. Ciò è dimostrato dal fatto che aveva guadagnato del denaro tenendo alcune conferenze a Richmond, ma che è stato
rinvenuto senza un soldo soltanto qualche giorno dopo. Bloccato a Baltimora, si era avveduto che i ladri lo pedinavano e aveva cercato di rifugiarsi
nella dimora di un caro amico, il dottor N. C. Brooks, direttore di vari periodici. Nondimeno il dottor Brooks non era in casa, e quei codardi, non
essendone al corrente, e temendo che lo scrittore riferisse le loro malefatte
a qualcuno degli occupanti, avevano appiccato un incendio che per poco
non aveva distrutto l'edificio. Poe era scampato per un pelo.
Il poeta aveva quattrini sufficienti per una stanzetta all'hotel United States, ma non per prendere un altro treno per New York o Filadelfia, dove lo
attendeva un redditizio lavoro letterario. La sua nuova rivista, che si sarebbe chiamata «The Stylus», avrebbe inaugurato una nuova era di genio per
le lettere americane, ma i suoi nemici volevano impedirgli di denunciare la
mediocrità dei loro scritti. Poe aveva pertanto cominciato a usare un nome
fittizio, E. S. T. Grey. Aveva persino pregato la sua dolce suocera, la sua
affezionata protettrice, di scrivergli a quel nome a Filadelfia «poiché temo
di non ricevere la lettera», giacché aveva paura che i suoi avversari avrebbero cercato di intercettare qualsiasi missiva di incoraggiamento e qualsiasi sottoscrizione alla sua audace impresa. Non desiderava nemmeno che
sapessero della sua partenza per Filadelfia, certo che avrebbero interferito
con il suo incarico e vanificato il tentativo di raccogliere fondi per il giornale.
Si era ritrovato intrappolato a Baltimora durante un'animata settimana
elettorale. Poe era un uomo di lettere. Era al di sopra di tutto ciò. Era al di
sopra delle azioni penose e meschine della politica e dell'individuo normale. Per il mascalzone comune, il grande genio è tuttavia una mera quisquilia.
Poe era una preda facile. Viaggiava sotto il suo nuovo pseudonimo, E. S.
T. Grey. La sera precedente alla giornata elettorale, fra il tempo orribile
che aveva flagellato la città quella settimana, qualcuno l'aveva rapito dalla
strada. Così è iniziato l'assassinio di Poe, forse uno degli assassini più lunghi della storia dei letterati, senza dubbio il più patetico. Il più triste da
quando il poeta Thomas Otway fu soffocato da qualche briciola di pane, il
più iniquo da quando Marlowe fu pugnalato alla testa, nell'organo stesso
del suo genio; e tutto ciò ha tramutato Edgar Poe nell'uomo più denigrato
dall'epoca di Lord Byron.
Cosa ancor peggiore, i familiari di Edgar Poe, le persone che avrebbero
dovuto tutelarlo, erano tra coloro che ne avrebbero fatto un bersaglio e una
vittima. Un certo George Herring, che forse siede tra noi oggi, presiedeva i
whig della quarta sezione, e Poe è stato rinvenuto all'hotel Ryan, il luogo
in cui quel gruppo si riuniva. George Herring era parente stretto di Poe
[qui il barone aveva preso un abbaglio, giacché Henry Herring era uno zio
acquisito di Poe, ed era Henry, non Edgar, a essere imparentato con George Herring, ma lasciamolo proseguire...] e, in quanto tale, sapeva che il
poeta era vulnerabile. Non è stata una coincidenza, gentili protettori del
genio, che Henry Herring sia stato tra i primi ad accostarsi a Poe allorché
si è diffusa la notizia del suo malore, tanto che il dottor Snodgrass si è meravigliato di imbattersi in Henry Herring ancor prima di mandarlo a chiamare. Gli Herring avevano infatti designato Poe come vittima. Lo conoscevano; per loro non era «E. S. T. Grey». Avendo appreso da Henry che
Edgar era imprevedibile quando veniva costretto ad assumere alcolici o altre sostanze intossicanti, George Herring aveva stabilito che era un soggetto abbastanza indifeso da far parte della sua grama «nidiata» di elettori.
Sapendo che probabilmente Poe avrebbe risentito di gravi effetti collaterali, George ha poi convocato Henry affinché costui accompagnasse Edgar
all'ospedale per evitare guai ai whig della quarta sezione. Henry Herring,
lo sappiamo, nutriva ancora dell'astio nei confronti di Poe perché quest'ultimo aveva cercato di corteggiare sua figlia Elizabeth con alcune poesie
d'amore durante la giovinezza, nel periodo in cui Poe viveva a Baltimora.
Quella è stata la meschina vendetta di Henry Herring per una manifestazione di affetto puro e giocoso da parte di un giovane poeta.
Quei manigoldi dei whig della quarta sezione, il cui quartier generale era
la rimessa delle autopompe della Vigilant Fire Company, di fronte al
Ryan, hanno chiuso il poeta inerme in una cantina insieme con altri sventurati: vagabondi, perdigiorno e forestieri. Ciò spiega come mai Poe, un
autore assai famoso, non sia stato veduto da nessuno nel corso di quei
giorni. Probabilmente quei bricconi l'avevano drogato con vari oppiacei.
Durante la giornata elettorale, l'hanno condotto in giro per la città, in vari seggi. L'hanno obbligato a votare per i loro candidati in ciascun seggio e,
per rendere più convincente l'intera farsa, l'hanno costretto a indossare abiti diversi ogni volta. Ciò spiega come mai, al momento del suo rinvenimento, portava vestiti sudici e cenciosi che non erano mai stati destinati a
lui. Quelle canaglie gli hanno tuttavia permesso di tenere la sua bella canna
di Malacca, giacché le sue condizioni erano così debilitate che persino quei
furfanti si sono avveduti che avrebbe necessitato di un sostegno. Poe era
entrato in possesso di quel bastone scambiandolo appositamente con quello di un vecchio amico di Richmond (che celava al suo interno una spada)
dal momento che gli erano sovvenuti i tanti detrattori che, in passato, l'avevano talvolta sfidato a duello o bistrattato in altro modo. Quando si accorse del pericolo che correva qui a Baltimora, era però troppo debole persino per sfoderare la lama, benché non l'abbia mai abbandonata. Anzi, l'avrebbero trovato con la canna stretta al petto.
A causa del tempo inclemente, che aveva tenuto le persone lontane dalle
strade, il circolo politico non aveva radunato tutte le vittime che aveva sperato. Avevano persino catturato un illustre funzionario dello Stato della
Pennsylvania mentre si recava dal teatro all'hotel Barnum, ma gli avevano
consentito di fuggire allorché avevano scoperto che era un pezzo grosso.
Così hanno seguitato a usare Poe, più del consueto, e quando i suoi aguzzini l'hanno portato al seggio della quarta sezione, allestito nella taverna
del Ryan, affinché votasse ancora, aveva ormai subito troppe angherie.
Dopo aver prestato giuramento dinanzi a uno dei segretari, un certo Henry
Reynolds, non è riuscito ad attraversare la stanza ed è stramazzato al suolo.
Ha chiamato il suo amico, il dottor Snodgrass, che è arrivato colmo di disgusto. Snodgrass, il leader delle leghe antialcoliche locali, era sicuro che
Poe avesse esagerato con i liquori. I furfanti politici, che ormai avevano
abbandonato il loro prigioniero, erano lieti che quella supposizione nascondesse il loro turpe gesto. L'intransigente Snodgrass non sarebbe stato
neppure l'ultimo a commettere quell'errore grossolano. Ben presto tutto il
mondo avrebbe creduto che la fine del nobile Poe fosse stata la conseguenza di una debolezza morale.
Ma ora la Verità torna da noi.
Poe, privato del sonno e sotto l'effetto di massicce dosi di droga, non era
in grado di spiegare alcunché; e nella parte ancora lucida della sua mente,
il poeta malconcio ha senz'altro subito un duro colpo allorché ha veduto
Snodgrass, il suo presunto amico, che lo guardava dall'alto in basso con ri-
provazione e con qualcosa di assai simile al disprezzo. L'hanno caricato su
una vettura a nolo e l'hanno spedito da solo all'ospedale. Lì, sotto le attente
cure del dottor J. J. Moran e delle sue infermiere, ha continuato a scivolare
dentro e fuori dall'incoscienza. Rammentando, come in una visione indistinta, il suo tentativo di celare il proprio genio ai suoi detrattori mediante
il vago nome di E. S. T. Grey, ha rivelato deliberatamente al buon dottore
il meno possibile riguardo a se stesso e agli scopi dei suoi viaggi. La sua
mente, tuttavia, era debole. A un certo punto, ricordando senza dubbio il
tradimento di Snodgrass, il poeta ha urlato che la cosa più bella che il suo
miglior amico potesse fare sarebbe stata fargli «saltare il cervello con una
pistola».
Pensando all'unico uomo che forse aveva notato la sua situazione in
tempo per fermare le azioni degli assassini (quel segretario di seggio,
Henry Reynolds, che, meccanicamente, aveva fatto prestare giuramento a
tutti gli elettori), Poe l'ha invocato con grida disperate, come se potesse ancora chiedere il suo intervento. Reynolds! Reynolds! L'ha ripetuto per ore,
ma non è stata tanto una richiesta d'aiuto quanto un rintocco funebre. Senti? Suonano a martello / qual novello di terror racconto fanno. La vita di
Poe è così giunta alla sua turbolenta fine.
Ecco. Ora siete gli unici ad aver udito un discorso che non è mai stato
pronunciato, ad aver ascoltato ciò che il barone Dupin avrebbe affermato
per entusiasmare il suo pubblico quella sera. Era un discorso che, sebbene
ne avessi ridotte le pagine in cenere con alacrità, mi sarei apprestato a tenere dinanzi al mondo intero di lì a poco.
Capitolo 30
Il terzo giorno dopo che ebbi scoperto gli indizi contenuti nel vecchio
«Graham's», Edwin si avvide che avevo il morale a terra. Mi sentivo più
avvelenato di quando Neilson Poe mi aveva raccolto dinanzi al numero 3
di Amity Street, ma, anziché il mio sangue, adesso erano la mia anima e il
mio cuore a essere stati infettati.
Edwin tentò di persuadermi a rintracciare Duponte per chiedergli aiuto.
Ma non conoscevo più Duponte. Chi era, che cos'era? Forse, pensai, Poe
non aveva mai nemmeno sentito nominare il mio Duponte. Ogni verità era
stata capovolta. Forse, fintantoché vi era riuscito, era stato Duponte a rubare, in maniera intenzionale e meticolosa, parte di quel personaggio dai rac-
conti di Poe, e non viceversa. Ora si nascondeva perché aveva capito di
non poter interpretare il ruolo che aveva immaginato. Non mi era mai sovvenuto, in tutto il tempo che avevamo trascorso insieme, che la sua potesse
essere una reazione morbosa alla letteratura, anziché una fonte di ispirazione per un autore? Suppongo che la soddisfazione di averlo aiutato a uscire dal suo isolamento parigino mi avesse spinto a negare qualsiasi dubbio sopito. Ormai non aveva più importanza, era un dettaglio irrilevante.
Ero solo.
L'acqua si ritirò intorno al conservificio e, allorché le strade circostanti si
fecero più affollate, Edwin mi consigliò di cercarmi un altro rifugio. Prenotò una stanza in una pensione fuori mano nel quartiere orientale della
città. Concordammo l'orario in cui incontrarci affinché mi accompagnasse
nel mio nuovo nascondiglio su un carro traboccante di pile di giornali da
consegnare. Alla fine, la perdita di Duponte mi turbò tanto che arrivai in
ritardo.
Avevo pregato Edwin di portarmi altri racconti di Poe. Avevo letto e riletto le tre storie di Dupin ogni volta che vi era luce sufficiente nello stabilimento. Se non esisteva nessun vero Dupin, nessun individuo il cui genio
avesse indotto Poe a plasmare quel personaggio, perché vi avevo creduto
con tanto fervore? Mi ero ritrovato dapprima a copiare alcune frasi in ordine sparso, e poi, senza nessuno scopo particolare, a trascrivere gli interi
racconti parola per parola, come se volessi tradurli in una forma utilizzabile.
Poe non aveva scoperto Dupin negli articoli dei giornali parigini, l'aveva
scoperto nell'anima del genere umano. Ora non saprei descrivere meglio
quanto era accaduto nello scompiglio della mia mente. Avevo meditato su
ciò che Neilson Poe aveva affermato, ossia che il significato di Edgar non
era racchiuso nella sua vita, nel mondo esterno, bensì nelle sue parole, nelle loro verità. Dupin esisteva. Esisteva nei racconti, e forse la verità di Dupin era racchiusa in tutte le nostre capacità. Dupin non era tra noi; era dentro di noi, un'altra parte di noi, una versione plurale di noi stessi, più forte
di chiunque potesse mostrare una lieve somiglianza con lui nel nome o nei
lineamenti. Avevo ripensato a quella frase degli Assassinii della Rue
Morgue: Esistevamo per noi soli.
Trovai Edwin che mi aspettava.
«Per fortuna state bene» disse, stringendomi la mano. «Stavo per setacciare la città alla vostra ricerca. Datemi quel cappotto e infilatevi questo.»
Mi porse un vecchio soprabito color sale e pepe. «Forza, sbrighiamoci ora.
Ho preso in prestito un carro per andare alla pensione. Non c'è un minuto
da perdere.»
«Grazie. Ma non posso fermarmi, amico mio» replicai, ricambiando la
stretta. «C'è una persona che devo vedere subito.»
Aggrottò le sopracciglia. «Dove?»
«A Washington. Vi è un tale di nome Montor, un ministro francese, che
tempo fa mi ha parlato di Duponte per la prima volta e mi ha dato qualche
consiglio per il mio viaggio a Parigi.»
Feci per incamminarmi, quando Edwin mi sfiorò il braccio.
«È un uomo di cui potete fidarvi, signor Clark?»
«No.»
Henri Montor, l'emissario francese a Washington, era preoccupato. In
patria, i repubblicani rossi e i loro seguaci si lamentavano con maggiore
veemenza. Il grido «Vive la république!» riecheggiava nelle piazze pubbliche. I parigini divenivano irrequieti se passavano troppi mesi senza battaglie politiche, pensò Montor, sicché ora si ribellavano a Luigi Napoleone. I
risultati sarebbero potuti essere catastrofici.
Non saltate alle conclusioni. Henri Montor non nutriva alcun affetto particolare per Luigi Napoleone (il principe presidente, un prodotto viziato e
arrogante della fama, che in passato aveva compiuto due tentativi vani e
stupidi di impadronirsi del potere), ma amava la propria posizione e non
voleva che subisse modifiche. A piacergli non era Washington, con il suo
cibo tiepido anche nelle sale da pranzo degli hotel più lussuosi (persino le
torte di granturco erano solo «calde», e non bollenti), bensì il fatto di essere l'emissario in un Paese straniero.
Leggeva tutti i giornali francesi disponibili a Washington (se ricordate,
era assorto nello svolgimento di quell'attività allorché, molto tempo addietro, un giovane di Baltimora intento a esaminare gli articoli su Auguste
Duponte aveva destato il suo interesse). Osservò che, negli ultimi tempi, vi
era un maggior numero di periodici francesi tanto audaci da prendere di
mira il principe presidente, anche se con allusioni velatissime. Ora Napoleone aveva ordinato al prefetto e alla polizia di chiudere le sedi delle pubblicazioni riluttanti a collaborare. Che cosa temevano davvero Napoleone e
i suoi consiglieri? Che cosa credevano che avrebbero fatto i rivoluzionaristi? Quale piano grandioso avrebbero potuto escogitare, ormai? La Francia
era già una repubblica. Avrebbero potuto eleggere qualcuno di diverso da
Luigi Napoleone. Forse, prima, avrebbero tuttavia potuto indebolire il suo
ruolo quanto bastava affinché un nemico esterno ne approfittasse... No,
monsieur Montor non immaginava il vero piano più di quanto facessero gli
altri. Eppure, era sempre in pensiero per gli accadimenti sugli ChampsÉlysées.
Aveva anche preoccupazioni più minute, locali. Vi era un francese morto in una sparatoria nella vicina Baltimora. Secondo alcuni, era quel riprovevole avvocato dei mascalzoni, il vanitoso «barone» Claude Dupin, che
aveva vissuto a Londra. Barone di cosa? Non aveva importanza, quello
stolto era senza dubbio coinvolto in qualche malefatta. Ma era francese, e
il sindaco di Baltimora aveva scritto a monsieur Montor comunicandogli
l'accaduto.
Ciò era avvenuto, tuttavia, già alcune settimane addietro, e Montor non
ci stava neppure pensando quella sera. Pensava soltanto al sonno. Aveva
due grandi piaceri nella vita e, a sua discolpa, nessuno dei due riguardava
superficiali questioni di denaro o potere. Questa caratteristica lo distingueva da uomini come i ministri del principe. Come abbiamo già accennato,
Montor amava soprattutto intrattenere i forestieri e godere della loro ammirazione, e inoltre amava dormire, per molte ore di seguito.
Poi vi era stato uno dei suoi incontri con quel giovanotto nella sala di
lettura. Montor gli aveva parlato con entusiasmo di Duponte. Non rammentava l'ultima volta che aveva sentito narrare una delle sue straordinarie
imprese, ma non importava. Lo sconosciuto era così affascinato che il
francese non aveva voluto dissuaderlo dal suo studio. Era capitato qualche
tempo addietro, quasi sei mesi prima, e Montor, che aveva la fortuna di
avere la memoria corta, ricordava solo vagamente quel tale e le loro numerose conversazioni. Fino a quella sera, quando rincasò. Gli occorse un istante per accorgersi di quanto fosse strano che il fuoco scoppiettasse già
nel camino, e un altro per notare qualcuno seduto al suo tavolo.
«Chi...? Che cosa...?» farfugliò. «Chi vi ha aperto, signore, e che cosa
desiderate?»
Nessuna risposta.
«Griderò "Al ladro"...» minacciò, prima di intimare: «Ditemi come vi
chiamate».
«Non mi riconoscete?» chiese l'altro in un francese impeccabile.
Montor strizzò gli occhi. In sua difesa, bisogna ammettere che la luce
era fioca, e l'aspetto del suo visitatore, alquanto spaventoso e macilento.
«Sì, sì» balbettò, pur non rammentando il nome. «Quel giovane di Baltimora... ma come avete fatto a entrare?»
«Ho parlato con il vostro domestico, in francese, e gli ho detto che avevamo un'importante riunione governativa privata. Gli ho ordinato di tornare fra due ore e l'ho pagato per il suo disturbo.»
«Non avevate il diritto di...» Sì. Ora Montor rammentava quel volto.
«Ricordo. Ci siamo conosciuti nella sala di lettura, studiando i giornali
francesi. Vi ho aiutato con la lingua e vi ho portato un poco in giro. Quentin, giusto? Cercavate il vero Dup...»
«Quentin Hobson Clark. Sì, è tutto esatto.»
«Benissimo, monsieur... Clark.» Ormai il motore della mente di Montor
si era acceso. «Devo invitarvi a lasciare subito la mia proprietà.»
L'emissario si era spaventato all'idea di avere un intruso nella sua dimora, sebbene si trattasse di un vecchio conoscente dall'aria tanto innocua. Si
era spaventato anche all'udirne il nome, Quentin Clark. Non lo rammentava dai tempi della sala di lettura. Ma ne aveva un altro ricordo, più recente.
Gli ci vollero alcuni minuti per emettere un qualsiasi suono, e quando vi
riuscì, fu un semplice sussurro: «Assassino! Assassino!».
«Monsieur Montor» ripresi quando si fu finalmente calmato. «Credo
sappiate tutto del barone Dupin.»
«Voi...» fece. «Ma voi...» Alla fine, riuscì a spiegarmi di aver ricevuto
un telegramma che mi definiva come il presunto colpevole del tentato omicidio di un francese.
«Sì. Sono io. Ma non ho sparato a nessuno. Tuttavia, penso siate a conoscenza di qualcosa che possa aiutarmi a scoprire chi è stato.»
Ora sembrava più restio a mettersi a urlare. «Aiutarvi? Dopo che vi siete
introdotto in casa mia e avete corrotto il mio domestico? Perché state facendo tutto questo?»
«Soltanto per la verità. Mi hanno costretto a cercarla con le maniere forti, e lo farò.»
«Mi avevano riferito che eravate in carcere!»
«Davvero? E non vi hanno riferito che mi hanno imbottito di veleno per
convincermi a confessare?»
«Non so cosa vogliate che vi dica, monsieur Clark. Non ho nulla a che
vedere con simili manovre e non ho mai nemmeno conosciuto questo...
questo... cosiddetto barone!» borbottò.
«I tizi che lo pedinavano erano due farabutti francesi. Credo fossero al
servizio di qualcun altro, una persona di grande intelligenza e lungimiranza.» Giacché Bonjour mi aveva assicurato che non potevano lavorare per i
creditori del barone, e giacché le due canaglie avevano parlato di «ordini»,
ero sicuro che vi era sotto dell'altro. «Di certo siete informato sui francesi
che entrano ed escono da questa regione.»
«Non trascorro il mio tempo al porto sbirciando attraverso gli oblò delle
navi, monsieur Clark! Sappiate che la polizia vi cercherà per questa... questa vergognosa violazione di domicilio.» Corrugò la fronte, rammentando
che probabilmente mi stavano già cercando per un reato assai più grave.
«Sembrate molto diverso da quando ci siamo conosciuti, monsieur.»
Torreggiando sopra di lui, lo guardai con freddezza. «Suppongo sappiate
dove si nasconderebbero uomini come quelli, e chi darebbe loro rifugio.
Conoscete tutti i cittadini francesi importanti che risiedono nell'area di Baltimora. Forse individui pericolosi come quei due furfanti si rivolgerebbero
persino a voi.»
«Monsieur Clark, lavoro direttamente per Luigi Napoleone da quando è
divenuto presidente. Se qui vi fossero fuorilegge francesi, e se volessero
nascondersi dalle vostre autorità e dalle nostre, non verrebbero certo da
me. Lo capite, vero? Rifletteteci.» Si avvide che ascoltavo la sua tesi con
gravità, e ora tentò di cambiare argomento per suscitare la mia indulgenza.
«Non vi ho forse aiutato a cercare Auguste Duponte, il vero monsieur Dupin? Già, a proposito... l'avete trovato a Parigi?»
«Tutto ciò non ha nulla a che fare con Auguste Duponte» ribattei, senza
però fare alcun gesto minaccioso, né alcun movimento improvviso nella
sua direzione. Eppure, tremò di paura; la sua convinzione che fossi pazzo e
violento mi invogliò quasi a dimostrargli che aveva ragione.
Non fu neppure necessario obbligarlo a rivelarmi qualunque cosa sapesse. «I Bonaparte!» barbugliò a un tratto.
«Che cosa volete dire?» domandai, irritato.
«A Baltimora» proseguì. «Monsieur Jérôme Bonaparte.»
«Mi avete presentato alcuni Bonaparte al ballo in maschera cui mi avete
condotto prima che partissi per Parigi. Jérôme e sua madre. Ma perché
qualcuno come Jérôme dovrebbe saperne di più riguardo a simili delinquenti? I Bonaparte sono parenti di Napoleone, non è vero?»
«No. Sì. Insomma, Napoleone non li ha riconosciuti. Vedete, mentre il
fratello di Napoleone (il vero Napoleone, l'imperatore intendo)... mentre
questo fratello, a diciannove anni, viaggiava per l'America con l'uniforme
da soldato, ha corteggiato e sposato una ragazza americana, Elizabeth Patterson. L'avete conosciuta al ricevimento... la "regina". Hanno avuto un figlio, battezzato Jérôme come suo padre, ed è quello che avete veduto con
lei, il tale travestito da guardia turca. Quando il bambino era ancora in fasce, l'imperatore Napoleone ha ordinato a suo fratello di lasciare la povera
sposa e, dopo una breve lotta, l'altro ha obbedito. Elizabeth Patterson, ormai abbandonata, è tornata con suo figlio a Baltimora, e quella famiglia
non sarebbe mai più stata riconosciuta dall'imperatore. Da allora, vive separata dal ramo orgoglioso della dinastia.»
«Capisco» interloquii. «Continuate, per favore, monsieur Montor.»
«Vi ripeto che i fuorilegge non si rivolgerebbero a me, un ministro ufficiale del governo, ora che Luigi Napoleone è a capo della repubblica. Ma
simili criminali potrebbero rivolgersi a coloro che sono disaffezionati al
nome di Napoleone. Già.» Gli si sciolse la lingua, e si entusiasmò, quasi
avesse compreso che ormai quella era anche la sua missione. «È possibile,
monsieur!»
«Avete lo stradario di Baltimora?» domandai.
Indicò uno scaffale in corridoio, lanciando un'occhiata furtiva alla finestra e alla porta. I miei quesiti l'avevano distratto per qualche istante, ma
mi accorsi che, nella sua mente, stava preparando una denuncia indignata
da inoltrare alla polizia.
Non aveva importanza. Bloccai il mio indice alla pagina giusta e la
strappai. Potevo ancora raggiungere la stazione prima che le dichiarazioni
di Montor arrivassero alle orecchie della polizia di Washington.
E infatti, il controllore parve non fare caso a me quando salii. Per sicurezza, sedetti nell'ultima carrozza passeggeri, e per avere una visuale migliore, aprii il finestrino accanto al sedile, attirandomi alcuni sguardi malevoli allorché le folate di aria gelida soffiarono all'interno. Un tizio sputò
del tabacco vicinissimo ai miei stivali, ma mi limitai a spostare le gambe.
Mi guardai intorno alla ricerca di eventuali dettagli strani, sforzandomi
di non chiudere gli occhi per più di qualche secondo. A un certo punto,
mentre stavamo superando una svolta, scorsi un bambino che correva lungo la parte anteriore del treno, afferrava con audacia il cacciapietre (l'aggeggio usato per scacciare dalle rotaie animali come pecore, vacche e
maiali) e, aggrappandovisi, si lanciava verso il primo vagone. Mi meravigliai, ma dissi a me stesso che era soltanto un clandestino. Di lì a poco dimenticai l'immagine del ragazzino che penzolava lì davanti e mi appisolai.
Mi destai sussultando allorché il convoglio vibrò con forza e, poco dopo,
iniziò ad avanzare con maggiore lentezza, approssimandosi a un ponte sopra un burrone. Balzai in piedi, e stavo per chiedere che cosa fosse succes-
so, quando origliai un altro uomo che interrogava il controllore e il macchinista. Il primo aveva un'espressione stordita, come se avesse paura persino della sua ombra.
«Il treno ha investito un calesse» dichiarò il secondo con distacco. «Due
signore sono state scaraventate fuori con molta violenza. Il veicolo è andato in mille pezzi.»
Il controllore lo oltrepassò, dirigendosi di corsa verso la carrozza successiva.
«Santo Cielo, signore!» esclamò l'altro passeggero, voltandosi verso di
me per cercare la medesima reazione. Indietreggiando di qualche passo,
controllai la porta del vagone merci agganciato all'estremità del convoglio.
Era chiusa a chiave.
Tenevo gli occhi puntati sul volto del macchinista, tentando di ricordare
se mai avessi udito uno schianto e maledicendomi per essermi assopito.
Quel tipo pareva un po' troppo calmo per aver appena cagionato un terribile incidente, che forse aveva ucciso due donne.
«Il veicolo è andato in mille pezzi» ripeté, assumendo un'aria stizzita
quando si rese conto di averlo già detto.
«Non ho sentito l'impatto» intervenni con disinvoltura. Certo, mi ero addormentato, ma credevo valesse la pena di fare quell'esperimento. Che
mentissero? Che stessero rallentando per permettere alla polizia di salire a
bordo?
«Buffo, signore» bofonchiò il viaggiatore puntiglioso dinanzi a me.
«Nemmeno io ho sentito lo scontro, e tutti dicono che ho l'udito più fino di
Washington!»
Non indugiai oltre. Mi gettai verso l'uscita mentre la locomotiva seguitava a ridurre la velocità.
«Ehi, voi! Fermatevi! Che cosa credete di fare?» mi gridò il macchinista,
afferrandomi il braccio, ma lo allontanai con un vigoroso scossone, e incespicò in una valigia. L'altro tale, in preda alla confusione, fece per bloccarmi, ma si paralizzò quando lesse la determinazione sul mio viso.
Dopo aver spalancato la porta, saltai sulla banchina erbosa lungo i binari
e mi rotolai lungo il fianco del ripido burrone sotto il ponte.
Capitolo 31
In seguito, mi sarei documentato con maggiore precisione sui Bonaparte
e sulla loro tranquilla permanenza a Baltimora nel corso dei decenni. Per
ora, desideravo solo rintracciarli. Ricordavo vagamente i miei genitori che
parlavano dello scandalo scoppiato tanti anni addietro, molto prima della
mia nascita, allorché il fratello di Napoleone aveva sposato Elizabeth Patterson, la giovane più agiata di Baltimora. L'uomo era tornato da tempo ai
lussi dell'Europa. Le persone a cui dovevo domandare se conoscessero le
due canaglie di cui avevo bisogno per scagionarmi erano i discendenti americani del frivolo fratello di Napoleone, il Jérôme Bonaparte che avevo
veduto in costume, la sua famiglia e i suoi alleati.
Per il momento, non nutrivo tuttavia alcun interesse particolare verso la
storia o le ambizioni della famiglia Bonaparte. Quel giorno, la questione
della mia sopravvivenza era troppo pressante.
Quei Bonaparte americani e la loro prole si erano moltiplicati e sparpagliati per Baltimora, conservando molte dimore in tutta la città grazie
all'immensa fortuna dei Patterson e alle somme che la moglie abbandonata
riceveva da Napoleone. La prima casa cui bussai non apparteneva più a loro, ma la cameriera che mi aprì, una paffuta irlandese, riceveva abbastanza
visitatori fuorviati da sapere dove indirizzarmi. Tuttavia, fu solo dopo numerose puntate in diversi quartieri, e vari colloqui con altri domestici, che
trovai la residenza più probabile: un palazzo del nipote del fratello di Napoleone, il pronipote disaffezionato del leggendario imperatore e, secondo
i miei calcoli approssimativi, il cugino dell'attuale presidente francese.
Dopo l'episodio sul treno, ero sicuro di aver eluso i poliziotti di Washington, ma seguitai a procedere con lentezza e metodicità, il che era esasperante per una faccenda così urgente. Era rischioso uscire durante il giorno.
Dopo la fuga dal convoglio, avevo aspettato il calar delle tenebre in un fossato gelido, quindi avevo trovato un passaggio sicuro verso Baltimora su
un carro della posta, accomodandomi tra la paglia sul fondo del veicolo
con alcuni servitori e un venditore ambulante ungherese che, tra gli apparenti spasimi di un sogno, mi aveva sferrato parecchi calci nello stomaco
con uno scarpone chiodato. Il cocchiere aveva viaggiato per tutta la notte
tra pietre aguzze e sentieri accidentati a una velocità paragonabile a quella
di un treno.
Per precauzione, attesi un altro giorno prima di recarmi al successivo indirizzo dei Bonaparte. L'edificio era deserto oppure non vi erano domestici
dal momento che nessuno venne ad aprire quando bussai all'uscio. Notai
tuttavia che la rimessa delle carrozze era aperta e, da fuori, scorsi alcune
sagome attraverso le finestre della casa. Appoggiandomi a un davanzale,
mi premetti contro il vetro e credetti di udire degli uomini che conversava-
no in francese.
Quando la porta si aprì, distinsi due figure con maggiore chiarezza. Riconobbi il farabutto che mi aveva quasi ammazzato da Curlett e il suo socio. Il primo aveva una vistosa benda intorno al braccio che la vettura, cadendo, gli aveva schiacciato.
Un altro tipo, quello più vicino al portone, porgeva del denaro ai due
furfanti, che ben presto si diressero verso la rimessa annuendo. Dal suo
comportamento, si sarebbe detto che il terzo uomo fosse il loro capo. Aspettai finché gli altri due furono spariti, quindi suonai il campanello.
Il tale ricomparve. Era più imponente delle due canaglie. Non più robusto, per essere precisi, ma dotato di una corporatura che, con le spalle perfettamente squadrate, suscitava rispetto anziché semplice paura. Per un attimo, restai immobile mentre attendeva che dicessi qualcosa. Mi guardò
mentre lo fissavo con l'impressione di averlo già veduto.
«Signor Bonaparte» esordii finalmente, reprimendo un sussulto. «Siete
monsieur Bonaparte?»
Scosse la testa. «Mi chiamo Rollin. Il giovane monsieur Bonaparte è via,
a West Point. Volete lasciargli un messaggio?» Era un ordine più che una
domanda, ma rifiutai. Vi era qualcosa nel suo tono che mi insospettiva.
Dopo avergli promesso di ripassare un altro giorno, me ne andai in tutta
fretta, temendo che uno dei due mascalzoni tornasse e mi vedesse lì. Ma
ero ancor più terrorizzato dal terzo uomo, quello che diceva di chiamarsi
Rollin. Si era sollevato piano il cappello per augurarmi una buona serata, e
prima che se lo rimettesse, avevo rammentato con esattezza dove l'avevo
già incrociato. Era stato un incontro così breve, e avvenuto tanto tempo
addietro, quasi dall'altra parte del mondo.
Ricordando quella prima immagine di lui mentre attraversavo la strada,
intuii a poco a poco come erano andate le cose e come si collegavano tutti i
fatti accaduti tra il mio viaggio a Parigi e quell'istante. Come i Bonaparte
avevano finito per essere coinvolti. Come il futuro della Francia dipendeva
davvero da un tentato assassinio perpetrato a Baltimora...
Mentre quei pensieri si affastellavano, camminavo a passo spedito, ma
con una certa sbadataggine, verso un'altra pensione in cui Edwin mi aveva
prenotato una camera dopo il mio ritorno da Washington. A un tratto avvertii un dolore bruciante lungo il dorso. Caddi in avanti, quindi rotolai
sulla schiena. Sopra di me, intravidi un cavallo bianco che si impennava
verso il cielo. L'uomo alto e massiccio sulla sua groppa srotolò la frusta,
questa volta colpendomi il braccio.
«Avvocato Clark, giusto? È strano vedere un signore così perbene ricercato per omicidio.» Era Slatter, il mercante di schiavi, in sella a un bell'esemplare di baio robusto. Cercai di rialzarmi, ma mi sferrò un calcio alla
tempia con lo stivale. Mi contorsi a terra per il dolore, tossendo e sputando
sangue.
Slatter saltò giù e, tenendomi fermo con il suo bastone di mogano scuro,
mi immobilizzò polsi e caviglie con dei ceppi.
«La festa è quasi finita, amico mio. Ho guadagnato duemila dollari
nell'ultimo mese, ma questa sarà una soddisfazione ancora più grande.»
«Non ho sparato a nessuno! E non vi devo alcuna spiegazione!» gridai.
«Ma mi dovevate qualche spiegazione l'ultima volta che ci siamo incontrati, non è vero? Riguardo al vostro giovane amico dai capelli lanosi. No,
a me non dovete alcuna spiegazione. La dovete alla città. Per me è sempre
un piacere aiutare la polizia di Baltimora.» I principali negrieri ricevevano
spesso gli elenchi dei ricercati, giacché molti di quegli uomini e di quelle
donne erano schiavi fuggitivi. «Forse, prima di andare alla polizia, gradirete trascorrere la notte nel mio recinto con i negri che sto per imbarcare.
Sono sicuro che saranno felici di rivedervi. Sappiamo che siete un estimatore dichiarato della loro razza. Magari parlate persino la loro lingua.»
Non riuscendo a liberarmi, non ebbi altra scelta se non incamminarmi
verso il suo recinto mentre mi trascinava dal cavallo con una lunga catena.
Si voltò più volte a guardarmi, e sembrava che provasse gusto nel procedere con lentezza, come se sfilassimo dinanzi a migliaia di spettatori, anche
se, in realtà, le vie buie e allagate erano vuote.
Disperato, tenevo lo sguardo basso, quando udii un rumore di passi. Alzai gli occhi, e suppongo che Slatter mi abbia veduto mentre li sgranavo
per la sorpresa. Girandosi rapidamente, scorse ciò che avevo scorto io: un
uomo che, gridando, spiccava un balzo per atterrarlo. La testa del mercante
urtò il suolo con violenza. La sollevò per un istante, quindi abbassò le palpebre con un gemito. Edwin Hawkins torreggiava sopra di lui, frugandogli
nel cappotto per recuperare le chiavi dei ceppi.
«Santo Cielo!» gridai. «Sono contentissimo di vederti, Edwin!»
Trovate le chiavi, mi liberò. «Signor Clark» disse, interrompendo le mie
esclamazioni di gratitudine «devo tagliare la corda.» Si voltò verso Slatter.
«Non preoccuparti. È svenuto» lo tranquillizzai. «Rimarrà incosciente
per un bel po'.»
«Devo andarmene da Baltimora. Subito, signor Clark. Mi conosceva
quando ero giovane.»
Allora capii. Se Slatter aveva intravisto Edwin, e vi aveva riconosciuto
un uomo che aveva venduto anni addietro, o l'aveva guardato abbastanza a
lungo da ricordarne il volto... il nero non sarebbe solo stato condannato,
ma sarebbe stato ritrasformato in schiavo. «Ti ha veduto?»
«Non lo so, signor Clark. Ma non posso correre il rischio di scoprirlo.
Mi dispiace non potervi più aiutare. Sono certo che troverete le prove di
cui avete bisogno.»
«Edwin.» Lo presi per un braccio. «Se solo non avessi lasciato trapelare
il mio stupore! Non si sarebbe girato, e tu non avresti mai rischiato che ti
vedesse. L'hai fatto per Poe!»
«No. Questo l'ho fatto per voi.» Mi strinse la mano con un sorriso cordiale. «Dimostrerete la vostra innocenza, e quella sarà la mia ricompensa.
Dovete continuare... anche per me, senza esitazioni.»
Assentii. «Vattene subito da qui, amico mio» bisbigliai «e non farti vedere da nessuno.» Scomparve tra le vie.
Incatenai le mani di Slatter, ma gli lasciai le gambe e i piedi liberi cosicché potesse cercare aiuto quando si fosse destato. Non pareva alto come mi
era sembrato in sella; anzi, era un vecchio decrepito steso sul selciato, con
un'espressione vacua e sciocca. Faticai ad allontanarmi. Senza Edwin, mi
sentii solo e sconfortato, e rammentai con nostalgia la consolazione delle
visite di Hattie in carcere, l'arrivo di Bonjour al penitenziario e l'esplosione
di forza che avevo ricevuto da entrambe.
Un pensiero improvviso mi costrinse ad alzarmi. «Bonjour» ansimai.
Udii Slatter che si riprendeva tra una serie di mugolii, ma non mi fermai a
guardarlo. Salii in groppa al baio e mi avviai nella direzione da cui ero venuto.
«Il mio cavallo!» strillò Slatter. «Restituitemi subito il mio cavallo!»
I miei timori si concretizzarono allorché notai la porta spalancata nella
dimora dei Bonaparte da cui mi ero appena allontanato. Dopo aver legato
l'animale a un palo, attraversai l'ingresso con circospezione. L'edificio era
immerso nel silenzio a eccezione di un respiro affannoso. Se vi fossero stati altri suoni, probabilmente non li avrei uditi. La mia mente li avrebbe registrati solo di sfuggita, insieme ai mobili. Ero ipnotizzato.
In salotto, tutto indicava che vi era stata una zuffa solo qualche minuto,
o forse solo qualche secondo, prima che arrivassi. Sedie, tende, lampade e
giornali erano disseminati sul pavimento. Il lampadario oscillava visibilmente. Non vi erano dubbi su chi avesse vinto. Bonjour sovrastava la ro-
busta figura di Rollin, madido di sudore. Dal disordine accanto a una finestra poco distante, era chiaro che l'uomo aveva cercato di fuggire da lì. Pur
essendo forse la metà di lui, Bonjour lo teneva fermo, sfiorandogli la gola
con una lama.
Gli occhi di Rollin incrociarono i miei, e mi domandai se mi avesse riconosciuto anche lui.
Io e Auguste Duponte eravamo sul punto di lasciare Parigi per dare inizio alla nostra indagine sulla morte di Poe quando, poco dopo che ci eravamo imbarcati, l'analista aveva annunciato che vi era un clandestino a
bordo del piroscafo. Lo rammenterete.
«Pregate l'assistente di bordo di riferire al capitano che vi è un clandestino su questa nave» mi aveva ordinato.
«Prima o poi desidererete sapere quello che so io!» aveva urlato l'intruso, Rollin, quando l'avevano catturato e accusato di voler rubare la corrispondenza. Nel suo tono, vi era qualcosa che forse aveva risvegliato i miei
ricordi allorché lo stesso individuo mi aveva chiesto, con una voce troppo
aggressiva: «Volete lasciargli un messaggio?» sulla soglia di casa Bonaparte. Ma più che altro era stato il momento in cui si era sollevato il cappello, rivelando il quadrato calvo che quel giorno, in mare, si era intravisto
per sbaglio quando l'avevano gettato dal parapetto. Era stato quel gesto a
ricordarmi dovevo l'avevo già veduto.
Quando mi imbattei in Bonjour in quella stanza, le implicazioni della
presenza di Rollin sull'Humboldt avevano ormai preso forma nella mia testa. Ma per rispondere al mio precedente quesito: no, non credo che mi avesse riconosciuto. Quel giorno, sulla nave, cercava qualcun altro.
Ora mi fissava, gli occhi che ardevano di curiosità spettrale, le gambe
bagnate e costellate dei petali che si erano sparpagliati sul tappeto con i
cocci di un vaso di fiori.
Bonjour si voltò abbozzando un sorriso, quasi volesse chiedermi scusa.
Scrutandola, per poco non avvertii di nuovo tutta la passione che mi aveva
scatenato il suo bacio.
«Mi dispiace, monsieur Clark.» Pronunciò quelle parole come se fossi io
il tale che, sdraiato a terra, la implorava di lasciarlo in vita.
«Voi!» esclamai esterrefatto quando, come un'illuminazione, intuii in
quale modo si erano svolti i fatti. «Siete stata voi ad avvelenarmi. Non sono stati i secondini. Siete stata voi. Mi avete infilato il veleno in bocca
quando ci siamo baciati.»
«Dopo essermi intrufolata nella prigione, ho notato che le pareti dell'infermeria si stavano già sgretolando a causa dell'acqua» spiegò. «Ho pensato che sareste potuto fuggire attraverso la fogna, ma dovevo fare in modo
che vi trasferissero. Potete dire che vi ho aiutato, monsieur.»
«No, non mi avete aiutato. Volevate seguirmi finché vi avessi condotto
da Duponte, cosicché stanasse gli uomini che avevano sparato al barone o
il loro mandante. Credevate che Duponte potesse ancora darci una mano e
che io sapessi dove si trovava.»
«Volevo la stessa cosa che volevate voi, monsieur Clark. Scoprire la verità.»
«Per favore» supplicò Rollin. Bonjour gli sferrò un violento calcio allo
stomaco.
Lo guardai mentre si contorceva per il dolore. Mi avvicinai di un passo.
«Bonjour, non servirà a niente. Ora la polizia può arrestarli.»
«Non ho fiducia nella polizia, monsieur Clark.»
Rollin balbettò qualche altra implorazione, scosso da un intenso tremito.
Bonjour si accovacciò, posizionando la lama. «Uscite» mi ordinò, indicando la porta.
«Non dovete alcuna vendetta al barone, mademoiselle» replicai. «Avete
adempiuto ai vostri doveri acciuffando l'uomo che ha commissionato il suo
omicidio. Uccidere questo manigoldo non farà altro che rendere la vostra
esistenza miserabile, costringendovi a fuggire come avete dovuto fare in
passato. E» aggiunsi «io sarò l'unico testimone di questo crimine. Dovrete
ammazzare anche me.»
Mi stupii quando, dopo essere rimasta immobile a riflettere, si voltò lentamente nella mia direzione con una lacrima nell'angolo dell'occhio. La sua
espressione pareva tradire un affetto sincero. Avanzò nella mia direzione
con prudenza, come una cerva spaventata. Sembrò trattenere il respiro allorché mi gettò le braccia intorno alle spalle con un gemito sommesso.
Chissà perché, fu un abbraccio meno energico di quando i nostri corpi si
erano intrecciati alle fortificazioni di Parigi. Fu più una richiesta di sostegno, e io restai diritto come un fuso. «Bonjour. Siamo pari. Ci siamo aiutati a vicenda. Permettetemi di darvi una mano.» Al che mi spinse via come
se fossi stato io a tirarla verso di me. Per poco non urtai il bordo di un divano. Dal vuoto nei suoi occhi, capii che non l'avrei mai più rivista.
Mollò il pugnale e, dopo aver guardato per un attimo la scena che aveva
provocato, iniziò a colpire il viso di Rollin con una serie di calci. Quindi
corse fuori del locale. Trassi un sospiro di sollievo perché non l'aveva ucciso. Ma non era stato il mio monologo a dissuaderla dal suo proposito.
Avvicinandomi al punto in cui Rollin giaceva inerte come un cadavere,
scorsi ciò che aveva visto Bonjour: uno degli oggetti che erano volati sul
pavimento durante la zuffa era un giornale di quel mattino. La prima pagina annunciava la morte del misterioso barone francese in ospedale.
Contrariamente a quanto avevo ipotizzato, Slatter non si era sbagliato allorché aveva affermato che ero ricercato per omicidio. Bonjour, dal canto
suo, doveva aver pensato che, in qualche modo, l'obbligo di vendicare
Claude Dupin si fosse consumato e dissolto con il suo decesso... Forse, per
la ladra che era in lei, la ricompensa, l'onore di suo marito, era scomparsa
per sempre. Forse, per la vera mente criminale, l'onore non continuava oltre la morte, nulla continuava oltre la morte. Non vi erano paradiso né inferno per coloro che cercavano quegli stessi territori in questo mondo. O
forse un dolore sincero aveva fatto impallidire tutto il resto. Qualunque
fosse il motivo, aveva rinunciato alla sua vendetta.
Mi chinai accanto a Rollin, constatando che, seppur privo di sensi, era
ferito solo leggermente. Gli fasciai i tagli con un pezzo di stoffa che strappai da una tenda orlata di frange. Poi, prima di andarmene, cercai un catino
per lavarmi via il suo sangue dalle mani.
La mia mente vorticava senza posa intorno a quanto avevo appreso. Pur
avendo fatto enormi progressi nella comprensione di tutto ciò che era accaduto, non avevo ancora nessuna prova contro gli uomini che avevano assassinato il barone. Non avevo nulla per dimostrare alla polizia la veridicità delle mie nuove informazioni. Anche se avessi aspettato che i due furfanti tornassero dai Bonaparte, non avrebbero esitato a eliminarmi. Anzi,
forse quello sarebbe stato il primo ordine di Rollin se fosse rinvenuto.
Giacché la polizia voleva solo arrestarmi, non avrei goduto di alcuna protezione se l'avessi mandata a chiamare.
E sarei rimasto per sempre l'uomo che aveva ucciso il vero Dupin. Ecco
che cosa avrebbe pensato la gente. Ero distrutto. Mi avrebbero impiccato
per i peccati di qualcun altro e, al momento, non sapevo neppure di chi...
di quegli individui o di Duponte. E, cosa ancora peggiore, avevo consentito a quella serie di avvenimenti di intralciare la soluzione del mistero di
Poe.
Assorto in quei pensieri, andai su e giù per le strade di Baltimora, fermandomi solo di tanto in tanto per riposare. Camminai fino alle prime ore
del mattino e, quando albeggiò, stavo ancora camminando.
«Clark?»
Mi voltai. Così facendo, mi accorsi di non essere lontano da una delle
centrali di polizia del quartiere, sicché, come potete immaginare, non fui
del tutto sorpreso del mio incontro.
«Ispettore White» dissi, per poi salutare anche il suo assistente.
Quando mi afferrarono, abbassai lo sguardo con un certo sbalordimento
sulle macchie di sangue che, simili a un marchio di colpevolezza, imbrattavano le maniche e i bottoni del mio cappotto cencioso.
Capitolo 32
Una settimana dopo, mentre sedevo sulla poltrona più comoda della mia
biblioteca, i miei pensieri volarono a Bonjour, che non vedevo da quando
ero andato per la seconda volta a casa dei Bonaparte. Benché fosse stata
spinta dal desiderio di vendicare l'uccisione del barone, e non avesse avuto
alcuna intenzione di aiutarmi a uscire dalla mia situazione disperata, non le
serbavo alcun rancore. Anzi, non avevo dubbi che l'avrei riveduta e credevo che mi volesse davvero bene. Ovunque fosse, non vi era nessun motivo
al mondo per ritenere che fosse in pericolo. Se avevo compreso qualcosa
di lei in tutta quella faccenda, era, suppongo, la sua capacità di cavarsela
da sola, sebbene avesse creduto di dipendere da Claude Dupin sin da
quando quest'ultimo l'aveva fatta prosciogliere in un tribunale parigino. In
fondo, la sua era una natura puramente criminale. Non esitava a usare
qualsiasi mezzo per rispondere alla minaccia con la minaccia, alla morte
con la morte.
Quando l'ispettore White mi aveva incontrato dopo l'episodio nella dimora dei Bonaparte, mi sarei accasciato ai suoi piedi se lui e il suo assistente non mi avessero sorretto. Il mio corpo era debilitato. Non mi ero reso conto di quanto tempo era trascorso da quando mi ero concesso un poco
di vero riposo. Mi ero destato in una stanza al primo piano della centrale
del Middle District. Quando mi ero svegliato e alzato a sedere, l'assistente
era andato a chiamare White.
«Signor Clark, state ancora male?» aveva domandato l'agente con sollecitudine.
«Mi sento meglio.» Anche se, a essere onesto, non sono certo che fosse
così. Non volevo tuttavia sembrare ingrato per la gentilezza che mi avevano manifestato sistemandomi in uno dei loro alloggi più confortevoli. «Mi
avete arrestato di nuovo?»
«Signore!» aveva interloquito White. «Vi cercavamo da diverse ore per
sincerarci della vostra incolumità.»
Avevo notato che sul pavimento era adagiato uno scatolone contenente
vari oggetti prelevati da Glen Eliza. «Sono evaso di prigione!» avevo esclamato.
«Ed eravamo decisi a ricondurvici. Tuttavia, nel frattempo, abbiamo trovato alcuni testimoni che avevano veduto gli assassini la sera della conferenza. Avevano scorto due uomini, uno dei quali gravemente ferito e bendato, e dunque facilmente identificabili. Entrambi avevano le pistole spianate mentre erano in piedi nelle corsie laterali del salone. Ciò ha provato la
vostra innocenza, ma non siamo riusciti a rintracciare quei due individui,
almeno fino a ieri.» Come mi aveva spiegato l'assistente, un importante
negriero aveva denunciato il furto di un cavallo. Un poliziotto aveva avvistato l'animale vicino a un edificio di Baltimora dove, guarda caso, vi erano anche due tali che corrispondevano esattamente alla descrizione fornita
dai testimoni. Sebbene quei due tizi fossero fuggiti, e fossero sospettati di
essere saliti a bordo di una nave privata con un terzo uomo, il loro comportamento era stato una prova inconfutabile a mia discolpa.
Vergognandosi di ammettere che un nero l'aveva messo al tappeto, Hope
Slatter aveva inoltre dichiarato che ad assalirlo erano stati alcuni turisti tedeschi. Giacché la polizia considerava la nazionalità tedesca abbastanza
simile a quella francese, e il cavallo era stato rinvenuto dinanzi al fabbricato cui i delinquenti stavano tornando dopo aver sbrigato una commissione,
gli agenti si erano persuasi che l'aggressione fosse stata perpetrata dagli
stessi individui che avevano ammazzato Claude Dupin.
«Allora non dovete arrestarmi?» avevo chiesto dopo aver riflettuto un
poco.
«Santi numi, signor Clark!» aveva risposto l'assistente. «Siete libero
come l'aria. Non desiderate che vi accompagniamo a casa?»
Come mi avvidi nei mesi successivi, altri non mi avevano perdonato per
quel lungo periodo di disonore.
Infatti, presto, tutto quello che possedevo sarebbe stato in pericolo.
Glen Eliza mi sembrava vuota e priva di valore senza Hattie Blum. Lei e
Peter si sarebbero sposati e nella mia mente non immaginavo neppure di
intralciarli. Forse erano entrambi persone migliori di quanto potessi essere
io; avevano tentato di tenermi lontano dai guai e si erano sentiti profonda-
mente uniti dalla stessa cosa che mi aveva allontanato da loro. Hattie aveva
messo a repentaglio la propria reputazione facendomi visita in carcere.
Adesso che ero libero, le scrissi una breve lettera per ringraziarla di cuore
e augurarle tanta gioia. Come minimo, dovevo loro pace e serenità.
Dal canto mio, non avevo nessuna delle due. La mia prozia era venuta a
trovarmi dopo che mi avevano ricondotto a Glen Eliza, dove mi aveva interrogato più volte sulle «illusioni» e sulle idee «maniacali» che, dopo la
lunga disperazione per la scomparsa dei miei genitori, avevano condotto
alla mia incarcerazione.
«Ho fatto ciò che ritenevo giusto» avevo affermato, rammentando le parole che Edwin Hawkins mi aveva detto mentre mi nascondevo nel conservificio.
Era rimasta in piedi con le braccia conserte, il lungo vestito nero che faceva da contrappunto ai capelli candidi. «Quentin, ragazzo mio, vi hanno
arrestato per omicidio! Un avanzo di galera! Sarete fortunato se qualcuno,
a Baltimora, tollererà la vostra compagnia. Una donna come Hattie Blum
ha bisogno di un uomo rispettabile come Peter Stuart. Questa casa è diventata un vero e proprio castello dell'indolenza.»
L'avevo guardata. Si era infervorata più di quanto avessi immaginato per
quella storia. «Non avrei chiesto nulla di meglio che sposare Hattie Blum»
avevo protestato, frase che era suonata ancor più riprovevole alle sue orecchie, giacché ormai mi riferivo a una donna in procinto di maritarsi. «Qualunque cosa possiate dire con l'intento di punirmi ulteriormente è troppo
poco. Sono felice per Peter. È un brav'uomo.»
«Che cosa direbbe vostro padre! Dio non voglia che i morti paghino per
gli errori dei vivi. Voi, ragazzo mio, avete una buona dose del sangue di
vostra madre nelle vene» aveva aggiunto con un brontolio mesto.
Quel giorno, prima di andarsene, mi aveva lanciato un'occhiata che - l'avrei capito in seguito - era intesa come una minaccia. Aveva guardato Glen
Eliza come se potesse crollare da un momento all'altro a causa dello sfacelo morale di cui mi ero macchiato.
Come avrei appreso entro breve, aveva intentato una causa per rivendicare il possesso di quasi tutti i beni che avevo ereditato da mio padre, tra
cui anche Glen Eliza, adducendo come motivazioni l'infermità e lo squilibrio mentali evidenziati dalla mia condotta dopo le dimissioni insensate
dallo studio di Peter... nonché la mia totale noncuranza verso gli investimenti e gli interessi commerciali della famiglia Clark, sfociata in notevoli
perdite di valore negli ultimi due anni... il tutto era poi culminato nelle folli
farneticazioni con cui avevo interrotto la fatale conferenza del barone Dupin... nella mia scandalosa evasione dal penitenziario, nel mio presunto
tentativo di dissotterrare un cadavere e introdurmi in una dimora di Amity
Street... con l'aggravante della mia assoluta incapacità di giustificare l'intera sequenza delle suddette azioni.
Avevo inoltre appreso che zia Blum l'aveva aiutata. A quanto sembrava,
aveva intercettato la mia lettera di ringraziamenti a Hattie. Adirata per le
visite di Hattie in prigione, aveva subito convocato la prozia Clark.
Quest'ultima mi aveva scritto una missiva, spiegandomi che intendeva
combattere per l'onore del nome di mio padre e perché mi era affezionata.
Cominciai a impostare la mia difesa. Lavorai febbrilmente, senza uscire
quasi mai dalla biblioteca, e ricordando il lontano periodo in cui Duponte
sedeva a quello stesso tavolo, talvolta per diversi giorni di fila.
Mi accinsi a difendere le mie azioni come meglio potevo. Era un processo estenuante. Non dovevo soltanto preparare le risposte a ciascuna delle
accuse che la prozia Clark avrebbe sostenuto per dimostrare che avevo dilapidato il mio patrimonio e fatto cattivo uso del mio buon nome in società, ma anche formularle nel linguaggio della legge, un linguaggio che credevo di non possedere più.
A quanto si mormorava, zia Blum aveva insistito affinché le argomentazioni contro di me sottolineassero il mio disinteresse verso il patrimonio di
famiglia. Confidava nel fatto che la raffinata Baltimora non tollerasse l'ingiustizia di un simile reato pecuniario. Era quella la nostra legge del linciaggio.
Frattanto, riflettei sui vari amici e testimoni cui avrei potuto chiedere di
parlare in mio favore, ma conclusi con tristezza che molti (tra cui Peter,
naturalmente) non erano più in condizioni di farlo. I giornali, che avevano
appena finito di diffondere le sensazionali notizie del mio arresto, della
mia fuga e del mio proscioglimento, aspettavano con impazienza quella
causa, come se fosse il degno seguito della mia storia, e affrontavano sempre l'argomento con un tono sospettoso, quasi esistesse la possibilità che
fossi colpevole di un crimine diverso e più grave.
A volte, mi convincevo che avrei dovuto lasciare pacificamente quella
costruzione decrepita, Glen Eliza, in cui sembravo ormai fluttuare anziché
vivere. Mentre attraversavo a grandi passi i piani superiori, o salivo una
rampa di scale e ne scendevo un'altra, l'edificio pareva confermare quella
sensazione. In effetti, la notizia della causa legale mi aveva indotto a do-
mandarmi: «Dove mai mi trovo?». La casa, nonostante tutte le sue numerose stanze e i suoi ampi locali, sembrava avere spazio solo per qualcuna
delle particelle in cui il mio ego sembrava essersi disgregato.
Non so perché mi arrestai dinanzi a un quadro in particolare. Era un dipinto che, in passato, avevo notato di rado. Anche se dovessi descriverlo in
questa sede, il lettore non lo giudicherebbe nulla di eccezionale: il profilo
di un normalissimo uomo anziano con un antiquato tricorno in testa. Rappresentava mio nonno, che era andato su tutte le furie quando aveva saputo
che mio padre voleva sposare Elizabeth Edes, un'ebrea. Aveva minacciato
e sbraitato, privandolo del denaro che gli spettava di diritto. Poco importa,
era solito dire mio padre, perché, da giovane, quella decisione l'aveva messo quasi sullo stesso piano della famiglia di mia madre, che aveva costruito
da sola il suo patrimonio. Grazie ai suoi conservifici («grazie alla mia intraprendenza» amava ripetere), si era arricchito abbastanza da edificare
una delle più belle ville di Baltimora.
Sebbene mio padre menzionasse sempre la laboriosità e l'intraprendenza
(le qualità che considerava l'opposto del genio), dinanzi a quel ritratto mi
accorsi che in realtà lui era stato molto più «pioniere» di quanto sosteneva
di essere. Mio padre e mia madre avevano infatti creato quel mondo dal
nulla per la loro felicità, ed era impossibile stabilire quanta perseveranza e
quanta caparbietà, quanto genio, ci fossero voluti per raggiungere quel traguardo. Mio padre soffriva degli stessi tormenti del genio da cui tentava di
mettere in guardia gli altri. Ecco perché aveva cercato con tutte le sue forze di tenermi lontano da qualunque strada non fosse quella consueta, non
perché lui l'avesse imboccata, ma perché l'aveva abbandonata e si era ritrovato, sì vittorioso, ma anche ferito.
L'austero patriarca del dipinto non aveva ritirato le sue obiezioni all'introduzione del sangue ebreo di mia madre nella nostra irreprensibile famiglia nemmeno in punto di morte. Eppure, i miei genitori ne avevano appeso il quadro in un punto ben visibile di Glen Eliza anziché nasconderlo,
gettarlo via o distruggerlo. Fino ad allora non avevo mai compreso del tutto il significato di quella scelta. Avvertendo un immediato senso di possesso verso la casa e la famiglia, tornai alla mia scrivania e al mio lavoro.
Non ricevetti alcuna visita fino al tardo pomeriggio in cui arrivò Peter.
«Nessun domestico ad aprire la porta, vedo» commentò, per poi aggrottare le sopracciglia come se volesse confessare che talvolta non sapeva
frenare la lingua. «Glen Eliza è ancora magnifica come quando eravamo
piccoli e giocavamo ai banditi nei corridoi. Alcuni dei miei momenti più
gioiosi.»
«Pensateci, Peter. Voi, un bandito!»
«Quentin, voglio aiutarvi.»
«Come sarebbe a dire, Peter?»
Ritrovò la sua solita spavalderia. «Non siete mai stato destinato a lavorare da solo; siete troppo eccitabile. E forse io non sono destinato ad avere
un socio diverso da voi... A proposito, negli ultimi sei mesi ne ho provati
due. A ogni modo, avete bisogno di aiuto.»
«Per la causa della mia prozia contro di me, intendete?»
«Sbagliato!» esclamò. «La tramuteremo nella vostra causa contro la
prozia Clark, amico mio.» Sfoderò un largo sorriso, come un bambino.
Quel giorno accolsi Peter con orgoglio, e ogni pomeriggio mi dedicò tutte le ore che poteva dopo aver ultimato il suo lavoro allo studio. Il suo aiuto fu impagabile, e cominciai a essere più ottimista riguardo alla mia posizione legale. Inoltre, avevo l'impressione di non aver mai conosciuto nessuno a fondo come conoscevo il mio amico, e discorremmo come le persone fanno solo dinanzi alla luce tremolante di un caminetto.
Eppure, ci astenemmo entrambi dal menzionare Hattie. Fino a una sera
particolare, mentre elaboravamo le nostre strategie in maniche di camicia.
«A questo punto della difesa, chiameremo a deporre la signorina Hattie,
per dimostrare l'onestà della vostra condotta e...» disse Peter.
Lo guardai con espressione allarmata, come se avesse appena lanciato
uno strillo acuto.
«Peter, non posso. Insomma... ecco, cercate di capire.»
Traendo un sospiro preoccupato, abbassò lo sguardo sul suo drink, un
bicchierino di ponce caldo. «Vi vuole bene.»
«Già» replicai «come la mia prozia. O coloro che mi vogliono bene mi
deludono, o io deludo loro, come nel caso di Hattie.»
Si alzò. «Io e Hattie abbiamo rotto il fidanzamento, Quentin.»
«Che cosa? Come?»
«Sono stato io a volerlo.»
«Peter, come avete potuto?»
«Lo notavo ogni volta che si voltava nella mia direzione, come se desiderasse guardare oltre me per vedere voi. Non che non mi voglia bene; in
un certo senso, me ne vuole. Ma tra voi due esiste un legame ancora più
forte, e non posso intralciarvi.»
Balbettai a stento qualcosa che potesse sembrare una sorta di protesta.
«Ma... Peter...»
«Non c'è ma che tenga. È cosa fatta e Hattie ha accettato, dopo una lunga discussione. Ho sempre pensato che vi amasse perché eravate attraente,
sicché ho provato una punta di singolare appagamento per averla conquistata nonostante tutto. Ma ha creduto in voi quando non vi era nulla in cui
credere, e nessun altro disposto a credervi.» Con una risatina melanconica,
mi posò la sua manona sulla spalla. «È stato allora che mi sono accorto di
quanto vi assomigliasse.»
Vagliai in fretta le mie alternative, domandandomi se dovessi recarmi
subito da Hattie, ma Peter mi invitò a risedermi agitando le dita.
«Non è così semplice, Quentin. Vi è ancora la sua famiglia, che le proibisce di frequentarvi, soprattutto ora che rischiate di perdere tutti i vostri
beni, compresa Glen Eliza. Prima dovete scagionarvi, poi Hattie sarà di
nuovo vostra. Fino ad allora è meglio far credere loro che io e Hattie stiamo per sposarci. Se la incrociate anche solo per la strada, giratevi dall'altra
parte ed evitate di farvi vedere insieme.»
Euforico, caddi in un nuovo delirio di operosità; ero più determinato che
mai a superare gli ostacoli generati dall'azione legale della mia prozia.
Di lì a poco, tuttavia, Peter fu oberato di impegni allo studio, il che cagionò una drastica riduzione del tempo che poteva dedicarmi. Inoltre, dopo
l'inizio del processo, la vicenda divenne sempre più complicata e sgradevole. L'intelligente strategia di Peter, volta a dimostrare l'ipocrisia e la cattiveria della prozia Clark, fu vanificata dall'appoggio che la mia parente ricevette dalla buona società di Baltimora, e soprattutto dagli amici dei
Blum. Per giunta, vi erano semplicemente troppi punti della storia che non
riuscivo a esplicitare abbastanza chiaramente per i membri della giuria.
«Poi, come ha accennato il suo avvocato, vi è il fatto che avete pedinato
il barone» osservò Peter un tardo pomeriggio durante il processo.
«Ma questo posso spiegarlo! L'ho seguito per trarre le giuste conclusioni
sulla morte di Poe...»
«Qualsiasi cosa può essere spiegata... ma può anche essere capita? Persino Hattie, per quanto vi ami, desidera comprendere questo aspetto, ed è
addolorata perché non vi riesce. Affermate che avete spiato quel tale per
trarre le giuste conclusioni sulla morte di Poe; ma quali sono queste conclusioni? Ecco qual è la differenza tra il successo e la follia. Per cavarvela,
dovete adattare la vostra tesi alla comprensione dell'uomo più ottuso tra i
dodici seduti dietro quel banco.»
Alla fine, man mano che la mia situazione si aggravava, dovetti riconoscere che Peter aveva ragione. Non avrei vinto. Per quanto mi fossi dato da
fare, non avrei salvato Glen Eliza e non avrei riconquistato Hattie. Non avrei ottenuto niente di tutto ciò senza la soluzione del mistero di Poe, senza
dimostrare di aver trovato la verità che avevo cercato per tanto tempo.
Sapevo che cosa fare. Avrei usato l'unica versione persuasiva della
scomparsa di Poe che era emersa da tutte le mie traversie: quella del barone Dupin. Era la mia ultima speranza. L'avevo imparata a memoria, e ora
la trascrissi, parola per parola, sotto forma di un discorso che avrei pronunciato dinanzi alla giuria.
Vi rivelerò, Vostro Onore e signori della Corte, la verità sulla
morte di quest'uomo e sulla mia vita, una vicenda mai narrata finora.
Intuii subito che avrebbe funzionato. Anzi, più leggevo quanto avevo
scarabocchiato sul mio taccuino e più la storia del barone mi pareva possibile... plausibile... probabile. Sapevo che non era attendibile, che era stata
manipolata e plasmata per l'ascolto e la soddisfazione del pubblico, ma sapevo anche che ora mi avrebbero creduto. Quanto segue è la pura verità.
Avrei raccontato fantasie, frottole belle e buone, se non addirittura menzogne. Ma mi avrebbero creduto e rispettato di nuovo, come avrebbe voluto
mio padre. Io dovrò esporla, giacché sono il più vicino a essa (Duponte, se
solo Duponte fosse stato presente). O meglio, l'unico ancora in vita.
Capitolo 33
Dicembre portò qualcosa di nuovo ma familiare in Francia. Luigi Napoleone decise di sostituire il prefetto di polizia, monsieur Delacourt, con
Charlemagne de Maupas, che sarebbe stato un alleato più forte. Stando alle
voci, il presidente gli aveva detto: «Necessito di uomini che mi aiutino ad
attraversare questo fossato».
Fu un segno.
Lo furono anche gli agenti della nuova polizia segreta incaricati di sorvegliare sia la prefettura sia il palazzo governativo.
Luigi Napoleone formò un gruppo che lo aiutasse a organizzare il colpo
di Stato. Il primo giorno del mese, regalò a ciascun membro mezzo milione di franchi. L'indomani, di buon'ora, de Maupas e la sua polizia arresta-
rono gli ottanta componenti dell'Assemblea Costituente che, secondo Luigi
Napoleone, avrebbero potuto opporglisi con maggior energia, e li rinchiusero nel carcere di Mazas. Non sarebbero più stati membri di un'Assemblea Costituente in ogni caso, perché, subito dopo, il presidente sciolse
l'organo legislativo, sequestrando frattanto le macchine tipografiche e
mandando il suo esercito a uccidere i leader dei repubblicani rossi appena
uscirono nelle strade. Altri avversari, soprattutto quelli appartenenti ad antiche e illustri famiglie francesi, vennero esiliati immediatamente dal Paese.
Accadde tutto molto in fretta.
Luigi Napoleone proclamò la nascita del Secondo impero. Si mormorava
che, da bambino, avesse supplicato suo zio di non partire per Waterloo, al
che il primo imperatore della Francia aveva commentato: «Sarà un uomo
probo, e forse la speranza della mia stirpe».
Ogni mattina, recandomi in tribunale, leggevo altre notizie sulle vicende
politiche francesi. Si diceva che Jérôme Napoleone Bonaparte di Baltimora
(soprannominato «Bo»), cugino del nuovo imperatore - il tale che avevo
veduto con due spade finte appese alla cinta, che non era mai stato riconosciuto da suo zio, il compianto Napoleone Bonaparte, per via della sua
madre americana - sarebbe partito per Parigi e avrebbe incontrato Napoleone III per porre rimedio alla lunga rottura dei loro rapporti.
Gli americani erano affascinati da quelle storie parigine, forse perché il
colpo di Stato pareva così diverso da qualunque sconvolgimento potesse
avere luogo quaggiù. Il mio interesse era un poco più limitato, o meglio
più personale.
Spedii numerosi biglietti alle varie dimore dei Bonaparte, sperando di
scoprire che Jérôme non si era ancora messo in viaggio per la Francia e
che era disposto a parlare con me, sebbene temessi che non ricordasse la
nostra breve chiacchierata al ballo in maschera con monsieur Montor. Avevo alcune domande da porgli, e volevo delle risposte anche se forse non
mi sarebbero state di alcuna utilità.
Nel frattempo, molti curiosi vennero in tribunale per assistere alle mie
continue umiliazioni. Giudicavano deplorevole, suppongo, che le mie precedenti comparse sulla stampa fossero state vane e non fossero sfociate in
una conclusione adeguata. Per fortuna, alla fine, molti furono scoraggiati
dai tediosi dettagli tecnici che riempirono in gran parte le giornate iniziali
del processo. Fu più o meno in quel periodo che mi stupii di ricevere un
messaggio con il sigillo dei Bonaparte e l'indicazione dell'ora a cui presentarmi presso una delle loro residenze.
Era una costruzione più grande di quella in cui avevo veduto i farabutti,
più isolata e circondata da alberi selvatici e incolte colline erbose. Venne
ad aprirmi un domestico molto servizievole, e sul lussuoso scalone ne incrociai almeno altri due (era uno scalone lungo), accomunati dall'irrequietezza con cui svolgevano le loro mansioni. L'edificio era sontuoso, e per
nulla sobrio o impacciato nella sua magnificenza, con splendidi lampadari
e arazzi bordati d'oro che costringevano il visitatore a stare sempre con il
naso all'insù.
Mi sorpresi di vedere, su una massiccia sedia rivestita d'argento brunito,
non Jérôme Bonaparte (il principale esponente maschile del ramo della
famiglia residente a Baltimora), bensì sua madre, Elizabeth Patterson
Bonaparte. Da giovane, aveva catturato il cuore del fratello di Napoleone
ed era stata sposata con lui per due anni prima che l'imperatore, mediante
varie macchinazioni, ponesse fine al matrimonio, arrivando persino a chiedere al papa di annullarlo. Benché ora non fosse travestita da regina come
quando l'avevo conosciuta, possedeva un naturale portamento regale.
La signora, ormai ultrasessantenne, aveva le braccia nude ornate da
braccialetti scintillanti, troppo numerosi per contarli, che le avvolgevano i
polsi. In testa, portava una cuffietta di velluto nero da cui spuntavano piume arancioni che le conferivano un aspetto feroce e spaventoso. Era attorniata da diversi tavoli su cui erano posati gioielli e abiti appariscenti.
Sull'altro lato del locale, una ragazza, probabilmente una domestica, oscillava su una sedia a dondolo come un'invalida.
«Madame Bonaparte.» Mi inchinai, pensando per un attimo che avrei
dovuto lasciarmi cadere su un ginocchio. «Non rammenterete di avermi
conosciuto, ma ero al ballo durante il quale voi eravate vestita da regina e
io non ero in costume.»
«Avete ragione, giovanotto. Non rammento di avervi conosciuto. Ma
sono stata proprio io a rispondere al vostro biglietto.»
«E monsieur Bonaparte, vostro figlio...?»
«Bo è già partito per incontrare il nuovo imperatore della Francia» disse,
come se fosse la ragione più ovvia del mondo per intraprendere un viaggio
all'estero.
«Capisco. Ho letto sui giornali della possibilità di tale incontro. Forse
potreste essere così gentile da informare monsieur che gli sarei obbligatissimo se mi fissasse un colloquio al suo ritorno.»
Annuì, ma parve dimenticare la mia richiesta appena l'ebbi formulata.
«Lungi da me litigare con un avvocato» riprese «ma mi meraviglia che abbiate il tempo di venire qui quando siete assai occupato tutti i giorni in tribunale, signor Clark.»
Mi stupì che fosse al corrente della mia situazione, anche se ricordai
l'ampio spazio dedicato dalla stampa alle mie vicissitudini. Eppure, sebbene il mio destino e la mia strenua difesa dalle accuse di infermità mentale
fossero appesi a un filo, per una donna il cui figlio si accingeva a conoscere un imperatore, i miei guai sembravano una quisquilia. Sedetti nella poltrona che mi indicò. Studiando il resto della stanza, notai un ombrellino
scarlatto, scintillante quanto i monili della mia ospite, appoggiato al fianco
di un grosso cassettone. Sul pavimento vi era una pozza d'acqua quasi asciutta, a segnalare che era stato usato di recente. Nella mia mente, rividi la
scena durante la fatale conferenza del barone, e la signora indistinta sotto
l'ombrellino rosso decorato di gemme.
Che fosse lei?
Con un brivido improvviso, capii perché quella donna doveva essere venuta al salone: non per ascoltare le rivelazioni sul decesso di Poe, bensì per
assistere a un altro decesso.
Mi ero convinto di aver compreso gran parte dei fatti quando avevo letto
dei recenti episodi di potere e morte a Parigi. Allorché aveva saputo della
ricomparsa di Duponte nella capitale, ricomparsa che io avevo incoraggiato, Luigi Napoleone aveva ripensato alle leggendarie capacità dell'analista.
Lui e i suoi complici dovevano aver temuto che sventasse il loro colpo di
Stato segreto, che raziocinasse e rivelasse le loro intenzioni troppo presto.
Napoleone dunque aveva ordinato l'eliminazione di Duponte più o meno
nel periodo in cui ci eravamo imbarcati per Baltimora. Sarebbe stato un incarico semplice per uno degli uomini di dubbia moralità noti alla polizia,
con i quali essa concludeva talvolta accordi vantaggiosi.
Si erano lasciati sfuggire l'occasione giusta mentre Duponte era ancora a
Parigi, e di lì a poco se ne sarebbe andato con me. Molti anni dopo, appresi
che avevano perquisito con cura e messo a soqquadro il suo alloggio mentre ci dirigevamo al porto. In preda all'agitazione, avevano programmato di
ucciderlo in mare, solo per ritrovarsi dinanzi all'espulsione del loro killer,
il clandestino, uno dei cui pseudonimi era Rollin. Ormai eravamo salpati
alla volta dell'America.
Vi erano tuttavia dei Bonaparte a Baltimora; anzi, vi era Jérôme Napoleone Bonaparte, che si era veduto negare il suo diritto di nascita. Bo aspet-
tava da tutta la vita di riconciliarsi con il ramo francese della famiglia, di
assurgere all'autorità regale. Ora aveva la possibilità di dimostrare quanto
valeva all'erede del potere del loro antenato, a colui che presto sarebbe divenuto imperatore. I tali che avevano pedinato il barone, che l'avevano assassinato sotto la direzione del clandestino, non erano affatto venuti a cercare Claude Dupin. Rollin si era nascosto a Baltimora perché sapeva che
Duponte avrebbe potuto ricordarsi di lui dopo l'episodio a bordo del piroscafo. Tra la nebbia del veleno, l'avevo intravisto in carcere, dove era finito per breve tempo perché si era legato a un delinquente locale. Rollin e i
suoi due scagnozzi erano venuti per ammazzare Duponte. Per l'avvenire
della Francia.
Per sua sfortuna il barone aveva commesso l'errore di travestirsi da Duponte. Ed era stato ucciso al posto del suo rivale.
Ecco come ero giunto a capire gli accadimenti verificatisi da quando mi
ero imbattuto in Rollin a casa dei Bonaparte. Ma ora, dinanzi a quella donna, non potei fare a meno di domandarmi: che cosa c'entrava Elizabeth
Patterson in tutto questo?
Distolsi lo sguardo dall'ombrellino, voltandomi di nuovo verso la sua
proprietaria. «Conoscevate la parte del complotto che vostro figlio stava
architettando?»
«Bo?» Emise un cinguettio divertito. «È troppo indaffarato con il suo
giardino e i suoi libri per cose del genere. È un membro del foro, ma non
ha mai ritenuto opportuno esercitare. È un vero uomo di mondo. Certo, desidera occupare il posto che gli spetta, riconquistare il nostro patrimonio e
i nostri diritti come membri della famiglia Bonaparte, ma non ha la forza
d'animo necessaria per essere un leader.»
«Allora chi è stato?» chiesi. «Chi ha fatto in modo che deste la caccia a
Duponte per rientrare nelle grazie di Napoleone?»
«Non mi sarei mai aspettata una simile impudenza nella mia dimora da
un giovanotto avvenente come voi.» Non pareva tuttavia troppo offesa.
Anzi, mi squadrò lentamente con un'occhiata che mi colmò di imbarazzo.
Prima aveva sorriso, ma ora che parlava del figlio, il suo volto divenne serio e immobile. «Bo... avevo tentato di persuaderlo che era di rango troppo
elevato per sposare un'americana. Ma si è rovinato con le sue mani ignorando i miei consigli. Quando era giovane, avrei voluto che sposasse Carlotta Bonaparte, sua cugina, affinché tornassimo a occupare una posizione
di prestigio, ma si è rifiutato.»
«Da ragazza, anche voi vi siete ribellata ai desideri dei vostri genitori»
commentai.
«L'ho fatto per ottenere un posto sotto le ali di un'aquila!» esclamò con
fervore. «Sì, l'imperatore mi aveva trattata con durezza, ma l'ho perdonato
molto tempo fa. Che cosa ha detto di me al maresciallo Bertrand prima di
spirare? "Coloro cui ho fatto torto mi hanno perdonato; coloro che ho coperto di gentilezze mi hanno abbandonato." Ah, Napoleone, non ho permesso ai miei nipoti di scordare che il loro prozio era il grande imperatore!»
Levò le mani in aria, attirando la mia attenzione su un vestito appeso alle
sue spalle. Era l'abito da sposa che aveva sfoggiato a Baltimora nel 1803,
durante la cerimonia che aveva gettato il mondo nella costernazione, che
aveva spinto gli emissari americani ad attraversare l'oceano in tutta fretta
per cercare di placare le ire del capo di Stato francese. Avevo letto di quel
vestito recentemente, mentre mi documentavo su quegli episodi. Era di
pizzo e mussola indiana, e aveva destato parecchio scalpore perché aveva
coperto un unico indumento. «Tutti i capi indossati dalla sposa entrerebbero nella mia tasca» aveva scritto un francese in una lettera a Parigi.
Ora pendeva dalla parete, conservato così bene che, se non ci si avvicinava abbastanza da scorgere i segni di deterioramento del tessuto, pareva
nuovo, e pronto per essere usato da un momento all'altro.
All'improvviso udii il pianto di un neonato, un vagito aspro e nervoso
che divenne sempre più insistente. Sbigottito, mi guardai intorno alla ricerca del piccino, come se stessi assistendo a un evento sovrannaturale, e mi
avvidi che, in realtà, la giovane domestica intenta a dondolarsi e a oscillare
nell'angolo teneva in braccio un bimbo di non più di otto mesi. Quello, mi
spiegò la signora Patterson, era Carlo Giuseppe Napoleone, l'ultimogenito
di Bo e di sua moglie Susan. Madame Bonaparte accudiva il suo nipotino
mentre Bo e la sua consorte americana erano sulla via di Parigi per chiedere all'imperatore di concedere ai Bonaparte di Baltimora i diritti tanto attesi.
La donna tolse il bambino alla balia e lo cinse saldamente tra le sue
braccia. «Ecco una delle speranze della nostra stirpe. E avete mai veduto
l'altro mio nipote? Ha frequentato Harvard e ora studia a West Point. È tutto ciò che mio marito non era. Alto, distinto, destinato a essere presto un
soldato dell'ordine più illustre.» Dopo aver sussurrato qualche parola amorevole al bebè, continuò: «Farebbe un'ottima figura come imperatore dei
francesi».
«Solo se Luigi Napoleone accetterà di reintegrare la vostra prole nella
linea di successione, madame» precisai.
«Il nuovo imperatore, Luigi Napoleone, è un uomo alquanto ottuso,
pressappoco come George Washington. Avrà bisogno di molta più astuzia
se vuole che l'impero sopravviva.»
«E la troverà nella vostra famiglia, secondo voi?» Ora Carlo Giuseppe
prese a strillare, e madame Bonaparte lo restituì alla giovane.
«Sono troppo vecchia per civettare, cosa che, in passato, era il mio unico
divertimento. Mi sono stancata di ammazzare il tempo, signor Clark. Di
sprecare l'esistenza sonnecchiando. Una volta, avevo tutto tranne il denaro.
Qui, non ho nulla tranne il denaro. Non permetterò che gli uomini della
mia casata siano semplici coloni americani come mio figlio crede erroneamente di essere.»
«Siete stata voi, dunque. Siete stata voi ad accettare di eliminare un uomo, un genio, perché Luigi Napoleone temeva che avrebbe previsto il suo
complotto finalizzato a rovesciare la repubblica.»
Scrollò appena la spalle. «Abbiamo fornito soldi e alloggio ai viaggiatori
provenienti dalla Francia, sotto la mia direzione... sì... se è questo ciò che
intendete. Ma gli ordini sono arrivati da qualcun altro, non da me.»
«E quegli individui hanno portato a termine la missione loro affidata?»
Agitando la mano, invitò la domestica a uscire dalla stanza e corrugò la
fronte. «Idioti» disse. «Hanno scambiato un tizio per un altro. A quanto ne
so, la polizia parigina li aveva avvisati di aspettarsi la vostra presenza accanto al Duponte che stavano cercando, ma vi hanno veduto aspettare vicino agli hotel di quell'altro... quel falso barone, quel falso Duponte. Non
importa, giacché l'obiettivo è stato raggiunto: nessuno ha interferito con i
progetti di Luigi Napoleone, e ora è salito al trono.» Mi scrutò ancora con
attenzione, e avvertii il suo sguardo sempre più penetrante.
«Secondo quanto ci hanno riferito,» aggiunse «avete portato con voi due
uomini di genio nel tentativo di rintracciare un poeta che vi piace. Ho sentito nominare questo Poe. L'America ha perlopiù dimenticato il suo talento.»
«Non per molto» ribattei.
Rise. «Voi sì che avete fede. Forse vi interesserà sapere che molti giovani poeti e scrittori parigini leggono il vostro Poe. Pare che fosse come il loro monsieur Balzac... brillante ma infelice, destinato a essere un burattino
del fato. Si guadagnerà un posto d'onore nella letteratura europea, come
tutti i migliori ingegni americani. Eppure, questo non è abbastanza per ap-
pagare la vostra adorazione di Poe, vero, signor Clark? Mio figlio non è
dissimile da come credo siate voi; ritiene che i libri siano scritti per la sola
sua lettura personale.»
«Madame Bonaparte, le mie motivazioni non sono importanti. Tutto
questo non ha nulla a che vedere con me.»
«Ma, aspettate! Rifletteteci, caro signor Clark. Ci avete aiutati dandoci
un compito fondamentale da svolgere, che ci ha consentito di dimostrare la
nostra lealtà alla Francia. Ci siamo garantiti un nuovo imperatore, che fonderà un impero in cui la mia famiglia potrà sopravvivere per sempre. Ho
dedicato la vita a far sì che i miei figli avessero la loro eredità legittima, e
ora darei la vita per questo scopo. Che cosa mi dite di voi? Eravate soltanto una crisalide e avete commesso l'errore di rinunciare a ciò in cui vi aveva tramutato la vostra famiglia. Ditemi, che cosa avete trovato?»
Mi alzai senza rispondere. «Ho solo un'altra domanda, madame Bonaparte. Se hanno scoperto di aver assassinato la persona sbagliata quella sera nel salone delle conferenze, poi hanno rintracciato quella giusta? Hanno
ucciso anche Duponte?»
«Ve lo ripeto» rispose piano «io mi limito a offrire loro un alloggio.
Fornisco loro un posto da cui cominciare, si potrebbe dire, un luogo di nascita per nobili cause. Sono altri a decidere il resto.»
Avevo scritto e gettato via un intero quaderno di lettere a Auguste Duponte, descrivendogli non solo la dura realtà (il fatto che, a quanto sembrava, Poe non si era ispirato ad alcun individuo reale per ideare C. Auguste Dupin, bensì aveva usato soltanto la sua straordinaria immaginazione),
ma anche le fasi del processo intellettivo che mi aveva condotto a quella
conclusione, sicuro che sarebbe stato interessato al filo dei miei ragionamenti. Anche qualora Duponte fosse stato ancora vivo e vegeto, non sapevo tuttavia dove indirizzare le missive. Non a Parigi, non alla sua abitazione d'un tempo, ne ero certo. Non sarebbe tornato in quella Parigi, non sarebbe andato nel Secondo impero di Luigi Napoleone, dove il suo genio
era considerato un nemico delle sconfinate ambizioni dell'imperatore.
Era stata l'inquietudine sul volto di madame Bonaparte al termine della
nostra conversazione, allorché le avevo domandato se Rollin e i suoi tirapiedi avessero rintracciato Duponte, a convincermi che probabilmente
quest'ultimo era più vicino di quanto avessi immaginato. Aspettava con
pazienza... non me, a dire il vero, ma ero io quello che avrebbe veduto.
Un giorno, mentre oltrepassavo il viavai di ospiti e facchini dell'impo-
nente hotel Barnum, tutti quei pensieri si cristallizzarono in un'idea. Rincasando, conclusi che forse il tempo a mia disposizione stava per scadere,
sicché tornai verso il Barnum. Tuttavia, uscii solo dopo essermi ricordato
di frugare nell'armadio alla ricerca della vecchia pistola che la polizia mi
aveva restituito con i miei effetti personali. Prima di infilarmela in tasca,
controllai che il cane non si fosse inceppato del tutto per via degli anni e
della mancanza d'uso.
«Signore?»
Un receptionist cinereo con un paio di favoriti impeccabili mi lanciò
un'occhiata sospettosa, aspettando che dicessi qualcosa.
«Monsieur» esordii all'improvviso e, come avevo sperato, la parola francese lo incuriosì tanto da indurlo a sollevare un sopracciglio. «Al momento, vi è un membro dell'aristocrazia francese che risiede nel vostro hotel.»
Annuì con tutta la gravità della sua carica. «Esatto, signore. Alloggia
nella stanza un tempo occupata dal barone che era giunto a Baltimora
qualche mese fa. Questo è suo fratello. Il duca.» Si chinò verso di me per
sussurrarmi quell'ultimo vocabolo in tono confidenziale. «Il lignaggio nobile è assai evidente in entrambi.»
«Il duca.» Sorrisi. «Già. Ma quando è arrivato l'augusto duca?»
«Oh, appena suo fratello (l'illustre barone, intendo) se n'è andato. La sua
presenza attuale è una faccenda della massima riservatezza... con tutto ciò
che sta accadendo in Francia, sapete.»
Assentii, divertito dalla facilità con cui mi aveva palesato il suo segreto.
Come se avesse pensato la stessa cosa, si premurò di aggiungere che non
avrebbe potuto indicarmi la camera del suo ospite altolocato.
«Non è necessario, signore» replicai, e ci scambiammo un cenno d'intesa. Naturalmente, conoscevo il numero della stanza. Avevo spiato il barone mentre vi abitava.
Salii la scala con impazienza.
Ora mi sovviene che Duponte mi parve piuttosto pallido ed emaciato durante quell'incontro, come se, da quando ci eravamo conosciuti, si fosse
logorato del tutto, o almeno per metà. Quando entrai, sedeva tranquillamente nella vecchia camera del barone Dupin. Non sembrò deluso dal fatto
che l'avessi rintracciato. Suppongo di aver immaginato che la sua impassibile compostezza sarebbe stata turbata dalla mia visita inattesa, che si sarebbe adirato e mi avrebbe minacciato se avessi manifestato l'intenzione di
smascherarlo, con le informazioni ormai in mio possesso riguardo alle sue
azioni e al suo nascondiglio. Aveva sempre saputo che il barone sarebbe
stato ucciso al suo posto, e non aveva fatto alcunché per impedirlo.
Mi offrì una sedia con cortesia. La verità è che non era meno calmo del
solito. Quindi chiamò il facchino suonando il campanello e gli ordinò di
prendere il suo baule. Lo guardai con aria interrogativa.
«Avevo rinunciato da tempo a rivedervi» osservai.
«È ora che me ne vada» dichiarò.
«Adesso che sono arrivato, volete dire?» domandai.
Mi guardò. «Avrete letto i giornali. Saprete cosa è successo a Parigi.»
Estrassi la pistola dal cappotto, studiandola come se non l'avessi mai veduta prima, e la posai su un tavolo accanto a lui.
«Può darsi che mi abbiano seguito... qualora vi stiano ancora cercando,
intendo. Non desidero mettervi in pericolo, monsieur Duponte, sebbene
voi abbiate messo in pericolo me. Prendetela.»
«Non so se mi stiano ancora cercando, ma se è così, non continueranno
ancora per molto.»
Capii. I Bonaparte di Baltimora erano partiti per Parigi con la speranza
di vedere ricompensata la loro lealtà verso il nuovo imperatore. Se vi fossero riusciti, non avrebbero avuto alcun motivo di seguitare a finanziare la
caccia a Duponte, anche se ormai madame Bonaparte e i suoi scagnozzi
erano consapevoli di non aver ucciso la vittima designata.
«Il barone è morto. Sapevate sin dal principio che l'avrebbero ammazzato al vostro posto, e l'avete permesso» ribattei. «L'assassino siete voi, monsieur.»
Un gong riecheggiò con fragore in tutto l'edificio. «Ceniamo? Sono rimasto rinchiuso troppo a lungo. Per un buon pasto, posso correre il rischio
di mostrarmi in pubblico» affermò Duponte.
L'ampia sala da pranzo conteneva circa cinquecento persone accomodate
dinanzi a porzioni di alose della Baia di Chesapeake. Un «maggiordomo»
di colore faceva segno di suonare il gong a ciascuna portata, e tutti i camerieri in piedi accanto ai tavoli sollevavano contemporaneamente i coperchi
dei piatti successivi.
Mi guardai intorno alla ricerca di un sicario in agguato, o magari di
qualcuno che conosceva il barone e ora credeva di averne scorto il fantasma. Il volto stanco del mio compagno non assomigliava tuttavia alla vivida imitazione di Duponte inscenata da Claude Dupin né al vecchio Duponte.
«No, l'assassino non sono io» asserì Duponte, rispondendo con pacatezza alla mia precedente asserzione. «Non sono io, ma forse siete voi, voi e il
barone, se volete. Il barone voleva imitarmi. Potevo forse proibirglielo?
Ho tentato di evitarlo. Mi ero rintanato nei miei alloggi a Parigi. Ma voi
avevate bisogno di "Dupin" per i vostri scopi, monsieur Clark. Il barone
aveva bisogno di "Dupin" per i suoi. Luigi Napoleone aveva bisogno di un
"Dupin" da temere. Il vostro arrivo a Parigi e la vostra insistenza mi hanno
spinto ad accettare il fatto che, per quanto io restassi nell'ombra, l'idea di
"Dupin" non avrebbe seguito il mio esempio. Come avete detto, era "qualcosa di pressoché immortale".»
Ah, ma voi non siete Dupin! Non lo siete mai stato!
Avevo quelle frasi sulla punta della lingua. Ero pronto a impadronirmi
della conversazione e ad assumerne il controllo. Tuttavia, nella mia mente
gravitavano ancora mille domande.
«Quando ve ne siete reso conto? Quando vi siete reso conto che cercavano voi? Che quegli uomini, pagati dai Bonaparte, volevano uccidere
voi?»
Scrollò il capo come se non conoscesse la risposta.
«Tuttavia, sull'Humboldt sapevate che vi era un clandestino a bordo,
quella canaglia di Rollin. Tutto ha avuto inizio lì. Monsieur, ho veduto ogni cosa con i miei occhi!»
«No, non sapevo che vi fosse un clandestino. Piuttosto, sapevo che, se vi
fosse stato un clandestino, avrebbe dato la caccia a me.»
«E avete indovinato!» esclamai.
Sorrise solo per un attimo, assentendo.
Quel giorno, credo di aver avvertito la sofferenza interiore che l'aveva
trasformato nell'individuo in cui mi ero imbattuto allorché avevo scoperto
la vita apatica che conduceva a Parigi: solo e incapace di reagire a qualsiasi stimolo esterno. Tutti gli avevano attribuito doti straordinarie dopo che
aveva risolto il caso di Lafarge. Il giovane Duponte era un uomo di raro ottimismo, e lui stesso aveva cominciato a pensare che le sue capacità avessero la natura quasi sovrannaturale cui accennavano i giornali. Gli articoli
che lo riguardavano avevano sottolineato il suo genio, e forse, all'inizio,
l'avevano persino generato, ma non sapevo ancora se fosse scaturito dalla
fiducia del mondo esterno. I lettori hanno sovente l'impressione che il Dupin dei racconti di Poe pervenga alla verità perché è un genio. Rileggeteli.
È vero solo in parte. L'analista perviene alla verità perché qualcuno ha una
fiducia incrollabile in lui... Senza il suo amico, C. Auguste Dupin non esi-
sterebbe.
«Ogni volta che vedevo Luigi Napoleone passare in rassegna le sue
truppe» continuò Duponte «non scorgevo il futuro, come ipotizzavano gli
idioti superstiziosi, bensì il presente. Non era contento di essere stato eletto
alla presidenza. Il prefetto Delacourt l'ha messo in guardia da me dopo che
le sue spie mi avevano intravisto con voi a Parigi, suppongo.»
«Il barone mi ha spiegato che cosa era accaduto con Catherine Gautier.
Il prefetto Delacourt ha messo in guardia Luigi Napoleone perché vi eravate schierato contro di lui in quel caso? Volevate vendicarvi sfuggendogli?»
«Le azioni del prefetto sono state motivate dal torto che lui aveva arrecato a me, non da quello che io avevo arrecato a lui. È la nostra malvagità
passata, non quella altrui, a metterci contro qualcuno per tutta la vita. Sono
certo che Delacourt è stato sostituito con il nuovo prefetto per varie ragioni: una di queste è stata, forse, la sua incapacità di trovarmi prima che io e
voi lasciassimo Parigi insieme. De Maupas non è astuto quanto Delacourt,
ma è molto più competente, due caratteristiche che non hanno alcun legame tra loro... e, fra parentesi, de Maupas è assai spietato.»
«Pensate si siano avveduti di aver ammazzato il barone al vostro posto?»
Ora Duponte tagliò un pezzetto di prosciutto ripieno, la seconda portata
servitaci dal cameriere. «Può darsi. Senza dubbio avete rivelato l'identità
del barone alla polizia con strepito sufficiente, monsieur Clark. Il pubblico
non la conosceva, e probabilmente, a Parigi, gli interessati non la conoscono ancora. È verosimile che i farabutti responsabili della morte di Claude
Dupin abbiano udito la verità quaggiù. È ragionevole supporre che, per il
loro bene, abbiano tenuto i loro superiori di Parigi all'oscuro di questo fatto. Invece, il loro capo (il clandestino mandato qui per dirigere la missione) mi ha dato la caccia di nascosto. Sapevo tuttavia che questo sarebbe
stato l'unico luogo di Baltimora in cui non mi avrebbero cercato: l'ultimo
alloggio del barone in città. Mi sono rifugiato qui durante la conferenza e
sono uscito per le strade raramente e solo di notte. Il personale dell'albergo
crede che sia venuto per piangere mio "fratello", il nobile barone, in santa
pace, e non mi ha mai disturbato. Ora che Luigi Napoleone è riuscito a
sorprendere Parigi proclamando la nascita di un impero, e poi ottenendo la
vittoria con un plebiscito, il clandestino inizia senz'altro a credere che il loro errore riguardo a me e al barone abbia perduto la sua importanza. Se il
figlio americano dei Bonaparte riuscirà nel suo intento, Rollin potrà restare
tranquillamente in Francia e ricevere la ricompensa che gli spetta prima
che si verifichino ulteriori cambiamenti politici. Lui e i Bonaparte ameri-
cani non diranno nulla dei loro sbagli, potete starne certo. Per Parigi, sarò
morto e sepolto.»
Ripensando alla sua semplice camera d'albergo al piano di sopra, rividi
nella mia mente quella che doveva essere stata la sua vita nei mesi successivi all'omicidio del barone, mesi trascorsi a nascondersi lì, sotto gli occhi
di tutti. Aveva alcuni libri, anzi la stanza era disseminata di libri, come se
alcune mensole di biblioteca fossero crollate e avessero sparpagliato al
suolo alcuni tomi. Tutti i titoli parevano riferirsi a minerali, sedimenti e caratteristiche generali delle rocce. Nel buio e nella tetraggine di quelle settimane, Duponte si era concentrato sui meccanismi regolari della geologia.
Mi sembrò terribilmente volgare e inutile, quella tomba di sassi e volumi, e
trovavo irritante che ora tentasse di ottenere la mia comprensione.
«Avete idea dell'affanno in cui ho vissuto, monsieur Duponte, dall'inizio
della nostra avventura?» chiesi. «Mi hanno ritenuto colpevole di aver ucciso il barone Dupin finché la polizia è rinsavita. Ora devo combattere per
non perdere la mia proprietà, Glen Eliza, e tutto ciò che possiedo.»
Dinanzi all'ultima portata, una fetta di anguria, gli narrai quanto era avvenuto durante la mia reclusione, l'evasione e la scoperta di Bonjour e dei
furfanti. Dopo aver finito quel pasto abbondante, risalimmo nella sua stanza.
«Dovrò raccontare l'intera storia della morte di Poe in tribunale» gli dissi
«in un ultimo tentativo di dimostrare che, in tutta questa vicenda, ho agito
seguendo la ragione, e non dei sogni folli.»
Mi scrutò con interesse. «Che cosa direte, monsieur?»
«Non avete mai avuto intenzione di risolvere il mistero sul decesso di
Poe, vero?» domandai con mestizia. «L'avete usato come diversivo, sapendo che presto il mondo avrebbe creduto che vi avessero ucciso quaggiù.
Allorché avete letto l'annuncio del barone su quel quotidiano parigino,
avete intuito che stava per prepararsi la trappola capace di liberarvi dalle
pretese altrui. Ecco perché vi siete entusiasmato all'idea che Claude Dupin
avesse mandato quel Van Dantker a Glen Eliza... cosicché potesse perfezionare la sua imitazione. Uscivate di casa solo la notte per essere sicuro
che la sua messinscena funzionasse. Volevate semplicemente cancellare,
una volta per tutte, la convinzione che foste il vero "Dupin".»
Annuì a quell'ultima affermazione, ma senza guardarmi negli occhi.
«Quando vi ho conosciuto, monsieur Clark, ero furibondo per la tenacia
con cui insistevate nel vedermi come il vero "Dupin". Poi mi sono avveduto che soltanto studiando i racconti di Poe e studiandovi avrei compreso
che cosa voi e tanti altri lettori seguitavate a cercare in un simile personaggio. Il vero Dupin non esiste più, e non esisterà mai più.» Vi era un singolare misto di sollievo e orrore nel suo tono. Sollievo, perché non era più
gravato dal fardello di essere il vero Dupin. Orrore, perché doveva diventare qualcun altro.
Avrei dovuto svelargli la dura verità. «Non siete Dupin!» avrei voluto
dirgli. «Non lo siete mai stato. Un uomo simile non è mai vissuto; Dupin
era un'invenzione.» Dopo tutto, forse era quello il motivo per cui avevo
tentato di rintracciarlo con tanta bramosia. Per costringerlo ad avvertire
con me il tormento di quella perdita. Per privarlo di qualcosa, e dunque lasciarlo ancora più solo.
Ma tacqui.
Ricordai le osservazioni di Benson riguardo ai pericoli cui si esponeva
un'immaginazione suscettibile che si dedicava alla lettura di Poe; all'illusione di trovarsi negli scritti del poeta. Forse, allo stesso modo, Duponte
aveva creduto, un tempo, di essere in un mondo immaginario creato da Poe, aveva pensato di essere nei racconti di Dupin. Eppure, era più reale di
quasi tutti noi in un mondo come quello tratteggiato da Poe. E chi poteva
asserire che ciò non lo tramutava nella vera incarnazione del personaggio
in cui ero incappato per la prima volta su una pagina del «Graham's»? Era
davvero importante stabilire se fosse la causa o l'effetto?
«Dove?» gli chiesi. «Dove andrete?»
Anziché rispondere, dichiarò con aria meditabonda: «Vi sono molte caratteristiche ammirevoli in voi, monsieur».
Non so perché, ma quell'affermazione mi sbalordì, sollevandomi il morale, e lo pregai di spiegarsi meglio.
«Alcune persone, sapete, non riescono ad abbandonare le loro posizioni.
Non riescono a fuggire, pur desiderandolo. Finora io non ci sono riuscito,
né qui né a Parigi, e monsieur Poe non ci è riuscito neppure prima di morire. Voi avreste potuto andarvene sin dal principio e non l'avete fatto.» Fece
una pausa. «Che cosa direte in tribunale?»
«Fornirò loro le risposte. Narrerò loro la versione della morte di Poe elaborata dal barone Dupin. Credo che la gente ci crederà.»
«Sì, lo farà. Così facendo, vincerete la causa?» domandò.
«Sì. Quella storia sembrerà vera quanto qualsiasi altra. È l'unico modo.»
«E quanto a Poe?»
«Forse» mormorai «un finale vale l'altro.»
«Vi comportate proprio da avvocato, dopo tutto» commentò con un sor-
riso distante.
Finalmente il facchino venne a prendere il resto dei bagagli. Duponte gli
impartì varie istruzioni. Recuperato il mio cappello, gli augurai buona serata. Rallentai un poco quando entrai nel foyer, ma pur volendo avere
un'ultima immagine di Duponte da ricordare, vidi soltanto che armeggiava
per imballare alcuni ingombranti strumenti geologici da portare via. Desiderai che si voltasse e mi rammentasse che non stavo guardando un uomo
normale. Che pronunciasse un insulto. «Imbecille!», magari, o «idiota!».
«Vi stimavo molto, duca» borbottai tra me e me, inchinandomi.
Capitolo 34
Ben presto giunse il giorno in cui dovetti salire sul banco dei testimoni e
raccontare tutta la «verità» sulla scomparsa di Poe. In quell'occasione avrei
dovuto fornire prove convincenti per dimostrare che azioni ritenute assurde
e illogiche erano state, in realtà, proficue, coerenti e assolutamente normali. Peter aveva lavorato con alacrità sin dall'inizio del processo per darmi
una mano, soprattutto riguardo a questi punti, e se non altro l'opinione prevalente del popolino ci considerava alla pari dei nostri avversari legali.
L'avvocato dell'accusa aveva una voce da leone che metteva in soggezione
la giuria con i suoi ruggiti. Peter aveva affermato che la mia spiegazione
della morte di Poe sarebbe stata indispensabile per vincere.
Hattie, sua zia e altri membri della famiglia Blum si presentarono in aula
tutti i giorni. Si meravigliavano dello zelo con cui Peter sgobbava per la
mia difesa («Vista la condotta tenuta dal giovane Clark!»), ma venivano
con assiduità a sostenere l'uomo che, pensavano, avrebbe sposato Hattie.
Credo che venissero in tribunale per il gusto di assistere al mio disonore e
al mio tracollo finanziario. Di tanto in tanto io e Hattie riuscivamo a scambiare qualche parola di nascosto, ma mai per molto. Ogni volta gli occhi di
sua zia ci individuavano, e ogni volta la signora escogitava nuovi stratagemmi per impedire ulteriori contatti.
Giacché la nostra comunità aspettava con impazienza la deposizione di
quel mattino, il pubblico era assai più numeroso del consueto. In particolare, avrei dovuto provare che il mio comportamento era stato davvero un
tentativo per cercare di far luce sull'incomprensibile decesso di Poe, e avrei
dovuto farlo dimostrando la fondatezza di quell'affermazione, ossia divulgando la soluzione a tale mistero. Talvolta, la notte, avevo sognato il personaggio letterario di C. Auguste Dupin (che assomigliava, anche se non
sempre nello stesso grado, a Auguste Duponte) e l'avevo udito suggerirmi
ogni dettaglio. Al mio risveglio, non ero tuttavia riuscito a giungere ad alcuna conclusione né a ricreare alcun procedimento del raziocinio, ma avevo trovato soltanto frammenti discordanti di idee e frasi, e mi ero sentito
disperato e frustrato. Era stato in quegli istanti che il barone era ricomparso nella mia mente, e avevo rammentato con gratitudine le sue risposte inattaccabili, affidabili e teatrali, risposte che avrebbero soddisfatto qualsiasi curiosità del pubblico.
Semplici parole capaci di salvare tutto ciò che possedevo.
Vi erano gli sguardi dei curiosi, uguali a quelli che avevano accolto il
barone sul palco nella sala delle conferenze. Sguardi colmi di avidità, i segni di un accordo in virtù del quale l'oratore e gli ascoltatori avrebbero
sfiorato la parte più recondita dei rispettivi animi. Erano presenti molti appassionati di Poe che un tempo erano stati ansiosi di udire Claude Dupin.
Avrei rivelato come era morto Poe, si mormorava in tutta la città. Scorsi
Neilson Poe e John Benson che entravano nel locale, uomini che, in modi
assai diversi, avevano bisogno di quelle risposte, di qualsiasi risposta. Ora
toccava a me e dovevo parlare con la persuasività melliflua del barone.
Dovevo soltanto raccontare una storia.
Il giudice mi chiamò, e abbassai gli occhi sulle righe che avevo scritto.
Trassi un respiro.
«Vi rivelerò, Vostro Onore e signori della Corte, la verità sulla morte di
quest'uomo e sulla mia vita, una vicenda mai narrata finora. Per quanto sia
stato privato di tutto, mi rimane ancora una cosa: questa storia.»
Potevo asserire, come aveva fatto Claude Dupin, che quanto sembrava
vero doveva essere vero? Sì, sì, perché no? Non ero forse un avvocato?
Quello non era forse il mio lavoro, il mio ruolo?
«Oggi sono presenti in aula alcuni abitanti della nostra città che hanno
cercato di farmi tacere per sempre. Seduto qui tra voi, vi è chi ancora mi
reputa un criminale, un bugiardo, un reietto, un assassino vile e scaltro.
Me, Vostro Onore, Quentin Hobson Clark, cittadino di Baltimora, membro
del foro e appassionato lettore.
«Ma questa storia non riguarda me...» A quel punto, consultai le mie annotazioni e andai avanti, leggendo quasi per conto mio. «Non ha mai riguardato me... Riguarda qualcosa più grande di me, più grande di tutto
questo, ovvero un uomo grazie al quale i posteri ci ricorderanno, sebbene
voi l'abbiate dimenticato ancor prima che la terra ricoprisse la sua bara.
Qualcuno doveva pur farlo. Non potevamo limitarci a tacere. Non potevo
tacere...»
Aprii la bocca per proseguire, ma non ci riuscii. Mi accorsi di avere
un'altra scelta. Avrei potuto raccontare ciò che era andato male. Come avevo rintracciato Duponte, come l'avevo condotto quaggiù, come gli uomini dei Bonaparte l'avevano braccato e avevano assassinato il barone per
errore. Le mie parole su quell'argomento avrebbero raggiunto la stampa, i
Bonaparte si sarebbero ritrovati coinvolti in uno scandalo, e Duponte sarebbe stato perseguitato di nuovo in qualunque luogo del mondo fosse
fuggito, questa volta, magari, svanendo addirittura nel nulla. Avrei potuto
concludere definitivamente quanto avevo cominciato a relegare nel passato.
Afferrai la mia canna di Malacca dalle due estremità e percepii sotto le
mie dita che si divideva in due. Quindi riecheggiò uno sparo.
Pareva abbastanza vicino da essere nell'aula, e subito scoppiò il caos. Si
diffuse la voce che un pazzo tenesse sotto assedio il tribunale. Il giudice
ordinò al cancelliere di informarsi, poi esortò gli astanti a lasciare la stanza
finché fosse stata ripristinata la calma. Aggiunse che saremmo dovuti tornare tutti dopo quaranta minuti. Alla fine, si levarono urla da tutte le parti,
e un paio di agenti iniziarono a spingere fuori i presenti.
Dopo qualche istante, rimasi solo, o almeno così credevo. Quindi notai
la mia prozia. Si sistemò la cuffietta scura tra i capelli, raddrizzandone la
sommità. Era la prima volta che restavamo soli dall'inizio del processo.
«Prozia» la supplicai «forse mi volete ancora bene, giacché sapete che
sono figlio di mio padre. Per favore, ripensateci. Non contestate il testamento, né la mia salute mentale.»
Il suo volto appariva contratto, avvizzito per il disgusto. «Avete perduto
la vostra Hattie, avete perduto Glen Eliza, avete perduto ogni cosa, Quentin, per l'illusione di essere una sorta di poeta anziché un avvocato. È sempre la stessa storia, sapete. Penserete di aver fatto qualcosa di coraggioso
perché stupido. Povero Quentin. Quando tutto questo sarà finito, potrete
esternare quotidianamente le vostre pene alle suore di carità del manicomio, e non sarete più in condizioni di affliggere gli altri con ansie e preoccupazioni.»
Poiché non replicai, proseguì.
«Forse penserete che agisca per cattiveria, ma vi assicuro che non è così.
Lo faccio per il dispiacere che provo nei vostri confronti e per onorare la
memoria dei vostri genitori. Tutta Baltimora vedrà che, alla mia età, questo
è l'ultimo atto compassionevole che possa compiere, impedirvi di essere il
più pericoloso tra i mostri: il fannullone affaccendato. Che la follia del
passato vi serva da monito per il futuro.»
Restai sul banco dei testimoni e, chissà perché, mi sentii sollevato e rattristato allorché una quiete assoluta calò sull'aula. Quel silenzio mi trasmise tuttavia una sensazione strana, perché un'aula di tribunale è uno di quei
luoghi che, come le sale dei banchetti, non paiono mai vuoti neppure
quando lo sono. Mi accasciai sulla sedia.
Anche quando udii l'uscio che si riapriva, e udii la mia prozia che, uscendo e oltrepassando qualcuno in procinto di varcare la soglia, bofonchiava «Scusate» in tono un poco offeso, sprofondai in un momento di astrazione troppo intenso per voltarmi. Se il pazzo che aveva sparato all'esterno fosse entrato, avrebbe potuto uccidermi, suppongo. Trasalii solo
quando sentii che qualcuno chiudeva la porta da dentro.
Auguste Duponte, avviluppato in una delle sue cappe scure più eleganti,
mosse qualche passo nella mia direzione.
«Monsieur Duponte!» esclamai. «Ma non sapete che c'è un folle in tribunale?»
«Ebbene, ero io, monsieur» rispose. Indicò fuori. «Preferirei che la folla
non ci fosse, in ogni caso. Ho pagato un vagabondo affinché esplodesse
qualche colpo innocuo nell'aria con la pistola che mi avete portato, cosicché la gente avesse qualcosa da guardare.»
«Davvero? Avete usato un complice, un assistente?» domandai stupito.
«Già.»
«Ma perché non avete lasciato Baltimora l'altro giorno, come avevate
programmato? Non potete fermarvi qui finché continuano a cercarvi. Potrebbero tentare di farvi del male.»
«Avevate ragione, monsieur Clark. Mi riferisco a qualcosa che avete
detto all'hotel. Sono venuto in America senza alcuna intenzione di risolvere il vostro mistero. Sono venuto qui, in verità, per cancellare la convinzione che sapessi fare cose simili, la convinzione che mi ha impedito per
tanto tempo di condurre una vita normale. La convinzione che spaventava
le persone, compreso il presidente di una repubblica, perché tutti mi giudicavano capace di scoprire informazioni che desideravano tenere nascoste.
Eppure, la gente credeva in quell'idea, la gente la voleva e la temeva, anche se non ho più messo il naso fuori del mio alloggio. Suppongo di non
riuscire a ricordare se sono stato io il primo a credervi, o se il primo è stato
qualcun altro.»
«Volevate distrarmi mentre progettavate la fuga dai vostri persecutori e
pianificavate una sequenza di accadimenti che avrebbero cancellato la vostra identificazione con il vero Dupin. Era questa la natura della nostra indagine per voi... una distrazione.»
«Sì» ammise con franchezza. «In un primo momento, è stato così, immagino. Ero stanco, credo: non stanco di vivere, ma di aver vissuto. Tuttavia, voi avete insistito. Avevate la certezza che eravamo qui per risolvere
qualcosa... non solo che potevamo farlo, ma anche che dovevamo farlo.
Avete raccontato la versione di Claude Dupin? Alla marmaglia fuori del
tribunale, intendo.»
«Stavo per farlo» risposi con una risata amara, abbassando lo sguardo
sul mio taccuino, dove avevo trascritto tutta la conferenza del barone così
come la rammentavo. Duponte mi pregò di mostrargliela. Lo osservai
mentre esaminava le pagine.
«La distruggerò» dichiarai quando posò di nuovo il quaderno sul tavolo.
«Ho deciso. Non mentirò riguardo alla morte di un uomo di verità. Non
accadrà ancora.»
«E invece sì, monsieur Clark» ribatté, cupo. «E lo farete molte volte,
probabilmente.»
«Non ho confidato a nessuno il resoconto del barone» ribadii «e non
penso che lui abbia avuto modo di riferirlo a Bonjour o a qualcun altro
prima di spirare. Voleva assurgere alla gloria esponendolo per la prima
volta dinanzi a una moltitudine. Il documento originale è andato distrutto,
monsieur; ve lo assicuro, questa è l'unica stesura esistente.»
«Non ha importanza che Claude Dupin abbia informato i suoi complici
delle sue conclusioni oppure no. Vedete, il barone era diverso dalla maggior parte degli individui solo per le sue doti di accuratezza e indelicatezza
e, se volete, per una certa ostinazione non dissimile dalla vostra. Le sue idee, tuttavia, non sono per nulla fantasiose. Scopriamo così il vostro errore. Che il suo discorso bruci nella stufa del penitenziario o nel grande incendio di Roma, le sue idee riaffioreranno nei pensieri banali di altri che
investigheranno sulla scomparsa di Poe.»
«Ma non vi è nessuno...»
«Ci sarà qualcuno. Ci sarà, eccome. Altri investigatori, a decine, a centinaia. Forse trascorreranno molti anni, ma le conclusioni del barone, e quelle altrettanto spaventose nella loro fallacia, e altrettanto persuasive nella
loro umanità, emergeranno ancora. Non vi sarà modo di fermarle fintantoché Poe verrà ricordato.»
«Bene, allora comincerò eliminando questa» affermai, strappando la
prima pagina.
«Aspettate.» Allungò la mano.
«Monsieur?»
«Non vanno fermate. Rammentate che cosa vi ho detto riguardo al barone?»
«Che dobbiamo vedere i suoi sbagli per appurare la verità» dissi, una
speranza profonda e inattesa che si riaccendeva dentro di me.
«Sì. Ecco un esempio: come leggo nel vostro taccuino, Claude Dupin
credeva erroneamente che Poe fosse giunto a Baltimora dopo essere stato
aggredito mentre era in viaggio verso New York. L'ha ipotizzato solo perché i giornali avevano riferito che Poe era diretto a New York per persuadere Muddy, la madre della sua compianta moglie, a trasferirsi a Richmond in Virginia con lui e la sua nuova fidanzata, Elmira Shelton. Il barone riteneva che, giacché Poe non era salito subito su un treno per New
York, fosse sorto un problema, scambiando, come spesso accade, un piano
semplicemente modificato per un piano rovinato. Procediamo.»
«Procediamo?» Il mio cuore batteva più in fretta di quanto le sue parole
si susseguissero.
Si fece serio. «Perché mi avete trovato, monsieur Clark.»
«Prego?»
«Mi avete domandato perché oggi ho rischiato di venire qui anziché
fuggire e mettermi in salvo. Perché mi avete trovato. Loro mi cercavano, e
voi mi avete trovato. Buonuomo, se non vi dispiace!»
A quel segnale, un facchino con la divisa del Barnum entrò trascinando
uno dei bauli di Duponte con tanta fatica che dentro vi sarebbe potuto essere un cadavere. Era il medesimo baule da cui, con totale sbalordimento,
avevo estratto la canna di Malacca per la prima volta. Duponte infilò alcune monete nella mano dell'uomo e lo congedò, sprangando la porta appena
fu uscito.
«Ora, riguardo al barone... procediamo?»
«Monsieur Duponte, intendete... Un attimo fa avete ammesso che, in realtà, non siete venuto qui per risolvere il mistero della morte di Poe!»
«Idiota! Le intenzioni non contano nulla ai fini dei risultati. Se non erro,
non ho mai affermato che non avevamo risolto l'enigma, monsieur Clark.
Siete pronto?»
«Pronto.»
«Claude Dupin asserisce che i manigoldi hanno pedinato Poe dal porto
finché si è rifugiato a casa del dottor N. C. Brooks, dove i medesimi fara-
butti hanno appiccato un incendio che per poco non ha raso al suolo quella
dimora. La sua catena di errori lampanti inizia con l'ipotesi secondo cui la
sosta di Poe a Baltimora è stata involontaria, ossia priva di uno scopo premeditato. Pertanto solo un atto brutale potrebbe spiegare il prolungamento
del suo viaggio. In realtà, dalle informazioni sulla prima destinazione del
poeta, possiamo trarre una conclusione del tutto differente.»
Duponte aveva già affrontato quell'argomento con me in precedenza.
«Brooks è un editore famoso e un direttore di riviste prestigiose» aggiunsi.
«Poe cercava sostegno per la sua rivista, "The Stylus", che avrebbe innalzato gli standard per qualsiasi periodico successivo.»
«La vostra tesi è corretta, seppure un po' troppo fiduciosa riguardo ai potenziali effetti del giornale. Sia come sia, se a quel punto Poe fosse davvero stato in pericolo, e se ne fosse stato abbastanza consapevole da fuggire
come vorrebbe indurci a credere il barone, forse l'avrebbe riferito a un
membro della sua famiglia, per quanto li trovasse detestabili, o magari persino alla polizia. Invece, Poe ha cercato un influente direttore di riviste.
Ora possiamo cancellare quei bricconi immaginari dalla scena e, piuttosto,
accompagnare Poe a casa del dottor Brooks di sua spontanea volontà. Forza.»
Mi risedetti sul banco dei testimoni.
Capitolo 35
«Avete osservato che il barone era deciso a interpretare gli ultimi giorni
di Poe come il frutto di una sequenza di fatti sempre più violenti. Qui
Claude Dupin stava guardando se stesso in uno specchio. È così che desiderava che la gente vedesse i suoi guai. Voleva esonerare Poe da qualsiasi
responsabilità in relazione alla sua morte individuando la causa della sua
sventura esclusivamente in altre persone.»
«Allora volete dire che l'incendio della casa di Brooks non ha nulla a che
fare con la ricerca di un rifugio da parte di Poe? Si tratta di una coincidenza?»
«Non proprio, anche se dobbiamo invertire il nesso nella vostra affermazione. La vana ricerca di un rifugio da parte di Poe ha a che vedere con
l'incendio della casa di Brooks. Giacché immaginiamo che lo scrittore si
sia diretto, con tanto di baule, verso la dimora del dottor Brooks subito dopo essere sbarcato, è quasi certo che sperava di trovarvi non solo un appoggio letterario, ma anche un letto.»
«Invece, ha scoperto che l'edificio era stato bruciato, o stava ancora bruciando, a seconda del giorno e dell'ora esatta del suo arrivo, ma sono dati
che non conosciamo.»
«Già, e a ogni modo, lo scrittore è rimasto senza alloggio. È questo il
problema. John J. Moran, il medico che l'ha curato qualche giorno dopo
all'ospedale, ha dichiarato che il poeta non sapeva che cosa facesse a Baltimora o come ci fosse arrivato. I periodici delle leghe antialcoliche, alla
ricerca di un insegnamento persuasivo e indimenticabile da impartire ai loro lettori, hanno sfruttato questo spunto per asserire che Poe aveva iniziato
a bere e questo spiega, secondo la loro logica, come mai avesse perduto la
cognizione del tempo.»
«Non ci credete?» domandai.
«È una teoria assai debole... non solo viziata, ma palesemente viziata.
Sarebbe come se voi mi incrociaste per la strada un giorno, e poi ancora
una settimana dopo, e in quella seconda occasione io vi chiedessi indicazioni, al che vi domandereste com'è possibile che abbia girovagato per
un'intera settimana. Ricorderete, perché ne abbiamo già parlato, che la signora St. Leon Loud aveva proposto a Poe di recarsi a Filadelfia e curare
un suo libro di poesie per un compenso di cento dollari. Un'offerta che, lo
sappiamo, lo scrittore aveva accettato. Ecco che cosa aveva scritto a
Muddy: "Il signor Loud, il marito della signora St. Leon Loud, la poetessa
di Filadelfia, è passato l'altro giorno da me e mi ha offerto cento dollari per
curare le poesie di sua moglie. Com'è ovvio, ho accettato la proposta. L'intero lavoro non mi occuperà più di tre giorni". Queste sono le parole che
Poe aveva scritto qualche mese prima, come apprendiamo dalle missive
che sono state pubblicate da allora.
«Se, come abbiamo già determinato con sicurezza, Poe stava raccogliendo altri finanziamenti per la sua rivista, e se aveva prolungato il suo viaggio decidendo solo in un secondo tempo di fermarsi a Baltimora per incrementare quelle sovvenzioni, e se i fondi che aveva racimolato non erano
stati decurtati da un furto ma dalla necessità di pagarsi una camera d'albergo, allora è assai probabile che, con quell'offerta ancora in attesa nella vicina Filadelfia, e il tanto sperato abboccamento con il dottor Brooks sfumato a causa di quell'incendio inopportuno, Poe sia ripartito entro breve
con l'intenzione di completare quel facile lavoro per la poetessa impaziente
e facoltosa. Anziché trascorrere diversi giorni nello "smarrimento", come
vorrebbero i direttori dei giornali antialcolici, Poe ha passato almeno una
notte, e forse più di una, in un hotel di Baltimora prima di salire su un tre-
no per Filadelfia. Quando, sul letto di morte, lo scrittore ha confessato al
medico di non sapere come fosse giunto a Baltimora e perché si trovasse
qui, non si riferiva dunque al suo arrivo da Richmond - viaggio di cui, ovviamente, conosceva lo scopo -, bensì a un secondo arrivo a Baltimora. Un
viaggio di ritorno intrapreso, in una sorta di incoscienza e in un momento
non meglio precisato (ma senza dubbio compreso tra la notte precedente al
suo malore al Ryan e qualche ora prima di quel malore), dopo una sosta a
Filadelfia.»
«Ma, monsieur, esaminando le poesie della signora Loud e i versi dedicati alla morte di Poe, avete dimostrato che Edgar non aveva curato quei
componimenti e che, giacché lo definiva uno "sconosciuto", la donna non
l'aveva veduto a Filadelfia poco prima della sua scomparsa» gli rammentai. «Avete osservato che quella era solo la prima prova in tal senso. E ora
parlate del soggiorno di Poe a Filadelfia. Avete forse mutato parere?»
Levò l'indice. «Attenzione. Non ho detto che Poe è arrivato a Filadelfia.»
«Avete ragione nell'affermare che, in passato, ho accennato a una seconda prova del mancato arrivo di Poe a Filadelfia, se mai sia necessaria un'altra dimostrazione oltre a quella evidenziata dalle produzioni liriche di
madame St. Leon Loud. Ora ricorderete che Poe aveva pregato Muddy di
scrivergli a Filadelfia indirizzando le lettere all'"Egr. Sig. E. S. T. Grey".
Vi dispiace recuperare dalla vostra cartella quelle istruzioni apparentemente oscure e rileggerle?»
Obbedii: «Rispondete immediatamente e indirizzate a Filadelfia. Poiché
temo di non ricevere la lettera, non firmatela e indirizzatela all'Egr. Sig. E.
S. T. Grey». Tacqui, posando l'articolo. «Monsieur, ditemi che avete la soluzione a questo codice tanto indecifrabile!»
«Codice? Qui l'unico elemento indecifrabile è negli occhi di chi guarda,
il quale, non capendo, decide di essere alle prese con un enigma.»
Aprì il baule, che era pieno fino all'orlo di giornali. «Prima di raggiungervi qui, mi sono fermato a Glen Eliza. La vostra cameriera, Daphne, una
ragazza dall'ottimo carattere e dall'arguzia pungente, è stata così gentile da
permettermi di portare via buona parte della nostra collezione di periodici,
che, negli ultimi mesi, è rimasta inutilizzata nella vostra biblioteca. Anzi,
ha insinuato che avrei dovuto consigliarvi di sbarazzarvene, giacché rende
impossibile la pulizia della stanza. Ora, per favore» continuò, tornando a
voltarsi nella mia direzione, «spiegatemi con precisione dove è racchiuso il
mistero delle istruzioni di Poe alla sua cara Muddy.»
Rilessi quelle righe in silenzio. Poiché temo di non ricevere la lettera...
«Innanzi tutto, sembra che abbia una paura singolare e insolita di non entrare in possesso della missiva.»
«Giusto.»
«E, inoltre, escogita un metodo piuttosto macchinoso grazie al quale
crede di poterlo impedire. Ricorrendo, in altre parole, all'uso di un nome
falso, E. S. T. Grey.»
«Questo, potrebbe sostenere qualcuno, è il nostro miglior indizio per
concludere che, alla fine, Poe era pazzo... delirante.»
«Ma voi non siete d'accordo?»
«Sarebbe un assunto del tutto infondato. Le scelte, mio buon monsieur
Clark, sono meno razionali e assai meno prevedibili di quanto sembri, ed è
questo a renderle così prevedibili per l'individuo pensante. Monsieur Poe,
non dobbiamo dimenticarlo, non era un uomo qualunque; le sue scelte che
paiono così irrazionali comunicano questa impressione perché, in realtà,
sono del tutto razionali. Forse ci sarà utile rammentare dov'era diretto Poe
quando ha scritto quelle parole nell'autunno del 1849, e dove sua suocera
riceveva le sue lettere.»
«Abbastanza facile. Mentre scriveva, Poe progettava di partire per Filadelfia prima di proseguire verso Fordham, nei pressi di New York, per portare Muddy a Richmond, dove avrebbe sposato Elmira Shelton. Muddy ha
ricevuto la missiva nella loro casetta di campagna a New York. Come ripeto, tuttavia, questo sembra abbastanza facile.»
«Allora lo è anche la spiegazione di quelle istruzioni inconsuete. In precedenza, avete accennato alle numerose città in cui Poe aveva vissuto da
adulto.»
«Dopo Baltimora, si era trasferito con Sissy e Muddy a Richmond, in
Virginia, per diversi anni. Poi a Filadelfia per circa sei anni. E infine,
nell'ultima fase della sua vita, aveva abitato a New York con Muddy.»
«Esatto. Dunque, comprenderete perché Muddy doveva scrivere: "Egr.
Sig. E. S. T. Grey".»
Lo guardai con incredulità. «Non lo comprendo affatto!»
«Perché, monsieur Clark, negate categoricamente la semplicità della situazione quando è già stata messa a nudo per noi? È stata una fortuna che,
a più riprese durante il mio soggiorno, abbiate descritto con precisione e
rigore il funzionamento dei vostri uffici postali americani. Se ho capito bene, nell'anno in questione, il 1849, le lettere nel vostro Paese non venivano
mai consegnate alle singole residenze, ma solo all'ufficio postale della città, dove il destinatario poteva ritirare la corrispondenza a lui indirizzata.
Se, nel 1849, fosse giunta a New York una missiva per Edgar A. Poe,
quest'ultimo sarebbe andato a ritirarla. Se, nel 1849, fosse giunta all'ufficio
postale di Filadelfia una missiva indirizzata a Edgar A. Poe, pensate a cosa
sarebbe inevitabilmente accaduto: il direttore, consultando la sua lista di
nomi degli ex residenti della città, e scoprendo che il nome corrispondeva a
uno di quelli sulla lista, avrebbe inoltrato la busta all'ufficio postale della
località in cui quella persona si era trasferita. In altre parole, una lettera di
Muddy spedita da New York a Filadelfia e indirizzata a Edgar A. Poe sarebbe stata considerata un errore dall'ufficio postale di Filadelfia e sarebbe
stata subito rispedita a New York.»
«Certo!» esclamai.
Proseguì. «Essendo anche lei un'ex residente di Filadelfia, Muddy l'avrebbe saputo e non avrebbe trovato nulla di strano nelle istruzioni di Poe,
che invece a noi sembrano così curiose. Il timore apparentemente bizzarro
di non ricevere la missiva di Muddy a Filadelfia era, in realtà, del tutto ragionevole. Se Edgar Poe si fosse presentato con il suo nome all'ufficio postale di Filadelfia, non vi sarebbe stata alcuna corrispondenza ad aspettarlo, giacché qualsiasi busta recante quel nome sarebbe stata rispedita; se avesse dato un nome falso, concordato in anticipo con la sua corrispondente, e una lettera fosse stata indirizzata a quel nome, avrebbe invece ricevuto la missiva senza problemi.»
«Ma non capisco perché ha chiesto a Muddy di non firmare la lettera.»
«Poe era inquieto. Muddy era l'ultimo membro rimasto della sua famiglia. "Rispondete immediatamente", scrive. Ricevere quelle righe era fondamentale, e qui lo scrittore ha mostrato segni di una meticolosità esagerata... non di illogicità, bensì di razionalità eccessiva. Sapeva che, quando si
piega e si sigilla una lettera, la firma e l'indirizzo possono essere confusi.
Se una simile confusione avesse avuto luogo, e il direttore dell'ufficio postale di Filadelfia avesse ritenuto erroneamente che la busta fosse indirizzata a Maria Clemm, anziché firmata da lei, la lettera sarebbe tornata, ancora una volta, direttamente a New York. Forse ricorderete che, in genere,
monsieur Poe si preoccupava della posta anche nella vostra sporadica corrispondenza con lui, manifestando in varie occasioni il timore che le lettere
andassero smarrite o recapitate all'indirizzo sbagliato. In un caso, scrive, se
non erro: "Scommetto dieci a uno che ho indirizzato male la lettera, poiché
sono molto sbadato in queste cose", riferendosi a qualcuno che non aveva
risposto a una delle sue missive. Grazie alle biografie, sappiamo anche che
Poe, da ragazzo, patì le sue prime gravi pene sentimentali allorché le sue
lettere non raggiunsero mai Elmira, il suo amore giovanile; e che un altro
corteggiamento, rivolto alla cugina Elizabeth Herring, andò a monte quando Henry Herring lesse le missive che contenevano i versi di Poe. Anzi, la
confusione riguardo alla collocazione di una lettera, l'ansia riguardo a chi
la possiede, e gli equivoci cui può condurre il modo in cui viene piegata e
firmata sono l'argomento di uno dei suoi migliori racconti del raziocinio e
dell'analisi, con cui credo abbiate molta familiarità.
«Vi è tuttavia la questione dello pseudonimo scelto da Poe, questo E. S.
T. Grey. In realtà, il nome utilizzato non aveva alcuna importanza purché
non fosse Edgar Poe, e non fosse comune come George Smith o Thomas
Jones, il che avrebbe comportato il rischio che qualcun altro portasse via la
lettera con una pila di altra corrispondenza. Monsieur Poe desiderava dunque che Muddy usasse un nome non con una, ma con due iniziali di mezzo, cosicché fosse assai più probabile che la missiva gli venisse recapitata.
«Vorrete nondimeno ulteriori spiegazioni riguardo al nome, suppongo.
Benissimo. In uno degli ultimi numeri della rivista fallita "Broadway
Journal", di cui Poe era stato direttore, noterete che il poeta ha pubblicato
due volte un annuncio chiedendo fondi per garantire il futuro (ormai segnato) del periodico. In quelle inserzioni raccomanda di spedire la corrispondenza finalizzata a tale scopo a "E. S. T. G.", presso la redazione del
giornale. Forse desiderava essere discreto nella raccolta del denaro. Sia
come sia, quando ha scritto a Muddy quella lettera quattro anni dopo, era
impegnato in un altro tentativo di fondare una sua rivista (questa volta
"The Stylus"), e forse la somiglianza tra le due situazioni, e le sue corrispondenti speranze in un successo tardivo, gli hanno evocato automaticamente il medesimo nom de plume di E. S. T. Grey. Le lettere che compongono il nome (E. S. T. G.) non possiedono altro significato, non contengono altro codice, se non il legame che rappresentavano tra queste due epoche della sua vita. I codici e le simmetrie sono per chi pensa troppo a pensare. Abbiamo dunque chiarito definitivamente il mistero delle istruzioni
di Poe a sua suocera.» Con una punta di soddisfazione, Duponte ripose nel
baule i fogli relativi a quell'argomento.
«Ma...» feci. Scorgendo un lampo nei suoi occhi, mi zittii.
«Ma?»
«Una volta non avete forse detto, monsieur Duponte, che questo punto
sarebbe stato una seconda prova inconfutabile del mancato arrivo di Poe a
Filadelfia?»
«Già. Come rammenterete, uno dei necrologi che avete raccolto dopo la
morte di Poe proveniva dal "Public Ledger" di Filadelfia. Troverete anche
quello, credo, tra gli articoli che ho portato da Glen Eliza.»
L'annuncio funebre compariva nel «Ledger» del 9 ottobre 1849, due
giorni dopo il decesso di Poe a Baltimora. Individuata la copia giusta, gliela porsi.
Me la restituì. «Che cos'è?»
«Be', il quotidiano che mi avete chiesto, monsieur Duponte!»
«Non vi ho chiesto nulla di simile. Ho soltanto affermato che era nel baule. Rimettetecelo. Quel necrologio di monsieur Poe è superficiale come
quasi tutti gli altri. Ma non avrete dimenticato che, poco dopo il nostro arrivo a Baltimora, vi avevo esortato a recuperare tutti i numeri dei giornali
risalenti a una settimana prima e a una settimana dopo ciascun articolo.»
«Non l'ho dimenticato» confermai.
«È la serie di numeri prima di quel necrologio quella su cui dovreste
concentrare la vostra attenzione. Mentre li cercate, ricordate che Poe aveva
pregato Muddy di rispondere immediatamente alla sua lettera. Lo scrittore
aveva concluso la medesima missiva supplicando di nuovo sua suocera,
come se quest'ultima potesse scordarsene: "Non dimenticate di scrivere
immediatamente a Filadelfia, cosicché la vostra lettera sia già lì al mio arrivo". Muddy non avrebbe certo potuto ignorare implorazioni tanto insistenti ed esimersi dallo scrivere a suo genero una parola gentile mentre
quest'ultimo era in viaggio.»
Recuperai tutte le copie del «Public Ledger» di Filadelfia che trovai nel
baule. Duponte mi ordinò di aprire quella del 3 ottobre 1849, il giorno in
cui avevano rinvenuto Poe al Ryan di Baltimora. Mi invitò quindi a leggere l'ultima pagina, quella in cui il direttore dell'ufficio postale elencava i
nomi dei destinatari della corrispondenza non ritirata. Lista delle missive
giacenti all'ufficio postale di Filadelfia, diceva. Lì, tra i minuscoli caratteri
del lunghissimo elenco, individuai la seguente voce:
GREY, E. S. F.
Sfogliando rapidamente il numero successivo che riportava una lista analoga, scorsi il medesimo nome.
«Dev'essere lui» conclusi.
«Certo che è lui. Qui leggiamo E. S. F. Grey anziché E. S. T. La lettera
"F", possiamo esserne sicuri, può divenire facilmente una "T" nella calligrafia di coloro che scrivono frettolosamente, come Poe dimostra nelle sue
lettere a voi, monsieur Clark. Muddy aveva scambiato la "T" di Poe per
una "F"; oppure l'ufficio postale di Filadelfia aveva scambiato la "T" di
Muddy per una "F"; o ancora il "Ledger" aveva scambiato la "T" del direttore dell'ufficio postale per una "F". Il nome di Poe aveva subito una nuova
trasformazione. Ma non dubitate: questa è la missiva di Muddy al poeta,
giunta a Filadelfia, se dovessimo calcolare la velocità della posta, proprio
nel momento previsto dopo che la signora Clemm aveva ricevuto la lettera
di Poe del 18 settembre e, accontentando le richieste del genero, aveva
scritto e indirizzato la sua risposta a monsieur Grey presso l'ufficio postale
di Filadelfia.»
«E il "Ledger" la indica in due giorni diversi.»
«Interessante, monsieur Clark, se ho inteso le regole del vostro sistema
postale allorché me le avete spiegate.»
«È vero. La prima volta che compare l'annuncio, il destinatario deve pagare due centesimi in più per le spese postali. In caso di un secondo e ultimo annuncio, gli vengono addebitati altri due centesimi. Poco dopo, la
missiva diventa una "lettera morta", e il direttore la getta via.»
«Il 3 ottobre, la data in cui la missiva viene elencata per la prima volta
sul "Ledger" di Filadelfia, è stato l'ultimo giorno che Poe avrebbe mai trascorso fuori da una camera d'ospedale» mormorò Duponte con espressione
assente. «Quel giorno, avremmo potuto varcare la porta dell'ufficio postale
di Filadelfia come se niente fosse e presentarci come l'Egr. Sig. E. S. T. (o
F, se volete) Grey (giacché voi non siete Grey meno di quanto lo fosse Poe) e ritirare la lettera.»
«Probabilmente quella è stata l'ultima missiva mai scritta a Edgar Poe»
commentai con mestizia, rileggendo il nome del ricevente e giudicando
ancor più triste che quell'ultima lettera, mai aperta e ormai abbandonata da
tempo, non fosse neppure stata indirizzata al poeta e, presumibilmente,
nemmeno firmata dall'unica donna che gli voleva bene.
«Probabilmente sì» convenne Duponte, assentendo.
«Avrei voluto vederla.»
«Ma non è necessario. Non per i nostri scopi, intendo. La lista del giornale dimostra che, nel periodo corrispondente agli annunci pubblicati dal
direttore dell'ufficio postale, Edgar Poe non era a Filadelfia. Ricordate infatti la veemenza con cui aveva insistito affinché Muddy gli rispondesse
immediatamente cosicché la lettera fosse lì al suo arrivo; è fuor di dubbio
che, se il suo arrivo avesse avuto luogo, sarebbe corso con impazienza a ritirare la busta.»
«Abbiamo pertanto un altro motivo per affermare con sicurezza che Poe
non aveva raggiunto Filadelfia» continuò Duponte. «Come ripeto, abbiamo
tuttavia molte ragioni per ritenere che ci abbia provato, e possiamo immaginare che non ci sia riuscito per un pelo.»
«Ma se ci ha provato senza riuscirci, che cosa è successo?»
«Ricordate che cosa abbiamo asserito circa il presunto alcolismo di Poe?»
«Sì. Che non era sregolato, bensì intollerante in un grado mai sperimentato da gran parte della gente. Il fatto che un singolo bicchiere di vino mutasse totalmente la sua indole, come testimoniato da coloro che lo conoscevano bene, indicava non che il poeta fosse ubriaco per abitudine, ma
l'esatto contrario... cioè che presentasse una rara sensibilità ai liquori.
Troppe persone, in luoghi e momenti diversi, hanno ribadito questo particolare per credere che sia soltanto una giustificazione gentile inventata da
chi gli era amico. Un bicchiere, abbiamo appreso, era sufficiente per cagionare uno spaventoso attacco di deliquio che poteva condurlo ad altri
comportamenti incerti e incontrollati. Può essere accaduto prima che arrivasse a Filadelfia?» suggerii.
«Ne riparleremo tra un attimo. Ora abbiamo ipotizzato, usando tutte le
informazioni disponibili, sia che Poe abbia cercato con tutta probabilità di
raggiungere Filadelfia sia che, nonostante ciò, non vi sia mai arrivato. Resta da appurare come sia tornato a Baltimora. Il barone, se il suo ragionamento fosse giunto fin qui, avrebbe senz'altro affermato che, dopo essere
salito sul treno per Filadelfia, Poe era stato avvicinato da un farabutto e costretto, per qualche motivo malvagio e inconcepibile, a fare ritorno con un
altro convoglio a Baltimora, dove poi è stato rinvenuto. Claude Dupin era
romantico quanto gli scrittori di romanzi d'amore. Non avrebbe alcun senso se un aggressore di qualsiasi genere avesse rimesso Poe su un treno per
Baltimora.
«Ciò non significa tuttavia che non l'abbia fatto qualcun altro, qualcuno
che ha agito senza perfidia. Anzi, è un'attività cui i controllori si dedicano
sovente per una serie di ragioni, con passeggeri che sono rissosi, indisposti, clandestini oppure privi di sensi. Per qualcuno che, come Poe, ha vissuto sia nella città di partenza, Baltimora, sia in quella di destinazione, Filadelfia, è assai più probabile incontrare sul treno un conoscente in viaggio
sulla medesima tratta piuttosto che un aggressore.
«Non è altro che un'ipotesi, direte, ma talvolta, monsieur Clark, è l'unica
cosa che ci aiuti a comprendere gli avvenimenti. Consideriamo la parola
inferiore alle pratiche consolidate del ragionamento. In realtà, ipotizzare è
una delle capacità più elevate e indistruttibili della mente umana, un'arte
assai più interessante della dimostrazione o del ragionamento, perché deriva direttamente dall'immaginazione.
«Orbene, immagineremo che Poe si sia imbattuto in un conoscente anziché in un nemico, e che quel conoscente, per definizione qualcuno che conosce lo scrittore ma non ha un'amicizia intima con lui, l'abbia invitato a
bere un drink sul convoglio, o in una stazione intermedia. Possiamo supporre che Poe, magari sperando di procurarsi ulteriore sostegno finanziario
per la sua rivista, abbia accettato l'invito, giacché il potenziale benefattore
gli ha proposto di bere un solo drink; proposta fatta, senza dubbio, da
qualcuno che non conosceva abbastanza il Poe adulto da essere al corrente
dei suoi problemi con il consumo di alcol. Forse, allora, un amico di infanzia, oppure un altro ex cadetto di West Point, poiché, rispetto ai membri di
qualsiasi altra istituzione, i vecchi componenti dell'esercito hanno maggiori probabilità di sparpagliarsi nei diversi Stati. O, magari, un compagno
d'università. Forse abbiamo già udito il nome di un simile individuo.»
«Z. Collins Lee!» interloquii. «Frequentava lo stesso college di Poe. Ora
è procuratore distrettuale, ed era il quarto uomo presente alle esequie.»
«Monsieur Lee è una possibilità da tenere in considerazione, un astante
del funerale che abbiamo trascurato a favore degli altri tre, più degni di nota. Rifletteteci. A parte il signor Spence (il custode del cimitero), l'impresario delle pompe funebri, il becchino e il sacerdote, solo quattro persone
hanno assistito a quella breve cerimonia.»
«Sì. Il dottor Snodgrass, Neilson Poe, Henry Herring e il signor Z. Collins Lee. Non c'era nessun altro.»
«Pensate a cosa accomuna i primi tre, monsieur Clark. Il fatto che conoscessero Edgar Poe, naturalmente. Ma ciò varrebbe per molti altri abitanti
di Baltimora, sicuramente più di quattro individui, giacché Poe aveva vissuto in questa città per diversi anni. Amici, amanti, ex professori, altri parenti. No. L'elemento comune più curioso è il fatto che ciascuno dei tre abbia un qualche legame con i suoi ultimi giorni di vita. Monsieur Herring
era all'hotel Ryan, dove Poe è stato rinvenuto e dove, in seguito, Snodgrass
è stato convocato e Neilson Poe si è recato all'ospedale dopo essere stato
informato delle condizioni di suo cugino. Il funerale non era stato annunciato in anticipo sui giornali o con altri mezzi e, certamente, quei tre signo-
ri avrebbero potuto chiedere ad altre persone di intervenire se l'avessero
voluto.
«Notando quanto unisce tutti e tre gli altri astanti, non dobbiamo dunque
ritenere assai probabile che anche il nostro Z. Collins Lee avesse veduto
Poe negli ultimi giorni prima del suo decesso? Lee è un uomo facoltoso, e
un candidato papabile quanto qualsiasi altro per aver viaggiato in treno e,
ricordando i tempi del college che sono sempre dissoluti, per aver bevuto
un unico bicchiere di liquore con il poeta. Poe, dal canto suo, sapeva che
monsieur Lee era un personaggio illustre nel campo legale, e avrà cercato
di essere socievole per ottenere l'appoggio necessario alla campagna per la
sua rivista. Se ciò fosse vero, spiegherebbe subito due cose: non solo l'episodio sul convoglio, ma anche la presenza di monsieur Lee alle esequie di
cui pochissime persone erano al corrente. Dopo il loro incontro, se procediamo, Poe ha avuto un attacco di deliquio, come lo chiamavate voi, per
aver ceduto a quell'unica tentazione. Questo è ciò che il nostro altro gruppo antialcolico, i Sons of Temperance di Richmond, cui apparteneva il vostro monsieur Benson, non ha voluto accettare e dunque portare a termine
la sua inchiesta. Desideravano che Poe non avesse bevuto un solo goccio
quanto gli altri speculatori della causa antialcolica desideravano che avesse
bevuto un barile intero. Ecco perché avete avuto l'impressione che monsieur Benson nascondesse qualcosa. Giungendo a Baltimora così presto
dopo la morte di Poe, aveva scoperto senza dubbio quel piccolo aneddoto.»
«Aspettate! Torniamo a quell'unico drink consumato sul treno» intervenni, indignato. «L'amico, fosse egli il signor Collins Lee o qualcuno che
non conosciamo, non avrebbe assistito Poe quando si è sentito male?»
«Se, come possiamo immaginare, questo amico non sapeva alcunché
dell'intolleranza di Poe all'alcol, e se il poeta, vergognandosi di questo disturbo, ha cercato il più possibile di dissimulare il suo degrado mentale e
razionale a tutela della sua dignità, può darsi che il conoscente si sia allontanato senza avvedersi di aver abbandonato un uomo in difficoltà. Benché
Poe possa essersi sentito tradito da un simile comportamento, l'amico ignaro non se ne sarà accorto. Un personaggio come Z. Collins Lee, un avvocato oberato di impegni, può aver scoperto che qualcosa non andava solo a
distanza di giorni, allorché si è imbattuto nel collega Neilson Poe e gli ha
accennato all'incontro con suo cugino. Cercate di ricordare per un momento come lo scrittore ha risposto quando il dottor Moran dell'ospedale di
Baltimora, pensando di tranquillizzare un paziente angosciato, gli ha pro-
messo di rintracciare i suoi amici.»
«"La cosa più bella che il mio miglior amico potrebbe fare sarebbe farmi
saltare il cervello con una pistola."»
«Esatto. In quel momento, Poe riteneva che un amico potesse soltanto
danneggiarlo, monsieur Clark. Non sappiamo forse il perché? Non possiamo forse individuare la causa di quei sentimenti nelle ultime esperienze
vissute dal poeta? Poe era andato a cercare il dottor Brooks, e invece era
rimasto in mezzo a una strada. Aveva incrociato un vecchio conoscente sul
treno, soltanto per sentirsi obbligato a esporsi a una tentazione pericolosa.
Aveva convocato il suo amico Snodgrass al Ryan, solo per riceverne
sguardi di disapprovazione e accuse chiare, seppur tacite, riguardo al suo
alcolismo. Henry Herring, un suo parente, l'aveva aiutato nella taverna, ma
anziché condurlo a casa sua, l'aveva mandato da solo in un ospedale fatiscente.
«Credete che, tra tutte le persone del mondo, Poe avrebbe convocato il
dottor Snodgrass se fosse stato davvero ubriaco fradicio? Non negheremo
che monsieur Poe aveva ammesso di aver ecceduto nel bere in alcuni periodi della sua vita, e dunque riconosceremo senza indugio che aveva alternato fasi di astinenza e di dissolutezza. Proprio per questo, giacché era
esperto nell'indulgere all'alcol e nel resistere al vizio, possiamo tuttavia interpretare con intelligenza il riferimento specifico a Snodgrass che lo scrittore ha fatto a monsieur Walker nella taverna... possiamo leggere quel riferimento con gli occhiali adatti. Se Poe fosse stato nel bel mezzo di una
sbornia, se fosse venuto meno al suo impegno, l'ultima persona che avrebbe menzionato sarebbe stato un illustre leader del movimento antialcolico
locale come Snodgrass. Inoltre, può darsi che, mentre era al Ryan, abbia
sentito dire che monsieur Walker era un tipografo del "Sun", e che l'abbia
scelto come testimone diretto di quella situazione. Per di più, se Poe aveva
letto le ultime notizie dei giornali, sapeva che, solo un giorno prima, Snodgrass aveva dovuto rinunciare a John Watchman, il candidato della sua
organizzazione, perché quest'ultimo aveva bevuto, e che il dottore avrebbe
cercato di compensare quell'accadimento come avrebbe fatto qualsiasi politico. No, Poe ha pronunciato il nome di Snodgrass dinanzi a Walker per
trasmetterci un messaggio: "Non sono ubriaco; anzi, sono stato così moderato, se non addirittura astemio, da chiedere aiuto a un rappresentante severo e alacre della lega antialcolica, e da farlo tramite un tale che lavora per
la stampa".»
Duponte continuò: «Torniamo al treno. Poe si è congedato dal suo ami-
co, che, possiamo supporre, è sceso per primo o si è semplicemente diretto
verso un'altra carrozza. In condizioni fisiche precarie, lo scrittore ha attirato l'attenzione di un controllore zelante, che ha creduto stesse male ma
senza sapere il perché. Per chissà quale ragione, l'uomo ha dato per scontato che il passeggero avesse più persone disposte ad aiutarlo a Baltimora, o
forse Poe ha borbottato qualcosa in tal senso. Alla stazione successiva, forse Havre de Grace, il controllore, scorgendo l'opportunità di compiere una
buona azione, l'ha accompagnato su un convoglio in partenza nella direzione opposta.
«Tenendo presente tutto ciò, possiamo analizzare gli eventi verificatisi
in ospedale con un maggior grado di sicurezza. Alle domande del medico,
Poe ha risposto di non sapere come fosse giunto a Baltimora né perché.
Non era in grado di spiegarlo. Ciò non è dipeso da giorni passati a gozzovigliare né dalla somministrazione di oppiacei per mano di invasati politici, come sostiene il barone. È dipeso dal fatto che il poeta alludeva al suo
secondo arrivo a Baltimora, quello successivo alla sua partenza, e non riusciva a ricordare come fosse finito sul treno del ritorno. Abbiamo così
smentito le affermazioni della stampa antialcolica su Poe, e la tesi di Claude Dupin secondo cui il poeta era stato rapito da un circolo politico».
Mi era chiaro come aveva confutato le dichiarazioni della lega antialcolica, ma non come ciò si collegava alla teoria del barone. Glielo domandai.
«Rammenterete la conclusione di Claude Dupin su questo punto, monsieur Clark, giacché l'avete trascritta nel vostro taccuino.»
La rammentavo.
Quei manigoldi dei whig della quarta sezione, il cui quartier generale era la rimessa delle autopompe della Vigilant Fire
Company, di fronte al Ryan, hanno chiuso il poeta inerme in una
cantina insieme con altri sventurati: vagabondi, perdigiorno e forestieri. Ciò spiega come mai Poe, un autore assai famoso, non
sia stato veduto da nessuno nel corso di quei giorni.
«A proposito del riconoscimento, avete notato la logica assurda del barone? In conseguenza delle sue azioni nei confronti della stampa di Baltimora e di altre città, e per via dei numerosi volumi e articoli biografici
pubblicati dopo la morte di Poe, il ritratto dello scrittore è stato ampiamente divulgato tra le masse, e il suo viso è diventato noto solo allorché hanno
preso il via le indagini sulla sua scomparsa. Ma prima, quando Poe era in
vita, l'avrebbero riconosciuto, di norma, soltanto gli altri poeti e i lettori
appassionati, che, come minimo, avrebbero avuto meno probabilità di gironzolare per la strada, e più probabilità di trascorrere le giornate in ambienti chiusi, come uffici, biblioteche e sale di lettura. Così, il fatto che
nessuno abbia asserito di aver veduto Poe in quei giorni diviene molto meno sorprendente, se non addirittura ovvio. Inoltre, giacché Edgar non aveva annunciato il suo soggiorno a Baltimora, nessuno si sarebbe aspettato di
incrociarlo in città, neppure i suoi parenti. Questo, se pensiamo al funzionamento degli occhi e della mente umana, riduce di parecchio le possibilità
di riconoscimento. Avete mai avuto occasione di osservare che, quando vi
imbattete in un caro amico là dove non vi attendevate di vederlo, vi occorre più tempo del consueto per registrarne l'identità nel vostro cervello?
Anzi, più tempo di quanto ne avreste impiegato se aveste scorto qualcuno
con cui avete un legame assai meno intimo? La condizione del secondo individuo è infatti più simile a quella dello sconosciuto per la strada, e dunque più facile da identificare.
«Questo è un errore comune che commettono anche i giornali, monsieur
Clark. Rileggete l'"Herald" di New York e ne avrete una dimostrazione.»
Aprii il mio taccuino, dove avevo annotato la deposizione che intendevo
pronunciare quel giorno. La parte interessante dell'articolo scritto dal corrispondente di Baltimora nella settimana della morte di Poe riferiva quanto
segue:
Lo scorso mercoledì, giornata elettorale, è stato rinvenuto vicino
al seggio della quarta sezione, in preda a un attacco di mania a
potu e in condizioni davvero spaventose. Essendo stato riconosciuto da alcuni dei nostri cittadini, è stato caricato su una carrozza e condotto al Washington Hospital, dove ha ricevuto tutte le
cure necessarie.
«Vi siete accorto dell'errore, vero, monsieur Clark? Il corrispondente di
Baltimora si sforza di riportare i fatti così come sono avvenuti. Per esempio, è esatto e veritiero che Poe è stato "caricato" su una carrozza da persone che poi non l'hanno accompagnato, come vedremo entro breve. D'altra parte, sappiamo però che nessun cittadino aveva riconosciuto Poe. Ce
lo conferma un testimone oculare.»
«Alludete al messaggio di Walker a Snodgrass, che abbiamo trovato fra
le carte del dottore?»
«Sì. Ecco che cosa scrive Walker: "Vi è un uomo, piuttosto malconcio,
alla quarta sezione elettorale del Ryan, che va sotto il nome di Edgar A.
Poe e che sembra in condizioni assai gravi eccetera". Per Walker, Poe è
"un uomo"; il tipografo ha potuto precisare chi si trovava in grande difficoltà solo perché Poe gli aveva detto come si chiamava. Anzi, il suo linguaggio ("che va sotto il nome di Edgar A. Poe") indica che sospettava si
trattasse di un nome falso. Come se fosse uno pseudonimo. Altrimenti non
avrebbe forse scritto: "Il signor Edgar A. Poe sembra in condizioni assai
gravi"?»
Su richiesta di Duponte, seguitai a leggere il resoconto degli ultimi giorni di Poe redatto dal barone.
Probabilmente quei bricconi l'avevano drogato con vari oppiacei.
Durante la giornata elettorale, l'hanno condotto in giro per la città, in vari seggi. L'hanno obbligato a votare per i loro candidati
in ciascun seggio e, per rendere più convincente l'intera farsa,
l'hanno costretto a indossare abiti diversi ogni volta. Ciò spiega
come mai, al momento del suo rinvenimento, portava vestiti sudici
e cenciosi che non erano mai stati destinati a lui. Quelle canaglie
gli hanno tuttavia permesso di tenere la sua bella canna di Malacca, giacché le sue condizioni erano così debilitate che persino
quei furfanti si sono avveduti che avrebbe necessitato di un sostegno... Anzi, l'avrebbero trovato con la canna...
All'udire quelle frasi, Duponte sottolineò con una certa soddisfazione
che la teoria di Claude Dupin, seppur sagace, tentava di scoprire il motivo
per cui Poe era stato rinvenuto in quel luogo e perché portava quegli abiti,
anziché usare la ragione per scoprire la verità celata dietro tutto quello.
«Senza una dimora, in un posto in cui la sua famiglia aveva risieduto in
passato, in cui alcuni suoi parenti continuavano a risiedere, e sotto l'effetto
di quell'unico bicchiere di liquore bevuto in compagnia di Z. Collins Lee o
di un altro amico, Poe si sarà sentito totalmente solo allorché è rientrato a
Baltimora. Senza rifugio, non aveva altra scelta se non camminare sotto la
pioggia torrenziale per cercarsene uno, inzuppandosi i vestiti ed esponendosi all'insorgere di altre malattie. Avete già constatato in prima persona,
credo, una peculiarità degli abiti che quasi nessuno prende in considerazione. Quando i nostri abiti sono fradici, diciamo: "La mia camicia è inutile, è rovinata". A differenza di qualsiasi altro oggetto "rovinato", diremo
tuttavia, come la grande Sfinge, che la sua desolazione è temporanea; avete
notato che questa peculiarità ha consentito a Poe di scambiare i suoi indumenti con capi asciutti, che naturalmente non gli andavano bene come i soliti completi su misura. Probabilmente ciò è accaduto poco distante dal
Ryan. Possiamo rilevare che, nonostante tutti gli aggettivi utilizzati per evocare le condizioni di Poe, nessuna delle descrizioni dettagliate dei suoi
vestiti nel giorno in cui è stato rinvenuto usa il termine "bagnati", anche se
questa sarebbe la prima parola a sovvenirci in altre circostanze. Sappiamo
che il poeta non aveva venduto né scambiato quella singolare canna provvista di una spada, perché, anche nel suo stato mentale, ricordava che non
era sua. Si sarebbe premurato di restituirla al proprietario, il dottor Carter
di Richmond. È stata la sua dignità, non la sua paura della violenza, a indurlo a stringersela al petto.
«Pensando a Poe nella taverna, arriviamo ora ai sospetti del barone verso
gli Herring, George e Henry. Non servirà a nulla, come vorrebbe Claude
Dupin, confondere gli eventi collaterali con l'oggetto della nostra indagine.
Come avete osservato nel resoconto che mi avete fatto dopo aver udito la
versione di Snodgrass, allorché il dottore ha veduto le condizioni di Poe, è
salito al piano di sopra per scegliergli una stanza prima di mandare a chiamare i suoi parenti, che, come ben sapeva, abitavano nelle vicinanze. Tuttavia, appena Snodgrass ha sistemato la faccenda della camera, è incappato
in Henry Herring ai piedi delle scale... prima di avvisarlo. Snodgrass, distratto dai suoi crucci personali e dallo stato di salute dell'amico, non ha attribuito molta importanza a questo dettaglio sorprendente quando ve ne ha
accennato. Ma noi sappiamo che è importante.
«Abbiamo identificato George Herring, lo zio di Henry, come il presidente dei whig della quarta sezione, il gruppo che aveva utilizzato più volte l'hotel Ryan per i suoi raduni nelle settimane precedenti, e anche due
giorni prima delle elezioni. Il barone dà per scontato che, dopo tanta fatica,
anche George Herring si sia recato al Ryan, la fortezza dei whig, durante
quella giornata elettorale. Fin qui, il suo ragionamento è corretto. Tuttavia,
Claude Dupin sostiene poi che Henry e George Herring, sapendo che qualsiasi sostanza intossicante avrebbe avuto gravi effetti su Edgar Poe, l'abbiano scelto per inserirlo nella loro "nidiata", tramutandolo così in uno dei
loro elettori da condurre avanti e indietro per la città.»
«Eppure, monsieur Duponte, è una coincidenza assai strana - oserei dire
sospetta - che George e Henry Herring fossero presenti entrambi al Ryan
ancor prima che il dottor Snodgrass avvertisse i parenti di Poe.»
«Vi è un evento singolare in tutto questo, monsieur Clark, e, in effetti, si
tratta di una pura coincidenza, che rende l'altro accadimento del tutto naturale. Mi riferisco alla comparsa di George Herring nel luogo del rinvenimento di Poe. Costui si trovava lì perché era il presidente dei whig della
quarta sezione, e quel giorno il Ryan era il seggio elettorale di quella sezione. La sua presenza era naturale. Quanto a quella di Poe, ne analizzeremo il motivo tra un istante. Henry Herring era diventato uno zio acquisito
di Poe in seguito a un matrimonio. La donna però era ormai morta da alcuni anni e il suo decesso era stato seguito, a breve distanza, da un altro matrimonio; il che, possiamo presumere, aveva indotto Poe a definire monsieur Henry "un uomo senza scrupoli" in una delle sue lettere. Per riassumere, dunque, Poe è finito in un luogo dalla triplice funzione (ossia un hotel, una taverna e un seggio elettorale) con un uomo che era lo zio di un
suo ex zio. Temo che questa non sia una coincidenza come vorrebbe il barone.
«Sia come sia, secondo Claude Dupin, George Herring ha deciso di includere Poe nella sua nidiata di elettori perché aveva appreso dalla sua famiglia che il poeta diveniva molto vulnerabile quando era sotto l'effetto
anche delle più comuni sostanze intossicanti. Che sciocchezza! Giacché,
probabilmente, monsieur George sapeva di quell'eventualità, questa sarebbe stata una motivazione sufficiente per indurlo piuttosto a escludere lo
scrittore dalla sua nidiata, dove gli sarebbero stati utili solo individui che
sopportassero bene l'alcol.
«Ma, accantonando le ciance del barone su questo punto, torniamo alle
nostre cosiddette coincidenze. Avendo sentito parlare di Poe, e forse avendolo conosciuto tramite Henry Herring, George, vedendo il poeta in difficoltà, avrà quasi sicuramente mandato a chiamare suo nipote. La nostra pura coincidenza, la presenza di George Herring e Edgar Poe nel medesimo
edificio, ha generato in maniera assai naturale il secondo episodio, il singolare arrivo di Henry Herring prima che Snodgrass lo avvertisse.
«E che cosa significano gli eventi successivi, quelli che hanno condotto
al ricovero di Poe in ospedale? Snodgrass gli aveva riservato una stanza al
piano di sopra. George Herring non avrà voluto che Poe restasse al Ryan in
quelle condizioni, giacché, essendo il presidente dei whig, avrà voluto evitare proprio le accuse di utilizzo illecito o violento degli elettori che il barone gli avrebbe poi mosso. Henry Herring non era esattamente un compagnone di Poe, come Claude Dupin ha osservato a ragione, e avrà preferito
non invitarlo a casa sua, poiché ricordava ancora con disapprovazione che
il poeta aveva corteggiato sua figlia Elizabeth anni addietro. Snodgrass
non rammentava se vi fossero uno o due parenti di Poe al Ryan... quasi sicuramente perché si era ritrovato dinanzi sia Henry sia George Herring.
Quei tre hanno dunque mandato Edgar in ospedale, dove gli inservienti
hanno avvisato Neilson Poe.»
«Se non vi era nulla di losco, se gli Herring non hanno fatto alcunché,
monsieur Duponte, allora perché Henry e Neilson erano così riluttanti a discutere dell'argomento o ad autorizzare un'indagine di polizia?»
«Avete risposto alla vostra domanda formulandola, monsieur Clark.
Giacché non avevano fatto alcunché (o meglio, molto poco), non desideravano richiamare l'attenzione sulla faccenda. Rifletteteci. George e Henry
Herring erano arrivati ancora prima del dottor Snodgrass e non avevano
fatto nulla. Si sono limitati a spedire Poe all'ospedale da solo, sdraiato sui
sedili di una vettura. Come avete udito dal dottor Moran, si sono persino
dimenticati di pagare il cocchiere. Hanno segnato il destino di Poe anche
dando per scontato che fosse semplicemente ubriaco fradicio, perché hanno senz'altro comunicato quell'idea ai medici tramite il biglietto che accompagnava il poeta... cosicché le cure prestate al paziente sono state quelle superficiali fornite a chiunque si sbronzi, anziché quelle necessarie per
la sua complessa malattia, e forse per la serie di malanni imputabili al
freddo e alla spossatezza. Neilson Poe si è recato in ospedale, ma non è
nemmeno riuscito a vedere suo cugino.
«Questi accadimenti non sono qualcosa di cui la famiglia possa andare
fiera, soprattutto per un uomo ambizioso come monsieur Neilson, che non
voleva infangare il nome Poe. Ciò spiega anche perché i parenti non hanno
organizzato un funerale più solenne. Non avranno voluto attirare l'attenzione sul loro coinvolgimento negli ultimi giorni del poeta né rammentare
a nessuno che, in precedenza, Edgar Poe aveva pronunciato parole caustiche sia su Henry sia su Neilson. Vi è una certa "vergogna" in tutto questo,
il vocabolo usato da Snodgrass nella sua poesia sull'argomento. I metodi
spesso indispensabili per comprendere le motivazioni di qualcuno non si
incentrano su ciò che quella persona ha fatto, bensì su ciò che ha semplicemente evitato di fare o trascurato di considerare.»
«Nondimeno» proseguì Duponte «il barone non è del tutto fuori strada
quando giudica più che fortuito il fatto che il rinvenimento di Poe sia capitato durante una giornata elettorale. Claude Dupin vuole trovare la causa e
l'effetto; noi, invece, cercheremo la causa e la causa. Come descrivereste,
monsieur, la città di Baltimora nei giorni delle elezioni?»
«Un poco imprevedibile» ammisi. «Turbolenta, a volte pericolosa, in alcuni quartieri. Ma ciò significa forse che Poe è stato rapito?»
«Certo che no. L'errore di uomini come il barone, che impiegano i loro
pensieri vorticosi per la creazione della violenza, è immaginare che quasi
tutte le manifestazioni di violenza abbiano un senso e un motivo, quando,
per loro natura, non ne hanno affatto. Non dovete tuttavia tralasciare gli effetti secondari che possono scaturire dagli scombussolamenti esterni. Pensate a monsieur Poe. Esposto a quel tempo da lupi, dopo non essere riuscito a procurarsi i contanti a Filadelfia, e dopo aver bevuto quell'unico bicchiere di liquore che l'aveva indebolito e confuso, sarà stato vulnerabile ai
più acerrimi nemici della nostra salute: primo, la paura, e secondo, l'orrore.
«Ora, quei periodici locali che avete raccolto poco dopo il nostro arrivo
da Parigi, vi dispiacerebbe posarli su questo tavolo?»
Il primo ritaglio che Duponte scelse proveniva dal «Sun» di Baltimora
del 4 ottobre, il giorno dopo le elezioni. «Pochissimo scompiglio» affermava, riferendo gli eventi di quel periodo. «Non abbiamo ricevuto notizie
di disordini ai seggi o altrove.»
Un altro articolo della stessa giornata diceva:
Ieri pomeriggio, un tale con più alcol in corpo di quanto potesse
convenientemente tollerarne si è appostato ai piedi di Lexington
Market, e per un'ora ha assalito e aggredito tutti i passanti, che,
per fortuna del povero ubriaco, l'hanno giudicato di indole assai
benevola, altrimenti gliele avrebbero suonate di santa ragione.
Ne ha colpiti diversi in viso, ma quelli si sono astenuti dal reagire
udendolo dichiarare di averne «vedute di cotte e di crude». In seguito, si è recato in una taverna, e da lì, forse cercando giustizia,
ha raggiunto l'ufficio del giudice Root, che era chiuso per l'ora di
pranzo.
E infine questo, risalente al medesimo pomeriggio:
Aggressione. Mercoledì sera, verso il crepuscolo, mentre una
carrozza con quattro passeggeri, tra cui il signor Martin Rudolph, ufficiale di macchina del piroscafo Columbia, oltrepassava
l'angolo tra Lombard e High Street, uno scellerato ha lanciato un
grosso sasso, che ha centrato il signor R. alla testa, fortunatamente cagionandogli soltanto un brutto ematoma.
«Il primo pezzo» riprese Duponte «sottolinea che non vi sono stati disordini in nessuna zona della città. Ma qui, a parte, troviamo alcuni esempi
di quelli che possiamo soltanto definire disordini. Vedete, in un giornale,
soprattutto in quelli più raffinati, un reporter si accorge a malapena dell'altro, o una rubrica di un'altra, sicché possiamo asserire di aver letto qualcosa solo dopo aver studiato tutte le pagine, non un singolo servizio. Probabilmente è stato un poliziotto a parlare loro della mancanza di disordini. La
polizia europea vuole che tutti i criminali sappiano della sua presenza; la
polizia americana vuole far credere alla gente che non esistano criminali.
«Esaminiamo questi due disordini distinti. Primo, abbiamo un tizio
chiassoso e villano, accusato di aver colpito in viso diversi passanti, ma lasciato agire indisturbato dai suoi concittadini. Benché il direttore del quotidiano, dalla comoda posizione dietro la sua scrivania, abbia preferito ritenere che le vittime non si fossero indignate perché avevano giudicato l'ubriaco "di indole benevola", mi domando quanti individui siano stati considerati tali dopo aver preso a pugni delle persone. Invece, possiamo ipotizzare con sicurezza che, quel giorno, disturbi di quel genere sono stati,
eccezionalmente, così numerosi da non attirare abbastanza l'attenzione della polizia e della gente comune. In altre parole, vi erano tanti uomini come
questo individuo che costui non è riuscito a suscitare scalpore. Ciò può
darci un'idea più precisa degli eventi verificatisi nel resto della città durante quella giornata di quanto facciano le fantasie dei direttori dei giornali.
«Passiamo ora al terzo ritaglio, che descrive un aneddoto avvenuto, credo, non troppo lontano dal seggio elettorale tra Lombard e High Street in
cui è stato rinvenuto Poe; rileggete questo articolo, che parla di un ufficiale
di macchina e degli altri passeggeri di una carrozza colpiti da un grosso
sasso gettato da un furfante. Possiamo supporre che anche Poe abbia dovuto schivare una tempesta di pietre vaganti in quei vicoli, o magari che il
poeta, ormai distrutto dall'alcol, dalle molte ore di freddo e pioggia e dalla
totale privazione di sonno, sia stato abbastanza disorientato da scagliare
sassi contro i mascalzoni, i delinquenti e i bricconi reali o presunti che affollavano le strade quel giorno. Non fa alcuna differenza se lo immaginiamo nei panni dell'aggressore o del bersaglio, o se sia stato coinvolto in
quell'episodio oppure no. Sappiamo che, a quel punto, Poe era probabilmente in preda a una paura folle per via delle azioni barbare e violente cui
aveva assistito nelle vie quel giorno. Il seggio elettorale, anziché essere un
oscuro covo di crudeltà, come il vostro barone ritiene necessario presumere, può benissimo essergli sembrato un rifugio, un luogo in cui era verosimile che vi fosse almeno una parvenza di ordine. Poe vi è entrato in cerca
di un aiuto che, ahimè, è arrivato troppo tardi. Abbiamo così seguito lo
scrittore passo dopo passo dal suo sbarco al suo inutile salvataggio operato
da Snodgrass.»
«Ma le parole pronunciate da Poe all'ospedale» obiettai. «Le sue invocazioni di "Reynolds"... non possono indicare una responsabilità o un coinvolgimento da parte di Henry Reynolds, il falegname che prestava servizio
come segretario nel seggio in cui è stato trovato lo scrittore?»
Duponte assunse un'espressione palesemente divertita.
«Non pensate che possa essere andata così?» chiesi.
«Non ho motivo di dubitarne in quanto possibilità fattuale, se è questo
che intendete, monsieur Clark. Altri penseranno di poter indovinare che
cosa vi era di inconsueto nella mente di Poe, un'impresa impossibile per
una persona qualunque, molto meno per un genio. Per rendervene conto,
leggete i suoi racconti, leggete le sue poesie; individuerete tutto quanto vi
è di straordinario e singolare, ossia non ripetuto nei flussi mentali al di fuori di Poe. Per capire le fasi della sua morte, dovete tuttavia accettare quel
che vi è di ordinario in lui, in chiunque, e in tutti coloro che lo circondavano e si scontravano con il suo genio. Sarà questo a fornirvi le risposte.
«Il fatto che Poe abbia gridato per molte ore questa parola, "Reynolds",
durante la notte del suo decesso in ospedale, è proprio l'elemento cui non
dobbiamo prestare attenzione, se il nostro scopo è comprendere come è
morto. A causa della combinazione delle varie circostanze che abbiamo elencato, il poeta non era lucido. L'insistenza del barone e di altri osservatori su quelle grida dimostra che molti non sanno come e perché gli individui
pensino e agiscano in un certo modo. Anche senza sviscerare la questione,
possiamo ricordare che Poe si sentiva completamente solo. In verità, avrebbe potuto chiamare chiunque. Forse quello era l'ultimo nome che aveva udito, magari quello dello stesso falegname che ci ha fatto visita nel vostro salotto, oppure era il nome di un uomo il cui ruolo in una spaventosa
vicenda di parecchi anni prima rende troppo pericoloso qualsiasi accenno
da parte nostra.* Più probabilmente, tuttavia, aveva qualcosa a che fare
con una faccenda assai lontana dalla sua morte, una faccenda di cui non
sapremo mai nulla, perché è quello cui Poe avrà pensato, proprio come un
tale intrappolato in una fossa penserebbe alla liberazione, non alla fossa.
Non alla morte che incombe su di lui, bensì alla vita che si è lasciato alle
spalle.
«Ormai l'avrete capito. Tutto questo, tutto ciò che Poe ha fatto nei giorni
dopo essere sbarcato dalla nave su cui era salito a Richmond, è stata una
fuga da Baltimora che un tempo era stata casa sua, la patria di suo padre e
di suo nonno, il luogo di nascita di sua moglie e della sua adorata suocera,
ma ormai non vi aveva più alcuna dimora.
«Ricercai il mio nido - ma non più tale per me,
poiché tutto era svanito quel che lo rendeva tale.»
A quel punto, Duponte, immemore della mia presenza, parve pronto a
recitare altri versi di Poe, ma si interruppe. «No, non aveva alcun nido qui.
Non in questa Baltimora, dove non si fidava degli ultimi membri della famiglia Poe nemmeno quanto bastava per informarli del suo arrivo; e infatti, in un secondo momento, costoro si sono vergognati tanto della loro reazione alla sua scomparsa che ne hanno parlato così poco da apparire sospetti. Non aveva un nido neppure a New York, dove sua moglie, Virginia,
era morta e sepolta, e da cui lo scrittore si accingeva a scappare per sempre; e nemmeno nella città di Richmond, dove il matrimonio con un amore
giovanile era ancora un semplice progetto, per quanto allettante, e i ricordi
della precedente perdita di una dimora, di sua madre e dei suoi genitori adottivi erano ancora vividi. Non lo aveva neanche a Filadelfia, dove, in
passato, aveva vissuto e scritto, dove era costretto a usare un nome falso
per non rischiare di perdere l'ultima lettera amorevole dell'unica parente
che gli era ancora affezionata, dove, chissà come, non era riuscito neppure
ad arrivare in treno.
«Ora vedrete con esattezza la mappa degli spostamenti che Poe ha cercato di compiere nell'ultimo periodo della sua vita (da Richmond a New
York, da Baltimora a Filadelfia). Non è un fatto irrilevante che avesse abitato in tutte e quattro queste città e che viaggiasse senza posa dall'una
all'altra. Se vi fossero stati venti uomini di nome Reynolds intorno alla sua
stanza d'ospedale, il Reynolds di Poe, fosse esso un individuo o un'idea,
sarebbe comunque stato lontano da lì (a prescindere dalla malattia e dalla
morte), in un luogo in cui il poeta desiderava essere. Quel nome, monsieur,
non ci rivela alcunché riguardo alle circostanze del decesso di Poe, e il poeta sarà per sempre l'unico depositario del suo significato. Questo è dunque
il particolare più saliente e misterioso di tutti.»
Quaranta minuti dopo che il tribunale si era svuotato, allorché emerse
che le porte erano chiuse dall'interno, scoppiò di nuovo il caos. In seguito,
tutti mi considerarono matto da legare per aver osato assumere una simile
condotta nei confronti del giudice, che, infatti, era furibondo. Ma non avevo ancora finito con Duponte quando i battenti cominciarono a vibrare con
violenza. Dopo aver terminato la sua dimostrazione, che conteneva solo
qualche dettaglio in più rispetto a quelli trascritti fedelmente qui sopra, l'analista guardò l'uscio, quindi tornò a voltarsi verso di me.
«Potete raccontare questo alla Corte» affermò. «Tutto quello che abbiamo detto, intendo. Non perderete il vostro patrimonio; non dovrete rinunciare a Glen Eliza. Alcuni stupidi tra i vostri pari non comprenderanno tutti
i punti precisi, naturalmente, ma funzionerà.»
«Non sono un drammaturgo abbastanza capace da sostenere che queste
idee sono mie, né un imbonitore così abile da affermare che sono del barone. Se esporrò questa versione, dovrò parlare di voi, monsieur, dovrò rivelare il vostro genio. E se lo facessi, potrei divulgare per errore qualcosa che
riconduca quei tali sulle vostre tracce. Se vi trovassero...»
«Potete raccontare ogni cosa» mi interruppe, annuendo con lentezza per
comunicarmi che era consapevole dei rischi ed era sincero nel concedermi
il suo permesso.
«Monsieur Duponte...» dissi con un leggero inchino, riconoscente.
Scrutai i frammenti di visi e bocche urlanti attraverso i vetri delle porte.
La folla chiedeva a gran voce che venissero aperte. Suppongo che la scena
mi abbia ipnotizzato. Quando, finalmente, i battenti si spalancarono, persi
di vista Duponte tra la fiumana di gente. Peter si precipitò nella mia direzione e mi prese da parte.
«Quello era... Chi era il tale accanto a voi?» domandò.
Non risposi.
«Era lui. Auguste Duponte. Vero?» insistette.
Negai, ma non fui molto convincente.
«Quentin, era lui!» esclamò, trattenendo a stento l'entusiasmo. «Allora vi
ha detto tutto. Vi ha fornito tutti gli elementi che vi servono per risolvere il
mistero della morte di Poe? E per cavarvi da tutti i vostri guai! Un miracolo!»
Assentii. Peter non smise di sorridere mentre mi riaccompagnavano sul
banco dei testimoni. Dopo essersi scusato per l'interruzione, avermi redarguito per aver sprangato l'uscio e averci assicurato che il vagabondo fuori
dell'edificio era stato disarmato, il giudice mi invitò a riprendere la mia
deposizione.
«No» mormorai.
«Prego, signor Clark?» sbottò. «Dobbiamo sentire il resto della vostra
testimonianza. Alzate la voce, per favore!»
Mi alzai. La pelle intorno ai suoi occhi si raggrinzì per l'irritazione. Gli
spettatori si scambiarono dei bisbiglii. Il sorriso svanì dal volto di Peter.
Prevedendo quanto stava per accadere, abbassò le palpebre e scosse il capo, portandosi una mano alla fronte.
Guardai la mia prozia tra la folla. Peter iniziò ad agitare la mano come
un forsennato, facendomi cenno di sedermi. Puntai il mio bastone dritto
verso di lei. «La memoria dei miei genitori appartiene a me, Glen Eliza e
tutto quanto contiene appartengono al nome che porto. Combatterò per tutto questo, prozia, anche se probabilmente non vincerò. Vivrò felice se potrò, e morirò povero se dovrò. Niente e nessuno - né voi né la signora
Blum né l'intero arsenale di Fort McHenry - mi costringerà ad arrendermi.
Un tempo, un uomo di nome Edgar Poe è morto a Baltimora, forse perché
era un uomo con sogni migliori dei nostri, e noi l'abbiamo sfruttato per
questo motivo... consumato finché non ne è rimasto più nulla. Farò in modo che nessuno lo sfrutti più. E» aggiunsi, spostando la mia canna di Malacca verso un altro punto del pubblico, «sposerò la signorina Hattie Blum
domani, al tramonto, nella valle sottostante Glen Eliza. Tutta Baltimora è
invitata, e ogni cosa andrà per il meglio!»
Credetti di udire una delle sorelle di Hattie che si accasciava sul pavimento, svenuta. Hattie, che sfoderava un sorriso raggiante sebbene fosse
stretta nella morsa delle braccia di sua zia, si divincolò e corse da me. Peter dovette tenere a bada i Blum con spiegazioni e rassicurazioni.
«Che cosa avete fatto?» mi sussurrò Hattie, agitata. La moltitudine era
divenuta più rumorosa, e ora il giudice cercava di zittirla.
«Ho dimostrato che la mia prozia aveva ragione, forse» risposi. «La vostra famiglia non ci darà alcunché, e io mi sono già indebitato. Forse ho
gettato via tutto ciò che abbiamo, Hattie!»
«No. Avete dimostrato che io ci avevo visto giusto. Oggi vostro padre
sarebbe orgoglioso di voi. Siete del suo stesso stampo, Quentin.» Dopo avermi dato un fugace bacio sulla guancia, si liberò dal mio abbraccio per
precipitarsi a tranquillizzare i suoi parenti.
Peter mi afferrò il gomito. «Che cosa significa tutto questo?»
«Dov'è?» chiesi. «Avete veduto dov'è andato Duponte?»
«Quentin! Perché non vi siete limitato a ripetere qualunque cosa quel
francese vi abbia riferito? Perché non avete raccontato alla Corte la verità
su quanto lui e voi avevate scoperto?»
«A quale scopo, Peter?» ribattei. «Per salvare me stesso? No, questo è
quanto sperano che faccia per avere l'illusione di conoscermi, e per potermi giudicare inferiore perché diverso. No, non credo che lo farò. Al diavolo l'opinione pubblica. Per ora, questa storia resterà segreta. Vi è una sola
persona cui la narrerò oggi, Peter. Desidero che mi comprenda sempre,
come ha fatto in passato, e deve udirla con le sue orecchie.»
«Quentin, Quentin! Riflettete su quanto state facendo!»
* Allorché implorai Duponte di spiegarmi meglio quella frase sinistra,
accettò solo a condizione che non ne scrivessi mai pubblicamente. Se, in
avvenire, avrò occasione di divulgare le sue rivelazioni riguardo a questo
punto, dovrò farlo in una sede assai più privata.
Capitolo 36
Non condivisi il resoconto della morte di Poe con quell'aula di tribunale,
né quel giorno né più avanti. Invece, sgobbai al fianco di Peter e divenni,
come il mio amico avrebbe preso l'abitudine di dire in seguito, un avvocato
inguaribile, deciso a individuare ogni contraddizione e ogni tesi vacillante
nella causa contro di me. Alla fine, vincemmo. Ottenni ufficialmente un riconoscimento della mia salute mentale e, a giudizio di quasi tutti coloro
che seguirono l'intero procedimento, vi riuscii con notevole facilità. Sebbene, in realtà, pochissimi mi credessero del tutto sano di mente, ammisero
che il processo aveva messo in evidenza quel fatto.
La mia inclinazione naturale per la legge mi rese famoso. Ripresi a lavorare con Peter come socio alla pari, e diventammo uno dei più celebri studi
legali di Baltimora, specializzato in debiti, ipoteche e impugnazioni di testamenti.
Reclutammo anche un terzo avvocato, un laborioso giovanotto della
Virginia, e di lì a poco Peter ne sposò l'altrettanto laboriosa sorella.
Benché la polizia non avesse ricercato Edwin Hawkins per l'aggressione
a Hope Slatter, il mercante di schiavi, si mormorava che questi avesse confidato a qualcuno che avrebbe riconosciuto quel furfante se l'avesse incontrato. Solo qualche mese dopo quell'episodio, Slatter aveva tuttavia deciso
che Baltimora cominciava a essere inaffidabile per la sua attività, e aveva
trasferito la sua società nell'Alabama, consentendo a Edwin Hawkins di
tornare in città senza correre rischi. Frattanto, Edwin, privato del suo incarico nelle redazioni dei giornali, aveva iniziato a leggere libri di diritto. Sarebbe divenuto un impiegato di prim'ordine nel nostro florido studio e più
tardi, all'età di sessant'anni, un avvocato.
Quasi nove anni dopo la mia ultima visita, ripartii per Parigi con Hattie,
portando con noi Annie, la figlioletta di Peter. Non vidi traccia della vigilanza e della diffidenza che avevo notato la prima volta. Anzi, per certi aspetti, Parigi era un luogo più tranquillo da quando Luigi Napoleone ne era
diventato imperatore. Essendo americano e provenendo da una repubblica,
avevo rappresentato un'influenza indesiderata per un tale che progettava di
rovesciare quella stessa forma di governo. Adesso che era imperatore, Napoleone III deteneva il potere cui aveva aspirato sin dal principio, sicché
non sempre lo esercitava appieno.
Dopo il colloquio di Jérôme con Luigi Napoleone, i Bonaparte di Baltimora avevano ottenuto per decreto il diritto al nome Bonaparte per tutti i
discendenti di Elizabeth Patterson, ma non i diritti alla successione o alla
proprietà imperiale che madame Bonaparte aveva ordinato a suo figlio di
pretendere. Quando, anni dopo, Luigi Napoleone morì, nessuno dei due
nipoti di Elizabeth, per quanto alti e belli, divenne imperatore dei francesi.
La signora abitò per molti anni a Baltimora, mostrandosi sovente per la
strada con la sua cuffietta nera e il suo ombrellino rosso, e sopravvivendo
persino al figlio Bo.
Nel frattempo, Bonjour era diventata un membro rispettato della piccola
comunità francese di Washington, assai ammirata e ricercata per la sua indipendenza e la sua arguzia. Aveva scoperto di godere di una libertà assoluta nei panni di una vedova in America. Madame Bonaparte, un'altra donna che si definiva vedova sebbene suo marito, Jérôme senior, fosse ancora
vivo e vegeto in Europa, fu ben lieta, per molti anni, di istruire e incoraggiare Bonjour riguardo a vari complotti e avventure sentimentali, anche se,
di solito, la giovane non seguiva i suoi consigli. Bonjour si rifiutò di risposarsi anche quando si ritrovò in una situazione economica precaria. Grazie
ad alcuni amici conosciuti tramite monsieur Montor, entrò ben presto nel
mondo del teatro e divenne un'attrice abbastanza famosa, recitando in diverse città americane e inglesi prima di cominciare a scrivere romanzi di
successo.
Quel giorno, in tribunale, era stata l'ultima volta che avevo veduto Au-
guste Duponte. Ci eravamo scambiati solo qualche altra parola oltre a
quelle che ho già riferito. Credo di aver avuto una sorta di illuminazione in
quell'aula, il presentimento che quello sarebbe stato il nostro ultimo incontro. Dopo che la folla si era calmata, ero corso fuori e lo avevo intravisto
mentre abbandonava l'edificio. Mi ero sforzato di riflettere su cosa dire.
«Poe» avevo farfugliato «è Poe...»
Nella mia mente, avevo qualcosa di logico e importante da comunicargli
prima di salutarlo, ma in quell'istante, dinanzi a lui, non ero riuscito a immaginare che cosa fosse. Avevo ripensato alla tanto attesa lettera di Poe da
Richmond, che avrebbe potuto confermare il suo tentativo di fissare un incontro con me a Baltimora. Quella missiva non era mai arrivata e non sarebbe mai arrivata, ma quel mattino mi ero sentito, se così si può dire, quasi come se l'avessi davvero ricevuta.
Guardando giù dai gradini del tribunale e sapendo che potevano esservi
coloro che l'avevano scorto per la strada e riconosciuto, Duponte fissava
Monument Square, dove un uomo e una donna ridevano insieme e un vecchio schiavo tirava un puledro. Peter e qualche altro avvocato mi avevano
gridato di tornare dentro. Rammento quella scena con assoluta vividezza,
come se vi avessi assistito oggi. Mi era parso che la mascella di Duponte si
rilassasse, che le sue labbra si allargassero insieme, e che lo strano sorriso
sfoderato per il ritrattista - quell'espressione maliziosa, compiaciuta e intelligente - passasse sul suo volto solo per un attimo fugace prima di scomparire con lui dall'altra parte della via.
Avrei sempre cercato qualche accenno a Duponte (sotto falso nome, naturalmente) negli articoli di giornale riguardanti luoghi lontani.
Talvolta avevo la certezza di aver trovato un riferimento al mio vecchio
amico, sebbene non si sia mai palesato direttamente e, a quanto ne so, non
sia mai tornato negli Stati Uniti. Ogni tanto avevo la vaga sensazione che
si materializzasse all'improvviso quando avevo più bisogno di lui: per esempio, nel periodo in cui Hattie si ammalò gravemente, o nei mesi in cui
non ricevemmo notizie di Peter dopo la sua tanto chiacchierata nomina a
generale dell'esercito durante la guerra.
Per molti anni ebbi, chissà perché, l'impressione di vivere come sospeso,
in attesa. Aspettavo di narrare la mia storia, la storia di Edgar Poe, aspettavo che la sua mente venisse scoperta; aspettavo il giorno in cui gli altri avrebbero necessitato di ciò che avevo imparato dal poeta. Scrissi questo resoconto con una calligrafia meticolosa in alcuni taccuini. Me ne servì più
di uno, giacché aggiungevo annotazioni senza posa; quindi aspettavo e
scrivevo dell'altro.
A volte prendevo la canna di Malacca per sentirne il peso tra le mani, e
quando ero solo, sfoderavo la lama scintillante e, con un sussulto, ridevo e
pensavo a Poe, vestito di tutto punto al suo arrivo a Baltimora, il bastone
che dava sicurezza ai suoi passi.
Hattie avrebbe voluto saperne di più su Duponte. Confessò persino di
invidiare sua zia perché l'aveva conosciuto, anche se l'anziana signora
Blum ci proibì di discutere dell'argomento persino a distanza di anni. Hattie mi invitava sovente a esprimere un giudizio definitivo su Duponte e sul
suo carattere. Non riuscivo a dire niente. Non riuscivo a formulare nulla di
adeguato. Conservavo il ritratto dipinto tanti anni addietro, ma quella che
in passato era sembrata una copia quasi perfetta ora non assomigliava per
nulla a Duponte o, se è per questo, al barone. O meglio, non assomigliava
a Duponte neanche lontanamente quanto le immagini impresse nella mia
memoria.
Eppure, rimase nella biblioteca di Glen Eliza, dove il mio amico era rimasto seduto tanto a lungo. Quando parlavo di lui, i nostri ospiti si meravigliavano che esistesse un uomo tanto raro. In quei momenti, l'interesse di
Hattie per Duponte scemava. «Siete stato anche voi, caro Quentin, a renderlo possibile» asseriva; poi, vedendo la mia espressione severa dinanzi a
quell'affermazione, mi rimproverava in tono scherzoso: «Sì, è così, siete
stato voi».
Nota storica
Edgar Allan Poe morì all'età di quarant'anni in un ospedale di Baltimora
il 7 ottobre 1849, quattro giorni dopo essere stato trovato in gravi condizioni nella taverna dell'hotel Ryan. Il 26 o il 27 settembre, il poeta era partito in piroscafo da Richmond, in Virginia, per raggiungere la sua casa di
New York, con un itinerario che comprendeva una sosta a Filadelfia per
curare un libro di poesie della scrittrice Marguerite St. Leon Loud. Poe aveva chiesto a Maria Clemm, sua suocera, di spedirgli una lettera a Filadelfia indirizzandola allo pseudonimo E. S. T. Grey. A quanto ne sappiamo, tuttavia, non aveva mai raggiunto Filadelfia né era rientrato a New
York, fermandosi invece a Baltimora per un'ultima visita fuori programma.
Non ci è pervenuta quasi alcuna informazione sui suoi spostamenti nei
cinque giorni successivi (dal suo sbarco alla sua apparizione al Ryan durante la giornata elettorale), e questa continua a essere una delle lacune più
persistenti nella storia della letteratura.
L'8 ottobre, nel cimitero presbiteriano di Westminster, il reverendo William T. D. Clemm celebrò una breve cerimonia funebre cui assistettero
quattro persone: Neilson e Henry Herring (parenti di Poe), il dottor Joseph
Snodgrass (un suo collega) e Z. Collins Lee (un suo ex compagno di università). I resoconti sulle cause e sulle circostanze del decesso, già nebulosi
e contraddittori, divennero ancora più confusi quando Rufus Griswold
pubblicò una biografia inventando fatti e persino citazioni. Con il passare
dei decenni, le tesi e le congetture sulla scomparsa di Poe si moltiplicarono, alimentate da chi lo conosceva ma anche da chi non l'aveva mai conosciuto.
L'ombra di Edgar contiene le notizie considerate più veritiere, unite a
dettagli finora inediti. Tutte le teorie e le indagini sulla morte di Poe presenti in questo testo si basano sugli avvenimenti storici e sulle prove più
solide. Attingendo da numerose fonti, tra cui archivi e centri di documentazione di sei Stati diversi, ho condotto alcune ricerche originali con l'obiettivo di inserire nel romanzo una disamina definitiva dell'argomento.
Tra le nuove scoperte sul decesso di Poe contenute per la prima volta nel
presente volume figurano: l'incendio a casa del dottor N. C. Brooks più o
meno nel periodo in cui Poe giunse a Baltimora e tentò di fare visita all'amico;* il ruolo di George Herring come presidente dei whig della quarta
sezione e la sua presenza al Ryan durante la giornata elettorale, nonché il
probabile nesso tra questo fatto e la comparsa, prima inspiegabile, di
Henry Herring all'hotel il 3 ottobre; la posizione preminente di Joseph
Snodgrass nei comitati antialcolici per l'approvazione della legge contro il
consumo di liquori nelle giornate festive, e il suo intervento decisivo per
rimediare ai danni cagionati dallo scandalo del candidato John Watchman
subito prima delle elezioni del 3 ottobre; l'esistenza di The Stranger's
Doom, la poesia composta nel 1851 dalla scrittrice Marguerite St. Leon
Loud di Filadelfia, forse i primi versi mai pubblicati sulla morte di Poe,
che questo romanzo riproduce e analizza, individuando per la prima volta
un legame con il poeta; e l'arrivo, mai accertato prima d'ora, di una lettera
per «Grey, E. S. F.» all'ufficio postale di Filadelfia nelle ultime settimane
della vita di Poe (con tutta probabilità l'ultima missiva a lui indirizzata),
nonché la nuova analisi qui proposta delle ragioni dietro la misteriosa scelta dello pseudonimo «Grey».
Altri particolari poco noti sono: la descrizione dei contatti di Poe con gli
Shockoe Hill Sons of Temperance e il suo ingresso in quel gruppo; la col-
letta organizzata dai dipendenti del «Patriot» per raccogliere fondi destinati
alla tomba dello scrittore; il fatto che il reverendo Clemm avesse redatto
un'orazione più lunga di quella che lesse effettivamente al funerale del poeta; le caratteristiche esteriori del messaggio di Walker; e i versi sulla
scomparsa di Poe composti dal dottor Snodgrass, poco conosciuti e parzialmente riprodotti in queste pagine.
Pur riportando il maggior numero possibile di informazioni originali nel
tentativo di chiarire gli avvenimenti, il libro cerca, quando fattibile, di restare storicamente fedele a quanto i personaggi avrebbero saputo di Poe intorno al 1850, conoscenze che talvolta differiscono da quelle attuali (due
esempi lampanti sono l'anno e il luogo di nascita del poeta e le condizioni
della sua adozione da parte della famiglia Allan, che continuarono a essere
oggetto di discussione per decenni, in parte perché lo stesso Poe nascose i
dettagli della sua biografia). Tutte le citazioni sulla morte dello scrittore e
sui fatti paralleli sono tratte da veri articoli di giornali del diciannovesimo
secolo, e tutte le frasi attribuite a Poe furono scritte o pronunciate dal poeta. All'età di vent'anni, Edgar Allan Poe fece davvero da intermediario a
Maria Clemm nella vendita di uno schiavo ventenne di nome Edwin a una
famiglia nera di Baltimora per la somma di quaranta dollari, procedura che
gli consentì di affrancare il giovane.
Il probabile aspetto di Baltimora e Parigi intorno al 1850 è stato ricostruito grazie a numerose memorie, guide turistiche, carte topografiche e
testi letterari dell'epoca. La polizia di Baltimora e di Parigi, Luigi Napoleone a Parigi, Hope H. Slatter e Elizabeth Patterson Bonaparte a Baltimora
si muovono tra gli eventi fittizi del romanzo, con gli interessi e i moventi
che la storia ascrive a queste figure.
Pur essendo un personaggio di fantasia, Quentin Clark dà voce alle parole e alle opinioni dei pochi appassionati di Poe in un periodo in cui quasi
tutti sottovalutavano la sua produzione letteraria, e molti denigravano la
sua moralità e il suo carattere. Le principali fonti di ispirazione per Quentin e i suoi contatti con Poe sono stati George Eveleth e Phillip Pendleton
Cooke, che intrattennero entrambi una corrispondenza con il poeta. Molti
degli individui qui associati a Poe e alla sua scomparsa - tra cui George
Spence (il custode del cimitero), Neilson Poe, Henry Herring, Henry Reynolds, il dottor John Moran, Benson degli Shockoe Hill Sons of Temperance e il dottor Snodgrass - sono reali, e le rispettive descrizioni si basano
sui personaggi storici. Queste figure riflettono le varie concezioni morali e
letterarie che, ancora oggi, fanno da cornice alle circostanze del decesso di
Poe.
Da oltre un secolo, gli studiosi cercano davvero di identificare il «vero»
Dupin che ispirò i racconti del mistero di Poe. Auguste Duponte e il barone Dupin sono inventati, ma sono modellati sul nutrito numero di candidati
papabili, la cui lunga lista comprende il precettore francese C. Auguste
Dubouchet e l'illustre avvocato André-Marie-Jean-Jacques Dupin.
Benché molti abbiano passato al setaccio la morte di Poe nel tentativo di
risolverne i misteri, l'indagine di Quentin è immaginaria. Le sue azioni e
alcune scoperte specifiche ricordano tuttavia i primissimi investigatori dilettanti, che precedettero di decenni gli studiosi e i teorici poi appassionatisi all'argomento. Maria Clemm, Neilson Poe e il signor Benson cercarono,
con discrezione, di raccogliere informazioni subito dopo il decesso di Poe,
quando era ancora possibile che, da qualche parte, emergessero indizi sui
suoi ultimi giorni.
* La teoria secondo cui Poe cercò invano di fare visita al dottor Brooks,
formulata dal biografo ottocentesco George Woodberry, è stata oggetto di
numerosi dibattiti. Gli studiosi successivi la contestarono affermando che
Woodberry non aveva menzionato alcuna fonte. Oltre ad aver appurato i
dati sull'incendio, sono riuscito a identificare il misterioso testimone di
Woodberry nel figlio di Brooks.
Ringraziamenti
Questo libro deve moltissimo a quattro persone: innanzi tutto, a Suzanne
Gluck, mia amica e agente letteraria, che è stata brillante e preziosa in ogni
momento, e poi a Gina Centrello della Random House, e a Jon Karp e Jennifer Hershey, i miei curatori, per le loro intuizioni, passione e fiducia.
Gli straordinari professionisti della mia agenzia letteraria e delle mie case editrici hanno contribuito a tutte le fasi del processo. Alla William Morris Agency, Jon Baker, Georgia Cool, Raffaella De Angelis, Alice Ellerby,
Michelle Feehan, Tracy Fisher, Candace Finn, Eugenie Furniss, Alicia
Gordon, Yael Katz, Shana Kelly, Rowan Lawton, Erin Malone, Andy
McNicol, Emily Nurkin e Bari Zibrack. Alla Random House, Avideh Bashirrad, Kate Blum, Sanyu Dillon, Benjamin Dreyer, Richard Elman, Megan Fishmann, Laura Ford, Jonathan Jao, Jennifer Jones, Vincent La Scala,
Libby McGuire, Gene Mydlowski, Grant Neumann, Jack Perry, Tom
Perry, Jillian Quint, Carol Schneider, Judy Sternlight (della Modern Li-
brary), Beck Stvan, Simon Sullivan, Bonnie Thompson e Jane von Mehren. Ho ricevuto sostegno e suggerimenti utili anche da Chris Lynch di
Simon & Schuster Audio, Stuart Williams e Jason Arthur di Harvill Seeker
UK, Elena Ramirez di Seix Barral e Francesca Cristoffanini di Rizzoli.
Grazie a chi mi ha aiutato con la stesura del presente volume leggendolo
e migliorandolo. Tra queste persone figurano, come sempre, i miei familiari: Susan e Warren Pearl, i miei genitori, e Ian Pearl, mio fratello; e inoltre,
Benjamin Cavell, Joseph Gangemi, Julia Green, Anna Guillemin, Gene
Koo, Julie Park, Cynthia Posillico, Gustavo Turner, Scott Weinger e Tobey Wiggins, che mi ha offerto un sostegno e un incoraggiamento incrollabili.
Ringrazio anche gli archivisti e i bibliotecari della Boston Public Library, dell'università di Harvard, dell'università dell'Iowa, della Duke
University, della Maryland Historical Society, dell'Enoch Pratt Public Library di Baltimora, della Johns Hopkins University, della New York Public Library, della Library of Virginia e dell'università della Virginia. Un
altro ringraziamento va a coloro che sono stati così generosi da fornirmi
informazioni su Poe e su aspetti specifici della vita e della cultura ottocentesche: Ralph Clayton, il dottor John Emsley, Allan Holtzman, Jeffrey
Meyers, Scott Peeples, Edward Papenfuse, Jeff Savoye, Kenneth Silverman e la dottoressa Katherine Watson.
Grazie anche alle generazioni di studiosi che hanno raccolto le nostre attuali conoscenze sull'esistenza di Poe, tra cui l'eccellente Burton Pollin,
che notò per la prima volta la comparsa, citata in questo romanzo, delle iniziali «E. S. T. G.» nel «Broadway Journal». Una nota di elogio al sito
web dell'Edgar Allan Poe Society di Baltimora (www.eapoe.org), creato da
Jeff Savoye, che dovrebbe stabilire i criteri per tutte le fonti letterarie on
line. Per finire, grazie a tutto lo staff e ai finanziatori delle case e dei musei
di Poe a Baltimora, Fordham, Filadelfia e Richmond, nonché al cimitero di
Westminster a Baltimora, perché tengono in vita la storia di Poe e offrono
a tutti noi l'opportunità di una visita.
FINE
Scarica