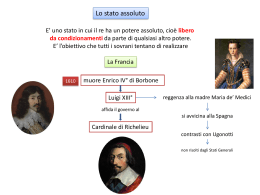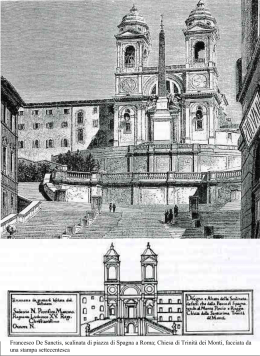RS RS Anno XLII RICERCHE STORICHE Direttore Ettore Borghi N. 109 aprile 2010 Rivista semestrale di Istoreco (Istituto per la storia della Resisistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia) Direttore Responsabile Carlo Pellacani Coordinatore di redazione ed editing Glauco Bertani Comitato di Redazione: Michele Bellelli, Lorenzo Capitani, Mirco Carrattieri, Alberto Ferraboschi, Alessandra Fontanesi, Benedetta Guerzoni, Marzia Maccaferri, Fabrizio Montanari, Francesco Paolella, Ugo Pellini, Massimo Storchi, Antonio Zambonelli Direzione, Redazione, Amministrazione Via Dante, 11 - Reggio Emilia Telefono (0522) 437.327 FAX 442.668 http://www.istoreco.re.it e.mail: [email protected] Cod. Fisc. 80011330356 Prezzo del fascicolo numeri arretrati il doppio € 13,00 Abbonamento annuale € 20,00 Abbonamento sostenitore € 73,00 Abbonamento benemerito € 365,00 Abbonamento estero Foto di copertina: Alcide Cervi con la famiglia Gabrielli (si veda il saggio di Serena Cantoni nel presente volume). Foto sfondo sezioni: Castel Ibarra (Guadalajara, marzo 1937) dopo l'assalto che aveva visto il battagliane «Garibaldi» sconfiggere le truppe fasciste italiane che vi erano asseragliate. (in A. Zambonelli, Reggiani in difesa della repubblica spagnola. 1936-1939, Tecnostampa 1974) € 50,00 I soci dell'Istituto ricevono gratuitamente la rivista I versamenti vanno intestati a ISTORECO, specificando il tipo di Abbonamento, utilizzando il Conto Corrente bancario BIPOP-CARIRE n. IT05J 02008 12834 000100280157 oppure il c.c.p. N. 14832422 La collaborazione alla rivista è fatta solo per invito o previo accordo con la redazione. Ogni scritto pubblicato impegna politicamente e scientificamente l’esclusiva responsabilità dell’autore. I manoscritti e le fotografie non si restituiscono. Stampa GRAFITALIA – Via Raffaello, 9 Reggio Emilia Tel. 0522 511.251 Fotocomposizione ANTEPRIMA – via Gramsci, 104/f Reggio Emilia Tel. 0522 271.185 Editore proprietario ISTORECO Istituto per la Storia della Resistenza Registrazone presso il tribunale di Reggio Emilia n. 220 in data 18 marzo 1967 Con il contributo della Fondazione Pietro Manodori Indice Ricerche Serena Cantoni, «Concueste poche righe», due famiglie reggiane migranti tra Castelnovo Sotto e l’Argentina, seconda parte Luca Fantini, Dalla parte di Francisco Franco. «Volontari» reggiani nella guerra civile spagnola 5 52 Memorie e testimonianze Gianfranco Romani, Il timbro tedesco. Quando Cesare Campioli sfuggì alla cattura 127 Giulio Campagnano, Una traversata sciistica. Un ebreo in fuga dai nazisti 142 Francesco Paolella (a cura di), Il «San Lazzaro» e il movimento antimanicomiale italiano. L’esperienza reggiana. Intervista a Christian De Vito 149 Didattica Beatrice Borghi, Rolando Dondarini, Insegnare storia con efficacia e qualità rinnovate in tempi di crisi e di involuzione del sistema scolastico 159 Luigi Guerra, Educazione al patrimonio e alla cittadinanza nella formazione del docente di storia 167 Lorenzo Capitani, Tiziana Fontanesi, Paola Montanari, Brunetta Partesotti, Progetto in rete. La costituzione della cittadinanza. Liceo scientifico statale «A. Moro», Liceo classico-scientifico «L. Ariosto-L. Spallanzani», Istituto Statale d’Arte «G. Chierici» con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia 174 Note e rassegne Michele Bellelli, La X flottiglia 181 MAS. Alcune brevi note Carlo Pellacani, Classificare, pensare, escludere. Un importante seminario di formazione per docenti. – Arte e design nel mondo diviso. (A margine di una mostra al MART di Rovereto) 187 188 Recensioni 190 3 Ricerche «Concueste poche righe» Due famiglie reggiane migranti tra Castelnovo Sotto e l’Argentina seconda parte* Serena Cantoni 3 Al maschile… 1 Questioni di genere nella scrittura «Noi siamo nella scrittura e la scrittura è in noi»1, in accordo con gli studi di antropologia della scrittura, le gerarchie, le differenze sociali e i ruoli di genere si riversano anche nei testi epistolari. Parlare di «scritture sessuate»2 non è un eufemismo, le scelte tematiche differenziano categoricamente le lettere in: maschili e femminili. Si tratta di due «modalità di lettura del reale»3 che attraversano le generazioni senza prevaricarsi, solo a volte, le trasformazioni sociopolitiche possono favorirne un parziale mescolamento. In linea generale l’armonia tra uomini e donne scriventi è basata su questo equilibrio che vieta * La prima parte è stata pubblicata sul n. 108/2009. Nota alla trascrizione dei testi. Abbiamo ritenuto importante, nella trascrizione degli epistolari, delle interviste e nelle citazioni, riportare esattamente tutte le espressioni e le forme grafiche (accenti, apostrofi, punteggiatura, maiuscole…) impiegate dagli scriventi sia in italiano che in spagnolo. La decisione è stata presa in base alla volontà di preservare il carattere specifico degli scritti e delle parole dei nostri protagonisti senza appiattirli sulla norma grammaticale, anche laddove il senso poteva risultare oscuro. I chiarimenti per le trascrizioni e le citazioni sono stati posti nelle note a piè di pagina come anche i dati di catalogazione delle lettere. Le lacune presenti nei testi sono state rese con i puntini di sospensione. 1 FABRE, Introduzione. Nove terreni di scrittura, cit., p. 14. 2 LAHIRE, Identità sessuali alla prova della scrittura, cit., p. 151. 3 A. CANOVI, M. FINCARDI, M. MIETTO, M. G. RUGGERINI, Memoria e parola: le «piccole Russie», «Rivista di storia contemporanea», estratto dal n° 3, 1994-95, Loescher, Torino, pp. 385-404: 393. 5 l’approccio all’ambito tematico di cui non si ha la competenza socialmente prestabilita, lasciando così al soggetto una possibilità di autoaffermazione preconfezionata. Da una parte, i temi dell’epistolografia maschile sono legati allo spazio pubblico4, quella dimensione esterna, che per i nostri scriventi si riassume in tre ambiti: politica, economia e società. Dall’altra, le lettere delle donne si articolano principalmente nell’ambito domestico5, questo confine è stato parzialmente superato, a partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento, con l’acquisizione di un ruolo pubblico femminile che ha introdotto nei suoi carteggi l’osservazione e l’analisi dei contesti sociopolitici6. La storia sociale è depositaria delle cause di questa distinzione di ambiti che si riflette anche nella letteratura popolare. 1.1 Storia della scrittura «maschile» In Europa gli uomini erano stati alfabetizzati più precocemente e in maggior numero rispetto alle donne, per molti secoli «sapere di lettera» era stato un attributo che aveva distinto la figura maschile da quella femminile decretandone la superiorità, infatti, una minima alfabetizzazione dava una parziale autonomia burocratico-amministrativa anche ai soggetti di estrazione popolare, favorendone l’integrazione sociale. Non è un caso che i più antichi documenti di scrittura popolare maschile (XI e XII secolo) siano quasi esclusivamente legati a un’utilità materiale: libri di conti, ricevute ecc7. Col passare del tempo la scrittura, attività propria della classe borghese, si fece sempre più incisiva negli ambiti: ufficiale, professionale e pubblico8, mentre per la società rurale si confermava un’azione rara, legata all’eventuale espletamento di pratiche burocratiche. A partire dal XVIII secolo il capitalismo imperante aveva indotto gli uomini ad allontanarsi dagli spazi locali per proiettarsi sui mercati mondiali. Questo portò, sempre in ambito borghese, alla diffusione della scolarizzazione femminile, passata da una dimensione incentrata esclusivamente sulla lettura, all’insegnamento della scrittura per necessità pratiche che dessero alle donne gli strumenti per sopperire all’assenza degli uomini. Da un lato, il regno «della scrittura maschile» si destabilizzò in seguito alle nuove modalità di relazione pubblica, per avvicinarsi sempre di più ad una dimensione esclusivamente orale, dall’altro, la scrittura femminile si fece sempre più forte in ambito domestico e privato. 4 LAHIRE, Identità sessuali alla prova della scrittura, cit., p. 152. Ibidem. 6 Vedi C. ROMEO, Narrative tra due sponde, Carocci, Roma 2005, pp. 38-40. 7 Vedi BARTOLI LANGELI, La scrittura dell’italiano, cit. 8 LAHIRE, Identità sessuali alla prova della scrittura, cit., p. 152. 5 6 Tra XIX e XX secolo, le grandi emigrazioni e le guerre mondiali, con lo sconvolgimento del preesistente assetto socioeconomico, destabilizzarono psichicamente i soggetti maschili che ne furono protagonisti, facendo crollare il mito della superiorità patriarcale capitalista. Questo sconvolgimento riavvicinò gli uomini alla scrittura, soprattutto nella sua forma epistolare. 1.2 Crisi patriarcale italiana Nell’Italia del XIX secolo la crisi agraria fu sia l’elemento destabilizzatore dell’identità maschile che il principale motore dei movimenti migratori. Di questa crisi furono «vittime» tutti gli esponenti della società rurale: i contadini, gli artigiani e i medio borghesi9. La rottura dei vecchi ordini sociali fu acuita dalla crisi, che con l’aumento demografico, l’inasprimento delle condizioni di vita, l’imposizione della «tassa sul macinato» e la costruzione dei primi inurbamenti, aveva favorito tra i lavoratori la diffusione dei gruppi sindacali bracciantili e operai. Il maggior numero di queste associazioni si trovava in Val Padana ove «un esteso bracciantato si era andato formando nelle aziende capitalistiche di pianura, soprattutto nelle regioni padane, e rivendicava nuovi diritti, migliori condizioni di lavoro, più elevati salari di fronte al vecchio padronato agrario»10. Nell’inchiesta Jacini si riportava che uomini e donne delle regioni padane si mostravano attivi e combattivi dal punto di vista politico, lottavano contro l’impoverimento causato dall’allargamento dei rapporti commerciali al mercato agricolo americano con l’importazione di grandi quantità di grano a prezzi molto più bassi di quelli italiani11. Questo non significava che prima dell’espansione delle rotte commerciali la società rurale fosse immobile, vi era sempre stato un movimento di merci e lavoratori sia uomini che donne data la stagionalità del settore. Vista la grande produzione americana e il contesto di urgenza economica in cui si trovava l’Italia, molti scelsero la propagandata emigrazione transoceanica come possibilità di riscatto per se stessi e le proprie famiglie. Nonostante gli studi etnografici attestino una doppia partecipazione, di uomini e donne, alle ondate migratorie di massa, lo status maschile era imperante: «Tra i movimenti migratori … che il nuovo contesto economico internazionale aveva contribuito a sviluppare, quelli collegati all’industria delle costruzioni erano particolarmente rilevanti. Vi prendevano parte esclusivamente gli uomini. Le donne non emigravano; restavano a casa ad occuparsi di una terra avara, che 9 Vedi M. PALAZZI, Donne sole, storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società contemporanea, Bruno Mondadori, Milano 1997, pp. 362-364. 10 BEVILACQUA, Società rurale e emigrazione, in Storia dell’emigrazione Italiana, vol. I, cit., pp. 95-112: 104-105. 11 Ivi, pp. 106-107. 7 richiedeva un lavoro durissimo e dava magri frutti destinati all’autoconsumo della famiglia»12. Così mentre gli uomini, vittime della propaganda capitalista, erano stati illusoriamente proiettati verso il mondo dell’imprenditorialità americana, sentendosi ancora più rafforzati nella loro mascolinità e intraprendenza, le donne erano state costrette a mantenere il contatto con la realtà quotidiana: «Dover badare alla coltivazione e al raccolto, … gestire rapporti di lavoro con terzi, … acquistare attrezzi, pagare debiti, smerciare prodotti»13 tutto questo comportò un generale mutamento di mentalità e cultura. Inizialmente gli uomini accettarono questo cambiamento di ruoli, in quanto idealizzavano l’esperienza migratoria come un evento di breve durata14, legato esclusivamente al guadagno economico. In realtà, l’avvento delle due guerre mondiali rese, in molti casi, definitiva la scelta migratoria. L’impossibile rientro e le difficoltà organizzative e lavorative incontrate nelle Americhe, acuirono negli emigrati il senso di sradicamento e di nullità già incontrato prima con la crisi economica italiana e poi durante la traversata oceanica. In breve tempo molti di loro realizzarono l’inesistenza del mito di forza e intraprendenza maschile fomentato dal capitalismo15. Spinti dalla frustrazione e dall’insoddisfazione16, gli uomini ritrovarono nella scrittura epistolare l’unico mezzo che permettesse loro di appagarsi17 riallacciando i legami affettivi rotti con la distanza, nella speranza di ricostruire la propria identità perduta. Essendosi riavvicinati alla «scrittura privata», ambito che, come si è visto, era divenuto prevalentemente femminile, gli uomini si canalizzarono nella narrazione di quegli aspetti che da sempre avevano distinto il mondo maschile. Facendosi narratori o cercatori del senso del vivere, grazie alla scrittura epistolare giunsero a riconoscersi, ancora una volta, autori delle proprie vite18. 1.3 Identità deboli nei carteggi castelnovesi La dominanza di lettere maschili nei carteggi dei Bartoli e dei Gabrielli riconferma le sopracitate cause della necessità dell’uomo di recuperare la scrittura epistolare: il bisogno di mostrare l’integrazione nel contesto argentino 12 RAMELLA, Reti sociali, famiglie e strategie migratorie, in Storia dell’emigrazione italiana, vol. I, cit., pp. 143-160: 145. 13 Ivi, p. 111. 14 Vedi PALAZZI, Donne sole, cit., p. 374. 15 Vedi FRANZINA, Merica! Merica!, cit., e PALAZZI, Donne sole, cit., p. 378. 16 Vedi ROMEO, Narrative tra due sponde, cit., pp. 152-153. 17 Vedi S. FERRARI, Scrittura come riparazione: l’esempio di Proust, Mucchi Editore, Modena 1986, p. 8. 18 Vedi C. CAPELLO, Il Sé e l’Altro nella scrittura autobiografica, contributi per una formazione all’ascolto: diari, epistolari, autobiografie, Bollati Boringhieri, Torino p. 73 e ROMEO, Narrative tra due sponde, cit., p. 155. 8 e le nuove competenze acquisite, dipendevano dal desiderio di riscattare la propria immagine indebolita dalla scelta migratoria19. I fratelli Bartoli decisero di partire nel pieno della crisi agraria che aveva colpito anche le campagne castelnovesi. Al motivo economico si aggiungeva la necessità di riscatto sociale, infatti, per godere dello status maschile, agli inizi del XX secolo, mancavano di due elementi fondamentali: la famiglia e la terra. La loro esperienza migratoria fu una rottura positiva con il passato, ne migliorò le condizioni economiche realizzandone le aspettative. Dopo un breve rientro in patria, la decisione, imposta per motivi politici, di ristabilirsi definitivamente in Argentina fu determinante per l’avvio di un rapporto epistolare con un fratello rimasto a Cogruzzo. L’intento dei Bartoli emigrati era quello di raccontare sia i progressi economici, dimostrando il proprio successo come capofamiglia secondo la tradizione patriarcale emiliana, che le evoluzioni del contesto politico sociale argentino. Quest’attenzione per l’aspetto sociopolitico risulta ancora più evidente nelle lettere dei fratelli Gabrielli in seguito alla loro partecipazione alla seconda guerra mondiale. Enzo ed Eber, maggiori, si erano arruolati nell’esercito per necessità economiche, Eugenio, essendo più giovane e di forti ideali socialisti, ebbe un ruolo attivo nel movimento reggiano della Resistenza. Terminata la guerra, Enzo scelse di emigrare in seguito ad una sofferenza psichica per i traumi vissuti. Sentendosi indebolito, ripose, come tanti, nel sogno americano la speranza di poter ricostruire la propria identità e riaffermarsi con un nuovo ruolo sociale. La sua produzione epistolare, tutta incentrata sui «temi da uomini» e principalmente indirizzata a parenti ed amici maschi (nei preludi il nome delle donne compare in seconda posizione: «Caro Eugenio e Vittoria»)20, concretizza sia il suo desiderio di aprirsi uno spazio da fantasma kafkiano21 nella famiglia e nel paese castelnovesi, di cui sente molta nostalgia, sia la necessità di sentirsi un cittadino attivo e riconosciuto anche in Pergamino. Una lettera interessante in cui Enzo scrisse una modesta autocelebrazione, sostenuta dai duri ricordi del passato, è quella che inviò ad una studiosa da cui era stato contattato per una ricerca storica: nemmeno lontanamente pensavo di essere stato artefice di una cosi lunga storia …, la mia vita e cominciata a 33 anni qui in Argentina, cominciai a lavorare che avevo 8 anni con mio padre dato che ero il magiore dei fratelli e stato un po troppo rigido, ma che sempre ho apresato. Cosi che fin da piccolo cominciai acomulare esperienze a beneficio della famiglia, e dopo con tutto il resto per me 19 Ivi, p. 151. Lettera di Enzo Gabrielli, 20 gennaio, 1984, carteggio Gabrielli. 21 Vedi FERRARI, Scrittura come riparazione: l’esempio di Proust, cit., p. 17 e anche ALESSANDRONE PERONA, L’epistolario come forma di autobiografia: un percorso nel carteggio di Piero Gobetti in «Dolce dono graditissimo», cit., p. 18. 20 9 non ce nulla che no si possa fare, dopo con l’aiuto di mia signora abiamo messo a parte qul pasato cosi nel camino a seguire con il mio prefisso nel bene si e formata la mia famiglia, e la pura verita nel tuo dire che sono cicatrici che non si chiudono mai … e stato il mio destino e di fronte a qualsiasi cosa cè sempre la rasegnasione, qualche cosa di me di quel teribile pasato ne ha saputo mio fratello Eber, Eugenio no, molto poco …, in settembre ho ricevuto dal sindaco Dallaglio di castelnovo sotto quel che fu mio 1° paese natio, il che non si dimentica, tre libri … “castelnovo fra 2 guerre” sono stati mandati dal municipio a tutti i castelnovesi sparsi nel mondo, è stato per me un riconoscimento generoso … il dopo guerra e stato per me un poco triste, lasiai 25 anni di lavoro in italia, e qui cominciai con le mani in mano, perdona il tono confidenziale …22. Non fu una reazione immotivata. Inconsciamente Enzo sfruttò l’occasione offertagli per enfatizzare il suo percorso argentino di rinascita e ricostruzione identitaria, rivalutandosi nel suo ruolo di uomo, ancora una volta, artefice di sé, della propria famiglia, del proprio successo e del proprio destino. Pare che «lo scrivere» questa lettera fosse per lui quasi come una seduta terapeutica, infatti individuava, tra le righe, le cause del suo disagio, legato ad uno stato di insoddisfazione, che cercò di risolvere emigrando. Durante la narrazione si fa sempre più consapevole della sua reazione allo spaesamento iniziale, e quando scrive: «con le mani in mano» si riferisce a quella nuova forza interiore che l’aveva portato a ricostruirsi da solo. L’esperienza di guerra, l’attivismo sociale tra Italia ed Argentina e l’attenzione costante per le dinamiche del paese natio, scriveva Enzo, gli avevano valso il riconoscimento nella storia di Castelnovo Sotto «il che non si dimentica». Ciò che sorge spontaneo chiedersi è se, pur in termini ridotti, non resti, in questo flusso di coscienza, il fantasma destabilizzante della traversata atlantica. 2 La partecipazione politica «Parlare della partecipazione politica degli immigrati può significare diverse cose: un approccio letterale suggerirebbe un confronto sul coinvolgimento nei sistemi politici dei paesi d’accoglienza. Un approccio … diverso … ci porta a riflettere sulle forme della partecipazione “da lontano” alle vicende della politica italiana»23. Su queste parole di Fernando Devoto si costruisce la duplicità che ha connotato il coinvolgimento politico degli emigranti. Da un lato presero parte attiva al clima politico argentino, dall’altro, come trapela dalle lettere, trasposero questo loro attivismo alla realtà italiana in cui continuavano a cercare di aprirsi uno spazio, anche a distanza. 22 Lettera di Enzo Gabrielli, 27 febbraio 1997, carteggio Gabrielli. DEVOTO, La partecipazione politica in America Latina, in Storia dell’emigrazione italiana, vol. II, cit., pp. 507-526: 507. 23 10 2.1 L’attivismo italiano Già dagli anni venti del XIX secolo, i viaggi di esilio dei primi repubblicani avevano legato l’Italia alla storia politica argentina. Gli esuli avevano scelto il paese in quanto, essendo ancora in formazione, il rischio di persecuzione era decisamente limitato rispetto ad altre realtà americane come gli Stati Uniti. In questo contesto, gli italiani contribuirono da subito al progresso in tutti gli ambiti: economico, politico e sociale, gli stessi in cui si canalizzano le narrazioni epistolari maschili. Con il passare del tempo, forti di un ruolo sociale riconosciuto, gli italiani costruirono un senso di appartenenza nazionale pur essendo lontani dalla patria. Gli intellettuali del Risorgimento, tra cui Garibaldi e Mazzini, incentivarono questo lungo percorso24. Sempre in seguito al lavoro dei mazziniani, nel 1858 si costituirono le prime società di mutuo soccorso che avevano incentivato la collaborazione tra connazionali25. Gli emigranti volevano prospettare un futuro di benessere «da italiani» per le giovani generazioni. Nel XX secolo prevalsero i governi totalitari e il potere delle associazioni politiche perse d’importanza sostituito dalle attività dei singoli o dei piccoli gruppi «ma non di un’azione collettiva che abbia avuto un peso nelle tormentate vicende sudamericane»26. Allo stesso tempo i membri delle associazioni si resero conto che il loro obiettivo di farsi influenti in Italia era fallito in quanto si trovavano di fronte una classe politica che non aveva fatto altro che mostrare loro un interesse saltuario e funzionale allo sviluppo delle reti commerciali estere. Fu questa presa di consapevolezza che portò gli emigranti a concentrare le proprie forze per realizzare l’integrazione sul suolo argentino con la quale si incentivò anche la ricostruzione identitaria maschile: «L’approdo alla nazionalità argentina appare qui quasi come una logica conseguenza del fatto di partecipare alla vita sociale e pubblica del paese di accoglienza … fa sì che elementi culturali originariamente estranei (lingua spagnola, … storia patria, … feste nazionali) perdano la condizione di negatività derivante dal carattere di imposizione iniziale»27. Questa linea attiva fu sempre mantenuta dagli italiani nel corso dei decenni. 2.2 La sensibilità politica reggiana I reggiani emigrati, tra cui i nostri scriventi castelnovesi, mostrarono una 24 25 26 27 DEVOTO, Storia degli italiani in Argentina, cit., pp. 40-41. Ivi, p. 70. DEVOTO, La partecipazione politica in America Latina, cit., p. 526. CATTARULLA, Di proprio pugno., cit., p. 90. 11 certa attenzione per il conflittuale panorama argentino; questo atteggiamento derivava dall’insieme di eventi storici che avevano segnato la sensibilità emiliana per la politica. Uno degli eventi più importanti da ricordare risale al XVIII secolo quando, sull’onda della Rivoluzione francese, venne proclamata la Repubblica reggiana e tra le prime adesioni dei comuni vi fu quella di Castelnovo Sotto28. Nel XIX secolo, in piena crisi agricola, i contadini delle valli del Po non esitarono ad organizzarsi per chiedere la soppressione della «legge sul macinato» con una serie concatenata di insurrezioni. Questo insieme di difficili condizioni di vita, malessere e restrizioni portò, nella bassa, alla costruzione di una coscienza sociale tra i lavoratori, uomini e donne, che sostennero l’affermazione del partito socialista e collaborarono per fondare le cooperative rurali, presenti nel reggiano dal 187329. Alle emigrazioni, dai primi anni del XX secolo, seguì un trasferimento dei principi morali e delle ideologie politiche, prevalentemente socialiste, che ritrovarono libero sfogo in terra argentina grazie alle società di mutuo soccorso. Gli stessi principi socialisti comparvero in seguito, rafforzati, negli emigranti degli anni Cinquanta: la guerra era stata un’esperienza incisiva, gli abitanti di Castelnovo Sotto, segnati da episodi molto cruenti, avevano interiorizzato i valori portati dalla Resistenza. Tra questi spiccavano: libertà e democrazia per le generazioni future, ideali che gli emigranti del dopoguerra fecero propri in qualunque paese si trovassero30. Le lettere «al maschile» dei nostri carteggi testimoniano l’immortalità di questi valori ripresentandoli nei testi di «padri» e «figli». 2.3 Primo tema: la politica In una lettera del 1967, quasi vent’anni dopo la sua partenza, Enzo Gabrielli esprimeva preoccupazione per il futuro dell’Argentina. La lettera, indirizzata a tutta la famiglia, era stata scritta subito dopo il rientro da una visita ai parenti oltreoceano e affrontava, con molta lucidità analitica, il grave sviluppo degli eventi politico-economici argentini. La spiccata sensibilità che permetteva ad Enzo di «leggere tra le righe» dei fatti avvenuti, lo portava a temere l’instaurazione di un regime dittatoriale cui sarebbe seguita la drastica cancellazione dei diritti democratici. Questo fatto era 28 G. BADINI, L. SERRA, Storia di Reggio, Ediarte, Reggio Emilia 1985, p. 191. Ivi, p. 233 e per il riferimento al partito socialista vedi R. CAVANDOLI, Le origini del fascismo a Reggio Emilia, Editori Riuniti, Roma 1972, p. 31. 30 Vedi M. STORCHI, Combattere si può vincere bisogna: la scelta della violenza fra Resistenza e dopoguerra (Reggio Emilia 1943-1946), Marsilio Editori, Venezia 1998, p. 100 e S. GUGLIELMIN, «Scritti nomadi» spaesamento ed erranza nella letteratura del Novecento, Anterem edizioni, Verona 2001, p. 45. 29 12 estremamente grave per un uomo reggiano che aveva già vissuto l’esperienza dei totalitarismi, e che riteneva la democrazia un diritto inalienabile. Inoltre, il pensiero di aver portato, con l’emigrazione, tutta la sua famiglia in un paese che non garantiva più un futuro di libertà, gli procurava un enorme senso di colpa. Questo accentuava la nostalgia per il paese natio che, da quel momento, divenne oggetto di un’idealizzazione che passava dall’America all’Italia: ed ora sai che stiamo proprio sotto una dittatura militare, non so se sarà per il bene, ma proprio già comincio a perdere tutte le speranse, ora mi hanno obbligato a pagare per la pensione è così con tutti, ed io devo cominciare a pagare fin da quel giorno che son arrivato al paese (qui) … se sarà per il bene de tutto vado avanti come dicono … e questo è stato anche un convegno fra il governo italiano e argentino, che se per esempio io dovessi rimpatriare il contributo fatto in Argentina vale per riscuotere poi la pensione anche lì in Italia … Caro Eugenio riferendomi a ciò che dici … i tuoi progetti sono buoni, ti ringrazio per il riguardo che tieni … la situazione attuale è contro ai nostri progetti e non c’è misura che si cambi così che tu sei libero di fare ciò che voi sensa pensare ad un nostro ritorno …31. Nonostante il dichiarato clima repressivo, Enzo scriveva senza temere censure. Probabilmente, all’epoca di questo testo, le lettere non erano ancora controllate, ma non si deve dimenticare che lo scrivente stesso era un soggetto che aveva vissuto da protagonista i tempi di guerra e non si lasciava intimorire, anzi sentiva molto forte la necessità di scrivere ciò che vedeva e pensava perché i fatti, per lui, non dovevano essere taciuti: il silenzio comportava assenso. Dopo aver rassicurato i parenti dell’avvenuto arrivo in Pergamino, definito «il paese (qui)» come per non rischiare una confusione con il suo paese natio, Enzo passava all’analisi degli eventi accaduti, cercando di attribuire un lato positivo all’intervento del governo italiano nella politica argentina. Pareva trarre conforto dalla consapevolezza di non essere stato dimenticato, come cittadino, dal suo governo ma di esserne stato addirittura tutelato. Riponeva le speranze nel fatto che la collaborazione tra i due paesi potesse allontanare l’ombra della dittatura. Mentre il suo inconscio combatteva costantemente per la speranza di un ritorno in Castelnovo Sotto, si rivolgeva al fratello Eugenio, con cui spesso trattava gli interessi economici e in nome della sua anzianità, con un tono da capofamiglia, lo autorizzava alla direzione del negozio e all’amministrazione delle finanze. Con il passare del tempo, dalle lettere si legge che le condizioni di vita in Argentina peggioravano e per Enzo, forte del senso di giustizia sociale, la causa principale della cattiva condotta economica era il governo di cui non esitava a denunciare con rabbia il malfunzionamento: ma qui si arriva al punto che il governo ha messo una tassa tanto grande che un quarto della repubblica è andato al fallimento e Ninfo, che aveva un credito bancario qui è venuto a Castelnovo ha preso un prestito lì da un amico di Silvano che regolarmente andava pagando fin che le cose andavano di usanza qui, ma quando venne questo cambio, lui si trovò in gravissima difficoltà …32. 31 Lettera di Enzo Gabrielli, 9 aprile 1967, carteggio Gabrielli. 13 L’assurdità della crisi economica e politica era tale per cui, non potendo dare una giustificazione logica alle decisioni governative, gli scriventi si sentivano perseguitati. Molti castelnovesi, come lo stesso Enzo, avevano creato doppi conti bancari, uno argentino e uno italiano. Se all’inizio la scelta era stata sostenuta dall’onda illusoria del sogno americano, per cui l’ingente ricchezza avrebbe richiesto un doppio conto bancario, in seguito questa condizione permise agli emigranti di avere in Italia una sicura base di risparmi cui attingere in caso di necessità. Ciò che prima era un’orgogliosa ostentazione di benessere, ora si faceva necessaria per assicurare la sopravvivenza all’emigrante. L’aggiornamento sulla situazione sociopolitica si realizzava sempre con un parallelo tra Italia ed Argentina, che rivelava molte similitudini: dato che rimane tanto spazio mi alungo un poco con la situazione, l’anno scorso mi è stata tagliata la pensione Italiana ma con i miei scritti e intervento di Rossano con Vera a fine 96 è stato rimesso con asegni …, comunque un poco aiuta, a altri che è stata tagliata stanno al medesimo punto, si vede che anche in Italia le cose sociali vanno come qui non troppo bene, il clima è come lì o vai molto variabile … se continua così va meglio 1 pesos 1 dollaro pari, e più 5 anni che ce stabilità monetaria ... 33. Da una riflessione sul particolare, ossia il taglio della sua pensione italiana, Enzo riusciva ad astrarre l’ipotesi generale: il taglio significava che la situazione economica italiana non doveva essere delle migliori, ma non potendo averne notizie certe ne chiedeva conferma al fratello. La sua predisposizione verso l’Italia lo portava a giustificare le decisioni prese dal governo. Si trattava senza dubbio di una presa di posizione idealizzata ma basata su una motivazione: mentre l’Italia era un paese democratico e in quanto tale non avrebbe potuto togliere la libertà ai suoi cittadini, l’Argentina totalitaria continuava ad ostacolare i diritti civili e le riforme sociali. Si nota come il discorso politico epistolare fosse molto soggettivo, legato alle esperienze e alla formazione di ogni scrivente. Mentre Enzo risulta essere diretto e descrittivo, e dai suoi costanti riferimenti a Castelnovo Sotto o all’Italia si evidenzia un legame affettivo mai tramontato, Camillo Bartoli, che in seguito all’esperienza migratoria di famiglia aveva vissuto con più mobilità tra Cogruzzo e Pergamino, risulta meno nostalgico seppur legato alla terra reggiana. Per Camillo Bartoli la prima cosa da fare, nel descrivere a parenti ed amici lontani la situazione argentina, era dare rassicurazioni sul proprio stato di salute e benessere, solo in seguito passava alla denuncia del caos in cui si era costretti a vivere: Qui stiamo tutti bene, sempre ci troviamo con Enzo e famiglia in quanto alla situazione è sempre la solita storia, scioperi per il caro vivere e il lavoro ... Il nostro presidente Alfonsín ancora non è riuscito a mettersi in calma coi sindacati si sono sviluppati molti ladri sia di 32 33 14 Lettera di Enzo Gabrielli, 7 dicembre 1982, carteggio Gabrielli. Lettera di Enzo Gabrielli, 27 febbraio 1997, carteggio Gabrielli. notte che di giorno specialmente ai negozi rivoltelle in mano e fuori i soldi poche parole …34. Tutto aumenta e le tasse sempre di più di modo che non resta mai quatrini in tasca (basta la salute). Si sono formate molte squadre di assaltanti, che rubano … non ti conto poi dei sequestri di persona, ma questo succede solo ai gran signoroni …35. La lieve ironia che trapela dai testi: «si configura come un formidabile meccanismo di difesa … rientra … nella grande schiera dei metodi costruiti dalla psiche umana per sottrarsi alle costrizioni della sofferenza»36. La repressione dei diritti civili e l’incapacità dei governi di provvedere al bene del paese destavano amarezza in Camillo che proveniva da una famiglia perseguitata dal regime fascista per i forti ideali socialisti. Nonostante avesse basi ideologiche ben definite, scelse di non riversare sulla carta la rabbia interiore ma di elaborare una strategia di distacco difensivo «nei confronti delle offese della realtà»37. In questo modo riusciva a rendere, in poche righe, uno spaccato della tragica situazione argentina affievolendone i toni, per non destare eccessive preoccupazioni nei corrispondenti oltreoceano: Qui in quanto alla situazione Politica (molta confusione) sempre molti progetti ma non c’è mai una soluzione favorabile ma sempre si vive sperando… (ma si muore come tutti sanno…) Adesso speriamo nella bella primavera che con le sue belle piante fiorite rallegrano un poco più la vita …38. L’aspetto dialogico delle lettere di Camillo è accentuato dall’uso di modi di dire del linguaggio popolare, ne è un esempio la citazione: «si vive sperando… (ma si muore come tutti sanno…)». L’uso libero delle lettere maiuscole, sempre proprio dell’italiano popolare, era legato al desiderio di enfatizzare l’argomento più importante della discussione, così anche «la Politica» assume una personificazione al pari degli altri compaesani citati nel testo e del proverbiale Parmigiano Reggiano: Enzo mi dice che per le feste è facile che venga un famigliare di Ninfo … in quanto sulla Politica, fanno molte discussioni, ma dei fatti pochi, il lavoro nelle città è scarso, mentre che le tasse sono sempre in aumento … ma dopotutto la vita si passa discretamente bene, speriamo in qualche miracolo di Alfonsin per stare meglio … È arrivato Farri Aldo – caro Eugenio e Vittoria vi ringrazio infinitamente del vostro gran regalo – per Natale saremo tutti riuniti con Remo … con il gran prosciutto e Parmigiano …39. Nelle nostre lettere maschili, si sente sempre la necessità di far riferimento all’assetto politico del paese, che si rivela essere un ingrediente fondamentale 34 35 36 37 38 Lettera di Camillo Bartoli, 5 marzo 1985, carteggio Gabrielli. Lettera di Camillo Bartoli, 31 agosto 1986, carteggio Gabrielli. FERRARI, Scrittura come riparazione: l’esempio di Proust, cit., pp. 29-30. Ivi, p. 31. Lettera di Camillo Bartoli, 31 agosto 1986, carteggio Gabrielli. 15 per l’espletamento dei compiti legati alla sfera sociale dell’uomo. Altro elemento caratterizzante della forma mentis degli emigrati castelnovesi era l’interesse per la storia sociale. La memoria storica italiana si arricchiva con quella argentina così da creare una duplice personalità che si andava rafforzando tra le generazioni. Consapevoli di questa evoluzione, per mantenere un dialogo epistolare paritario, anche gli uomini castelnovesi rimasti in paese, volevano conoscere la storia della patria «adottiva» dei parenti chiedendone informazioni. Così Remo Bartoli, figlio di Camillo, raccontava la storia argentina all’amico Eugenio Gabrielli: Non allarmarVi per noi tutti, perché Dio a messo in un paese molto ricco un mucchio di gente: gli argentini, che ci hanno una terribile malatia, dove fanno capo l’invidia, la superbia, calunnia, non sono solidarii, scaltri, mascalzoni, il dannaro prima che la Patria etc etc … Questa disgrazia incomincia con l’inizio della propria storia dell’Argentina. Secondo i documenti dal 1810 quando si formò il primo governo patrio c’erano due gruppi di gente: uno, fu il capo il generale C. Saavedra, chi con i suoi seguaci dominarono tutto il commercio dil cuoio, il sale e del contrabbando; e l’altro, formato da Mariano Moreno, Belgrano ed altri, avvocati, dottorati dell’Università di Chuquixaca … cui furono allievi di professori che venivano imbuiti dei principii della revoluzione francesa dove nacquero: la libertà ed i diritti naturali del essere umano, etc. ¿Pensate chi vinse? ¡¡Bravi!! avete vinto ed indovinato. Il generale … I primi volevano un governo centrale a Buenos Aires, erano gli “unitari”, ed gli altri hanno voluto e conseguirono formare province per un più efficace governo, questi furono e sono i “federali” ed hanno preso come modello la Carta Magna degli Stati Uniti cui Stati sono quasi indipendenti. Questa Carta regge l’Argentina d’oggi. Vale a dire c’è un grande sbaglio: un paese «federale» governato da un’unica autorità in Buenos Aires (unitaria). Nel presente continuano nel governo centrale gli unitari come Saavedrà, uniti al potere finanziario, etc, che man mano passa il tempo manegiano il capitale, p.e. Perón, i militari, Alfonsín, Carlos Menem, De la Rua e Dimalde adesso. E sono i milionarii. I federali sono impoveriti e dispersi nel vasto territorio argentino … Vi spiegate perché siamo così e non possiamo, dopo 200 anni, aspettare niente da un governo unitario come oggi abbiamo ... ¡¡tre presidenti in una settimana!! e la cittadinanza «federale» è incredula, stanca, apatica e brontola. E questo è che le famiglie vogliono andare via, p.e., a gli Stati Uniti, Italia, Spagna, Alemagna etc … Preghiera: che l’anima di Dante mi lasci eternamente tranquillo e senza castigo per lo scritto in italiano di sopra40. Il racconto esplicita le simpatie socialiste dello scrivente, accompagnate, come per le lettere del padre, da un leggero tono ironico usato per non allarmare troppo i conoscenti informati delle tristi cronache argentine. Partendo da una rabbiosa accusa alla corruzione del paese, a suo parere gli argentini erano gente avida, senza morale e con il denaro come unico interesse, la narrazione si snodava come un flash back che illustrava le cause storiche della situazione politica che stava vivendo. In seguito all’accusa di un malgoverno, dal 1810, l’attenzione per i diritti civili dell’uomo pareva non essere mai stata una prerogativa dello Stato argentino. Remo spiegava esaustivamente anche le ragioni dell’esodo dall’Argentina di molti europei con la doppia cittadinanza 39 16 Lettera di Camillo Bartoli, 16 dicembre 1985, carteggio Gabrielli. non nascondendo il suo affetto per l’Italia. Come per la maggior parte delle lettere dei carteggi, anche questa avvalora l’uomo italiano, in quanto soggetto attivo nella costruzione politica del paese d’emigrazione e soprattutto con una morale legata ai nobili valori della democrazia di cui l’Argentina è stata privata. 3 Secondo tema: l’economia Spesso nella stessa lettera si passava dal piano politico a quello economico che era un ulteriore ambito di interesse maschile, in quanto l’uomo avvalorava se stesso, sia nel contesto argentino che in quello castelnovese, come autore del benessere familiare41 in base al quale l’opinione pubblica decretava la riuscita o il fallimento dell’esperienza migratoria. Per la storia dell’emigrazione si trattava di una prova molto importante e non scontata in quanto non sempre si concretizzava il mito dell’Eldorado americano. Le variabili erano legate ai fattori climatici e al sistema economico del luogo di destinazione. Ne fu un esempio il Brasile, ove a causa del clima le aree coltivabili erano poche ed erano state lottizzate come feudi, la mancata libertà di iniziativa limitava moltissimo le possibilità di costruire un patrimonio autonomo e questo portava a numerose delusioni. Diversamente, «l’Argentina dotata di sterminati territori di pianura scarsamente popolati, ricca più di bestiame che di uomini, aveva adottato una politica di richiamo di forza lavoro dall’Europa». Si concedevano al colono, «oltre all’abitazione, animali da lavoro e da razza, utensili e sementi fino al primo raccolto, e per dieci anni, l’esonero da ogni imposta e contribuzione»42. Ecco spiegato il motivo della scelta argentina, in cui furono soprattutto gli italiani a detenere il monopolio delle attività commerciali. I capifamiglia, nelle loro lettere, descrivevano ai parenti in Italia queste concrete possibilità di successo, che venivano lette con scrupolosa attenzione stuzzicando i sogni e i progetti di coloro che non avevano sufficienti entrate per mantenersi. Gli uomini ritenevano che la buona riuscita del viaggio migratorio dipendesse anche dalla solidità del nucleo familiare, ritenuto un importante «gruppo sociale produttivo». Infatti si trattava di veri e propri centri di microeconomia con particolari strategie organizzative: quelle famiglie che non erano in grado di mantenersi unite e di strutturarsi erano inevitabilmente destinate al fallimento. L’uomo emigrante cercava così di giustificare l’abbandono del paese in nome di una 40 41 42 Lettera di Remo Bartoli, 8 gennaio 2002, carteggio Gabrielli. Vedi N. REVELLI, L’anello forte, la donna: storie di vita contadina, Einaudi, Torino 1985, p. 58. BEVILACQUA, Società rurale e emigrazione, cit., pp. 107-108. 17 causa a favore più della famiglia che di se stesso, ottenendo solidarietà e onori: «Coloro che emigrano per sfruttare l’opportunità di guadagnare un gruzzolo che andrà ad ampliare i poderi di famiglia, che favorirà i riaccorpamenti e che è finalizzato a un migliore equilibrio e a un potenziamento dell’azienda agricola sono … investiti di un compito … a vantaggio di tutti»43. Questa forza della famiglia trapela da una lettera di Giovanni Bartoli, inviata ai parenti di Cogruzzo subito dopo la seconda guerra mondiale: Caro zio Vittorio e familia la presente lettera e per dirvi che noi toviamo tutti in buona salute e cosi esperiamo di voi tutti infamilia … sono desideroso di sentire vostre notizie e come ve la passate ora e come va la avete passato in tempo di guerra … che esperiamo che tutto vi sia andato bene. Caro zio e famiglia noi qui in tempo di guerra se la abiamo passato sempre bene siamo estati sempre trangquilli non e mai mancato niente siamo estati sempre come grandi signori incomparazione a quello que e passato lì in Italia e sempre fin ora si continua estando bene si lavora e si va avanti meno male. Caro zio abiamo saputo que li estate molto scarsi a certe cose da mangiare io o fatto el posibile di mandarvi un pacco che contiene cafe e zucchero e ve lo mandato per mezzo della Croce Rossa Italiana esperando che presto lo riceverete fatelo sapere subito …44. La parte di famiglia emigrata in Argentina, essendosi mantenuta unita, aveva continuato a prosperare e a lavorare, dunque la scelta migratoria era stata efficace. L’invio delle citate derrate alimentari, che nell’Italia dell’immediato dopoguerra erano sinonimo di benessere, sottolineava come la famiglia oltreoceano non si fosse dimenticata di quella cogruzzese provvedendo appena possibile ad un sostentamento. Questo risultava essere anche un modo per sdebitarsi della lunga assenza in una situazione critica come era stata la seconda guerra mondiale, infatti tale senso di colpa persisteva in molti uomini emigrati, che scelsero di non tornare in patria per combattere. Così, con il riferimento al benessere economico e l’invio degli alimenti, Giovanni Bartoli giustificava una «non partecipazione» dovuta ad un impegno lavorativo per il miglioramento delle condizioni familiari anche dei parenti in difficoltà. Per gli uomini era sempre molto importante rendere noto che mai avrebbero dimenticato né tradito il proprio ruolo di sostegno della famiglia. La situazione si invertì quando, anni più tardi, furono le famiglie argentine a risentire delle nefaste conseguenze della crisi economica e i parenti castelnovesi si attivarono per aiutarle. Nonostante questo, i capofamiglia in Pergamino si sentirono la responsabilità di contribuire al sostenimento di tutti e cercarono di reagire ancora una volta. Nella seguente lettera di Enzo Gabrielli si avverte questo progresso lento ma inarrestabile: Caro Eber … andiamo sempre con il nostro tran tran io faccio qualche cosa ma non molto e piano piano continuo con le vendite di materiali e qualche cosa compro in comercio un 43 44 18 RAMELLA, Reti sociali, famiglie e strategie migratorie, cit., p. 159. Lettera di Giovanni Bartoli, 1° settembre 1946, carteggio Bartoli. poco sottinteso al margine delle tasse ed anche mi dedico alla compra di qualche auto per rivendere lavori de pensionati che al finale rendono il suo guadagno bene come già ho mandato a dire a Gabriella Maria Laura ha finito il suo studio ha già il titolo di professoressa di matematica fisica e cosmetologia … Proprio oggi sono state bloccate tutte le banche e si pensa che un cambio penseranno di fare ma certo che è una confusione dal lato economico. Solo per darvi un’idea prima che partisse Venturi quel nostro amico che si trova lì aveva 300 vacche da vendere ed era un poco titubante, e io gli dissi che era un momento di comprare vacche così le ha lasiate e ora se avete occasione di avvisarlo sono cresiute nel prezzo più del doppio cosi che si è guadagnato 20 volte il viaggio. … e Paolo come va con il lavoro immagino che si avrà preso tutto a suo carico il negozio …45. Nonostante la grave crisi, come sottolineato dal riferimento al blocco delle banche, il suo senso di conservazione del nucleo familiare lo rendeva sempre più intraprendente. Con quelli che lui stesso reputava «lavoretti da pensionato» riuscì a mandare avanti tutta la famiglia e garantirne uno status di un certo livello indicato dal completamento degli studi della figlia. La sua lucidità sulla situazione economica del paese era notevole e il suo ruolo di dirigente della comunità emigrata (vicepresidente della Società italiana) lo portava a non esitare nel fornire consigli ai compaesani, come ad esempio il signor Venturi che, non sapendo come affrontare vari problemi, aveva deciso di rimpatriare. Oltre ai molti impegni richiesti dall’emergenza economica in Pergamino, Enzo, non voleva perdere il controllo sulla situazione finanziaria in Castelnovo e per questo chiedeva come andassero gli affari della tappezzeria di cui sentiva ancora la responsabilità, come se vivesse la colpa per averla abbandonata. Indipendentemente dalle esperienze soggettive, l’uomo raffigurato dalle lettere era un soggetto che doveva trasmettere, in un clima di instabilità politicoeconomica: decisione, lucidità, consapevolezza della propria situazione e sicurezza provvedendo ai bisogni familiari. Che fosse aiutato dalla moglie e dai figli non era contemplato negli scritti, in quanto il bisogno, pur se inconscio, era rivalutare se stesso. Queste considerazioni non sono proprie solo degli uomini emigrati ma si possono ricondurre anche ai castelnovesi rimasti in paese. Infatti in una lettera di Eugenio Gabrielli si legge: in quanto alla nostra situazione, come certamente saprete, non è più rosea come gli anni passati, molte ditte sono in fallimento, e i disoccupati aumentano, l’inflasione si è fermata all’otto per cento, si dice che potrà ancora sendere; io mi sono ritirato a vita privata per meglio curare la salute di entrambi noi, spero quest’anno di finire il restauro della casa, la settimana prossima incominceremo a finire l’ingresso e la scala46. In un contesto difficile e piuttosto decadente, anche in questo caso era l’uomo a scrivere di aver preso in mano la situazione per provvedere alla salute di se stesso e della moglie. Il senso di protezione legato alla responsabilità dell’andamento 45 46 Lettera di Enzo Gabrielli, 14 giugno 1985, carteggio Gabrielli. Lettera di Eugenio Gabrielli, 29 gennaio 1986, carteggio Gabrielli. 19 economico e del benessere si canalizzava nel restauro della casa così da poter offrire un riparo dignitoso e confortevole al proprio nucleo familiare. Ancora una volta Italia e Argentina erano unite da simili destini. 4 Terzo tema: la società Società e paese natio sono altri elementi che si ritrovano spesso nelle lettere maschili. Da un lato, gli emigranti non riuscivano a distaccarsi dal confronto con la terra d’origine per una questione di abitudine e di affettività innata, dall’altro i capifamiglia volevano orientare la ricostruzione identitaria sui valori della cultura originaria tenendo come secondo termine di paragone il contesto natio. Per questo, come si evince dalle nostre lettere, il loro ruolo di azione sociale si organizzò su due piani: uno che rimaneva legato alle sfere familiari private: una rete di compaesani per l’aiuto nella gestione di problemi che interessavano i singoli castelnovesi. L’altro si fece di portata istituzionale ed era legato a tutti gli italiani emigrati presenti sullo stesso territorio e canalizzava il proprio interesse nella promozione della cultura d’origine tramite le Società italiane. 4.1 Lo spaesamento e la rete dei compaesani Una tra le preoccupazioni maggiori per gli uomini emigrati era subire un disorientamento in seguito alla prolungata assenza dal paese d’origine, questo avrebbe comportato per i soggetti un indubbio indebolimento del loro ruolo maschile nel contesto sia pubblico che privato del luogo natio. Questo problema considerato come una «malattia» non era raro e poteva capitare anche in seguito ad un’assidua corrispondenza epistolare. In una lettera scritta di ritorno da una visita al fratello Eugenio in Castelnovo, Enzo lamentava alcune situazioni piuttosto ostili vissute in paese, che lui stesso non riusciva a comprendere: notai nel 1984 da Genova a casa subito tu hai detto che lauto non potevo usarlo …, ricordo che andammo a Sassuolo e passando per una località che non ricordo più il nome avrei voluto fermarmi vedere un compagno mio della Germania e tu non hai voluto, dopo con Rino M.: lo incontrai dove abitava a Reggio Emilia al paesino chiesi informazione mi dissero che per parlare con lui prima dovevo parlare col suo segretario così che quando è venuto a Castelnovo a cena lo ai messo al tuo fianco … disse che non si ricordava di me che feci del bene in Germania … poi la storia del libretto che ai messo su una montagna di calunnie a tuo modo verso di me … per difamarmi … che io a tutti vi ho dato l’esempio, mi trovo un po’ mal messo certo col mio passato non ho niente da desiderare … credo nella mia condotta che è sempre stata per il bene di tutti …47. 47 20 Lettera di Enzo Gabrielli, 27 febbraio 1997, carteggio Gabrielli. Dai fatti elencati nella lettera si percepiscono molta tensione e altrettanto risentimento da parte dello scrivente che riteneva di non essere stato sufficientemente rispettato dalla famiglia e dagli amici nonostante la sua storica propensione al bene comune, senza nascondere un eccesso di tragicità. Nella lettera scriveva di essere stato vittima di sfiducia e restrizioni da parte del fratello, nonché di aver incontrato un vecchio amico di guerra che pareva non ricordarsi di lui. Enzo, ferito nell’animo, sfogava sul foglio di carta molta rabbia, accusando sempre il fratello di averlo tradito con una serie di infamie che screditavano la sua immagine con l’intento di sostituirlo nel suo ruolo d’anzianità familiare. Tutti questi disagi risultano alquanto forzati e ciò che si percepisce, con un’attenta analisi, è la mancanza di comunicazione tra Enzo, la realtà del suo paese e i compaesani. Il problema di disagio pare dipendere principalmente da un cambiamento percettivo del soggetto emigrato ormai abituato ad altri codici comunicativi. Se ne trova una conferma nella lettera di risposta del fratello Eugenio: Caro Enzo, rispondo alla tua del 27-2 ricevuta il 14-3 … prima risposta: nel venire a casa da Genova, alla tua domanda del portapacchi sull’auto … non si parlò di un tuo eventuale uso … Seconda risposta: due settimane prima andammo dal direttore del banco S. Giminiano … noi due soli … con i medesimi dati risultò tutto esatto … anche lì non sapevi cosa dire … Raineri … mi fece capire che è molto facile che a un uomo, dopo esser stato vittima di una lunga guerra, con 2 anni di prigionia, essendo per forza del momento partito anche volontario e, alla fine, dover emigrare sono tendenti a incolpare tutto e tutti, della loro cattiva sorte … rispondo anche in merito a quel sig.re di R.E. che era con te in Germania quel giorno … andammo a Baiso non a Sassuolo per trovare Venturi che non cera … poi nel ritorno vicino a R.E. avevi questo nome e nientaltro, cercare a R.E., di domenica … quasi deserta è come un ago in un pagliaio. Rimediasti poi con Montanari e quando venne da noi, tu a capotavola, come sempre e noi 2 ai lati, come tutti quelli che sono venuti a trovarti …48. Ecco che improvvisamente la realtà appare completamente diversa da quella che Enzo aveva percepito, Eugenio chiariva confusioni geografiche, scambi di persona ed erronee interpretazioni delle modalità relazionali di cui Enzo era stato partecipe. Tutto questo sconcertava Eugenio che tendeva a giustificare il fatto come una conseguenza alla rabbia di aver dovuto scegliere l’emigrazione per risolvere i disagi psichici dovuti alle esperienze di guerra. La lunga permanenza in terra argentina aveva fatto di Enzo un uomo diverso che faticava a destreggiarsi nella sua realtà d’origine, pur impegnandosi a farlo con tutte le forze. Eugenio non esitava a sottolineare, ancora una volta, l’assoluto rispetto per il fratello più anziano, ad esempio, il posto a capotavola rimaneva il suo e ciò delineava, per la tradizione emiliana, il ruolo più importante della famiglia. Questa vicenda capitata ai Gabrielli era in realtà molto comune tra gli 48 Lettera di Eugenio Gabrielli, 24 marzo 1997, carteggio Gabrielli. 21 emigranti che, proprio per questo, cercavano di mantenersi aggiornati con il paese d’origine lottando per ricevere degli incarichi, per rendersi utili ai compaesani oltreoceano facendosi contemporaneamente artefici della realizzazione di qualcosa che li costringesse a non dimenticare il loro luogo natio e a non perdervi il proprio ruolo. Così, lettere come questa erano all’ordine del giorno nei carteggi degli uomini: mi dirai nella prossima lettera ciò che passa con Rino Montanari perché con Iole Bartoli stanno in raporto per telefono e lui aveva promesso di venire ma sembra che abia prestato una forte somma di denaro a uno di li che non li restituise e sembra che sia in litigio tramite avocato e invita a Iole a venire li in Italia e lei sta indecisa perché apunto anche la indecisione di Rino da a pensare Iole mi incarica di questo però che rimanga fra noi49. Erano sempre gli uomini ad assumersi il ruolo di «ponte» tra Castelnovo Sotto e quella che ritenevano essere la colonia da loro stessi fondata: Pergamino. Questa comunicazione tra Italia ed Argentina comprendeva varie mansioni tra cui anche il farsi referenti di ogni problema, per la comunità emigrante, così che molto spesso i compaesani erano costretti a rinunciare alla privacy per chiedere un aiuto. A parte alcune situazioni più intime che potevano creare imbarazzi, la rete dei compaesani era uno dei mezzi più importanti ed efficaci per la ricostruzione dell’identità nel paese d’emigrazione, connotando la personalità dell’uomo emigrante della duplice influenza sia in ambito pubblico che privato. Infatti, oltre a farsi referente di questioni personali l’uomo si occupava anche dei servizi di anagrafe gestendo, ad esempio, le richieste dei compaesani che avevano necessità dei documenti per fare i passaporti italiani: «ho ricevuto la tua cartolina ed informato a mio figlio tutto quello che tu mi dici. Adesso aspettiamo che cosa succede nel consolato d’Italia a La Plata. Vi ringraziamo per tutta questa incomodità …»50, e ancora: Carissimi, … certo che nelle notizie del paese come dici Eber la magior parte sono sempre brutte, pero al saperle sempre ci portano un conforto, quando ricevetti la tua lettera ricevetti pure una lettera da Carla Ferrarini che nella cuale mi ringrasia tanto per i documenti che le mandai come mi dice mi aveva risposto alla prima che le mandai già da Gennaio, ma io non lò ricevuta, così che tramite i miei amici che sono venuti a casa di Eugenio le mandai pure la fotocopia di quei documenti …51. La prima parte di questa lettera, scritta da Enzo, sottolineava come fosse di conforto, per gli emigranti, ricevere gli aggiornamenti sui fatti di Castelnovo che, pur tristi, supplivano una celata nostalgia. Poi si specificava che l’efficacia 49 50 51 22 Lettera di Enzo Gabrielli, 20 gennaio 1984, carteggio Gabrielli. Lettera di Remo Bartoli e moglie, 12 giugno 2001, carteggio Gabrielli. Lettera di Enzo Gabrielli, 12 agosto 1985, carteggio Gabrielli. del proprio ruolo coordinante all’interno della comunità dipendeva dalla solerzia delle risposte epistolari, cosa di cui Enzo non esitava a raccomandarsi con i parenti in Italia: Eugenio e Vittoria sono già tre lettere che le scrivo e le domando l’indirizzo di Achille di Scandiano ma si vede che si dimenticano … spero che alle prossime di uno di voi ricevere questo indirizzo di Achille con il cognome … così pure le altre che scrissi io non pretendo risposte ma sapere da te Eber = C. Cafarro, Volfango, Aldo T., R. V. Sacani, M. Rino, … Loris Cervi bene Loris mi ha risposto …52. Questa precisione era accresciuta in importanza dal fatto che i compaesani, organizzati come un microcosmo, facevano maggior affidamento sui conterranei che sulle istituzioni per quanto riguardava le decisioni da prendere o il recapito di informazioni e denaro. Gli uomini, in quanto ritenuti più consapevoli e più pratici in ambito finanziario, erano garanti di queste delicate operazioni e non potevano permettersi di mancarne l’effettiva risoluzione: Caro Eugenio, come vedi ti do le ultime notizie, ieri sera mi parlò Ledo B. al cuale le ha scritto Ninfo domandando per suo fratello Silvano un prestito di £ 1.500.000 circa un milione e mezzo, siccome che di qui Bartoli L. non può mandare per banco ha chiesto a me di poter fare il cambio, comunque io lo lasio a tuo criterio, se vuoi possiamo fare meta cada uno, così quando vieni già algo ormai qui se … le darai dei miei facendole fare una ricevuta che tu le ai prestato a nome mio … che lui poi mi pagherà qui “Silvano credo che le domandò a Ninfo ma Ninfo non dispone e così viene la cosa” …53. Gli «affari da uomini» si snodavano con un’assoluta precisione nella rete che loro stessi si erano costruiti tra Castelnovo e Pergamino. Non sempre però la collaborazione tra compaesani era realizzata con onestà, gli episodi di speculazione sulle spalle dei conterranei erano una verità che rompeva l’immagine idilliaca di una comunità senza malizie. Anche se questa mancanza di rispetto offendeva chi aveva creduto nell’unione fraterna tra compaesani come Enzo, molti uomini che si sentivano accresciuti da una posizione di potere ed imprenditoria, raggiunta grazie alle libertà economiche argentine, non esitavano ad esercitare la nuova autorità per imporsi su coloro che erano in difficoltà: Caro Eugenio e Vittoria, è già due o tre volte che ti scrivo che proprio non saprà cosa dire ma non voglio tacere ciò che bene ho saputo nei 10 giorni che sono stato a Rio Tersero con Eledo … vi ho dato ad intendere di come era il carattere di L.B. e nell’afare che è stato fatto fra te e Silvano dei 2 milioni … lui che se ne avantava e non voleva interessi è risultato tutto al contrario Ninfo che si è fatto carico di pagare qui la somma ha dovuto pagare più di tre volte ciò che Ledo ha messo fuori in pesos, … ed è una somma che qui è molto alta che Ninfo già ha pagato, anche se le sue condizioni sono un poco precarie, … quando sei 52 53 Lettera di Enzo Gabrielli, 14 giugno 1985, carteggio Gabrielli. Lettera di Enzo Gabrielli, 28 agosto 1981, carteggio Gabrielli. 23 stato tu da Ninfo non ti disse nulla ma … si trovava sull’orlo del fallimento … io faccio per dirti che Ledo non dovrebbe essere stato tanto esigente perché lui ha messo fuori a quel tempo pesos non lire …54. Le critiche che si muovevano non volevano essere drastiche accuse ai comportamenti tenuti dai conoscenti ma tradivano una certa delusione per la constatazione di atteggiamenti che non si condividevano e che non avrebbero dovuto realizzarsi tra castelnovesi. Nell’ideale degli emigranti erano gli argentini ad avere «il dannaro prima che la Patria»55, non i compaesani. 4.2 Italclubs Per accrescere l’importanza delle proprie comunità di emigranti, depositarie dell’identità italiana oltreoceano, e per acquisire una rilevanza da un punto di vista istituzionale, gli italiani manifestavano tutti lo stesso tratto comune: «quello di aggregarsi, almeno inizialmente, in uno spazio geografico sufficientemente concentrato da consentire pratiche quotidiane di collaborazione, solidarietà, massimizzazione delle risorse»56. Questo comportò dal XIX secolo, l’ufficiale formazione delle Società italiane su suolo argentino. Maria Susanna Garroni aggiunge, nel suo studio comparativo delle Little Italies, che le comunità argentine si erano sviluppate in quasi tutti i centri abitati maggiori e avevano coltivato un terreno di fervente acculturazione politica che si preservò attiva anche con le dittature. In generale, appartenere alla Società italiana era un modo per rafforzare la propria identità in quanto spazio in cui veniva «rappresentata e vissuta quella emozionalità, … quella forza dei sentimenti sanguigni, profondi, di lealtà alle ragioni del sangue che ancora albergano in tutti …»57 nonché luogo in cui l’interazione e il dialogo favorivano i processi di contatto e integrazione con la realtà estera. Per questo gli uomini che vi prendevano parte identificavano subito l’ambiente come la propria seconda famiglia e ciò forniva un aiuto oggettivo e concreto alla ricostruzione di sé. Enzo Gabrielli che ne fu vicepresidente per anni, quando, in una sua lettera, nominò la Società italiana ne parlò al plurale: «Poco piu di un anno che mi sono ritirato come Vice Presidente della Società italiana di tanto in tanto vado come vecchio in maggio festegeremo i 125 anni di esistensa …»58, pur avendo cessato il suo incarico la commemorava, perché averne fatto parte accresceva il suo lustro in quanto personalità pubblica. 54 55 56 57 58 24 Lettera di Enzo Gabrielli, 7 dicembre 1982, carteggio Gabrielli. Lettera di Remo Bartoli, 8 gennaio 2002, carteggio Gabrielli. GARRONI, Little Italies, in Storia dell’emigrazione italiana, vol. II, cit., pp. 207-233 [:208]. Ivi, p. 233. Lettera di Enzo Gabrielli, 27 febbraio 1997, carteggio Gabrielli. Tra gli scopi più importanti delle Società c’era la promozione della cultura italiana con iniziative pubbliche nei paesi d’immigrazione, tale lavoro verteva a riscattare l’immagine stereotipata che aveva emarginato molti italiani come portatori di degrado. Il dialogo culturale era certamente la prima via per l’integrazione anche se in Argentina la situazione fu generalmente favorevole: «la città era ancora in formazione … e … i nostri connazionali – favoriti anche dalle affinità, di lingua e religione, con le élites locali di origine spagnola – ebbero a disposizione abbondanti opportunità di inserimento in attività qualificate …»59. All’interno di questo panorama, la Società italiana di Pergamino aveva lavorato molto per valorizzare i propri emigranti. Nel carteggio Gabrielli sono conservati alcuni articoli del giornale della Società italiana di Pergamino in cui Enzo era stato intervistato, si è scelto di farvi riferimento in quanto utili a mostrare come i nostri scriventi avessero rafforzato la propria identità grazie alla Società italiana. Una delle interviste riguardava il suo passato di guerra, una tappa storica che pochissimi uomini argentini avevano vissuto. L’altra aveva ricostruito il quadro familiare dei Gabrielli oltreoceano mostrandolo come un successo d’integrazione, che motivava la nomina di Enzo a vicepresidente della Società italiana. Nelle interviste Enzo ebbe la libertà di sottolineare più volte il suo senso di appartenenza: Ambos nacieron en el mismo pueblo, Castell Nuovo Sotto, provincia de Reggio Emilia, “la ciudad donde fue fundada la bandera Italiana, que este año cumple 200 años”, comenta con gran satisfación don Enzo ... 60; e di rappresentarsi come desiderava: Los Italianos estaban muy desunidos, no había colectividad ... los había separado la guerra ... . Luché mucho para cambiar eso ... estoy contento porque hoy no existe esa adversidad ... . Este italiano nato que no abandonó sus raíces, ya radicado en nuestra ciudad se integró en seguida a la Sociedad Italiana, en la cual trabajó durante 40 años, ... . Para Don Gabrielli su trabajo fue orgullo y también un ejemplo ...61. Si autoritraeva come un uomo deciso e coraggioso che grazie al suo senso razionale ed imprenditoriale aveva creato un vero e proprio modello di famiglia immigrata, i cui membri avevano avuto qualcosa da insegnare nella realtà argentina: Trabajé mucho, pero también vine a enseñar y sembrar cultura; me siento parte de esto, he 59 Ibidem. Enzo Gabrielli, Lidia Mori, intervista sul giornale della Sociedad Italiana de soccorros mutuos, archivio Gabrielli. 61 Ibidem. 60 25 hecho una experiencia de vida que muy pocos la hicieron. Estoy muy orgulloso de las dos chicas que tengo ... ellas también enseñan y estoy muy contento por eso62. Mentre Enzo veniva così rinfrancato delle umiliazioni del passato con la possibilità di rafforzare la sua storia e il suo senso di appartenenza di italiano in Argentina, un altro uomo castelnovese importante per la comunità di Pergamino era Camillo Bartoli. Come gli altri fratelli, Camillo aveva vissuto fin da piccolo un continuo spostamento tra Argentina ed Italia, iniziando la sua formazione artistica a Parma63. Per Camillo l’arte pittorica divenne oltre ad una passione un mezzo di comunicazione transoceanico, un modo figurativo di esprimere se stesso e interagire con le comunità tra scorci di Emilia e d’Argentina. Negli anni Settanta Eugenio Gabrielli, forte della valorizzazione dei compaesani all’estero, chiese al Comune di Castelnovo Sotto di accettare per un concorso di pittura le opere di Camillo Bartoli, che fu premiato e menzionato anche sui giornali locali: «Camilo Bartoli el reconocimiento a su calidad plastica»64. Nella lettera di ringraziamento Camillo scriveva ad Eugenio: Carissimo Eugenio ... non so in che forma ringraziarti per tutto quello che per me ai fatto, relascionarmi con il gruppo pittori di Castelnovo, con Autorità Comunali che mi inviano a mezzo geom. Marco Mattioli … un atestato di Benemerenzia con una bella medaglia d’argento …, siete proprio bravi e generosi anche per gli amici lontani sono proppio rimasto contento con immensa soddisfazione anche per merito dei pittori castelnovesi … per la Città tutti si congratulavano e mi facevano onori, in casa tutti sempre suonava il telefono, perfino mi mandarono fiori, dunque un vero successo, e ancora non è finita i pittori di Pergamino mi vogliono riunire in una cena … Infine i turisti vi diranno il resto ed io mi alungherò in un’altra mia ho pure scritto al Sindaco e gruppo pittori … (il sig. Mattioli ha il resto delle lettere)65. Vincere un concorso di pittura nel paese italiano aveva avuto, per lui, un valore inestimabile sia per completare il suo inserimento in Pergamino che recuperare la sicurezza di sé. Come si nota dalla lettera il riconoscimento per le opere pittoriche, significava che il suo codice espressivo continuava, nonostante la lontananza, a comunicare con quel mondo in cui lui stesso si riconosceva e che non aveva mai voluto abbandonare. Le vite di Enzo Gabrielli e Camillo Bartoli, rivalutate dalla Società italiana, rappresentano anche i percorsi di altri uomini emigrati che, poco per volta avevano avuto la possibilità di ricostruire la propria identità grazie alla scrittura epistolare che ne agevolò l’interazione sia con il paese natio che con quello d’emigrazione. 62 63 64 65 26 Ibidem. Vedi l’autobiografia di Camillo Bartoli conservata nel carteggio Gabrielli. Articolo del quotidiano «La Opinion», 7 gennaio 1976, conservato nel carteggio Gabrielli. Lettera di Camillo Bartoli, gennaio 1976, carteggio Gabrielli. 4 …al femminile… 1 La scrittura delle donne Come abbiamo più volte ricordato, per molto tempo le donne erano state escluse dall’istruzione, era opinione comune che per svolgere le mansioni domestiche non fosse necessario sapere di lettera, inoltre lo «scrivere» era legato all’ambito delle funzioni pubbliche e del potere maschile che non voleva condividere i propri privilegi. In periodo medievale, eccezion fatta per alcuni casi di donne nobili, erano le monache le uniche figure femminili ad avere accesso alla scrittura. Timorate e costrette all’estraniamento sociale, risultavano inoffensive ed era concessa loro una valvola di sfogo psichico. A partire dal Cinquecento, come si è visto, l’istruzione si diffuse anche nelle campagne tra i ceti popolari, mantenendo una chiara distinzione negli ambiti del sapere per cui l’educazione delle donne verteva solo sulla vita domestica, discriminazione che proseguì fino all’epoca contemporanea. Dal XIX secolo, infatti, mentre gli uomini del ceto borghese si allontanavano sempre più dalla dimensione familiare richiamati dall’espansione dei mercati capitalisti, le donne furono istruite per gestire l’amministrazione domestica e inevitabilmente impararono a scrivere: «la produzione di carte da parte delle donne diviene più consistente, le redigono in contesti differenti, … scrivono, raccolte nei loro studioli, camere, angoli domestici … La lettera diviene, in seguito ai progressi del sistema postale che ne favoriscono la diffusione, mezzo privilegiato di comunicazione, le cui regole, … vengono trasmesse con impegno e precisione fin dall’infanzia»66. Con le evoluzioni del XX secolo, soprattutto in seguito al movimento migratorio, anche le donne della società rurale furono costrette a scrivere per impellenti necessità comunicative, così da «gesto interdetto, considerato una sovversione all’ordine tradizionale, la scrittura si conferma come una pratica diffusa e l’individualità femminile, fino ad allora almeno in parte celata … trova … differenti modalità di espressione e lascia tracce sempre più consistenti del suo percorso»67. Era avvenuta una rivoluzione nei ruoli di genere. Sia in patria che oltreoceano, l’approccio femminile alla scrittura non ebbe solo fini utilitari ma anche psicologici, non solo compensava lo spaesamento indotto dall’esperienza migratoria, ma aiutava a cercare un equilibrio in un insieme di sentimenti contraddittori che connotava lo status di «capofamiglia» di secondo grado, privato delle libertà e dei diritti maschili. 66 P. GABRIELLI, Andare per archivi, in P. GABRIELLI (a cura di), Vivere da protagoniste, donne tra politica, cultura e controllo sociale, Carocci, Roma 2001, pp. 9-52: 13. 67 Ivi, p. 14. 27 Scrivere si fece sempre più una scelta consapevole, un gesto di coraggio, orientato al consolidamento della propria identità. A differenza degli uomini le donne accettarono la mutevolezza degli eventi, lasciando che i cambiamenti esterni interagissero con la loro personalità in continua evoluzione. Si concentrarono sulle proprie emozioni, sulla forza interiore che le aveva rese capaci di sopportare soprusi e repressioni. Per questo le forme espressive che meglio le rappresentarono furono autobiografie, memorie, diari e carteggi. Le donne della classe popolare, predilessero la scrittura epistolare per il suo legame con l’oralità e riuscirono a dar voce ad un mondo cognitivo diverso da quello maschile, che risultò vincente in quanto rispondeva meglio agli eventi storico-politici in cui andava formandosi. La donna per troppo tempo relegata ad un’esistenza materiale come Altro rispetto all’uomo, con la pratica della scrittura «divenne» nel senso hegeliano del termine68, ossia si trasformò con una presa di autoconsapevolezza entrando in contatto con il suo inconscio, scoprì di essere lei stessa autrice della sua identità e di avere un pensiero che poteva esprimere nelle lettere. La diversa sensibilità percettiva tra uomo e donna è molto visibile nelle scelte tematiche dei nostri carteggi. Mentre quelli maschili erano incentrati sulla sfera pubblica, quelli femminili si ponevano nel privato, con una pluralità di temi che andava dalla famiglia alla salute, alla nostalgia, ma anche dalla cucina alla politica. Le lettere femminili si diversificarono, tra le generazioni, influenzate dai contesti sociali e facendosi sempre più dirompenti. Per un miglior approfondimento del tema culinario, si è scelto di integrare le lettere con citazioni tratte da una pubblicazione curata dalle discendenti delle emigrate castelnovesi in Pergamino. Questi materiali sono risultati utili nel delineare le mappe del pensiero femminile troppo spesso costretto dalla razionalità dei canoni maschili. 2 Aspetti di emigrazione femminile Nella società rurale l’inserimento di uomini e donne nel mondo della scrittura epistolare avvenne nello stesso periodo e per le stesse ragioni, vissute, come si è visto, da angolature opposte. Come precisato nei capitoli precedenti, la «crisi agraria» delle campagne italiane si era fatta «detonatore» del movimento migratorio che continuò in seguito all’avvento delle guerre mondiali. Il sistema economico capitalista aveva favorito l’occupazione maschile oltreoceano, questo non implicava che le donne vivessero in una condizione di immobilità. 68 Al verbo «essere» andrebbe sostituito il senso dinamico hegeliano di «essere» nel senso di «essere divenuto», vedi M. DE CHIARA, Teoria e critica letteraria, in P. DI CORI, D. BARAZZETTI (a cura di), Gli studi delle donne in Italia, una guida critica, Carocci, Roma 2001, pp. 153-170: 159. 28 Lo spostamento regionale in cerca di terra coltivabile era un fenomeno principalmente femminile e coinvolgeva in particolar modo le giovani che necessitavano di un lavoro autonomo. Le mondariso, uno degli esempi più imponenti di migrazione interna, passavano stagioni intere lontano da casa, organizzate in comunità esclusivamente femminili. Queste esperienze lontano dalle famiglie patriarcali accrescevano nelle donne la consapevolezza della propria autonomia e le portavano a rielaborare le sofferenze psicologiche cui erano sempre sottoposte. Le migrazioni femminili non erano legate solo alle attività agricole ma vertevano anche sulla città. Nel XX secolo, alcune donne sostituirono la manodopera maschile, assente per motivi bellici, nelle fabbriche, altre trovarono impiego come domestiche nelle case signorili69. Certo queste strategie non si rivelarono risolutrici per una situazione di grave emergenza economica e, in breve tempo, anche le donne furono coinvolte nelle traversate oceaniche. Ancora una volta, il fenomeno migratorio non si presentava come una scelta spontanea ma bensì imposta da un sistema economico in cui la classe popolare non aveva alternative. A differenza degli uomini, le donne si misero in viaggio con gradualità, all’inizio si crearono due gruppi: quello maggioritario era delle madri di famiglia, che restavano a casa mentre mariti e padri partivano in avanscoperta alla volta dell’America, l’altro gruppo era quello delle donne giovani che, in quanto nubili, non erano ancora state vincolate ai ruoli imposti dalla società e si erano lasciate illudere dalle promesse di ricchezza ed emancipazione oltreoceano: qualunque grande occasione di lavoro salariato costituiva l’esca che metteva in moto flussi di emigrazione anche a grande distanza, mettendo in fermento perfino le società più stabili e tranquille … così, accanto all’emigrazione maschile si avviò un consistente flusso di emigrazione femminile, formato da giovani donne che di fronte alle prospettive di un … guadagno violavano apertamente le rigide regole della morale del tempo …70. 2.1 Donne che restano Per le donne che restavano al paese natio si apriva una nuova vita, oltre alla gestione della famiglia dovevano occuparsi della terra e il lavoro agricolo non portava a «vedere alcuna differenza d’occupazione secondo l’età e il sesso»71. Queste donne non furono mai particolarmente propense al viaggio transoceanico, non avevano vissuto l’idealizzazione dell’America per il fatto che la nuova condizione sociale, al contrario della parte maschile, le aveva 69 Vedi BIANCHI, Lavoro ed emigrazione femminile, in Storia dell’emigrazione italiana, vol. I, cit., pp. 257-274: 260-261. 70 BEVILACQUA, Società rurale e emigrazione, cit., pp. 100-101. 71 BIANCHI, Lavoro ed emigrazione femminile, cit., p. 257. 29 accresciute nelle loro responsabilità con un nuovo ruolo dirigente: «iniziarono così a frequentare l’ufficio postale e lo studio notarile … Spettava infatti a chi era rimasto investire le rimesse, ricorrere a piccoli prestiti, soddisfare i creditori; una condizione di autonomia che se non intaccava l’autorità maschile si sostituiva ad essa nelle decisioni di ogni giorno …»72. Dover gestire gli affari di famiglia aveva potenziato la loro razionalità rendendole meno permeabili al sogno della propaganda. Questa condizione di autonomia era stata tollerata dagli uomini solo come temporanea: nel caso in cui il rientro risultava impossibile o sconsigliato dagli interessi economici, subito si richiedeva il ricongiungimento del nucleo familiare all’estero, per la gestione domestica. Così mentre gli uomini trovavano conforto nelle cure delle donne, che incarnavano il focolare del paese natio, queste vivevano il trasferimento con molta sofferenza. Non avevano tempo da dedicare a loro stesse e si trovavano troppo lontane dal conforto della rete conterranea di amicizie femminili73. Per questo le donne emigravano solo dopo aver stabilito che si trattava della scelta migliore per il bene della famiglia appellandosi a sopportazione, pazienza e spirito d’adattamento, «valori» che facevano parte dell’educazione prematrimoniale. Con il tempo riuscirono a creare nuove reti di compaesane che favorirono anche l’occupazione nelle Americhe. I contesti sociali influirono molto sull’approccio femminile all’emigrazione. Mentre, tra XIX e XX secolo, molte donne subirono il trasferimento per adempiere agli obblighi matrimoniali, come nel caso della famiglia Bartoli, dalla prima metà del XX secolo si accentuarono le migrazioni di coppia «che vedono entrambi i coniugi trasferirsi all’estero, o partendo insieme o, … a breve distanza l’una dall’altro»74, «sono spesso coppie di giovani artigiani o operai … nuclei familiari ancora senza carico di figli che non dispongono di alcuna base di terra …»75, esattamente come i coniugi Gabrielli. 3 Peculiarità delle lettere al femminile Nei nostri carteggi, le lettere delle donne ci riconducono, per la maggior parte, ai vincoli della scrittura al femminile76. Questo limite ebbe un effetto positivo perché le scriventi iniziarono a «prestare attenzione alla propria interiorità, per far emergere a livello di consapevolezza e quindi di narrazione 72 Ivi, p. 259. Vedi N. FILIPPI, Una storia che si ripete. Donne emigranti e donne immigrate nel Veneto, in F. CAMBI, G. CAMPANI, S. ULIVIERI (a cura di), Donne migranti, verso nuovi percorsi formativi, Edizioni ETS, Pisa 2003, pp. 185-221: 187. 74 RAMELLA, Reti sociali, famiglie e strategie migratorie, cit., pp. 152-153. 75 Ibidem. 76 Vedi G.R. CARDONA, Antropologia della scrittura, Loescher editore, Torino 1981, pp. 95-96. 73 30 dinamiche e conflitti interiori»77, la sfera intima e della memoria familiare divenne un modo diverso di percepire il mondo: ufficioso, domestico, invisibile e privato78 completamente opposto a quello maschile. Le donne interiorizzarono questo modo di pensare la realtà «beneficiando per prime del processo di autocostruzione del proprio Sé narrante/conoscente»79. Esse intendevano affidare alla carta la ricostruzione e la narrazione dei nuovi sviluppi delle proprie storie di vita. Certo se da una parte erano incoraggiate e richieste come depositarie delle emozioni, che gli uomini per cultura reprimevano80, dall’altra questa pratica si rivelò emancipatoria, perché con l’autoriflessione le scriventi presero atto delle proprie capacità intellettive e acquisirono maggior fiducia in se stesse e si rivitalizzarono81. 3.1 Da madre a figlia Trovandosi così lontane da casa e soffrendo della solitudine che ne derivava, le madri reagirono dedicandosi alle lettere di famiglia e trasmettendone la passione ai figli. La madre insegnava sia la lingua d’origine, con cui scrivere ai parenti oltreoceano, che il senso di responsabilità di mantenere viva la memoria raccontando le proprie esperienze di vita. «L’elemento orale rappresenta una componente centrale della scrittura migratoria … quale debito riconosciuto dagli autori verso i ricordi tramandati in famiglia … la narrativa migratoria comincia a connotarsi al femminile, perché memoria, aneddoto, racconto sono quasi sempre un fardello che le donne hanno conservato/elargito ai posteri»82. Questi riferimenti alla figura materna si ritrovano, nel carteggio Gabrielli, nelle epistole redatte da Graziella e Maria Laura. La madre avviò le figlie allo scambio epistolare facendosi lettrice e correttrice dei loro scritti, instaurando una complicità per cui lei riconosceva in loro ciò che era stata, mentre le figlie si identificavano nei suoi comportamenti83. Molto spesso nelle lettere delle ragazze, soprattutto in quelle di Maria Laura, vengono aggiunte, prima della conclusione, le scuse per una probabile 77 S. ULVIERI, Donne migranti e memoria di sé, genere, etnia e formazione: una ricerca nell’area napoletana, in Donne migranti, cit., pp. 241-275: 245. 78 LAHIRE, Identità sessuali alla prova della scrittura, cit., p. 152 e FABRE, Introduzione. Nove terreni di scrittura, cit., p. 24. 79 CAPELLO, Il Sé e l’Altro nella scrittura autobiografica, cit., p. 151. 80 Vedi ROMEO, Narrative tra due sponde, cit., p. 50. 81 Vedi F.M. SIRIGNANO, Donne e storie di vita: la memoria autobiografica come ricerca interculturale, in Donne migranti, cit., pp. 399-413: 401-402. 82 C. CATTARULLA, I. MAGNANI, L’azzardo e la pazienza, donne emigrate nella narrativa argentina, Città Aperta Edizioni, Enna 2004, pp. 13-14. 83 Vedi LAHIRE, Identità sessuali alla prova della scrittura, cit., p. 155. 31 scorrettezza grammaticale: «Vi chiedo scuse questa volta perché non so come ho scritto, senza la mamma vicino non so scrivere bene, solo aspetto che mi capiscono qualcosa di tutto lo scritto …»84. La presenza della madre è sinonimo di sicurezza, limita l’orizzonte dei figli dando loro la possibilità di sentirsi accasati, vicini a lei e protetti85. Infatti, questa nota si ripete per quasi tutte le lettere: Bene adesso penso di finire con il mio “testamento”, forse non capite qualche parole, so che non scrivo tanto bene ma non cé la mamma vicino per chiedere aiuto86. E un po tarde e non cé la mamma vicino per dirmi come devo scrivere …87. Questa relazione particolare che si stabilisce tra madre, figlia e lettera porta a privilegiare la figura femminile su quella del padre anche per quanto riguarda gli «affari di famiglia»: Di questa lettera papà e mamma non sanno nulla, ma forze a mamma se lo dirò perché lei si sentiva molto male per quello che è passato fra di voi, lei non a altre che parole buone e ricordi belli di voi e so che vi vuol tanto bene88. Dalla lettera di Maria Laura si evince come, in caso di malumori tra parenti, fossero le donne a dover riportare l’armonia. Lo facevano con spontaneità in quanto l’unione della famiglia era un valore fondamentale, soprattutto per chi emigrando aveva perso la rete di contatti del paese natio; la corrispondenza con i parenti oltreoceano era uno dei momenti più importanti e il pensiero di perderla destava una evidente preoccupazione. 3.2 Da donna a donna Pur mantenendo atteggiamenti pazienti e rispettosi nei confronti degli uomini di famiglia, le nostre scriventi avevano sviluppato una rete comunicativa autonoma in cui davano rilevanza prima di tutto alle destinatarie. Nelle sue lettere Lidia impostava il preludio avviando la conversazione sempre al femminile, non solo con i cognati: «Carissimi Vittoria e Eugenio»89, «Carissima Vittoria e Eugenio»90, ma con tutti i parenti: «Carissima Lisa Eber e tutta la famiglia»91. Non mancano simili attenzioni anche nel carteggio Bartoli, Anita inviò dall’Argentina un biglietto augurale alla cugina cogruzzese Diva 84 Lettera di Maria Laura Gabrielli, 23 marzo 1988, carteggio Gabrielli. Vedi JANKOWSKI, Ascoltare la madre, cit., p. 13. 86 Lettera di Maria Laura Gabrielli, 21 giugno 1987, carteggio Gabrielli. 87 Lettera di Maria Laura Gabrielli, 10 novembre (senza anno), carteggio Gabrielli. 88 Ibidem. 89 Lettera di Maria Laura, Graziella e Lidia Gabrielli, 18 luglio 1985, carteggio Gabrielli. 85 32 rendendola sua referente privilegiata: «Cara Diva con cuesto invio i più cari auguri a tè e tutta la familia»92. Ciò dimostra come questa complicità si fosse diffusa con la lettura collettiva dei carteggi e fosse stata poi interiorizzata come pratica ad ampio raggio. Nelle lettere delle donne più giovani tali attenzioni sono meno ricorrenti in seguito ad un’educazione che dava per scontata la parità di ruoli e diritti. Nelle lettere di Maria Laura i nomi dei destinatari erano spesso alternati: «Carissimi zii Vittoria e Eugenio»93 ma anche «Carissimi zii Eugenio e Vittoria»94, la stessa situazione si incontra nel carteggio Bartoli nei testi di Liliana Giurlani: «Queridos Vittorio, Enrica e Guido»95 ma anche «Carissimi Enrica e Vittorio»96. La progressiva perdita di questo preludio al femminile da un lato, era positiva in quanto presupponeva un’evoluzione del contesto sociale, dall’altro, negativa, perché causa del progressivo indebolimento di quella silenziosa alleanza transoceanica che le donne avevano costruito con «l’azzardo» per aver sfidato le regole patriarcali e «la pazienza» con cui avevano affrontato il duro cammino dell’emancipazione. 4 Lettere alla famiglia Scritte in ambito domestico, uno dei principali argomenti delle lettere femminili erano le vicende di famiglia che includevano lo stato di salute dei parenti e tutti gli eventi che quotidianamente segnavano l’esistenza sia delle persone che abitavano la stessa casa che dei compaesani con cui si avevano strette relazioni. Spinte dall’istinto materno e favorite dalla forma dialogica della lettera, le scriventi non volevano solo raccontare ma anche essere informate del benessere dei parenti oltreoceano, così «la lettera, veicolo di notizie di tutti i generi, diventò un’esigenza, un dovere familiare e sociale …»97. Nel carteggio Gabrielli le lettere di Lidia e delle figlie Maria Laura e Graziella cercavano continuamente il contatto con i parenti castelnovesi: Dopo tanto tempo vi scrivo solo due righe per mandarvi i nostri più cari saluti (la mamma vi ha scritto tante volte, ma non ha riuscito a mandare neanche una lettera) per dirvi che sempre vi ricordiamo tanto con tanto affetto … mi fa male non avere tue notizie in forma diretta. La mamma sempre mi dice che chi sa cosa pensa la zia Vittoria perché io non l’ho scritto più … per questo io … vi scrivo …98. 90 Lettera di Maria Laura, Graziella e Lidia Gabrielli, 21 giugno 1987, carteggio Gabrielli. Lettera di Lidia e Enzo Gabrielli, 12 agosto 1985, carteggio Gabrielli. 92 Lettera di Anita Bartoli, senza data, carteggio Bartoli. 93 Lettera di Maria Laura Gabrielli, 23 marzo 1988, carteggio Gabrielli. 94 Lettera di Maria Laura Gabrielli, 24 gennaio 1989, carteggio Gabrielli. 95 Lettera di Liliana Giurlani, 15 gennaio 1993, carteggio Bartoli, «Queridos» è il termine spagnolo per «cari». 96 Lettera di Liliana Giurlani, 17 giugno 1993, carteggio Bartoli. 97 BETRI, MALDINI CHIARITO, Introduzione, in «Dolce dono graditissimo», cit., pp. 7-17 [:8]. 91 33 Come si legge in questa lettera di Maria Laura, le ragazze si appassionavano alla pratica epistolare tanto da trovare sempre un po’ di tempo per scrivere sapendo che spesso, non ricevere notizie poteva essere causa di preoccupazioni e malessere per le donne lontane. L’epistola seguente è un esempio canonico di lettera familiare nel carteggio femminile. Il testo si suddivide in tre parti, in cui le donne di famiglia raccontano episodi personali o semplicemente riportano un saluto: Con tanto piacere abiamo ricevuto il pachetto con le due camicie e la cartolina che hanno portato Olga e Enzo Venturi, cosi pure le vostre notizie. Bene, questa volta incomincio io la lettera per ringraziarti quello che mi hanno mandato e per dirvi che ho gia finito il mio studio; e gia sono inscritta in tutti le scuole medie di Pergamino dove posso lavorare, spero di trovare presto un posto così sarò di meno peso a papa. In quanto a la mamma sono gia 20 giorni che è stata operata ad una gamba, e andata tutto bene, adesso dovrà andare per 4 o 5 mesi con la fasia elastica e poi dopo starà tutto a posto. Si è sentita un poco molesta per l’anestesia che l’hanno dato, ma l’ha superato abbastanza bene. Papa sempre fa qualche cosa ma piu che altro si dedica alla vendita dei materiali ed anche compra e vende delle machine insieme a Amadeo. Graziella, si tutto marcia bene, diventerà mamma in Gennaio, dopo tanto tempo di aspettare adesso e realtà. Qui siamo tutti tanto felice, io solo spero che tutto vada bene, Olga mi ha detto che mi aspettavano la, ti ringrazio tanto l’invito e spero di poter andare un giorno non tanto lontano Papa mi disse che aspettava l’indirizzo di Achille con il cognome ma anche questa volta vi siete dimenticati. Senz’altro, vi manda un forte abbraccio e un bacione, vostra nipote Maria Laura99. La prima parte è scritta da Maria Laura, che ha voluto precedere la madre, solita ad iniziare, mossa dal felice obbligo di ringraziare gli zii per il regalo ricevuto. L’entusiasmo che trapela dal testo è visibilmente sincero, inoltre, data la quantità numerica di lettere presenti nel carteggio, si deduce che Maria Laura amava realmente scrivere ai parenti oltreoceano per aggiornarli dei fatti perché, come lei stessa specificava, erano la sua famiglia e dovevano essere resi partecipi delle buone come delle brutte notizie. Il corpo di testo passa dalla descrizione della propria vita, il termine degli studi e il prossimo lavoro da insegnante, al buon esito dell’intervento operatorio subito dalla madre. Il campo di narrazione si allarga a tutti i membri di famiglia dallo stato di gravidanza della sorella Graziella alle attività lavorative del padre e del cognato. Nelle ultime tre righe Maria Laura interrompe la sua conversazione per trascrivere un messaggio del padre Enzo rivolto ad Eugenio, si tratta di uno degli «affari da uomini» di cui lei non è al corrente. Questo non è un fatto casuale, spesso gli uomini esercitavano la loro autorità sulle scriventi, imponendo la formalità della propria presenza nella lettera con la pretesa che la donna sospendesse la propria narrazione per citarli verso la conclusione e nei saluti. Non scrivevano in prima persona in quanto si trattava di argomenti al femminile. 98 99 34 Lettera di Maria Laura Gabrielli, 24 gennaio 1989, carteggio Gabrielli. Lettera di Lidia, Maria Laura e Graziella Gabrielli, 18 luglio 1985, carteggio Gabrielli. La lettera prosegue con il breve intervento di Graziella: «Carissimi … vi ringrazio tanto perche sempre con qualcosa vi ricordate di noi. Io sto bene un bacione grande Graziella e Amadeo»100. A differenza del padre e del marito che non scrivono, Graziella si sente a sua volta in dovere di rispondere all’affetto dimostrato dagli zii con il regalo. Nelle tre righe, si preoccupa implicitamente di inserire anche il saluto del marito Amadeo allo stesso modo in cui sua sorella aveva citato il padre. Carissimi … spero la presente incontrarvi in buona salute, come già Maria Laura vi dice sono stata operata e vado abbastanza bene la verità ora già sta, ma se sapevo quello che era non mi sarei operata continuavo come stavo, bé già sta e speriamo sia per il bene. Vi dirò che mi ricordo tanto e già ò tanta voglia di vedervi tutti, cara Vittoria quante sere sono qui guardo la televisione e mi ricordo di noi che guardando pure tele e mangiando le caramelline verdi i nostri giri in bicicletta che già non verranno più. Auguro che possiate terminare la casa presto Olga mi disse che state bene, loro sono venuti il 9 Luglio … grazie tanto delle camicie sono molto belle ma perché sempre disturbarvi? Spero che Lisa Eber Paolo e tutta la fam stiano bene fatele i nostri più cari saluti, saluti cari e un forte abbraccio per tutti sempre vi ricordo tanto Lidia La sorella di Lisa come sta? Quando ho nostalgia ascolto la casetta con vostre voci e faccio una piangitina101. La terza parte dell’epistola è scritta da Lidia che si preoccupa, con la domanda retorica sullo stato di salute, di recuperare il preludio trascurato dall’enfasi di Maria Laura. In seguito ripete in poche righe la sua condizione post intervento, questa brevità palesa come le donne amassero molto incentrarsi sugli interlocutori. Così Lidia si mette da parte velocemente per passare ad un dialogo a due con Vittoria, raccontando la propria nostalgia di casa e delle belle esperienze passate insieme dalle serate davanti alla televisione ai giri in bicicletta. Tempi, che come scrive, non torneranno più. Subito dopo Lidia cerca di riemergere dai meandri dei ricordi recuperando il suo ruolo archetipico di donna di casa, informandosi sullo stato di salute degli altri Gabrielli castelnovesi ma non riesce a reggere all’emozione e tracolla confessando che nei momenti più tristi si sfoga piangendo e ascoltando le voci registrate dei parenti. Non mancano anche nel carteggio Bartoli lettere di famiglia al femminile. Una missiva modello, di cui si riportano solo alcune parti in quanto molto lunga, era stata scritta da Ioles ai cugini cogruzzesi, Vittorio ed Enrica, subito dopo una conversazione telefonica: La tua chiamata (da due ore fa) è stata proprio come se una finestra si aprisse nel tuo paese! Io ero a letto che leggeva (e ore 16) del pomeriggio ho un po di raffreddore già che siamo in autunno … io sto bene … altri parenti tutti bene … . 100 101 Ibidem. Ibidem, «fam» forma abbreviata per famiglia, in originale nel testo. 35 Il bisogno di scrivere che segue al dialogo probabilmente sottolinea come le donne si sentissero più a loro agio e libere di raccontare sul foglio di carta. Infatti, dalla lettera di Ioles pare che, nonostante la telefonata di poche ore prima, si avessero ancora moltissime informazioni da comunicare: In quanto alla zia Adela, molto commossa per la disgrazia del Iofre, che era giovane ancora … pativa di una constante depressione, come risultato di altri fattori (come penso io), la sua ditta … non va tanto bene … è tutto fermo … Iofre si richiudeva in casa sua non vedeva nessuno, aveva paura in forma patologica … è morto per un sincope cardiaco, credo che alle 3 del mattino … ti dirò che incomincio a sentire nostalgia di vedersi a tutti i conoscenti e le loro … città …102. Anche in questo caso il ruolo della donna è farsi depositaria degli affari di famiglia da raccontare ai parenti per renderli pienamente partecipi della vita di comunità. Oltre ad essere a conoscenza di quasi tutte le vicende familiari le donne tendevano anche a spiegare i fatti accaduti facendo appello al loro «sesto senso». La nostalgia resta un topos immancabile. 5 «Con tanta voglia di vedervi» La nostalgia era uno dei sentimenti più ricorrenti nelle lettere al femminile. La sua presenza costante risaliva ai tempi della scelta del viaggio migratorio compiuta, molto spesso, dal marito e sopportata dalla donna che, nonostante il coraggio e la determinazione d’animo, continuava a soffrire per tutta la vita la lontananza dal paese e la solitudine per la perdita degli affetti femminili: Non sempre e non necessariamente le mogli erano felici di partire … L’emigrazione comportava l’interruzione dei rapporti con i parenti e amiche in patria, che avrebbero potuto essere mantenuti solo in absentia. Quando non vi era la prospettiva di sostituirli con altri all’estero, il trasferimento esponeva le donne al rischio di ritrovarsi sole, senza relazioni proprie … l’inesistenza di reti femminili nelle quali inserirsi … non le incoraggiava a emigrare … Non era scontato che la solitudine fosse la prospettiva che attendeva le mogli con il trasferimento all’estero. Quando l’emigrazione avveniva nel quadro di quella di altre famiglie con le cui donne vi erano rapporti di parentela e di amicizia non era così103. Ciò spiega perché le mogli dei primi Bartoli emigrati avessero convinto i mariti a sposare sorelle o vicine di casa, in modo tale da avere una rete con cui aiutarsi reciprocamente. Invece Lidia era emigrata sola con il marito lasciando tutti i parenti e gli amici in Castelnovo Sotto e nonostante la presenza dei compaesani in Pergamino, con cui si erano costruiti dei rapporti di amicizia, non si trattava della stessa condivisione di affetti e confidenze che aveva vissuto nel paese d’origine. Manifestava la sua nostalgia in molte lettere anche solo 102 103 36 Lettera di Ioles Bartoli, 7 aprile 1991, carteggio Bartoli. RAMELLA, Reti sociali, famiglie e strategie migratorie, cit., pp. 154-155. con una frase: «Tu continui ancora con la barberia? Le notizie del paese buone e brutte sempre fanno piacere. Vi ricordo sempre tanto tutti un abbraccio per tutti»104. Altre volte sentiva ancora più forte il bisogno di manifestare il proprio affetto ai parenti, spesso questa pressione emotiva era legata ai rientri da vacanze trascorse al paese, distacchi da una realtà cui non ci si voleva separare e rientri in un’altra realtà cui non era mai semplice adattarsi: Vi ricordo sempre tanto e non dimenticherò mai l’atenzione ricevuta nella mia permanenza lì con voi la verità verità vi voglio tanto bene e tu cara Vittoria sei stata così buona con me credimi che ti ricordo con tanto affetto sono sincera105. Sempre le manifestazioni di affetto e nostalgia sono le chiavi che ci portano a riconoscere l’autenticità degli scritti femminili. Luce Irigaray sostiene che, con questi codici emozionali, le donne insegnassero come «abitare il linguaggio … un modo di legare linguaggio a realtà … senza raddoppiare il mondo a parole …»106 che, al contrario, era prerogativa indispensabile della psicologia maschile. Qualora l’aura emotiva delle lettere perdesse la propria vivacità sarebbe indizio di una forzatura, di una pressione proveniente dall’esterno non certo dall’animo della scrivente. 5.1 «Il dittatore e la dettatura»107 Una simile impressione si è incontrata in una delle lettere di Lidia, la sua scoperta ha svelato un elemento frequente nell’epistolografia femminile e che si ricongiunge ad aspetti precedentemente trattati: Mi auguro che al ritorno Bartoli e signora incontrarvi bene, peccato che sono rimasti solo 15 giorni per un viaggio tanto lungo credo non vale la pena, grazie per le cose che avete mandato tutto molto bello e gradito … La foto dell’entrata molto bella proprio allo stile che Enzo immaginava … in questo modo qui continua la propaganda che a casa del fratello di Enzo ci si incontra molto bene … ma che mai cerchiamo di mandarvi degli amici nostri non è affatto vero … Ora pure vedrete che arriveranno Rossinelli e Signora per circa un mese, solo per roscuotere l’eredità di una casa … ed anche questi vengono di sua spontanea iniziativa dato che si sono fatti amici con voi. Di tanto in tanto sentiamo le novità del paese per tramite Eber le belle a volte sono brutte ma col passare del tempo gl’anni sono sempre più … cose in bene non si possono aspettare. Dal nostro ultimo viaggio le relazioni fra di noi si sono cambiate lasiamole perdere e dire solo che il destino le a volute cosi, non è un 104 Lettera di Enzo e Lidia Gabrielli, 12 agosto 1985, carteggio Gabrielli. Lettera di Lidia Mori, 26 gennaio 1987, carteggio Gabrielli. 106 ZAMBONI, Le riflessioni di Arendt, Irigaray, Kristeva e Cixous sulla lingua materna, in All’inizio di tutto la lingua madre, cit., pp. 137-150 [:143]. 107 Vedi LAHIRE, Identità sessuali alla prova della scrittura, cit., p. 156. 105 37 bene io capisco ma andare incontro a ragioni che proprio Enzo non ne a affatto nessuna colpa. Ci avete mandato pure delle fotografie da dare a Venturi e Olga ma loro si trovano in Italia su a Baiso lui non si trovava bene di salute a deciso in fretta vendere tutto e venire a radicarsi lì nel suo paese, dopo di questo noi non abbiamo più saputo nulla … Abbiamo visto le filmine che ha mandato R … sono chiare e non nascondo che al vederle ho sentito molta nostalgia e un nodo alla gola, con tanta voglia di vedervi tutti un forte abbraccio vi voglio tanto bene108. Dopo un periodo di silenzio dovuto a dissapori familiari, Lidia riapre la conversazione per recuperare i rapporti. Nel discorso che articola con molta formalità, non nasconde il suo disagio per una condizione che avrebbe sempre voluto evitare, rassicura i parenti del suo affetto ma si intuisce anche un’aura di freddezza nelle parole, anomala per le sue lettere. Tale senso di estraneità si acuisce nel punto in cui, con tono retorico, Lidia chiede ai parenti di sollevare Enzo dalle colpe del litigio. La frase risulta molto strana, non è motivata e pare quasi «imposta». Il discorso prosegue e si dilunga sulle vicende dei compaesani Venturi, un altro esempio di famiglia in cui, ancora una volta, l’uomo, dopo anni passati in Argentina, preoccupato per le proprie instabili condizioni di salute, opta per un repentino rientro in patria senza prestare ascolto ai desideri della moglie, conoscente di Lidia. La nostra scrivente non esprime giudizi su questi atteggiamenti maschili che ha imparato, come le altre donne del suo tempo, a rielaborare, si limita a narrarli con tono informativo. Il suo sentimento sostenuto tracolla alla fine della lettera, tornando ad una ormai insperata vivacità emotiva che esprime la nostalgia per il paese e i parenti. Uno scritto di qualche tempo dopo conferma le impressioni suscitate dal testo di Lidia: Conosco bene le due versioni su quel incidente da anni fa e la ultima lettera che hanno mandato in quella che dice che scrive la mia mamma; bene lei non si ricorda di cosa ha scritto perché non ha fatto altra cosa che copiare una lettera scritta per mio papa perché lui le a detto di copiarla, ma lei non voleva. Non so cosa pensate voi, ma io posso parlare per lo que vedo in casa, mio papà non sta bene. In questi ultimi anni ha invecchiatto tanto; si è venito tanto abbasso che non è la stessa persona che voi avete visto neanche che io conosceva. Ha avuto molti “achagui” … lui non si vede bene ha perso tutta la sua securità …109. Ecco che si spiega la freddezza parsa così insolita per le sue lettere, non si trattava di un testo autografo ma della trascrizione di una comunicazione dettata dal marito! Se Lidia non ha il coraggio di denunciare questo atto di forza subito, lo fa Maria Laura che, forte di un’educazione, quella degli anni Ottanta, in cui le donne avevano già ottenuto la parità dei ruoli non teme l’autorità del padre. Maria Laura difende la madre ma allo stesso tempo giustifica la reazione del padre che, a suo parere, aveva fatto ricorso ad un 108 Lettera di Lidia Mori, 28 gennaio 1987, carteggio Gabrielli. Lettera di Maria Laura Gabrielli, 21 giugno 1987, carteggio Gabrielli, «achagui» significa acciacchi. 109 38 gesto arrogante per nascondere le sue difficoltà a scrivere dovute alla vecchiaia. Inoltre l’uomo, fortemente indebolito, cercava un modo per imporsi ma aveva perso la sua sicurezza ed era tracollato esprimendo la propria disperazione negli autoritarismi domestici. Nella storia della scrittura femminile queste prevaricazioni erano comuni e diffuse in ambito familiare: «Molto spesso, quando il marito acconsente a partecipare alla redazione di lettere … detta a sua moglie così come fa … alla … segretaria» questa azione trova la sua spiegazione nell’etimologia della parola «Dicto, significa tanto dettare un discorso … quanto dettare nel senso di prescrivere, ordinare, raccomandare, consigliare»110. 6 Sapori e parole Nelle lettere di migrazione si parlava spesso di cibo perché il mito americano era legato all’abbondanza alimentare, simbolo di benessere e ricchezza per la società rurale. Questo non porta a sostenere stereotipi come l’assenza di un’offerta diversificata di prodotti alimentari nelle campagne o l’inesistenza di una cultura culinaria. Già nel XIX secolo l’inchiesta Jacini e il ricettario del celebre Pellegrino Artusi documentarono la presenza, nelle campagne italiane, di regimi alimentari che erano prevalentemente vegetariani in quanto il resto delle risorse animali, dovevano essere cedute dai braccianti ai proprietari terrieri. Quindi si trattava più di un esproprio alimentare che di una mancanza e la creatività nella realizzazione di piatti semplici non era estinta111. I membri della società rurale avevano talmente tanto interiorizzato le abitudini vegetariane che, una volta compiuto il viaggio d’emigrazione, tendevano a mantenere i propri costumi alimentari consumando prodotti già noti che, molto spesso, venivano trapiantati in nome di un vero e proprio conservatorismo. Come per la lingua, gli emigranti vollero mantenere inalterata anche la cucina perché era l’espressione più tangibile delle loro origini e realizzava quell’identità che non era ancora pronta per il processo di decostruzione. Ancora una volta le donne, protettrici del focolare, dovevano provvedere ai fabbisogni nutritivi, che erano sempre stati di loro competenza, ma anche incarnare la madrepatria cucinando esclusivamente piatti nazionali, o ancora meglio, regionali. Il substrato di cultura materiale si fece base della cultura femminile e oggetto dei dialoghi tra compaesane oltreoceano, passo fondamentale verso la destrutturazione e ricomposizione dell’identità112. 110 111 112 LAHIRE, Identità sessuali alla prova della scrittura, cit., pp. 157-158. Vedi TETI, Emigrazione, alimentazione, culture popolari, cit., pp. 575-597 [:577]. Vedi ROMEO, Narrative tra due sponde, cit., p. 116. 39 6.1 «a mangiare cappelletti» in casa Gabrielli Nei primi tempi da emigrati, uomini e donne sopraffatti dalla nostalgia del paese e dall’ansia di dover reagire allo spaesamento subito nel nuovo contesto, rafforzavano la propria identità associando all’atto del «mangiare» un’aura di sacralità. «Mangiare insieme», come avveniva nel paese d’origine, diveniva una via possibile per riconoscersi e riconoscere «l’altro … la convivialità … avvicina le persone, annulla le distanze, allontana la paura …»113. Questa convivialità connotava anche i nostri scriventi castelnovesi. Le lettere raccontano che erano le donne, le organizzatrici di piacevoli ritrovi gastronomici tra compaesani, parenti ed amici e, se invitate, erano sempre loro a prestare attenzione al cibo preparato che traducevano, per istinto materno, in uno scambio di affetto. A differenza degli uomini che tendevano al conservatorismo del piatto tradizionale vedendo nell’autoisolamento l’unica difesa culturale, le donne dialogavano di cucina e cibo nelle loro lettere, confrontavano e scrivevano delle proprie diversità per comprenderle, accettarle e rielaborarle114. La precisione che le portava a ricordare nei dettagli i cibi consumati insieme alle persone care era un’ottica non convenzionale che metteva in discussione la stessa cultura americana, avversa al dedicare tempo al pasto, celebrando una mentalità esclusivamente italoamericana115. In una lettera Lidia scriveva alla cognata: «guardando pure tele e mangiando le caramelline verdi …»116, risulta quasi incredibile come, a distanza di tempo, specifichi il colore delle caramelle. In questo modo voleva comunicare a Vittoria che la memoria di lei sarebbe sempre stata distinta dagli altri ricordi, in quanto resa speciale dalla peculiarità delle caramelle verdi, per niente comuni. Sempre nella stessa lettera Lidia aggiungeva: «Olga mi disse che state bene, loro sono venuti il 9 Luglio a pranzo con noi e abbiamo parlato tanto di voi tutti …»117. Ecco realizzata la convivialità, il cibo che favorisce la comunicazione e il recupero della memoria familiare, un altro attributo molto importante per il processo di ricostruzione della soggettività dell’emigrante. Allo stesso tempo questi messaggi femminili davano anche informazioni sul benessere della famiglia perché l’abbondanza di cibo che si poteva offrire agli invitati, era sinonimo di un’ottima situazione economica. Oggi è venuto Camillo Bartoli e sembra proprio che venga con la famiglia a fare un giro, vi dirò che con noi è molto buono e pure Enzo mi disse che … si è portato tanto bene con 113 Vedi TETI, Emigrazione, alimentazione, culture popolari, cit., p. 590. Vedi BAROLINI, Riproponendo The Dream Book, an anthology of writings by Italian American women, cit., p. 219. 115 Vedi ROMEO, Narrative tra due sponde, cit., p. 144. 116 Lettera di Lidia Mori, 18 luglio 1985, carteggio Gabrielli. 117 Ibidem. 114 40 lui, come pure sua moglie e figlia veramente sono i paisani che più spesso vengono da noi e che pure invitano sempre a pranzo …118. L’amicizia con i compaesani, necessaria per costruire legami d’affetto con cui motivare la propria vita oltreoceano, era spesso rafforzata dalla tavola. In questa lettera, i molti inviti a pranzo sono per Lidia un segno di altissima considerazione da parte della famiglia Bartoli, l’offerta del cibo, per altro risorsa preziosa per chi aveva vissuto momenti di difficoltà, era un dono non comune, proprio delle situazioni speciali. Lidia si ritiene onorata di essere così di frequente un’occasione speciale per i Bartoli, inoltre, ancora una volta, è una donna a scrivere con ammirazione di queste occasioni ritenute grandi espressioni di gentilezza. Il fatto che fossero soprattutto le donne a rivalutare l’offerta gastronomica era dovuto alla loro consapevolezza dell’impegno richiesto per la preparazione del cibo, sia che si trattasse di ricette tradizionali, che di piatti di nuova creazione. Per essere invitante il cibo necessitava di cure e, nel caso di piatti emiliani, i procedimenti si ricordavano a memoria. La tecnica infallibile che le donne mettevano in pratica per non dimenticare nulla era la diretta associazione di un ingrediente a un evento familiare, così le ricette potevano essere ricordate più agevolmente anche dalle giovani generazioni che ingigantivano questi episodi di vita quotidiana in eventi epici di un mondo passato quasi mitologico. Sempre nel carteggio Gabrielli si trovano altri riferimenti all’atto conviviale: Giorni fa siamo stati a visitare (e a mangiare cappelletti) a casa di suo fratello la lagnanza è reciproca per le estremamente rare comunicazioni epistolari!! Qui tutti stanno bene; la signora Lidia è stata operata della vena e con qualche riguardo si muove bene …119. A scrivere in questo caso sono i coniugi Venturi che, dopo essere stati ospiti di Eugenio Gabrielli, erano tenuti ad espletare il ruolo di ambasciatori di famiglia. La signora Olga aveva costruito una relazione d’amicizia con Lidia e si preoccupava di rendere note le condizioni di salute dell’amica ai suoi parenti castelnovesi. La specificazione: «e a mangiare cappelletti …» lascia dedurre che gli emigranti, in occasioni speciali quali visite tra conoscenti, usavano preparare piatti emiliani e la felicità di poterli mangiare era accresciuta se ci si trovava in terra argentina, perché provava come si potesse ricreare un breve contatto con il paese natio. In questo caso, per attutire la nostalgia del rientro e allo stesso tempo per festeggiare la ventata castelnovese che tornava in casa Gabrielli, personificata dai due paesani, si era deciso di cucinare un piatto che rappresentasse tutti questi emigranti e li facesse sentire uniti almeno per alcune ore. 118 119 Lettera di Lidia Mori, 9 aprile 1967, carteggio Gabrielli. Lettera di Olga e Enzo Venturi, 14 luglio 1985, carteggio Gabrielli. 41 La tavola acquisiva importanza anche come luogo di riunione familiare, sia nei momenti di festa, che in quelli seri, legati a decisioni da prendere o questioni da risolvere: «Con tutto l’altro pacco che mi avevi consegnato ci siamo seduti tutti insieme a tavola e l’abbiamo letto con attenzione … papa ha detto che per lui è tutto dimenticato …»120. Sempre una donna, in questo caso Maria Laura, invita la famiglia intorno al tavolo per leggere con attenzione le carte che le sono state inviate per posta dallo zio Eugenio Gabrielli. La presenza di tutti, presuppone un atteggiamento di massima attenzione per i documenti da discutere, su cui sarebbe stato richiesto il parere di ogni membro della famiglia. In questo caso, nonostante l’approccio democratico al problema proposto dalla figlia, il padre esercita il suo ruolo autoritario chiudendo subito la discussione con la decisione di dimenticare tutto. Certo la tavola era risolutrice dei malumori familiari che si risolvevano a volte, con la discussione e l’allegria, altre volte con l’imposizione del silenzio e il persistere di un rammarico irrisolto. 6.2 «della grande varietà di mangiare» dei Bartoli Nel carteggio Bartoli i riferimenti alla cucina e al cibo non sono scritti direttamente dalle donne ma da loro raccontati e poi trascritti per mano maschile. Questo parrebbe contraddire tutto ciò che è stato teorizzato finora sulle lettere degli uomini, in realtà è il contesto in cui si redige la lettera a favorire questo passaggio. Camillo Bartoli scrive al cugino cogruzzese Guido per ringraziarlo dell’ospitalità e dell’accoglienza dimostrate al figlio Remo, in uno dei suoi primi viaggi oltreoceano. Riporta nel testo le osservazioni di Remo e della moglie ed è proprio la donna a confermare la sensibilità per l’argomento gastronomico: con il ritorno di Remo siamo stati di festa al raccontarci tutta la sua gita a casa vostra anche mia nuora e rimasta tanto contenta, ci raccontano che le avete fatto una grande accoglienza e della grande varietà di mangiare fattagli, noi vi ringraziamo di tutto cuore …121. L’abbondanza e la varietà della cucina, colpiscono la donna che ne apprezza la creatività. Oltre ad essere segno di grandissima gentilezza dimostrata dai parenti, si rivela una vera e propria scoperta per quei discendenti che non erano nati in Emilia, rivelazioni che forse avevano contribuito a costruire il sentimento di italianità espresso da Remo nelle lettere analizzate nel capitolo precedente. 120 121 42 Lettera di Maria Laura Gabrielli, giugno 1995, carteggio Gabrielli. Ibidem. 6.3 Cucina creativa per una nuova identità femminile In seguito ai vari esempi riportati si vede come il legame tra alimentazione e convivialità, cibo e lingua, era segnato dal vincolo materno. Come era la donna a garantire la diffusione della lingua d’origine con cui si conversava a tavola, era sempre lei a garantire la sopravvivenza e il futuro alla famiglia per mezzo del cibo122. Alimentazione e linguaggio erano i due elementi fondamentali per il recupero dell’identità individuale. Le donne, forti di questa ricchezza, si appropriavano più velocemente della propria soggettività ed erano incentivate ad aprirsi al dialogo interculturale con le tradizioni del luogo d’emigrazione. Il senso pratico le portò a tradurre il processo di integrazione con la creazione di nuove ricette che univano la tradizione reggiana ai prodotti reperibili in terra argentina. Questo processo non fu solo delle donne castelnovesi ma si trattava di un gesto istintivo, proprio del pensiero femminile, realizzato da quasi tutte le emigrate. In Argentina, trovando un contesto più aperto al confronto transculturale, l’influsso italiano si fece preponderante in campo culinario con l’introduzione dei vegetali, uso comune nella società rurale. A sua volta la cucina vegetariana si integrò di prodotti animali dando una certezza tangibile di benessere123. La mediazione e la promozione di occasioni di incontro sul tema per opera delle Società italiane aveva contribuito ad agevolare il contatto e lo scambio culinario tra le culture del territorio. Così, la cucina delle donne, che ne esprimeva la creatività, si qualificava come luogo di costruzione etnica, uno strumento che rendeva più immediata, con il linguaggio del cibo, la percezione di sé nel nuovo mondo124. 6.3.1 La cocina della nonna125 Con l’intento di stabilire una comunicazione culturale tra Pergamino ed Emilia Romagna, un gruppo di donne italoargentine ha curato una pubblicazione in cui si raccolgono ricette tradizionali emiliane e le corrispettive realizzate con ingredienti argentini. Quest’opera di traduzione ha reso i cibi più comprensibili e più apprezzati perché integrati agli aspetti culturali del paese in cui sono 122 I. MAGNANI, Il desco e la lingua, in I. MAGNANI (a cura di), Il ricordo e l’immagine, vecchia e nuova identità italiana in Argentina, edizioni Spartaco, Cesena 2007, pp. 87-101: 93-94. 123 Ivi, pp. 90-91. 124 Vedi TETI, Emigrazione, alimentazione, culture popolari, cit., p. 593. 125 Vedi A. BARRERA, La cocina della nonna, recetas de la Emilia-Romagna, Artes graficas Buschi, Buenos Aires 2006. 43 preparati e consumati, rivelandosi anche di fondamentale importanza per la diffusione della memoria emiliana tra i discendenti degli emigrati. Le ricette sono state proposte in nome dell’imperitura «maniera di essere delle donne»126 forte e radicata nella duplicità italoargentina, come testimoniato dalla doppia versione linguistica del libro, italiana e spagnola. La maggior parte delle ricette è associata al nome di chi ne ha fornito sia l’originale che l’arrangiamento, questo per sottolineare la soggettività di ciascun autore e renderlo, ancora una volta, consapevole della propria integrazione realizzata nel piatto. In nome della tradizione mnemonica femminile ma anche per agevolare la comprensione della ricetta con uno sguardo al contesto reggiano, ogni piatto è accompagnato da un proverbio o dalla narrazione di una storia della bassa che contribuisce ad esaltare di ricordi il sapore del cibo. Il capitolo dedicato ai tortelli è quello in cui meglio si realizza il parallelo culturale. Dopo averne specificato la provenienza reggiana e le tipologie del ripieno: erbette o zucca, si passa alle indicazioni pratiche per la realizzazione. Nel caso si vogliano preparare quelli di zucca è necessario aggiungere una batata 127 alla zucca argentina che è più acquosa di quella reggiana. Esistono due ricette per i ripieni, la prima: «1 zucca di quelle che si chiamano «pucherito», mostarda a piacere, amaretti a piacere, Parmigiano-Reggiano a piacere (se non avete dei parenti che possono inviarvi il vero, si può usare un buon reggianito argentino, però il migliore)…» la seconda: «Zucca, batata, amaretti, noce moscata, mostarda, sale e pepe, Parmigiano-Reggiano …» ... «Si possono mangiare con qualche salsa, però a noi piace con burro, formaggio e gratinati al forno»128. La batata è fondamentale per rendere la consistenza del ripieno simile a quella originale, il formaggio può essere sostituito da una variante che ben si sposa con gli altri ingredienti. Non è dunque necessario il prodotto emiliano se non lo si può reperire facilmente, non è necessario cercare in esclusiva i prodotti di una terra ormai troppo lontana per avere un buon risultato, l’importante è saper proporre la propria ricchezza culturale servendosi dei mezzi disponibili sul nuovo territorio. I metodi di cottura che seguono lasciano libertà d’interpretazione anche se la specificazione di «a noi piace con …» dà adito a due pensieri, da una parte, delinea un gusto proprio dei reggiani, un piccolo limite cui potrebbe seguire un adeguamento in nome di un recupero completo dell’appartenenza, dall’altra, può essere una specificazione solo informativa per rendere noto come li si consuma abitualmente in Castelnovo. La ricetta dei tortelli verdi, legata alle vicende di due Bartoli, pone subito a confronto i «tortelli verdi – Castelnovesi» e i «tortelli verdi pergaminensi»129, 126 127 128 44 Ivi, p. 12. Patata dolce. Ivi, pp. 44-45. gli ingredienti dei primi sono quelli tradizionali reggiani: «Bietola o spinaci, cipolla, lardo, sedano, pane grattugiato. Parmigiano-Reggiano e asparagi»130, la variante argentina sostituisce alcuni prodotti che non sono di facile reperibilità: «Bietola o spinaci, cipolla, peperone, aglio, salsiccia e Parmigiano-Reggiano»131, ecco che aglio, peperone e salsiccia arricchiscono il piatto con un tocco sudamericano apprezzato dalle generazioni italoargentine, acuendo il piacere di gustare e scoprire i cibi e le storie degli antenati. Altri contributi delle donne Bartoli sono le ricette dei cappelletti e poche pagine dopo ci si imbatte in un ripieno per lasagne «Lidia», purtroppo non ci sono specificazioni ma dato il contesto, in cui la maggior parte delle donne collaboranti è membro del gruppo degli emigranti e discendenti castelnovesi, non risulterebbe insensato collegare il nome a quello di Lidia Mori in Gabrielli. Il ricettario è completo di tutti i cibi della tradizione reggiana: risotti, insalate, tagliatelle, bruschette, polenta, cannelloni, spongata, tortellini dolci, insomma rende possibile trasportare l’Emilia nella propria casa argentina. 7 Donne e politica «Anche se il termine politica deriva dall’aggettivo greco politikos (da polis) significante tutto ciò che si riferisce alla città e quindi cittadino, civile, pubblico – senza distinzione di genere –, la politica come arte e scienza del governo è stata intesa per lungo tempo come prerogativa dell’uomo-cittadino. Le trasgressioni in questo campo venivano a disturbare … non si esitava a definire «mostruoso regime delle donne» …»132 quei governi che avevano a capo figure femminili. Come nel campo culturale, anche in quello politico le donne erano state escluse per evitare che una loro presa di consapevolezza rompesse la subordinazione imposta dalla società maschile. Nello stato moderno del XVI secolo, la donna di ceto medio era considerata una cittadina ma raramente veniva coinvolta nelle assemblee elettive o consultive del suo territorio. Per altri due secoli la politica rimase un «affare da uomini». Sempre a livello europeo, nel XVIII secolo con l’affermazione dei partiti e la crescente alfabetizzazione, una minoranza di donne colte iniziò ad orientarsi e a partecipare attivamente e coerentemente alla vita politica prendendo consapevolezza del proprio status di cittadine senza cittadinanza. La determinazione a farsi riconoscere il proprio ruolo determinante in ambito pubblico indusse le donne a lavorare con molta pazienza per diffondere queste consapevolezze anche tra gli strati sociali popolari. In Italia, a partire 129 Ivi, pp. 46-47. Ibidem. 131 Ivi, pp. 46-48. 132 F. TAROZZI, Donne e politica, in G. ZARRI (a cura di), La memoria di lei, storia delle donne, storia di genere, Società editrice internazionale (SEI), Torino 1996, pp. 105-121: 105. 130 45 dal XIX secolo, i cambiamenti socioeconomici che si manifestarono portarono a diverse dinamiche di relazione tra i sessi con la responsabilizzazione delle donne, della società rurale, in quei settori lavorativi e amministrativi da cui erano sempre state allontanate. Facilitato dall’ormai diffusa istruzione, il richiamo delle donne in questi ruoli organizzativi si era rivelato indispensabile in seguito all’esodo maschile migratorio e bellico, ciò aveva comportato per le lavoratrici il riconoscimento, almeno formale, di alcuni diritti sul lavoro e in famiglia. Le donne acquisirono lentamente la gestione delle eredità e, con l’impiego nel settore industriale, partecipavano della vita di fabbrica interessandosi gradualmente al corporativismo come ai movimenti dei lavoratori133. Nello stesso periodo le suffragiste lottarono duramente per il raggiungimento dell’indipendenza giuridica ed economica della donna, per l’affermazione di un’identità femminile che permettesse un’autonomia di gestione dei salari guadagnati col lavoro. Nel corso del Novecento furono numerose le commissioni istituite per aprire il dibattito sul riconoscimento dei diritti femminili in quanto le donne erano sempre più protagoniste attive del loro tempo. La fuoriuscita dalla cerchia domestica le aveva rese consapevoli delle dinamiche esterne che potevano vivere di persona, si ricorda che, nel reggiano una maggioranza femminile sostenne l’affermazione del partito socialista134. Dopo la seconda guerra mondiale, la partecipazione delle donne alla Resistenza impose finalmente di dover considerare le figure femminili come soggetti con piena cittadinanza e diritti civili, un decreto del 1945 che precedeva la riunione della Costituente, garantì questo riconoscimento135. Non si hanno molti dati riguardo la partecipazione femminile alla vita sociopolitica argentina, certo è che, a scavalco tra XIX e XX secolo, nel paese gli italiani iniziarono ad essere protagonisti attivi in questo campo. Il territorio argentino non si mostrava particolarmente ostile, motivo per cui gli italiani avevano organizzato dei movimenti operai piuttosto influenti cui probabilmente parteciparono anche le donne lavoratrici136. Infatti, da alcuni studi, risulta che nei primi decenni del XX secolo in America si estese il diritto di voto al pubblico femminile, anche se la strada dell’emancipazione non fu affatto priva di ostacoli soprattutto nel realizzare concretamente la parità dei diritti. Per molto tempo ancora l’accettazione pubblica restava legata alla vecchia distinzione che prevedeva per gli uomini l’esercizio del governo e per le donne l’assistenza sociale137. Sempre dal 1945 si aprì un contatto tra Italia e Argentina per cui si chiedeva una rappresentanza politica oltreoceano che si 133 Vedi PALAZZI, Donne sole, cit., pp. 48-241. Vedi CAVANDOLI, Le origini del fascismo, cit. 135 Vedi TAROZZI, Donne e politica, cit., p. 110. 136 Vedi BRETAGNA, L’associazionismo in America Latina, in Storia dell’emigrazione italiana, vol. II, cit., pp. 579-595: 588-589. 137 Vedi TAROZZI, Donne e politica, cit., p. 110. 134 46 realizzò, dopo un lungo dibattito, con l’estensione del diritto di voto per gli emigrati con cittadinanza italiana138, così anche le donne ebbero la possibilità di interagire con le questioni politico-sociali del paese di provenienza. In realtà non esercitarono quasi mai questo interesse, come dimostrano le lettere delle nostre scriventi, per una questione di educazione e di sottomissione al capofamiglia. Furono i movimenti femministi degli anni Settanta ed Ottanta, diffusi in tutto il mondo, a conquistare una dimensione paritaria completa permettendo alle donne di acculturarsi e crescere in un contesto equilibrato tra gli aspetti dell’educazione materna e la consapevolezza del contesto sociopolitico e degli ambiti che erano stati competenza dei loro padri. Nei nostri carteggi gli scritti di Maria Laura Gabrielli e Ioles Bartoli introducono riflessioni e constatazioni politiche ed economiche che figurano come vere e proprie novità, inesistenti nelle lettere al femminile delle altre scriventi. 7.1 Due donne che non ballano il tango Maria Laura e Ioles erano di generazioni diverse ma entrambe avevano ricevuto un’istruzione prevalentemente, se non esclusivamente, argentina. Nelle loro lettere le difficoltà di resa espressiva dei concetti sociopolitici dipendono più dal blocco linguistico rispetto ad un uso disinvolto e pieno dell’italiano, che da una limitata consapevolezza sull’argomento. Maria Laura vive il problema socioeconomico del suo paese in età universitaria, quando si trova incentivata a terminare gli studi per poter ottenere un posto di lavoro e mantenersi senza gravare sulle spalle della famiglia. Si tratta di un momento di passaggio che la introduce nella vera dimensione sociale, l’impatto che ne deriva è duro, l’Argentina degli anni Ottanta è in piena crisi economica causata dal continuo susseguirsi di governi instabili ma questo non impedisce a Maria Laura di sviluppare una capacità di reazione determinata dalla volontà di riscatto personale. Nelle lettere che scrive a Castelnovo, agli zii Vittoria ed Eugenio Gabrielli, rende nota questa situazione: che in l’argentina le cose non vanno tanto bene, per noi i giovani è tutto difficile; molte volte ho pensato di andare via, di fare qualcosa in altro paese pero mi manca l’ultima decisione, bene abbiamo una speranza di riuscire bene di tutto questo casino …139. Io adesso sto lavorando molto grazie a Dio, perché in questo paese non c’è altro que disoccupazione; non so dove si andrà a finire140. 138 Vedi COLUCCI, Il voto degli italiani all’estero, in Storia dell’emigrazione italiana, vol. II, pp. 597-609: 604-609. 139 Lettera di Maria Laura Gabrielli, 23 marzo 1988, carteggio Gabrielli. 140 Lettera di Maria Laura Gabrielli, giugno 1995, carteggio Gabrielli. 47 La certezza di un futuro precario diviene per lei un’abitudine, entra a far parte della sua forma mentis, spesso lo scrivere ai parenti italiani si rivela una valvola di sfogo che aiuta a rielaborare lo sconforto quotidiano, acquisendo nuove forze di reazione. Il fatto che nelle lettere non compaia mai la richiesta di un aiuto né economico né burocratico legato all’espatrio, testimonia come lo scrivere le serva esclusivamente per confrontarsi e ricevere consigli da persone fidate. Dagli estratti analizzati pare che la sua consapevolezza sia ridotta esclusivamente al contesto giovanile. Forse non è così, il fatto stesso di sostenere che l’espatrio non sarebbe la strada giusta per uscire dal «casino» potrebbe tradire un’idea generica delle cause economico politiche che hanno contribuito al crack. La concisione del testo risulta un po’ eccessiva ma si deve anche comprendere la difficoltà di elaborare un’argomentazione, con termini specifici, in lingua italiana. In questa lettera scritta anni più tardi, la situazione di vita pare non essere molto diversa dalla precedente: Carissimi zii Eugenio e Vittoria, vi ringraziamo tanto che sempre avete un pensiero per noi e nostri figli che crescono bene grazie a Dio. Nostro paese in crisi ma noi stiamo abbastanza bene. Vi ricordiamo sempre con tanto affetto141. Divenute adulte le sorelle Gabrielli hanno confermato la loro determinazione a costruirsi una vita normale con la realizzazione della famiglia nonostante le difficoltà economiche del paese. In una semplice lettera di saluto ai parenti, con una sola frase in cui rassicurano del loro benessere, dimostrano una costante consapevolezza della situazione politica ed economica in cui vivono che si integra al senso di protezione familiare del loro ruolo di madri. Ioles Bartoli era più vecchia di Maria Laura, ma essendo cresciuta in Argentina aveva goduto di un’educazione più poliedrica rispetto a quella delle coetanee italiane, curando un certo interesse per l’ambito politico del suo paese. Da questo punto di vista le sue lettere sono le più incisive e descrittive tra quelle delle nostre scriventi: È da molto tempo che volevo scrivervi però i giorni passano in fretta, … sempre vi abbiamo in mente, parecchie volte viene Enzo in bicicletta … facciamo due chiacchiere e intrattiene mio padre. Qui la situazione non è tanto facile c’è tanta gente che non arriva al 10 del mese e allora rubano. Il presidente attuale è una brava persona … però … situazione di incertezza. Ieri sono stata con una mia amica che va imparare l’italiano e le sue compagne quasi tutte figlie di italiani, stanno facendo il passaporto italiano per qualunque eventualità; in questi giorni ho pensato di farlo anch’io e mi manca solamente l’atto di nascita della mamma; mi rivolgo a voi se mi fa il piacere di andare all’ufficio del Comune di Castelnovo 141 48 Lettera di Maria Laura e Graziella Gabrielli, 24 gennaio 2002, carteggio Gabrielli. Sotto per avere il documento. I dati sono: Fieni Rina nata il 16 luglio 1902 a Villa Cogruzzo, padre Fieni Carlo mamma Cocconi Adele … vi facciamo tanti auguri Buone Feste142. Adesso c’è una grande inflazione e il governo di Alfonsin dice che per Settembre sarà tutto diverso (una politica di shoc) … e dicono che se non fanno cosi l’anno prossimo nessuno voterà questo partito, per le elezione presidenziale …143. Ioles non tralascia nulla dei classici ambiti dell’epistolografia al femminile, infatti inizia a scrivere agli amici castelnovesi (sempre Eugenio e Vittoria Gabrielli) per aggiornarli delle dinamiche familiari. Poi, cosa inaspettata nelle lettere di una donna, aggiunge con disinvoltura le proprie osservazioni politiche, non nascondendo simpatie governative. Questo significa che Ioles conosceva i programmi di governo e compiuta una scelta personale avrebbe voluto discuterne e renderla nota anche oltreoceano. Inoltre ripone fiducia e spera in un miglioramento futuro anche se la situazione di povertà estrema non è di semplice risoluzione. Come molti altri figli di emigranti, pensa all’eventualità del ritorno in patria e chiede agli amici castelnovesi di inviarle i dati anagrafici dei propri antenati per avviare le procedure del passaporto. Nonostante la lucidità razionale che esprime nei suoi scritti, in quanto donna non teme di rivelare il proprio sconforto per l’ovvia mancanza di prospettive, così che il recupero dei dati anagrafici è un appiglio che le dà una speranza futura, ossia la libertà di poter eventualmente uscire dalla disperazione dilagante nel paese. Tutto questo resta solo un sostegno psicologico perché, in realtà, sia Ioles che Maria Laura, non vogliono lasciare il territorio, riconoscono nell’Argentina una delle loro due patrie, l’altra è l’Italia, cui si appellano tramite i fantasmi degli antenati, per avere un supporto morale. Adesso passiamo ad un altro discorso, in quanto alla situazione economica è molto difficile, però adesso sembra che il governo sia sulla strada corretta, (di libero mercato) si incomincia una nuova Argentina, tra due mesi più o meno si dovrebbe capire il miglioramento in caso contrario si svolgerà una fatale iper inflazione che ci coinvolge e a tutti … Adesso c’è una battaglia contro la corruzione questo fa molto bene … Il matrimonio che oggi domenica parte per l’Italia è la figlia della … sorella del Bartoli … La sua zia di Alicia e Berta (cognata della Bianca Magnani) così non so dove andranno … ¡¡Coraggio!! venite un’altra volta vi aspettiamo144. Le speranze riposte nel governo sembrano trovare finalmente una risposta e le buone notizie di una ripresa sono accompagnate da un’aura ottimista che si propaga per tutta la lettera. Ioles dimostra di avere, oltre alle competenze politiche anche quelle economiche, perché specifica che la linea intrapresa dal governo è quella del libero mercato, una consapevolezza non comune 142 143 144 Lettera di Ioles Bartoli, 16 dicembre 1985, carteggio Gabrielli. Lettera di Ioles Bartoli, 25 luglio 1988, carteggio Gabrielli. Lettera di Ioles Bartoli, 7 aprile 1991, carteggio Bartoli. 49 per le donne della sua generazione. Come sempre le osservazioni politico economiche si mescolano con quelle familiari e risulta interessante il parallelo, involuto, tra la ripresa argentina e la notizia del matrimonio dei conoscenti (o forse lontani parenti) castelnovesi che, in nome delle proprie origini, decidono di svolgere la cerimonia in Italia. A una notizia tanto insperata si associa un evento importante che richiede un grande festeggiamento. La lettera si chiude con un affettuoso invito ai parenti cogruzzesi a recarsi ancora in Argentina, come si nota, la nostalgia è sempre latente. La presenza di riflessioni politiche ed economiche nelle nostre lettere femminili conferma il loro «essere poliedrico» citato all’inizio del capitolo. Si è scelto di darvi spazio per illustrare compiutamente come i carteggi delle donne esprimevano compiutamente le preoccupazioni, le passioni e «il sentire» che caratterizzavano l’esperienza umana dei nostri emigranti sconfessando in pieno quel ruolo di «limbo di bontà e nobili sentimenti» che aveva cercato di relegare la razionalità femminile «ai margini della vita reale, esattamente come avviene nel tango»145. Esistiamo perché ci raccontiamo Il 25 settembre 2004, poco dopo la morte di Enzo Gabrielli, Lidia scrive una lettera a Eugenio e Vittoria, si è pensato di proporla in conclusione come metafora della ciclicità dell’esistenza dei nostri scriventi. Dopo molti anni, Lidia, si ritrova a vivere in un contesto completamente trasformato in cui ritrova elementi che la riportano al suo passato. Non è spaventata dal cambiamento, lo vive come un’evoluzione naturale della vita cui lei stessa si adeguerà dopo aver compiuto un’altra visita ai parenti oltreoceano: auguro al ricevere la presente trovarvi in buona salute. Qui tutti bene grazie Iddio il piccolo Enzo crese bene e sano come pure Emilia … Io … cerco di curarmi perché voglio venire a vedervi tutti che tanto ricordo con affetto. Dopo la morte del caro Enzo non sono stata bene … In quanto all’ Italclub con Enzo era molto non andavamo perché Enzo già ammalato non si muoveva da casa. Graziella dove va alle reunione che fanno sono le reunione degli Emiliani che Analia è la presidenta …146. Ciò che realmente ci interessa di questa lettera è la continuità che lega tutti gli elementi citati, molti aspetti di quel mondo familiare, in cui fiora ci si era proiettati con la lettura dei carteggi, sono mutati e questo non implica l’approdo ad un’assenza di riferimenti ma anzi, una proiezione nel futuro. Il ricordo dei defunti vive nei discendenti, l’essenza del vecchio Enzo, recentemente 145 146 50 Vedi CATTARULLA, MAGNANI, L’azzardo e la pazienza, cit., p. 15. Lettera di Lidia Mori, 25 settembre 2004, carteggio Gabrielli. scomparso, si ritrova nel piccolo Enzo che, come scrive Lidia, cresce bene. La nipote Emilia si fa personificazione del «ponte» che collega Pergamino con Castelnovo, terra delle origini, assicurando, con la sua giovane età, un futuro alla memoria di famiglia. Graziella partecipa alle riunioni dell’Italclub al posto del padre, coltiva e conserva il senso d’appartenenza che le era stato trasmesso e lo stesso club da centro prevalentemente maschile oggi ha una presidentessa che ne promuove le attività. Ottima credenziale vista la citata creatività delle donne nella costruzione di legami transculturali. La lettera prosegue: «abbiamo gia fatto il pasaporto italiano tutte e 3, la mamma, Lucia e io per venire in Italia e abbracciarvi forte …»147. Ecco che torna la ciclicità, la traversata oceanica che unisce al paese natio, se per Lidia pare essere l’ultimo viaggio, per la nipote Lucia è di una delle prime visite agli zii italiani. Ci pare possibile individuare in queste continue alternanze: nascita e morte, inizio e fine, Emilia ed Argentina, femminile e maschile, le simbologie del duro percorso di ricostruzione di sé che, dai primi anni del XX secolo, gli emigranti castelnovesi, donne e uomini, «padri» e «figli» avevano intrapreso in terra argentina. I carteggi delle nostre famiglie, confermando il loro valore di fonti storiche, ci hanno permesso di entrare negli eventi vissuti esplorando e condividendo con i protagonisti le tappe di queste articolate storie di vita. Le emozioni, le esperienze, le parole scambiate tra parenti e amici hanno evidenziato come ogni soggetto scrivente sia stato autore della propria esistenza, all’interno di contesti storico sociali che determinavano linee generali di azione e pensiero. Inoltre, lettere e fotografie hanno svolto il loro ruolo di prolungamento della personalità dei soggetti tenendo vivo un processo di rinascita iniziato molti anni fa, che è giunto oggi alla realizzazione di un’identità pluriculturale. 147 Ibidem. 51 Dalla parte di Francisco Franco «Volontari» reggiani nella guerra civile spagnola Alcune interviste Luca Fantini Quel che resta dell’antifascismo reggiano, nella seconda metà degli anni Trenta del Novecento – circa mille aderenti al PCI a Reggio Emilia, tra carcerati, confinati e liberi – si mobilita clandestinamente in favore della legittima Repubblica spagnola, aggredita dalla rivolta del generale Francisco Franco. Il regime fascista di Mussolini, all’indomani della ribellione, invia un contingente armato di «volontari» a sostegno del golpista, che ha come alleato anche la Germania hitleriana. L’anno scorso, ricordiamo, si sono conclusi i settantesimi della guerra civile spagnola, iniziata nel luglio del 1936 e terminata nel marzo 1939, con l’entrata a Madrid delle truppe di Franco. Abbiamo, perciò, ritenuto interessante recuperare la tesi di laurea di Luca Fantini, Dalla parte di Franco. Opinione pubblica e «volontari» reggiani nella guerra civile spagnola, discussa con Luciano Casali, nell’anno accademico 1988-89. Le interviste che qui pubblichiamo sono solo alcune delle tredici raccolte da Fantini. Ne abbiamo scelto quattro, rilasciate da appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN) e da soldati e ufficiali, appartenenti al regio esercito italiano. A conclusione della breve antologia proponiamo quella dell’avvocato Alcide Spaggiari, allora giovane dirigente del GUF reggiano, da cui esce un interessante profilo dell’intellighenzia reggiana di quegli anni. L’interesse delle testimonianze, soprattutto, risiede nel fatto che documenti di questo genere non hanno avuto nel tempo un’adeguata diffusione e riflessione storica, a differenza della partecipazione degli antifascisti reggiani. Ricordiamo, per tutti, il lavoro di Antonio Zambonelli, Reggiani in difesa della repubblica spagnola (1974). «Il reclutamento per la Spagna – ci fa notare Fantini – avveniva in modo discreto e senza molta pubblicità, utilizzando diversi canali. Uno di questi consisteva nel fare compilare un modulo di domanda intestato alla milizia, dove il riferimento esplicito per l’arruolamento era costituito dalla campagna d’Africa, a cui seguiva la dicitura “e per qualunque altra destinazione”. Forse questo è il motivo che spiega come dice ad esempio Buffagni di essere stato “chiamato”, o dell’arrivo “di una lettera di partire per Cadice”. Firmando quella 52 domanda, attratti dal miraggio di benessere che rappresentava in quel momento l’Africa, si ritrovarono soldati di Franco». Infatti nel 1937 il «problema principale per alcune fasce della popolazione – prosegue Fantini – era rappresentato dalla ricerca del lavoro, tanto è vero che la maggioranza dei futuri “volontari” spagnoli avevano presentato domanda per l’Africa orientale... [...]». Dai dati ricavati dall’indagine di Fantini sarebbero 292 i reggiani impegnati nelle operazioni militari contro la Repubblica spagnola, mentre diciassette furono i caduti. Qui di seguito, riportiamo alcuni passaggi della tesi di Fantini per facilitare la lettura delle interviste, fornendo un minimo di contestualizzazione in cui inserire i fatti raccontati dagli intervistati. Fantini ha raccolto i dati consultando: • lo schedario dei gerarchi fascisti (conservato oggi presso il Polo archivistico del comune di Reggio Emilia) suddiviso per Fasci di combattimento, in cui, tra le altre informazioni, è segnalata la partecipazione alle campagne di guerra, nel nostro caso alla guerra civile spagnola: la sigla OMS (Oltre mare Spagna) nel gergo burocratico militare serviva a coprire l’aiuto fascista a Franco; • i documenti depositati all’Archivio di Stato di Reggio Emilia, ossia «gli elenchi dei volontari OMS appartenenti alla MVSN (Milizia volontaria sicurezza nazionale) e al regio esercito, che i comuni di tutta la provincia compilarono in risposta alla circolare prefettizia n. 832 del 5.08.1937». La presenza dei legionari reggiani in Spagna diviene pubblica solo a partire dalla metà del 1937, attraverso la pubblicazione sul «Solco Fascista» delle interviste e delle lettere di «volontari» «che insieme alle biografie dei caduti – scrive Fantini – contribuiscono alla composizione di un indice della forza reggiana impiegata». Allo scoppio della guerra, infatti, le «pagine locali del “Solco Fascista” ignorarono totalmente gli avvenimenti spagnoli, così come fecero ufficialmente le varie associazioni fasciste della città, anche se nel dicembre del 1936 alcuni reggiani erano già presenti nella penisola iberica». Nel corso del 1937 l’atteggiamento del regime mutò: il «Solco Fascista», infatti, pubblicò oltre duecento articoli riguardanti il fronte spagnolo, «che con un linguaggio eroico-spirituale presentavano i fatti come una crociata di liberazione». Il 27 febbraio 1937, era stato pubblicato nella terza pagina del «Solco Fascista» l’ordine del giorno della Milizia in cui si affermava: «In data 15 gennaio 1937 le sottonotate CC.NN. vengono passate nella forza indisponibile perché mobilitate per esigenze speciali e avviate al centro di reclutamento della 67esima legione». «Le “esigenze speciali” – annota Fantini – altro non erano che la copertura che ancora si dava all’appoggio italiano a Franco [...]. Anche la Chiesa reggiana, 53 che fece la sua scelta di campo molto presto e in maniera decisiva, pubblicò nel luglio del 1936 sul “Bollettino Diocesano” le Preghiere per la Spagna, mobilitando una vastissima campagna propagandistica all’interno dell’Azione cattolica, organizzò conferenze come quella del 6 gennaio 1937 al Cenacolo Francescano con padre Antonio da Barcellona, dedicata a svelare le Verità sconosciute sulla Spagna martire». Anche i Gruppi universitari fascisti (GUF) – si veda a questo proposito l’intervista a Alcide Spaggiari anche se ha ricordi differenti – intervennero a più riprese nel corso del 1937, pubblicando nella pagina che periodicamente aveva a disposizione sul «Solco Fascista» cinque articoli. Fu dopo la pubblicazione dell’articolo di Mussolini, Guadalajara, uscito sul «Popolo d’Italia» il 7 giugno 1937, e ripreso dal «Solco Fascista» nell’edizione del 18 giugno, che l’intervento italiano in Spagna non venne più tenuto nascosto. «Il 26 giugno – afferma Fantini – il fascismo reggiano fornì la versione ufficiale degli avvenimenti organizzando una cerimonia presso la caserma della Milizia, dove, alla presenza del comandante della Legione 10, seniore cavaliere Pallotta, il seniore Fulloni lesse e commentò l’articolo di Mussolini e ricordò la morte del generale Alberto Liuzzi, che era rimasto ucciso proprio nella battaglia di Guadalajara. [...] I festeggiamenti del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma avvenuta nel 1922, furono l’occasione per ricordare i caduti di Spagna, che vennero accomunati nel rito fascista dell’appello, a quelli di tutte le guerre e ai martiri della rivoluzione fascista. Le disposizioni per le celebrazioni del 31 ottobre – che ricordavano, tra l’altro, la sfilata delle camicie nere dinanzi al re avvenuta all’indomani della marcia su Roma – furono pubblicate su un’intera pagina. Gran parte del programma, che comprendeva una funzione religiosa in omaggio ai caduti e l’inaugurazione delle opere pubbliche eseguite nell’anno XV dell’era fascista, venne riservata alla memoria dei legionari, infatti, dopo un corteo che si snodò per le vie del centro, la manifestazione si concluse con lo scoprimento dei nomi dei morti presso il Sacrario della federazione. Adunate si verificarono in tutte le Ville e in provincia. Venne officiato, inoltre, un rito religioso in duomo e nel cortile della casa del fascio si schierarono autorità, gerarchi, insieme a rappresentanti delle forze armate, degli squadristi, dei reduci dell’Africa orientale e dei reduci della Spagna. [...] Le donne fasciste, invece, organizzarono il “Natale dei legionari” dedicandosi alla preparazione di pacchi contenenti: “tutte quelle soavissime cosucce alle quali solo una madre sa pensare; le calze di lana ... La carta da lettere ... e calendari”, da inviare in Spagna, così come pacchi furono inviati in Africa». Il 19 ottobre 1938 il «Solco Fascista» – citiamo sempre il lavoro di Fantini – diede alle stampe un comunicato che annunciava lo sbarco a Napoli di cento legionari reggiani reduci dalla Spagna e che l’onorevole Rabotti, che nel frattempo era diventato direttore del giornale, si recava ad accoglierli. 54 Il programma della manifestazione di accoglienza ai legionari di ritorno dalla Spagna (pubblicato dal «Solco Fascista» del 22 ottobre 1938) comprendeva: «Il saluto ai legionari all’interno della stazione da parte della fanfara del comando federale della GIL e un servizio d’onore composto da una compagnia della MVSN, da una compagnia dell’esercito, da un reparto di reduci dall’AOI e da un reparto di squadristi. La manifestazione sarebbe proseguita con un corteo che dal piazzale della stazione si sarebbe snodato fino alla piazza Vittorio Emanuele e quindi al Palazzo Comunale; lungo tutto il tragitto del corteo si sarebbero schierate le forze fasciste. Furono emanate inoltre delle disposizioni generali che riguardavano lavoratori, infatti, la federazione prese accordi che permettessero in caso di arrivo durante le ore lavorative di consentire egualmente la partecipazione degli operai. L’arrivo dei legionari sarebbe stato annunciato dalla sirena dello stabilimento delle Reggiane e successivamente da tutte le altre sirene e dalla campana civica, i pubblici edifici e le case private dovevano essere imbanderiati e alla sera illuminati. Il giorno successivo seguì il testo del messaggio di saluto del segretario federale e l’ordine di adunata alle associazioni; si curò la preparazione della manifestazione nei minimi dettagli». La cronaca del giorno pubblicata sul «Solco Fascista» così racconta la giornata: «Si parlò di “Trionfali accoglienze” e di “Entusiasmo di popolo”. I legionari dopo il corteo vennero ricevuti nella Sala del Tricolore dal podestà e da tutte le massime autorità, e presenziarono nella cattedrale alla messa in suffragio ai caduti della rivoluzione dove il vescovo prima di salire all’altare, rievocò il radioso sacrificio di quanti rimasero per sempre “nella martirizzata terra spagnola, caduti in nome di un ideale di fede, giustizia e libertà”». La caduta di Barcellona, avvenuta il 26 gennaio 1939, venne annunciata dal fascismo con l’esposizione delle bandiere tricolori su tutti i balconi della città. «Il giorno successivo – scrive Fantini – fu la volta della manifestazione ufficiale, la cui cronaca occupò quasi completamente una pagina del “Solco Fascista”. Le celebrazioni per “la splendida vittoria di Barcellona”, così fu definita, iniziarono molto presto, quando al mattino gli studenti in corteo si recarono “dove tutti vanno quando hanno alcunché nel cuore”. Arrivati alla casa del fascio vennero accolti dal segretario del GUF, che improvvisò un discorso, interrotto frequentemente, così riportarono le cronache, da “alti e ardenti alalà provenienti da tutte le parti”. In quel clima, che veniva definito “lietamente festoso”, si attese la sera, quando in piazza della Vittoria si riversò una folla immensa che, cantando e sventolando bandiere, si riunì per ascoltare il discorso del federale, il quale, assunti i toni trionfalistici dei vincitori [...] La manifestazione, che si concluse con l’omaggio ai caduti e all’esercito, venne ripetuta presso le case del fascio di tutta la provincia, e in modo particolare a Guastalla, dove si riunirono oltre duemila persone. Ancora le bandiere “ali tricolori della nostra gioia”, comunicarono la vittoria di Madrid [28 marzo]». L’ultimo contingente di legionari reggiani fece il suo rientro il 14 giugno 1939. (g.b.) 55 Testimonianze Walter Cigarini Nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1913. 6a elementare, impiegato daziario, disoccupato. Ha prestato servizio militare come soldato nel 2° genio minatori. Iscritto al PNF dal 24 maggio 1935; iscritto alla MVSN dall’1° dicembre 1936 CNS, plotone esploratori. Iscritto all’Associazione volontari di guerra e al Sindacato industria. Volontario Oltre Mare Spagna (OMS). Ingaggiato per la Spagna il 28 dicembre 1936, è sbarcato a Cadice l’11 gennaio 1937. Ha partecipato alle battaglie di Malaga, Guadalajara, alla campagna della Catalogna, rimanendo nella penisola iberica fino al giugno 1939. Qui si guadagna diverse onorificenze: croce di guerra ordinaria nel 1937, distintivo commemorativo campagna di Spagna, medaglia di volontario di guerra, nastrino seconda croce di guerra al merito e nastrino cruz roja. Dal 19 settembre 1939 è capo-nucleo del Fascio di combattimento di San Pellegrino (RE). Le note informative del 1939 esprimono un giudizio «buono». Nel 1940 è in Africa, nel 1943 viene fatto prigioniero dall’esercito francese. Fonti: Schedario dei gerarchi fascisti, ora in Polo archivistico Comune di Reggio Emilia-Istoreco. L’intervista si è svolta il 15 luglio 1987 a Reggio Emilia. […] Come le ho detto io, per esempio, per quello che riguardava la partecipazione alla Spagna, io come… come venivo da… da militare e facevo parte del genio minatori, un reparto di specialisti. Questo per quanto riguarda la faccenda della Spagna, che poi, quella lì è stato l’ingaggio. Io facevo parte del Gruppo rionale qui di San Pellegrino… Del partito? Del partito, era come... praticamente non ero neanche iscritto, però siccome quelli che erano addetti al partito, uno... il segretario era stato mio direttore, perché ho lavorato sotto allo spaccio dell’Ente autonomo consumi… Allo spaccio dell’Ente autonomo consumi? Ente autonomo consumi, generi alimentari... in città c’erano parecchi spacci, anche fuori di città. Facevo capo a questo... che aveva poi gli uffici, la direzione, tra l’angolo fra via Fontanelli e via San Martino, sopra; sotto c’era il magazzino, dove c’è la cosa, come si chiama… quella degli artigiani, la CAAM, tutta la casa della CAAM era occupata 56 dalla cosa, dall’Ente autonomo, e direttore era Vittorio Rossi; lui era segretario del Fascio qui di San Pellegrino. Allora io siccome dopo ero rimasto a casa... disoccupato, e avevo bisogno di lavorare, perché a casa purtroppo filava, filava molto, allora per vedere se potevo intrufolarmi da qualche parte, così facevo un po’ il galoppino per la sede quando avevano bisogno di portare via qualche missiva, qualche cosa lì. Io ci andavo volentieri, un po’ per far piacere, anche perché li conoscevo e anche per vedere se riuscivo a trovar qualche cosa. Finché una giornata andai là e mi hanno chiesto, anzi mi diedero, un appuntamento una sera alle undici... Così tardi? Frequentavo questo bar qua della rotonda, c’era un caffé lì, c’è ancora... e m’hanno chiamato alle undici e quando sono là, c’era lui, il segretario, il rappresentante dei combattenti, il capo manipolo della milizia, c’era il fiduciario, che era un mio amico anche lui (sono amico anche con suo fratello che è ancora al mondo) e mi ha chiesto se volevo andare a combattere, i’ho dìt: «Dove?» e lui dice: «Prima devi dire se ci vai, dopo ti dico dove». Dico: «Tanto lo so già», c’era solamente quella lì, non si trattava mica tanto di scegliere. Dico: «Facciamo un patto; è lo stesso se vi dico, se vi do la risposta domani sera?». Dice: «Ma sì». Siccome volevo vedere un po’ come andava, avevo... era poco che era morto il povero mio padre ed era lui che tirava avanti la baracca, poi è successo che c’è... avevo in famiglia, oltre a me, che ero l’unico maschio, avevo tre sorelle; […]. Alòra sono andato a casa, ho parlato con mia sorella, non ho chiesto neanche a mia madre perché mia madre era ancora in gamba, ma oh... morale della favola, che... che decisi di andare via, più che tutt’altro perché sapevo, mi ero già informato, sapevo come era il trattamento. Insomma, non era lo spirito d’avventura... che politico, che me ne fregava proprio un bel po’. Perché un motivo solo, perché io la politica, a dirlo in poche parole, m’ha sempre fatto schifo. lo sono nato socialista, lo dico io … Lei era socialista? Lo dico io... No, non ero socialista, ma ho vissuto con dei socialisti; avevo un mio zio, fratello di mio padre, che era un socialista e dormivamo nella medesima camera. Allora ho imparato un po’ da lui il modo di trattare, ma più che altro era lo spirito mio, a me piaceva veder la gente che andasse d’accordo e che si dividessero il pane, non come facevano in genere gli italiani, se no... sono... anche adesso, sono iscritto al partito socialista, ma le dico la verità: àm piés mìa; come an n’um piés ch’ietér, non mi piacciono gli altri; io ci ho però un punto di partenza e quando dico, quando sento parlare degli italiani, àm và vìa tùtt al vòi. Me a m’han delùs talmeint, sarà anche un... il carattere mio, che me a sùn quasi un tedésch, praticamente nel modo di fare... Cioè il modo di fare preciso? Preciso, metòdic, metodico, disciplinato; non sentivo neanche la naia quando m’han mandato a chiamare a militare, non la sentivo per niente, anche quando si era via... Dopo son partito sono andato in Libia, dopo aver fatto la Spagna ho fatto la Libia, son turné a ca’, ho fatto sei anni con tre anni di prigionia e tutto; non sentivo mica 57 la disciplina, cioè sentivo l’affetto per i miei cari, perché ci pensavo volentieri... tanto alla povera mia madre specialmente, alle mie sorelle, però non sentivo quell’affanno che hanno in genere... Il patriottismo? I còs... Sì... No, non era patriottismo, era come si dice... spirito di disciplina ecco, tutto lì. Insomma in poche parole, allora è successo che, che mi misi d’accordo, andai alla sera... Siccome però andar via allora, come le ho detto prima, che io non ero mica un iscritto. Sì facevo parte del cos... come si dice… del gruppo dei giovani fascisti, perché mi piaceva fare dello sport, praticavo, giocavo a pallavolo, a pallacanestro, corsa a piedi... corsa campestre, niente di buono perché purtroppo, perché a un dato punto dovevo fermarmi, per via... del cuore. Allora accettai perché mi dissero che prendevo... a me non davano niente, ma mandavano... il governo italiano, subito lo ricordo, non so di preciso questo qua, se il pagamento, il pagamento dei, dei volontari che andavano in Spagna veniva fatto tramite la Santa sede, non lo so di preciso... Lei dice attraverso la Santa sede? So perché vede, io sono andato giù allo sbaraglio, cioè in poche parole, un gruppo, non eravamo ingaggiati dall’Esercito italiano; dopo ci fu la partecipazione diretta... del governo italiano. Lei andò prima? Allora mandarono giù dei milioni e tante belle cose, invece no, noi eravamo un gruppo di gente, tanto è vero... da Reggio siam partiti in sette... Ma che data era, se la ricorda la data precisa in cui è partito? Dunque quando siamo andati via, partiti direttamente da Reggio, andati in Spagna o partiti per la Spagna, perché a gh’è da scéglier, cioè mé a sùn sté ingagié il 28 dicembre del ’36... e la rivoluzione spagnola era scoppiata il 18 luglio. Andammo a Cadice. Cioè da Reggio, o da dove? Da Reggio andammo giù a Napoli, da Napoli, siamo stati là dal 28 fino al 9 o al 10 pressapoco, poi arrivammo a Cadice l’ 11 gennaio ’37, là eravamo tutti... anche giù a còs, anche giù a Napoli non eravamo mica incorporati, non l’eravamo mica... Eravate in borghese? Sì. tant’è vero che a Napoli ci fu un capitano, che veniva dalla Marina, era un tenente, primo tenente, dopo passò capitano, si chiamava Maltese, era un esperto in fatto di artiglieria. Siccome noi, io, poi, avevamo domandato consiglio, poi dopo non potevo, non sapevo che branca prendere, quando ci fu chiesto se, in che corpo volevamo andare, si imbatté il caso che un giorno o due prima trovammo un ufficiale reggiano giù... che lui non lo conoscevo, ma conosceva gli altri, fra i quali c’era Consolini, ma Bassoli non c’era mica, che era già... venne dopo... tra gli altri che già erano venuti via con me. In poche parole... «Lei di dov’è?» «Ma io sono... in artiglieria... voglio venire in 58 artiglieria...», «Dite... che... siete degli artiglieri, poi se caso mai mi chiederanno confermerò...». Cioè l’era un po’ una baraonda, in pochi paròli. Fatto sta che, che infatti ci chiesero in che corpo volevamo andare in artiglieria, artiglieria, még... con me, c’era uno che è ancora al mondo... qui di Reggio, però non so se lui sia un tipo adatto da... Lo sa il nome? Si chiama Montanari Enzo... siamo venuti su da ragazzi insieme. [...] Al dìs: «Béda bein – al dìs – mé a vòi gnìr via tég...». Perché voleva venir via con lei? Perché era proprio un suo amico? Sì, a parte quello lì non è questione che, era che lui si trovava nelle condizioni che ero io, cioè anche lui aveva lavorato sotto all’Ente autonomo ed era disoccupato anche lui... alòra... Anche lui aveva bisogno di lavorare? No, non è che fosse proprio nella necessità di lavorare lui, lui poteva campare ugualmente, io no, che avevo... avevo bisogno, lui invece poteva anche tirare avanti senza, senza farcela alta, intendiamoci bene: aveva dei fratelli che lo potevano aiutare ecco, in poche parole... ma lui voleva venir via con me, anche perché lui come ho detto non aveva fatto il militare. Era un po’ di spirito avventuroso, alla vela, ma... non sapeva da che punto... Insomma voleva venir via e tutto, allora ci siam messi d’accordo che la sera dopo, quando dovevo riportare la risposta alla sede... quando sono andato là, ho parlato con il segretario e dico: «C’è un mio amico che vuol venir via con me». Perché allora, come le ho detto, gli ingaggi erano fatti a «in una qualche maniera». Mi domandano chi è. «Ma l’è Montanari... Enzo» rispondo: «Ah... alòra», poi dopo... «Ma... noi abbiamo chiamato te perché sappiamo chi sei». Allora andava anche un po’ in fiducia... che non fosse uno da mandare via e poi quando arrivava là passasse dall’altra parte, capito... In poche parole era quello lì lo spirito; dico: «No, ma lui ci ha anche il fratello che è capo manipolo...». Ah mo al dìs: «Mo sé, mo sé – al dìs – no, no... va bein, va bein, alòra dìg c’àl végna anca lò». Infatti a l’ho mandato là, perché prima di firmare la domanda di partenza per la Spagna, noi dovevamo fare il passaggio alla milizia, se no, non potevamo mica andar via. Quindi, anche se uno non era iscritto doveva iscriversi per forza alla milizia? Iscriversi alla milizia per partire, in quelle condizioni lì, perché si diceva allora che tutti i sold... tutti i reggiani, tutti gli italiani che andavano in Spagna, dopo che era scoppiata quella rivoluzione lì, che facevan parte... della parte di... Franco, logicamente dovevano... venivano pagati dalla cosa... Da Franco? No, dalla Santa sede e difatti io ho trovato un amico mio che abitava lì alla Rosta Vecchia, dove abitavo anch’io prima... l’ho trovato giù... In Spagna? 59 Dopo, dopo due mesi, due mesi o tre mesi circa che ero su ho trovato questo, Benedetti Alfio si chiamava... dice: «Ma cosa fai qui?» «Eh…» mi dice... aveva cambiato nome... si chiamava Bianchi, perché allora quando siamo andati noi avevamo, tenevamo il nostro nome e cognome che ci avevamo, invece quando furono mandati via quelli là, erano mandati via in incognito, quelli là cambiavano nome arrivati in Spagna... Erano proprio i primissimi quelli là? Sì, quelli erano i primi, erano partiti un mese o due dopo l’avvento di questa rivoluzione... insomma e se... in poche parole... sono riuscito... che non... poi, dopo quando là, il comando di legione, che era lì dove c’è la polizia stradale adesso, lì in viale Timavo, lì c’era il comando di legione della milizia... allora siamo andati a richiedere... facendo parte della milizia sono andato a finir sotto al battaglione di Reggio che era l’89° battaglione di Reggio delle camicie nere... e una giornata mi han mandato a chiamare. [...] E sono andato al comando della milizia. Quando sono stato là, ho parlato con un capo squadra... «Guarda tu sei ingaggiato... ti abbiamo mandato a chiamare per tenerti pronto, at’ mandòm via». «Un momento – dico – beh mi avete mandato a chiamare, ma il tale non l’avete chiamato»... Lui dice: «No, lo chiameremo dopo, ma lui per il momento non c’è». Dico: «Ma quanti siamo?». Risponde: «Siete in sette». Eravamo... partimmo in sette dalla zona che ci trovavamo poi... Eravate tutti di San Pellegrino, no? Non di Reggio e basta? No, no, di San Pellegrino c’ero solo io, no in due, uno è uno che è morto subito... un certo Lusuardi... Morì in Spagna? No, no, morì a casa... e io e lui, poi c’era uno di... di San Polo, uno di Cavriago mi sembra, o Ciano o Cavriago, insomma eravamo in cinque, poi so che facemmo il gruppo qui emiliano nostro e eravamo in sette, fra i quali ce n’era due ferraresi con noi, incorporati con noi, eravamo in sette, per part... quando siam partiti dalla legione di Bologna, che noi da Reggio andammo alla legione di Bologna, dalla legione di Bologna ci mandarono a Napoli alla caserma Bianchini, che era là il raduno [...] Montanari, allora, partì? […] Sì, siamo andati giù e quando siamo arrivati là, siccome là han fatto la designazione dei, dei reparti... come ho detto, siamo andati a finire tutti e due in artiglieria, solo che io sono andato in un gruppo e lui andò in un altro... oh... obici... da cento, sa cosa vuol dire obici? Sono cannoni corti, cioè il cannone, esempio il calibro 105, non so il cannone migliore che avevamo allora al tempo... [...] Senta, posso chiedere una cosa? Prima, lei prima ha parlato del problema dell’ingaggio, quanto era questo ingaggio? Dunque l’ingaggio era questo... ah noi partivamo... da, come partivamo da, da... Reggio, partiva la cosa... ogni mese mandavano a casa, direttamente a casa seicento lire... alla famiglia. [...] 60 Quindi loro le mandavano seicento lire... a casa? A casa direttamente, il governo mandava direttamente ecco... allora figurava il governo fascista, poi... praticamente più noi, arrivati giù in Spagna, da quando fummo inquadrati, almeno penso che fu... abbiamo preso questa data, a questo modo... noi percepivamo cinque pesetas al giorno... che erano poi la nostra mercede che davano... come si dice... il soldo... però da queste cinque pesetas veniva detratto il vitto, praticamente, tutti i mesi ci davano 60, 65 pesetas circa, perché... circa tre pesetas al giorno li tenevano giù per il mangiare… E questi soldi glieli davano in pesetas? Questi soldi ce li davano in pesetas, là, ci pagavano là... […]. Valevano circa due lire nostre... e così alòra dopo un po’ di tempo che eravamo lì, che avevamo fatto un po’ di addestramento... perché come le ho detto... Perché voi sbarcaste a Cadice? A Cadice. Su quale nave eravate imbarcati? Sulla «Lombardia» per caso? No? Dunque mi sembra che fosse il «Toscana», lì c’erano tutte... le navi che portavano tutte il nome di regioni, c’era il «Toscana», il «Lombardia», l’«Emilia»... non mi ricordo se c’era anche, no, il «Conte Rosso» l’ho preso ad andare in Libia... Comunque voi arrivaste a Cadice? A Cadice, in quale data diceva che era arrivato a Cadice? Circa l’11, l’11 di... sbarcammo, mi sembra, la notte fra l’11 e il 12 di gennaio... del ’37... E là sbarcaste di notte, quindi non c’era...? Perché non c’era mica il còs... l’oscuramento no e anche perché c’era, c’era il pericolo di un attacco da parte... Di apparecchi? Non di apparecchi, no apparecchi... una cosa minima quella lì... per quanto noi non lo sapessimo... però c’era il pericolo dei cecchini; perché, ad esempio, lì a Cadice io ho avuto occasione di vedere due o tre fucilazioni, cioè quelli che, che venivan presi da, da quella gente là... a noi ci davano un po’ di libera uscita, bisognava andar fuori in gruppo, perlomeno in quattro o in cinque e armati, col moschetto... perché potevamo essere attaccati o altro, l’era ‘na rivoluziòn, in pochi paròli, non era una guerra vera e propria... là c’è il nemico, qui ci siamo noi, non si sapeva mica da dove venivano le fucilate... […]. Lei ha fatto Guadalajara? Dopo... la prima è stata Malaga, la prima, la prima spedizione... però ecco le dico una cosa. Credo, credo che sia stato circa dopo venti, un venti giorni, venticinque che eravamo lì a Cades e partimmo, un gruppo, eravamo due gruppi, partì solamente il nostro e lui non partì quel mio amico lì, non venne con noi... Facciamo la colonna, 61 ci avviamo, andammo all’interno, attraversammo l’Andalusia e poi ci portammo su dietro la Sierra che c’è di dietro a Malaga e c’è... come si chiama, credo ci sia la Sierra Leone, mi sembra ci sia, adesso non ricordo preciso, adesso ricordo che a un dato momento ci fermammo... mettemmo in postazione i cannoni e lì cominciò il mio calvario... calvario nel senso di fare il mio servizio... dovevo fare i collegamenti. Il comando artiglieria... […] m’han dato l’ordine da portare qui al comando di batteria... han fatto un po’ di fuoco, poi ci spostammo, poi andammo su. È sucés un fàt, am ricòrd, no è stato dopo, alòra siamo partiti... ci siamo appostati con la fanteria, un po’ la pasèva lé, às déven al cambi tanti vòlt, perché succedeva che noialtri eravamo in artiglieria, però a sucediva che nuéter éren in artiglieria, però a féven da préma linea tanti vòlt. Siccome la guerra di Spagna non era mica stata fatta... per esempio questo è uno sbarramento «X» e quello là lo sbarramento «K», no a s’andéva avanti a colòni, a colòni veniva fatta la guerra di Spagna, perché un po’ la vastità e un po’ perché gli eserciti erano, erano organizzati a una qualche maniera, capisce, erano bande. Loro gli spagnoli avevano le banderas, quello che noi chiamiamo battaglione loro lo chiamavano banderas, e dentro in quelle banderas lì ce n’erano poi anche dei nostri che erano andati già prima... poi loro portavano a differenza... Noi per esempio, quando siamo andati giù, avevamo l’elmetto e poi avevamo la bustina classica da, da... soldato... alòra la bustina via e ci han dati il basco. Il basco nero, il basco spagnolo insomma? Sì e così facevamo parte... a loro... poi... Loro avevano anche i marocchini, avevano? Ma i marocchini normalmente loro avevano il fez, più che tutt’altro, ne ho visti pochi dei marocchini col basco. Però ce n’erano dei soldati marocchini? Eh, altroché... era... Ed eran bravi a combattere? Come si dice, i marocchini erano il nerbo dell’esercito di Franco, perché Franco quando è partito dal Marocco è partito, è venuto in Spagna coi marocchini, erano fedelissimi a Franco... E alòra a sucéd quesché, che combattendo, va e va... siamo arrivati in Malaga, non ci fermammo, noi proseguimmo. Cioè lo schieramento nostro continuò lungo la strada e siamo arrivati a un paese che si chiamava Motril, Motril questo qua me lo ricordo bene, me lo ricordo bene perché ci sono stati, c’è stato de, de... degli episodi da non dimenticare. E difatti è successo che... all’entrata di Motril c’era un viottolino, sarebbe come dire una stradetta, mica larga molto... e, e a destra dell’entrata del paese... come a dire qui c’è il paese... qui a destra c’era un campo di canna da zucchero e dentro vi erano loro, mentre che e paséven nuéter, lòr a sé sparéven... e gh’era gnù un fuggi fuggi... perché, come ho detto, non si capiva da dove venivano i colpi... às saieva mia d’an’du gnìven i colp... ogni tànt se vdìva un quelcdùn a caschér... partiva... va bein. Siamo andati dentro al paese, poi abbiamo circondato al còs... in basso, perché 62 di là c’eran loro... messo lo schieramento di difesa e allora loro si sono ritirati, però ogni tànt partiva séimper al còs... perché nuéter as’ s’éren fermè la nostra fanteria non aveva mica fatto... come si dice... la pulizia di questa cosa... di questo campo. Oltre questo campo qui c’era... una piccola... un piccolo borgo che... ma... dicevano tramite chiacchere i paesani lì, che quel borgo là c’era un magazzino di viveri e cose del genere. Alóra sucéd un fàt che la sìra am ricòrd: io ero sopra uno di quei camioncini lì, facevo parte della colonna «OC», pattuglia «OC» (Osservazione e collegamento), cioè io facevo il telefonista, il centralinista, avevo imparato a fare anche il radiotelegrafista... [...] Beh l’é tòt un tira-mola, insomma succede che alla sera, mi ricordo, e venuto l’aiutante maggiore del battaglione, della batteria. È venuto da me che ero sul camioncino. Mi dice: «Veh Cigarini, vieni con me stanotte?», «Dove, dove andiamo?». Era un tenente, l’ho sempre in mente, ma quando penso il nome... Non era Maltese, no, un altro? No, no, era, era uno di Carrara, uno che credo che abbia fondato lui il Fascio a Carrara... come si chiama, beh non ha mica importanza il suo nome... ma... un brav’uomo, un uomo anziano piuttosto... tànt nuéter éren zòven... mi dice: «Andiamo domani, han detto che c’è un magazzino, se possiamo arraffare qualche cosa...». Infatti, la sera dopo, io con il resto della pattuglia, che eravamo in sette, sette o otto, più un altro sottufficiale siamo andati attorno al campo e siamo arrivati dentro al Colàr... era un po’ abbandonato, ogni tanto incontravamo qualcheduno... buena noches, buena noches... e l’òm fata do volt c’la tiritera lé, siamo riusciti ad arrivare là, siamo andati dentro un magazzino, abbiamo trovato delle sigarette mi ricordo sempre dello zucchero, del caffé, sì roba di conforto, l’abbiamo chiamata conforto del soldato... e siamo riusciti a portarla al campo allora abbiamo fatto la cuccagna, mi è piaciuta perché il giorno dopo, dopo quando eravamo là... nel tornare indietro so che mi seriviva al cos... perché io mi intendevo un po’ di cucina, i’iva imparé da na mé zìa a Santa Croz, cla féva al budghér, avevo imparato a far da mangiare, m’arrangiavo bene, solo che non mi andava... lui mi chiamava sempre dicendomi: «Mo perché non vai mica alla mensa?» «Perché mé a sun gnù ché per fér al suldé, mia per fér al servitor...». Al vriva mìa ca g’al dgìsa... bein an’importa mìa... e c’sé, e poi a sucéd... Questo a Malaga? Questo è a Malaga, succede che... un giorno […] st’uficiél […] Al vìn da me, al dìs: «Veh, tu bisogna che mi fai un piacere...». Già lui l’ìva fàt di piasér anch’a me, serché ed lavéres al màn un cun cl’éter... «S’è ammalato – al dìs – il capo, il capo-cuoco della mensa ufficiali, tu bisogna che lo venga a sostituire, perlomeno per domani – al dìs – perché viene, viene lo Stato maggiore, non c’abbiamo il cuoco... e gh’era il generale Mancini...». C’era il generale Mancini? Mancini [generale di brigata Mario Roatta, alias comandante Colli, alias generale Mancini, N.d.R.], allora c’era Mancini allora e dopo cambiò, poi... venne Bergonzoni [si tratta in realtà del generale Annibale Bergonzoli, N.d.R.] anche, venne... [...] Allora io 63 avevo preparato un capretto, da fare per questa gente... gli avevo fatto la còs, le còs... e gh’o fàt i quadertéin... i quadrettini con il coso di carne, perché loro la carne da fare in brodo, come l’adoperiamo noi, non l’adoperano mica loro. E alòra ho trovato un po’ di carne in macelleria, ho fatto il brodo, i pulàster i catéven, i rafféven. [...] Purté a magnér tòt sti magna-magna che e sbaféven [...] Quand l’è sté dòp d’avér magné la mnestra e duvi vén... al còs, mé i’ìva purté a cosér sté cavrét... ma méinter a sùn le al forén ariva i aparéc... in séma, davanti, davanti àn dò sbucheva sta streda et fiànc al forèn e gh’era tre o quatér autoblindi dal nostri... gh’era du aparéc ag’n’era mìa tànt, perché a me al masìm c’abia vìst in Spagna insém e n’ho vìst tri... Di quelli nemici? Tri, nemìg, […]. E dopo Malaga? Donca, dopo Malaga... abbiamo preso la strada del ritorno, abbiamo formato l’autocolonna, siamo venuti giù... abbiamo riattraversato un po’ della, della bassa Andalusia e siamo arrivati a Siviglia, ma da Siviglia siamo andati vicino a Siviglia e poi a sòm sté férom un quelch giòren lé... un assetaméint e poi abbiamo... e sòm andé vérs Granada, da càl perti lé, dove ci hanno messi in colonna, su un treno, una tradotta militare, sul treno e siamo andati sù, siamo passati... girato attorno a Madrid e siamo andati sul fronte di Guadalajara. A Guadalajara là abbiamo trovato la fanteria e nel frattempo, nel frattempo venne anche l’altro gruppo, perché cusché... bah; perché non ha mica importanza, ma lo dico perché dopo un po’ lì, dopo Guadalajara, cul mé amìg lé l’ha pérs la gamba... […]. Montanari? Lui, s’era addestrato bene a fare il puntatore, […] l’era un ragàz a pòst, l’era. Insomma, in pochi paròli, me a féva seimper i colegaméint [...] ‘Na volta a m’han dé ‘na bicicléta ed quìli da bersagliér, ed quìli che useva ‘na volta che al s’dupiévén... bicicletta... lung a la stréda, su la strada di Francia, era chiamata la strada di Francia perché era la strada che da Madrid va in Francia ed era quella che passava da Guadalajara... […] Méinter che steva lé... ta-tacpum, tac-pum,tac-pum, tac cusché, quel là... tòt e sparéven […], viene, viene fatto l’attacco […] cumincia a sparér subìt, alé pom, pom, pom, pom..., insomma un disastro... che erano andate nelle batterie alzo tre... lé i’òm fàta la bataglia... quand a sòm andé avanti, quaranta chilòmeter circa... i’hom fàt n’avanséda... Una avanzata di quaranta chilometri? Circa quaranta chilometri siamo andati avanti, a un dato punto... è saltato fuori i... reparti nuovi che venivano in aiuto da Madrid, c’erano dei carri armati grossi e nuéter gh’ìven i càr armé d’assélt, i càr, i cariuléin cichin... a gh’ivén gnint da fér, perché quand riveva ‘na canunéda al vuléva via... Cos’erano? Carri armati russi? Carri armati russi. Gròs, canunséin, do mitragli... am ricòrd mìa s’erén 35 o 37... e 64 féven del stragi... […] e in dal frateimp, meinter a sòm andé in sosta i’ho savù che cùl mé amìg lé l’era armés frì... era rimasto ferito... […]. Gh’è scupié una granata propria davanti al scùd dal canoun propria in téra... e l’era armés frì ... in do posiziòn, in pochi paroli... [...] ho vrù cuntér l’afàri de sté Montanari... e andammo a Tudela del Duero, in còs... Com’è che si chiamava questo posto? Tudela del Duero. Era un paese sul Duero che il Duero l’era un fiùm, era il fiùm più gròs... più lungo della Spagna... eravamo in sosta, in retrovia insomma in pochi paròli e lì non c’era il gruppo di questo mio amico, ma l’è capité lé dòp suquànt gioren che nuéter i’eren feirom lé in atéisa; alòra a vàg subìt là a vàg... a dmandér... [...] Al fà: «A Malaga... a còs a Guadalajara, e l’han ciapé e l’han mandé a l’ospedél da camp, da l’ospedél da camp e l’han mandé a l’ospedél civil, dal civil e l’han mandé a Irùn, in séma ai Pirenei»... un paés c’lé ai confini fra la Francia e la Spagna, dalla parte e dl’oceàn atlantic, Irùn. L’han mandato all’ospedale là e sembrava che fosse guarito, ma quànd l’è lé al g’ha fàt infesiòn... al dìs lé al còs... a la sira a vàg là al sò grùp, anzi no. A la sìra an g’sùn mia andé, ho savù cl’éra là e a vriva andérel a catér, a m’han dìt c’l’era a Valladolid... […]. A sùn rivé là, quand sùn rivé là và a l’ospedél, quand sùn a l’ospedél i gh’ìven bé le tajé la gamba. I g’l’ìven tajeda, la gh’iva fàt infesiòn, a g’àn tajé la gamba ché sòta al snòc apeina. E gh’era ‘n’inferméra... ed Réz. C’era un’infermiera di Reggio? Come mai c’era una infermiera di Reggio? Mah. A s’véd c’l’é andéda con la Croce rossa internazionale, può darsi, e péins. [...] La m’ ha sintù a parlér e la dìs: «Sei di Reggio tu?». A dìg sì. La dìs: «E dig bein e cume la metòmia ché... – la dìs – eh è andato tutto bene, ma ha solo bisogno di mangiare, bisogna che mangi...». «Ma non vede come mangia? Come fa a mangiare – a dìg – àl gh’a bisògn ed trafusion ed sangòv». La dìs: «No, no, non ne ha bisogno». Alòra ac’sé in manéra che al g’l’ha cavéda a spuntérla, l’è pò gnù a ca a la meté dal ’38 circa o ai prìm, prìm méis dal ’39. Chi, Montanari? E, l’è gnù a cà, l’han mandato a... è stata la sua fortuna... cuntra a la disgrassia... nel senso che lui è venuto a casa, s’era acquisito dei diritti, perché alòra... la facenda al sà... è come qui chi g’ha dirit adésa perché ihan vìnt la guéra, me l’ho persa lòr l’han vinta... alòra s’in pérla, s’in pérla più. In pochi paròli ag’l’ha cavéda tramite l’aiùt e... de, dei reduci legionari d’la Spagna, tanti béli còsì, l’è andé impieghé in banca, a la Càsa ed rispérom, a la Càsa ed rispérom, al gh’è sté fìn a quatér o sinc àn fà, c’l’è andé in pensiòun. E allora tornato a casa, il partito gli ha trovato il posto? Sì. A l’han iuté i reduci... Lui ha preso, come si chiama, una onorificienza in Spagna? No, no... no, perché... 65 Una croce di guerra? Sì, una croce di guerra, ma è la croce di guerra spagnola che non vale mica. Che cos’è la Cruz roja? La cruz roja… e g’l’ho mé... Lei ce l’ha? Sì. La vuol vedere? Sì, volentieri. Alòra è sucés che, che dòp a s’l’han deda anc’a nuéter, mé e g’n’ho trei dal cròs ed guéra, mo cola d’la Spagna l’an gh’eintra per gnìnt... Senta, facendo il punto, allora torniamo a questa cosa, quindi Guadalajara, questo incidente di guerra a Montanari, dopo voi cosa avete fatto? Da Guadalajara, dunque siamo partiti e siamo andati a fare l’azione di Barcellona, cioè la campagna della Catalogna... [...] Ma gli italiani che erano in Spagna, che erano con lei, erano dei bravi soldati o no, come efficienza bellica? Beh come efficienza bellica a féven al sò duvéir... E gli spagnoli erano bravi? Beh erano, erano, cuma s’dìs, dei faciloni, gente abituata con la faccenda della corrida, della tradizione, perché andér a affruntér al tòr in d’la corrida ag’vòl dal curàg... e sono gente anche coraggiosi, però éren ànc un po’ imbambì da cul lato lé. Tanti vòlti quand andevén per fér l’asélt andavano avanti in pé, in piedi, imbambì e cadéven come al moschi, ma... andér avanti... i’erén mìa boun, n’erén mìa bòun de, de schivér un po’... capisci, propria da nustràn, in pochi paròli. Lì a Guadalajara avete incontrato, dall’altra parte, quelli delle Brigate Garibaldi? C’erano gli italiani dall’altra parte o no? No, i’ italiàn nuéter an i’òm mai caté, propria diretaméint. Quànd e riveven sul pòst nuéter, i’eroi, i’eroi ch’in dvinté adésa, tòt i’eroi d’la famòsa bataglia, tòta gìnt ch’ in seimpér scapé... a cumincér dai vari Saragat e tanta et c’l gìnta lé. Ah sì! Quindi quando c’erano le camicie nere quelli delle Brigate Garibaldi tornavano indietro? Sàl se gh’era? e gh’era da, da la pért de d’là a gh’era, a gh’era un esércit cosmopolita, a gh’era, a gh’era la fécia ed tòt al mònd, e gh’era fìn di giapunéis ànca... ag’n’era et tòt al qualité, ma l’era la fécia ed tùt al mònd. At dìg ànc perché. Nuetér i’òm caté ‘na màsa ed dòn incinti... perché, perché la famosa «Pasionaria», la famosa, la s’ciaméva a créd c’la s’ciamìs Dolores Ibarruri, praticava il libero amore, la ghe d’giva: «Quei soldati là fanno il vostro, fanno il còs per salvér la Spagna, ma badate quando arrivano, voi dovete soddisfare». Tàant... l’oblighéva st’al dòni, stì ragàz, st’al dòni 66 che puvréti... i’in armasi lé cun di ragàz. Me a gh’o avù ‘na relaziòun lé prìma ed gnìr a cà apéina a Alicante quand è finì la guéra, cun una che aveva un bambino, che ha avuto... una cosa del genere... ho dovuto darmi per forza... Ma perché, le, come si dice, le violentavano? Beh i feven... ig’duvìven stér per fòrsa. Perché ec’cateven fòra la facénda dal còs, del diritto, perché erano soldati e avevano diritto di divertirsi quando venivano dal fronte... e fèven dal vandalismo... Fatto del vandalismo? Vandalìsom e féven un po’ de tòt... È vero che bruciavano le chiese? Guardi: erano della brutta gente a cumincér da i’ italiàn. Oh, premetto una faccenda, che cert... certùn in méz al mùc... infàti un quelcdùn l’ha fàt... anc da nuéter, perché me i’ho vìst, per ipotesi, in un paés gh’è sté, a gh’eren rivé deintér i’italiàn e come i’in rivé déinter... an saiéven mìa sa fér, andéven a arafér... a gh’è sté un c’l’ha, du o tri, che i’ in andé deintér in un apartaméint, a gh’era un òm anzian a lét malé e alòra as’ véd i’han mìa caté gnìnt da fér bél, da gratér a g’han purté via i linzòl in dal lét. Capisce sa vòi dìr... di episòdi a n’è capité anc a nuéter... E quindi diceva... un’altra cosa, quindi la gente, il popolo spagnolo... simpatizzava più con voi o più con l’altra parte? A dir la verité cun ch’iéter a n’han mai simpatizé dimòndi. Non hanno mai simpatizzato? Se cun nuéter prima et tùt ag féven véder di fàt e la liberté c’ag déven, quand per esempi ag liberéven al sò paés, dal mumeìnt che priven fér i sò coméd... diferéint da qui là che... gh’impunìven ed fér cus’ché o cul ‘là... Insòma, in pochi paròli noi davamo la libertà e la possibilità di vivere, invece ded’là e gh’impunìven ed fér... come ho detto al ragiunaméint ed prìma, c’a s’ catéva un mùc ed dòni incinti... caté di, di prét muré... Lei li ha visti? Sì, sì. Ha visto dei preti murati? Ma sì... a m’è tuché d’andéri a li berér... ‘Na volta a g’l’ho dìt cun al prét che ed San Pelgreìn... Parland dal più e dal meno a dìg: «Na volta a sùn andé deintér in d’na cantéina a sintìva a picér, déinter a un mùr ed dré dal mùr a gh’ era al prét, e’ c’ purtéven da magnér a la nòt... atravérs a un bùs... E non l’avete liberato, no? Sì. Ah, quand a riveven nuetér a liberevén tùt. 67 Ma chi è che gli portava da mangiare? I sò pesàn. Al saieven mìa ch’iéter de’d’là... se no ag feven la péla... eh e n’han masé... E di chiese incendiate ne ha viste? Di chiese incendiate dai repubblicani ne ha viste? No. Non ne ho mica viste. Non avevan mica interesse, perché s’accattivavano le, le simpatie del popolo a quella maniera lì... In gh’iven mìa gnìnt da cuslér... ma come ho detto io, noi, e me am sùn caté tanti vòlt in prima linea con i canòun e me, per esempi, proprio durante la campagna per andare a Barcellona, mi ricordo... che una postazione presa durante la notte, al mattino credevamo d’aver davanti la fanteria, invece non c’era, era dietro e davanti avevamo loro... come a... come i’ in gnù a avisér, han cumincé a sparér con i... col mitragli cuntra i canòun e alòra an’gh’era mìa asé distansa, perché a gh’era la distansa ed séint metér, séintsinquanta metér... che nuetér un po’ a i’òm lasé scarghér e po dòp i’òm cumincé a sparér a zéro coi ca... coi còs... con i canòun. In dal fratéimp, am ricord che a gh’éven un generale, che credo che sia commemorato lì in una via lì a Strada Alta, Cascino, generale Cascino. Alòra... ancora comandava un battaglione di... di... di còs, camicie nere... un po’ smerciédi d’italian, insòma... che dopo eravamo mischiati, se quand l’era, quando la ghe strichéva un po’, che a gh’era ‘na posiziòun un po’ dura... normalméint ag’ mandéven al camìs nigri, perché non che fùsen difereint da ch’iéter, no, ma gh’era la facénda che erano, lo spirito, specialmente per quello che riguardava il partito e tanti béli còsi. Eren ataché un po’ al partì e alòra per fér béla figura e gh’andeven... invici i suldé, qui ch’è sté ublighé a andér là, perché ag’nè sté un quelcdoun c’l’è sté un pò, l’è sté ciapé un po’ a tradiméint l’è mia c’al sia sté ublighé a anderégh, però i’ in sté ciapé a tradiméint, perché me a sò, per esempi, c’à gh’è sté di suldé in Italia, ch’in sté imbarché per andér zò in Africa orientél e po dòp invici i’han dirotté... i’ han dirotté là... Lé i g’han fàt capir c’l’era, a gh’era da stér mìa mél e tanti béli còsi e alòra t’sé i s’in lasé lusinghér, t’sé speciallméint i cuntadéin e via... la ginta ed basa plebe, chi gh’i ven... da l’istrusiòun ag’n’iven mìa dimondi, mo sé... ànc sa c’fùsa sté un quelcdùn c’al prìsa... c’al li savìsa... ac’ tuchéva taséir perché ‘angh’iva mìa nisùna voz in capìtol... Ma l’era un po’ un casòt via... e così l’è andéda a finir che dopo siamo andati a Barcellona, oltre Barcellona, siamo proseguiti e ci siamo portati fino vicino ai Pirenei... a... péins c’la s’ciaméva Figueroa [si trattava evidentemente di Figueras, N.d.R], Figueroa, sì vicino ai Pirenei. Poi dopo è finita, lì anche l’han preso possesso le truppe di Franco e... e i reparti italiani... sòm turné indré i’hom fàt tùt al gìr, i’hom turné a girér atorna a Madrid e sòm andé a Toledo, dove si è fatta poi l’ultima... insòma vicino al còs, come si chiama quel palazzo... l’accademia militare... L’Alcazar, che avete liberato? L’Alcazar, beh a dir la verità sì a l’hom liberé però... le... quand ac’sòm rivé nuéter praticaméint l’era béle quasi liberé, perché a gh’era rivé prima... [Alcazar di Toledo: i giovani cadetti dell’accademia Militare, agli ordini del colonnello José Moscardó Ituarte, rimasero assediati per diverse settimane. L’assedio e la eccezionale resistenza dei militari vennero ampiamente sfruttati dalla propaganda fascista e l’Alcazar nella Spagna di Franco sarebbe diventata monumento nazionale, meta di un pellegrinaggio nostalgico, N.d.R.] 68 Franco? No. Emilio Mola Vidal? Anca lòr, a gh’era Mola, a gh’era Franco a gh’era tùt lilòr... ma più che tùt eter a gh’era al trùpi d’la fanteria davanti a nuéter. T’sé nuéter a sòm andé ed ripos e po dopo... E pò dopo di lì cominciò la famosa facenda d’la bataglia ed Madrid, ma prìma a gh’era d’andér... al mér, da Toledo i om ciapé la stréda d’la Mancia, abbiamo attraversato la Mancia, che sòm pasé in un paéis, sulla strada della Mancia, non mi ricordo se si chiama proprio la Mancia, am ricòrd mìa, ad ogni modo mi ricordo che in questo paese, un paés c’l’era costegé dalle case no, la strada principale, e sulle case c’era pitturata la storia del Cervantes... Don Chisciotte. E gh’era tùt, tùti al pitùri. […] Il paese dov’è nato il Cervantes? No, la Mancia è la regione, ma la città è quella che... non so se sia nato lì, non me lo ricordo […] Quindi, arrivaste lì? E sòm rivé lé, e sòm rivé fino ad Alicante, poi da Alicante siamo andati fino vicino al porto, ma non siamo andati al porto, perché e gh’eren lòr… e s’vrìvren mìa arénder, non volevano arrendersi. Alòra in’han mìa reagì; il comando italiano diede ordine di tenerli bloccati, ma di non sparare. Nuéter as’sòm giré d’atorna a Alicante e sòm andé in un paesino c’al s’ciaméva Muciamiel ed era distante... c’era anche il tram che partiva da Alicante per andare a stò Muciamiel. A Muciamiel i’òm lìs... i’òm pianté al nostér cmand, mìs sù al centraléin telefonic, fra i quali normalméint a féva servìsì mé, anche per un motìv che mé era un po’ al factotum […]. A ghe sté ‘na volta è capité, durànt campagna della Catalogna, sì a Barcellona; una notte e féven servisi al centraléin, come solit e ciàm, perché ogni tànt bisogna ciamér per savéir se, se funzionava il collegamento, tànt da ‘na pért come da c’l’etra. [...]. A gh’era am ricòrd me a gh’era un certo Comitti ed Como, comasco, càl zoni lé, l’era un cuntrabandér, al gh’iva ‘na fifa, a ghe d’giva pò: «Cuma févet a fér al cuntrabandér cun c’la...». Insòma al dìs: «Mé quand a vàg fòra ca seint a sparér... un lavòr...». Quello era un volontario no? Sì. Sì, l’era ‘na camìsa nìgra, l’era gnù via anca lò con la, con la... perchè ag’n’è sté dimondi ch’in gnù, dìt fra nuéter, con l’idea d’andér a arafér...[…]. Volevo sapere una cosa. Lei quando è andato in Spagna sapeva cosa stava succedendo là? Lei era convinto di essere dalla parte giusta fra le due parti? Ma diciamo la verità, ho detto prima... ma la politica a la lés da ‘na pért e gnàn an in vòi mìa sintìr parlér ed politica. L’ho detto prima, me ac’sùn andé... Certo: per i soldi? …E basta. Perché potevo aiutare la mia famiglia e nient’altro. […] 69 Senta, volevo chiedere una cosa, quando lei, lei è tornato in Italia dopo i festeggiamenti? Quando è finito, dòp ch’è sté un còs un po’. Dònca e sòm sbarché, e sòm sbarché a Napoli, in sìma al «Toscana» am sembra, e al «Toscana» e s’han purté a Salerno, però a gh’ era d’i’ eter repért che eren lé, tra Salerno e Napoli, i’éren ed la fanteria e nuéter éren a Salerno, e gh’o la fotografia ed Salerno, ma ac’ sòm in trì, nuéter trì e basta, an’g’a mìa nisùn valòr. Dòp d’un po’ a gh’era da fér la sfiléda a Roma... Davanti al duce? Davanti al Duce, al Zìo. [...] Senta e a Roma, lei è andato, no? No. È tornato a Reggio subito? Ah, sùn gnù a Rez subito. Dòp è sucés, è sucés che quand i’in rivé a Réz i reduci ed Réz i’han fàt la sfiléda per via Emilia e alòra i’han... C’era anche lei? No. Ac’sùn mìa andé... Cioè ac’sùn andé e àm sùn mìs da ‘na pértà, insìma a la via e quànd i’in pasé a g’ho dìt: «ciao veh... salàm», el tulìva pò in gìr perché ac’tuchéva sfilér... n’etra volta. E quando è tornato a Reggio no, lì dal partito come è stato accolto? Più o meno, coi festeggiaméint fàt a c’la manéra lé. Ah un episodi c’ag voi dìr. Dòunca me a serchéva d’andér a lavurér... a n’iva bisògn, dòunca era béle un méis e méz e più ch’era a cà e gnàn ché ed lavurér an m’in catéva mìa nisùn. ‘Na béla giurnéda e partìs e vàg sù dal segretari, dal federél... e alòra a gh’era al vice; fàghia al nòm? L’era Menada. Menada? Sì, figlio del vecchio sindaco di Reggio. Menada fighìn. [...] Allora, Menada, cosa le aveva detto poi? Menada, alòra, l’ha tiré i remi in barca, al dìs: «Adesso, adesso vedremo»; «Serché ed movrév, perché mé am ciàp sù e pò a vàg a Ròma, fé uetér mé an vòi saltér davanti a nisùn, però se uetér an tulì mìa di provediméint, che mé e sùn ché, a g’ho ‘na famìia da mantgnìr e créd ed veir còs... mé an vòi mìa vantér di dirìt, perché a g’han tùt dirìt ed lavurér, mé a sùn fàt a c’la manéra lé, en vòi mìa di privilég perché a sùn sté in Spagna. In Spagna ag’sùn andé per ciapér da vìver e ché a vòi fér etertànt, a vòi lavurér per vìver». Premét una facénda, che prìma d’andér in Spagna cun Montanari lé, siccome l’era un po’ ed téimp ch’i’éren a cà tùt dù, i’hom fàt tùt al pusìbil per andér in Africa a lavurér, là in Etiopia, an g’l’hom mìa cavéda a andér vìa, i’hom fàt tùti al dmandi possibili per andér via, ag’l’hom mìa cavéda a andér via, gnàn in méz, gnàn in méz a i cuntadéin, perché, al perché nuetér an feven mìa pért et cul sindachét lé, mo bein, mo c ‘lavòr... 70 Che sindacato era? Il sindacato di commerciànt, al noster, col lé l’era al sindachét e di agricoltòr, c’la gìnta lé, i cuntadéin... Quindi lei era ancora disoccupato? Eh, ero ancora disoccupato. Che cosa ha fatto dopo? Niente... […] Sùn andé a l’olificio... e as’sòm a la fìn dal ’39, è scupié al bugnòn, è scupié. […] E premét una facénda, che mé quand a féva al budghér, i’ho fàt al còrs da agente daziario, i’ho dé l’esàm in Prefetùra, a g’ho ancòra la patéinta e a sùn pasé agìnt daziari, oh a sò che a gh’era da catér al lavòr anca lé. A sùn andé fìn a Fiuràn ed Mòdna, ‘na vòlta in bicicléta, quànd i’ho sintù dìr che serchéven ùn. Quand a sùn sté là a m’han dìt: «No, per al muméint an n’hom mìa bisògn, però lasés ché l’indirìs, che se vìn bisògn». Gnìnt. Alòra i’ ho ciapé servìzi a l’olificio... e gh’è sté una... dòunca cuma éla gnùda la facenda... ah a lavuréva a l’olificio, doùnca, a còs, a vàg a cà, dòp avér finì e d lavurér la giurnéàa, e vàg a cà e am’mànda un a ciamér a cà d’andér al còs, al dazi, al dìs: «A sùn dal dazi, che al Diretòr l’i va bisògn». A vàg là, am preséint. «Dunque lei – al dìs – è disposto a prendere servizio». «L’è còl c’serchéva mé». A dìg: «Si, però, ma...» al dìs: «No tu per venire qua bisogna che ti fai dare il libretto di lavoro, eh, altrimenti non posso mica assumerti». Mé al giorén dòp am preséint subit a l’ufizi ed ragioneria e tanti béli cosi, e ghé spiég la facenda... al dis: «lè un brùt lavòr – al dis – sét, per un motiv sòl l’oleificio l’è un stabiliméint ausiliàri, te’ et pò mia licensiér, nuetér at pròm mia licensiér, a meno che et végn licensié cun al fòi ròsa, in pochi paròli, come lavativ. Sét perché an gh’è gnint da fér? Perché se a vin ché al capitàni ed l’aviaziòun» perché l’era: Oleificio nuova società aeronautica italiana... Cosa facevate all’oleificio? L’olio e l’alcol. Se avin ché al capitàni c’al cmanda al repért, al còs, che et gh’è mia, che an gh’è mia al tò librét, a gh’è da pasér di guai. Insòma, in pochi paròli, a l’hom mnéda, a l’hom mnéda tànt a digh: «L’è tùta la mé véta che a séirch ed metròm a pòst e an’ né g’ la chév mia». […] Al dis: «adés a prepér al librét e pò a t’al dàg». Tu al librét e pò vin fòra e po a vàg a, al còs, al dazi, quànd sùn rivé sù al dàzi vàg dal diretòur a digh: «Sgnòr dutòur ché a gh’è al librét ed lavòur». «Bravo – al dìs – allora aspetta qua un momento». L’ha ciamé al càp dal guérdii c’ l’era, c’ l’era Curti al barbòun, al capo delle guardie del dazio, al l’ha ciamé, l’è gnù subit: «Dòunca, al dis, vé, Cigarini, l’era sabét, Cigarini lunedé matéina al ciàpa servizi».[…] «Bravo, bravo Sigaréin a sùn propria cuntéint, andòm vin mo még» e as sòm purté a la barriera ed San Peder, là an du gh’è la péisa, […] Olà a sùn cuntéint cume una pasqua, finalméint che propria tiré al fié a la loùnga, finalméint am chév ‘na sodisfasiòun; a vàg a cà e ca càt la povra mé medra cun la cartuléina in man, d’andér via. Am duvìva presentér al martedi matéina, al lunedé i’ho tgnù andér, ho tgnù fér a l’indré tùt quél gh’iva fàt al dò giurnédi prcedeinti, per avéir la cosa per andér là. E dove l’han mandato? In Libia. [...] 71 Ernesto Bini Nato il 6 luglio 1917 a Gatta (Villa Minozzo). Durante il servizio militare viene mobilitato per la Spagna, ed il 27 novembre 1938 parte con destinazione Cadice. Rientra in patria il 12/13 maggio 1939. Soldato di leva appartenente al Battaglione «Verona», ritorna in caserma al Brennero, non congedato a causa dell’inizio del conflitto con la Francia. Partecipa poi alla campagna d’Albania e di Grecia. L’8 settembre tenta di raggiungere la propria famiglia ma viene bloccato dai tedeschi, riesce a sfuggire tentando di espatriare in Svizzera. Viene catturato e consegnato ai tedeschi; rinchiuso in un campo di concentramento, fa il cuoco. Ritorna in patria nel 1945. Testimonianza raccolta il 20 ottobre 1987. Perché è andato in Spagna? Noialtri il battaglione... la 2a «Tridentina» si chiamava, il battaglione «Verona» è stato messo... è stato mobilitato per la Spagna, tutta la «Tridentina», c’era il battaglione... io ero nel battaglione «Verona», però ci sono in una divisione, ci sono; adesso non ricordo... dieci o dodici battaglioni che formano una divisione e allora noialtri siamo stati mobilitati per la Spagna, ma però come volontari. Lei stava quindi facendo il soldato? Io facevo il soldato su al Brennero e avevo 21 anni... ero nel ’38... avevo 21 anni perché ero andato sotto in maggio del ’38... è stato mobilitato del general Franco un aiuto per la Spagna... e allora... noialtri ci ha fatto partire tutti... ha fatto partire tutta la divisione per... in aiuto e però tutti in borghese. E ne aveva richiamati tanti di soldati che... tanti volontari che volevano andare in Spagna, e ce n’erano un mucchio, tutta gente di trenta o trentacinque anni, fino di quaranta anni ce n’era, che sono venuti in Spagna, che li abbiamo trovati noialtri a La Spezia che montavano su nella nave con noi tutti questi volontari, però volontari anche noi eravamo. Vestiti da borghese col cravattino tutti belli... e siamo arrivati sullo stretto di Gibilterra e ci siamo fermati per un giorno e una notte fermi, perché non ci lasciavano passare e dopo a forza non so di reclami di una cosa o dell’altra, ci hanno lasciato passare. E siamo passati noi con la nave, di dietro a noi c’era la nave dei muli, perché noialtri eravamo degli alpini e c’erano tutti i muli. Allora noialtri siamo passati a distanza... non so ogni tanto si vedeva la nave che avevamo noialtri di dietro che veniva... han fermato anche quella dei muli e quella dei muli l’hanno fatta saltare per aria e così noialtri dopo siamo... siamo arrivati la sera dopo o due sere, ci abbiamo messo quattro giorni per arrivare in Spagna. Siamo partiti il 27 di novembre del ’38 dal Brennero e così siamo arrivati... lo chiamavano il porto di Santa Maria, che aspettavano che arrivasse i muli per andare sui Pirenei e così gli è arrivato un avviso che la nave dei muli era sprofondata e così tanto per fare ritornare i muli dall’Italia, noialtri siamo stati fermi 22 giorni lì. E allora in questi 22 giorni, che abbiamo aspettato che venisse i muli, è venuto come 72 una liberazione che finiva la guerra e così noialtri siamo stati questi 22 giorni tanto che arriva i muli, ecco sono arrivati i muli e poi dopo abbiamo fatto delle grandi passeggiate lì, mangiare si mangiava poco, del pane, una razione di pane tanto come quella che ci davano quando ero prigioniero in Germania; del resto si mangiava quel pochino di rancio che ci davano: ceci... C’era la gente borghese che era lì della Spagna, signorine, ragazzi così, che venivano nella paglia a raccogliere su tutte le briciole del pane perché c’era fame. Io poi avevo trovato un ragazzo... un bambino che aveva sei o sette anni che mi aveva imparato a conoscere e mi chiamava e così lì andare via insieme... un giorno mi dice dove abitavo e così c’ho detto che ero un italiano... lui mi voleva bene questo bimbo e mi portava sempre delle banane e io ci davo due soldi, dieci pesetas, e allora... lui tutte le mattine quando ha visto che ci davo questi soldi, tutte le mattine era lì e mi portava le banane, queste banane. Noialtri, era il brutto che si andava fuori sulla montagna, che c’era questi del Marocco, questi marocchini che quelli che trovavono fuori, li facevano fuori e altro che una raccomandazione di andare via in gruppo molto grossi e col fucile e essere sempre pronti perché se trovavano una squadra di quelli lì del Marocco di farli fuori, io avevo questo ordine. Ma non erano vostri alleati i marocchini? No, ma era... ce n’era... questi e quegli altri, c’era dei marocchini che avevano come una coperta addosso, con una fune, quelli erano che volevano la repubblica... e così dopo noialtri si girava sempre per questo paese, abbiamo girato lì circa quaranta giorni e poi dopo siam cambiati. Dal porto ci hanno, dal porto di Santa Maria ci hanno portati a Cadice, che era una città molto grossa e molto bella, era la città... che mi ricordo era... eravamo a Cadice dunque lì a Cadice, era la settimana santa perché la Spagna c’era... erano molto religiosi, la Spagna, in questo paese tutte le sere andavano in giro la settimana santa a portare un Cristo, che portavano in dodici e allora con il capitano g’ho dét: «Ci posso andare anch’io una notte così a fare una passeggiata?» E dice: «Chi vuole andare ci facciamo il permesso, però armati. E allora sòm andé una nòta, una notte a girare dreda a sté Crést. Dei versi, che dal volti capiva ma dal volti capiva un’ostia perché lo spagnolo si capisce abbastanza bene. E di lì siamo stati lì fino alla fine d’aprile e poi dopo siamo andati, ci hanno mandato sui Pirenei come per fare... un controllo se c’era ancora della gente... dei rastrellamenti, ecco facevamo quel lavoro lì noialtri. Ma stavano bene, perché noialtri e gh’iven gùst che dùressa la guera perché ciapévom una mucia d’ sold in Spagna del ’38, io prendevo 36 lire al giorno e 36 lire al giorno erano tanti, perché noialtri qua si prendeva cinque lire al giorno, invece in Spagna erano 36 lire al giorno che si prendevano. Arrivavano in Italia o ve li davano in Spagna? Loro ci davano questi soldi, però a noialtri sei lire da consumare in Spagna in pesetas e il resto lo mandavano a casa, dove li volevi mandare a una banca, a una posta, ecc., perché tutti soldi non li davano perché a dare tutti quei soldi lì c’era di quelli che... c’era le donne così e allora «fochi fochi» cinque pesetas, «fochi fochi» cinquo pesetas, e allora c’era di quelli che li spendevano tutti per quei affari lì e tutte le mattine avevano la visita noialtri, tutte le mattine la visita dal medico perché c’era 73 una pestilenza... e quelli che prendevano qualche cosa subito li rispedivano in Italia... eh! Quanto gridava il colonnello, il capitano per quel lavoro lì che... mentre io ero socio di quel bambino e mangiavo banane ne mangiavo un cavagno al giorno... Per il resto noi abbiamo girato... come di guerra, non abbiamo fatto, siamo andati di presidio così da un paese all’altro, c’erano dei paesini piccoli ma... come guerra noialtri siamo arrivati... Si partiva subito se i muli arrivavano, quando noi allora si partiva subito per i Pirenei han detto: stasera facciamo sosta qua a Santa Maria, domani si parte per i Pirenei. Il nostro colonnello, invece, la fortuna che non è mica arrivato i muli, è stato sfortunato quei soldati che ci sono restati dentro alla nave perché l’hanno fatta saltare per aria... Ah quando siamo stati nello stretto di Gibilterra che ci facevano le prove a noialtri di camminare alle barche perché se tiravano alla nave avevamo tutti il nostro posto di... al N° 5, al N° 7, ecc. bisognava andare tutti a quel posto che c’era la barca per tutti ed erano barche grosse perché sulla nave eravamo in settemila. Si ricorda il nome della nave? Non mi ricordo la nave... era una nave brutta non era mica come adesso e stata poi la prima nave che ho visto, che ag’niva mai vist ed navi ma non era mica... era brutta e allora ho detto: «mi se sòuna l’allarme e deg invece d’ càminer a la barca vado giù in stiva giù sotto ac’ sé sun al prem ad ander so» perché era terribile il mare quando siamo andati là... c’era dei pesci che erano come i muli [Probabilmente delfini, N.d.R.] e correvano dietro alla nave, sembravano muli e deg: «Se salt dénter in mar m’magnen subét»... del resto la vita è stata bella... io l’ho detto tante volte, ritornerei in Spagna. Sui Pirenei, in quale località vi trovavate? Sui Pirenei abbiamo fatto tutta la costa lì della Francia e adesso i nomi non me li ricordo, c’era scritto dei nomi lì che ag gh’iva ed nov a sàveir léger. Mi ricordo che ce n’era uno che si chiamava... Gijòn era proprio di questi paesetti che non mi ricordo... sulla montagna dei Pirenei ma lì poi ci sono... abbiamo fatto dei rastrellamenti dieci/ quindici giorni, poi siamo tornati indietro e dopo il colonnello ha detto: «Ritorniamo in Italia, siete contenti?»... tutti quanti dicevano no... che si stava bene in Spagna... si stava male per il mangiare, ma i soldi si prendevano, poi con i soldi si mangiava. Non ha mai avuto paura? No, mai, avevo paura solo dei marocchini. E fino a quando è rimasto in Spagna? Fino al 12 o 13 maggio. Come vi hanno detto che era finita? Lo sapevano già da quando siam partiti da Cadice che era finita la guerra, che il general Franco aveva vinto e che la guerra era finita. No, perché tutti i bimbi di dodici/ tredici anni erano mobilitati, quelli là della Spagna tutti ci avevano il fucile, bambini di dodici, tredici, quattordici, quindici anni, tutti sté ragazzini avevano tutti il fucile. 74 Erano in divisa? Divisa non si capiva che cosa fosse, i paséven con dei cavalli che... in mezzo a queste pianure in questa sabbia che facevano paura, anche questi ragazzi tutti anche con le frecce, no col bastone che lanciavano... delle lance. Ma stavano dalla parte di Franco questi ragazzini? Sì, tutti dalla parte di Franco, volevano che finisse questa guerra... ma era pur finita... noi siamo andati là... dopo venti giorni, un mese che siamo stati là, la guerra era finita... noialtri tenevamo l’ordine, il buon ordine... e... mangiare delle banane e fumare delle sigarette ed è stato là che mi sono rovinato a fumare... potevo iniziare anche in Italia ma in ogni modo... Erano forti le sigarette spagnole? Sì, ma c’erano poi tutte, c’era «calipso», «tre stelle», quelle sigarette, che usavano una volta che ci sono anche adesso... mi ricordo io quando al tenente ci ho detto: «Tenente non si potrebbe comperare delle sigarette?» e dice: «Dove le mettiamo?» e io: «Le munizioni le buttiamo in mare, riempiamo le cassette e le piombiamo e dico dentro c’è munizioni e nessuno ci guarda. Allora il tenente dice: «Lo facciamo». Ne abbiamo prese non so non ricordo se erano 12.000 o 13.000 pacchetti di queste sigarette ma tutti i soldati ne avevano poi preso... le munizioni facciamo conto di averla drovata e la butòm szò per mar. Avevate messo le sigarette nelle scatole di munizioni? Eh sì, in tutte queste cassette di legno o di ferro e le abbiamo portate in Italia. Poi dalla Spagna cosa avete portato in Italia? Niente, perché i soldi si prendevano ma non ne davano, davano quella quota. In Spagna c’era del vin bon, e alòra me al vin am piasìva e vag dénter a un’osteria e go dét: «Datemi una bottiglia di vino» al dìs: «In quanti siete?» e dìs: «Ac son da mé». Ero lì vicino all’accampamento, al dìs: «No, no un bicchiere, un bicchiere, un bicchiere di vino basta» perché qua e a vriven gnan gli ufficiali che s’abvéssa perché se catéven un che avesse bvù, che fussa sté ubriaco l’’masseva subìt e alòra bisognava star semper atenti a quel che s’feva. Come erano i rapporti con gli spagnoli? Oh, abbastanza in ordine, perché poi c’era tutta gente vecchia e donne e bambini... donne giovani... di uomini non ce n’era anche i ragazzini erano via tutti con al sciòp, tutti col fucile. Ma la gente come vi deveva? Di buon occhio oppure... Sì con noialtri italiani molto... con noialtri italiani guai, avevamo sempre la gente così attorno all’accampamento che volevano venire... ma non si poteva lasciarli... perché avevano messo un filo per dire qua... è zona militare e avevano messo un filo... e venivano dentro e c’erano degli ufficiali che non dicevano niente c’era quell’ufficiale che vedeva che parlavi con quella gente lì e... non volevano. Ecco. 75 Cosa dicevano della guerra gli spagnoli? Dicevano quello che dicevano anche i tedeschi lo stesso, che speravano che un giorno o l’altro finisse... di finirla la guerra. Ma sapevano e anche voi sapevate che guerra era quella? Quella lì... la guerra della Spagna era... come... una rivolta perché... c’era Franco con l’altro... adesso non lo so come si chiamava, non mi ricordo... lottavano loro insieme lottavano, era partito contro partito, erano due partiti che lottavano insieme il resto... E la gente da che parte stava? Da quella di Franco o con i repubblicani? Eeeh... ben come ho detto prima che dalla parte di Franco ce n’era tanti ma quando si trovava quegl’altri, quelli che avevano quel cinturone così come... una coperta forata e... messa addosso, legata, legata con una fune... quelli che passavano quelli, che delle volte noialtri andavamo su in montagna, erano qua accampati e andavano fino in cima a fare un giretto. Dieci/quindici tutti armati si guardava... c’era un sergente con noi, un sottotenente... si guardava per vedere... insomma per vedere cosa c’era nella Spagna così... e si trovava lassù in questa montagna che non si poteva... si trovava molti maialini, ma come tutti, come i cinghiali ecco maiali selvatici e guai non si poteva spararci perché allora... allora era proprio una rivolta. E quelli del cinturone contro a Franco e si trovavano sempre giù nella valle, nella pianura perché c’era tanta pianura lì come Cadice, Porto di Santa Maria... era tutta pianura e... lì non ce n’era, si trovavano ad andare su nelle montagne che stavano nascosti come i ribelli quando erano qua si trovavano in quelle zone lì... Ne avete catturati di questi repubblicani? No, noialtri quando sono andato via io non ho mai... ho visto passare una squadra, ma noialtri... perché anche loro non si tiravano mica se non erano mica sicuri e loro cercavano di prenderti più che ammazzarti, di prenderti perché non volevano far sentire sparare e loro ti tiravano con quelle frecce che ho detto io prima, con quelle lance lì ma... con i cavalli, loro avevano i cavalli... Erano quelli i vostri nemici, a cavallo con le lance? C’era quelli e quegli altri... loro con una lancia di quelle lì come di qua sulla strada c’entravano a cavallo mentre che andavano a cavallo, perché io l’ho visto anche quelli là, la squadra di Franco che passavano lì nella pianura... quando tiravano queste lance c’era il capitano, il colonnello che voleva vedere come facevano ma... prendevano questo bastone con questa lancia poi, mentre che andavano di gran galoppo, tiravano questa lancia a un centro e prendevano eh... c’era di quelli che era... E i rossi che incendiavano le chiese, violentando le suore... le risulta? No, perché nelle zone dove mi sono trovato io non è mai successo... so soltanto che... noialtri quando siamo stati a Cadice ho visto... son stato a visitare le chiese... del resto come a Santa Maria, quel paese grosso lì, la messa la diceva il capellano del campo. Non siamo mai andati fuori lì si circolava lì sempre e dopo, quando abbiamo 76 sentito che era finita la guerra, allora ci lasciavano più liberi. Ma però basta andare via con... in quindici/venti e alla talora rientrare, essere tutti dentro perché prima che andasse giù il sole bisognava essere tutti nell’accampamento. Erano tutte case vecchie con brande per terra con della paglia e al mattino lì, dopo che era finita la guerra veniva dentro queste ragazze lì, a pescare nella paglia una briciola di pane così... prendevano e se lo mettevano in bocca... Torniamo a una cosa vista prima. Secondo lei combattere per Franco era giusto? Era giusto rischiare la vita per Franco? Quello lì poi... noialtri siamo partiti giovani e non abbiamo saputo e ci hanno mobilitato... il tal giorno bisogna partire lì, eravamo al Brennero in mezzo a un metro di neve... ci avevano messo con le scarpine basse vestito col cravattino il vestito leggero... siamo stati otto giorni al Brennero abbiamo preso un freddo... essere vestiti prima da militari con... e dopo da borghese... Diceva di essere rimasto fermo 22 giorni in attesa dei muli. Come passavate le giornate? A girare qua per questa pianura qua e non facevano niente altroché aspettare che arrivasse i muli dall’Italia... e quando sono arrivati... prima di raccogliere i muli ancora e di fare il carico per venire ancora in Spagna son passati questi venti giorni. E alla sera cosa facevate? Che cosa inventavate per passare il tempo? Per passare il tempo facevamo la lotta noialtri soldati lì nel campo, non si poteva andare fuori... i primi venti giorni erano chiusi... lì portavano... c’erano quelli che avevano le carte e... facevano alla lotta tre/quattro ragazzi insieme... Diceva prima di quest’ordine di partire per la Spagna mentre era militare; quindi una decisione «costretta». Com’è invece che poi risultò volontario? Non so poi... il battaglione «Verona» parte volontario per la Spagna come volontari perché... non si poteva andare... come militari. Ha firmato delle «carte» per andare in Spagna? No, non, non abbiamo firmato niente perché ci avevano fatto partire da... come borghesi, dicevano lì gli ufficiali, perchè da soldati non si poteva... e credevano che fosse una nave di civili che... andava in Spagna... ecco. Lei era iscritto al partito, alla milizia? È stato costretto ad iscriversi? No, mai! Io... non ero iscritto da nessuna parte, né allora né adesso io... non ho voluto sapere di... nessuna cosa... il mio partito l’è a cà. Quando è tornato a casa e dove siete sbarcati? Sono tornato nel ’39 a maggio... il 12 o il 13 maggio... e siamo sbarcati a Napoli... e a Napoli, anche a Napoli, abbiamo fatto venti giorni di contumacia... No diciamo di... come una disinfezione... ecco che facevano per... prima di... venire su. Perché li tutte visite mica visite... eh... bisognava essere a posto prima di partire da lì... se uno aveva 77 preso una malattia infettiva... una cosa o un’altra. Ci hanno tenuto diciannove giorni a Castellamare di Stabia. Vi hanno ridato le divise poi? Ah no! Le divise... i vestiti in borghese... ci hanno spogliato subito, appena siamo arrivati... era tutta la divisa coloniale. Ma dove? In Spagna. Siamo arrivati in Spagna vestiti da borghese poi sulla nave avevamo poi tutta la divisa... munizione... fucile mitragliatore... io avevo la mitragliatrice pesante ero... avevo il fucile mitragliatore... poi su al Brennero ci hanno ridato le divise da alpino. Poi su al Brennero che cosa è successo? Quando sono tornato è arrivato ancora le reclute nuove e allora han detto: «Eh quando – e c’era poi dentro alle caserme qualche anziano – eh quando arriva i lupi dalla Spagna voialtri…»... perché sfortunatamente io avevo il comando di una camerata... ce ne avevo 27 o 29 di queste reclute che erano sotto... che sono venute sotto. Quando sono rientrato così... gli hanno detto: Questo qua è il tuo comandante della baracca... allora alla sera quando venivo a casa, mi facevo pulire le scarpe... mi facevo levare le scarpe... e far piano... perché mi rompete le ossa che me le hanno rotte là... in Spagna. Alla prima mattina quando ci ha dato il caffé... ce lo ho buttato in faccia... E poi dopo... siamo ritornati dalla Spagna e poi dopo abbiamo fatto una ventina di giorni lì al Brennero e poi dopo siamo andati in licenza per quindici giorni e poi... siamo ritornati sotto. E poi dopo a noialtri non è arrivato il congedo... sette anni... e poi dopo guerra contro alla Francia, contro l’Albania, contro la Grecia, contro alla Francia e... sono stato fortunato che non sono andato in Russia. Quando è tornato a casa? Io sono andato sotto dal... ’38 in maggio... sono venuto a casa del ’45 quando la guerra era finita, sono venuto a casa del ’45. Ed è stato, mi dicevano, deportato in Germania? Anche in Germania sono stato molto fortunato che appena arrivato in Germania... io ero... un comandante... della Germania. Come? Un comandante? Non ho mai patito fame... davo da mangiare ai tedeschi... Dove è stato catturato? Mi hanno preso al Brennero anche lì... perché dopo noialtri, il nostro battaglione... la nostra divisione «Tridentina» era su sopra... da Trento che andava fino al Brennero, del ’43 quando è stato l’8 Settembre che ci hanno presi... a me mi hanno preso sulla... Pala Bianca che avevo tentato di andare in Svizzera... e... mi ha preso dei borghesi... 78 e... dice: «Ah sei qua!» e lì io ero disarmato... avevo buttato via tutto, ero borghese... e lì mi hanno preso sulla Pala Bianca e mi hanno portato giù a Merano... e da Merano sono andato a finire in Germania. Quando ce ne era tanti che scappavano, che tentavano di scappare, quando ho visto che ne ammazzavano un, due, tre... dieci, questi tedeschi... dico sarà il destino... vado in Germania. Quando è tornato nel ’45 a Gatta come ha usato i soldi che aveva guadagnato in Spagna? Per comperare un aratro e... un carro. Perché li avevano mandati a casa a mio padre; io non li ho mica mandati... in banca, in posta o così, io li ho mandati a mio padre. Quindi suo padre li ha tenuti, quando lei è arrivato... No, no aveva già... usati... e se ha comprato anche una fune per legare i carri del fieno. Ma quanto aveva spedito a casa? Erano 36 franc al dé... per sei mesi... novecento lire al mese, seimila lire... Una volta tornato, la sua esperienza spagnola, le ha creato dei problemi con la gente del posto? Nessuno ha detto... era volontario... era fascista... nessuno ha parlato niente perché la divisione «Tridentina» era stata... avevamo i volontari che noialtri gli dicevamo: «Come mai siete venuti volontari per andare in Spagna che noialtri vorremmo andare a casa? E voialtri siete venuti volontari in Spagna per venire in guerra»... Tutta gente, la maggior parte, erano tutti questi volontari erano tutti toscani, tutti della provincia di Lucca, Pisa, Pistoia... la maggior parte erano tutti toscani… andiamo in Spagna, come c’era della gente che sono andati in Africa per prendere qualche soldo perché qua non si... Ma erano fascisti o poveracci? No, qui non si prendeva niente... perché sono andati a lavorare in miniera in Belgio... perché qua non c’era lavoro; sono andati in Africa perché qua non si prendeva niente, non c’era lavoro, non c’era soldi... Ha conosciuto delle camicie nere volontarie «vere»? No! Neanche in Spagna? Là era tutta una divisa. Almeno dove sono stato io era tutta quella divisa color kaki, color caffélatte lì... ma del resto non c’era mica come... non ho visto... da dire qua c’è un’altra divisa di roba di fascisti o una cosa o l’altra. Io non ci pensavo nemmeno... a quel lavoro lì. E dopo essermi trovato in Spagna dicevo: «Almeno essere qua come siamo, durasse la guerra» dicevo che... 79 Quando è tornato a Gatta cosa ha fatto? Il contadino, il mezzadro... ai conti, dare... dare; facevano una pagina lunga come di qua al fiume, tutto dare, non c’era mai avere. Lei quindi è tornato a casa tranquillo. Anche alla sua famiglia mentre era via non è mai successo niente, ritorsioni...? Sono venuti che abitavo lì in fondo... lì dentro mio papà lo hanno calciato e ci hanno portato via tutto, anche il bestiame. Perché lei era andato in Spagna? No, io ero prigioniero in Germania, ma al tempo della guerra di Spagna non ci hanno portato via niente. È successo dopo quando era in Germania? Sì. I partigiani e i tedeschi tutti quanti ci sono andati; una volta i partigiani... mia moglie me lo diceva, perché io sono venuto a casa e ho preso moglie, quando sono venuto dalla Spagna, mi sono sposato nel ’41; sono venuto a casa in una licenza agricola, perché uno aveva della campagna da lavorare... davano un mese... quaranta giorni... di licenza agricola per lavorare la terra... e così ho preso moglie. Poi sono andato via, ci ho detto a mia miglie, lasciami prendere dietro il vestito da borghese che così almeno quando sono... me lo sentivo... lei no! No, no, perché dopo tu... e le donne... e perche è ancora giovane... e così io facevo servizio al Brennero, al tempo prima dell’8 Settembre, facevo servizio al Brennero... segnavo le macchine che entravano e che uscivano dal confine. Io avevo tutto il collegamento lì... e... l’Italia era andéda a... gamb all’elta. E allora mi sono incamminato in stazione per prendere il treno per venire a casa; i borghesi li lasciavano andare, e il militare... niente... E lì è stata una battaglia, è stata una battaglia che ho perso il cappello [perdere il cappello per un alpino è un disonore, N.d.R.]... Cioè? Ho avuto uno scontro con i tedeschi... e lì è stata una battaglia che ho perso il cappello... sarà state le 11 di notte così, sento cammilinare pian piano e dico: «Chi va là?»... non ho capito niente. Io mi sono buttato giù per un burrone... e così... ho perso il cappello ma mi sono salvato e poi dopo al mattino così... quando è incominciato a venire giorno, traversavo così la montagna, che ero molto pratico che era già tre o quattro anni che ero su questa montagna e dico: «Vado in Svizzera». Quando sono arrivato per andare, per passare il confine, che c’era ancora cinque/seimila metri, ho trovato due borghesi di quei crucchi che abitavano... a Merano, Bolzano così, di quella gente lì e mi hanno preso e mi hanno portato giù e così... in Germania, in Germania che ero un comandante. Della Germania potrei raccontarle tantissimo, la Spagna cosa vuol mai... abbiamo fatto lì cinque/sei mesi di villeggiatura. Perché violenze non ne ha viste? No, niente proprio… niente... della gentaglia che combatteva contro queste signorite. 80 Cioè? Come dire... quelli che andavano in giro con la donna spagnola, anche abbastanza belle e... andavano con queste donne... era tutta una malattia proprio una battaglia, tutta la battaglia del grano. Si ricorda la cosa più bella accadutale in Spagna? Il ricordo più bello è stato quando ero a Cadice che si passeggiava così che mi piaceva molto, avevo poi girato poco prima di andare soldato. Ero stato a Reggio una volta... del resto non avevo visto... vedere una città come la Spagna lì a Cadice... dico ... non avevo mai visto... ecco, bello, mi divertivo. E il ricordo più brutto? Dispiaceva essere lontani, pensare ho a casa una famiglia e chissà se ritorno a casa... del resto per la Spagna mi sono divertito molto... perché si andava a spasso; si mangiava e si andava a spasso. Di cosa parlava insieme ai suoi commilitoni? Quali erano gli argomenti di discussione? Era soltanto che noialtri si poteva sapere di più se noialtri andavamo su al fronte, allora si poteva sapere... noialtri eravamo rinchiusi e allora si parlava... meglio che qua... non facciamo niente... siamo venuti in Spagna a fare una villeggiatura in Spagna... e le ho detto tante volte che mi sarebbe piaciuto tornare in Spagna a visitare la Spagna; ma ormai ho una età... come la Germania, mi sarebbe piaciuto tornare... ma mi è piaciuta meno. La Spagna quelle città che ho visto, per me sono state stupende. I vostri superiori invece cosa vi dicevano? Noialtri siamo venuti qua... altro che dicevano: «Mi raccomando, mi raccomando di entrare la sera» perché c’era sempre la ronda che girava, perché eravamo in settemila ma ce n’era cinquecento la sera che giravano di ronda intorno all’accampamento che giravano se qualcuno andava fuori, se qualcuno veniva dentro, borghesi... quei marocchini lì... e per fare qualche cosa. C’erano dei suoi compaesani in Spagna? Sì, però la maggior parte erano qua di... del comune di Villa Minozzo, di Cerré Sologno, della Val d’Asta... eran tutti di questa montagna... ce n’eran tanti degli alpini in Spagna. Quanti reggiani conosceva in Spagna? Saran stati... duecento. Là ha incontrato altri reggiani? No. Là tutti i volontari che sono venuti... perché duecento... ci saremo stati anche forse trecento perché tutta la divisione «Tridentina»... la maggior parte erano tutti di queste montagne qua. Gli alpini erano emiliani, poi c’eran veronesi, friulani, tutta gente della montagna, la maggior parte, perché dalla nostra pianura qua non c’era nessuno. 81 Là, non ha sparato neanche un colpo? No. Noialtri quando siamo arrivati... mancando i muli, ci siamo bloccati lì, siamo stati fermi lì, non abbiamo fatto niente. Altro che mangiato e bevuto del vin buono. Mangiato? Mangiato delle banane, perché pane non ce n’era, carne poca poca, pasta... con tanta pasta così facevano da mangiare a cento persone. Ceci, ceci. C’era una miseria in Spagna che... era proprio nera. Quando ha vinto Franco, cosa avete pensato? Noialtri quando han detto «La guerra è finita!», «Franco ha vinto!» e... dico: «Speriamo di stare in Spagna lo stesso». Noialtri per la Spagna abbiamo fatto niente, niente. Sapeva che dall’altra parte, quella dei repubblicani, c’erano degli italiani, quelli della Brigata Garibaldi? Sapevano che noialtri dovevano andare là sui Pirenei che c’era il fronte di... combattere... no... Dicevo un’altra cosa. Se sapeva di italiani come nemici? No, non so se c’erano degli italiani sui Pirenei fra quella gente loro, come ho detto, cercavano sempre di non sparare, se potevano ti prendevano, ti facevano prigioniero e basta. Come trattavate i prigionieri? I prigionieri li mettevano rinchiusi lì dentro che si sentivano gridare, dentro in queste caserme grosse che c’eran le guardie... si sentivano urlare, alla notte dei versi così, ma... poi noialtri non c’entravano... Andavate d’accordo con i soldati spagnoli? Abbastanza perché... c’era poi la maggior parte che erano lì con noi, c’era tutti dei ragazzini qualche vecchio, del resto i giovani erano proprio tutti al fronte. Cosa ha portato a casa dalla Spagna... oltre alle sigarette? Niente, perché tanto si ritornava a fare il militare e non si veniva mica a casa. E siamo arrivati a Napoli e lì a Napoli poi dopo... siamo andati di nuovo su al nostro reggimento. È vero che i soldati italiani avevano diritto al saccheggio? Adesso io quello non lo so perché non mi sono trovato in questi e gli italiani sono peggiori dei tedeschi, quello sì che lo dico! In che senso? Perché io mi sono trovato in Albania, quello che facevano gli italiani, i tedeschi non lo facevano. Invece i tedeschi, saranno stati severi, crudeli, però facevano il suo servizio, invece gli italiani, ci siamo trovati in Grecia, in Albania... portavano via tutto, entravano dentro, portavano via tutto, trovavano... una ragazzina... così... la violentavano, mentre che i tedeschi, quelle cose lì, e sono stato due anni in Germania, 82 quelle cose lì non le ho mai viste, mai! Che a me mi facevano schifo... io ero uno di quelli che... se c’è una passati i venti che insomma mi trovo lì in compagnia... va bene, ma delle ragazzine, delle bimbe ancora... di dieci/undici anni... lì bisognava tagliargli il collo. Io sarei stato cattivo... È vero quello che si diceva, che gli italiani in Spagna dovevano difendere Franco ma anche la libertà, la chiesa dai rossi? Non ha mai sentito questi discorsi? No. Guarda io di quelle cose lì non posso spiegare niente perché non ho sentito... non ho mai sentito, di quelle cose lì... uno voleva buttare giù un partito, una cosa o l’altra... non ho mai sentito. Noialtri ci hanno rinchiusi in questo pezzo di terreno, come diciamo di due chilometri quadrati, ci avevano chiusi lì... cosa vuol mai... come della Spagna ho fatto... l’ho fatto bello perché, ho visto la Spagna che non avevo mai visto niente... Aldo Buffagni Nato a Reggio Emilia il 24 maggio 1912. Sposato con un figlio, 4a elementare, forgiatore Officine meccaniche italiane. Ha prestato servizio militare in fanteria con il grado di soldato. Dal 24 maggio 1934 è iscritto al pnf e alla mvsn con il grado di cn. Risulta iscritto a: Sindacato industria; Dopolavoro metallurgico; Associazione volontari di guerra. Volontario oms, partito il 26 gennaio 1937, rientra il 19 giugno 1939. Decorato con la croce di guerra al valor militare. Dal 30 giugno 1939 è capo-nucleo del Fascio di combattimento di Pieve Modolena. Le note informative del gerarca Buffagni del periodo 1939-41 esprimono un giudizio «buono». Dal 6 marzo 1943 è capo-nucleo del Fascio di combattimento di Pieve-Roncocesi. Aderisce al pfr ed entra in forza alla gnr dal 25 febbraio 1944, nella Compagnia op. Il nominativo del Buffagni è presente nell’elenco delle persone catturate, collaboratori dei nazifascisti, partecipanti ai rastrellamenti. Viene condannato a dieci anni di reclusione in sede di primo giudizio dalla sezione speciale della corte d’assise di Reggio Emilia con sentenza del 13 marzo 1946, sentenza successivamente annullata in data 12 dicembre 1946 senza rinvio per aministia. Il Buffagni risulta nullatenente. Fonti: Schedario dei gerarchi fascisti; la Polizia Partigiana, ora in Polo archivistico Comune di Reggio Emilia-Istoreco. Intervista raccolta il 10 luglio 1987 nella sua abitazione di Reggio Emilia, vi ha assistito anche la moglie. * Indica gli interventi della moglie. 83 Per iniziare la conversazione, come prima domanda, le volevo chiedere com’è che è partito per la Spagna? Lei era volontario? No. Ero operaio alle Reggiane, è arrivata una lettera di partire per Cadice per... L’Africa? *No. Per la Spagna proprio direttamente per la Spagna, perché mi ricordo anch’io che quando ti è arrivata la cartolina, che sono andata in sede... In sede dove? *In sede del partito, che mi hanno detto: «Adesso guardiamo se troviamo uno da mettere al suo posto», perché aveva una bimba di tre mesi. E allora io ci ho risposto: «Se lo mandate magari in un matrimonio lo trovate, ma andare in guerra sarà difficile». Perché avevo già il fratello e il cognato... In Spagna? *No, in Africa, ne avevo già due e poi hanno chiamato questo per la Spagna. Ma lei allora cos’era? Militare? Dove prestava servizio? No, mi hanno messo nelle brigate nere [Nella MVSN. Nelle Brigate nere ci andò nel 1944, quando furono istituite, N.d.R.]... Lei era iscritto al partito fascista? Sì, c’era la milizia allora, mi hanno mandato a Santa Maria Capua Vetere a Napoli e lì siamo stati tre giorni e poi siamo andati a Gaeta e ci siamo imbarcati al 26 gennaio del ’37 e il giorno 31 mi son sbarcato a Cadice. Era con altri reggiani? Sì, c’era ben degli altri reggiani, c’era una compagnia e c’era anche il capitano che comandava la compagnia. Si ricorda il nome? No, non mi ricordo, so che abitava lì all’Ospizio. Quello lì lo so, ma non mi ricordo il nome. Quindi lei era alle Reggiane quando... Ero alle Reggiane e difatti dopo mi hanno fatto fare delle firme per la liquidazione che ero ancora via; quando sono venuto mi hanno fatto fare delle firme... e poi dopo da Cadice siamo andati al fronte, poi dopo c’è stato un combattimento, siamo avanzati venti chilometri e il giorno dopo siamo stati contrattaccati, abbiamo indietreggiato venti chilometri per la ritirata di Guadalajara. Quindi, lei ha partecipato alla battaglia di Guadalajara? Sì. 84 Lei sapeva che guerra c’era in Spagna? No, io non sapevo nulla. Neanche i suoi commilitoni? Non sapevate che situazione c’era? Per chi andavate a combattere? No, anzi, io dovevo andare in Africa che c’era anche mio fratello, dovevo andare in Africa e non mi hanno mandato. Lei voleva andare in Africa? Io volevo andare in Africa; quella compagnia dov’ero è andata in Spagna e allora io... Quanti reggiani eravate? Ma saremo stati dei reggiani... 45. Io ci avevo un catalogo, ma dopo la Liberazione smarrito: o con noi o contro di noi. *Ma come si poteva tenere dei ricordi con il momento che abbiamo passato. Avevamo anche general Franco un quadro... Che il figlio poi ci ho messo nome Franco. Quando sono venuto a casa è rimasta incinta di quello lì... Lei lo ha chiamato Franco in onore del comandante delle truppe franchiste? Sì. I reggiani che sono partiti con lei erano tutti operai delle Reggiane o erano contadini? No, erano una compagnia di milizia. Io alle Reggiane ero in magazzino. Questi ragazzi che sono partiti con lei erano tutti operai? Tutti operai. Difatti c’era uno «stradalone» di Casina, quell’altro era un contadino che è Bertani, c’era Galeotti operaio, il povero Ildebrando operaio, erano tutti operai... *… Non c’era mica dei signori. No, no quelli a casa, quelli sono andati via da soli. Che clima c’era in questo battaglione? Allegria, tristezza...? C’era allegria, non è che stessero in pensiero... il pensiero è venuto dopo, là al fronte, il 19 marzo che c’era la festa a Scandiano, la fiera di San Giuseppe mi torna sempre in mente, che c’è stato un bombardamento nella battaglia di Guadalajara. Dopo ho indietreggiato, sono andato a finire in un paese che si chiamava, aspetta pure... *... Bilbao? No… Miranda d’Ebro. Da chi siete stati accolti a Cadice? Dai falangisti, ma c’era anche i marocchini, sa quelli lì erano per Franco, guai... 85 C’erano tedeschi? Sì, c’erano anche i tedeschi, ma erano un plotone e battaglione a parte. La più parte erano con gli apparecchi da bombardamento, loro bombardavano più che altro. Gli spagnoli come vi hanno trattato appena arrivati? Ci hanno trattato bene. Erano contenti del vostro arrivo? Sì. Appena arrivati dove avete alloggiato? Lì a Cadice. A Cadice siamo stati un giorno o due, poi con il treno ci hanno portato sul fronte e davanti a noi c’era i marocchini e difatti, man mano che si avanzava, si vedeva qualche morto, quasi tutti marocchini. Come eravate equipaggiati? Eravamo equipaggiati bene. Che armi usavate? Io ero per le bombe, avevo un tascapane più un mitra italiano, era piccolo, corto. In che squadra eravate? Ero nella quinta squadra. Quanto tempo è rimasto in Spagna? Trentasei mesi, sono venuto a casa, son sbarcato a Napoli il 19 giugno del ’37. Qual è l’episodio più significativo della guerra di Spagna che si ricorda? Lì a Teruel, che allora adoperavano le pallottole dum dum, e un mio amico gli è arrivata la pallottola qua e gli è scoppiata la gola... *... di 27 sono venuti a casa in tre... ... e, infatti, ce n’è rimasto uno di Bagno, due di Casina... *... uno di Castelnovo. Lei non ha conservato un elenco dei suoi commilitoni? *Macché avevamo anche i ricordi di quando son partiti da Bologna, ma purtroppo abbiamo buttato via tutto, chi è che tiene quella roba lì nei momenti che abbiamo passato... Volevano far fuori anche lei. *Mi hanno fatto la buca per mettermi dentro. Sa perché secondo loro era andato via volontario, invece ce lo hanno mandato, poi invece era risultato volontario... 86 Quindi nei documenti ufficiali risultava volontario? Sì. Quindi mentre suo marito era in Spagna...? *A me mi hanno fatto il resto. Quindi, che cosa le hanno fatto signora? *Glielo ho detto, mi hanno fatto la buca da mettermi dentro, mi sono salvata perché avevo la bimba piccola. […] Lei ha imparato lo spagnolo? Perchè là mi sono scritto, anche dopo a casa avevo una amicizia con uno.... Con chi? Con un falangista e allora ci siamo scritti ancora per cinque/sei mesi. Poi dopo si vede o che è morto o chissà, non ho più sentito... […] Che rapporto c’era fra voi e gli spagnoli? Erano contenti della vostra presenza? Sì, sì. Ma perché erano contenti? Perché volevano Franco... Avevano paura dei rossi e volevano...? Avevano paura dei rossi. Perché avevano paura dei rossi? Perché là hanno fatto la rivoluzione e chi ha salvato Franco sono stati i marocchini. Guai per Franco. Però la gente aveva paura dei rossi perché avevano fatto la rivoluzione... O perché? Perché allora chi ci faceva paura era la Brigata Garibaldi, gli italiani all’estero. Perché cosa faceva la Brigata Garibaldi? Avevano paura; era quella lì che combattevano. Gli spagnoli. Allora la popolazione aveva paura della Brigata Garibaldi? Infatti, un qualcheduno ci è rimasto lì a Santander; perché Santander, Bilbao, Barcellona, Teruel io li ho fatti. È stato in tutte queste città? Sì, un mese stavo in un posto, l’altro mese in un altro. Sa, variazioni di compagnie. Lei diceva che avevano paura della Brigata Garibaldi, ma perché avevano paura di essere uccisi? 87 Perché hanno visto che quando si ritiravano c’era qualche cosa che non andava. Io non so poi il perché. Non riesco a capire: quando si ritirava la Brigata Garibaldi? Allora avanzavano questi qua. Però che ci faceva paura era di essere invasi dalla Brigata Garibaldi. Perché, quando arrivavano i rossi nelle città spagnole controllate dai falangisti, cosa facevano? Non so, non mi ricordo. In queste operazioni di guerra cosa succedeva quando facevate dei prigionieri? Guardi di là come prendevano dei prigionieri li facevano fuori mentre noi li mettevamo con i prigionieri. Come li trattavate? Li trattavamo bene. Sa mi ricordo che hanno fatto prigionieri. Va bene, gli hanno dato da mangiare subito e poi sono stati un bel po’ in compagnia poi li hanno portati con gli altri prigionieri di guerra. Dove li portavano? Li portavano in gita nelle città, rispettavano l’idea. Mentre quando catturavano dei vostri li ammazzavano subito? O li picchiavano o li ammazzavano subito, dipende da chi trovavano. Se trovavano un volontario, lo facevano fuori, se invece trovavano un obbligato, lo lasciavano lì. Ripensandoci oggi, cosa è successo in quegli anni in Spagna? Chi è che aveva ragione, voi o gli altri? Queste sono cose che non si possono sapere. Ma secondo lei? Io sono convinto che il sistema stava bene dalla nostra parte; che poi se stavano bene loro, garantisco che non stavano bene. Quando arrivavate in una città che era occupata dai rossi fino al giorno prima, la gente era contenta del vostro arrivo? Sì, sì, proprio contenta. Ci battevano le mani e poi ci chiamavano: «Venga qua, qui c’è casa de comida». Quindi il popolo stava con voi? Era più dalla nostra parte. Lei si è scontrato con gli italiani della Garibaldi? No, io non ho mai usato una pallottola. 88 Non ha mai sparato. Io sparare non sparavo, non potevo nemmeno vedere quando uno dava uno schiaffo, anche se era un nemico. *La più parte è stato in magazzino. Lei era nei viveri? *Sì, lui ha fatto poco. Dopo sono stato anche qua a Reggio, facevo il «cuciniere». Dove? Lì dove sono i carabinieri adesso, c’era la caserma della milizia; di là c’era la compagnia delle Brigate nere. Quando è tornato dalla Spagna cosa ha fatto? Come siete stati accolti una volta tornati dalla Spagna? Eeh, sono venuti a prenderci con la musica. Dove? Siamo sbarcati a cosa... A Pompei. Siete partiti da dove? Da Cadice. Chi c’era ad aspettarvi a Pompei? C’era poi la compagnia, anzi c’era i militari perché ci hanno smobilitato. Vi hanno fatto festa? Sì. Chi c’era? La musica. Chi c’era del partito? Non mi ricordo. Siamo stati lì cinque giorni... Quando è arrivato a Reggio come è stato trattato? Ci hanno fatto la festa. Anche a Reggio? La marcia su via Emilia San Pietro, di lì alla stazione. Chi vi ha accolto? Il federale? Sì. 89 Chi era il federale allora? Chi si ricorda?!? Poi come lavoro è stato assunto? Sì, come volontario. Quindi, lei non ha perso il lavoro. Tornato dalla Spagna lavorava ancora? Sì, non mi hanno dato il mio vecchio posto. Le hanno trovato un nuovo posto visto che l’avevano fatta licenziare dalle Reggiane? No, non me lo hanno dato, me lo sono trovato. Ho dovuto mandare in servizio lei [la moglie, N.d.R.] e dopo si è impegnato il ragionier Bertolini della Banca agricola e commerciale. Era un gerarca? Non era niente, era perché c’era andata mia moglie a fare dei fatti per dare da mangiare ai bimbi. Ma lei quanto guadagnava in Spagna? Venticinque pesetas al mese. Quindi, lei riceveva lo stipendio in pesetas, non in lire. Ma chi glieli dava questi soldi, Franco o Mussolini? No, no. Franco ce li dava a noi, noi li mandavamo a casa che qua a mandare dieci pesetas ne tiravano ventimila lire. Ventimila lire? No, erano il doppio che prendevo, la lira là era mezza. Cioè dieci pesetas erano cinque lire? Sì. Quindi, lei mandava venti pesetas...? ... E ne tiravano quaranta lire. Lei là non spendeva niente? Ne spendevo anche là, ne tenevo anche per me. Per andare al cinema? Perché dopo questa qua [sempre la moglie, N.d.R.] prendeva qualche cosa di più perché aveva gli assegni familiari. Per i figli. Ma sua moglie riusciva a vivere con i soldi che inviava dalla Spagna? *Andavo a lavorare; non c’erano abbastanza dei soldi di lui con dei figli... 90 Insomma in 36 mesi mi sono messo da parte settecento lire, allora erano soldi. Allora è riuscito anche a risparmiare? *Ah, io cercavo di risparmiare, cercavo di lasciare fermi i soldi che arrivavano dalla Spagna, io vivevo con quelli che guadagnavo io perché passavano il latte, passavano lo zucchero, passavano la legna. Chi è che passava queste cose? I tre partiti uniti: comunista, socialista e democristiani; allora c’è l’associazione, facevano i più bisognosi e passavano qualche cosa ai bambini. Ma in che anni? Nel ’45. Ma io dicevo quando suo marito era in Spagna? *Mi davano soltanto le pesetas di lui e basta. Nessuno vi aiutava. Il partito fascista vi aiutava? *Dopo sì... Voglio dire, c’era un po’ di riconoscenza da parte del partito per il fatto che suo marito era in Spagna? *Quando lui era via, se c’era qualche cosa mandavano a prendere, sa dicevano: «avete bisogno di qualche cosa?»... Il partito fascista? *Sì, il partito fascista, anche il comunista; me mi hanno dato l’aiuto tutti. Sì, perché dopo quando sono venuto a casa... *... A me mi hanno dato l’aiuto tutti. Lei è tornato ferito dalla Spagna? No, no, sono tornato con la pleure.... *… Con la pleure e ha fatto 32 mesi di sanatorio. Una volta caduto il fascismo lei cosa ha fatto? Io andavo a lavorare che mi ha messo a posto quel ragioniere lì della Banca agricola, aveva un laboratorio lui fuori e faceva la fotochimica, Industria italiana dagherratopia facevano... per i fotoincisori i cliché, non so se è pratico... Quindi lei ha continuato a fare il fotografo? Ho continuato vent’anni poi sono venuto qua, in carrozzeria. Facevo anche il carrozzaio e mi hanno preso qui e gli ultimi tre anni mi sono ammalato e allora sono 91 andato invalido... *... Del ’69 sei andato invalido sì e dal ’48 sei ammalato. Che rapporto aveva con i partigiani? Ero amico di tutti. Durante la guerra di Liberazione che cosa faceva? Me mi hanno fatto un processo che ho preso dieci anni. Chi le ha fatto il processo? Quando è finita la guerra mi hanno fatto il processo per... *... Perché avevi fatto la guerra in Spagna... Sì, dieci anni per favoreggiamento con il tedesco invasore e poi dopo quello che mi aveva fatto quella denuncia lì non si è presentato. Qualcuno aveva fatto la «spiata» che lei era andato in Spagna? *Sì, ci volevano male, un odio personale... Lui adesso è al cimitero e io sono qua. Quindi finita la guerra qualcuno ha detto «il Signor Buffagni è andato in Spagna volontario»? *Sì, perché si è trovato bene, non ci è stato niente, si è sempre comportato bene e lui dalla gelosia che ha avuto dei fratelli che purtroppo ce ne ha lasciato ci ha avuto l’odio personale e ci ha fatto del male. Quindi, il processo è andato bene? Sì. Quindi i partigiani...? Anzi hanno fatto una scena a lui. Non ha fatto la guerra di Liberazione? No, no, sono stato nascosto qualche giorno poi quando ho visto che avevo sempre i carabinieri «vicino al culo» allora sono andato sotto alle armi, ero stato chiamato, sono stato nascosto ma dopo ho visto che erano sempre lì, sempre lì mi sono ripresentato. Senta, tornando alla Spagna, quando eravate in città e in riposo, cosa facevate al pomeriggio e alla sera? Andavamo a letto, andavamo un po’ fuori e poi a letto. Non c’erano cinema, bar, luoghi di ritrovo? 92 C’era la corrida che, quando c’era la corrida, mandavano tutta la compagnia. Sì ci sono stato anch’io. Andavate a letto presto? Alla sera andavamo a letto quando si poteva, quando non si poteva, se si era al fronte, bisognava stare lì in agguato tutta la notte. I rapporti con i tedeschi? I tedeschi come vedevano gli italiani in Spagna? Ma erano visti bene, però non stavano sempre insieme, erano pochi i tedeschi fuori di quelli che avevano gli apparecchi, ma del resto non avevano mandato una compagnia o un battaglione come noi, l’Italia, ha mandato tutti per terra... E i vostri comandanti erano bravi? Ma noi avevamo tre ufficiali di Reggio. Adesso non li vedo più. Dove sono morti i suoi commilitoni? A Bilbao ce n’è stato un mucchio e a Teruel, perché lì c’era dei passaggi obbligati da fare e allora avevano piazzato sulla collina loro e quando passavano «tack» avevamo cinquanta metri col tascapane da fare a piedi e allora c’erano le pallottole dum dum che, quando ti colpivano non ti salvavi più, è come una bomba, come va dentro scoppia. Avevate anche mezzi corazzati? Carrarmati italiani; c’era l’artiglieria. E i nemici erano bravi a combattere gli spagnoli dall’altra parte? Di quelli ne combattevano pochi, per la grande maggioranza erano inglesi e italiani quasi tutti. Ma gli spagnoli? Ma non so erano bravi. Noi li chiamavamo i «cecchini». Perché cecchini? Perché quando c’erano i passaggi obbligati... Li chiamavamo cecchini per quello. Ma come valore, al fronte eravate più bravi voi o quelli dell’altra parte? Non so cosa dire... so solo che uno non vedeva l’ora di arrivare a casa. Ho sempre detto: «Noi siamo qui al fronte sotto ai bombardamenti e gli altri saranno a casa il 19 a Scandiano alla fiera di San Giuseppe». È vero quello che si dice? Che là i rossi incendiavano le chiese, torturavano e ammazzavano i preti...? No, no; ho visto ammazzare una suora, questo sì, a Teruel. Ma come mai? Non lo so. 93 Ma chi era stato? Ma mentre si ritiravano l’hanno trovata accanto a un olivo impiccata su un olivo, le mancava anche una mammella. Ma torture non ne ho viste. Lei ha visto solo una suora morta? Fucilazioni di preti, chiese incendiate...? No, non ne ho viste! Quindi secondo lei non era vero quello che... *Sì caro mio in tempo di guerra ci sono più chiacchere che terra. Ma si diceva che i rossi uccidevano i preti... Si diceva che gli italiani fossero andati in Spagna per difendere la libertà e la Chiesa, che i rossi attaccavano. Lei era convinto di essere andato in Spagna per difendere queste cose? No, no; io non ci capivo niente, ho sempre capito niente in quei lavori lì. Lei là ha fatto il suo dovere, quello che le ordinavano...? Sì, perché quando sono venuto a casa e sono andato da quello che mi ha trovato da lavorare, lavoravo con il fratello di Valdo Magnani comunista, era il nostro dottore; «Buffagni – diceva – non rientrare nella politica». Magnani Marte, e adesso c’è Paolo che è suo figlio. Dopo la guerra è rimasto fascista? No! No! Non ho più voluto sapere niente di niente. Perché ha voluto chiamare suo figlio come Franco? Mah. Lei quindi ammirava il generale Franco? Sì, come «lasciato», come «lasciato» di questa esperienza. Che altri ricordi ha della Spagna, a parte la guerra, del popolo per esempio? Ho visto della gente buona come da noi che dicono quelli della «bassa»; quelli della «bassa» ci sono i buoni e i cattivi qui come là è un popolo un po’ più unito. Avevate il capellano con voi? Sì, avevano il parroco di compagnia e dove andavamo dicevamo sempre la messa; anzi gli spagnoli si sono meravigliati che noi fossimo così di chiesa. Perché loro non erano «così di chiesa»? No, loro sono sempre di chiesa perché vedevo che, dove andavo, vedevo che c’era sempre pieno, sempre pieno. Però voi dicevate più messe di loro? Io dicevo più messe perché sa con quello che hanno detto, se c’è Dio vedrà anche i peccati che uno fa, tutti i modi è così. 94 È tornato in Spagna dopo la guerra? No, mai! *Lui non è più andato in nessun luogo; ha fatto del sanatorio, dell’ospedale a vita... Sono andato anche in Sardegna, ma ci sono andato con la macchina perché avevo i miei figli che lavoravano là. Cosa dicevano i vostri comandanti al fronte? Mah ne dicevanto tante... Hanno sempre ragione quando parlano là. Per farvi combattere che cosa dicevano... «Combattiamo per uccidere i rossi»? No, no, parlavano di libertà, la libertà. Secondo lei e secondo i suoi compagni era giusto che degli italiani andassero in Spagna per aiutare degli spagnoli? Ma noi si discuteva poco, noi si discuteva lì che non vedevamo l’ora di finire per arrivare a casa. Questa era la cosa più importante? Sì, speriamo che non vengano più guerre per me è finita, ma è per i figli e i nipoti. Quando è morto Franco lei che cosa ha pensato? Non ho fatto festa. Allora a Franco erano in molti ad applaudirlo; una parte lo odiava, ma l’altra è stata male quando è andato via Franco. Lei lo ha visto Franco? Sì, a Madrid prima di venire a casa abbiamo fatto la sfilata a Madrid poi di lì siamo andati a Cadice, a Cadice ci siamo imbarcati con il «Lombardia». Franco che cosa vi ha detto? Ci ha applaudito che gli italiani hanno fatto il suo dovere. Ha avuto delle medaglie in Spagna? No, non ho niente, solo il congedo militare. Mi è rimasto quello, quando ho fatto il soldato a Gorizia, 23° fanteria. Come è che gli è venuta la pleurite in Spagna? Ma la pleure è sufficiente una sudata e un colpo d’aria. E là non l’hanno curata non avevate quindi una buona assistenza medica? No, c’era il dottore di compagnia, ma poi quando ero al fronte non avevano tempo, erano molti che facevano i malati anche se non lo erano. Mangiare avete sempre mangiato...Cosa vi davano? Anche sigarette? Ecco sigarette ci passavano 25 sigarette al giorno. 95 Italiane? Spagnole, un po’ forti allora fumavo sì. Vi davano anche liquori? Vino, un quarto a testa a pasto, poi al fronte ci portavano da mangiare. In caserma dormivate in camerate? Sì. Il momento più brutto che ha avuto in Spagna quale è stato? Il bombardamento di Guadalajara: i proiettili venivano giù... Che cosa pensava? Di ripararmi. E i suoi compagni? Facevano quello che facevo io: cercavano di evitarli. E il momento più bello? Quando siamo venuti a casa. Un altro momento bello? Mah… Non c’è mai stato un momento in cui ha pensato di essere utile a qualcosa o a qualcuno? No, pensavo solo di venire a casa. Non ha conosciuto dei ragazzi contenti di essere in Spagna? Dei volontari contenti di essere là a combattere? No! C’era qualcheduno, ma pochi. E le donne spagnole? Sono «buone»; chi ci riusciva si andava in casa de puta, al casino; la prima sbarcata che ho fatto a Cadice è venuto un ragazzetto, avrà avuto dieci anni, e dice: «Italiano vuole casa de puta?» e io gli ho risposto che ero venuto apposta. Quindi andavate nei casini? Quello sempre, quando si è giovani anche per ridere. Anche gli ufficiali o solo la truppa? No, no roba di truppa. Gli ufficiali ci rimanevano due minuti poi andavano... Italiani che si sono sposati con delle spagnole...? Alcuni sì, anche uno di Reggio si è sposato con una di Guadalajara. 96 Si ricorda il nome? No. La gente che incontravate che mestiere faceva? Mah. Lei signora riceveva corrispondenza da suo marito? *Sì! Quasi una cartolina tutti i giorni e le dicevo: «sono al fronte». Le avete tenute tutte le cartoline? Sì, tutte. Finita la guerra non si è più parlato della Spagna? *Basta, chiusura. Partiti o non partiti basta quando si pensa che uno è partito anzi lo hanno mandato via e poi figura volontario; no allora i partiti si lasciano andare l’idea c’è... ... Avevo il mio posto e una figlia avevo proprio bisogno di andare via, sono venuto a casa che mia figlia non mi voleva vedere. Giorgio Guindani Nato a Gualtieri il 23 dicembre 1916. Abilitato all’insegnamento. Ha prestato servizio militare nei bersaglieri con il grado di sottotenente. Iscritto al pnf dal 24 maggio 1938. Volontario oms. Tenente di complemento dell’8° bersaglieri, viene inquadrato nel reparto camicie nere «Dio lo vuole» e sbarca a Cadice alla fine di dicembre del 1936. Partecipa alle battaglie di: Malaga, Guadalajara, Bilbao, Fronte dell’Ebro, Barcellona; rimpatriato verso la fine del 1938. Richiamato allo scoppio della guerra con la Francia, finisce prigioniero in Marocco. Nel 1945 viene promosso in servizio permanente effettivo e continua la carriera militare raggiungendo il grado di generale. È stato decorato con la croce di ferro di 1a e 2a classe (onorificenze tedesche). Fonti: Schedario dei gerarchi fascisti, ora in Polo archivistico Comune di Reggio Emilia-Istoreco. Intervista effettuata il 3 settembre 1987 a Gualtieri. Quando e perché è andato in Spagna? Io sono andato in Spagna... eravamo non sicuri di andarci, praticamente un ufficiale 97 di Stato maggiore lì all’8° reggimento bersaglieri e dice, riunivano il circolo ufficiali e allora... è un momento molto eroico in Italia, i giovani tendevano a dimostrare amore per la patria, quel credo che loro ci avevano insegnato, e allora venne e chiese chi voleva andare a combattere all’estero per l’Italia, e allora io ho alzato la mano e pure un mio collega dietro ha alzato la mano, siamo partiti dopo pochi giorni e ci hanno fermato a Pisa e ci hanno dato una divisa da truppa color kaki. Lei era già ufficiale? Tenente all’8° bersaglieri. Di leva o di carriera? Di complemento, ci hanno fermati lì a Pisa non ricordo più quale reggimento di fanteria, in deposito lì ci hanno fatto fare la nostra cassettina con il nostro materiale da spedire a casa che poi non è mai arrivata e... ci hanno dato un’uniforme una divisa e poi ci hanno mandato a Napoli, a Napoli ci hanno imbarcato mi pare sul «Sardegna» o sul «Monviso», su una di queste navi e siamo andati in Spagna, siamo sbarcati... lì abbiamo trovato della truppa a Pisa, un plotone mitraglieri e abbiamo fatto un plotone mitraglieri e allora siamo sbarcati a Cadice; da Cadice poi ci hanno inquadrato in un reparto camicie nere che era la prima divisione mi pare camicie nere che aveva il titolo si chiamava «Dio lo vuole». E noi abbiamo formato con questi reparti un battaglione di mitraglieri, una compagnia di mitraglieri all’ordine del capitano Guarino e con quella compagnia lì siamo andati da Cadice a Siviglia e da Siviglia siamo andati verso Malaga, ed è stata la prima azione che hanno subito gli Italiani, che ha scombussolato un po’ il loro sistema di combattere che era un sistema molto blando, molto spagnolo. Si ricorda la data di quando è sbarcato in Spagna? Dicembre. Era verso l’ultimo dell’anno del ’36; poi siamo andati a Malaga, siamo arrivati prima di Malaga, ci siamo fermati, ci siamo assestati, ci siamo sistemati bene ci siamo organizzati e poi abbiamo puntato su Malaga. Ricordo che a Malaga, io ho perso il documento mi dispiace molto, a Malaga è stata occupata il 5 febbraio ufficialmente, e io il 4 febbraio ero a Malaga, con la pattuglia di esplorazione sono entrato in Malaga, penso per primo e ho evitato che tagliassero il cavo sotterraneo, ho mandato un telegramma in Italia datato 4 febbraio e non ci credevano nessuno, perché ufficialmente è stata occupata il 5 e io già dalla sera prima ero in Malaga; dopo da Malaga a Motril 150 chilometri avanti mi ricordo e da lì il fronte si è fermato lì perché da lì non siamo andati più avanti non siamo più riusciti ad andare avanti, la nostra unità è stata ritirata, ecc. Da lì ho portato 150 prigionieri a Malaga mi hanno dato questo incarico fra i quali un ragazzo siciliano che era fra i fuoriusciti italiani, dall’altra parte, che abbiamo scoperti in un canneto con una radiolina. E questo qua non l’ho messo con gli altri, l’ho consegnato ai comandi italiani perché gli altri in quel momento lì in Spagna c’erano delle vendette personali che facevano spavento, una guerra, una rivoluzione vera e propria come è accaduto praticamente anche qua dopo il ’40 è successo... la storia si ripete sempre, odii non odii e questi poveri prigionieri quando sono arrivati c’era di tutti i ceppi: anglosassoni, francesi, russi, spagnoli e poi li hanno fucilati perché loro fucilavano con una facilità spaventosa. 98 Appartenevano alle Brigate internazionali? Sì alle Brigate internazionali... e mi ricordo che consegnai questi prigionieri ed esigevo la ricevuta come una merce e sono rimasto molto impressionato da questo perché a diciannove/venti anni certe cose danno anche fastidio, dover dare della gente e vedersi dare un pezzo di carta con la ricevuta, ma io l’ho desiderato perché volevo documentare che i prigionieri erano stati consegnati a un altro militare, però loro mi hanno fatto un «recibo» così alla buona. Così gli ha evitato la fucilazione? Ma chi è che entrava in merito con quella gente lì, erano scatenati, io l’ho consegnato in una caserma, là c’era gente dentro ce n’erano altri poveretti, dico poveretti erano comunisti, poveretti perché li hanno fucilati; la stessa fine hanno fatto altri di Franco quando sono andati di là a Barcellona. Venivano anche torturati i prigionieri? No, venivano presi e fucilati, non c’erano problemi anche dall’altra parte; lì a Malaga rimasi impressionato perché avevano fatto propaganda che noi tagliavamo la lingua ai bambini, agli animali, delle robe così, propagande banali dei comunisti e allora nei canneti trovavamo un sacco di gente, poverina, disgraziati che aspettavano che noi arrivassimo per questo ci temevano, poi quando li vedevamo così ridotti ci commuovevamo gli davamo il rancio, poi una pena vedere dei bambini con tutta la gola ingrossata perché non mangiavano niente, poveretti succhiavano delle canne... è il vero grande dramma e poi abbiamo incominciato a vedere le chiese bombardate, le chiese devastate, i campi santi devastati, le tombe scoperchiate, tutte sté cose... erano comandati male erano poco comandati, non erano molto riuniti, non erano disciplinati come i nostri; insomma i nostri erano più disciplinati, io al mio reparto non avrei mai permesso una cosa del genere e questo è il primo contatto che ho avuto con una guerra strana, una guerra civile praticamente fino a che la guerra si svolge al fronte è una cosa diversa, poi siamo andati a Badajòz, ecc. poi siamo arrivati ad un’altra grande battaglia che era Guadalajara, quindi abbiamo fatto trenta chilometri avanti e tredici indietro: lì è stato un combattimento atroce, specialmente a [incomprensibilie, N.d.R.] proprio vicino a Guadalajara, prima di Guadalajara, e lì ci sono stati dei combattimenti molto violenti e il battaglione di camicie nere poveretto ha subito delle perdite grandissime. Lì cominciammo a sentire le Brigate internazionali italiane, il battaglione «Garibaldi», si cominciò a sentire qualche parola d’italiano e se non stavi attento non c’era un collegamento tra le linee, è stata una battaglia tutta disorganizzata quella lì. Mi ricordo che venne da noi una notte un generale che io non riconobbi, ero in prima linea e venne un generale e feci uscire i miei ragazzi, era come una pattuglia e i miei ragazzi attorniarono questa pattuglia armi alla mano pronti ad intervenire, perché sapevamo che c’erano delle infiltrazioni italiane di questo battaglione che invitavano ad andare là da una parte o dall’altra facendo ritenere che conoscevano l’ambiente e tutto per portarci in definitiva oltre le linee loro; fecero così con un battaglione. In questo guazzabuglio si vedeva una guida, un individuo vestito come un italiano, si fermava chiedeva «voi dove dovete andare, io so dove...» invece era dei loro, e allora noi stavamo attenti a questo perché lo sapevamo, allora il mio comandante, Olivas si 99 chiamava il comandante di battaglione, e questo generale che io armi alla mano portai dal mio comandante Olivas era Bergonzoli «barba elettrica», il quale poveretto con la sua divisione cercava disperatamente di creare dei collegamenti per avere un fronte unico, ma è stata una cosa molto difficile, tutte queste infiltrazioni hanno provocato un po’ di caos e così ci siamo trovati di dover ripiegare di tredici chilometri e noi siamo andati verso Saragozza a riposo e li ci siamo ricreati un pochino perché... molti sono tornati in Italia cioè, avevamo fatto un reclutamento molto veloce in Italia per questa Spagna i reparti camicie nere erano stati reclutati molto velocemente, insomma non c’era un grande... io venivo dall’esercito e vede la differenza che c’era anche come inquadramento, e allora naturalmente, delle persone che vivevano solo di grida e di evviva, quando si sono trovati a dover combattere, dove ci vuole della disciplina di ferro, dove un superiore deve sapere quello che deve fare e dove deve sapere anche trascinare i suoi, sapere decidere se fermarsi o continuare e lì sono i dilemmi che hanno messo in crisi tutti perché non essendo i quadri sufficientemente preparati a questo, è accaduto quello che è accaduto. Dopo di lì sono andato lì vicino a Saragozza, ci siamo rimessi a posto e molti sono tornati in Italia, come le dicevo, e non so dove li hanno mandati, insomma, non è che erano indegni, erano incapaci, erano gente che non valevano la pena tenere in Spagna, insomma, in guerra. Dopo di che hanno chiesto dei volontari per andare al fronte, lì si stava tranquilli, io ero un po’ irrequieto ero giovane così... e allora si sapeva che sul nord c’erano delle brigate italiane miste, fatte di italiani e di spagnoli, che andavano verso Bilbao, che andavano verso Bilbao e io chiesi di andare al nord, che non potevo stare cosi a fare niente. E allora mi hanno mandato alla brigata mista «Frecce Nere» che c’erano il cinque percento di italiani, ed erano tutti spagnoli, i ragazzi che erano lì a combattere. Anche marocchini? No, noi i marocchini non li abbiamo mai avuti, abbiamo avuto solamente spagnoli alle dipendenze ed erano dipendenze nostre insomma perché erano inquadrati da italiani questi ragazzi, questo cinque percento di italiani con il grado di tenente o capitano formavano delle compagnie o dei plotoni; io sono andato al battaglione «Laredo» che era il battaglione d’assalto di questo reparto «Frecce Nere». La massa di questi ufficiali veniva, molti venivano dall’esercito e lì abbiamo fatto la campagna del nord e siamo arrivati fino a Bilbao. Bilbao, io ero lì nel reparto «arditi», nella compagnia «arditi» della brigata e siamo entrati in Bilbao ma poi abbiamo dovuto ripiegare, perché il diritto di precedenza era stato dato a quelli spagnoli del generale Mola, che era un grande generale, militarmente dicevano migliore di Franco, che poi è accaduto... anzi è caduto con un aereo che si è parlato di sabotaggio. A Franco dava fastidio un generale come Mola; lui aveva tutti i «requétés» navarrini, aveva quelli della Navarra poi ha fatto una divisione con quelli della Navarra; eh sì, combattenti di valore. Dopo di lì siamo andati verso Santander e poi la guerra del nord è finita. Poi dopo, è iniziata la campagna dell’Ebro. La campagna dell’Ebro, siamo arrivati fino al mare attraverso anche dei combattimenti violenti, siamo arrivati fino al mare, sempre con la brigata mista «Frecce Nere». Io sono rimasto con quella e al reparto «arditi» di questa brigata. Abbiamo fatto il nostro dovere... poi dopo si è aperto il fronte di Barcellona, e a Barcellona si è concluso tutto. La battaglia più dura è stata rompere 100 il fronte, dividere il fronte, sotto la battaglia dell’Ebro: dividere il fronte di Madrid e il fronte di Barcellona, cioè la Catalogna, che è la parte più delicata dell’argomento. I catalani sono dei separatisti nati, proprio non vogliono saperne, hanno una lingua loro, hanno una cultura loro, hanno una preparazione loro e hanno dei capitali loro come li hanno i baschi. I baschi lo stesso; noi abbiamo combattuto al nord tra mine e tra non mine; da non credere i disastri che procuravano loro ritirandosi, perché erano dei grandi minatori e come grandi minatori, lei vede l’età adesso, sono capaci di mandare una macchina al quinto piano, sono dei minatori formidabili... è rimasto per 48 ore tra due blocchi di cemento insomma una chiesa che è crollata, erano tutti dei maestri nel far saltare degli edifici, peggio del bombardamento di Guernica insomma, quando passavi per un paese minato da loro, trovavi la distruzione quasi assoluta ponti o non ponti... e lì a Bilbao è stato interessante il «cinturone di ferro», il superamento del cinturone di ferro che loro avevano scritto «no pasaràn», non passeranno, che invece dopo ha ceduto. Che cos’era il «cinturone di ferro»? Era come il vallo atlantico praticamente, per loro il cinturone di ferro era un cinturone intorno a Bilbao che nessuno avrebbe potuto superare, invece siamo riusciti a superarlo. Fortificato, ed era pieno di mine, era minato da morire era minato da far spavento, se non c’era l’artiglieria nostra che con delle preparazioni adeguate tagliava i fili delle mine perché eran fatti anche abbastanza semplicemente questi campi minati, però di notte non sapevi dove camminavi e molte volte i fili erano tagliati e ti salvavi, perché c’erano dei tubi di gelatina sotto che facevano paura. Lei è arrivato anche a Madrid? No, non sono arrivato a Madrid, sono stato a Barcellona e poi sono rimpatriato. E l’Alcàzar? L’Alcàzar è caduto quando poi hanno deciso i capi comunisti di arrendersi... la gloria dell’Alcàzar è rimasta intatta insomma praticamente sono usciti questi ragazzi dell’accademia con Moscardò che lì ha perso il figlio. Qui di Gualtieri c’erano molto volontari, molti volontari, ma io non so elencarli, perché proprio non c’ero in quel momento lì, ma molti sono morti che io sappia di vivi c’è Donelli che me lo ha ricordato lei. Prima diceva che per la Spagna avete sbagliato il reclutamento. Perché, come si è svolto? Hanno preso i reparti delle camicie nere volontari e così li hanno mandati in Spagna. Avrebbero dovuto fare un reclutamento diverso, scegliere un pochino, eventualmente... le persone che dovevano rappresentare bene o male l’Italia e non mandar via della gente... e poi soprattutto i quadri della milizia, molti non erano preparati. Esisteva anche un premio d’ingaggio? Premio d’ingaggio io non l’ho mai avuto, avevo uno stipendio italiano e uno 101 stipendio di Franco che mi mettevo in tasca e che spendevo appena potevo. Si parlava di seicento lire al mese come stipendio accreditato in Italia, più la paga di Franco. Sì, ma è stato anche quello ad invitare molta gente ad arruolarsi probabilmente. Quindi secondo lei questo ha contato? Penso di sì, c’è sempre stata della miseria in Italia, non c’è stata mai dell’abbondanza, della ricchezza. Questi ragazzi sono stati, oltre all’entusiasmo anche la guerra d’Africa, tutto andava a gonfie vele e allora in quel momento eroico così clamoroso, queste vittorie italiane da una parte e dall’altra e poi la propaganda che ha gonfiato bene le cose e allora questi figlioli andavano anche... perché là di soldini. Mandavano a casa anche i soldi che ricevevano molti... si potevano anche convertire, volendo, si spendevano perché quando avevo dei soldi in tasca sapevo dove spenderli, ma molti avevano famiglia; io non avevo famiglia, mio papà e mia mamma non avevano necessità, già ricevevano il mio stipendio... Là come si potevano spendere i soldi? Ci sono nelle retrovie, noi quando avevamo riposo due/tre giorni ogni tanto tempo, avevamo le tasche con delle pesetas con parecchi soldini insomma, e allora andavamo in giro, da un locale all’altro prendevamo qualche mezzo per andare a San Sebastian sulle spiagge di San Sebastian, andavamo quasi in linea in taxi addirittura per stare fuori fino all’ultimo momento. Non avevamo problemi economici là. Mangiare, si mangiava bene? Le dirò che mangiare, noi mangiavamo il rancio che facevano loro, perché io avevo gli spagnoli che facevano la cucina, mangiavo molti fagioli e molti ceci perché loro queste cose qua loro le mangiano a spron battuto, pastasciutta niente perché loro non conoscono la pastasciutta... andavamo a mangiare giù quando andavamo al riposo due/tre giorni e mangiavamo lì, nei ristoranti di Saragozza o di Valladolid e cercavamo di trattarci bene, era un retrovia tutta la Spagna, quello che mi aveva impressionato era la spinta patriottica che aveva la gente: le famiglie erano orgogliose di mandare un figlio in combattimento o in guerra. Gli spagnoli che ho conosciuto erano dei franchisti convinti. Io parlo della parte dove era Franco, nella parte dove era Franco non ho mai avuto dubbi su questo, che loro amassero Franco, loro Franco lo amavano, lo inneggiavano e lo amavano. Abbiamo avuto al nord qualche sentore di gente che pensava diversamente, al nord soprattutto, lì in Biscaglia nel santanderino, nelle Asturie e lì abbiamo avuto la sensazione di essere un pochino in casa d’altri e allora... infatti un battaglione di «Gallegos» della Galizia... mi ricordo al mio reparto venne una informazione che si sarebbero ribellati, insomma, e per una notte o due siamo stati molto all’erta con dei fidati un pochino per vedere cosa succedeva. Ma non è poi accaduto niente, dopo qualche giorno sono arrivati degli ufficiali spagnoli che hanno sistemato la questione tirando via qualcheduno, qualche elemento spostandolo da una parte o dall’altra. Ma da noi non è mai accaduto niente di serio, che io ricordi, quello lì è stato l’unico episodio... mi ricordo dovevamo fare un attacco quella notte lì 102 e non lo abbiamo fatto proprio perché pensavano che questi soldati, nostri i «Gallegos» della Galizia, si sarebbero rivoltati, ribellati al regime di Franco, in combattimento quando uno si ribella si volta e spara perché l’unico modo per ribellarsi è quello e allora noi l’attacco, è stato annullato, non abbiamo fatto niente... ma penso che possa interessare questo ambiente non vedo diversamente. D’altra parte se lei va a chiedere a uno che ha fatto le battaglie del Carso perché la guerra ’15-18 è scoppiata non lo sa. Lui sa che ha fatto delle battaglie al Carso e poverino è sopravvissuto cioè, più si va avanti nel combattimento lei deve cercare qualcheduno che è stato ai comandi, anche in Spagna o nelle retrovie, per avere una sensazione più precisa, perché io ero in prima line. Il mio obiettivo era una quota. Facevo solamente degli attacchi di notte, degli assalti di notte, perché andavamo a fare dei colpi di mano di notte... Ma la popolazione come vi accoglieva? Bene, bene, bene... ospitalissimi loro hanno avuto un po’ di ribellione con noi italiani dopo le prime vittorie, ma più che altro non era mica colpa nostra, era colpa dello Stato italiano che esaltava enormemente tutte queste vittorie italiane. Dopo Guadalajara ci sfottevano per via che non eravamo arrivati a Madrid; avevamo un bel da dire noi che eravamo andati avanti trenta chilometri ed eravamo arretrati di tredici solamente, però loro ci sfottevano dopo Guadalajara e a noi questo non è stato gradito, però quando si vive sempre al fronte queste cose non hanno nessuna importanza, che sfottano o meno, lì ognuno fa il suo dovere e basta insomma. La popolazione a noi ho trovato... io ho conosciuto anche delle famiglie spagnole, erano patriottissime, Franco aveva veramente la nazione con lui, parte della nazione con lui a mio avviso, quel poco che ho visto ecco perché le chiedo di prendere contatto con gente che era dietro non davanti come me. Ho difficoltà a rintracciarla questa gente... Eh, lo so... Quindi, i rapporti con i civili erano buoni? Sì, sì, buoni e ospitali guardi in tutte le regioni sono stati molto ospitali; in Andalusia e dappertutto dove noi ci siamo fermati qualche giorno per rimetterci a posto, per riposare così dopo qualche combattimento, qualche battaglia cosi, abbiamo trovato della grande ospitalità e soprattutto dell’amore di patria anche lì, anche lì al nord insomma c’erano delle isole contrarie che dopo è nata l’età, è nata la ribellione cioè non tutti sentivano la propaganda antifranchista, noi abbiamo trovato della brava gente. La «Pasionaria», siamo andati anche a Laredo proprio nella sua casa, mi pare che sia lì e in quella zona lì abbiamo visto la sua casa e allora raccontavano, io penso che siano fandonie, che quella donna lì è venuta in Italia a fare della propaganda antipatica e non aveva il diritto di farlo e dicevano che lei aveva iniziato la campagna contro il clero, praticamente era lei che aveva dato avvio alla campagna contro il clero, uccidendo un prete lei, la Ibaruri, sono episodi questi... Da una parte hanno ucciso Primo de Rivera, dall’altra il grande poeta Lorca. Sono ripicche che hanno avuto tra di loro e non se la sono perdonata mai. 103 E il vandalismo contro la Chiesa? Guardi io posso testimoniare che hanno distrutto delle chiese, fucilato Gesù Cristo, si vedevano i colpi di fucile su Gesù Cristo, tombe scoperchiate, quello lo posso testimoniare. Suore violentate non ne ho mai viste, me lo dicevano, non c’è da meravigliarsi perché è stata una accozzaglia di gente, dicevo, da una parte loro, come c’è stata in parte dalla parte nostra: ma in fatto di violenze loro ne hanno fatte molte e poi c’era una grandissima propaganda sulla libertà, sull’amore libero, sì una grande propaganda, trovavamo molti opuscoli su queste cose e anche libri, capivamo il motivo perché loro... uno si poteva accostare con la donna che gli piaceva senza vincoli matrimoniali o di fidanzamento niente, erano delle violenze, insomma, finalizzate alla distruzione della famiglia. Perché la famiglia per loro era una cosa contraria, lì è lo Stato che è valido, è lo Stato che educa i tuoi figli, è lo Stato che li cresce come vuole lui e che insegna a loro quello che crede. Lei ha conservato del materiale? Macché, macché. Facciamo un passo indietro. La propaganda italiana per preparare la leva per la Spagna su quali punti batteva? Qui non saprei rispondere. Come le dico guardi come è scoppiata la guerra di Spagna c’è stata questa indagine ai reparti, ed è partito un gruppo «X» di ufficiali... Allora perché lei è partito? Il dovere di fare qualcosa per l’Italia d’allora, perché quando ti vengono a dire: «Chi vuole combattere per l’Italia all’estero?» io sono andato. Allora era un po’ una gara per i giovani fare qualcosa, io avevo già chiesto di andare in Africa e non mi presero perché ero troppo giovane e allora quando mi è capitato di andare, sono andato. Non ero neanche certo di andare in Spagna praticamente... Ma perché combattere? Difendere il Mediterraneo dal comunismo sicuramente era il primo obiettivo, quello di difendere la Chiesa è stato connaturato poi dopo con noi quando abbiamo visto quello che succedeva. Loro avevano tutte le armi russe, cecoslovacche, francesi, loro avevano delle armi molto superiori alle nostre, loro avevano delle mitragliatrici che avevano degli alzi azzerati a settecento metri noi avevamo l’alzo... a duecento metri dovevamo già alzarla l’arma; loro avevano dei cannoni che facevano spavento, avevano loro delle armi micidiali bellissime che venivano dal nord, venivano dall’Inghilterra, da tutte le parti e poi armi tedesche, c’erano anche russe, svedesi, avevano dei cannoni, delle armi... bellissime solamente che erano inquadrati male. Ne abbiamo risparmiati molti noi di loro quando venivano avanti, anche disarmati, per punizione, a volte li mandavano anche disarmati sì... dall’altra parte c’era il commissario politico e allora il commissario politico era quello che si faceva temere anche dai comandanti e allora per punizione mandavano avanti dei soldati disarmati. Noi capivamo che erano disarmati poveretti e allora non sparavamo, praticamente la mia parte, io parlo del mio settore, io non ho mai sparato a un disarmato perché è proprio contrario alle mie regole. Io 104 ho cercato di fare una guerra leale e quando alzavano le mani li risparmiavo cosa che difficilmente accadeva a volte con i marocchini, noi ci siamo anche lamentati perché questi marocchini ne risparmiavano pochi. I reparti «Tagor», i battaglioni marocchini quando davano l’assalto erano terribili, erano preparati... avevano diritto al bottino... loro ed erano inquadrati da ufficiali spagnoli. Anche voi avevate diritto al bottino? No, no, loro sì per invitarli a fare le cose, se no è difficile che potessero... li eccitavano anche attraverso la possibilità di... infatti molti marocchini quando avevano finito un combattimento si davano al commercio cioè il loro comando diceva: «Voi rientrare alla base e fra tre mesi ci rivediamo lì, siete liberi per due mesi per esempio, allora loro in quei due mesi lì... che avevano il commercio nell’anima loro, loro giravano per i reparti addirittura in linea sì... andavano in linea per fare il té e lo facevano pagare naturalmente oppure commerciavano altra roba, quello che trovavano. Che garanzia avevano i comandanti che rientrassero? Nessuna garanzia, però loro avevano interesse perché gli promettevano la fucilazione o di rimandarli a casa e loro a casa non volevano tornare... volevano raggranellare dei soldi... i marocchini, ma era simpatico a volte. Lei vedeva un reparto italiano con dietro due tendine, in queste tendine c’erano due marocchini che avevano già combattuto che erano in riposo e facevano il té... facevano delle cose strane... era una grande tragedia, è stata una grande tragedia; è ancora in ginocchio la Spagna secondo me. Hanno ucciso tutti ragazzi di venti anni, è partita una generazione. Le rivoluzioni portano a questo grandissimo scompenso, uccidono la parte migliore. Sono tornato amareggiato un po’ dopo aver visto tutte queste cose. In che anno è tornato? Nel ’38... sono sbarcato a Napoli e poi dopo sono tornato subito a casa qui a Gualtieri; poi dopo nel ’40 è scoppiata l’altra guerra e allora mi hanno chiamato subito al 12° bersaglieri qua a Reggio Emilia e mi sono fatto tutta l’altra guerra fino alla prigionia con i francesi in Algeria nel campo di [incomprensibile, N.d.R.] governato dai marocchini della legione straniera... è stata dura sì. Praticamente sono partito a diciotto anni e sono tornato a più di trenta insomma. Sono partito ragazzo e sono tornato uomo con la testa da ragazzo... È questa la fregatura ho fatto solo esperienze di violenza e di guerra. Sì perché sono tornato a casa definitivamente nel ’46... nel ’45, no nel ’46. Dovrei guardare i documenti. Nel frattempo ero stato promosso in servizio permanente effettivo, ero stato promosso per un concorso di duecento posti, lo avevo vinto e sono andato al reggimento... sono andato in servizio permanente quindi ho continuato la mia carriera, sono arrivato al grado di generale e adesso sono a casa in riposo. Ero generale dei bersaglieri fino a 58 anni. Io ho l’onore di essere stato... non ho partecipato alla... a libri storici ecc. perché ritengo che non si debbano valorizzare le persone ma soprattutto gli atti di valore, ma io sono qui nella storia dei bersaglieri. A 26 anni ho avuto l’avventura di comandare un battaglione di bersaglieri. A 26 anni non è facile comandare cinquecento uomini in combattimento, poi in Tunisia, 105 che è stato un momento terribile in Tunisia qui siamo ad [incomprensibile, N.d.R.] ho fatto tutto anche questo... vede noi bersaglieri abbiamo avuto la sfortuna di non avere una sezione di cinefoto dietro come avevano gli alpini. Loro avevano il cinematografo, a noi non l’hanno data, noi non avevamo tempo... Quando è tornato in Italia la sua partecipazione come volontario alla guerra di Spagna le ha creato dei problemi? La sua iscrizione al partito? No, no e poi io iscritto al partito non lo sono mai stato. Sono stato anch’io epurato per modo di dire, cioè venivamo processati dopo la guerra ma nessuno... sulla base di quello che è stato scritto su di noi... no nessun problema perché i miei amici che avevo qua uno ha fatto il partigiano, l’altro ha fatto quando sono tornato era dall’altra parte, nelle Brigate nere, io non ho mai avuto problemi. E la sua famiglia? C’erano i tedeschi a casa mia, era un comando tedesco in casa mia, mi sono salvato perché io avevo avuto delle decorazioni tedesche, io ho la croce di ferro di prima classe e quella di seconda classe datami da Rommel personalmente e quindi io avevo mandato a casa i documenti e i tedeschi che erano in casa vedevano i documenti e allora... È un paese amico questo qua per me, ho sempre salvato capra e cavoli, me la sono presa anche con il segretario politico perché non ho mai capito certi atteggiamenti: l’olio di ricino, l’atteggiamento di obbligare la gente a comperare il «Popolo d’Italia». Quindi lei non fece mai la tessera? Io non ricordo di averla fatta, ricordo di avere avuto una tessera da balilla nel ’22 e pensi un po’ anche quella storica l’ho persa. Io non ho mai avuto problemi, con me sono rimasti amici tutti io ho cercato di aiutarli tutti dopo... servizio militare e non servizio militare, tutta brava gente e poi in definitiva questo è un paese tranquillo, paese che ha dato moltissimi volontari, però non c’è stata violenza in questo paese, la violenza c’è stata per colpa di altri che sono venuti da fuori... durante il periodo partigiano... sono venuti da fuori per potere... e qualcheduno è stato ucciso poveretto e poi una famiglia, la famiglia Rossi è stata distrutta dalle truppe russe [germaniche, N.d.R.]. Tornando alla Spagna. Le riesce a distanza di cinquant’anni a fare un bilancio? Penso che siamo arrivati fino qua in queste condizioni anche per questo, proprio per questo, la Spagna era diventata un baluardo che ci ha permesso di vivere in completa libertà. Assolutamente senza dei principi che possano imporre alla società una certa linea d’azione, che non è conforme ai principi della libertà; io non apprezzo... la gente scappa da Est verso Ovest, non da Ovest verso Est, e allora è significativo questo qua mi sembra, quindi noi abbiamo evitato questo con la guerra di Spagna che poi ci siano state delle correlazioni e ripercussioni negative o strane che poi accusino l’Italia di aver dato alla Spagna delle armi vecchie della prima guerra mondiale, proiettili che non scoppiavano, questo è anche vero perché abbiamo scaricato i 75 del deserto... Chi ha fatto la guerra lo sa perché facevamo preparazioni d’artiglieria vedevamo, ma che 106 sia stata... e poi quello che è più bello in questa guerra di Spagna è l’insegnamento che ha dato che andrebbe segnalato a tutti ed è importante: tutti i caduti per un’idea e per la patria sono dello stesso livello nella valle de «Las Caidos», a Madrid ci sono tutti dentro, comunisti e fascisti abbracciati. Franco non ha fatto distinzioni, li ha messi tutti insieme e questo è un insegnamento secondo me che dovrebbe essere di carattere storico... Quando muori per un ideale, sei un uomo degno di considerazione, quando muori vuol dire che hai dato tutto te stesso per questo e quindi questo sacrificio immenso, questo immolarti per questo ideale... Lei non ha mai pensato alla morte? Non perdi di vista questo particolare, perché se in combattimento uno pensa a questo può diventare anche un vigliacco, deve essere leggermente fatalista perché se no... Io sapevo di partire e potevo non tornare. Diventa un’abitudine un pochino il pericolo, cioè diventa abitudinario essere nel pericolo, però a volte devi dare qualche scrollata di spalle se no puoi diventare anche un vigliacco, di fronte ai propri uomini non è possibile fare così, noi poi nel nostro corpo siamo abituati a trascinare. Il ricordo più bello della Spagna? Guardi spontaneamente non le saprei dire, potrei dire la fine di un combattimento vittorioso, quando c’era un’azione difficile da fare che si risolveva, il momento più bello era quando dopo l’azione mi mettevo intorno i miei ragazzi e ci guardavamo in faccia e c’eravamo quasi tutti, quello era il momento più bello e io ho fatto così anche in questa guerra, ho cercato sempre di aiutare chi sbaglia e di evitare di fare morire stupidamente della gente, non è più il momento di dire «ho avuto tante perdite e merito tanto», io dico che è indirettamente proporzionale alle perdite il valore, cioè o sei un incosciente e allora... Il ricordo invece più brutto della Spagna? Un brutto ricordo ce l’ho quando hanno ammazzato il tenente... che ha fatto in tempo a dire «mamma!» e poi è crollato; questo è un brutto ricordo, che ho poi dei brutti ricordi ne ho, perché avevo degli amici che partivano per un combattimento che sembrava stupido e non tornavano più. I ricordi brutti sono di quando perdevo qualcheduno per me era strappato il cuore quando perdevo uno dei ragazzi così. Che grado aveva lei in Spagna? Sottotenente, ma io avevo il grado di tenente. Ci davano il grado agli ufficiali italiani, ci davano il grado di tenente perché sottotenente là era una stelletta sola e c’era l’Alferez, l’Alferez che era un aspirante ufficiale, diciamo, allora a noi davano il grado di tenente. Che sentimenti provava a combattere in Spagna contro suoi connazionali, come per esempio a Guadalajara? Per lei che era un patriota? Potrei dire tranquillamente che avrei potuto avere più odio che per gli altri perché lo stesso succedeva a loro, che si erano messi contro gli stessi italiani, ma se avessi fatto dei prigionieri li avrei risparmiati indubbiamente, come ho sempre fatto, ma in combattimento non avrei esitato perché non fai in tempo a guardare. 107 Quindi lei non si pose problemi per la presenza di italiani come nemici? Sì, me li sono posti prima del combattimento e dicevo guarda un po’ perché si deve arrivare a questo punto, di batterci tra di noi ma quelli erano degli esagitati... come noi d’altra parte; loro la pensavano diversa da noi e quindi ci battevamo per qualche cosa e ognuno pensava di avere ragione... ma senso di vendetta... no... A Tortosa, per esempio, sull’Ebro dove siamo stati, quando siamo arrivati a [incomprensibile, N.d.R.] per cui avevamo proposto di fare uno sbarco al di là dell’Ebro e di tagliare fuori tutto il gruppo degli italiani nell’ansa dell’Ebro e allora e allora potevamo prenderli tutti ma non è stata accettata, sarebbe stata una bella cosa perché avremmo fatto dei prigionieri e ci sarebbero stati meno morti, ma Franco non lo ha accettato, perché c’era sempre questa punta d’invidia, se noi facevamo qualche azione bella un po’ brillante ci rimanevano male. Franco non si può dire che fosse invidioso certo è… vede la propaganda italiana ci picchiava dentro, noi avevamo di grandioso l’aviazione; pochi apparecchi ma... avevamo l’asso di bastoni: la squadriglia «Campoforbi» dove avevamo i gobbi, gli 81 e gli S81 da bombardamento, ma erano i caccia che erano spettacolari... loro avevano dei caccia superiori; loro avevano i Rata [Polikarpov I-16, aereo da caccia sovietico N.d.R.], erano russi, erano più veloci dei nostri però i nostri erano molto più abili e quando c’erano dei combattimenti aerei eravamo tutti fuori dalle linee... Vedere i nostri volteggiare per aria... un aereo nostro è riuscito a stare in coda ad un russo e lo ha fatto atterrare al campo di Badajòz senza sparargli standogli in coda e poi dopo ha fatto delle acrobazie sul campo e naturalmente i comunisti hanno dovuto battere le mani. Si parlava di politica in Spagna? Non avevamo tempo di parlare di politica; non si parlava di cosa può succedere, cosa può non succedere. Io dico che oltre l’entusiasmo di fare qualche cosa per l’Italia d’allora per quel momento particolare non c’era niente che potesse interessare. Noi avevamo alle spalle un’Italia che sembrava una cosa colossale... enorme... un impero, una potenza e pensavamo che fosse così... che dopo ci siamo accorti durante la seconda guerra che non era così purtroppo e allora non si pensava alla politica... Si poteva dire gli altri che faranno, ma non noi cosa faremo; noi su quella strada e pensavamo che fosse la strada migliore, ci avevano insegnato quello e praticamente poteva essere anche giusto, che fosse giusto poi lo abbiamo visto che non era così, perché dopo l’impreparazione della guerra mondiale abbiamo visto cosa c’era. Abbiamo visto che, per cercare una divisione per mandarla in Russia, Mussolini ha girato mezza Italia e si è dovuto anche arrabbiare... e allora vuol dire... la politica era entrata nelle file delle forze armate e che non doveva entrarci. I tedeschi in Spagna avevano sperimentato gli aerei, delle armi, dei forni, noi abbiamo sperimentato niente; loro avevano dei sottoufficiali per esempio, vestiti da sottufficiali, che erano degli ingegneri che guardavano che cosa si poteva fare per sfruttare in Spagna, qualche cosa per chiedere a Franco qualche cosa perché sapevano cosa chiedere a Franco... il nord della Spagna è ricchissimo, loro avevano dei sottoufficiali tecnici... ingegneri minerari e tutta quella gente lì, avevano al loro seguito, avevano un’armata di scienziati, di specialisti per sfruttare al massimo tutto, noi no. 108 Ma è vero che eravamo male equipaggiati in Spagna? In Spagna avevamo roba della prima guerra mondiale, noi avevamo le carrette ancora, ma noi abbiamo incominciato questa guerra con il 18BL; questo sta a significare... immagini cosa c’erano tre o quattro anni prima in Spagna. 18BL con le gomme piene con la tendina davanti sopra era degli anni ’12-13... Noi per arrivare a [incomprensibile, N.d.R.] prima dei tedeschi abbiamo camminato giorno e notte per due o tre giorni senza dormire, sono caduto tre volte addormentato in motocicletta per arrivare prima dei tedeschi a Monstar con degli autocarri. Così loro ci passavano davanti di giorno e noi continuavamo giorno e notte ad andare e intanto li superavamo... siamo arrivati primi lo stesso. Loro ci passavano con il rancio che facevano il rancio tranquillamente noi per il rancio dovevamo fermarci, tirare giù i bidoni stagnati e fare il rancio... Le marmitte da campo... quelle cose lì loro avevano la loro cucina con i reparti corazzati e motorizzati che erano una meraviglia con tutte quelle moto lì impermeabili... noi... chi le ha mai viste impermeabili... siamo arrivati in Africa c’erano le mosche che ci uccidevano... i tafani in Africa, c’erano delle miriadi... uno non poteva fare così che venivano giù dappertutto, loro avevano la retina già per le mosche, noi non abbiamo mai avuto la retina o se qualcheduno dice che non era vero, era la retina ai comandi o dietro perché io di retine dalle forze armate italiane non ne ho mai avute... ci davano della pomata scura per gli occhi perché si infiammavano gli occhi. Avevamo paura del tracoma perché lì in Africa c’è il tracoma che può portare anche alla cecità... Per dirle che c’è stato qualcosa che non ha ingranato ed era veramente una cosa di coscienza. Anche in Spagna più che la tecnologia è stato l’entusiasmo...? È stato il valore e la capacità dei reparti inquadrati bene e non la forza vera e propria delle armi, noi avevamo le mitragliatrici FIAT 14 della prima guerra mondiale, quelle ad acqua e in Africa avevamo i fucili mitragliatori che li buttavamo via i nostri e prendevamo i «bren» inglesi perché con i nostri non si sparava... Il contributo italiano fu fondamentale alla vittoria di Franco: abbiamo insegnato un tipo di guerra a loro che non conoscevano, lei deve sapere quando abbiamo trovato il fronte così fermato, bloccato; si scambiavano le sigarette la domenica e chiacchieravano tra di loro, la domenica era difficile che si combattesse... Alla «domingo descanso»: riposavano, si scambiavano le sigarette sulla linea... Dopo noi abbiamo tolto questa mania combattendo, a loro abbiamo rotto un pochino l’ambiente in quel modo lì e poi quando abbiamo fatto l’azione di Malaga. L’azione di Malaga è importante perché abbiamo tagliato una fetta di Spagna direttamente. Senza guardare né a destra né a sinistra siamo piombati su Malaga ed è finita lì la cosa e allora loro non avrebbero mai pensato... facevano una quota poi... starebbero ancora facendo la guerra loro... una mentalità così. Atti di valore indescrivibili gli spagnoli sono di... getto. Io ero proprio nei reparti d’assalto ma dovevo tenerli a freno. Erano proprio ragazzi in gamba; perlomeno i miei hanno combattuto molto, ma molto bene. Io non posso che dir bene. 109 Alcide Spaggiari Classe 1904, avvocato. L’intervista è stata registrata il 15 marzo 1988, nel suo studio. Alcide Spaggiari nel 1938 diventò segretario del GUF e componente effettivo del direttorio federale. La sua è quindi una testimonianza che proviene direttamente dall’interno del potere politico. Vorrei ricostruire con lei l’opinione pubblica di quegli anni, partendo dalla sua esperienza, dal suo osservatorio privilegiato. Dalla cronaca del «Solco» è assente la guerra di Spagna, c’è un elenco dei caduti che viene pubblicato nel ’39 e poi ripreso nel ’40 e poco altro... C’è l’esaltazione di alcuni che sono caduti, alcuni di primo piano, non so, per esempio il capitano Bottazzi che morì in un incidente aereo; poi c’è l’esaltazione di... come si chiama... Degli Incerti, che cambiò nome e diede nome alla sua famiglia Degli Incerti Tocci poi dopo morì in un incidente a Rimini... o a Riccione. Ma in generale allora non se ne parlava molto, cioè, la stampa metteva in risalto gli orrori, diciamo così, della parte avversa... degli spagnoli nemici di Franco, ma che se ne parlasse molto... no. E forse la ragione, io penso, è che l’intervento di Spagna è sempre stato un intervento simulato, non è mai stato un intervento ufficiale, perché in fondo in fondo se noi pensiamo a modo, il fascismo diceva che in Spagna si era fermata l’avanzata comunista. Francia e Inghilterra sembrava che non la pensassero così, però gli aiuti ai nemici di Franco non ne hanno mai dati. È una delle lamentele dei comunisti, cioè di quelli che combattevano... era questa mancanza di aiuti. Insomma, si vede che la partita si giocava su un tono politico, diciamo così, di «dico non dico»; tant’è vero che dall’Italia non abbiamo visto partire dei reparti... come partivano per l’Africa. Per l’Africa abbiamo visto partire... non so, mi pare due battaglioni di camicie nere, un gruppo d’artiglieria, ecc. in fila, scortati: quella era la guerra aperta, là non era più così. Io non riesco neanche a capire, ho avuto qualche amico, qualche cosa... come siano andati, se siano andati volontari scelti nei reparti, o se li abbiamo mandati, anche perché reparti combattenti, oltre le camicie nere non ce ne sono andati, c’è andato qualche gruppo di artiglieria... purtroppo c’è andato anche un mio carissimo amico, che poi lo hanno ammazzato nel ’45, Mirotti, era un mio caro amico... .... che tornato dalla Spagna diceva «Di rossi ci sono rimasto solo io»? L’ha scritta a me, dietro a una fotografia «Di rossi ci sono rimasto solo io», perché era rosso di capelli. Ma Mirotti dice «io ho saputo di andare in Spagna quando sono arrivato là». Allora c’era questo vasto movimento verso l’Africa e allora molti ufficiali... Poi c’era anche un gruppo notevole di ufficiali che in Africa erano diventati ufficiali 110 effettivi. Ora, a questi io credo, che si potesse anche imporre, o per lo meno far forza, per mandarli in Spagna. Gli ufficiali diventati effettivi in Africa erano moltissimi, ma in Africa andavano giù con entusiamo, era un po’ un modo di sistemarsi, ma perché bisogna pensare che allora tutti i diplomati e i laureati facevano i corsi allievi ufficiali, arriva l’Africa, c’è stata un’ondata di gente che è andata giù, per esempio non so... il generale Lasagni poveretto che è ancora qui, è andato giù come ufficiale di complemento, il mio amico Franzoni che è morto l’altro giorno, e che è poi tornato su perché passò comandante della guardia alla frontiera, il fratello del senatore Franzini, quello che adesso è in Cile, che era diventato colonnello, il povero avvocato, non povero deve essere vivo ancora, erano andati in Africa però si erano conquistati queste posizioni. Io penso che qualcheduno sia stato sollecitato ad andare là, dico lo penso, perché allora non se ne parlava; ad un certo punto si sapeva che era partito uno, che era partito un altro, ma in genere gli ufficiali superiori… Lei che era un intellettuale già allora, ho trovato un suo articolo del ’34 intitolato Fascisti universitari e giovani fascisti sul «Solco Fascista», lei era responsabile del GUF e poi...? No, io sono stato segretario del GUF e vicepresidente dell’Istituto di cultura, quindi come segretario del GUF, oltre ad accogliere gli studenti universitari ed agevolarli, qualcheduno mi ha fatto anche dei riconoscimenti, come Landini che non sarebbe andato all’accademia se io non avessi detto che lui era fascista, perché non avrebbe potuto esserlo nel senso che non era venuto dai fasci giovanili, l’ha detto nel libro di cos... il mio amico Leonardi... ad ogni modo noi come GUF più che altro, organizzavamo gli universitari e una delle attività più notevoli era quella di organizzare i Littoriali del lavoro, ed erano interessanti è stata una bella azione, cioè facevamo delle gare di lavoro fra gli operai dei diversi cos, nominavamo... cioè facevamo fare dei concorsi locali e il primo che risultava a Reggio lo mandavamo a Roma, se a Roma uno diventava primo, diventava littore aveva l’M d’oro... che lo ha avuto Leonardi, lo ha avuto... aspetta pur quell’altro che era al Consorzio agrario... in un anno so che ne ho avuti quattro, Alcide Farri, Leonardi e quell’altro come si chiamava... e questa è una bella attività. Poi l’altra attività, quella dell’Istituto di cultura fascista, noi davamo, come GUF, molti dei relatori che al sabato andavano nelle diverse sedi a fare delle conferenze, ci andavano i Dossetti, ci andavano... ci andavano tutti, sui sindacati, sulla previdenza sociale, ecc. Ricordo un particolare curioso ed interessante, il mio amico Manghi Mariano, il padre dell’assessore in Comune, aveva fatto una bellissima relazione sulla previdenza sociale, perché ci eravamo laureati insieme e sperava di entrarci. In guerra è andato tra i partigiani, ha avuto dei guai; dopo la guerra quando lo vedo, gli dico: «Guarda che c’ho ancora quella relazione che mi hai fatto vedere...». «Me la dai...». Infatti gliel’ho data e l’avrà distrutta. Questa era un po’ la nostra attività; ma lì nel periodo della guerra, diciamo così... passava sopra di noi, non se ne sapeva. L’opinione pubblica era messa al corrente degli orrori degli eroi repubblicani spagnoli, delle violazioni dei conventi, delle stragi, delle uccisioni, ecc., ma sulle vicende guerriere non si sapeva mica molto. Così anche per quel che riguarda, non so, i volontari. Io a un certo punto ricordo che era partito, ed era uno che partiva sempre, Patroncini. Era un impiegato dell’ospedale, un maestro elementare che, venuta l’Africa, era tenente della milizia, è 111 andato in Africa, venuta la Spagna è andato in Spagna, venuta la Russia è andato in Russia... un valoroso, ed è sopravissuto perché poi si era impiegato alla Camera di commercio di Milano, è morto quattro o cinque anni fa. E ricordo che quando tornò dalla Spagna, noi facemmo un po’ di festa, fra amici, ma niente di ufficiale, e il povero dottor Manfredo Manfredi, era quello che era amministratore, stava a Como per la verità, era amministratore della Banca commerciale italiana, era un po’ il factotum, uomo intelligente, medico, ma non ha mai fatto il medico, è sempre stato un gerarca di quelli... di quelli che ha fatto anche i quattrini bisogna dirlo; ricordo che diceva: «Patroncini – era carico di decorazioni – aveir il tuo giubét e la mia testa...». Fra l’altro è diventata famosa... Ma come dico erano queste figure, per esempio Bottazzi; io non ho mai saputo come Bottazzi sia andato giù. Bottazzi, era il capitano Bottazzi perché era capitano delle Reggiane perché era centurione della milizia. Io ho saputo che era in Spagna, sì che lo conoscevo, quando ho avuto la notizia che al ritorno della Spagna è precipitato con un aereo, anche lui era della milizia, ufficiale superiore della milizia. Ma come mai non riusciamo adesso a trovare un elenco dei reggiani che parteciparono? È quello che mi domando anch’io. Ci pensavo in questi giorni dopo che mi hai telefonato, perché per esempio noi vediamo che in provincia c’è la lapide di quelli rossi, cioè di quelli dell’altra parte della guerra di Spagna; qui forse non hanno fatto in tempo a farla, ne sono caduti anche di Reggio; forse non hanno fatto in tempo ad organizzarla, perché tra la fine della guerra di Spagna, poi lo scoppio dell’altra... oppure non so, non c’è stato un interesse adeguato... Per una lapide sì, ma per un elenco... Ma un elenco dovrebbe esserci, ma resta da vedere questo elenco chi lo poteva fare. Per esempio il comando della milizia, poteva fare l’elenco dei suoi, l’esercito i suoi, ma non è che ci fosse un istituto che li congiungesse, in federazione non mi consta che ci fosse una cosa del genere, non c’era, in federazione... la federazione organizzava altre cose, una cosa del genere non c’è mai stata. Quindi si parlava solo in maniera ufficiosa di questo periodo? Anche all’interno non è che fosse così compatto anche il pensiero. Certo ufficialmente la cosa era quel che era, però si sapeva ad esempio che in quell’epoca lì, subito dopo la guerra d’Africa, d’Abissinia, c’era stato un tentativo d’avvicinamento, il famoso viaggio di Eden a Roma, quindi era una cosa sulla quale almeno la stampa, il pensiero ufficiale, evidentemente doveva andarci adagio. Quella di Spagna per me è passata, io dico che la guerra di Spagna per me è passata... non me ne sono accorto, anche nei riflessi interni proprio... non c’era niente, non c’era niente. Nelle vostre riunioni, nei vostri momenti di aggregazione, non ne parlavate? Si sentiva qualche discorso, qualche cosa, ma non c’era niente. Perché a un certo punto per esempio in quel periodo lì, io ero segretario del GUF, all’interno si parlava piuttosto di un cambio nell’indirizzo generale, era il periodo di Starace, era il periodo della ginnastica nei cerchi di fuoco, ecc., e si sperava da parte nostra che il cambiamento 112 fosse in senso di dare una importanza maggiore agli intellettuali, tant’è vero che io, questo è il ricordo che ho... L’ultima volta che sono stato a rapporto a Roma su a palazzo Vidoni, all’ultimo piano da Mezzasoma – Mezzasoma che è andato a morire volontariamente con Mussolini, anche se nessuno lo avrebbe trovato, anche perché prevalendo le idee contrarie cioè intellettuali, cioè lo chiamavano «mezzasega» questo per dire, ed era un amico carissimo con il quale sono stato in rapporto fino all’ultimo) – disse: «Pare che sia la volta buona». Ed era la volta che pensavano tutti a Bottai, invece, ci fu il cambio di Starace, ma venne Muti cioè venne la corrente più intransigente, più squadrista più cos, che la corrente che voleva essere intellettuale. Questo era il problema tra la guerra di Spagna e la guerra si sentiva. Ma la guerra di Spagna non ha... secondo me non ha lasciato il segno di una certa presenza nell’opinione pubblica, poi del resto se tu hai letto i giornali, hai visto che non se ne parla. Ma è vero che durante la guerra di Spagna assistiamo a un rafforzamento delle forze antifasciste. Che a Reggio parecchi giovani comunisti, a partire dal ’36, si inseriscono nei GUF? Non ricordo la data esatta, ma quando ero io segretario del GUF, successe a Reggio il fatto di Poppi. Poppi che poi durante il partigianato diventa il partigiano Davide, quello che ha scritto anche Il commissario, che poi lo hanno tolto dal cos perché parla addirittura diretto delle cose, dei modi di concepire... dell’estremismo comunista d’allora, perché Poppi scrive nel suo Commissario, era in vendita alla [libreria, N.d.R.] Rinascita, e a un certo punto lo hanno tolto e io sono riuscito a prenderlo, a un certo punto si lamenta che i giovani erano disposti nei primi anni dopo l’8 Settembre del ’43 a far saltare un ponte, ma non si azzardavano ad affrontare uno e a sparargli in faccia, poi dice «invece dovremo favorire questa forma di guerra per suscitare le reazioni anticomuniste». Quindi era proprio uno che guardava la fine in questo modo qui, ora il fatto, Poppi fu l’unico fatto che successe quando io ero segretario del GUF. Io ero amicissimo di Poppi, tant’è vero che nel periodo in cui non ero ancora a Reggio, prima del ’37, perché la mia famiglia era ancora a Puianello, avevamo una stanza insieme come alloggio; Poppi era segretario del Fascio di San Bartolomeo, ufficiale della milizia, ecc... Improvvisamente Poppi si scopre che era a capo di una cellula comunista, era a capo di una cellula comunista che lavorava soprattutto nel campo delle Reggiane, delle officine ecc., è stato arrestato e processato a Roma. Ricordo che il federale Bolondi me lo disse; Poppi io lo vedevo al circolo del «Casino» a fare una partita ecc., me lo disse una sera che mi prese e disse: «Sai cosa è successo a Poppi?». «No!». Al dìs: «È stato scoperto, lo hanno arrestato e adesso noi diciamo che si tratta di un incidente stradale, ma non lo potremo tenere nascosto per parecchio tempo». Questa la mentalità di allora. Poi fu processato a Roma, tant’è vero che io ricordo che feci anche quasi un falso, l’ho poi detta a Poppi dopo, perché Bolondi a un certo punto mi disse: «Guarda, c’è il processo di Poppi a Roma, lo difende lo zio di sua moglie, che è il vecchio avvocato Borsiglia», dice: «Mi hanno chiesto se è vero che Poppi abbia fatto domanda di andare volontario in Africa a suo tempo». Gli ho detto: «Guarda al GUF non c’è niente, però quando l’avvocato Mariani mi ha dato le consegne del GUF, mi ha detto che tutti gli universitari che avevano delle cariche politiche avevano fatto domanda di andare in Africa; questa è la dichiarazione ufficiale 113 che lui ha fatto nel discorso di consegna a me. Ora se vuoi che ti dichiari che risulta al GUF che ha fatto domanda di andare in Africa lo dichiaro, non ho documenti specifici, ma te lo posso dichiarare». E l’ho fatto. Non so se gli sia servita al processo, Poppi non mi ha saputo neanche dirmi... ma quello è stato un fatto di notevole importanza, perché gli studenti universitari, perché lui era già laureato, non c’era solo Poppi, ma c’era una quantità di ragazzi delle Reggiane, mi pare dieci o dodici che sono stati arrestati, processati, tant’è vero che quando è scoppiato l’8 settembre, Poppi è stato condannato, non so se a diciannove o venti anni, Poppi avrebbe potuto scappare perché era in un ospedale in... là in un ospedale in Piemonte, ed è scappato; poi dopo è venuto e ha fatto tutta la Resistenza, era il commissario temutissimo e potente di tutta la zona dell’alto Appennino reggiano. Quello è un fatto realmente accaduto, in quel periodo lì, ma la Spagna non c’erano. Erano anzi gli anni del consenso, perché dopo il periodo della guerra d’Africa effettivamente tutti i grandi dissensi erano scomparsi, era il periodo migliore, quello lì era il periodo in cui la gente si era lasciata veramente trascinare. Io ricordo sempre questo episodio: nel periodo della guerra d’Africa io ero allievo ufficiale a Moncalieri, perché io ho fatto l’allievo ufficiale dal ’35 al ’36, poi dopo ho fatto il servizio qui al 3° artiglieria, prima di diventare segretario del GUF. Beh, io ricordo che la sera del 5 maggio, mi pare, dopo la presa di Addis Abeba, il giorno insomma della vittoria definitiva della guerra di Abissinia, ho visto a Reggio un episodio che mi ha impressionato. Le truppe erano uscite dalla caserma, han fatto tutta la via Emilia, ben inquadrate, colonnello a cavallo in testa ecc., per arrivare davanti al monumento dei caduti a rendere omaggio... la città era piena in un modo che non si immagina. Al ritorno non c’era più l’esercito, c’eran dei soldati con le canne dei fucili con dei fiori che cantavano e che urlavano. Io ero nel periodo, avevo atto il corso allievi ufficiali e aspettavo la nomina, infatti, la nomina è arrivata il 1° giugno, ricordo che mi trovai vicino l’uomo più austero, che mi faceva paura, che era l’avvocato Leuratti, il padre dell’attuale avvocato Leuratti, presso il quale avevo fatto la pratica legale. Un uomo che non parlava mai, aveva però due medaglie d’argento della prima guerra mondiale, era nella brigata «Sassari». Era vicino a me che cantava... cantava, quando mi ha visto è arrossito; per dirti l’entusiasmo che aveva suscitato, del resto i giornali lo dicono, tutti i giornali lo dicono che era il periodo del maggiore consenso, che era il periodo del maggiore consenso. Quindi, io ti posso assicurare che nel periodo che io sono stato al GUF... In che periodo c’è stato al GUF? Non me lo ricordo neanch’io. Dunque, io ho finito di fare il servizio militare il 31 dicembre del ’36, credo che sia stato dall’estate del ’36, fino al ’38, mi pare. È un periodo in cui le cose sono andate con la maggiore tranquillità, io non ho avuto un sol caso di ragazzi devianti; e poi nel GUF c’era sempre un clima goliardico, non prendevamo sul serio probabilmente, cioè eravamo convinti, facevamo... Però, proprio nel ’36-37 iniziano, così si dice, i sabotaggi alle Reggiane degli aerei che partivano per la Spagna, gli arresti dei comunisti che raccoglievano fondi per la Spagna rossa... Quello lo si diceva, l’ho sentito dire però non ho visto niente, non si è visto niente; un vero sabotaggio c’è stato, ma c’è stato durante... Nel ’41 quando è morto Scapinelli, 114 che è stato un sabotaggio, quando è morto il colonnello Scapinelli, ma era nel ’41 perché ricordo che io avevo soldato sotto di me suo fratello e ho ricevuto e ho detto: «guarda è successo questo e questo» per dargli la licenza e mandarlo a casa subito; ma prima se ne era sentito parlare ma... almeno allora non risultava, ecco. Poi erano cose che non interessavano certamente noi del GUF. Noi facevamo le nostre manifestazioni. Ricordo io feci venire allora Marinetti, che per poco non mi procurò delle grane, sì perché io lo feci venire e nel salone della casa del fascio (c’era un gran salone che adesso non c’è più, che lo hanno buttato giù, dove adesso mettono le macchine i carabinieri); Marinetti, naturalmente Marinetti, fischi, urla, ecc. Un federale lì su che sentiva mi chiama: «Ma cosa succede?». È un genere che Marinetti le vuole così, dico, infatti, urla, c’era il vecchio Pino Garavelli con la cravatta di latta, ecc., urla ecc., e ci ha parlato di tutte queste cose e tutto è andato bene: entusiasta Marinetti, entusiasti gli altri, riunione in cui Marinetti parlava più serio nella sala del circolo «Casino», il prefetto in prima fila. Ad un certo punto mentre parlava, e parlava della necessità di demolire i vecchi modi di fare, le vecchie retoriche ecc., e a un certo punto prese la parola l’avvocato Strozzi. Era un tipo strambo e originale; non so se era iscritto al fascio, ma non credo. Domanda la parola e dice: «Io desidererei sapere come Marinetti concilia queste idee con la sua feluca di accademico d’Italia?». Il prefetto... fischi e il prefetto lo fa cacciare fuori dalla sala. Questo è l’unico episodio che io ricordo, ma altri episodi non ce ne furono. Vi fu un episodietto, ma lì non riguardava il GUF, non riguardava niente. Cioè, una volta mi chiamò il federale e mi disse: «Va a vedere cosa è successo ieri sera a Campegine». A Campegine la sera prima era successo che un segretario del fascio, nuovo, mandato lì (era uno anche molto duro), insomma, aveva preferito dare l’olio di ricino a due che non so cosa avessero fatto; e quei due glielo hanno buttato se non in faccia, per terra, insomma non lo hanno preso, e allora voleva denunciarlo, perché c’era la questione di cui si è discusso, se il segretario del fascio era un pubblico ufficiale, altrimenti ci sarebbe stato reato. «Vai a vedere cosa è successo». Io vado a Campegine. A Campegine c’era un mio amico, poveretto, gh’iva un oc ed véder, era comandante del fascio giovanile, ma lo conoscevo perché eravamo stati in collegio insieme, un certo Brugnoli, «Cosa è successo l’altra sera, dimmi tu, tu c’eri?». «Ma sai, il segretario ha esagerato, buona gente, una cosa e l’altra, li ha offesi, li ha minacciati ecc., e loro non è che gli hanno buttato in faccia l’olio di ricino, lo hanno buttato per terra». E mi ha fatto vedere dalla finestra che c’era ancora la macchia. E allora io venni a Reggio e dissi a Eugenio: «Guarda, a me pare che abbiamo esagerato nel dire le cose, le cose si sarebbero svolte così...». «Ma sai...», il Bolondi era giovane, non era alla marcia su Roma e quindi con i vecchi squadristi faceva fatica a barcamenarsi con loro; «Ma – dice – sai, Pietranera, ecc., lo vogliono denunciare, vogliono fare il processo… io non lo farei». Fatto sta, che venne fatto il processo e furono assolti, furono poi inviati al confino ecc. e fu uno dei colpi peggiori per Bolondi, ma era un fatto così di periferia, altri fatti io non ne ho. Per esempio, io feci l’assemblea annuale del GUF, che venne presieduta da Pallotta, che allora era il segretario nazionale dei GUF, col teatro Ariosto pieno, entusiasta, ecc., ricordo che uno dei più entusiasti era il mio amico Arrigo Negri, quello che è sempre stato poi funzionario della federazione comunista, quello di Novellara, che è morto una decina di anni fa, un entusiasta, era uno dei più originali per fare un po’ di casino, fatto sta che facemmo questa cosa qui. Io feci la relazione 115 (quando Vaiani ha fatto la mostra ho visto anche le fotografie, simpatiche) e restammo impressionati tutti perché a un certo punto Pallotta disse: «La nostra generazione non è destinata a morire fra due lenzuola». Poco dopo, sette/otto mesi dopo, partì per l’Albania e morì appena arrivato in Albania. Era il conte Pallotta di Torino, un uomo... Era un mondo così, di entusiasmi forse senza pensarci; si accettavano le cose come erano... non so se ci fosse qualcheduno... per esempio io ho sempre sentito dire, dopo, delle riunioni che si facevano alla libreria Prandi, alle quali avrebbe partecipato i vari Cocconi, Maramotti, Cucchi, Valdo Magnani, ecc., l’ho sentito dire dopo, prima non ho mai sentito niente. Io Magnani l’ho avuto come collega, abbiamo fatto tre anni, due anni di guerra insieme nello stesso reparto... soltanto che sette/otto giorni prima dell’8 settembre lui era giù nelle Bocche di Cattaro, è scomparso ed è andato con i partigiani, con cui si vede aveva già da prima dei contatti. Ma di questa azione qui... io dopo lo ho sempre sentito dire, non l’ho mai negato, non ho mai detto di no, perché non lo sapevo; non è che fossi un cretino, non mi interessava, pensavo a tutte altre cose. Certo che Prandi dice che si riunivano lì, e lì si riunivano Degani... Ricordo, che nello studio di Degani per delle riunioni parlando di letteratura, ci sono andato tante volte anch’io, ma non ho mai avuto la sensazione di questa fronda, che ci fosse, a meno che non sospettassero di me perché ero segretario del GUF e non me lo dicessero. Era una vita così serena, così... se tu pensi, per esempio, che io andavo a raccontare al federale tutte le barzellette antifascite: «Sai questa, sai questa...?» e lui faceva: «Chi te la ha detta?». «Guatteri». Guatteri, era un ufficiale della milizia, che era funzionario qui all’ECA, era il padre di quel Guatteri che adesso è farmacista su a Busana, zio di quel Guatteri che è alla Banca agricola, un «barbetta» simpaticissimo, spiritoso; mi raccontava tutte le barzellette e io le andavo a raccontare al federale, e il federale rideva come un matto. Questo per dirti come era l’ambiente insomma di quella cosa lì, quindi in questo ambiente la guerra di Spagna è passata là come una cosa... che forse riguardava i superiori comandi, forse riguardava qualcheduno. Voi non avete svolto nessuna attività? Né attività di ricerca di fondi, né attività di convinzione per ottenere delle... perché poi dei volontari per la guerra di Spagna, io non ne conosco. Conosco quelli che ci sono andati, conosco Mirotti, conosco Zoboli, conscevo Degli Incerti Tocci, ma sono cose che ho saputo dopo. Io Mirotti non ho fatto in tempo neanche a parlargli, perché quando lui è tornato, io ero a soldato […]. Uno che non è mai stato... Ma iscritto forse sì, perché la sua famiglia a Campagnola, era soprattutto una famiglia religiosa, erano dell’Azione cattolica ecc., suo padre era un ricco agricoltore. Recentemente mi è arrivato un libro di uno di Campagnola sull’oratorio, e mi è piaciuto perché... per questa cosa qui, per questo accenno a Mirotti, perché sai, si fa presto a parlare e a dire tutte le cose, ma quando trovi uno che ti parla di un amico di cui nessuno parla perché sembra una cosa proibita parlarne e ti dice male di un caro amico come era Mirotti e... mi ha fatto piacere... me lo hanno mandato... ma l’ho già portato a casa... è la storia dell’oratorio di Campagnola... l’ha scritta un ragazzo giovane... sarebbe interessante trovarla... non c’è... l’ho portata a casa. 116 E i cattolici e la guerra di Spagna? I cattolici? Non si è mai sentita la loro voce. I giornali ci tenevano a far vedere che era una difesa della cattolicità, almeno dalla stampa, ma che ci fossero delle posizioni precise, no. Io ricordo che allora ero in contatto, come sempre perché era un amico, con monsignor Prospero Simonelli che quando aveva qualche grana della Curia con la Federazione veniva da me; certe cose... mi ha detto e mi ha scritto che ha sempre avuto soddisfazione; d’altra parte io c’ero con Bolondi, quando Bolondi era l’uomo più mite e più tranquillo e meno... anzi quello che gli rimproveravano era che lui era un antifascista diventato fascista quando lo hanno fatto federale. Masini di Milano, fratello della Masini che è stata partigiana, è stata a villa Cucchi ecc., e lui mi raccontava sempre che Bolondi era uno di quelli che criticavano il fascismo, quando improvvisamente lo hanno fatto federale, perché aveva la protezione di... e lo ha fatto bene perché, dove è passato lui, sia a Reggio, sia a Padova, mai successo niente. Ma come dico, quella lì della Spagna non l’abbiamo avvertita qui in periferia come... l’unica cosa che io ricordo, e ricordo molto bene, è stata quella di quei due o tre miei amici che erano là e non sapevo come. Mirotti era ufficiale d’artiglieria e gruppi d’artiglieria non so se li hanno mandati. Qualcheduno, non certamente da Reggio. Ero ufficiale anch’io qui a Reggio del 3°... anche perché i nostri pezzi, erano pezzi pesanti e quindi probabilmente per la guerra di Spagna ci volevano dei pezzi leggeri. Mirotti era stato in Africa e poi è andato in Spagna; Zoboli, il maestro Zoboli è andato in Spagna, è stato ufficiale... Lei prima ha parlato di una festa che avevate organizzato. C’era stata per il ritorno di un vostro amico dalla Spagna...? Sì, ma erano cose personali... Cose personali sì, ma di cosa si parlava, che testimonianze vi aveva portato? Ci ha portato prima di tutto del cognac «Fundador», e poi noi eravamo convinti che non potesse aver fatto niente sul serio. E poi era già ufficiale, credo che fosse già maggiore, fatto sta che è tornato con tutte... so che dopo è andato in Russia con il 79° battaglione camicie nere con Margini, famoso, e lì hanno fatto veramente il loro dovere. Non si è avuto il senso del dramma. Era una visita serena, tranquilla, l’organizzazione consisteva come dico al sabato, nel fare i littoriali del lavoro, che ci impegnavano per tre/quattro mesi, nel farli partecipare alle celebrazioni normali e soprattutto l’attività dell’Istituto di cultura, quello sì. Ma erano cose interessanti. Intendiamoci bene, non può mica pensare che in pubblico un Dossetti andasse a sparare della retorica. Prima parlavo di quella relazione sulla organizzazione e funzione della previdenza sociale che era uno studio serio; io poi non mi ricordo, perché non facevo altro che avere i nomi di quelli che potevano andare... e chiedevo: «Tu hai qualche cosa di pronto? Vai qua, vai là». Era una vita tranquilla e serena e poi c’è questo, insomma, che ci avevano abituati che di politica, ne parlavamo meno che adesso perché la politica era quello che era. Questa era la realtà. Ho trovato un dato pubblicato su un inserto del «Resto del Carlino» dedicato alla storia del fascismo reggiano a cura del dottor Badini, che indica in 193, quindi un 117 numero ben preciso che fa pensare ad un elenco, i fascisti, o meglio i «volontari» reggiani partiti per la Spagna. Mi chiedo, come è possibile che sia partito un numero così elevato di persone senza che nessuno se ne sia accorto, senza che nessuno abbia organizzato, promosso la partecipazione? Che Badini l’abbia tratto probabilmente dai cos della prefettura; se noi ci pensiamo 193, immagini che, 193, almeno, almeno una cinquantina fossero già in Africa, a destra o a sinistra, che poi partiti così alla spicciolata, oh 193... erano cinquecento o seicento le camicie nere quando sfilarono in via Emilia quando andarono in Africa. Erano 120 quando, no erano quattrocento e tanto quando un gruppo d’artiglieria, ricordo con il mio colonnello Russo in testa, partimmo per l’Africa. Quindi erano migliaia. Ora questi alla spicciolata che potevano andare, a me non risulta che ci sia stato una partenza di gruppi, ma che fossero delle cose individuali che andavano, tornavano, qualcheduno probabilmente con la speranza, essendo ufficiale effettivo di nuova nomina, di completare la sua... qualcheduno anche dei reparti di camicie nere che volesse... insomma come dico, io proprio nei miei ricordi, come ricordo benissimo le partenze per l’Africa, quelli lì della Spagna non mi è rimasto niente, niente perché come dico era una cosa clandestina, era come non so se adesso, non dico lo scandalo di Palermo, quello fa più rumore, non c’era una cosa, probabilmente come dal punto di vista ufficiale doveva essere una azione, diciamo così simulata, nel senso che non c’era da rompere dei rapporti internazionali, non doveva comparire. Se un aviatore andava là e cambiava il nome, non doveva essere... e d’altra parte non solo da parte nostra, ma anche da parte dell’Inghilterra che non ha mai aiutato la controparte, quindi è logico che anche questi invii di truppe passassero in silenzio ecco, o fossero simulati, o fossero partenze per l’Africa e poi andavano in Spagna, volontari o non volontari, non lo so io questo, ma come dico nell’opinione pubblica, anche nella federazione, se ne sapeva poco, almeno dal mio punto di vista. Lei come responsabile dei GUF, non ha mai ricevuto direttive, coordinate dall’alto sulla guerra di Spagna? Io non ho mai ricevuto nessuna direttiva sulla guerra di Spagna, non se ne parlava così, ma la nostra era tutta azione per l’organizzazione per la formazione di corsi di cultura, per i Littoriali del lavoro e della cultura, in quanto non li organizzavamo noi quelli della cultura, ma venivano organizzati nelle sedi universitarie, ma ci andavano anche i nostri. Per esempio ho avuto un universitario, che era Iannaco, che si segnalò ai Littoriali della cultura e divenne poi titolare di letteratura all’università di Firenze. È morto due anni fa, ha sposato una sorella del dottor Laghi... ma nei littoriali del lavoro ho avuto successi. Quelle erano le cose che facevamo e che io in particolare facevo volentieri. Per il resto... nota che posso dire una cosa: non avevano i riflessi di quegli avvenimenti lì neanche nel direttivo federale, perché io come segretario dei GUF, ero di diritto nel direttivo federale, eravamo in otto o dieci. Quindi neanche nel direttivo federale? Trattative speciali no, neanche lì; quindi secondo me era tutto una campagna mossa dal centro attraverso azioni particolari in determinati settori ecc., ma io non ricordo, 118 e son sicuro, che non ho mai avuto nessun particolare interessamento, direttiva o cos per potere agire, non so per stimolare i volontari... Non sono arrivate domande di volontari? Non sarebbero mai arrivate a noi, arrivavano alla milizia, al massimo la federazione avrebbe potuto fare un’azione di stimolo, ma la milizia aveva il suo ortus conclusus, perché noi dobbiamo pensare, che la legione aveva il suo comando a Reggio, ma in servizio non c’era più di venti persone. I legionari erano in tanti distaccamenti, in tanti drappelli, in tante squadre, erano in tutte le frazioni, in tutti i paesi, quindi non è che ci fosse un esercito acquartierato in un angolo, quindi loro avevano il loro comando, erano tutti di diversi paesi i loro sottoufficiali, ufficiali con venti, trenta, quaranta militi, era tutta una cosa seria. Attraverso i GUF non aveva risonanza ecco. Mi dispiace che non ti ho potuto dare tante cose. È vero che nel ’36-37 si registra un aumento della attività clandestina degli antifascisti? Ci sono le raccolte di denaro «pro Spagna rossa»? Si ascolta Radio Barcellona? Oh, queste cose erano molto clandestine, o noi eravamo molto ingenui; perché alla federazione non arrivava niente, proprio niente. Io credo che anche Bolondi sapesse ben poco. Anche perché voglio dire come era la situazione. Il prefetto Pellizzi, il prefetto della Liberazione, a conclusione di un suo libro nel 1936 scrive a conclusione di un suo libro: conviene a questo punto che la narrazione abbia termine. Uno studio delle vicende che seguirono sarebbe, infatti, come si dice principium inopportuno perché scaldata da ricordi e da passioni troppo recenti che non consentirebbero una serenità necessaria. Ci basta aver tratteggiato per ora questi pochi anni del primo Novecento reggiano che furono la premessa degli svolgimenti futuri, fra qualche tempo si potrà descrivere l’ulteriore conquista sociale, le grandi opere pubbliche, lo sviluppo industriale e agricolo della provincia, le nascenti speranze nazionali, il movimento interventista sbocciato in pieno furore socialista, le opere civili compiute in pace e in guerra, il contributo di sangue e di eroismo offerto dai reggiani nell’immane conflitto europeo. Il dopoguerra, la degenerazione socialista, il fenomeno del pescecanismo, i primi passi del movimento fascista, il trionfo dell’idea mussoliniana, l’attuale vita reggiana protesa nella luce dell’impero, sono fatti che balzano come creature viventi nella anima nostra, nessun pennello […]. Ah, aah... stampato eh!! Questo per dirti qual era il consenso che si manifestava in questo periodo qui. Lei insiste a parlare di consenso senza dissenso, ma abbiamo per esempio l’antisemitismo. Quello viene molto più tardi, ’38-39 e nessuno ci credeva. Ma era un’imposizione tedesca. Questo perché nessuno di noi, del resto lo ha scritto adesso anche il figlio di Mussolini, Vittorio, nessuno era convinto. Se la maggior parte, moltissimi gerarchi erano ebrei, la casa del Fascio di Modena, andando verso Bologna, è la casa del fascio Sinigallia. Mi viene in mente un episodio con l’avvocato Finzi: una volta, ero nello studio dell’avvocato Finzi, con Mascheroni, poveretto, e altri amici, e si parlava 119 dello sviluppo... e dice: «Mo pensa che durante il periodo fascista a Correggio – lui era di Correggio – non hanno fatto niente, proprio niente, e secondo me la colpa è del segretario del Fascio d’allora», che era lui; e suo fratello Riccardo era ufficiale della milizia. Quando è venuta la campagna, ovviamente si sono trovati in stato d’opposizione. Reggio e gli ebrei? Ma guarda, io non c’ero più a quell’epoca lì perché... a Reggio se ne sono andati... sono andati via prima delle deportazioni, perché le deportazioni sono venute con i tedeschi, perché per esempio il professor Bonaventura, ecc., nessuno li ha disturbati in un primo tempo, invece quando sono venuti i tedeschi... io ricordo una volta quando cominciava a inspessirsi questa azione, andai in federazione verso le 3 e vidi nell’anticamera del federale Cesarino Sinigalia, quello che vendeva i mobili, che suo figlio c’è ancora che fa il consulente... «Cosa fai qui?», sono rimasto sorpreso perché sapevo... e mi dice: «Guarda io vado via, ma bisogna che saluti Bolondi», e li ho visti piangere come due cos, l’uno nelle braccia dell’altro, e Bolondi avrebbe dovuto farlo arrestare. Dopo poi le cose naturalmente sono andate come sono andate, ma io ho la fortuna di quelle cose lì di non aver fatto in tempo a viverle, perché quando è andato via Bolondi hanno mandato via anche me, cioè hanno sostituito anche il segretario del GUF e al mio posto in primo momento ci avevano messo Nicoli, poi Nicoli è stato richiamato e credo che ci abbiano messo Pasini, quello che adesso sta a Bibbiano, poi dopo si sono avvicendati perché mettevano uno e poi veniva richiamato, c’era poco da fare. Lei continua a descrivermi un clima «tranquillo e sereno», ma per un intellettuale come lei, provvedimenti come la censura, l’indice dei libri, che valore avevano? Ma... non arrivavano fino a noi. A meno che non fossero quei pochi che andavano a cercare chissà che cosa, non arrivava fino a noi. Come si fa a parlare di censura; un libro si pubblica o non si pubblica, la censura la capisco durante la guerra, quando c’era una mezza colonna bianca. Effettivamente io sono convinto che questo movimento sotterraneo ci fosse, soltanto che l’hanno un po’ scoperto dopo, allora era veramente clandestino e clandestino sul serio si vede, perché noi non ne abbiamo avuto nozione. Il caffé Bussetti viene descritto come luogo di ritrovo di antifascisti… Io ci sono sempre andato, non so se ero antifascista anch’io. Si parlava su discorsi proibiti, su letture proibite, al caffé Bussetti e alla libreria Prandi... Alla libreria Prandi l’ho letto anch’io, l’ho sempre sentito dire, ed è probabile, perché Prandi, essendo in contatto per ragioni di lavoro, naturalmente, con tutti gli editori, probabilmente doveva anche editare le cose che la propaganda ufficiale... ma il caffé Bussetti era un caffè di giocatori, di commercianti, era bello: aveva due grandi sale, oltre alla sala bar che era in angolo, poi aveva una sala sulla via Emilia e una sala su via Crispi ed era proprio il ritrovo... Da Prandi l’ho sempre sentito dire che ci fosse questa cosa qui, ma io di Prandi ho solo un bel ricordo che lo ha ricordato 120 anche lui, lo ha fatto ricordare a Montanari, ed è che quando io fui tornato all’Ente del turismo nel ’44-45 fui chiamato in prefettura per accompagnare Dollman a visitare, è stato anche pubblicato sulla «Gazzetta di Reggio», per accompagnare Dollman a visitare la città. Io accompagnai Dollman per la città a visitare i monumenti. Avevo una paura maledetta, parlava benissimo l’italiano, ne sapeva più di me su tante cose; a tutti i modi gli ho fatto vedere la città e abbiamo chiacchierato cordialmente di cose simpaticissime, finché alla fine, mentre uscivamo da San Pietro dove ero andato per fargli vedere i quadri di Luca Ferrari, dice: «Ho visto in prefettura due bei volumi su Francesco IV e Francesco V di Clelia Fano», perché quando era venuto in Italia, era venuto per fare uno studio sui Farnesi, e mi chiese se a Reggio c’erano dei rapporti con i Farnesi e mi dice che i volumi sono belli e mi chiede se Clelia Fano è ebrea e io gli rispondo che è stata mia collega, perché nel ’35 prima di andare a soldato feci in tempo a fare sette mesi di supplenza sostituendo il professore di filosofia che era malato, e c’era Clelia Fano e dico: «Sì, io l’ho conosciuta molto bene...». E dice: «Era ebrea?». «Sì» dico e mi dice: «Ma si possono trovare quei due libri?». E dico: «Se non ne ha la libreria antiquaria» e andai dentro da Prandi con lui e strinsi l’occhio a Prandi per dire: «sta attento». Li trovò e da quel giorno Dollman è andato quasi tutti i giorni o ha mandato, a comperare dei libri antichi da Prandi. E Prandi ha fatto un affare. Poi non solo, e Prandi lo ha raccontato in un’intervista che ha fatto a Montanari recentemente, quando furono condannati a morte suo fratello Ferrari, Zanti, ecc., fu fucilato soltanto il padre della Zanti, perché Dollman nel suo libro Roma nazista dice che aveva dei precedenti tali che non poteva salvarlo, ma gli altri quattro, non fidandomi di lasciarli a Reggio, li portai a Modena prima, poi a Roma e si salvarono così. E questo Prandi lo ha ricordato e mi ha fatto piacere: «e lo aveva accompagnato il professor Spaggiari». Ma che Prandi fosse questa cosa qui, lo dicono e io credo che lo sia, perché Prandi è sempre stato di quell’idea lì, però io non ne ho mai avuto la sensazione. Andavo da Prandi se avevo bisogno di un libro, lo comperavo, trovavo lì degli amici, li salutavo, ma non ho mai avuto la sensazione che i miei amici, Cocconi che era in collegio con me... Comparoni... Beh, Comparoni era molto più giovane, Comparoni era stato mio addetto alla cultura del GUF ed era giovane e forte prima della guerra, non so cos’è, del ’28... era giovanissimo, io lo presi, non so se aveva appena finito il liceo nel ’36, quindi era del ’20-22-23, che io lo presi, che io non lo conoscevo, che Bolondi mi disse, Comparoni era compagno di scuola dei suoi fratelli, e mi dice: «Ma c’è quel ragazzo lì che è molto bravo». E lo presi come membro addetto alla cultura, che era poi l’organizzazione dei littoriali. Un caro amico. Poi siamo rimasti amici, poi ci siamo ritrovati che io insegnavo al liceo e lui non so dove, fino agli ultimi tempi che... conoscevamo tutti un po’ il suo dramma, il suo dramma familiare poveretto... un caro amico. Così, come dico era tutta una cosa. Adesso quando si parla di queste cose qui, si ha sempre un po’, da una parte l’esaltazione, dall’altra la demonizzazione. Tornando alla Spagna, secondo me è difficile trovare elementi per la sua ricerca, secondo me è stata fatta una azione nei reparti, cioè nei reparti armati, nei reparti della milizia ecc., per vedere chi andasse, quando non hanno preso qualche reparto e lo hanno portato là dritto 121 credendo di portarlo in Africa, sono questi fatti. Che io ricordi a modo a Reggio c’era Zoboli, c’era... Mirotti, Degli Incerti, il capitano Bottazzi e non ne ricordo altri. Prima riferendosi a Degl’Incerti diceva che gli cambiarono il nome? Agli aviatori spesso cambiavano il nome, infatti Degli Incerti in Spagna era il capitano Tocci e quando venne a casa la famiglia prese il nome Degli Incerti Tocci. Erano aiuti che non dovevano apparire in un primo tempo, soprattutto nei confronti dell’Inghilterra, con la quale c’era stato un breve rallentamento dell’urto quando venne Eden a Roma... Lei era amico di Mirotti. Secondo lei uno come Mirotti come ci arriva in Spagna? Che tipo di canali, che tipo d’immaginazione lo colpisce per andare in Spagna? Mirotti essendo ufficiale di artiglieria, quindi uno specialista, sia stato preso e portato in Spagna. Era uno che se ne fregava, era un tipo ameno, simpaticissimo. Perché venne assassinato Mirotti nell’immediato dopoguerra? I comunisti non gli avevano perdonato questa cosa qui, forse c’erano dei rancori personali... Il suo omicidio è da collegarsi all’avvenuta partecipazione come «volontario» alla guerra di Spagna? Intanto lui era figlio di un ricco agricoltore, quindi cattolico, pretino, quindi non della corrente del sindaco di allora; era stato in Spagna, ce n’era di più... per ammazzarlo ce n’era abbastanza, e lui poi non aveva nessun timore, lo hanno sorpreso mentre tornava a casa di notte, era in borghese... era un tipo... il tipico... non dico menefreghista ma un tipico ragazzone che aveva sempre voglia di scherzare, la stessa frase «Di rossi...», ma io credo, perché Mirotti era ufficiale d’artiglieria, che in Spagna avessero bisogno soprattutto in un primo tempo di specialisti, gente abile cioè gente abile ad operare... cioè aviatori, artiglieri forse non lo so, volontari di qualsiasi tipo, infatti, Maccario era nei bersaglieri. Infatti Brindani era ufficiale, Patroncini era un maestro elementare impiegato all’ospedale che quando poteva andare fuori, andava fuori, se c’era una guerra, andava a fare una guerra, è andato in Africa, in Spagna, in Russia, aveva messo su un giubét che Manfredi diceva: «Patrocio, àl tò giubét e la me testa», è bella... Terminata la guerra di Spagna, rispetto a quell’esperienza...? C’era già quell’altra pronta. C’era una paura... io ricordo la paura che ho avuto prima di Monaco cioè prima dell’incontro di Mussolini a Monaco; la guerra faceva paura insomma. Quella d’Africa l’hanno presa tutti alla leggera; sono andati ma si sono accorti che molti non sono tornati. Hanno capito che la guerra è la guerra. Quindi la guerra del ’39 metteva sotto qualche cosa che faceva paura, perché si aveva voglia di dire che Hitler era forte... ma quella faceva pensare; la Spagna era quel che era. L’unica cosa che fece impressione fu la saggezza per lui di Franco a non entrare in guerra con noi. Di Franco dicono tutto il male possibile, ma Franco ha salvato la Spagna e l’ha avviata a una forma d’organizzazione moderna. Franco è stato saggio. 122 C’è stato l’incontro a Bordighera di Mussolini e Franco, non so la data esatta, ’39-40... Era un momento così, ma come dico la guerra di Spagna è passata così... Si sapeva di questi episodi, di questi amici che erano là, ma che ci fosse un riflesso sulla vita politica, non c’era, era proprio tutta una cosa... forse era come il comunismo clandestino ecco, clandestino quello e un po’ meno clandestino quell’altro, perché tutti sapevano cosa succedeva perché qualche conoscente in guerra non so, io ricordo quelli, ma probabilmente conoscevo qualcheduno altro che andava; nel GUF no, al GUF non ricordo proprio nessuno. Ricordo Zoboli e Mirotti che c’erano, ma c’erano da prima perché erano stati chiamati durante la guerra d’Africa. Quindi c’erano da prima, erano soldati, dall’Africa qualcheduno veniva, qualcheduno tornava... ma per la guerra di Spagna non c’è stata un’eco e neanche il fatto di rafforzare il comunismo sapevamo, chissà, forse se ci sono documenti che lo dicono, si saranno documentati bene. Non solo i comunisti, nelle stalle, nelle osterie si parlava della «Spagna rossa»... La stalla fino alla guerra era il salotto dei contadini, si trovavano lì; c’era la posta vuota dove veniva il calzolaio aggiornato, il sarto aggiornato, dove si invitava a fare l’amore la contadina, dove piantavano il telaio per fare... quindi che anche lì si parlasse, è probabile. Però professore si parlava, come dice lei, nei salotti dei contadini, della guerra di Spagna e non nei salotti della città? Ma Dio, anche quelle lì sono interpretazioni... Come dico come quelle insomma delle conversazioni antifasciste nella libreria di Prandi e al caffé lì di piazza del Monte, all’Ente autonomo, come lo chiamavamo, che ci fosse qualcheduno che realmente parlava che comunicava così è possibile, anzi lo sarà, se me lo dicono, ma che fosse una cosa così palese, non credo. Anche sul «Solco» non se ne parlava? Ma lì al «Solco» chi faceva tutto fin d’allora era un uomo in gamba che probabilmente non credeva in niente, ma sapeva scrivere, Paglia, che poi aveva sposato una ricca, la Sidoli che è morta recentemente e lui dopo e lui dopo la guerra subito è andato in Sudamerica dove è ancora e si è accompagnato con una negra, ha ottenuto il divorzio dalla Sidoli la quale era proprietaria di quella casa lì in fondo a via Monte Cusna sulla sinistra, una bella casa, aveva dei poderi a Parma, a Puianello, è la zia di Matteo Sidoli, Matteo Sidoli quello che parla sempre in televisione, quello sportivo che è anche consigliere a Quattro Castella. Professore, lei sicuramente lo sa, le notizie che il «Solco» pubblicava in prima e quarta pagina erano notizie d’agenzia... Erano veline, non credo che ci fosse nessuno allora che si permettesse in un giornale locale... la redazione sistemava quelle cose lì, metteva le notizie locali, sceglieva forse anche fra le cose meno... lo ricordo che tutte le volte andavo al «Solco», perché a un certo punto credo anche di aver fatto una pagina anche del GUF, non so se la curava Bellocchi, comunque collaboravano Comparoni, il povero Strozzi. Comunque ti ripeto, era un periodo così. Io ricordo che in quell’epoca lì, nel ’38, mi 123 sono sposato. Era un’ottica che andava con la maggiore tranquillità, perché subito dopo la guerra d’Abissinia e di Spagna si aveva l’impressione che si fosse raggiunta la pace ecc., finché è saltato fuori quel matto là di là e poi fortunatamente tutto è andato come è andato. Voialtri... sono episodi che non vivrete: la guerra, l’essere ferito come sono stato io, l’essere... andare via da casa e lasciare moglie e figli, torneremo... booh, l’imbarcarsi sapendo che ci sono dei sommergibili pronti a silurare. Mi viene sempre in mente quel marinaio, dice: «Ma in mare un’ascia si trova sempre», era naufragato non so quante volte, e io mi guardavo attorno e non vedevo asce, mi consolava mentre attraversavamo l’Adriatico per andare alle Bocche di Cattaro. Lei dov’è stato ferito? A Punta Colza che è a metà strada tra Fiume e Segna. Tutti i giorni, dovendo trasferire o macchine civili o militari da Segna a Fiume, si faceva una colonna a cui si aggregavano, quindi in testa alla colonna ci mettevano un’auto protetta, una specie di camion con le lamiere, metti una mitragliatrice sopra, una specie di carro armato. Quando siamo arrivati a Punta Colza che la strada fa una specie di budello, cominciarono a spararci adosso da tutte le parti. Un disastro e il guaio è che per strada c’è una colonna d’artiglieria di quelle con cavalli. Ammazzati i cavalli davanti e di dietro, io non riuscivo ad andare né avanti né indietro con il mio automezzo e poi ho appena detto al mitragliere: «Prova a sparare là perché c’era un cos», l’ hanno centrato in faccia e io mi sono sentito gelare e poi noi eravamo nella strada, da una parte il mare dall’altra la montagna e dalla montagna hanno incominciato a gettare giù delle bombe a mano e allora le bombe a mano sono scoppiate in questo carro qui. Ci fregava tutti e allora sono smontato e poi ho fatto scendere i soldati e quando sono sceso mi sono accorto che sanguinavo ecc., da una delle feritorie di fianco è entrato una scheggia, una gran quantità di sangue, ma non c’era niente. Infatti, non c’è rimasto neanche il segno. Ad ogni modo sono rimasto ferito e mi hanno curato e siamo stati lì in quelle condizioni e fatto sta che non hanno avuto il coraggio di saltare sulla strada dove eravamo noi, sono saltati proprio dentro il fiordo, ma venirne fuori non sono venuti, finché dopo un’ora e mezza circa è arrivato un reparto di bersaglieri e gli altri sono scappati. In testa ai bersaglieri vedo uno con una croce rossa: era don Bruno Moratti, il mio compagno di scuola e parroco di Santa Teresa. Chi posso sentire per avere ulteriori informazioni su quel periodo, chi da un osservatorio privilegiato come il suo mi può aiutare a capire il rapporto tra la guerra di Spagna e la nostra città? Ma perché in Federazione lì, nella Federazione di quel periodo lì c’ero io, segretario del GUF, tutti gli altri membri del direttivo erano tutti vecchi squadristi: Rabotti... tutta gente che è morta da un pezzo, io ero il più giovane, e poi non se ne è mai parlato. La segreteria di Bolondi era tenuta, poveretto, a quell’epoca lì dal dottor Sani che poi divenne dopo la prigionia professore di inglese, titolare di inglese all’istituto tecnico ed è morto. C’era Falcetti, l’avvocato Falcetti, che è ancora fascista missino: è un vecchio rimbambito, ma forse potrebbe anche tenerci; abita nella sua grande villa lì a Rivalta; in città viene poco. Lui era segretario particolare del federale. Per un certo periodo lì alla segreteria c’è stato Max Menada che è vecchio, io dico vecchio come se io fossi 124 giovane, sono del 1904, ma la realtà è questa che io lavoro ancora come lavoravo venti/trent’anni fa, vivo la mia vita anche se purtroppo vedo che l’età per certi conta. Sarà perché mio padre è arrivato fino a 94 e io devo batterlo, sì devo batterlo, perché mio padre era un operaio, un ciabattino, e io ho due lauree e tutto il resto, però fino a 94, cioè fino a quando è morto, se c’era qualche cosa che non andava… «Et capés gnint, té un stùpid!» e io penso che, se per caso non arrivo alla sua età, à m’ndà dal stùpid per l’eternité. Am dis: «Ma se t’ om fàt studiér a fér?». È un ragionamento che io faccio, se poi non va, pazienza. Ma non credo che ci sia altra gente; se Falcetti volesse parlare esaltando il duce e il fascismo, lo farebbe, ma non credo. L’atteggiamento, secondo lei, della Chiesa a Reggio? Beh, sulla guerra di Spagna in particolare non lo so, com’era prospettata come guerra contro il comunismo ateo eccetera, la religione, io penso che fosse favorevole; io l’ho sempre pensata favorevole, bisogna vedere gli atteggiamenti concreti. 125 Memorie e Testimonianze Il timbro tedesco Quando Cesare Campioli sfuggì alla cattura Gianfranco Romani Premessa Chi scrive queste note è ben consapevole che in parti solamente narrative di contorno, riguardanti il racconto, sono presenti descrizioni pensate: la mia età di otto anni all’epoca dei fatti non poteva consentire diversamente. Ovvio. Ho inteso così interpretare le situazioni, le persone e i dialoghi di allora attraverso contatti, testimonianze e letture. Essendo nato ed avendo vissuto a Cavazzoli fino a 19 anni, ho «respirato», se pur giovane, l’ambiente, gli umori e credo di avere in certa parte introitato lo spirito morale prevalente degli abitanti della frazione, avendoli all’epoca in gran parte conosciuti di persona e frequentati. Il filo concettuale degli avvenimenti descritti, però si rifà ai veri eventi accaduti. Continuo a frequentare ai giorni nostri l’ambiente cavazzolese, incontrandomi con piacere con i miei pari età. Debbo riconoscenza a Raffaele Campioli (classe 1934), nipote di Cesare (al sio Céser), per le valide testimonianze. Oggi è diventato reggitore/erede della numerosa famiglia di un tempo (contava otto fratelli senza contare mogli e figli) e abita tuttora nella casa paterna. Anche con il padre di Raffaele, Severino (classe 1903), deceduto dieci anni or sono, ebbi sempre buoni rapporti. Di carattere bonario, mi confidava con gioiosità nei nostri incontri, preziose notizie e aneddoti che non potevano andare dimenticati. Era il 1987 quando combinammo un incontro a casa sua nel corso del quale registrai le nostre conversazioni, pregando Severino di citarmi quella tale circostanza, o l’altra sul fascismo, molte sul fratello Cesare, sulla guerra, i tedeschi in casa e nella stalla, ecc. 127 Testimonianze espresse nel lessico del nostro dialetto, con la stupenda schiettezza e genuinità dell’animo contadino: vero magnifico reperto di una lunga vita vissuta in operosità e onestà. In seguito, purtroppo, con l’intento di fare copia della cassetta incisa, disgraziatamente, per un disguido tecnico, il nastro venne cancellato con mio profondo rammarico. Fortunatamente per certi episodi avevo preso appunti. Altro testimone prezioso è stato Giulio Montanari (classe 1933) del luogo, che mi ha reso spontaneamente noto l’episodio chiave, del quale oltre a lui, quasi nessuno era a conoscenza: l’impensabile avvertimento da parte dell’impiegato della questura Enzo B. (parente della famiglia Montanari), trasmesso ai Campioli, riguardante un’irruzione notturna da parte della GNR nella casa, intesa alla cattura di Cesare. Anche altri nativi del borgo che hanno vissuto concretamente gli anni 1944-45, hanno contribuito con schietta naturalezza, rendendomi valide testimonianze ed episodi. Nell’ambiente, nei contatti umani che ancora persevero come già detto, purtroppo oramai ridotti ai pochi anziani rimasti, colgo ancora la presenza, l’atmosfera dei tempi trascorsi, il paradigma della passata, umile, ma equilibrata sapienza: lontani figli di Paolo Davoli e Cesare Campioli. La situazione nel ’44 a Cavazzoli Vogliano i lettori considerare che gli avvenimenti riferiti hanno una visione di quanto accadeva limitatamente alla frazione, compresa la zona di San Giulio. Solamente in modo marginale vengono considerati gli episodi certamente più importanti accaduti in città e ciò, se da un lato può essere giustamente valutato come restrittivo, dall’altro consente di esprimere un linguaggio più conciso, spinto anche dall’amore per il proprio borgo natio. Cavazzoli aveva, come ha tuttora, un’appendice costituita da un gruppo di case coloniche, una dozzina, denominata valle San Giulio, percorsa da una stradina che seguiva, parallelamente, l’argine sinistro del Crostolo. Il viottolo termina contro il piccolo oratorio chiamato con il nome del santo, riedificato nel 1761. Detta località appunto perché isolata, viveva maggiormente l’atmosfera tesa del ’44. Le notizie giungevano agli abitanti riportate attraverso fonti indirette e, come spesso accade, in maniera distorta. La zona si prestava a colpi di mano, a nascondigli di armi, di volantini di propaganda, di vestiario destinato alla montagna. Nei punti più isolati dei vasti campi, si individuavano zone idonee per riunioni a cui partecipavano i primi gruppi che poi divennero squadre SAP. C’era preoccupazione e paura, specialmente di notte negli animi di semplici contadini, sopratutto nelle donne. Si era saputo che alla fine di aprile erano stati affissi nel centro di Cavazzoli diversi manifesti che incitavano i giovani a disertare la chiamata alle armi; su qualche casa apparvero scritte come «viva i 128 partigiani» e «viva la democrazia». Facendo cronologicamente un passo indietro. A parte la caduta di Mussolini del 25 luglio 1943, è noto che l’8 settembre fu firmato l’armistizio. Assieme ad altre migliaia di soldati sbandati del nostro esercito, una dozzina appartenevano a famiglie fra Cavazzoli e San Giulio. Spogliatisi della divisa (per chi ancora la indossava), nascosti, specialmente nei primi giorni nei fienili o nei solai, vivevano una situazione di preoccupazione i cui sviluppi erano ignoti. I cosidetti «disertori» avevano disposto, incaricando genitori e fratelli, una guardia discreta alla strada, temendo un controllo da parte dei carabinieri. La loro posizione li teneva in allarme e con loro i famigliari: tutti si muovevano con circospezione attenti ad ogni evento. Trascorsi i primi dieci-venti giorni, la tensione cominciò ad allentarsi. I più intraprendenti si mossero nottetempo, si cercavano incontrandosi, si interrogavano ansiosi sul da farsi. Quelli di famiglie contadine si diedero ai soliti lavori nei campi mischiandosi ai famigliari, ma restando sempre guardinghi; quelli di famiglie operaie (i casànt) avevano maggiori difficoltà: stavano spesso nei solai, uscendo solamente in certi orari per lo più notturni, indossando capi comuni. Tutti dovevano prestare molta attenzione nell’evitare incontri, in special modo con gli iscritti al fascio e loro simpatizzanti, spesso vicini di casa. Maggiormente dovevano tenersi lontano dal postino Massimo e dal parroco don Minardi, ritenuti, a torto o a ragione, referenti dei fascisti locali. Col passare delle settimane alcuni dei giovani militari imboscati vennero contattati con cautela da amici (i primi elementi SAP), per un iniziale abboccamento con proposta di collaborazione, tenuti poi sotto discreta sorveglianza. Altri maggiormente decisi e più conosciuti, dopo i primi contatti, accettarono di essere accompagnati nottetempo, attraverso percorsi programmati, da elementi addestrati allo scopo, per poi raggiungere le formazioni in montagna. Normalmente il primo agganciamento avveniva in una piccola località sopra al paese di Borzano. Nella frazione continuavano le azioni di sabotaggio alle linee telefoniche e volantinaggio contro il regime. Il 17 maggio due «repubblichini» soliti a frequentare la località San Giulio a caccia di selvaggina, all’imbrunire furono affrontati sull’argine del Crostolo da quattro armati con viso coperto (uno aveva una pistola finta, un altro un vecchio mitra inceppato). Erano aderenti alla futura squadra SAP locale, ma ciò lo si seppe mesi dopo. I due militi colti di sorpresa innalzarono le mani sbiancando in volto, facendosi disarmare senza porre resistenza. Sequestrate le armi, spogliati dalle divise, furono lasciati liberi e in mutande, incitati a fuggire di corsa. La notizia di tale fatto suscitò notevole scalpore. Da qualche tempo si sentiva nominare nel borgo la strana parola «SAP» senza conoscerne il significato, ma poi si era capito che era collegata agli elementi antifascisti in zona. Si era anche saputo di incontri notturni giù dall’argine del Crostolo, con 129 alcuni uomini che provenivano dalla dirimpettaia parte di Sesso: si trattava dei fratelli Manfredi. La tensione aumentava. Altra circostanza di preoccupazione fu la messa in atto da parte del nucleo fascista locale, in ottemperanza agli ordini provinciali, di imporre a mezzo dei propri capi, uomini di loro fiducia nella conduzione e amministrazione del caseificio e della cantina sociale. Si potevano così controllare la produzione e le giacenze facilitando le destinazioni alle truppe tedesche o ad elementi fascisti. Al tempo stesso veniva preventivamente impedita la possibilità di prelievi da parte dei sappisti locali (alcuni di questi ultimi erano anche soci produttori della latteria e cantina), dei prodotti che sarebbero poi stati inoltrati in montagna. Le disposizioni messe in atto però si ripercuotevano sugli stessi contadini produttori: essi vedevano diminuite le loro quote parti di burro e formaggio normalmente assegnategli, indispensabili al fabbisogno alimentare dei propri numerosi famigliari. La riduzione di tali alimenti basilari nella dieta contadina, portò disagi e rabbia ai capi famiglia. Nel mese di novembre ’44 fu effettuata una importante azione alla quale parteciparono oltre trenta persone fra partigiani e sappisti provenienti anche dalle ville vicine. Il casino Nobili di Cavazzoli era stato adibito a deposito decentrato delle farmacie comunali riunite. Nottetempo con l’ausilio di automezzi, posti alcuni uomini armati di guardia, il gruppo asportò una ingente quantità di medicinali, inoltrati poi all’intendenza in montagna attraverso la squadra SAP di Roncocesi. Nei primi giorni di dicembre altro rilevante intervento alla cremeria di Sesso. Fu necessario un non facile lavoro organizzativo nel coordinare squadre di Cavazzoli, Roncocesi, Sesso e San Prospero, data la quantità di burro asportato pari a trenta quintali. Il cospicuo lavoro manuale di prelievo e caricamento su automezzi, comportò l’impiego di un centinaio di uomini, considerati i partigiani armati di guardia, posti all’inizio, alla fine del viottolo di accesso all’opificio-latteria e all’imbocco della statale SS 63. L’avviso di Enzo B. La notte fuori casa Era un caldo pomeriggio degli inizi del settembre ’44. Nel podere Montanari nella valle San Giulio, Beniamino e il figlio giovinetto stavano arando nel campo verso il Crostolo. Alla tornata del trattore in direzione della casa, il ragazzo alla guida con i suoi undici anni, si sentiva ancora più importante contando che almeno qualcuno delle famiglie lo guardasse. Il trattore scartò leggermente ad un tratto dato che le piccole mani allentarono la presa sul volante: il ragazzo Giulio vide comparire all’improvviso nel cortile della casa un uomo vestito bene in bicicletta. La persona si fermò guardandosi attorno e dopo qualche minuto una donna 130 anziana col fazzoletto in testa, uscì di casa andandogli incontro: i due si misero a parlare. Papà Beniamino camminava a fatica nel solco prodotto dal vomere con lo sguardo fisso, attento al regolare rivoltarsi delle zolle; ma si accorse del piccolo spostamento del trattore e urlando per superare il forte rumore del motore, diede una voce al figlio. Poi non capì perché Giulio diminuì i giri del motore: nell’uscire dal solco per avere la visuale aperta e guardando in direzione della casa, vide l’uomo fermo nel cortile che parlava con la donna. Pur fissando lo sguardo, con gli occhi semichiusi dal sudore, dopo essersi asciugato la fronte e alzata l’ala del logoro cappello, data la distanza, non riuscì a riconoscere la persona. Tornò all’aratro, alzò i vomeri e disse al figlio di spegnere il motore. Quell’uomo nel cortile lo preoccupava dati i tempi di ostilità che si vivevano. Essendo sudato, si infilò la vecchia giacca e si incamminò a passo svelto lungo la carraia. Allorché fu più vicino riconobbe con sollievo la persona che lo guardava e pareva lo attendesse. Riconobbe, infatti, Enzo B., napoletano di origine, impiegato col ruolo di ispettore in questura, parente acquisito avendo sposato una seconda cugina di sua moglie. Il B. ricambiò il saluto e avvicinandosi disse qualcosa all’uomo che si fece serio annuendo. Poi i due entrarono in casa. Poco dopo Beniamino uscì con gli abiti cambiati e inforcata la bicicletta, si diresse con energiche pedalate verso il centro del borgo. Giulio rimasto sorpreso, non comprendendo gli strani movimenti del padre, scese dal trattore, si calò il berretto e correndo si diresse verso casa. Mentre il Montanari pedalava deciso verso casa Campioli, perché era là diretto, era serio in volto, pensieroso. Era preoccupato della notizia che aveva ricevuto dal parente e pensava a come i fratelli Campioli avrebbero inteso la rivelazione; cercava di riflettere pedalando, quale poteva essere stata la ragione che aveva portato il B. a rendere noto, anche se a persona conosciuta, una così importante informazione riservata, che dava la notizia nientemeno di una operazione di polizia riguardante la cattura di un uomo schedato, ricercato quale «elemento attivista comunista pericoloso». Con la testa in confusione, il contadino arrivò nell’ampio cortile che trovò deserto. Dopo un momento gli si fece incontro Severino, sbucato dal portico che dava alla stalla. Si salutarono freddamente e dopo un attimo di imbarazzo Beniamino chiese: «È a casa Cesarino? Perchè avrei una cosa importante da dirgli». Il Campioli tolse le mani di tasca, se le stropicciò facendo un passo indietro cercando di nascondere l’agitazione che lo aveva colto e rispose: «Mio fratello non è a casa ed è un po’ che non lo vediamo!» (si capiva che stava mentendo). Mentre disse ciò, gli mulinavano in testa molte cose: pensava come mai l’uomo che aveva di fronte di nota famiglia di stampo fascista, stava parlando di un argomento così delicato e importante. Poi aggiunse confusamente: «Quello che dovevi dire a Cesare dillo pure a me!». 131 Il Montanari che aveva ancora la bicicletta fra le mani, rosso in volto, imbarazzato, la appoggiò al muro sospirando e con tono grave disse: «En’sò mîa c’mè dir! Lèe un lavor poch béll! Còll me parèint ch’al lavora in questura, lée gnûu a cà mia dsadèss e al’ ma détt, per fàr un piasèir, cl’à savû da un sò colèga amîgh, ma amîgh dabòun, che la nôt ’ch vîn gnirà a cà vostra un gròpp ed fasésta cun al camiunéti, per ciapêr Cesèr!». Poi ha aggiunto che Enzo B. disse ancora, di avere sentito come un impulso, di usarvi un riguardo conoscendo attraverso noi la vostra famiglia come gente onesta e buona d’animo; ha detto ancora in un certo modo (ingenuo?): «Di non dire niente a nessuno al di fuori di voi!». Riprese Montanari: «anch’io Severino, credimi, sono molto sorpreso di questo fatto, non so cosa dire, ma ho piacere per voi se la cosa in qualche modo può aiutare tuo fratello». Campioli non sapeva più quale atteggiamento prendere! Fra l’imbarazzo e la riconoscenza, salutò a mezza bocca l’amico che, inforcata la bicicletta sparì rapido nella strada. Pensò in confusione che non l’aveva neanche ringraziato. Mentre rimuginava su tutto ciò, quasi soprappensiero, entrò in casa, salì le scale dove in uno stanzino d’angolo trovò Cesare seduto sul letto; su un lato c’era un vecchio armadio che copriva uno stretto passaggio che dava nel solaio nel quale era stato approntato un buon nascondiglio. Cesare dall’alto aveva visto l’uomo giù nel cortile che parlava fitto con suo fratello, ma non l’aveva riconosciuto anche perché doveva stare ad una certa distanza – il finestrino era senza tenda – per non essere visto. Gli pareva però di avere capito che il colloquio, dagli atteggiamenti dei due, riguardava una cosa importante. Cesare informato della notizia si fece serio e assieme al fratello convennero di informare uno degli altri fratelli, Otello, e lo chiamarono. Al momento non ritennero di dare la notizia agli altri e men che meno alle sorelle e mogli per non creare un dannoso allarmismo. Solamente prima di andare a letto Severino avrebbe informato i restanti componenti della famiglia, in modo blando, della eventualità del sopralluogo che avrebbe definito come un ordinario controllo. Anche se l’informazione presentava aspetti non certi, Cesare, che rientrava nell’organizzazione del Comando piazza, poteva disporre di contatti abilmente dissimulati, con collaboratori quali una staffetta e il responsabile della squadra SAP Walter. Per ragionata precauzione venne deciso che Cesare doveva trascorrere la notte fuori casa; si mise in contatto con la staffetta Wally incaricandola di recarsi presso la famiglia Iotti preavvisando, come avvenuto in altre occasioni. Gli Iotti, contadini, antifascisti fidati, abitavano in una casa in aperta campagna fra Pieve Modolena e Roncocesi. La località era denominata «Ballan le oche», ma non veniva mai pronunciata in lingua1. 1 In dialetto viene pronunciato «in’bàla-àl ‘gli’òch», un quasi toponimo pittoresco e fantasioso che si può prestare ad essere inteso, nella verbalità dialettale che antepone l’in – ovvero dove – anche come: «imballano le oche». (in=im) Uno strambo esilirante «detto». Certo non per le oche! La passione per il dialetto ci ha fatto deviare dalla narrazione dei fatti che subito riprendiamo. 132 Cesare, prima di allontanarsi alla chetichella da casa sull’imbrunire, sulla sua fida bicicletta, si infilò a tracolla la solita borsa di pezza con le cose per la notte; poi tutto coperse con un deciso giro del tabarro scuro, alzò il bavero e si calcò il cappello fin sugli occhi. Prima di lasciare la casa trovò il modo di avvisare Walter della sua temporanea assenza e della azione notturna che avrebbe potuto avere luogo da parte dei fascisti neri. Walter a cui il coraggio certo non mancava, si attivò come più oltre vedremo, in attesa dell’evento della notte. Partì piano piano il Campioli, guardingo; non si diresse dal cortile di casa verso la strada principale, bensì imboccò il breve tratto di carraia che portava al vicino viottolo del cimitero che all’epoca, su un lato, godeva di un’alta siepe di bosso che copriva alla vista: una circostanza vantaggiosa. Severino da sotto il portico lo seguì con uno sguardo affettuoso. Il ciclista, pedalando piano, di tanto in tanto, girava la testa leggermente ma in modo sufficiente per guardare dietro e accertarsi di non essere seguito. Certo i tanti episodi vissuti in latitanza, mesi di prigionia e i tanti anni trascorsi da esiliato a Parigi, lo avevano temprato ad un’esperienza che gli consentiva un controllo, un dominio sui sentimenti che pur premevano. Come nelle volte precedenti, abbandonò quasi subito la strada principale per infilarsi in viottoli e carrarecce che ben conosceva. Arrivò in vista della casa con un po’ di fiatone; la vide deserta ma di lì a poco apparve sotto il portico la moglie di Iotti, grembiule smunto a fiori e fazzoletto in testa. Cesare alzò la mano per rispondere al cenno di saluto della donna; il cane che aveva accanto subito abbaiò, poi smise ad una voce della padrona. Per tre giorni l’ospite si intrattenne, per maggiore cautela, pensando al disagio che la «visita» notturna doveva avere procurato ai suoi famigliari, come gli fu poi puntualmente riferito dalla staffetta. Riceveva un trattamento con ogni riguardo dalla famiglia. Sentendo il dovere di sdebitarsi in qualche modo, Cesare mostrava un comportamento di modestia e amicizia con tutti i famigliari, anzi chiese allo Iotti di poterlo aiutare nei lavori di aratura però nei campi più lontani dalla casa. Indossò così un grembiulone e un largo cappello di paglia, rivivendo i tempi di anni addietro, allorché, nei giorni che gli erano consentiti poteva aiutare i fratelli nei lavori dei campi. L’irruzione nella casa Era imbarazzato Severino durante la cena. Pensava gravemente fra sé: chi avrebbe potuto avvertire dei famigliari del fatto che sarebbe potuto avvenire a poche ore, dato che avevano visto stranamente Cesare andare in bicicletta verso il cimitero. Sì, perché sull’avvertimento del pomeriggio trasmessogli da 133 una persona con la quale non aveva mai avuto frequenti rapporti, nutriva ancora dubbi. Però Cesare, parlandone col fratello prima che uscisse di casa, pur avendo avuto esperienze peggiori di quella che probabilmente sarebbe accaduta, si dimostrava abbastanza tranquillo e ciò rincuorò il fratello. Nessuno però conosceva bene gli intendimenti veri del B., le sue idee politiche: era pur sempre un «questurotto» napoletano! La delazione avrebbe potuto essere un modo per snidare il Campioli dalla casa, oppure creare un allarmismo in seno alla famiglia costituita da gente semplice: il pensare a uomini armati in casa di notte! Specialmente dalle donne, dal loro comportamento, si sarebbe potuto trarre delle utili indicazioni. Puntualmente nella notte avvenne l’irruzione. Nella casa abitavano una quindicina di persone, fra fratelli, sorelle, mogli e figli piccoli. Erano circa le tre di notte quando i militi della GNR, divisi in due gruppi, parcheggiarono le camionette ad una certa distanza dalla casa, cercando di evitare rumori, ma da due case vicine si accesero delle luci, però con finestre subito chiuse. Un automezzo si fermò lungo il viottolo del cimitero in modo da intercettare una via di fuga attraverso i campi; l’altro si fermò sulla strada in direzione di Roncocesi. Su ogni camionetta restò un milite di guardia. Una parte del gruppo circondò la casa mentre i restanti si accodarono al capo pattuglia, il quale attraversato il cortile, picchiò forte alla porta. Immediatamente diverse finestre si illuminarono e comparve nel vano di entrata la figura allarmata di Severino, rimasto in attesa dissimulata senza avere chiuso occhio; però finse bene la sorpresa. Gli uomini irruppero; un paio si infilarono velocemente nelle stanze a piano terreno chiedendo se c’era una cantina interrata, mentre gli altri gli altri con il capo pattuglia in testa salirono rumorosamente alle stanze superiori. Il forte trambusto verosimilmente impaurì i famigliari, specialmente le donne: vennero sbattute le porte, accese le luci, accertate le persone scrutando a fondo i visi maschili con bruschi commenti ad alta voce. Si vissero attimi di paura: persone inermi in un letto, armi puntate, militi con modi sgarbati a chiedere il nome degli uomini. Solamente Raffaele, con la spensieratezza dei suoi dieci anni, interpellato oggi, ricorda vagamente il trambusto e le rauche sgradevoli voci non famigliari. Era addormentato e si girò appena nel letto all’aprir secco della porta, intravedendo figure scure. Poi si rimise nella posizione solita cercando di riaddormentarsi alla vista rassicurante del papà, apparso nel vano della porta rimasta semiaperta. Vennero perquisiti vecchi armadi che emanavano all’apertura l’odore del tempo e cassettoni. Trovarono unicamente indumenti personali e sugli scaffaletti vecchi candelabri, piccoli libri consunti e bolle di consegna della cantina sociale, ma nessun documento che potesse riguardare l’attività di Cesare. Accorto ed esperto, consapevole di non creare altri problemi ai fratelli, 134 non teneva tracce e/o documenti personali nella casa paterna. Serpeggiava nei famigliari il forte timore che, non trovando il ricercato, uno dei fratelli venisse portato in questura come ostaggio. Infatti, uno di loro pareva assomigliasse a Cesare: fattolo alzare bruscamente dal letto, risultava di statura inferiore, più magro in volto e con capelli radi, mentre la persona ricercata era completamente calvo. Due militi salirono nel solaio perlustrandolo in ogni angolo con una torcia, ma trovarono soltanto ragnatele e polvere. Poi tutti gli uomini, ad una voce del loro capo scesero e si riunirono nel corridoio d’ingresso: il comandante era alterato in volto dalla rabbia così come i militi. Disse loro di uscire in cortile, chiamando quelli in attesa dietro casa. «Meno male», pensò Severino ancora molto scosso dall’accaduto, avvertendo nell’intimo una punta di soddisfazione. Mentre si avvicinavano agli automezzi, alcuni militi imprecavano, altri accesero una sigaretta, delusi dall’azione conclusasi con un nulla di fatto. Risaliti sui medesimi nervosamente, finalmente ripresero la strada per la città. In casa Campioli si respirava una mal celata aria di contentezza per lo scacco subito dai fascisti, ma diversi, fra fratelli e sorelle, rimasero assai turbati tanto che la Cesarina dal carattere più sensibile, scoppiò in un pianto dirotto, consolata dalla sorella Adelfina anche lei con gli occhi lucidi. Accesero subito il camino ed Emore, uno dei fratelli, ravvivò il fuoco aggiungendo un bel ciocco. Chi riuscì si appisolò mentre una buona parte dei componenti la famiglia scesero in cucina, sorseggiando, con gli occhi fissi sul muro, una tazza di caffelatte preparata dalla Adelfina sulla stufa. Le narrate circostanze sui movimenti dei militi all’esterno della casa, i loro comportamenti, le rabbiosi frasi dette, avevano avuto dei testimoni. Due sappisti locali erano appostati in due punti idonei, abbastanza vicini al cortile: uno era a poche decine di metri dalla camionetta ferma nel viottolo del cimitero, acquattato dietro al muretto, dalla parte che dava sui campi di Grisendi. E ciò da testimonianze riportate da un anziano antifascista che non ha desiderato essere citato, che a sua volta le ebbe subito dopo il 25 aprile 1945, da un componente del gruppo SAP deceduto da anni. Come qui narrato, la cattura di Campioli non avvenne grazie all’avvertimento di Enzo B. e in quei tempi l’arresto, considerata la posizione di Cesare, significava altra galera, torture certe, più che probabile fucilazione. Si consideri l’esempio tragico dell’amico e compagno Paolo Davoli, come è noto anch’egli di Cavazzoli. La ragione dell’avvertimento trasmesso, è rimasto privo di una spiegazione logica, tenendo conto del rischio che in se comportava. Oltre all’ipotesi della «buona azione» prima citata, ma a nostro avviso non del tutto convincente, ci sentiamo di prendere in buona considerazione un’altra probabilità. Da notizie certe acquisite, in questura erano presenti all’epoca, alcuni addetti in servizio, di fede non proprio fascista, che segnalavano molto accortamente notizie utili, 135 a persona oltremodo conosciuta e fidata, in contatto con il CLN. Qualche mese dopo il 25 Aprile Enzo B. fu trasferito alla questura di Parma. Anche negli anni che seguirono il 1962, allorché lasciò la carica da sindaco della città, Campioli continuò a dare attività al movimento democratico e all’antifascismo. Assunse la presidenza dell’azienda municipalizzata gas, in pratica da lui fondata. Istituzione che divenne in seguito la Gas-Acqua, poi successivamente AGAC. Colpito da un male incurabile che lo costrinse alla immobilità, morì il 25 gennaio 1971. Le sue spoglie riposano nel cimitero monumentale nel grande sepolcro comune dei reggiani illustri. Cenni biografici Cesare (all’anagrafe Cesarino) Campioli nacque a Cavazzoli – dove oggi ha una via a lui intitolata – il 24 marzo 1902 da famiglia contadina di piccoli proprietari. Frequentò fino alla 4a elementare in una scuola precaria ricavata in un lungo caseggiato con unica maestra per le varie classi. Iniziò con piccoli lavori nei campi assieme ai famigliari, poi a quattordici anni fece domanda e fu assunto ovviamente come apprendista-aggiustatore alle Reggiane, dove si lavorava undici ore al giorno senza riposo settimanale. Si consideri che nel 1916 ci si spostava a piedi, pertanto il ragazzetto Cesarino doveva scarpinarsi due volte al giorno la distanza da Cavazzoli a via Agosti. Nel 1920 fu tra i primi ad aderire al movimento giovanile socialista. Nello stesso anno, al rientro di Paolo Davoli dal servizio militare (anch’egli di Cavazzoli, nato nel 1900), i due ebbero i primi incontri politici. Divennero inseparabili amici essendo accomunati dalle stesse idee politiche e anche il Davoli2 s’iscrisse alla federazione giovanile socialista appena fondata. Le «posizioni» politiche dei due si rivelarono però dopo diversi anni... Stava nascendo il fascismo, appoggiato dalle classi padronali e agrarie e chi aveva idee diverse era considerato un «sovversivo», una posizione che comportava forti rischi, come è noto. Dopo il congresso di Livorno, Cesare si avvicinò alle posizioni comuniste. Nel 1922 s’intensificarono le violenze squadriste, pertanto gli sparsi gruppi di aderenti alla federazione giovanile comunista dei quali Campioli era dirigente, dovettero muoversi in costante all’erta. Venne fondata a copertura della iniziale attività antifascista, un gruppo denominato «Giovani escursionisti reggiani», che organizzava gite sull’Appennino per poi trasformarle in riunioni politiche. 2 Un breve ricordo di Paolo Davoli (Sertorio) è doveroso. Fu importante figura dell’antifascismo e della Resistenza, uomo equilibrato ma coraggioso, anch’egli esule per lunghi anni a Parigi. Fu vero martire. Arrestato in circostanze fortuite il 2 dicembre 1944, dopo torture e atrocità subite, venne fucilato il 28 febbraio 1945 assieme a nove patrioti sulla SS 63 nei pressi di Villa Seta ove esiste un cippo memoria. 136 Le squadracce fasciste colpirono e si distinsero per viltà in un episodio della metà di febbraio del ’24. In quella fredda giornata, mentre Campioli si recava al lavoro, vide alcune persone in un campo adiacente alla strada per Cavazzoli vicino alla ferrovia Reggio-Ciano. Si avvicinò e vide un corpo steso nella neve con una macchia di sangue rappreso uscito dalla bocca. Chiese alle persone presenti, ma nessuno aveva identificato il cadavere. Con un doloroso presentimento riconobbe, chino sulla vittima, Antonio Piccinini, noto dirigente socialista candidato al Parlamento. Prelevato con la forza da un gruppo di squadristi la sera prima dalla sua casa, davanti alla moglie implorante e alle due figlie ancora bambine. Nel 1926, Campioli, ricercato dai fascisti, si spostò a Milano dove rimase quattro anni svolgendo clandestinamente attività sindacale all’interno delle officine Breda, fino al 1928. Autodidatta, dotato di forte carattere, in quel periodo arricchì le sue scarse nozioni tecniche studiando con impegno i manuali tecnici della Hoepli e frequentando corsi serali di perfezionamento sul disegno meccanico. Alla fine del 1929, avendo effettuato una breve visita ai famigliari e compagni di Reggio, venne riconosciuto e trattenuto quale «persona pericolosa», diversi giorni nel carcere di San Tommaso, poi rispedito con foglio di via a Milano ai primi di gennaio del ’30. Nel breve tempo trascorso coi fratelli, apprese con sgomento che alla fine del 1928 la casa paterna subì una irruzione da parte di una squadraccia fascista che si concluse con l’incendio della stalla. Del grave fatto si sentiva responsabile. A Milano quale schedato politico subiva opprimenti controlli e così decise di provare ad espatriare. Ottenne con difficoltà, aiutato da un compagno «introdotto», un passaporto per la Svizzera quale operaio specializzato, quindi con uno stratagemma passò in Francia. A Parigi si mise subito in contatto con Paolo Davoli e Pietro Montasini, riuscendo ad ottenere un primo precario lavoro. Nel luglio del ’30 faceva parte del direttivo della sezione parigina collegata con le correnti di sinistra, per la conclusione di un patto d’azione con i gruppi comunisti. Proseguendo nell’attività politica, partecipa ad Amsterdam nell’ottobre del ’32 ad un congresso internazionale contro il fascismo. Non soltanto uomo politico, Campioli a Parigi, migliorata anche la conoscenza della lingua, lavorò poi per dieci anni in una fabbrica meccanica ove imparò la costruzione di complesse macchine per la stampa: naturalmente premeva anche l’ordinario sostentamento personale. L’esperienza detta gli consentì, una volta tornato a Reggio, di impostare la prima organizzazione tecnica ad una importante attività legata alla produzione speciale di macchine da stampa per l’applicazione su corpi rotondi. Nel 1933-34 partecipa a vari congressi e continua nell’attività di coordinamento della dei gruppi comunisti sparsi nella grande città. Dal ’35 al 137 ’37 fu segretario di raggruppamenti di lingua italiana della sezione parigina del PCF e agli inizi del ’39, perdurando la guerra civile spagnola, reclutò uomini e organizzò raccolte di materiali. Il 5 giugno 1940 ha inizio l’occupazione tedesca della Francia. Campioli dopo lo sbandamento iniziale, si occupò della organizzazione per la diffusione della stampa clandestina nella capitale tessendo una rete di fidati collaboratori. Per circa tre anni, avendo anche aderito ai gruppi del Maquis, svolse rischiose attività varie cospirative contro l’occupante, collaborando attivamente ad atti di sabotaggio in zone militarizzate, muovendosi sotto il pericolo di essere scoperto dai tedeschi. Improvvisamente arriva dall’Italia il 25 luglio 1943, come una bomba, la notizia della fine del regime fascista: Mussolini esautorato dal re, Badoglio promosso capo del governo. I momenti di sfrenata gioia dovettero essere subito accantonati, poiché arrivò dalla direzione del PCI al Campioli la direttiva che i quadri comunisti emigrati dovevano subito trasferirsi in Italia. Il governo Badoglio però non aveva revocato i mandati di cattura relativi agli antifascisti. Infatti, Campioli era iscritto alla rubrica di frontiera di Bardonecchia, con scheda segnaletica riportante «provvedimento di arresto». Così dopo quattordici anni di permanenza, partì da Parigi con la famiglia che nel frattempo aveva formato, verso la fine di luglio. Giunto alla frontiera, dopo rapido controllo dei documenti, venne subito arrestato dai carabinieri e trasferito alle carceri di Susa assieme ad un compagno che poi rivelò essere Giuseppe Saragat. La famiglia fu fatta procedere. Fu trattenuto in carcere fino al 20 agosto, mentre Saragat fu liberato una settimana prima. Arrivò finalmente a Reggio ed ebbe la gioia di riabbracciare l’amico e compagno Paolo Davoli che lo attendeva in stazione. Davoli era rientrato in Italia nel ’39. Dopo un commosso saluto ai famigliari a Cavazzoli e sistemata la moglie e la figlia, venne subito incaricato dalla federazione di organizzare la creazione di un movimento unitario e allo scopo si incontrò alcune volte con l’avvocato Pellizzi. Seguirono alcuni sondaggi preparatori per concretizzare il 28 settembre nella canonica di San Francesco, in pieno centro, grazie alla coraggiosa ospitalità di don Lorenzo Spadoni, la prima riunione ufficiale del CLN reggiano. Interrompiamo la cronologia degli avvenimenti, per rendere noto un periodo legato alla assenza di Campioli da Reggio, dal luglio al settembre ’44. In tale periodo venne chiamato a dirigere la federazione comunista di Parma. In uno degli spostamenti in bicicletta legati alla nuova attività, fu fermato quindi arrestato da militi fascisti e da questi consegnato alla polizia tedesca, assieme al dirigente Giorgio Amendola col quale aveva appuntamento. Amendola si muoveva con falsi documenti intestati ad un certo avvocato Re di Roma e subito animatamente contestò il suo arresto. Dal viottolo periferico dove venero bloccati, i due, ammanettati, vennero caricati su un automezzo e portati in città in un grande edificio dell’istituto 138 case popolari e adibito a comando della polizia militare tedesca, la SD. Dopo quattro giorni preoccupanti trascorsi nella cantina dello stabile adattata a prigione, con la guardia fissa di brigatisti neri, senza comunicazione alcuna, alla sera sul tardi senza avere avuto nulla dello scadente solito cibo, Campioli venne fatto uscire e scortato all’ultimo piano dello stabile. Come scrive il Campioli stesso nel suo libro, «l’orario non lasciava presagire nulla di buono». Nella grande sala c’erano alcuni soldati seduti con le armi appoggiate sul tavolo; uno pareva un ufficiale ma non aveva il berretto e l’illuminazione era scarsa. Quello che parlava uno stentato italiano, disse bruscamente al prigioniero di avvicinarsi al tavolo; gli venne subito chiesto dei suoi rapporti nei confronti dell’avvocato Re, della sua identità e posizione. «L’atmosfera era molto tesa, si respirava un aria pesante: tutto aveva l’aspetto di un improvvisato tribunale piuttosto sbrigativo». (Campioli). Circa l’avvocato Re l’interrogato rispose, nel modo più naturale possibile, che non l’aveva mai visto e che non sapeva nulla sulla persona. Non insistettero. Per se stesso Campioli esibì (con molto coraggio!) un falso permesso, come emesso dal comando piazza (Ortskommandantur) di Reggio Emilia, autoredatto, con timbro e firma falsificati (testimonianza del nipote Raffaele raccolta dallo zio Cesare). Aggiunse come altro alibi, questo autentico, che la sua presenza a Parma era dovuta a pratiche che stava curando, relative alla morte di un suo cognato investito da un automezzo tedesco. Dopo un confabulare fra il presunto ufficiale e un collega, il primo si alzò, prese il telefono ed ebbe una lunga conversazione a tratti animata. Campioli sudava freddo: in condizioni psichiche provate, cercando di dissimularle, venne fatto alzare e preso per un braccio, accompagnato verso l’uscita. Il tedesco che parlava un po’ d’italiano lo guardava fisso con dura espressione del viso, ma non disse parola. Scortato nella cantina, in uno stato d’animo molto depresso, cercò di appisolarsi inutilmente. Gli mulinavano nella testa: quale poteva essere stato l’argomento oggetto della telefonata dell’ufficiale? E maggiormente un’altra preoccupazione assillante circa il «permesso» presentato: era davvero stato riconosciuto ufficiale? Trascorsero altri due giorni di angoscia e notti pressoché insonni senza ricevere nessuna informazione. Il guardiano della brigata nera non profferiva parola. Era forte la preoccupazione di finire lì i propri giorni! Ma al mattino del terzo giorno la guardia nera aprì la porta della cantina-prigione facendo cenno al prigioniero di uscire, dicendo in malo modo: «Puoi considerarti molto fortunato!». Campioli molto provato, subito temette di non capire. Dopo un attimo di smarrimento, raccattò in fretta due cose personali sparse sulla branda e uscì quasi incredulo nel corridoio. Non poté nulla dire ad Amendola dato che la cantina dov’era rinchiuso era nel corridoio opposto. Seppe in un secondo tempo che anch’esso fu liberato qualche giorno dopo. 139 Un gruppo di giovani escursionisti reggiani fra i quali è Paolo Davoli (il primo a sinistra, in alto). Ecco i loro nomi: fila in basso da sinistra a destra: G. Torelli, C. Campioli, A. Galingani, S. Iotti, A. Manghi. Seconda fila: P. Fantozzi, Cucchi, E. Ciroldi, Varini, G. Bertani, R. Gallingani. Terza fila in alto: P. Davoli, Riccardo Gallingani, R. Panciroli, A. Belloni, G. Orlandini. (L. Fanti, Paolo Davoli Sertorio, Quaderni del decennale 2, Reggio Emilia 1955) Riallacciandoci all’episodio sopraddetto, ci sembra importante precisare che l’esperienza acquisita a Parigi dove lavorò su macchine da stampa, procurò al Campioli una manualità di primo ordine. Infatti, dopo essere rientrato a Reggio, eseguì, con arnesi di fortuna un timbro a forma rotonda, ad imitazione di quello del comando tedesco, come si può notare nella riproduzione in calce. Va considerata la perizia dell’esecuzione. Si ritiene che nell’episodio dell’arresto di Parma, il timbro contribuì in modo determinante alla sua liberazione, avendo dato «ufficialità» al documento. Tornato a Reggio, trovò altri difficili momenti: apparivano proclami con minacce di pena di morte, in un’atmosfera di oppressioni e violenze e dove un minimo sospetto bastava ai fascisti per procedere ad arresti; automezzi tedeschi che circolavano e carri armati coperti da frasche dislocati in punti strategici. E venne finalmente il 25 aprile! All’alba dello stesso giorno, Cesare, stanchissimo, infreddolito, dopo una notte convulsa, emozionante ed insonne, si diresse a piedi verso la casa paterna con l’unico desiderio di dormire. Incontrò per strada, (oggi via Rinaldi) quasi di fronte alla chiesa, il compagno attivista militante Michele Rovacchi raggiante e 140 felicissimo dalle notizie apprese nella notte. Si scambiarono un forte abbraccio convulso e alcune frettolose, ma gioiose parole. Si divisero subito: Cesare in direzione della propria casa, mentre Michele, esultante e quasi ebbro, pedalava vigorosamente sulla sua vecchia bicicletta in direzione della città, agitando, col pugno chiuso, un braccio verso l’alto gridando: «Lèe finida! Lèe finida! Lèe finida!» (in un bel dialetto). (Testimonianza di un mio zio, Arnaldo Manghi, amico di Paolo Davoli, deceduto nel 1998. Nella foto di gruppo è l’ultimo in basso a destra). Oggi a Michele Rovacchi è stata intitolata una via a Cavazzoli, in seguito a una biografia inviata all’ufficio toponomastica, redatta da chi scrive. Anche Rovacchi era mio zio (paterno). Nei giorni immediatamente successivi, per disposizioni e accordi con il CLN, Campioli venne nominato sindaco della città e Pellizzi ebbe l’incarico di prefetto. BIBLIOGRAFIA C. CAMPIOLI, Cronache di lotta, Edizioni Guanda, Parma1965. L. FANTI, Paolo Davoli. Sartorio in «Quaderni del decennale», n. 2, marzo 1955. COMUNE DI REGGIO E, C. Campioli, operaio, antifascista, sindaco della Liberazione, (a cura di G. Soncini), Ed. Centro Stampa del Comune di Reggio Emilia, 1981. A. CANOVI, L’orma di Paolo, Ed. III Circoscrizione Comune di Reggio Emilia, 1991 FONTI Raffaele Campioli (nipote di Cesare) testimonianze; conserva il timbro «tedesco». Giulio Montanari la sua preziosa testimonianza su Enzo B. ha dettato l’episodio della tentata cattura. Ermes Tondelli memorie, «Due martiri una scuola»; manoscritto in proprio con annessa pianta di Cavazzoli e San Giulio, 1981. Alfredo Nizzoli (Bosco) e Franco Fabbi (Robert), appartenenti al gruppo SAP di Cavazzoli; testimonianza del 23 aprile 1947 sulle azioni dei medicinali al Casino Nobili e del burro alla cremeria di Sesso. 141 Una traversata sciistica Un ebreo in fuga dai nazisti Giulio Campagnano Giulio Campagnano, con la moglie Luisa Brolis, la nipote e un’amica. La foto è stata scattata dalla figlia Lidia negli anni Ottanta. Il racconto della fuga dall’Italia di mio padre, Giulio Campagnano, classe 1905, ha preso la forma scritta che segue quando noi figli eravamo ormai grandi o grandicelli. Nella sua forma orale, frammentata, carica di interrogativi, sentimenti e considerazioni tanto personali quanto politiche ed etiche, ha determinato fin dalla nostra prima infanzia il clima della convivenza familiare e l’indirizzo educativo di noi tre: Alberto, Marcella e la sottoscritta, nata dopo la guerra. Mio padre era un ebreo di Roma, le leggi razziali lo avevano privato del lavoro oltre che di ogni diritto. Sulle amate montagne del Nord aveva conosciuto Luisa Brolis, la figlia del veterinario di Verdello, in provincia di Bergamo: lei, cattolica, maestra di professione, disgustata dalle ruberie del fascismo, aveva osato la strada di quel matrimonio 142 anomalo, celebrato da un amico prete secondo il rito detto «paolino» previsto per i matrimoni con un coniuge non convertito, e la cerimonia si era tenuta a Bergamo il giorno precedente la promulgazione di quel dettato legislativo particolare che proibiva i matrimoni «misti». Gli sposi si stabilirono nel piccolo paese di campagna dove lui, laureato in giurisprudenza, si era messo a fare il contadino e allevava api e conigli. I contadini «veri» lo avevano accolto con rispetto e affetto: la loro diffidenza si rivolgeva alle sue proposte di innovazione delle tecniche agricole, piuttosto che al suo non frequentare chiese di sorta. La famiglia Brolis era molto amata a Verdello, ricca com’era di prestigio e povera di soldi, il che era un titolo d’onore, a quel tempo: significava onestà e generosità. Dopo l’8 settembre però nessuna protezione, né quella familiare né quella del paese, bastava più: sia a Verdello che a Branzi, dove la famiglia sfollava spesso a causa dei bombardamenti. Perché c’era, anche in quei paesi, chi aveva scelto di militare per la repubblica di Salò e per l’invasore tedesco, e cercava gli ebrei. Di qui la scelta – tormentata – di nascondersi in una baita nei pressi del borgo montano di Parre, e poi l’espatrio e, per la prima volta forse, quel sentirsi, nonostante le manifestazioni di solidarietà ricevute, (il «Polo» e il Bellarmino, tra gli altri, non uscirono mai più dai nostri ricordi) un senzapatria, un abusivo, un fuorilegge minacciato ogni giorno da pericoli che andavano facendosi sempre più chiari nel loro orrore. Una parte della famiglia romana di mio padre, infatti, fu deportata e sparì in un campo di sterminio, i nonni e gli zii si nascosero in un convento sul Gianicolo. Durante la permanenza in Svizzera, come risulta dai diari in forma di lettere ai suoi cari che mio padre ci ha lasciato, l’angoscia per la loro sorte insieme a quella per un futuro che non si riusciva a immaginare ma appariva disperato tormentava mio padre come tutti i suoi compagni di sventura, nonostante la coltivazione quotidiana, insieme alle patate, della dignità e della speranza, e il prepararsi a capire meglio il mondo e la politica per diventare capace di contribuire alla rinascita di quella che si ostinava a chiamare la sua patria. Tornò dalla Svizzera a Verdello nell’aprile del 1945, accolto da gente in festa che inseguiva vociando quel compaesano adottivo ricomparso all’improvviso a tutta velocità su una bicicletta presa in prestito. Perché a un certo punto decise di scrivere qualche memoria? Alla mia domanda rispose, semplicemente, che scrivere gli piaceva, ma credo che anche altro determinasse la sua scrittura: la percezione di un «voler dimenticare» che andava diffondendosi. Ricordo bene come, alle elementari e alle medie, io fossi l’unica a narrare di persecuzioni e di orrori nazifascisti: le mie piccole compagne non ne sapevano niente, e niente trasmetteva la scuola. Quel silenzio mi turbava. Se mio fratello e mia sorella hanno dovuto certamente confrontarsi con l’enigma della sparizione del papà dalle loro vite, anche la terza figlia recepì un complicato messaggio identitario : siamo (un po’) diversi da altri perché siamo inclini a ricordare cose diverse. Cose enormi, pesanti. 143 Cose che riguardano la Storia. Essere uguali è un ideale da raggiungere, un impegno, un attivo e consapevole essere parte dell’umanità che è una sola e ci accomuna. Mio padre esprimeva con parole sue quel che ha scritto Primo Levi: è accaduto, dunque può accadere di nuovo. Vigilare è un dovere e una necessità. Insomma, abbiamo ricevuto un’eredità. A questo serve, tra l’altro, la scrittura. Lidia Campagnano La fila dei sei uomini si snoda lentamente nella nebbia che nasconde la montagna, con gli sci che affondano nella neve, attraversa i canaloni che rompono il pendìo bianco, supera i costoloni che scendono dalle alte creste, raggiunge gli alti pascoli coperti dal manto nevoso dove le folate di nebbia e nevischio diventano più aggressive Eravamo partiti da Chiesa Val Malenco verso le tre del pomeriggio con l’intenzione di attraversare il confine al Passo del Muretto, oppure, in caso di presenza dei tedeschi a Chiareggio, più in alto, al Passo Tramoggia, che si trovava a circa tremila metri. All’albergo avevo lasciato mia moglie che mi aveva accompagnato fin là con mio cognato Tonio. Avevo riveduto mia moglie alla stazione di Bergamo dopo tanti giorni di separazione durante i quali ero stato in una baita sulle montagne della Val Seriana dove per tutto il mese di novembre avevo visto l’autunno ingiallire i boschi mentre le notizie giungevano frammentarie e confuse portate da quelli che fuggivano dalla città e venivano a rifugiarsi in montagna perché ricercati dai fascisti o dai tedeschi. Si era in dicembre e cominciava il triste inverno del ’43. Prima di partire Tonio era andato all’atrio della stazione ad incontrarsi con mia moglie Luisa e a vedere se ci fosse qualche controllo dai partenti da parte dei militi fascisti o tedeschi. Era ancora notte. Io ero rimasto solo, vicino a un muro che accresceva l’oscurità intorno a me; ero fermo e guardavo le ombre di quei pochi che si affrettavano verso il loro treno, ognuno con la propria sorte sulle spalle ingobbite dal freddo e dai loro pensieri: poi partimmo. Nel vagone quasi deserto e poco illuminato, sulle panche di legno, restammo a lungo in silenzio. Eravamo d’accordo che se ci fosse stato qualche pericolo per causa dei tedeschi o dei loro amici io dovevo essere considerato un estraneo, perché sarebbe stato inutile mettere nel rischio mia moglie e mio cognato. Pericoli ce n’erano sempre, in quei momenti. Quando arrivammo a Sondrio e cercammo di salire sulla corriera per Chiesa questa era così affollata che non riuscimmo a prenderla. Allora ci recammo a Chiesa con un auto a noleggio. La corriera venne poi fermata da militi fascisti che avevano controllato l’identità di 144 tutti i passeggeri, per fortuna senza conseguenze. E noi non eravamo provvisti neanche di documenti falsi che ci potessero proteggere. La proprietaria dell’albergo, alla quale eravamo stati indirizzati da un amico, era una donna dal fare cortese ma deciso, che aveva già aiutato altre persone a varcare clandestinamente il confine per sfuggire alla cattura e alla morte. Mandò subito ad avvertire le guide che dovevano accompagnarmi, ma queste non erano disponibili, ci dissero, perché già impegnate in montagna. Allora la piccola signora decise che da quel momento avremmo dovuto starcene nelle nostre stanze, anche per consumarvi i pasti, finché le guide non fossero tornate. Così avevamo passato due giorni in attesa. Finalmente le guide arrivarono e prendemmo gli accordi per partire il pomeriggio del giorno dopo. Era l’8 dicembre. Il cielo era coperto e si sentiva nell’aria la nevicata imminente. Con Tonio attraversai il paese seguendo a distanza una donna che portava nascosto nel gerlo il mio sacco da montagna con quelle poche cose da portare con me in Svizzera. Giunti in mezzo alle case di una frazione al di là del torrente ci eravamo ritrovati nella casa di «Polo», guida alpina, espertissimo della montagna, così appellato perché era stato con il capitano Sora al Polo Nord alla ricerca di Nobile e dei dispersi del dirigibile «Italia». Con noi veniva anche il portatore Bellarmino. Da quella casa avevamo preso il sentiero per la montagna. I miei passi avevano preso il ritmo del lungo cammino, staccandomi dai miei, da mio cognato, che dopo un furioso abbraccio non aveva più la forza per salutarmi, appoggiato all’angolo di una delle ultime case. Era lì contro il muro di sassi di quella povera casa di montanari e anche lui era una sembianza umana che esprimeva il dolore di tutti in quei momenti, il dolore della nostra miseria già visibile in quei sassi contro i quali sosteneva la sua pena come alla ricerca di una solidarietà che lo aiutasse: il dolore del ’43, della nostra gente che pure mi dava aiuto con quei due uomini che mi conducevano verso la salvezza senza essere nemmeno sicuri della loro salvezza, loro che restavano, come tutti i miei, in una Italia dove non c’era più pace per nessuno. Pernottammo in una baita al limite del bosco dove cominciavano i pendii nevosi. La sera era giunta presto, anzi più presto perché il cielo era grigio, era sempre stato grigio nei giorni precedenti, o così mi era parso e, al calore del fuoco acceso nel camino, nel fumoso ambiente, ancora e ancora mi apparivano i visi dei miei cari, i musini dei miei due piccoli che avevo lasciato. Perché non erano con me? Perché io dovevo salvarmi? C’era forse una maggiore sicurezza per loro, per tutti loro che erano rimasti a casa?... Già dopo l’8 settembre io avevo pensato ad organizzare un nostro esodo in Svizzera, con moglie e figli, da Branzi dove ci trovavamo in previsione di quello che sarebbe successo. Ma poi mi ero lasciato convincere che il tentativo era troppo incerto per l’incolumità e per la salute dei miei piccoli, di due e quattro anni. Avevo fatto bene o 145 male a rinunciare? Ora che ero nel vivo della realtà, non solo nell’astratto di una previsione, mi rendevo conto che il mio espatrio mi aveva reso uguale a tutti coloro che avevano subito il terrore dei bombardamenti nelle città, la deportazione nei vagoni piombati, il ferro nelle carni piagate, uguale nella coscienza del nostro tormento e delle nostre miserie. E con quale speranza? Non lo sapevo e tuttavia me ne andavo in cerca di salvezza. Alla baita è giunto un altro fuggiasco, anche lui accompagnato da due guide. Anche lui ha lasciato la moglie ed una bambina che si ritengono protetti da una religione che non è la sua. Non conosce l’uso degli sci e quando al mattino iniziamo la lunga traversata nella neve alta, solo la sua volontà tenace lo aiuta a procedere faticosamente per ore ed ore. Dobbiamo tenerci alti perché sappiamo della presenza di alpini tedeschi in fondovalle. Il tempo cattivo ci protegge per tutta la lunga salita con nebbia e raffiche di neve che ci occultano alla mira di ogni binocolo che scruti la montagna. Attraversiamo colatoi e canaloni con le cautele suggerite dal «Polo» per evitare di provocare una valanga, seguiamo la profonda pista tracciata dal primo della fila sollevando lo sci ad ogni passo. La fila degli uomini procede lentamente mentre le guide si alternano a battere la pista che si snoda fra boschi e rocce e poi fra gli alti pascoli coperti da una neve pesante nella quale si affonda fino a mezza gamba. Altre volte avevo fatto lunghe, lunghissime traversate sciistiche sulle deserte montagne dell’Abruzzo e sulle Alpi, durante un’intera giornata iniziata fin dalle ore notturne e il mio essere aveva segretamente gioito di quelle marce che mi portavano in alto, in zone desertiche e silenziose dove il ricordo delle mie letture giovanili su esplorazioni di terre nuove mi esaltava come se ritrovassi lo spirito di avventurose spedizioni. Anche ora i miei muscoli rispondono bene alla durata dello sforzo. Ma ora non mi trovo con una spensierata compagnia di amici, ora c’è una diversa atmosfera. L’impegno della salita è uguale e sembra distogliere il pensiero da tutto quello che sto lasciando dietro di me, ma l’aria, la stessa montagna sembrano diverse, non sono fini a se stesse, non mi danno il piacere di respirare profondo, il piacere della mia forza e del paesaggio che mi circonda. Anche senza pensarci mi accompagna la sensazione della stranezza che in piena guerra io stia facendo dello sport sciistico mentre a poca distanza da me altri uomini stanno facendo questa guerra che colpisce tutti e potrebbe colpire anche i miei più cari. La punta dei miei sci si apre la pista in una neve che sembra grigia e ostile come la montagna intorno a confronto con la neve e con le cime dell’Abruzzo quando entravano a far parte del mio godimento e rispondevano lietamente al mio muto richiamo. Ora l’8 settembre è scoccato come l’ora della nostra condanna e, mentre nelle città e nelle pianure gli uomini neri hanno ripreso a sferzare le turbe sotto lo sguardo freddo dei padroni tedeschi, nelle vallate alpine stanno ancora uomini che si sentono liberi perché lontani da un supposto fronte di guerra, 146 uomini che si cercano per unirsi ed organizzare qualcosa, uomini che per primi hanno fatto una scelta per far rinascere in tutti una speranza, e le valli sono percorse in su e in giù da gente ancora incerta sulla propria sorte e su quella di tutti gli Italiani. Sostiamo per un breve riposo presso una baita chiusa e la porta serrata in mezzo al muro grigio della facciata, nella luce fredda di un cielo chiuso, accresce il senso dell’indifferenza delle cose dinnanzi al tormento degli uomini. Il mio compagno, spossato dalla fatica inconsueta, non ha più la forza di parlarmi e siede abbandonato su di un masso con la buffa testa ricoperta da un turbante di astrakan nero donatogli dalla moglie al momento della fuga e sembra che la sua testa, divenuta più grossa, sia spinta sempre più in basso da un enorme peso. Eppure è un uomo giovane e sereno, come lo conobbi poi durante la nostra convivenza in Svizzera, fornito di un temperamento serio, da scienziato, che svolse infatti felicemente, durante l’internamento, la sua attività di chimico e che, dello studioso astratto dalla realtà quotidiana, conservava una specie di ingenuità fiduciosa verso gli altri, lasciandosi guidare da chi lo preservava dalle asperità pratiche della vita. Riposiamo per un po’ davanti a quella baita, in silenzio, uomini di temperamento e di abitudini diverse che la guerra ha riunito su quello spiazzo nevoso e che sentono tuttavia di essere uniti da una solidarietà che supera le diversità esistenti specialmente tra noi due profughi e le guide, sebbene tra me ed esse la comune conoscenza della montagna e la mia abitudine ad avvicinare la gente dei monti attutiscano quella differenze. Ma il mio compagno ed io siamo sempre per le guide gente di città ed è diverso il tono con il quale i montanari parlano fra loro e il tono con il quale si rivolgono a noi due. Soltanto il «Polo», il buon Pedrotti, da uomo che è disposto a sacrificare anche la vita pur di mantenere l’impegno di salvarci, ha una nota nella voce che, anche se consapevole di essere il capo guida, quando si rivolge a noi si attenua in un tono quasi paterno. Riprendiamo la salita, ancora per ore in silenziosa lotta con il pendio, spesso ripido, nella neve alta e pesante e la nebbia che a volte ci avvolge da vicino e diventa più fitta e poi più scura ci annuncia che il sole sopra di essa si avvia al tramonto e che si avvicina la sera. Finché usciamo dalla nebbia e vediamo vicino il Passo del Muretto con il palo che segna il confine. Lo raggiungiamo che è ormai sera e il vento ci investe con raffiche che vengono dal versante italiano. Mi volto per un muto appello e mentre ricevo sul volto le folate di neve sollevata dal vento guardo all’orizzonte lontano la sagoma scura delle Alpi Orobiche stagliarsi nell’oscurità rossastra. Distinguo il Pizzo del Diavolo e le altre cime vicine, vicine ai miei cari che stanno in montagna in quel paese di Branzi dove ho vissuto tanto tempo accanto a loro, quando le notizie giungevano lassù dalla pianura con gli uomini che ne fuggivano le notti illuminate dai bombardamenti e i giorni carichi di minaccia opprimente. 147 Care montagne bergamasche, dove mi sono aggirato tante volte solo o con i miei amici e parenti montanari, con mia moglie, la mia compagna forte e sensibile, con il mio piccolo che mandava avanti le sue gambette quando poteva scendere dalle mie spalle e mi accompagnava come un ometto dallo sguardo pensoso, come se intuisse ciò che ci sovrastava!... La nostra vita a Branzi! Ormai ci consideravamo quasi dei montanari e quando i miei giovani cognati, che pure volevano sfuggire ai bandi di chiamata alle armi del regime fascista, venivano con me a far legna nei boschi per l’inverno imminente sembrava che tutto dovesse continuare così, che la montagna ci avrebbe protetto senza un preciso atto di volontà da parte nostra per dare agli avvenimenti una svolta decisiva verso la liberazione dalla guerra, dalla violenza, dalla paura. Ora dovevamo prendere la discesa su Maloia. Era notte, ma la luna ci illuminava nel gelo del versante nord, in un cielo libero, in una luce che ci permetteva di evitare il letto dei torrenti nascosto e reso insidioso dalla neve che li copriva. Ci rifugiamo un po’ in una baita a mangiare qualche cosa bevendo grappa a grandi sorsate rese inoffensive dal grande freddo e riprendiamo subito la discesa. Il mio compagno ora non ne può più, si è già lasciato andare sulla neve più volte dichiarando di non volersi più muovere. Le sue guide ormai vorrebbero liberarsene, essendo in territorio svizzero e ci vuole tutta la mia energia per imporre loro di assisterlo fino in vicinanza dell’abitato. Siamo giunti infine a poche centinaia di metri dalle prime case di Maloia e lì ci separiamo dalle nostre guide che ritornano indietro con i nostri sci legati sulle spalle. Do al caro «Polo» il compenso pattuito: veramente irrilevante in confronto al loro rischio e alla loro fatica, e una lettera già preparata per annunciare ai miei il mio arrivo in Svizzera, che il Pedrotti si è offerto di impostare al suo ritorno a Chiesa, ed infine stringo forte la mano a lui e al Bellardino staccandomi da loro come se lasciassi due fratelli. Seguito dal mio compagno al quale ho cercato di infondere ancora un po’ di energia, prescrivendogli di calcare addirittura le mie orme, affinché non si lasci cadere nella neve, mi avvio verso le case silenziose nel freddo notturno in cerca di un rifugio. 148 Il «San Lazzaro» e il movimento antimanicomiale italiano L’esperienza reggiana Intervista a Christian De Vito Francesco Paolella Christian De Vito è un giovane storico, che si occupa da tempo della storia del sistema penitenziario italiano, tema a cui ha dedicato anche la tesi di laurea in storia contemporanea, all’università di Firenze. Si è quindi perfezionato alla Scuola normale superiore di Pisa. Si interessa anche di storia della psichiatria, di politiche migratorie e di altri ambiti del welfare. Nel 2009 ha pubblicato per i tipi della casa editrice Laterza Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia. Lo abbiamo incontrato a Bologna, nell’ottobre 2009. Perché hai deciso di dedicarti alla storia del carcere nell’Italia del Novecento e poi di scrivere questo libro? Tutto è partito dalla mia tesi di laurea. Volevo impegnarmi in una ricerca di storia sociale sull’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Inizialmente non avevo pensato alla realtà del carcere, che non conoscevo. Anche in seguito, del resto, ho inteso dare un taglio non soltanto istituzionale al mio lavoro, considerando il carcere come un osservatorio dell’Italia degli anni del boom e della stagione dei movimenti. Il filo conduttore della mia ricerca, che ha portato a una tesi di 1200 pagine, è stato appunto il tentativo di leggere la storia sociale italiana attraverso il carcere, da dietro le sbarre per così dire. Ho cercato di far emergere la dialettica fra la realtà carceraria italiana e le spinte che premevano dall’esterno su di essa. Per il libro, poi, ho ulteriormente accentuato questa impostazione, provando a rivolgermi soprattutto ai non specialisti di carcere: se la «questione carcere» è in primo luogo una grande questione sociale, è giusto che tutti ne siano informati e possano farsene un’opinione. Ed oggi continui ad occuparti di questo tema. Sto per cominciare una ricerca per l’università di Lovanio, in Belgio. Approfondirò il periodo più in ombra del secondo dopoguerra, quello fra il 1945 e il 1968, gli anni del «carcere pacificato»: in quella fase è cambiata la popolazione carceraria, ma il carcere è rimasto una realtà impermeabile, del tutto chiusa, nella quale sono falliti tutti i tentativi di riforma. Era presente 149 allora una prospettiva soltanto tecnica di cambiamento, una utopia tecnicistica affermatasi negli anni Cinquanta che è poi crollata con i movimenti del ’68. Negli anni Cinquanta di carcere parlavano soltanto giuristi, tecnici, criminologi. È stato dal ’68 che a parlare di carcere sono stati anche altri soggetti, in primo luogo i detenuti stessi. In quest’ottica, mi interessa ora una prospettiva comparativa con il caso belga e con quello francese, che mi può permettere di allargare la riflessione anche su altri aspetti della storia sociopolitica e culturale: il problema dell’epurazione nel dopoguerra; la circolazione delle idee criminologiche e giuridiche a livello europeo; il ruolo del volontariato e lo sviluppo dell’assistenza sociale; il rapporto tra religione e concezione della pena. Tu da molto tempo hai affiancato all’attività di ricerca quella di militante nei movimenti per i diritti dei detenuti. Sì, questo intreccio di ricerca e attivismo è iniziato il giorno stesso in cui ho deciso di occuparmi di carcere, quando ho telefonato al carcere di Sollicciano, a Firenze, ed ho iniziato anche a lavorare come volontario dall’altra parte del muro di cinta. Sono poi nati a Firenze una serie di gruppi per favorire il collegamento fra detenuti e società esterna. Ho fatto parte del gruppo «Istituzioni totali» del Firenze social forum, alla cui base stava l’idea che le politiche neoliberiste comportano un inevitabile maggiore ricorso alle pratiche di esclusione sociale, fra cui, non ultimo, anche il carcere. Dal 2004 è poi sorto il gruppo «Dentro e fuori le mura», per metà formato da ex detenuti e legato alla commissione interna del carcere di Sollicciano. Successivamente è anche nato un coordinamento, «Voci dal carcere», composto sempre da ex detenuti, membri di associazioni di volontariato e attivisti. Oggi sono presidente dell’associazione «Liberarsi» (per info: www.informacarcere.it), composta di detenuti, in particolar modo ergastolani, e che si batte, con la campagna «Mai dire mai», per l’abolizione dell’ergastolo. A mio parere il collegamento tra ricerca e militanza è fondamentale. Una cosa richiama l’altra: l’attivismo permette di superare una visione tutta accademica dell’argomento studiato; il lavoro di ricerca consente di dare una base solida all’intervento politico e sociale, che altrimenti rischia di trasformarsi in un’affannosa rincorsa alle emergenze. Tendo a vedere il mio lavoro come una permanente attività di inchiesta, che tiene insieme la ricostruzione del passato e lo sguardo sull’oggi, l’attenzione scrupolosa alla critica delle fonti storiche e l’ascolto dei molti punti di vista che si intrecciano nel tessuto sociale, nei tanti luoghi di cui è fatta la società. Mi piace pensare in verità che la ricerca possa diventare in futuro qualcosa di molto più democratico, di radicalmente democratico: non il prodotto del lavoro di un singolo studioso, ma il frutto di un processo collettivo di memoria e di conoscenza; non l’attestazione di chissà quale dote accademica individuale, ma l’affermazione della soggettività di tutti coloro che sono protagonisti di 150 quella parte di storia sociale che si intende ricostruire. Penso per questo ad esperienze del passato recente, che sarebbe bene riprendere in mano: la conricerca dei «Quaderni Rossi», le «150 ore», la rivista «Inchiesta», per restare in Italia; ma credo che bisognerebbe anche abituarsi a guardare oltre i confini, ad esempio verso i Subaltern Studies indiani, la storia orale brasiliana, la pratica di inchiesta dei paesi scandinavi. Hai avuto molte occasioni di presentare il libro in un carcere? Tutto dipende dalla disponibilità dei direttori, ovviamente. Sono stato nel carcere di Lauro (un carcere molto piccolo vicino ad Avellino), nella casa di reclusione di Padova, presto sarò nel carcere di Bollate, a nord di Milano (una grossa struttura, con circa 950 reclusi) e poi andrò nello storico penale di Porto Azzurro. Le presentazioni in carcere sono discussioni serrate, non facili per me anche dal punto di vista emotivo. Parlare di storia del carcere in un carcere vuol dire incontrare persone che hanno vissuto in prima persona quei passaggi storici che io ho cercato di descrivere nel mio libro e che vivono anche oggi, quotidianamente, la detenzione. Veniamo al tuo libro e partiamo dall’attualità. L’ultima parte di Camosci e girachiavi è dedicata al tema del passaggio dallo stato sociale allo stato penale. Negli ultimi venti anni si è verificata un’importante crescita del numero di persone non soltanto passate per le carceri, ma in generale coinvolte nella più ampia area penale. Volendo sintetizzare: oggi il carcere è soprattutto per migranti («clandestini») e tossicodipendenti. Quali sono le ragioni di questo boom penitenziario? Tu in particolare parli di neoliberismo, di globalizzazione economica, di mutamenti radicali nel discorso politico sulla criminalità. Per vedere cosa c’è nel carcere, secondo me bisogna porsi da un punto di vista esterno al carcere. Tutta la letteratura più recente insiste sulla connessione fra politiche neoliberiste e processi di ricarcerizzazione: è quindi un fenomeno non solo italiano, anche se nei diversi paesi ha assunto dinamiche differenti; ad esempio in Gran Bretagna si è assistito a un vasto fenomeno di criminalizzazione dei minori. Ad ogni modo, anche in paesi che vantano una forte tradizione abolizionista, come quelli scandinavi o i Paesi Bassi, il numero dei detenuti è triplicato. In Italia la situazione attuale deriva, a monte, dalla tendenza a condannare a pene più lunghe (gli stessi ergastolani sono passati in venti anni da 300 a 1500) e ad inasprire la repressione verso tossicodipendenti e migranti, a partire dai primissimi anni Novanta con la legge Martelli sull’immigrazione e la legge Jervolino-Vassalli. Inoltre, un ulteriore, progressivo restringimento si è avuto in uscita dal carcere. In particolare tre fattori hanno contribuito a ciò: l’ampliamento dell’area dei reati ostativi (quelli cioè che impediscono di accedere a misure alternative al carcere); la scarsità di organico della magistratura di sorveglianza (fra l’altro schiacciata dalle pressioni sociali contro 151 le «scarcerazioni facili»); le difficoltà nel trovare una casa e un lavoro una volta usciti dal carcere. Esiste infine una specificità legata ai migranti, per i quali formalmente vale il diritto alle misure alternative, ma che, essendo assai di frequente senza permesso di soggiorno, passano dal carcere ai Centri per l’identificazione e l’espulsione (CIE, ex CPT). Nella lettura securitaria dei fatti sociali c’è stata una sostanziale continuità fra governi di centro-destra e governi di centro-sinistra. È una tendenza accentuatasi con il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica: la dottrina sociale cattolica ed il punto di vista socialdemocratico in questo campo sono stati messi da parte. Il discorso politico si è trasformato in una rincorsa a provvedimenti sempre più repressivi. Non voglio con questo banalizzare le differenze pure esistenti fra le diverse idee di governo, ma si tratta a mio parere soltanto di sfumature: il centro-sinistra ha sempre cercato di coinvolgere anche in questo campo gli enti locali, territorializzando il più possibile le politiche sulla sicurezza; il centro-destra, invece, ha un’impostazione più centralista (si pensi al decreto Maroni, dell’agosto scorso). La differenza è appunto quella che intercorre fra i «patti per la sicurezza» e il «pacchetto sicurezza». Il risultato di tutto questo è sotto gli occhi di tutti o, almeno, di chi vuole vedere. Oggi assistiamo a un aumento vertiginoso dei nuovi ingressi, che nella storia carceraria dell’Italia repubblicana eguaglia soltanto la situazione dell’immediato dopoguerra: c’è un saldo di mille persone in più ogni mese, fra il numero delle persone che entrano in carcere e di quelle che escono. Da tutto ciò non possono che derivare condizioni intollerabili di sovraffollamento, ossia problemi sanitari, igienici, psicologici. In sostanza: un drammatico peggioramento nelle condizioni di vita delle persone detenute. A qualche anno di distanza, come giudichi a questo proposito non l’indulto in sé, ma gli usi politici dell’indulto, le speculazioni politiche e mediatiche, nell’ambito dell’ideologia della «sicurezza»? L’indulto era necessario, a fronte delle condizioni inumane di detenzione. Sarebbe stato necessario che fosse accompagnato da una svolta politica, nel senso della riforma del codice penale e dell’ampliamento delle misure alternative. La speculazione politica e mediatica sull’indulto è andata invece in direzione opposta, rivelandosi funzionale all’ulteriore rafforzamento delle politiche repressive. L’uso politico della sicurezza muta il vocabolario politico, modifica l’ordine del discorso, la percezione della realtà. Un solo esempio: i migranti finiscono di più in carcere a causa di precisi meccanismi di selezione penale, e invece la loro carcerazione viene usata come argomento per dimostrare la loro maggiore pericolosità. Cosa resta dello spirito della legge Gozzini, a più di vent’anni dalla sua approvazione? È uno strumento ormai svuotato? 152 Quella legge, promulgata nel 1986, si riferiva a un tipo di detenuti che è ormai minoritario. Pensava a un carcerato di nazionalità italiana, riconosciuto colpevole di un tipo di reato che aveva in sé un’assunzione di responsabilità che poteva evolversi nell’accettazione di un percorso di reinserimento. Il che con ogni evidenza non corrisponde all’attuale carcere della «detenzione sociale», che rinchiude in larga maggioranza persone imputate o condannate per reati legati alla clandestinità o alla tossicodipendenza. Della legge Gozzini è venuto così in primo piano l’aspetto «premiale» e questo ha finito per contribuire alla desolidarizzazione del carcere, ha individualizzato i detenuti, ovviamente interessati soltanto ai possibili benefici e non più ad una rivendicazione collettiva dei diritti. A vederlo dal punto di vista dei detenuti, questo aspetto rappresenta un fattore di netto peggioramento rispetto al passato. Dalla lettura del tuo libro, spiccano inevitabilmente gli anni Settanta, con i diversi interessi politici sul mondo penale e penitenziario (e, più in generale, sulle «istituzioni totali»), come momento storico in cui le carceri, i bisogni e le voci sommersi in quei luoghi, sono riusciti a rompere l’isolamento, la chiusura radicale a cui erano state condannate. Penso in particolare all’esperienza di Lotta continua nei primi anni Settanta. Lotta continua, ma non solo: anche gli anarchici, il Soccorso rosso, Potere operaio, riviste come «Re Nudo»... Però in effetti Lotta continua è intervenuta in maniera più sistematica sul carcere. Secondo Lotta continua il carcere era per il sottoproletariato l’equivalente di quello che la fabbrica rappresentava per il proletariato, ossia un luogo di oppressione, ma anche di potenziale rivolta. In realtà, dentro il movimento c’erano ampi settori che di carcere e sottoproletariato non volevano occuparsi. La «Commissione carceri», attiva fra il 1971 e il 1973, era composta da non più di quindici persone, favorita in quella fase dalla linea politica con cui Lotta continua voleva appunto aprirsi dalle fabbriche verso il territorio. Si è avuta allora una relativa sensibilizzazione dei movimenti verso il mondo carcerario e contemporaneamente le carceri sono state attraversate da un moto autonomo di politicizzazione di strati della popolazione detenuta. È andata così un po’ in tutta l’Europa occidentale, dove tra il 1968 e il 1969 sono nati movimenti collettivi dei detenuti. Quegli anni hanno rappresentato una cesura netta, segnata anche da rivolte violentissime, impensabili fino a pochi anni prima. Questi due processi – politicizzazione all’interno e sensibilizzazione all’esterno – si sono in parte incrociati: i militanti arrestati hanno incontrato i detenuti comuni, che già si stavano muovendo. Sono gli anni del caso di Valpreda, e poi del Soccorso rosso per i detenuti. A mio avviso è molto interessante la differenza di impostazione di atteggiamento verso il carcere fra Lotta continua e i gruppi della lotta armata. 153 Lotta continua non puntava tanto alle evasioni, quanto piuttosto a creare gruppi dentro le carceri e mantenere il più possibile contatti con l’esterno. I gruppi di lotta armata, invece, davano del carcere un’interpretazione solo ideologica: avevano il punto di vista esclusivo della detenzione politica. Lotta continua, invece, non tralasciava una lettura sociale del carcere. Una riflessione particolare merita in questo senso il caso dei NAP, gruppo armato formato in larga parte da detenuti comuni che, abbandonati da Lotta continua a metà degli anni Settanta ed esposti ad una repressione crescente, finirono per fondersi con le Brigate rosse. La loro esperienza rappresenta un punto fondamentale nel passaggio dai gruppi parlamentari ai gruppi della lotta armata. E gli anarchici? Anche gli anarchici avevano nella loro tradizione una lettura sociale del carcere (pensiamo a Emma Goldman), ma sono rimasti sul piano del «fuoco alle galere», affermazione di un’opposizione tutta identitaria verso il carcereistituzione. Non hanno puntato a creare una forza interna al carcere, ritenendo che questo avrebbe implicato una legittimazione dell’istituzione penitenziaria. In sintesi, come ti sentiresti di descrivere i cambiamenti della popolazione carceraria italiana dal secondo dopoguerra? È esistita senza alcun dubbio una continuità di fondo: la popolazione detenuta rispecchia costantemente l’emarginazione sociale, rappresenta una selezione dall’universo dei «devianti». In questo contesto generale, la discontinuità è relativa al tipo di gruppi repressi nei vari decenni attraverso il carcere: negli anni del miracolo economico, erano gli immigrati meridionali i più colpiti, mentre con gli anni Ottanta e poi negli anni Novanta sono stati i tossicodipendenti il principale obiettivo, poi gli immigrati. L’altro elemento da considerare è quello della repressione politica. Proseguendo a ritroso, il tuo libro incomincia dalla Repubblica di Salò: il mondo carcerario è stato davvero un segno esemplare dell’agonia del regime repubblichino. Quello era davvero un regime che voleva essere totalitario e che è stato senza dubbio il più arbitrario. Nel libro ricordo la formula usata da John Foot, quella di «anarchia nella dittatura», ossia la completa assenza di legalità e ordine, pur pretendendo di disciplinare tutto. Guardare alla RSI da dietro le sbarre permette di osservare bene questo aspetto fondamentale della storia di quel periodo. Un’altra questione storiografica centrale è quella del ruolo delle carceri nel processo di deportazione dall’Italia, nell’ambito più ampio del rapporto fra autorità fasciste e naziste. Queste ultime hanno istituito propri uffici nelle carceri italiane – è un aspetto ancora poco studiato – finendo per utilizzare il carcere per meri motivi di repressione poliziesca, al fine della deportazione. 154 E come sintetizzeresti una storia dei rapporti fra sistema penale italiano e sinistra istituzionale? Nella sinistra istituzionale è sempre prevalsa una visione da ordine pubblico del carcere, senza una vera apertura alla questione sociale. Esempio lampante di questa prospettiva è stato nel dopoguerra l’atteggiamento del guardasigilli Togliatti verso le rivolte nelle carceri. Per giustificarne la repressione egli è arrivato a usare l’argomento – del tutto pretestuoso, come ho potuto verificare – che quelle proteste erano di marca fascista. La stessa impostazione è poi ricomparsa contro la lotta armata e, in verità, contro l’insieme assai eterogeneo dei movimenti sociali che erano attivi in Italia sul finire degli anni Settanta. In questa visione tutta statalista, il carcere appare come un’istituzione pienamente legittimata, le cui contraddizioni rispetto allo sviluppo politico e sociale sono poste sullo sfondo o completamente rimosse. Se si segue questo filone di pensiero lungo i decenni, non stupisce poi, giunti agli anni Novanta e alla fase attuale, la sostanziale e massiva adesione della sinistra «di governo» al discorso securitario. Da un punto di vista storico, colpisce inoltre la scarsa preparazione della sinistra istituzionale sulla questione carceraria, dall’epoca della Costituente fino almeno agli anni Settanta. La principale eccezione è rappresentata dal Centro per la Riforma dello Stato, legato alla sinistra del PCI, da cui è emersa la sinistra garantista (oggi rappresentata ad esempio dall’associazione Antigone) che, sia pure minoritaria, negli anni Settanta ed Ottanta ha saputo collegarsi al mondo degli indipendenti cattolici, come lo stesso Gozzini, svolgendo un ruolo centrale nella riforma penitenziaria. Nel corso delle tue ricerche, ti sei anche occupato diffusamente del caso reggiano, dedicandogli la tesi di dottorato, I «tecnici ragazzini». Operatori sociali, medici e tecnici nei movimenti degli anni Settanta a Reggio Emilia. Hai anche pubblicato un saggio sui «saperi speciali» in un recente volume sugli anni Settanta a Reggio (Tempi di conflitti, tempi di crisi. Contesti e pratiche del conflitto sociale a Reggio Emilia nei «lunghi anni Settanta», a cura di L. Baldissara, L’ancora del Mediterraneo, 2008). In particolare, ti sei dovuto occupare delle lotte contro il manicomio del «San Lazzaro» come «istituzione totale». Che cosa ha significato quel movimento? Penso anzitutto evidentemente alla creazione nel 1969 del Servizio psichiatrico provinciale e alla figura di Giovanni Jervis, a capo del Servizio fino al 1975. L’esperienza reggiana rappresenta senza dubbio un lato specifico e originale del movimento antimanicomiale italiano. Ha rappresentato anzi un modello, alla cui base stava l’idea di chiudere il manicomio attraverso la costruzione di un sistema di servizi dall’esterno, sul territorio, in alternativa e senza contatti con l’ospedale psichiatrico. Era il modello opposto a quello seguito a Gorizia, ad Arezzo, a Perugia, dove lo smantellamento dell’istituzione manicomiale si è sviluppata dall’interno dell’ospedale psichiatrico stesso. 155 A Reggio si voleva costruire un filtro davanti alle porte del manicomio, per prosciugarlo, per così dire. Ossia: lavorare sul territorio per evitare i ricoveri. Credo si possa dire che quel tipo di intervento, pur presentando caratteristiche molto affascinanti, ha fallito storicamente il suo compito: il «San Lazzaro» è stato chiuso (molto lentamente) a seguito della legge 180 e non per l’azione del Servizio psichiatrico provinciale. Del resto, è quanto è successo anche all’estero, in tutti i casi in cui si è cercato di svuotare i manicomi dall’esterno: ospedali psichiatrici e servizi territoriali hanno semmai diversificato le utenze, senza che si sia pervenuti ad una effettiva chiusura dei primi. E su Jervis, che è scomparso nell’agosto scorso, cosa ti senti di dire? Colpisce senza dubbio l’acredine di Jervis verso Basaglia e i basagliani, la sua insistenza nel definire Psichiatria democratica come un gruppo iperpoliticizzato, che avrebbe impedito un lavoro più prettamente teorico e clinico. La tesi è stata ripetuta più volte da Jervis e ha trovato una sua esposizione particolarmente chiara e dura nel libro scritto con Gilberto Corbellini (La razionalità negata. Psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati Boringhieri, 2008). In parte, la posizione di Jervis merita di essere approfondita perchè rimanda al suo interessante percorso di formazione personale, che lo ha visto ad esempio lavorare con De Martino alla fine degli anni Cinquanta nelle ricerche sul tarantismo. Da questa formazione derivava sicuramente la tendenza ad accentuare l’importanza di una preparazione tecnica. Del resto Jervis già a metà degli anni Settanta e proprio a seguito dell’esperienza reggiana ha scritto il Manuale critico di psichiatria, che sin dal titolo mostra il suo punto di vista peculiare nel dibattito tra psichiatria, psichiatria democratica e antipsichiatria. A mio avviso comunque è un errore non riconoscere che è poi stata proprio la componente politica del movimento ad aver consentito il superamento di un discorso soltanto tecnicistico sulla psichiatria, a mostrare l’esclusione manicomiale anche come esclusione sociale, a determinare la chiusura di quelle istituzioni della violenza che sono stati gli ospedali psichiatrici. Nel non riconoscere questo aspetto, la polemica di Jervis è onestamente fuorviante: definendo «antipsichiatrico» l’intero movimento antimanicomiale italiano, egli ha rimosso non solo le profonde differenziazioni interne a quel movimento, ma anche l’elemento di distinzione di esso dall’antipsichiatria di derivazione anglosassone, che è stato proprio nella capacità del movimento italiano di uscire da una dimensione puramente tecnicistica, ponendo al centro le contraddizioni della dimensione sociale e politica del sapere e della prassi psichiatrica. «Accanto» a Jervis c’è stato a Reggio, in montagna, Giorgio Antonucci, psichiatra antipsichiatra. È interessante pensare alla convivenza, nella Reggio dei primi anni Settanta, fra Jervis e Antonucci. Rispetto a quella di Jervis e a quella basagliana di 156 Gorizia e poi di Trieste, l’esperienza di Antonucci ha rappresentato infatti un terzo modello di negazione dell’istituzione psichiatrica. Antonucci aveva un riferimento teorico soprattutto nell’antipsichiatra statunitense Thomas Szasz, ma ha cercato di radicare il discorso dell’antipsichiatria nel contesto sociale, a partire dalla zona della montagna dove operava. Quindi la sua è stata un’antipsichiatria non soltanto ideologica, come ha dimostrato anche nella successiva esperienza di Imola, dopo l’allontanamento da Reggio. Antonucci e la sua équipe dell’epoca hanno ripreso e radicalizzato lo strumento delle assemblee nei reparti e nel territorio e con le famose «calate» sul «San Lazzaro» hanno affermato nella forma più diretta ed esplicita il principio del controllo popolare sull’operato dei tecnici, che rimane tuttora un punto decisivo. 157 Didattica Insegnare storia con efficacia e qualità rinnovate in tempi di crisi e di involuzione del sistema scolastico Beatrice Borghi, Rolando Dondarini Può sembrare paradossale puntare alla crescita di qualità e di efficacia nell’insegnamento della storia, in tempi che vedono succedersi e attuarsi «riforme» che, nel nome di un sua presunta razionalizzazione volta al contenimento degli «eccessi» di spesa, compromettono oggettivamente le potenzialità formative del nostro sistema scolastico. È fin troppo facile intravedere nelle continue limitazioni imposte all’insegnamento un premeditato attacco alla scuola pubblica. In queste condizioni può prevalere l’aspirazione a resistere e a mantenere i livelli faticosamente raggiunti in tanti anni di elaborazioni e sperimentazioni; ma sarebbe un adattamento ben poco fertile, dato che le involuzioni apportate e progettate attraverso provvedimenti e decreti si calano su una realtà generale che non è certo giunta ad uno stato ottimale, ma che vede poche eccellenze isolate emergere da un panorama quasi desolante. Peraltro le bordate che giungono dai diversi ministri mettono a nudo anche le contraddizioni e l’inefficacia di un certo modo di intendere e sviluppare l’ambito disciplinare della didattica della storia, che spesso si rivela con teoricismi e metodologismi non adeguatamente misurati sulle situazioni concrete, ben poco attenti alle esigenze degli insegnanti e quindi incapaci di incidere significativamente sulla realtà scolastica. In effetti negli ultimi decenni le questioni legate all’insegnamento della storia durante tutto il curricolo formativo sono state al centro di lunghe controversie, suscitate in particolare da diversi progetti e provvedimenti di riforma che però nella sostanza non hanno mutato, ma semmai accentuato un quadro di generale inadeguatezza e di grigiore, da cui emergono solo rari punti luminosi accesi dalla passione e dalla preparazione di una parte purtroppo minoritaria di insegnanti. Un esempio significativo è dato dalle amputazioni imposte per legge all’insegnamento della storia nell’ambito dei curricoli formativi. Certo i programmi o le indicazioni ministeriali dovrebbero essere intesi come riferimenti generali che non possono e non debbono determinare rigidamente competenze e conoscenze da apprendere e che quindi non dovrebbero incidere sulla qualità dell’insegnamento. 159 Tuttavia, non ci si può nascondere che alla luce dei primi anni di applicazione le «Indicazioni» Moratti – sostanzialmente confermate dal ministro Fioroni il 3 settembre del 2007 – hanno comportato quegli esiti prevalentemente negativi che furono paventati fin dalla promulgazione da una parte consistente degli insegnanti italiani: • la scomparsa delle visioni anche più generali dei due ultimi millenni dagli orizzonti formativi di una fascia scolare come quella «primaria», nella quale si acuiscono sensibilità e interessi che rimangono indelebili; • la sottovalutazione e il ritardo nell’acquisizione della consapevolezza e del rispetto del patrimonio storico/artistico scaturito da quei periodi; • l’abbandono di una ricca varietà di esperienze didattiche innovative condotte sia in ambito scolastico che extrascolastico, per le quali insegnanti e operatori culturali hanno attivato ampie convergenze multidisciplinari; in particolare in riferimento alle didattiche museale e archivistica e bibliotecaria e agli apporti di enti e associazioni; • le conseguenti lacune e mancanze di riferimenti per gli apprendimenti riferiti agli aspetti storico/ambientali da un lato e globali dall’altro, che si stavano sempre più spesso adottando come terreni di incontro e di comune formazione per gli scolari di diversa provenienza; • le gravi ripercussioni sui corsi di formazione per gli insegnanti della scuola primaria, che non essendo più tenuti a prepararsi su quei periodi storici, ne hanno eliminato lo studio dai loro curricula con le conseguenti carenze formative e culturali. Naturalmente queste constatazioni lasciano presumere che ci sarebbero stati esiti ancor più negativi nel caso si fosse giunti ad adottare la riforma per l’intero curricolo scolastico. Altre e autorevoli voci hanno già sottolineato le incongruenze di una simile scelta e come essa leghi fatalmente l’apprendimento dei vari periodi storici alle diverse fasi della crescita e alle loro differenti opportunità di approfondimento e renda quanto mai problematiche le correlazioni con altre discipline come la letteratura, l’arte, la filosofia. Il superamento delle ripetitività dei cicli andava affrontata non riducendoli da tre a due, ma con una differenziazione profonda dei «formati» con cui la storia può essere affrontata per intero nella scuola primaria, in quella secondaria di I grado e nella scuola secondaria superiore. Di fatto ora avviene quasi ovunque che gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, prima di intraprendere dal medioevo il cammino prescritto dalle «indicazioni», svolgano per diversi mesi corsi accelerati di riassunto dei 160 periodi precedenti con metodi ovviamente di pura acquisizione mnemonica che non possono che demotivare e demolire quanto eventualmente si era fatto prima. Ovvio dunque che gli insegnanti di scuola media superiore si ritrovino pesanti problemi di motivazione e i residui di una preparazione riproposta in maniera affrettata proprio sui periodi che si affronteranno nel primo biennio. Dunque ancora una volta e come troppo spesso accade gli insegnanti italiani sono costretti a dar prova di capacità di adattamento non solo rispetto alle naturali evoluzioni e ai continui mutamenti, ma spesso anche rispetto a direttive imposte loro da provvedimenti ben poco attenti alle esigenze dell’insegnamento. Tali provvedimenti presi dall’alto non agevolano la soluzione dei problemi dell’insegnamento della storia, cioè di un settore tra i più delicati e fondamentali di un percorso formativo in cui l’apprendimento di conoscenze e competenze potrebbe concorrere a far acquisire consapevolezza, autonomia e responsabilità. Ciò non toglie che sia sempre possibile e auspicabile perseguire un elevato grado di qualità e di efficacia nell’insegnamento della storia. Va, infatti, dato atto che negli ultimi decenni si sono registrate anche felici esperienze in proposito, con l’adozione di criteri metodologici e la realizzazione di percorsi volti a far acquisire capacità e conoscenze effettivamente utili all’insegnamento. L’insegnamento della storia oggi L’insegnamento della storia continua a pagare le conseguenze del difetto più evidente che l’affligge da molto tempo: quello di essere proposto male e percepito peggio, secondo un circolo vizioso che pare difficile rompere. Lo stridore tra il nozionismo prevalente che lo caratterizza e gli intenti formativi di una scuola in via di rinnovamento, tra un metodo trasmissivo ancora preponderante e l’esigenza di coinvolgere gli scolari sottraendoli ad una passività estraniante è venuto emergendo sempre più distintamente ed è apparso tanto più insopportabile per gli insegnanti più sensibili e solleciti a recepire e concretizzare le nuove istanze. Sono gli stessi mutamenti in atto a richiedere non solo che la storia non sia bandita dai percorsi della scuola di base, ma che opportunamente riconsiderata sul piano motivazionale e metodologico, sia proposta in armonia con lo sviluppo delle caratteristiche cognitive e psichiche e degli interessi dei soggetti. Ma come affrontare le questioni legate al suo insegnamento nel rispetto delle correlazioni tra crescita, formazione e apprendimento quando riforme e «controriforme», «indicazioni» e «raccomandazioni», prescrizioni e innovazioni sottopongono gli insegnanti di ogni ordine e grado ai continui avvicendamenti di disposizioni e di indirizzi conseguenti all’alternanza delle affermazioni 161 politiche e al prevalere dei relativi e spesso opposti orientamenti? Lo stato di provvisorietà e di parzialità delle sollecitazioni e delle prescrizioni istituzionali nei confronti della scuola e dei suoi programmi appare ancora più paradossale e contraddittorio per un paese che continua a manifestare particolari difficoltà a concepire e promulgare riforme organiche e complessive per l’intero sistema scolastico, per i diversi gradi di istruzione e per i differenti ambiti disciplinari. La diffusa percezione di una continua precarietà che rischia di sfociare in confusione, non è certo attenuata dalle ricorrenti contrapposizioni teoretiche tra i cosiddetti «esperti» della didattica che sono troppo spesso riconducibili a schieramenti politici o ad ambiti ideologici e che appaiono particolarmente pressanti proprio in relazione all’insegnamento della storia, per il quale sono ben pochi i criteri generalmente condivisi. Ne è prova l’annosa disputa sul curricolo e sui cicli da proporre per l’intero itinerario formativo: anche se è convinzione comune e generale che si debba programmare e adottare un curricolo verticale che armonizzi in un percorso coeso e unitario le diverse tappe di apprendimento ai vari gradi scolastici secondo finalità, metodi e contenuti coerenti, si deve poi constatare che sono ben rare le realizzazioni conformi a tale criterio; per non parlare delle diverse e spesso opposte scelte sul numero e sulla scansione dei cicli cronologici da affrontare nell’intero percorso formativo. Tuttavia per chi voglia cogliere stimoli e sollecitazioni positive anche da situazioni non ottimali, vale la considerazione che ogni terreno problematico e incerto può divenire particolarmente fertile e stimolare creatività. Motivazioni Tenuti ad essere al passo coi tempi, agli insegnanti si chiede di essere artefici e interpreti di un continuo rinnovamento che consenta loro di scegliere e adottare criteri e metodologie in grado di rendere efficace il loro insegnamento attraverso concrete procedure applicative che sappiano stimolare positivamente i soggetti della formazione, suscitando interesse, curiosità e apprendimento. Benché generalmente condivisa da tutte le componenti della società, questa esigenza, così ardua da sostenere e da perseguire, trova ben poco spazio nei percorsi formativi dei docenti. È notorio che insegnanti motivati e appassionati sono in grado di suscitare analoghi atteggiamenti nei loro scolari; si potrà affermare che la passione non si insegna, ma di certo l’interesse e la curiosità possono essere stimolati e suscitati attraverso la valutazione delle motivazioni che sottendono l’apprendimento. Tra le finalità da perseguire nei processi formativi vengono generalmente indicate l’autonomia di pensiero e la capacità creativa e progettuale. Riconoscersi e orientarsi per poter scegliere e progettare più consapevolmente 162 e responsabilmente, raccordando passato, presente e futuro, sono esigenze che hanno sentito tutte le generazioni umane, ma che oggi sono amplificate da un’inedita accelerazione nel cambiamento di comportamenti, scale di valori e contesti ambientali. A dimostrare che proprio in presenza di uno straordinario strappo col passato è necessario un generale recupero di conoscenza storica è sufficiente constatare come lo smarrimento sia il primo e sicuro effetto per chi perda la memoria. L’incapacità di fare scelte consapevoli, di formulare progetti motivati, di prevedere almeno in parte le conseguenze dei propri gesti rende ogni smemorato preda dell’angoscia di non poter scegliere liberamente e lo subordina alla volontà altrui, poiché, non conoscendo il proprio vissuto, non dispone di riferimenti essenziali ed è costretto all’immobilità o a passi azzardati. Oggi si rischia di affrontare da smemorati un futuro dai contorni indefiniti, non conoscendo adeguatamente nemmeno le premesse e le radici delle questioni più inquietanti dell’attualità, come quella della convivenza o quella dei limiti e degli squilibri dello sviluppo. L’appiattimento degli orizzonti, degli interessi e della conoscenza su un presente apparentemente privo di retroterra è poi uno dei possibili esiti del completamento di quel millenario processo di saldatura delle sorti umane in un unico orizzonte planetario che convenzionalmente chiamiamo «globalizzazione». Mentre a beneficiarne sono ancora quasi esclusivamente i grandi monopoli economici e nell’attesa che a trarne vantaggio sia la totalità del genere umano, uno dei timori più giustificati che esso suscita è proprio quello dell’annullamento delle diversità in un panorama piatto e indistinto, uniformato alle culture e agli interessi dominanti. Si tratta di una svolta epocale di cui si colgono i primi pesanti esiti con sempre maggior chiarezza. A sostenerla e a renderla efficace sono i più potenti mezzi di diffusione e di propaganda che siano mai stati a disposizione della specie umana: quelli radiotelevisivi, quelli delle reti informatiche e telefoniche, al cui interno inarrestabili processi di concentrazione stanno selezionando i dispensatori di informazione e cultura con effetti concreti e già ben percepibili di condizionamento dei comportamenti e di manipolazione delle coscienze. D’altronde le opportunità offerte dalla comunicazione e dall’informazione possono essere utilizzate anche in senso contrario rivalutando e mettendo a confronto voci, culture, conoscenze ed opinioni. In tale prospettiva l’insegnamento della storia va finalizzato oltre che ad una maggiore conoscenza delle origini e delle premesse delle realtà odierne, anche ad una fondata capacità critica e di comprensione nei confronti dei processi evolutivi in atto e alle conseguenti possibilità di progettare quanto più coscientemente il proprio futuro individuale e collettivo in un tornante della storia in cui ogni grande scelta è destinata a ripercuotersi sulla qualità di vita delle generazioni future e rischia di divenire irreversibile. In una società sempre più composita deve essere indirizzato anche a promuovere una formazione culturale basata sulla consapevolezza delle 163 identità e delle diversità presenti, nella convinzione che ogni identità si evolve e che è infondata qualsiasi presunzione di una sua immobilità con cui giustificare il rifiuto dei nuovi arrivi e dei relativi cambiamenti. A tutte queste motivazioni se ne aggiunge un’altra che dovrebbe essere particolarmente sentita da una comunità nazionale erede di un patrimonio storico-artistico valutato tra i più ricchi e consistenti del mondo. L’interesse e la sensibilità verso i temi della salvaguardia e della tutela dei beni ambientali e culturali dipendono in buona parte dalla soglia e dalla qualità della conoscenza storica dell’intera società. L’attenzione per retaggi pervenutici dal passato non si impone solo nell’ambito della formazione, ma anche come esigenza di percepirli e valorizzarli come risorsa. In questa luce le scuole possono concorrere alla sensibilizzazione necessaria, promuovendo in collaborazione con sedi museali, archivistiche e bibliotecarie una più ampia conoscenza dei beni presenti nel loro territorio. Il «patrimonio» appare così come un approdo necessario e uno sfondo integratore di rilevante valenza formativa, capace di proiettare in orizzonti più ampi le potenzialità delle specifiche didattiche dei beni culturali e di avvalersi degli strumenti più aggiornati della comunicazione. Esso diviene così un’occasione di acquisizione e di produzione del sapere con cui si stimola l’acquisizione di competenze e la costruzione di conoscenze mediante specifiche esperienze di ricerca e di didattica; esige la confluenza di pertinenze e la convergenza di percorsi in un intreccio interdisciplinare; implica un uso sistematico di tutti gli strumenti della comunicazione e in particolare delle tecnologie telematiche e dei supporti multimediali utilizzabili in ogni progetto didattico e divulgativo. Da quanto esposto appare evidente come vi sia un nesso significativo tra il concetto di formazione e quello di «educazione al patrimonio» per la comune sottintesa tensione a sviluppare processi di apprendimento integrati, ricorrenti e permanenti. In particolare sono due gli aspetti che rendono strettamente attinente alla formazione l’apprendimento che verte sul «patrimonio»: l’integrazione di molteplici competenze e conoscenze tratte da attività di simbiosi tra scuola e sedi esterne in un quadro multidisciplinare di educazione alla consapevolezza e alla responsabilità; l’adozione di metodi costruttivi che motivino, coinvolgano e attivino all’apprendimento, spaziando dalla percezione e definizione delle componenti e delle sedi del «patrimonio» all’acquisizione specifica relativa alle sue componenti, fino ai più aggiornati metodi e strumenti di comunicazione. Il tutto in una continua ricerca d’interazione tra le discipline che si occupano dei processi di conoscenza e di valorizzazione del «patrimonio», degli aspetti estetici e storico-artistici del territorio per una formazione che permetta e induca scambi concettuali, pratiche comparative e affinamenti metodologici oggi particolarmente importanti per attivare dialoghi interculturali e rapporti da svolgersi in tutti i settori delle attività umane e in orizzonti senza limiti. 164 In merito poi all’attuale situazione italiana riferita all’educazione alla cittadinanza europea si rivela che, a fronte di una crescita delle iniziative, permane una certa loro sporadicità e frammentarietà che non rispondono certo a quelle sollecitazioni ministeriali che invitano le scuole ad approntare offerte formative all’interno di quadri generali di indirizzo dettato dalle regioni. Tale sporadicità può essere superata a favore di un’adeguata sintonia e di una maggiore continuità proprio attraverso il coordinamento regionale che, senza imporre scelte e adesioni, può attivare sinergie, ottimizzare risorse ed evitare sovrapposizioni. Per educare al riconoscimento dei propri diritti e doveri, delle proprie responsabilità nei confronti degli altri e al fine di promuovere una convivenza basata sui valori della pace, della tolleranza, nel rispetto delle culture e delle tradizioni dei diversi paesi europei occorre contare su un proficuo dialogo tra la scuola e il territorio in cui gli enti locali e tutti gli altri soggetti educativi esterni possano concorrere ad allestire gli itinerari formativi. Persistenze e innovazioni di strumenti e opportunità Tra i rapidi mutamenti che intersecano necessariamente il campo dell’insegnamento si debbono annoverare le formidabili trasformazioni degli strumenti a disposizione di docenti e scolari; trasformazioni tanto radicali da interferire con le stesse finalità e metodologie di insegnamento. Compito degli insegnanti è perseguire le strade più efficaci per stimolare l’apprendimento, aggiornando e adeguando il ricorso agli strumenti secondo le continue evoluzioni in atto e selezionando persistenze e innovazioni. Alla perdurante esigenza di rendere gli scolari capaci di leggere e produrre testi scritti si è abbinata quella sempre più pressante di avvalersi della multimedialità e delle opportunità offerte dalle tecnologie più aggiornate. In merito il patrimonio di esperienze condotte con esiti positivi e il novero delle nuove proposte si stanno arricchendo di anno in anno. Che l’informatica debba trovare ampio spazio nei processi formativi in armonia con finalità e percorsi didattici adeguatamente programmati è ormai un criterio generalmente condiviso; tuttavia si rendono indispensabili le cautele e le attenzioni che tale ricorso comporta. Nella rete sono ormai innumerevoli i siti di interesse storico, ma data la scarsa attendibilità che ne caratterizza la gran parte, occorre che gli insegnanti si documentino in merito e forniscano agli allievi una sitografia selezionata e motivata inducendoli ad un atteggiamento critico e creativo. Pertanto anche per strumenti così ricchi e articolati occorre evitare ogni forma di sudditanza e assumere comportamenti attivi che consentano di avvalersene come opportunità di conoscenza e come assunzione di capacità autonoma di documentarsi. D’altronde la rete offre anche strumenti e opportunità immediate che non 165 danno adito ad alcun dubbio sulla loro utilità; si pensi alle illimitate possibilità di accesso ai siti di sedi museali, da quelle più prestigiose a quelle più specialistiche e locali presso le quali sempre più spesso sono fruibili percorsi didattici appositamente preparati. Queste nuove opportunità non debbono indurre a trascurare quelle consolidate e tradizionali che rendono insostituibile e preziosa la figura dell’insegnante; egli infatti può avvalersi di quel contatto e dialogo umano che nessuna trasmissione o sollecitazione esterna può rimpiazzare. In contrasto con la passività imposta da tali sollecitazioni, egli può mettere a frutto la possibilità di far parlare e rendere ogni soggetto protagonista della propria formazione, spronandolo ad un impegno che si rivelerà gratificante perché comunque si tradurrà in cosciente conquista personale. Ogni conquista è tanto più efficace, duratura e gratificante quanto maggiore è il coinvolgimento emotivo che deriva dalla coscienza delle difficoltà e delle sfide che si debbono superare per raggiungerla. Ciò non significa che si debbano perseguire itinerari ardui e selettivi, ma che si possano rendere avvincenti facendo leva sulla consapevolezza di compiere passi importanti e non comuni, qualitativamente elevati, innovativi e degni di attenzione. È una convinzione che deve essere ripetutamente stimolata e che può valere come ulteriore incentivo all’apprendimento: sentirsi soggetti e partecipi di imprese originali che portano a scoperte sempre nuove frutto dell’impegno di ognuno e di tutti. Del resto è stato ampiamente verificato che promuovere l’apprendimento motivando e attivando i suoi soggetti in un percorso coscientemente impegnativo e verso una meta ambita e gratificante, comporta sempre per insegnanti e scolari un incentivo e un consolidamento della stima reciproca da cui entrambi si sentono vincolati a esprimere il meglio di sé. 166 Educazione al patrimonio e alla cittadinanza nella formazione del docente di storia Luigi Guerra Educare al patrimonio: evoluzione di un concetto Il concetto di patrimonio si è progressivamente dilatato negli ultimi anni sia nella definizione che ne danno autorevoli organismi internazionali (a partire dall’UNESCO) sia nella coscienza comune. Da un’accezione interpretativa che la vedeva riferita esclusivamente alle testimonianze monumentali o comunque artistiche prodotte e conservate in un certo territorio nel corso degli anni, l’idea di patrimonio culturale si è allargata inglobando al suo interno prima di tutto l’insieme delle manifestazioni della cultura materiale prodotta dall’uomo in riferimento alle esigenze della sopravvivenza, del lavoro, della relazione sociale. In questo senso, fanno parte del campo del cosiddetto patrimonio i materiali legati allo sviluppo della tecnica e della produzione industriale: quindi, un primo passaggio è stato quello che ha visto introdurre, a fianco dei beni artistico-monumentali, i beni tecnico-materiali. Ma, in tempi più recenti, in parallelo con l’affermarsi di una concezione dell’ambiente non più inteso come contesto naturale dell’attività umana, bensì drammaticamente interpretato come luogo dell’incontro/scontro tra uomo e natura e quindi non come contenitore preesistente e statico, ma come prodotto continuamente in modificazione dell’attività umana, della relazione tra intervento culturale ed evoluzione naturale, l’ambiente stesso è entrato nell’idea di patrimonio in quanto anch’esso largamente prodotto dai nostri «padri». Da questi brevi note introduttive derivano alcune considerazioni, quali: • se l’educazione al patrimonio poteva essere una volta affidata a singole discipline del curricolo scolastico, con particolare riferimento alle discipline artistiche e a quelle storiche, oggi non si può non riconoscere che il patrimonio è strutturalmente oggetto di studio di tutte le discipline che riguardano i prodotti dell’attività dell’uomo nel suo dispiegarsi nel tempo e nello spazio e nel suo consolidarsi in oggetti, strumenti, idee conservati e formalizzati attraverso l’uso dei diversi «linguaggi» elaborati dall’uomo stesso. Quindi, in senso generale, quasi tutte le discipline hanno a che fare con l’educazione al patrimonio e, in particolare, è necessario che di questo assumano immediatamente consapevolezza i docenti di area tecnico-scientifica; 167 • l’idea di patrimonio è stata per troppo tempo coniugata con l’evidenza di una eccezionalità, grande rilevanza o comunque cospicuità degli oggetti cui era riferita. Di qui anche, fondativamente, il confinare del concetto di patrimonio culturale con quello di patrimonio inteso come insieme delle risorse materiali messe a punto dai sistemi familiari o sociali in una cornice di natura utilitaristica. La dilatazione citata dell’idea di patrimonio, mentre ne apre orizzontalmente i confini introducendo i beni naturali e i beni ambientali, consente di allargare anche verticalmente l’idea stessa verso una concezione di patrimonio che comprende sia l’eccezionale sia il quotidiano, sia l’enorme sia il piccolo, sia il «bello» sia il «brutto» e via dicendo. In altri termini, e questo è sicuramente un risultato delle attuali riflessioni sulla sostenibilità ambientale, costituisce un patrimonio dell’umanità sia l’enorme Wellingtonia che troneggia da secoli sul quai di Lugano o la più importante ulteriore sequoia dell’omonimo parco californiano quanto la più umile delle parietarie calpestabile sui bordi dei marciapiedi cittadini. È una consapevolezza che può portare a prospettive di radicalità forse eccessiva, ma anche nel campo dell’arte e della cultura sono indubbiamente patrimonio (e come tale sono percepiti nella crescente consapevolezza che fonda la miriade dei musei locali) tanto i prodotti artistici di coloro che sono stati riconosciuti come grandi, quanto il sistema dei prodotti di coloro che sono stati definiti epigoni, attori secondari e che comunque hanno costituito il contesto che nella maggior parte dei casi ha consentito l’emergere dei grandi, la loro affermazione sul mercato, il loro fissarsi nella memoria collettiva; • l’educazione al patrimonio è quindi compito di molte discipline. A tutte comunque richiede quell’approccio interdisciplinare che solo può garantire una conoscenza delle diverse tipologie dei prodotti umani, collegati nell’idea stessa di patrimonio, di natura non feticistica, capace di contestualizzazione e quindi di interpretazione critica. Nello specifico dell’insegnante di discipline storiche, punto di partenza deve essere la consapevolezza che l’intero sistema della «storia», il suo intrecciarsi tra fonti, documenti, narrazioni, costituisce di per se stesso un patrimonio: e un patrimonio in continua evoluzione. Educazione al patrimonio e educazione alla cittadinanza Nelle direzioni fin qui indicate, l’educazione al patrimonio non può che essere fatta rientrare, a pieno titolo, all’interno dell’ambito più vasto della «educazione alla cittadinanza». E questo non certamente nelle asfittiche prospettive previste dall’art. 1 del C K 137/2008, che comunque vale la pena ricordare: «A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 … sono 168 169 nostro paese proprio in quanto relativa all’area dei saperi «caldi», legati alle scelte esistenziali (valoriali, politiche, confessionali) del singolo cittadino. Presente invece, ci permettiamo di ricordarlo anche per sottolineare la possibile deriva nazionalistica di questa interpretazione, in quasi tutte le discipline della scuola del ventennio: una scuola tutta tesa a predicare l’italianità come valore fondamentale dell’educazione e a proporla come radice identitaria comune di ogni cittadino. Le due interpretazioni possono essere percorse in modo unilaterale o in modo integrato, ma, come è facile intuire, ogni assunzione unilaterale del concetto comporta un’immediata riduzione del significato complessivo del progetto pedagogico ad esso correlato. Interpretare univocamente l’educazione alla cittadinanza come civicness significa correre il rischio di un percorso pedagogico improntato al formalismo civico, fatto cioè esclusivamente di leggi e norme, di diritti e doveri. Saremmo di fronte, in questo caso, ad un approccio per così dire «oggettivo» all’educazione alla cittadinanza. Un approccio, da un lato, in negativo, scarsamente motivante e coinvolgente perché giocato in chiave prevalentemente giuridica, d’altro lato, in positivo, utile a formare un cittadino rispettoso del quadro complesso di «diversità» esistenziali che caratterizza la comunità civile. L’esito della cittadinanza come civicness è infatti il famoso «cives romanus sum» di san Paolo: l’affermazione di una identità amministrativa (con il suo quadro positivo di garanzie) del tutto scollegato dall’identità linguistica, culturale, religiosa del singolo soggetto, ma proprio per questo del tutto funzionale ad una città caratterizzata dall’esplosione delle differenze. Interpretare altrettanto unilateralmente l’educazione alla cittadinanza nel senso che abbiamo dato in precedenza all’idea di citizenship significa correre il rischio di investire su radici comuni, condivisioni culturali, omogeneità valoriali tanto forti nel garantire identità, appartenenza, partecipazione, quanto esposte a fenomeni di fanatismo, esclusione del diverso, prevaricazione delle minoranze. L’esito, che purtroppo vediamo più o meno consapevolmente progettare in questi anni di migrazioni imponenti dalla parte più retriva e conservatrice della nazione, può essere sì il cittadino consapevole e criticamente radicato nella storia che ha prodotto la sua città, ma anche e soprattutto l’hooligan, il «celtico», il cultore della purezza delle tradizioni (se non della razza). Non a caso, tra l’altro, chi sulle piazze e sui giornali si distingue oggi nel difendere una cittadinanza pretesamene omogenea e storicamente determinata dimostra per lo più di avere scarsa conoscenza del complesso di vicende culturali e politiche che hanno costruito la nostra storia. Interpretare l’educazione alla cittadinanza come integrazione problematica dell’idea di civicness e di citizenship (l’unica prospettiva strutturalmente positiva sul piano educativo) significa infine fondare la conoscenza e la pratica delle regole della società civile sul sistema di valori e culture che la singola microcomunità e, alla fine, il singolo soggetto, riconoscono alla base delle 170 regole stesse: un sistema complesso fatto di omogeneità e disomogeneità, di comunanze e differenze in costante modificazione. Solo questa è una visione forte della cittadinanza che la può rendere oggetto di un progetto formativo articolato in percorsi di istruzione, di ricerca e di creatività: istruzione, per gli infiniti possibili rimandi alle singole discipline del curricolo di ogni ordine scolastico; ricerca, perché l’idea di continua trasformazione delle differenze che formano la città chiede la partecipazione diretta del discente a percorsi formativi fatti solo in parte di saperi consolidati; creatività, perché nel senso indicato la cittadinanza è fatta di cittadini chiamati a dare alla città il loro contributo originale di conoscenze, valori, utopie. Quale educazione al patrimonio? Proposte per una didattica problematica Il modello problematico di una didattica del patrimonio all’interno dell’educazione alla cittadinanza è già stato di fatto avanzato alla fine del paragrafo precedente e può essere intitolato ai tre concetti indicati di istruzione, ricerca, creatività. L’educazione al patrimonio utilizza oggi prevalentemente se non esclusivamente gli strumenti di una didattica di tipo riproduttivo. La concezione «museale» del patrimonio, unita all’oggettivo ritardo dell’innovazione didattica all’interno dei musei stessi, sostiene esperienze formative per lo più costruite come visite sporadiche e frettolose a monumenti/prodotti culturalmente attrezzati e socialmente riconosciuti come luoghi di conservazione formale del patrimonio. Non mancano di certo (sarebbe ingiusto non riconoscerlo) esperienze significativamente diverse, ma la realtà consolidata della didattica del patrimonio coincide sostanzialmente con l’escursione didattica, con la gita scolastica, con la frequentazione occasionale ad ambienti in cui guide/ animatori specializzati sostituiscono l’insegnante di fronte ad allievi distratti, impreparati, attenti solo agli aspetti «ricreativi» dell’uscita. Contro questa prassi, far valere le ragioni di una didattica problematica significa sostenere esperienze educative di utilizzazione del patrimonio: • che abbiano, innanzitutto, le caratteristiche della continuità e della sistematicità e che non si rivolgano solo ai prodotti e alle forme di eccezionale rilevanza del patrimonio. Può essere facile perfino per un razzista rimanere affascinato da manifestazioni straordinarie di una cultura che pure disprezza. Educare al patrimonio, pertanto, non vuole dire frequentare soltanto le vetrine in cui è conservato il volto «alto» di una cultura: vuol dire invece aprire un confronto continuativo con le quotidianità dentro alle quali i prodotti eccezionali hanno trovato radici e ragioni di esistere. E questo non è semplice perché, come afferma Vecchioni in Malinconia leggera: «Volare 171 è facile, si sa, ci vuol più fantasia per camminare»; • che presentino, in secondo luogo, una collocazione strutturale all’interno della programmazione educativa, con forte attenzione ai momenti della predisposizione culturale dell’esperienza, all’assegnazione di specifici compiti di conoscenza agli allievi durante la sua effettuazione, all’analisi delle ricadute in termini di competenze effettivamente conseguite dopo l’esperienza stessa; • che attivino, infine, le citate dimensioni educative dell’istruzione, della ricerca e della creatività. È su questo aspetto di una didattica problematica del patrimonio che ci si soffermerà in questa ultima parte del paragrafo. Appartiene all’autore (che l’ha già presentata in numerose sedi) l’adesione convinta ad un approccio didattico plurilaterale e problematico che impone di riconoscere la possibile compresenza integrata di tre prospettive dell’educazione intellettuale: rispettivamente, la prospettiva monocognitiva (quella dell’istruzione), metacognitiva (quella della ricerca) e fantacognitiva (quella della creatività). La prospettiva monocognitiva interpreta l’educazione intellettuale come alfabetizzazione culturale: intende cioè garantire ad ogni allievo il possesso delle informazioni indispensabili a livello di organizzazione dei contenuti, di lessico, di conoscenza degli strumenti di indagine delle diverse discipline che compongono il sapere. La prospettiva metacognitiva persegue l’attivazione significativa presso gli studenti dei modi e delle competenze del cosiddetto «pensiero scientifico»: di modalità, cioè, di assunzione, formalizzazione e risoluzione dei problemi che passino attraverso le fasi canoniche della osservazione, ipotesi, sperimentazione, verifica. In altre parole, si ripromette di stimolare in modo sistematico l’utilizzazione di strumenti di indagine diretta (atteggiamenti, metodi, tecniche) che aprano alla possibilità, appunto metacognitiva, della concettualizzazione, della generalizzazione, della trasferibilità dei saperi prodotti. La prospettiva fantacognitiva, da parte sua, si propone di stimolare e sostenere lo studente nella costruzione di percorsi originali di comprensione/rivisitazione del sapere: nell’elaborazione di «altri volti» – interpretati soggettivamente – della cultura. Intende perseguire la scoperta non soltanto di oggetti culturali nuovi o diversi, ma anche e soprattutto di approcci nuovi/diversi (originali/creativi) agli stessi oggetti messi a punto attraverso la valorizzazione della propria soggettività. La dimensione istruttiva della didattica del patrimonio richiede la capacità di costruire «presentazioni» dei luoghi/monumenti/prodotti progettate all’insegna della chiarezza e della capacità di individualizzazione. Postula un lungo lavoro dell’insegnante sia nella direzione della didascalizzazione del singolo fenomeno sia in quella del suo inserimento in quadri/mappe concettuali che ne combattano una mera conoscenza da idiota specializzato. Può contare sulle 172 straordinarie risorse in direzione di multimedialità offerte oggi dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La dimensione metacognitiva dell’approccio al patrimonio si fonda sull’attivazione di competenze di ricerca e riformalizzazione delle dimensioni del patrimonio assunte come strumento e oggetto di lavoro. Richiede all’insegnante stesso di essere un ricercatore e di muoversi verso concezioni dell’insegnamento di tipo socio-costruttivistico all’interno delle quali lo studente (il gruppo degli studenti) venga stimolato ad assumere ruoli da protagonista del proprio apprendimento. Può utilizzare le significative potenzialità in direzione di autonoma produzione di documentazione e di ipertestualizzazione offerte anch’esse dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La dimensione della creatività nei percorsi di educazione al patrimonio deve essere garantita nella consapevolezza che la memoria collettiva e i luoghi/ oggetti in cui si è sedimentata è costituita in gran parte dalla somma degli «sguardi» individuali che l’hanno accompagnata. Di qui l’esigenza didattica di assicurare agli allievi (ad ogni allievo) la possibilità di una ricostruzione delle diverse manifestazioni del patrimonio che valorizzi l’estetica individuale, a partire dall’affermazione della propria specifica sensorialità fino alla capacità di illuminare oggetti e avvenimenti con gli occhi del proprio vissuto. 173 Progetto in rete La costituzione della cittadinanza Liceo scientifico statale «A. Moro» Liceo classico-scientifico «L. Ariosto-L. Spallanzani» Istituto Statale d’Arte «G.Chierici» con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia Lorenzo Capitani Tiziana Fontanesi Paola Montanari Brunetta Partesotti Presentazione Sono giornate tristi per tutti coloro che hanno a cuore le sorti di una democrazia fragile come la nostra, ma che nel riferimento al dettato costituzionale aveva fino ad oggi trovato un limite invalicabile. E le parole dossettiane, pronunciate nel lontano 1995, sembrano risuonare ancora una volta profetiche. Attenzione, agli assalti alla sovranità popolare che si pretende di sostituire con una sovranità mitica, che seduce il popolo, ma in sostanza lo viola e lo delegittima. La conseguenza sarà il passaggio da una democrazia rappresentativa parlamentare, con le sue mediazioni dialogiche spesso difficili, a una democrazia populista, a influenza mediatica, in cui l’assenza di razionalità e l’appello prevalente a “mozioni istintive e impulsi emotivi” ridurranno il consenso del popolo sovrano a un mero applauso al Sovrano del popolo. Non sappiamo cosa ancora ci riserverà la crisi che in questi giorni, dopo anni di ossessivo martellamento proprio contro la Costituzione, e dalle parti più diverse per la verità, si dispiega in tutto il suo potenziale di devastazione del tessuto civile, con il conseguente diffondersi di ampie arie di fastidio, di disincanto, di allontanamento da ogni forma di partecipazione alla vita della comunità. Anzi lo stesso termine comunità, proprio quando ricordiamo il magistero olivettiano, appare blasfema, quasi che in essa fosse implicita una dose di organicismo totalitario, mentre ben altro spessore viene assumendo il nuovo «totalitarismo» che oggi dobbiamo fronteggiare. 174 Come reagire a questa deriva? Qualcosa si sta muovendo e, come ha recentemente ricordato Stefano Rodotà, «tutti sappiamo che la Costituzione vive proprio grazie al sostegno e alla capacità di identificazione dei cittadini». La «comune identità costituzionale» può ancora essere assunta come «leva per cercare di uscire da una crisi che, altrimenti, davvero ci porterebbe, in modo sempre meno strisciante, a un cambiamento di regime»? In questo orizzonte, inevitabilmente, viene a collocarsi anche ogni iniziativa che abbia un valore educativo non epidermico o tradizionale. Del resto, in poche settimane, nella scuola, siamo passati dalla evocazione di una nuova disciplina Cittadinanza e Costituzione, con un suo autonomo statuto ed una sua autonoma valutazione, a un più cauto e modesto inserimento sperimentale di tematiche costituzionali nell’ambito delle discipline storiche o giuridiche. Del resto, il contesto sopra richiamato rischia di stridere non poco con il significato generale che si vuole assegnare a queste nuove proposte, con il pericolo di essere vissuto, da parte dei giovani, come la solita predica sulle buone norme del vivere civile, del tutto incapaci di «mordere» una realtà che ben altri modelli quotidianamente è in grado di presentare. Tuttavia, quando, in pieno giugno, nel cuore delle attività scolastiche finali, il ministero della Pubblica istruzione ha bandito un concorso per progetti sperimentali sulla educazione costituzionale, non ci siamo tirati indietro. Abbiamo messo insieme alcune esperienze di lunga data, già consolidate, unito grandi sforzi personali e modeste risorse economiche, confezionando un a proposta che infine ha raccolto grande consenso, piazzandosi nei primissimi posti della graduatoria nazionale e ottenendo il finanziamento previsto di 15.000 euro, con il quale già molte cose abbiamo potuto impostare e realizzare. Giocando sulle parole, abbiamo voluto, con il titolo, ricordare che la cittadinanza non può essere concepita staticamente e si trova continuamente a fare i conti con nuove e più complesse modalità per la sua effettiva costituzione. Un approccio che ha cercato di evitare strade più consuete e che punta ad un coinvolgimento attivo delle classi interessate, con l’intento di fornire spunti, materiali, percorsi utili per tutti gli indirizzi scolastici. Al di là delle incertezze normative, infatti, un quadro di educazione costituzionale fondato sulla cultura, sulla storia, sulla lettura critica del presente, che riesca a coinvolgere una pluralità molto ampia di soggetti pubblici e associativi, è nostra convinzione possa rappresentare un buon antidoto per contrastare i tanti veleni che vanno diffondendosi nel nostro quotidiano vivere civile. Non a caso il tema di fondo del Progetto che di seguito presentiamo è rappresentato dal significato di città, intesa come comunità allargata e plurale, non luogo ideale e pacifico, ma ricco di contraddizioni non facili da dipanare, su cui deve esercitarsi ogni autentica volontà di integrazione e condivisione. A partire dai giovani, con i giovani. A partire dalla scuola, con la scuola. (l. c.) 175 Finalità del progetto • avvicinare i giovani alla Costituzione come loro «compagna di strada» (Giuseppe Dossetti); • educare alla cittadinanza attiva, solidale e consapevole; • promuovere la capacità di lettura critica del presente attraverso percorsi innovativi; • educare alla legalità e alla vita democratica; • educare alla solidarietà, alla tolleranza, alla pace; • promuovere la consapevolezza di essere parte, come cittadini protagonisti, di una comunità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; • promuovere la consapevolezza che in tale comunità ciascuno è portatore di diritti e di doveri ed è responsabile della crescita qualitativa collettiva; • promuovere un atteggiamento di apertura e condivisione nei confronti di diverse realtà e culture; • promuovere la consapevolezza di essere cittadini dell’Europa e del Mondo, impegnati ad affrontare i problemi in una visione planetaria; • stimolare la memoria storica del passato, nell’ottica della speranza verso un futuro da costruire. In sintesi il nostro Progetto si propone di produrre concreti modelli curricolari che diano sostanza all’introduzione della nuova disciplina, facendo leva, del resto, su un’esperienza largamente consolidata da oltre dieci anni. Nucleo tematico Il titolo che abbiamo scelto per il nostro progetto, «La costituzione della cittadinanza», «giocando» con le due parole-chiave della nuova disciplina, allude ai significati e alle forme attraverso cui si fonda l’idea di cittadino. Il nucleo tematico individuato dalle tre scuole in Rete ruota pertanto intorno all’idea di città, intesa in senso etimologico come polis/civitas, dunque non solo come urbs, bensì una città fatta di persone, cittadini e cittadine che possano viverla attivamente e consapevolmente come luogo di incontro, di relazione, di integrazione, di esperienze multiculturali. Obiettivi di apprendimento • acquisire conoscenze e concetti-chiave relativi alla storia della nostra Costituzione : una sorta di «grammatica etica essenziale»; 176 • trasmettere ai giovani quel patrimonio di valori che sono il fondamento dell’ordinamento repubblicano e che contribuiscono alla formazione di una coscienza politica orientata ai principi della convivenza civile e della democrazia; • comprendere e utilizzare i concetti-chiave della storia e del pensiero costituzionale, indispensabili per orientarsi nelle tematiche e nei problemi di attualità, anche in riferimento al territorio locale; • conoscere e utilizzare il lessico di base relativo alle tematiche della cittadinanza e della Costituzione; • comprendere la complessità del concetto-chiave di «società»; • analizzare e utilizzare documenti e fonti di diversa tipologia. Strategie organizzative Le tre scuole in Rete hanno concordato alcune fasi di lavoro comune. Formazione e autoformazione: un ciclo di incontri-seminari-aggiornamenti sui temi prescelti, da svolgersi nella parte iniziale dell’anno scolastico 2009-2010, presso la scuola capofila (Liceo Moro) in orario mattutino e/o pomeridiano, rivolti specificatamente ai docenti, ma aperti anche agli studenti-studentesse e alla cittadinanza. L’autoformazione avrà dunque l’obiettivo primario di valutare luci ed ombre di tali esperienze, in modo da individuare percorsi formativi credibili ed efficaci, strettamente connessi al tema generale del nostro progetto: le visioni della città. La formazione dovrà invece essere rivolta prevalentemente all’approfondimento di tematiche riguardanti sia la genesi, le finalità, le partizioni interne della nostra Carta sia la consistenza di alcuni nuclei essenziali della trama costituzionale, senza trascurare il necessario aggiornamento intorno al dibattito in atto sulle riforme costituzionali. In particolare, si farà riferimento alla esperienza della «Scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale» promossa a Rovigo dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Ferrara, una scuola operativa già da due anni, con risultati eccellenti, accreditati dall’Alto patronato della presidenza della Repubblica. Intendiamo anche avvalerci di un rapporto organico con l’Associazione italiana dei costituzionalisti, attraverso la collaborazione del professor Roberto Bin, responsabile del Progetto Scuola e Costituzione della Regione Emilia Romagna. Infine, intendiamo sviluppare esperienze organizzate di partecipazione alle attività della Fondazione Camera dei deputati: in sintesi, si tratta di andare al di là delle tradizionali visite ai «luoghi del potere», spesso anche controproducenti, 177 per favorire invece momenti ben costruiti di approfondimento sia di figure significative della storia parlamentare sia di tematiche di rilevante attualità. Queste le fasi fondamentali di lavoro che abbiamo individuato. 1. Attività nelle classi: ogni scuola della Rete coinvolgerà i consigli di classe in fase di stesura della programmazione annuale, sollecitando la partecipazione al progetto e la scelta di un tema o attività da svolgere: almeno una classe per ogni anno di corso parteciperà al progetto. Inoltre tre classi appartenenti alle tre scuole in Rete lavoreranno su uno stesso modulo/percorso. 2. Attività con altre scuole, anche esterne alla Rete, di diverso ordine e grado: negli scorsi anni il Liceo Moro e il Chierici hanno lavorato con scuole elementari e medie di Reggio Emilia; per il 2009-2010 si prevede di collaborare con le scuole dell’infanzia ed elementari. 3. Laboratori aperti con il territorio: si collaborerà con varie associazioni e istituzioni, sulla base di esperienze già consolidate: Comune e Provincia di Reggio Emilia, Foro dei magistrati di Reggio Emilia, arma dei carabinieri, Direzione provinciale del lavoro, Istoreco, Consorzio «Oscar Romero», Libera, CO.LO.RE., Pax Christi, Nondasola, Parada, Periferica. 4. Visite di istruzione-stages: si prevedono le seguenti mete: Roma-Montecitorio, in collaborazione con Biblioteca della Camera-Fondazione Camera Deputati, «Le giornate di studio a Montecitorio», promosse dalla Camera dei Deputati o «Un giorno a Palazzo Madama», promossa dal Senato della Repubblica; Montesole e Barbiana sul sentiero della Costituzione, in collaborazione con Pax Christi e Fondazione don Milani; visite di istruzione-campi di volontariato nei territori liberati dalla mafia; Bruxelles-Parlamento Europeo; 5. Percorsi creativi: produzione di manufatti artistici, esperienze teatrali, lavori multimediali da parte degli studenti e studentesse della Rete, ispirati alla Costituzione e/o alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Per quanto attiene al manufatto artistico, l’idea è quella di realizzare un grande murale nell’atrio della scuola capofila: le proposte elaborate in forma di bozzaidea dagli studenti saranno interpretate graficamente con una realizzazione artistica. Si può pensare a dipinti su pannelli che costituiscano non solo un elemento di decoro per l’atrio del Moro ma portino all’allestimento di una «mostra itinerante» trasferibile in altre scuole o luoghi della città. Per quanto riguarda poi la possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale, si può contare sulle originali esperienze che tutte le scuole in Rete vantano, sia per la stesura del testo che per la regia, la recitazione, la scenografia, la musica… 178 Modalità e tempi di realizzazione Il Progetto si articola in due parti: 1. 1a Parte (settembre-dicembre anno scolastico 2009-2010): • coinvolgimento dei Collegi docenti delle tre scuole • riunione del Gruppo di Progettazione per predisporre le proposte da presentare nei Consigli di classe • approvazione del Progetto all’interno della programmazione didattica del Consiglio di classe • formazione e autoformazione • incontri con le diverse componenti della scuola (docenti, genitori) • collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio • revisione e adattamento del Progetto sulla base della formazione e autoformazione e delle collaborazioni attivate 2. 2a Parte (gennaio-settembre a.s. 2009-2010): • Attività didattiche scandite in quadrimestri e/o trimestripentamestri 179 Note e Rassegne La X flottiglia Mas Alcune brevi note Michele Bellelli Dagli esordi alla seconda guerra mondiale La X flottiglia MAS, famosa o famigerata a seconda dei punti di vista, è stata in effetti un’unità militare molto più complessa di quanto generalmente non si creda. Per alcuni anni della seconda guerra mondiale è stata un’unità di punta della Regia marina, mentre durante la guerra di Liberazione divenne un reparto specializzato della RSI nella lotta antipartigiana; attività quest’ultima che le ha meritato la parte più triste e sanguinaria della sua celebrità. Le origini della «Decima» si possono far risalire al primo conflitto mondiale quando reparti di motoscafi veloci assaltavano le navi della flotta austroungarica, oppure cercavano di violarne i porti. Il primo progetto di un motoscafo silurante risale al 1906. Si trattava di una piccola unità lunga poco più di una decina di metri, armata di un siluro e munita di motore a scoppio che potevano imprimerle una notevole velocità. Si pensava che, date le sue piccole dimensioni e l’elevata velocità, essa avrebbe potuto portarsi di sorpresa a distanza brevissima da qualsiasi unità di superficie senza che il tiro delle artiglierie riuscisse ad arrestarla … Il progetto rimase sulla carta. Fu solo la guerra mondiale che riportò alla ribalta l’idea dei motoscafi armati di siluro…1. L’impresa più celebre di quegli anni fu quella compiuta dai MAS del capitano di corvetta Luigi Rizzo che il 10 giugno 1918 riuscirono ad affondare la corazzata Santo Stefano, una delle più importanti navi da battaglia della flotta nemica, nelle acque dell’isola di Premuda (a ricordo di quell’evento è stata intitolata una via cittadina, mentre l’anniversario del 10 giugno è tuttora ricordato con eventi e celebrazioni dalla Marina militare italiana). I MAS avevano cominciato a cogliere i primi successi esattamente due anni prima con l’affondamento di alcuni piroscafi austriaci nel porto albanese di Durazzo. Fra gli equipaggi possiamo ricordare anche Giuseppe Aonzo, che partecipò col capitano Rizzo all’impresa di Premuda e Costanzo Ciano, futuro gerarca di primo piano del fascismo e padre di Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri del Duce e marito di Edda Mussolini. Proprio Costanzo Ciano era stato protagonista dell’affondamento di un’altra corazzata austriaca, la Wien, avvenuto il 16 novembre 1917 al largo di Cortellazzo (Jesolo)2. 1 2 N. MORABITO, La Marina italiana in guerra 1915-1918, Marangoni, Milano 1933, p. 161. Ivi, pp. 210-217. 181 L’ultima importante impresa legata ai MAS nella prima guerra mondiale avvenne proprio nelle ultime ore precedenti l’armistizio del 1918. Nella notte fra il 31 ottobre e il primo novembre il maggiore del genio navale Raffaele Rossetti e il tenente medico Raffaele Paolucci forzarono il porto di Pola e affondarono la nave da battaglia Viribus Unitis. Nella seconda metà degli anni Trenta saranno proprio Rossetti e Paolucci a ridare vita ai reparti incursori della Regia marina e a sviluppare i futuri maiali. Molto si è detto anche sul significato della sigla MAS: motoscafo armato silurante, motoscafo anti sommergibile … Gabriele D’Annunzio vi volle trovare un motto da tramandare: Memento audere semper. La sigla originaria probabilmente significa semplicemente motobarca armata SVAN, dove SVAN sta per Società veneziana di automobili nautiche, che era la ditta costruttrice dei battelli durante la Grande Guerra. Nel corso degli anni fra le due guerre la forza navale aveva mantenuto in servizio le flottiglie MAS con scopi sostanzialmente simili a quelli avuti durante la grande guerra ed in seno ad una di queste, la I, vennero ufficialmente aggregati i reparti d’assalto al fine di celare la loro vera natura e sotto tale copertura avrebbero iniziato la seconda guerra mondiale. Il 15 marzo 1941 il reparto assume la sua denominazione ufficiale di X Flottiglia MAS, nuovo nome di copertura per mascherare la vera attività del reparto speciale della marina. Suo primo comandante fu il capitano di fregata Vittorio Moccagatta; l’unità si strutturò su un reparto di superficie agli ordini del capitano di corvetta Giorgio Giobbe ed un reparto subacqueo diretto dal capitano di corvetta Junio Valerio Borghese. La prima azione della X nella sua nuova denominazione avvenne nella notte fra il 25 e 26 marzo 1941 con l’attacco al porto cretese di Suda. Pochi mesi dopo il comandante Moccagatta morì in azione durante un tentativo di forzamento del porto di Malta (25-26 luglio)3 e Junio Valerio Borghese ne assunse interinalmente il posto fino all’autunno, quando il comando effettivo della X Flottiglia MAS è affidato al capitano di fregata Ernesto Forza. Il principe Borghese riceverà nuovamente il comando dell’unità a partire dal primo maggio 1943. Fino all’armistizio la X MAS è attivissima contro le flotte nemiche operando soprattutto nel mare Mediterraneo, ma anche nel Mar Nero dove partecipa alle operazioni militari contro i sovietici, in particolare durante l’assedio di Sebastopoli. Il sito web ufficiale della Marina militare (www.marina.difesa.it) elenca tredici operazioni compiute con successo dalla flottiglia, alle quali vanno poi aggiunte quelle concluse invece con un insuccesso e costate la vita a molti operatori, nonché le operazioni già pianificate, ma mai portate a termine per motivi vari (incluso naturalmente l’armistizio dell’8 settembre 1943 che automaticamente annullò tutte le operazioni previste contro gli Alleati). Fra le imprese concluse vittoriosamente la più famosa è certamente quella compiuta contro il porto di Alessandria nella notte fra il 18 e il 19 dicembre 1941 quando, in un momento già particolarmente delicato per la Royal navy, vennero gravemente 3 Nella medesima operazione muore anche il capitano di corvetta Giorgio Giobbe al cui posto viene nominato il capitano di corvetta Salvatore Todaro. 182 danneggiate le navi da battaglia «Queen Elizabeth» e «Valiant», il cacciatorpediniere «Jervis» e la petroliera norvegese «Sagona». In questo caso tutti gli assaltatori sopravvissero, ma vennero catturati dagli inglesi. Fra le operazioni fallite possiamo ricordare quella del 25 e 26 luglio 1941 contro Malta e costata la vita a ben quindici marinai italiani (fra i caduti Moccagatta, Giobbe e Teseo Tesei) e la cattura di altri diciotto. Un altro grave insuccesso fu l’operazione contro il porto di Haifa conclusasi con l’affondamento del sommergibile «Scirè» che trasportava gli assaltatori e la conseguente perdita di tutti i membri dell’equipaggio e di tutti gli operatori il 10 agosto 19424. Nel novero delle operazioni mai eseguite vale la pena ricordare il progettato attacco contro il porto di New York, previsto per la fine del 1943 e mai realizzato per ovvi motivi. Dopo l’armistizio: la X MAS nella Repubblica sociale Come tutti gli italiani anche i marinai di Borghese rimangono sgomenti alla notizia della resa incondizionata agli angloamericani, ma a differenza di quanto avviene nel resto delle forze armate la X MAS non si sbanda e rimane a piè fermo nelle proprie caserme in attesa degli eventi. Come è noto Borghese con buona parte dei suoi uomini si schiera immediatamente al servizio dei tedeschi, rifiutando l’obbedienza agli ordini del governo italiano che imponevano di cessare le ostilità contro gli Alleati e di considerare l’esercito tedesco come invasore e quindi di combatterlo (messaggio di Badoglio dell’11 settembre). Comandante effettivo della X MAS solo dal maggio precedente, Borghese, comportandosi come un antico capitano di ventura, stipula un vero e proprio patto privato di alleanza con la Werhmacht in base al quale la X era alleata delle forze armate germaniche. Tale patto farà diventare il reparto una forza del tutto autonoma e parallela rispetto ai corpi armati della RSI, perfino della Marina nazionale repubblicana della quale pure formalmente faceva parte. Sulle motivazioni del capitano Borghese di mettersi al servizio dei tedeschi ha pesato certamente anche la sua personale visione del mondo: non poté accettare che il governo avesse firmato un armistizio senza prima informare il comandante della X MAS, discendente di papi e principi, che per una sorta di diritto ereditario avrebbe dovuto essere avvisato di tale iniziativa5. Vale la pena sottolineare alcune caratteristiche del nuovo Stato fascista che lo rendevano palesemente uno Stato a sovranità limitata privo di ogni effettiva autonomia. Gli odierni difensori della RSI vi vogliono vedere uno Stato nazionale italiano sovrano 4 L.E. LONGO, I «reparti speciali» italiani nella seconda guerra mondiale, Murisa, Milano 1991, pp. 54-63. 5 Sulle motivazioni di Borghese vedi anche: S. NESI, Decima flottiglia nostra, Mursia, Milano 2008, S. BERTOLDI, Salò, vita e morte della Repubblica sociale italiana, Rizzoli, Milano 1994, J.V. BORGHESE, Decima flottiglia Mas, Mursia, Milano 2005. 183 e indipendente contrapposto al cosiddetto Regno del Sud nella lotta per il potere nella penisola. La repubblica di Salò continuò (ma sarebbe più esatto dire che iniziò) a combattere a fianco dei tedeschi per rimanere fedele all’alleanza italo-tedesca e vendicare il sedicente tradimento del re e di Badoglio che avevano consegnato l’Italia al nemico. Prescindendo dal fatto che il re era il capo dello Stato e che in base allo Statuto albertino aveva il diritto di dichiarare la guerra e la pace senza consultare il Governo e il Parlamento (un’istituzione quest’ultima eliminata grazie alla dittatura fascista), i nostalgici di Salò amano parlare di onore, di fedeltà e di giuramenti. Evidentemente però anche i giuramenti hanno una loro graduatoria e quello di fedeltà al proprio paese e al proprio sovrano, prestato da tutti i militari, contava meno di quello fra due ideologie. La nascita della RSI servì quindi non tanto a evitare che l’Italia diventasse «un’altra Polonia», come recita una delle scuse preferite dei neofascisti, quanto semplicemente a perpetuare nel tempo l’ideologia e la dittatura di Mussolini. Premesso ciò che cosa mancava alla Repubblica sociale italiana per essere una nazione sovrana? Praticamente tutto, a cominciare dalla sua stessa fondazione, fatta dal duce, ma dietro perentoria richiesta nazista. E poi ancora: è sovrano uno Stato che cede supinamente ampie porzioni del proprio territorio ad un altro paese (Trentino Alto Adige, Friuli)? È sovrano uno Stato che trasferisce la sua stessa capitale per soddisfare le richieste del suo alleato? È sovrano uno Stato che lascia internare centinaia di migliaia di suoi cittadini dal suo alleato? Che lascia completamente in balia della brutalità di un esercito straniero, ancorché ufficialmente alleato, la sua popolazione? Che lascia trasferire in Germania le sue industrie più importanti con la scusa di sottrarle ai bombardamenti (le città tedesche erano attaccate molto più pesantemente di quelle italiane eppure nessuna industria germanica si è trasferita nell’alleata RSI)? È sovrano uno Stato il cui stesso capo è protetto da truppe straniere? Che sovranità può aver una nazione i cui cittadini in tempo di guerra prestano il servizio militare in un esercito straniero? Migliaia di italiani hanno servito nella Werhmacht e addirittura nelle SS: quanti tedeschi hanno militato nella GNR? Ai repubblicani mancava addirittura il requisito basilare per essere un moderno Stato indipendente, vale a dire quello che viene chiamato il monopolio della violenza, cioè l’esercizio esclusivo da parte delle istituzioni del potere militare e di polizia. Come è ben noto, infatti, accanto alle forze armate e di sicurezza ufficiali dello Stato (esercito, marina, aeronautica, guardia nazionale e questure) operò tutta una miriade di milizie private agli ordini diretti ed esclusivi di gerarchi e ras di ogni genere che agivano in maniera del tutto autonoma rispetto al governo di Salò ed a volte anche in contrasto con esso alla ricerca di interessi privati e criminali o al servizio dell’alleato nazista. Fra queste possiamo ricordare le bande Koch e Carità, ma anche, e mi riallaccio al discorso iniziale, la X flottiglia MAS. Privata di fatto di ogni possibilità di operare in mare e contro gli angloamericani si trasformerà in un reparto terrestre, specializzandosi nella lotta antipartigiana. Vi furono alcune eccezioni come le operazioni compiute dal battaglione «Barbarigo6» lungo il fronte di Anzio e altre azioni minori dei MAS contro il naviglio alleato, ma ormai il «destino» militare dell’unità era definitivamente orientato verso la guerra antipartigiana. 184 Grazie ad alcuni importanti miglioramenti relativi al trattamento del personale7 e al rispetto di cui gode presso i tedeschi, che non fanno mistero del loro disprezzo per le altre forze armate repubblicane, la nuova X MAS di Borghese riesce ad attrarre nelle sue fila alcune migliaia di italiani. Fascisti irriducibili, illusi della vittoria finale, avventurieri, militari troppo disgustati dal presunto tradimento del Re che volevano rimanere fedeli all’alleanza con la Germania nazista (ma avevano giurato fedeltà al Re e all’Italia e non al patto d’acciaio) ed altro ancora. Nel corso della guerra di Liberazione assunse una dimensione stimata in circa 20.000 unità8 suddivise in vari battaglioni fra i quali possiamo ricordare i nomi di «Sagittario», «Barbarico», «Nuotatori paracadutisti», «Lupo», «Colleoni», «Fulmine» ed altri ancora fino a incorporare, cosa alquanto strana per quello che formalmente era un reparto di marina, un battaglione di alpini. Ebbe anche una sua unità di intelligence quale la compagnia O (Operativa) posta agli ordini del tenente Umberto Bertozzi e del sergente Schininà dell’ufficio I (Informazioni). Nell’ambiente repubblicano non tutti erano contenti del principe Borghese e dei suoi comportamenti, tanto che più di una volta si tentò di estrometterlo, di metterlo in cattiva luce e di arrestarlo, di portare la X all’interno della normale gerarchia militare, ma senza successo. La fama del suo comandante e il patto stipulato con i tedeschi permisero sempre al reparto di mantenere una completa autonomia decisionale e operativa. Anche da un punto di vista delle prestazioni militari più di una voce si levò contro gli uomini di Borghese: del battaglione «Mai Morti», comandato da Beniamino Fumai, gli stessi nazifascisti ad esempio ironizzavano sul nome dicendo che i suoi uomini non morivano mai perché non combattevano mai9. Nel corso dei venti mesi fra l’armistizio e la liberazione dunque la X MAS si dedicò prevalentemente alle operazioni antipartigiane compiendo, al pari delle altre forze repubblicane e tedesche, rappresaglie ed eccidi contro partigiani e civili. Delle sue azioni in quei venti mesi è rimasta famosa la fotografia che ritrae il partigiano piemontese Ferruccio Nazionale impiccato dagli uomini di Borghese dopo un fallito attentato contro il cappellano del reparto; appeso al collo portava un cartello con la scritta «Aveva tentato con le armi di colpire la X». 6 Il battaglione prese il nome da un sommergibile oceanico della Regia marina affondato nel giugno 1943. Il battello è rimasto noto anche perché il suo comandante, Enzo Grossi, nel 1942 aveva dichiarato di aver affondato due corazzate statunitensi nell’oceano Atlantico; affondamenti sempre negati dalle autorità di Washington. Al «Barbarigo» sono invece ufficialmente accreditate 39.299 tonnellate di naviglio nemico affondato, ma nessuna corazzata. 7 Vitto uguale per ufficiali e truppa, promozioni solo per merito di guerra e non più per anzianità, arruolamento esclusivamente volontario e una paga migliore fra le altre cose. 8 I mezzi d’assalto, Ufficio storico della marina militare, Roma 1992, pp. 211-213. 9 Lo stesso Borghese decise di disfarsi di Fumai e dei suoi «Mai morti» perché ritenuti non affidabili e non gestibili. 185 La Decima del Sud Quella parte di marinai che al momento dell’armistizio del 1943 scelsero di non seguire Borghese e la sua linea di condotta filonazista cercò di raggiungere, chi già non vi si trovava, il Governo italiano a Brindisi nel sud già liberato dagli alleati. Pur fra mille difficoltà Badoglio riuscì a creare una piccola forza armata da affiancare agli angloamericani ed anche la Regia marina fece la sua parte. La X del sud riprese la sua attività con il nuovo nome di Comando mezzi d’assalto, abbreviato in Mariassalto, e portò a termine centinaia di operazioni a fianco degli alleati e in appoggio al movimento clandestino del nord. Secondo l’Ufficio storico della marina militare solo entro il dicembre 1943 vennero eseguite 250 missioni di sbarco e recupero di sabotatori e informatori oltre le linee nemiche e 32 missioni di recupero di militari italiani dai Balcani che consentirono il rimpatrio di 1600 commilitoni. Ricominciarono anche le vecchie operazioni di forzamento dei porti nemici come quelle del 21 giugno 1944 per affondare l’incrociatore Bolzano a La Spezia (operazione congiunta con gli inglesi) e a Genova il 19 aprile 1945 per affondare la portaerei Aquila. Venne tentato anche un nuovo assalto alla baia di Suda che aveva visto l’esordio operativo della X flottiglia MAS nel 1941. Comandante di Mariassalto fu Ernesto Forza, già predecessore di Borghese alla guida dei mezzi d’assalto della marina italiana10. È noto pure che le due X, quella del nord e quella del sud, rimasero sempre in contatto durante la guerra di liberazione: una sorta di lavoro preparatorio per rimettere insieme le due anime del reparto in vista di un dopoguerra che comunque si preannunciava denso di problemi per le forze armate. A riprova di ciò valga la fuga di Borghese verso sud nei giorni della liberazione grazie alla collaborazione degli alleati e dei suoi ex commilitoni11. Non vi è traccia di un’attività militare della Decima nel reggiano, anche se è da ricordare che la locale XXX brigata nera venne intitolata a Giuseppe Ferrari, un volontario reggiano che fu ucciso dai partigiani il 14 ottobre 1944. 10 I mezzi d’assalto, cit., pp. 211-213. Borghese utilizzò fra l’altro, sebbene con più fortuna, lo stesso stratagemma di Mussolini che in quegli stessi giorni cercava di fuggire in Svizzera: il dittatore cercò di passare inosservato indossando un’uniforme tedesca, mentre il comandante ne indossò una statunitense. 11 186 Classificare, pensare, escludere Un importante seminario di formazione per docenti Carlo Pellacani Promosso dalla Sezione didattica del nostro Istituto – d’intesa con il Mémorial de la Shoah di Parigi, gli Istituti storici della Resistenza dell’Emilia-Romagna, la Fondazione Fossoli, l’ANPI e la Commisione sanmarinese per l’UNESCO – nelle giornate del 6-7 novembre e del 6-8 dicembre 2009 s’è svolto il seminario di formazione per docenti al quale ha partecipato una nostra nutrita rappresentanza costituita da operatori di Istoreco e da docenti di scuole cittadine. Il seminario aveva per titolo Classificare, pensare, escludere ed aveva come obiettivo di mettere in luce il terreno culturale che nel corso del XVIII e del XIX secolo ha preparato la Shoah e, più in generale, gli altri genocidi di massa del Novecento. Esso ha fornito elementi di valutazione per identificare alcune tappe di un percorso che ha condotto a concepire e realizzare programmi di annientamento, in nome della razza, in un periodo in cui in Europa era prevalente l’esaltazione della forza e della virtù redentrice della guerra, nonché una ferma convinzione dell’ineguaglianza delle «razze umane». Tale concezione era possibile nell’ambito di un rifiuto dell’insegnamento positivista dell’Illuminismo che aveva i suoi cardini nelle proposizioni di libertà, uguaglianza, fraternità, accolte anche in Italia e alla base delle scelte repubblicane e democratiche della nostra gente a partire dal 1796. Il corso, svoltosi a Bologna nei primi due giorni ed a Parigi nelle restanti giornate, ha fornito ai partecipanti strumenti interpretativi e storiografici che consentiranno loro di approfondire gli eventi e i temi proposti, soprattutto alla luce delle diverse ricerche storiografiche pubblicate in questi ultimi anni in Europa. Non sono mancati interventi più prettamente didattici, con l’intento di offrire agli insegnanti materiali e spunti di lavoro per la rielaborazione dei concetti discussi in una prospettiva educativa, declinando al tempo presente un tema di grande attualità come il razzismo. Qualificato il parterre di studiosi con i quali gli insegnanti hanno potuto confrontarsi. Tra gli altri, Alberto Burgio, Nicola Labanca, Tal Bruttmann, Georges Bensoussan, Joel Kotek, Christian Ingrao, Iannis Roder, Valentina Pisanty, Annette Becker, Alberto Cavaglion, Gianluca Gabrielli. Determinante per il buon esito dell’iniziativa è stata la collaborazione della Regione Emilia Romagna (che ha ospitato la prima parte del seminario ed è stata rappresentata per tutta la sua durata dalla presidente Monica Donini e dall’assessore Massimo Mezzetti), ma soprattutto la efficienza della struttura operativa del Mémorial de la Shoah, attraverso la puntuale gestione esecutiva di Laura Fontana e l’ospitalità e i servizi della sede parigina del Museo. I partecipanti (oltre sessanta persone, in rappresentanza della Regione EmiliaRomagna, di cui nove per il nostro Istituto) hanno potuto trarre importanti indicazioni 187 per la loro attività, approfittando della condivisione di momenti di forte impatto culturale e del contatto con valenti studiosi delle logiche di formazione del pensiero razzista in Europa. Il giudizio positivo sull’iniziativa che ha accomunato i docenti che hanno potuto fruire di questa opportunità ha fatto emergere l’esigenza che simili occasioni di approfondimento e di crescita culturale possano ripetersi negli anni a venire. Tale attesa è avvalorata dalla convinzione che l’antisemitismo è un retaggio del passato che non è destinato a scomparire, come afferma autorevolmente Georges Bensoussan. Arte e design nel mondo diviso (A margine di una mostra al MART di Rovereto) Carlo Pellacani La Guerra fredda la cortina di ferro, le tensioni tra l’alleanza atlantica e i Paesi del blocco sovietico, oggi sembrano episodi lontani, ma in realtà hanno accompagnato la storia del Novecento, dal dopoguerra agli anni Settanta, ed hanno ispirato e animato le manifestazioni della creazione artistica per alcuni decenni. Due studiosi inglesi, Jane Pavitt e David Crowley, con l’appoggio del Victoria & Albert Museum di Londra e del Museo d’arte moderna di Rovereto, hanno cercato di ricostruire il clima di un periodo cruciale per la società, la politica e la cultura mondiale, attraverso lo sguardo delle arti, dal design all’architettura, dal cinema alle arti visive. Per raggiungere il loro scopo hanno raccolto e posto in mostra duecentocinquanta oggetti che potessero testimoniare, nella loro autenticità, le differenze culturali e le logiche contrapposte in base alle quali le due nazioni più potenti del periodo – URSS e Stati Uniti – hanno influito sullo sviluppo sociale ed economico delle rispettive aree d’influenza, condizionandosi vicendevolmente. Basandosi sulla ricostruzione del percorso ideativo, delle realizzazioni e degli utilizzi di oggetti e opere artistiche provenienti dai due blocchi del mondo diviso, i curatori hanno esposto l’evoluzione della Guerra fredda, dal momento del suo manifestarsi, nel momento della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, alle fasi più acute e al suo declino dopo trent’anni di competizione acerrima a base di innovazioni scientifiche, corsa agli armamenti, programmi di edilizia sociale. Con l’esposizione di materiali provenienti da Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito, Cuba, Germania Ovest e Germania Est, Italia, Polonia, Francia e Cecoslovacchia, i curatori della mostra Guerra fredda, arte e design nel mondo diviso hanno promosso un’approfondita analisi delle conseguenze dirette della contrapposizione del mondo in blocchi, favorendo una presa di coscienza del divario crescente che si era stabilito tra le forze in campo e del costo – in termini economici, sociali e culturali – che tale competizione comportava per le popolazioni coinvolte. 188 I nuovi prodotti e le tecnologie industriali del mondo occidentale sono stati messi a confronto con l’arte e l’architettura del realismo socialista. In questo campo uno spazio privilegiato è stato fornito all’esposizione delle visioni architettoniche rivali che si fronteggiavano a Berlino: nella parte est la monumentale Stalinallee e nel settore ovest i programmi edilizi di Interbau, con il coinvolgimento di protagonisti dell’architettura moderna come Le Corbusier e Walter Gropius. La mostra ha dedicato un’attenzione speciale al desiderio di modernità che era presente nei due poli (basti pensare al celebre dibattito tra Nixon e Kruscev sulla funzione dello spazio della cucina all’interno della casa), anche se l’immaginario collettivo era ossessionato dal pensiero di un’incombente guerra nucleare. Per dare concretezza a tale ansia di progresso tecnico, sono stati esposti oggetti e dati sulle conquiste dello spazio e sui trionfi della scienza applicata. È stato possibile accostarsi alla prima navetta spaziale russa e ad oggetti appartenuti a Yuri Gagarin nel suo volo con la Vostock, ma anche a progetti americani per gli interni delle navette spaziali della NASA, cui erano affiancate tute sperimentali e mobili e architetture ispirati al mondo della fantascienza. Tra i documenti esposti non potevano mancare manifesti e films di carattere propagandistico, giungendo a contrapporre, per documentare la gara in altezza tra le grandi realizzazioni edilizie, un modello della Post office tower di Londra e della torre Ostankino di Mosca. Ampio spazio è stato riservato anche alla presentazione di progetti sviluppati grazie alla ricerca tecnologica derivante dall’industria bellica e studi di architetti per oggetti di consumo rivolti ad una nuova società tecnocratica. Non meno importante, sotto il profilo documentativi, la presenza di fotografie illustranti il disagio delle nuove generazioni da una parte e dall’altra dei due blocchi. La mostra e il catalogo, già impegnati in successive trasferte a Mosca e a New York, hanno costituito un’occasione importante di approfondimento della conoscenza delle logiche della «Guerra fredda» e degli effetti che tale stato di fatto ha generato nella collettività mondiale. Essa ha inoltre permesso di confrontare la realtà e le ambizioni di due mondi divisi, in conflitto per una supremazia che non aveva come fine il benessere dell’uomo ma unicamente l’affermazione di potenze militari e politiche. Attraverso materiali e documenti d’epoca è stata realizzata una lezione di storia che meriterebbe di essere divulgata in modo più ampio tra le generazioni d’oggi. 189 Recensioni I. DEUTSCHKRON, L. RUEGENBERG, Papà Weidt, l’uomo che tenne testa ai nazisti, RS libri-Istituto Regionale per i ciechi «G. Garibaldi», Reggio Emilia 2009, 10 euro «Questa è la storia di un giusto: Papà Weidt» sono le prime parole dell’introduzione scritta da Matthias Durchfeld al libro-testimonianza per ragazzi omonimo. Una piccola importante produzione di Istoreco e Istituto Regionale «G. Garibaldi» per i ciechi per svariati motivi. Il primo: perché racconta una storia personale, una microstoria, persa nella storia con la lettera maiuscola di un uomo coraggioso che ha osato sfidare i nazisti sul tema delle leggi razziali e della deportazione, un piccolo uomo che non si è arreso al contesto in cui viveva e ha agito secondo coscienza salvando altre vite, altri uomini, donne e bambini. Quest’uomo si chiamava Otto Weidt, era un non vedente, che ha deciso di dare lavoro e trattare umanamente e non conformemente al pensiero razzista vigente, ad altri che in quel momento erano ai margini della società e stavano per esserne espulsi attraverso la loro eliminazione fisica: gli ebrei. Otto Weidt ne salvò diverse decine, molti esseri umani, una persona più una persona più una persona, quasi cento vite, volti, corpi, ricordi che senza la sua generosa e coraggiosa condotta si sarebbero persi nei sei milioni di morti assassinati della Shoah, il genocidio del popolo ebraico. Otto Weidt come dice il Talmud ha «salvato il mondo intero», salvando vite, e diventando un «Giusto fra le nazioni», un non ebreo che salva ebrei: è stato definito in questo modo dal Museo memoriale Yad Vashem di Gerusalemme in Israele che gli ha riconosciuto questo grande merito. Papà Weidt è poi importante perché è una testimonianza di una ragazza dell’epoca, Inge Deutschkron, che oggi parla ai ragazzi di ciò di cui è stata privata, delle persecuzioni che ha subito, e anche della solidarietà che ha ricevuto nella fabbrica di spazzole di Otto Weidt e da altri tedeschi che non si erano lasciati mettere i paraocchi dell’ideologia che si fa legge di stato. La signora Deutschkron l’abbiamo incontrata a Berlino durante uno dei nostri Viaggi della Memoria che da anni come Istoreco organizziamo. Il suo volto e la sua voce sono stati fermati nelle immagini del video che documenta il viaggio. Di lei in questo video (a cura di Andrea Mainardi) dove incontra gli studenti reggiani in visita allo spazzolificio, ora museo di Otto Weidt, ricordo due cose limpide e chiare: la sua grinta e la sua determinazione nell’affermare che «i neonazisti sono dei fuori di testa e gli dovrebbero proibire di dire le cose che dicono visto ciò che è accaduto» e la sua dolcezza nel ricordare Otto Weidt e ciò che era riuscito a creare nella sua fabbrica di spazzole: «ci trattava come persone, cosa che non ci era più capitata da molto tempo, e noi ci sentivamo protetti per la prima volta». Papà Weidt rientra in un progetto di rilievo del nostro istituto, in collaborazione con Istituto Regionale «G. Garibaldi» per i ciechi: questa storia, come già accennato, l’abbiamo conosciuta durante il Viaggio della Memoria a Berlino nel 2009 e i ragazzi 190 della classe 4a A del Liceo Scientifico «Spallanzani» (a/s 2009-10), liceo che come molte altre scuole della provincia di Reggio Emilia partecipa al progetto, hanno poi scelto assieme ai loro insegnanti Tiziana Fontanesi e Manuela Marcucci di tradurla dal tedesco per il giovane pubblico italiano. Ed ecco l’ultimo, ma non ultimo, motivo di importanza di questa piccola ma preziosa pubblicazione: il pubblico a cui essa si riferisce. Una storia vera narrata e disegnata per i ragazzi di oggi, una rarità nel panorama dell’editoria italiana in questo ambito così povera di edizioni originali e mal fornita anche di quelle storie adatte a un pubblico di giovani lettori che – provenienti da paesi vicini come Francia e Germania – potrebbero essere benissimo tradotte e pubblicate in Italia. È adatto a un pubblico di giovani lettori, Papà Weidt, perché affronta l’argomento della persecuzione razzista e deportazione in modo non traumatico scegliendo di raccontare una rara storia di solidarietà, che lascia qualche speranza rispetto al disastro e al vuoto procurato dalla caccia e dall’uccisione sistematica degli ebrei da parte dei nazisti e dei loro collaboratori in tutta Europa. Il libro quindi si inserisce in un percorso di divulgazione pedagogica non traumatizzante già tracciato altrove in Israele e nel vecchio continente. Anche il linguaggio utilizzato così come l’illustrazione all’interno della narrazione favorisce un approccio soft a temi ben più «pesanti» che lo rendono perciò particolarmente adatto ai più piccoli. Papà Weidt quindi nelle nostre librerie e nelle nostre case, letto ai nostri figli, ci ricorderà di tempi difficili in cui alcune persone hanno compiuto scelte profondamente coraggiose. Per chiudere con le parole di Durchfeld: «I Giusti, non risultano sui libri di storia, anche se il loro messaggio è molto importante. I Giusti erano ovunque. Non esisteva e non esiste un paese dove tutti si comportino in modo uguale. Non erano grandi eroi né santi. Erano persone che hanno avuto però il merito di salvare, oltre a delle vite, anche la dignità dell’unica razza che esiste: la razza umana». Alessandra Fontanesi M. CARRATTIERI, M. MARCHI, P. TRIONFINO, Ermanno Gorrieri (1920-2004). Un cattolico sociale nelle trasformazioni del Novecento, (con un saggio introduttivo di Paolo Pombeni), Il Mulino, per conto della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali di Modena, Bologna 2009, pp. 872, 50 euro L’opera, frutto di una ricerca biennale condotta in équipe da Mirco Carrattieri, Michele Marchi e Paolo Trionfino, propone un quadro esaustivo – a cinque anni dalla sua scomparsa – dell’opera e della figura di Ermanno Gorrieri. Come sottolinea Paolo Pombeni nell’introduzione, si è trattato di un’operazione alquanto rischiosa in quanto ha dovuto fare i conti con l’esigenza di ricostruire un itinerario esistenziale non soltanto utilizzando fonti archivistiche, ma confrontandosi con frammenti di vita che non sono riproducibili nelle pagine di una ricerca storica. A tali difficoltà si è sommata la peculiarità di un personaggio la cui attività si è sviluppata in un arco temporale che copre quasi tutto il Novecento e presente in contesti diversi tuttora da acquisire sul piano storiografico. La storia personale di Gorrieri ha portato, poi, i ricercatori a scontrarsi con un andamento divergente tra documenti d’archivio e studi sul periodo, a favore di questi ultimi nella fase iniziale della vicenda da narrare e caratterizzata da assenza di riferimenti storiografici nell’ultima fase. 191 I tre studiosi che hanno svolto la ricerca per conto della Fondazione modenese, hanno suddiviso la loro fatica per periodi. Michele Marchi ha sviluppato il percorso evolutivo della storia personale di Gorrieri dal 1920 al 1963, proponendone un’analisi dettagliata dello sviluppo culturale, dell’affermazione della sua coscienza democratica e del consolidarsi del ruolo di attivista politico e sindacale. A Paolo Trionfino è stata affidato il compito di delineare l’articolata militanza politica nella Democrazia cristiana, a livello locale e nazionale, e la partecipazione allo sfaldamento della «nazione cattolica» nonché ai tentativi di rifondare tale partito. Mirco Carrattieri ha analizzato la storia di Gorrieri dall’inizio degli anni Ottanta e fino alla sua scomparsa, un periodo denso di iniziative e di sperimentazioni, con un’attenzione permanente alla responsabilità sociale della politica e alla ricerca di uguaglianza nelle condizioni di vita dei cittadini. La ricostruzione storica della vita di Ermanno Gorrieri, pur con le approssimazioni derivanti dalla difficoltà di contestualizzarne ogni aspetto, costituisce un contributo di grande importanza per la conoscenza del Novecento. Il lavoro, realizzato per esplorare e divulgare la straordinaria figura e la variegata attività di questo modenese d’eccezione, rappresenta un tassello insostituibile per la comprensione di un periodo ancora largamente inesplorato. Il merito spetta ai tre ricercatori e a quanti hanno inteso – tramite loro – conservare la memoria di un convinto e pervicace testimone dell’impegno politico per il bene comune. Carlo Pellacani G. NOTARI, Hai un cuore forte, puoi correre. Autobiografia di un partigiano montanaro, prefazione di Antonio Zambonelli, Edizioni Consulta, Reggio Emilia 2010, pp. 128, 12 euro Giacomo Notari, partigiano montanaro e attivamente impegnato nella vita pubblica reggiana prima di essere chiamato a presiedere l’ANPI di Reggio Emilia nel 2002, affida a queste pagine la storia di una vita intensa, vissuta senza ripensamenti. La narrazione è vivace e avvincente, ricca di riferimenti e di informazioni su eventi che hanno caratterizzato il periodo bellico e la ricostruzione politica e civile della provincia reggiana. Notari adotta come confini della sua autobiografia l’amore per l’ambiente montano, la passione politica e l’attaccamento alla famiglia. Tre cardini attorno ai quali si sviluppano ottanta anni di vicende personali e di impegno pubblico, visti nell’ottica di un abitante di Marmoreto di Busana che si mantiene costantemente avvinto alle sue radici. L’opera fornisce una fotografia fedele dell’evoluzione sociale e politica del Novecento attraverso la descrizione delle motivazioni e della partecipazione dell’Autore alla lotta per la libertà e per la democrazia: unitamente al resoconto efficace e documentato di vicende partigiane e di incarichi elettivi svolti nel dopoguerra, accoglie descrizioni particolareggiate degli usi, dei costumi e delle bellezze naturali dell’Alto Appennino. Completando le informazioni fornite da preziose immagini didascaliche, la prefazione di Antonio Zambonelli sottolinea la capacità dell’Autore di mantenere un 192 atteggiamento di understatement, cioè di non cedere alla propensione a ipervalutare ruoli e funzioni, spesso adottata da parte di chi stende la propria autobiografia. Per gli aspetti indicati l’opera costituisce un supporto attendibile per la comprensione di un periodo del secolo scorso che lamenta carenze di ricostruzione storiografica, contribuendo a colmare carenze conoscitive e sanando informazioni distorte. Carlo Pellacani M. CARRATTIERI, G. VECCHIO, La Penna. Periodico indipendente, Riproduzione anastatica, Edizioni Diabasis, 2010, 60 euro. Esce, a quarant’anni di distanza, l’edizione anastatica dell’intera raccolta del periodico «La Penna», il giornale che riporta le cronache e le polemiche sull’attività resistenziale a Reggio nel periodo bellico e nell’immediato dopoguerra nell’ambito della quale è maturata l’uccisione di Giorgio Morelli, giovane e tenace volontario della libertà. Come allora, la pubblicazione ha sollevato interessi e attese. Anticipando aspetti di ricerche in corso, il volume accoglie significativi contributi storici su questioni irrisolte della biografia del Morelli e del suo impegno politico, ma anche sull’interpretazione dei fatti e sull’uso e sull’abuso della memoria. Mirco Carrattieri effettua un attento risarcimento dell’autonomia e dell’originalità della figura di Giorgio Morelli, solitario per scelta esistenziale ma anche per costrizione degli eventi nei quali si trova avviluppato. «La tragedia del Solitario», scrive Carrattieri, «non può essere di seconda mano, né avere secondi fini», come è invece ridotta ad essere da parte di coloro che ne fanno «oggetto di polemica politica più che di un’accurata ricostruzione storica». È un richiamo esplicito all’utilizzo, non sempre metodologicamente lineare, che Giampaolo Pansa e certa pubblicistica di parte hanno fatto di questa vicenda. Ed è un invito pressante ad approfondire le indagini su una storia umana e politica che s’innerva con decisione nella realtà reggiana dell’immediato dopoguerra e trae le sue ragioni più profonde dall’esercizio della lotta partigiana e dalla condivisione di ansie e speranze di un’intera collettività. «Si tratta di un’esperienza molto legata al suo contesto e ai suoi straordinari attori, anche se non ha avuto un seguito significativo», conclude Carrattieri. Tali ragioni rappresentano una forte sollecitazione a decifrare la reale portata di un percorso di vita e d’impegno politico che coinvolge altri personaggi reggiani, identificati «per il loro coraggio nell’assumere gravose responsabilità, ma anche per il loro approccio alla vita pubblica». L’edizione anastatica del giornale morelliano offre la stura per un risarcimento del suo apporto alla stagione di lotte e di speranze che nasce dalla fine del conflitto armato, quando una rigida contrapposizione ideologica e lo scontro fratricida sembrano minare proiezioni ideali. Giorgio Vecchio fornisce un’analisi di controverse interpretazioni della memoria storica, spesso contrabbandate come volontà di conseguire una «memoria condivisa» che naufraga in una ricostruzione disonesta dei fatti, fatta celando i lati oscuri e 193 rimuovendo le differenze. Altrettanto rilevante è, per Vecchio, l’esigenza di contestualizzare il passato, evitando la prassi generalizzata e fuorviante di formulare giudizi sugli eventi e sui comportamenti delle generazioni che ci hanno preceduto sulla base delle conoscenze e delle consapevolezze dell’oggi. Inoltre, lo storico pone in risalto gli effetti dell’onda lunga della violenza che spesso si somma con quella della memoria, creando effetti perversi per lunghi periodi, travalicando la responsabilià delle generazioni direttamente coinvolte. Questa analisi, complessa e fluida nel suo farsi, rende problematico un giudizio sulle manifestazioni di violenza dei giorni antecedenti o seguenti la Liberazione. Esse paiono non derivare da razionalità, calcolo politico, programmazione, quanto essere frutto di individualità represse, di paure inconfessabili, di mire di potere personale o di vendette per torti subiti. Della complessità e diffusione del fenomeno, più che di una verifica quantitativa, è espressione il costante monitoraggio degli eventi e l’attenzione che i massimi dirigenti nazionali dedicano loro. L’epopea morelliana si colloca in questa fase con la determinazione e la risolutezza di un sovversivo, indifferente alle intimidazioni, proteso a smascherare fatti e comportamenti che non riescono a trovare adeguata copertura in versioni di comodo. Con i suoi scritti e con il suo atteggiamento, Giorgio Morelli ricerca verità e giustizia tra le piaghe purulente di una classe dirigente che non riesce a recuperare i caratteri di una comunità che aveva sempre professato coesione sociale e alacre laboriosità. Molti aspetti non sono ancora ben chiariti a sessant’anni di distanza, né è così facile comprendere le ragioni dei protagonisti, spesso travolti dal contesto di lotta. «La Penna», con le ingenuità ed esacerbazioni proprie dell’età giovanile, è specchio fedele di un periodo che ha inciso profondamente sul processo di affermazione di una cultura democratica nella nostra comunità. C’è da augurarsi che, sull’onda del crescente interesse per la comprensione di tali momenti, le ricerche su Giorgio Morelli possano continuare, e con esse anche quelle relative all’immediato dopoguerra e alle fasi successive della ricostruzione nazionale. Sarebbe, questo, il modo migliore per risarcire la figura e l’opera del Solitario. Ci sia consentita una nota sulla scelta del formato del volume. La difficoltà di comprensione dei testi originali e il rispetto delle dimensioni originali della raccolta non sono ripagate dalla scomodità di lettura e di gestione del volume, ridotto a icona rappresentativa più che a strumento di approfondimento e di divulgazione di una testimonianza umana e politica. Tali ragioni, purtroppo, disperdono gran parte del recupero storicistico, non agevolano la percezione della reale portata dei contenuti e tolgono meriti ad un’iniziativa editoriale qualificata. Carlo Pellacani G. RINALDI, I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie, Ediesse, Roma 2009, pp. 198, 10 euro Negli anni dell’immediato secondo dopoguerra, molti convogli ferroviari trasportarono migliaia di bambini dalle zone devastate della guerra e travolte dalla miseria dell’Italia centromeridionale (ma anche da grandi città come Milano) verso 194 l’ospitalità di altrettante famiglie dell’Emilia Romagna (e la città di Reggio è stata in prima fila), della Toscana, delle Marche. Una ospitalità ispirata senza dubbio anche da motivazioni politiche (fu una iniziativa in sostanza di comunisti), ma più sensatamente parleremo di un profondo senso civile di solidarietà. Il libro di Giovanni Rinaldi, un ricercatore pugliese che da tempo si occupa di memorialistica, rappresenta appunto un primo, fondamentale punto fermo nella ricostruzione e nella divulgazione di questo vero e proprio fenomeno di massa – un fenomeno, sia detto per inciso, che appare ancora più formidabile (e anche incomprensibile) a rileggerlo con gli occhi dell’Italia di oggi; davvero da allora una «rivoluzione antropologica» si è consumata nel nostro Paese. Come oggi sarebbe possibile una solidarietà comunista di quella ampiezza, di quella intensità? Il volume è a un tempo una raccolta di interviste, sia ad alcuni bambini allora ospitati, sia a membri (quasi sempre allora pure bambini) di alcune famiglie ospitanti, ma anche un racconto del farsi di questa ricerca, un saggio sul costituirsi di un interesse e di una serie di relazioni e conoscenze. Che cosa spicca da questi dialoghi, da queste testimonianze raccolte con tanta fatica? Va detto anzitutto del magnifico lavoro, spontaneo, dal basso, diffuso, spesso in conflitto con i vertici del PCI, svolto dalle militanti e dalle responsabili dell’UDI, per riuscire a formare i treni, per garantire un’ospitalità diremmo oggi di «qualità» (sanitaria, educativa, ricreativa), anche grazie poi al supporto di diversi amministratori locali. Per molti bambini poverissimi del sud l’Emilia era già quel «mondo nuovo» sognato da tanti. Queste esperienze non potevano che creare conflitti, anzitutto nelle menti di quei ragazzi catapultati da un’Italia a un’altra, catapultati in un ambiente radicalmente diverso per mille ragioni, da un sottoproletariato assillato dalla fame a contesti di famiglie proletarie (spesso di «aristocrazia operaia»), dove già si poteva immaginare una vita nel benessere. Conflitti nascevano quando i bambini dovevano dopo qualche mese rientrare nelle famiglie d’origine, che giudicavano ormai con occhi irrimediabilmente diversi. In molti casi essi hanno deciso di tornare in Emilia, e molti vi hanno passato la vita. Le famiglie d’origine a loro volta si ritrovavano dei figli «viziati», abituati a mangiare più e meglio, a indossare vestiti che non fossero stracci, a usare le scarpe. E dire che – questo è un tema che ritorna costantemente nelle testimonianze – i bambini spesso partivano con nella testa le paure instillate loro dalla propaganda anticomunista dei parroci (e non solo da quelli). Ad esempio: «“Ricordo solamente che partimmo da questo paese, e c’erano anche i miei genitori. Tutti dicevano: ‘Non li mandate via perché là ci sono i comunisti che se li mangiano!’. Ricordo il viaggio di notte, che a me sembrò eterno e il cartellino col nome che mi avevano cucito al cappotto perché ero la più piccola”. Anche lei ripete di aver viaggiato nel terrore perché prima di partire, al paese, le avevano raccontato che in Romagna i comunisti bruciavano i bambini» (p. 140). Questo libro è anche la cronaca di un lungo viaggio alla ricerca di un’Italia ormai scomparsa, un’Italia dove l’ospitalità verso i bambini del dopoguerra non era spesso che la prosecuzione dell’ospitalità verso partigiani e soldati alleati durante la guerra. Francesco Paolella 195 M. NACCI, Storia culturale della Repubblica, Bruno Mondadori, Milano 2009, pp. 149, 14,50 euro Questo libro è una rassegna ricca e complessa della saggistica prodotta attorno al cosa, al chi e al come della cultura italiana dal secondo dopoguerra a oggi, ossia: a che cosa sia stato e sia oggi considerato «cultura» nel nostro Paese, al potere rivestito dagli intellettuali italiani (e ai rapporti degli intellettuali con il potere), agli strumenti a disposizione della cultura (editoria ed altri mezzi di comunicazione, istituzioni, università). Al centro del volume sta appunto il libro come prodotto culturale, ma anche come merce caduta negli ultimi tempi in un coma pare irreversibile. Una storia della cultura italiana (e quindi dell’identità italiana) dal 1945 non può fare a meno di alcuni ingredienti: le riflessioni sul fascismo (e quindi sull’antifascismo degli intellettuali), l’irrazionalismo, il provincialismo, l’antitecnicismo come elementi costanti, il rapporto fra politica (il PCI su tutti) e la cultura (l’intellettuale organico, i compagni di strada). Michela Nacci attinge ai libri di Gramsci (il Gramsci dei Quaderni), di Bobbio, di Garin, di Del Noce, e colloca agli anni Settanta il momento in cui l’Italia ha iniziato a cadere, a perdere, a svuotarsi, anche culturalmente. Si è trattato di una frattura prodotta dall’intricarsi e sovrapporsi di tanti elementi: l’«impero irresistibile» del consumismo, la fine delle ideologie, la confusione crescente fra «destra» e «sinistra» (ricordarsi dell’ultimo Gaber!), la decadenza del ruolo dell’intellettuale, la desolazione dell’università e delle istituzioni culturali. Oggi la cultura non è che il punto di incontro – non conflittuale – fra politica (interessi particolari) e spettacolo (in senso lato): le lauree honoris causa a sportivi e cantanti lo dimostrano con violenza. Si è creato un cortocircuito fra cultura alta e cultura bassa (di massa), fra editoria, televisione, pubblicità: tutto è diventato «oggetto culturale». Quale è allora il rischio di una posizione «neoapocalittica», secondo la definizione classica di Eco del 1964, che la Nacci rielabora? È quello di cadere nella nostalgia confusa, nel conservatorismo cieco, nell’idolatria di un passato per molti versi pure pessimo (ad esempio dal punto di vista della miseria e delle ingiustizie, del ruolo supino degli intellettuali verso il potere, ecc.). Non bisogna assumere la modernità come «feticcio negativo». L’ultimo capitolo del volume, L’epoca e il suo spirito, senza dubbio il più interessante, è appunto dedicato alla rappresentazione di questa posizione «neoapocalittica», tanto ormai diffusa quanto (almeno all’apparenza) radicale. Michela Nacci cita due autori, Claudio Giunta (L’assedio del presente, Il Mulino 2008) e Raffaele Simone (Il Mostro mite, Garzanti 2008) come le espressioni più compiute di questa attuale (ma non nuova) autoriflessione della cultura italiana: che Paese è oggi il nostro? Dobbiamo collocarlo in una prospettiva di crescita o di declino? L’Italia è una nazione avanzata oppure arretrata? Questi temi, trasversali a ciò che resta della destra e della sinistra, vengono letti alla luce di una modernità cattiva e fallimentare, in uno stato di allarme permanente: il progresso è perdita secca di cultura. La cultura autentica è scomparsa o ridotta a un fantasma, dominano la pigrizia, il disinteresse, il cinismo, l’omologazione; i «nuovi soggetti culturali», come i giovani, le donne, ma anche i migranti, sono schiavi ebeti del consumismo. E che dire degli «imbecilli specializzati» di cui parlava Flaiano? Le masse sono abbrutite dalla televisione, dall’ignoranza, dalle spese compulsive. Consumismo e tecnologia sono 196 mostri ormai ingovernabili, male puro. Questo affermano i «neoapocalittici» nel quadro fatto dalla Nacci. Ecco allora tornare (di moda) la lezione dei francofortesi e imporsi quella di Bauman, ed ecco soprattutto dominare l’immagine di Pier Paolo Pasolini, usato come un «padre spirituale» di questa corrente. Per l’autrice si tratta però di un Pasolini addomesticato, imbalsamato nel ruolo un po’ ingenuo di «poeta delle lucciole», di un difensore paradossale (solo paradossale) di una tradizione tutt’altro che dorata. E su questo non si può che essere d’accordo. Sicuramente avremo sempre più bisogno delle profezie del poeta bolognese, ma certo non di un suo santino alla lunga irritante. Non ha davvero senso contrapporre in maniera assoluta passato e presente; non si può invocare una tradizione di purezza intellettuale rispetto all’orrore attuale. D’altra parte, i «neoapocalittici», pur facendo bene a denunciare con ostinazione la desolazione attuale e l’assenza di prospettive, non possono rinunciare alla prospettiva del cambiamento e al riconoscimento (almeno della necessità) di un soggetto politico per il cambiamento. La storia, la ricostruzione minuta e marginale delle origini (economiche, politiche, culturali) del disastro presente, possono essere senza dubbio un sostegno a questa battaglia ancora tutta da inventare (e probabilmente da perdere). Francesco Paolella G. MAMELI, Fratelli d’Italia (a cura di D. Bidussa), Feltrinelli, Milano 2010, pp. 122, 6.50 euro In anticipo rispetto le celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia, nel corso delle quali è prevedibile che qualche spazio verrà riservato a controverse prese di posizione sull’inno nazionale e sul suo autore, David Bidussa ha raccolto gli scritti di Goffredo Mameli, poesie d’amore e convincimenti morali, ma soprattutto gli articoli e i proclami politici che egli produsse nel periodo 1846-1849, emblematici di una fede salda nei valori risorgimentali e di una forte speranza nella nascita di uno Stato democratico e unitario. Goffredo Mameli fu, prima di Mazzini, tra i fondatori della Repubblica romana nel 1849. E morì alle porte di Roma il 6 luglio di quell’anno (dopo un’agonia durata quasi un mese) per il «fuoco amico» di un bersagliere che partecipava all’assalto per riconquistare posizioni occupate dalle truppe francesi. Garibaldi e Bixio (anch’egli ferito) assistettero alle sue ultime ore, mentre Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi, Carlo Armellini, Giuseppe Montanelli gli fecero visita più d’una volta all’ospedale Trinità dei Pellegrini ove gli era stata amputata una gamba. Per la sua eroica condotta nel fatto d’arme, il generale Giuseppe Avezzana gli conferì la promozione a capitano. Nei suoi scritti Mameli denota lucidità cospirativa e determinazione unitaria, confermando la fondatezza della descrizione che ne rese Giuseppe Mazzini dopo la morte, quando annotò che era un giovane dotato di «dolcezza quasi fanciullesca e di un’energia di leone da rivelarsi in circostanze supreme». L’opera di Bidussa riprende e completa la ricostruzione biografica che Antonino Mameli ha steso nel 2002 (Un gigante del Risorgimento, con prefazione di Sandro Pertini) e che resta finora l’opera più completa sul patriota piemontese, in nome del quale si è costituita anche un’associazione culturale che si prefigge di valorizzarne la memoria. 197 Gli scritti di Goffredo Mameli sollecitano, però, un altro problema che resta tuttora irrisolto, cioè il riconoscimento ufficiale di «Fratelli d’Italia», con le parole di Mameli e la musica di Michele Novaro, quale inno nazionale quale di fatto è dal periodo risorgimentale. È noto, infatti, che il 12 ottobre 1946 si adottò tale inno provvisoriamente ed esclusivamente per le cerimonie militari, essendo manifestata la volontà di provvedere in tempi successivi alla sua adozione quale inno dello Stato italiano. Tale decreto non è mai stato emanato, ma le parole di Mameli e le musiche di Novaro continuano a rappresentare l’Italia in tutte le manifestazioni ufficiali, essendosi meritati importanti apprezzamenti nel corso degli anni. Essi rappresentano un valore simbolico che si accompagna indissolubilmente alla nostra bandiera. È del 2002, per iniziativa dello stesso Antonino Mameli e presentata in aula dall’onorevole Agostino Ghiglia, una prima petizione parlamentare per il riconoscimento ufficiale dell’inno. Non avendo completato l’iter previsto, nel 2006 fu presentata (questa volta per iniziativa di chi scrive e di Antonino Mameli) una seconda petizione, ripetuta nell’agosto 2008 per sopravvenuta conclusione della legislatura. Anche questa è iscritta nell’agenda della Commissione affari costituzionali del Senato, ma non se ne ravvisa alcun interesse all’esame definitivo. La pubblicazione degli scritti di Goffredo Mameli e il suo sacrificio per la causa dell’unità nazionale probabilmente possono sollecitare maggiori attenzioni a sanare un vulnus legislativo ed a fornire il dovuto riconoscimento ad una parte così rappresentativa della nostra storia. Il volume di Bidussa costituisce pertanto una buona occasione per far conoscere nella sua reale dimensione una delle testimonianze più vive della nostra storia risorgimentale e per promuovere il consolidarsi dell’orgoglio di appartenenza di vecchi e nuovi cittadini. Carlo Pellacani P. RICOEUR, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 152, 11.50 euro Il filosofo Paul Ricoeur, notoriamente uno degli interpreti più acuti del pensiero freudiano, affronta l’uso equilibrato dell’analisi storica, rifuggendo dalla malattia storica causata da un sapere puramente retrospettivo e provocando una catarsi, attraverso il perdono, che consenta «un nuovo inizio» in grado di alleviare e rischiarare le mete del futuro. Come sintetizza Remo Bodei nella prefazione, Ricoeur propone di «prendere serenamente congedo dal passato» e di non macerarsi per sempre nel melanconico sentimento della perdita, nella paura che tutto sfugga e precipiti nel nulla. Per giungere a queste conclusioni, il filosofo francese parte dalla considerazione che il passato, in quanto non è più, indica che qualcosa va sempre irrimediabilmente perduto a causa della potenza corruttrice e distruttiva del tempo. A questo aspetto negativo il tempo accomuna il lato positivo dell’anteriorità dell’essere, identificato nella «cosa assente, nella sua permanenza umbratile, non garantita dalla memoria, ma suscettibile di essere evocata attraverso un ricordo che torna». 198 Il ricordo, oltretutto, non resta immutato nel tempo. Come evitare di immobilizzarlo e di falsificarlo?, si chiede Ricoeur. Accettato come verosimile che la storia e la memoria siano condannate a «oscillare fra fiducia e sospetto» l’unico rimedio consiste nel rivendicarne una dimensione etica, realizzando un nuovo rapporto tra passato, presente e futuro in cui trovi posto anche il gesto del perdono. Ricoeur ritiene il perdono contrario all’oblio passivo e richiede un «sovrappiù di lavoro della memoria» in quanto non verte sugli avvenimenti in se stessi, la cui traccia deve al contrario essere accuratamente protetta, ma sulla colpa. «L’oggetto dell’oblio – dice Ricoeur – non è l’avvenimento passato, l’atto criminale, ma il suo senso e il suo posto nell’intera dialettica della coscienza storica». E precisa: «C’è bisogno di un nuovo rapporto con la colpa e con la perdita», introducendo «il lavoro del lutto accanto al lavoro della memoria» e fornendo una dimensione al «perdono difficile, che prende sul serio il tragico dell’azione» e «punta alla radice degli atti, alla fonte dei conflitti e dei torti». In questo modo si sciolgono i nodi delle controversie insuperabili, dei danni e dei torti irreparabili. E si frantuma «la logica infernale della vendetta perpetuata di generazione in generazione», tracciando una linea sottile tra l’amnesia e il debito infinito, che porta a prendere congedo dal passato ed aprire una pagina nuova nella propria vita e nel proprio tempo. Il lavoro di Paul Ricoeur, docente alle Università di Nanterre e di Chicago, si aggiunge ai sei precedenti già pubblicati dal 1965 al 1970 e delinea un percorso coerente di rottura con il determinismo storico. Esso offre spazi alla rimeditazione delle aperture, delle possibilità, delle intenzioni degli uomini del passato mentre vivevano e decidevano, e reintroduce nel corso della storia una componente di contingenza. In tal modo il tempo che separa lo storico dal passato e dai morti di tutte le generazioni precedenti diventa il «cimitero delle promesse non mantenute», da risvegliare e da realizzare da quanti hanno la responsabilità della cosa pubblica. Questa è per Ricoeur la «politica della giusta memoria». Carlo Pellacani L. CANFORA, La storia falsa, Rizzoli, Milano 2008, pp. 322, 17 euro È intrigante il saggio di Luciano Canfora, perché svela passaggi sconosciuti della nostra storia passata e recente, ma soprattutto perché affronta con determinazione gli effetti di interpretazioni false di eventi che hanno influito in modo decisivo sull’evolversi delle situazioni e sulle conoscenze di intere generazioni. Ed è ancor più coinvolgente in quanto, inducendo ad effettuare agganci con recenti polemiche relative a protagonisti e fatti della politica italiana del secondo Novecento, fa meditare sulle controverse versioni di cui si avvalgono gli storici e i testimoni dei periodi considerati. Come afferma Canfora riferendosi a Spriano e al suo Gramsci in carcere e il partito del 1988, «lo sforzo di salvare il salvabile della storia sacra» può avere il respiro corto e può indurre addirittura l’effetto contrario, rendendo «inefficace, specie presso interlocutori ostili, anche il meglio della fatica» dello storico. In quel caso l’ancoraggio alla «storiografia di partito» ha leso la credibilità del comportamento risoluto e coraggioso di Togliatti nel 1938, quando si oppose al fanatismo cominternista 199 di Berti, solidale con la critica di Manuil’skij a Gramsci. Quello di Spriano è soltanto un episodio di utilizzo della storiografia a fini particolari. La casistica è ben più vasta, trovando esempi significativi anche nella trattazione della storia giacobina della Francia rivoluzionaria e nella storia «sabauda» del Risorgimento italiano. Canfora dedica il suo saggio (ultimo di una serie che comprende Il mistero di Tucidide ma anche Il papiro di Dongo, Esportare la libertà, Un mito fallito e Il papiro di Artemidoro) a tre esempi di falsificazioni che hanno influito sul corso della storia, confermando l’attendibilità del timore che i criteri di identificazione di un falso possano costituire un campo minato. A scapito della verità storica, ovviamente. Il primo «caso» cui Canfora dedica le sue attenzioni nasce dalle specifiche competenze dell’autore, docente di filologia classica all’Università di Bari. È la vicenda di Pausania, il potente re di Sparta, vincitore nella battaglia di Platea contro i persiani nel 479 AC e successivamente accusato di avere avuto contatti con il nemico sulla base di una lettera al re di Persia e alla risposta di quest’ultimo. Entrambe le lettere sono riportate da Tucidide, anche se la lettera di Pausania, che per quel documento compromettente fu murato vivo nel tempio nel quale si era rifugiato in nome del diritto di asilo, risultò poi essere un falso. Pausania ha pagato per una colpa che non ha commesso e si è dovuta attendere l’investigazione di attenti studiosi di duemila anni dopo per accertarne l’innocenza. Ma soprattutto il decorso degli eventi è stato falsato da una denuncia falsa. L’altro passaggio documentato da Canfora riguarda la storia più recente, collocandosi nel periodo 1923-24, gli anni della malattia di Lenin e delle sue proposte al XII congresso del partito comunista sovietico per una sostituzione di Stalin alla segreteria in ragione della ruvidezza e slealtà dei suoi comportamenti. Il promemoria di Lenin non giunse mai all’esame dei congressisti. O meglio, vi giunse ma mutilato della parte relativa alle critiche a Stalin, come ha potuto stabilire lo storico Buranov nel 1994. Anche in quel caso il corso della storia fu falsato e la ricostruzione degli eventi nella loro realtà ha faticato a trovare adeguata evidenza nonostante sull’argomento si siano confrontati eminenti studiosi. Più «attuale» e controverso il terzo caso di forzatura del corso della storia: si riferisce alla detenzione dei dirigenti comunisti Scoccimarro, Terracini e Gramsci presso il carcere di San Vittore a Milano. I fatti si svolgono nel 1928 e sono originati da una lettera a firma «Ruggiero» che viene spedita ai tre soggetti. È una lettera dal contenuto tanto compromettente da far esclamare al giudice: «Onorevole Gramsci, lei ha degli amici che certamente desiderano che lei rimanga un pezzo in galera». Chi scrisse quella lettera e quale iter seguì il documento? Avvalorava esso la convinzione dello stesso Gramsci che i suoi compagni non avevano fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità per salvarlo dal carcere? Su questi interrogativi si è sviluppata un’attenta ricerca archivistica, che ha preso avvio da una segnalazione dello stesso Canfora del 1968 ed è poi stata ripresa da Spriano e da altri studiosi della storia del partito comunista che tentarono una difesa d’ufficio di Grieco, in quegli anni esponente di punta del partito. Dalla comparazione dei testi di diversi anni dopo (anni Ottanta) è emerso che le lettere furono oggetto di manipolazione (se non di rifacitura totale), ma soprattutto che l’iniziativa di inviare una lettera da parte di un contumace a tre 200 imputati in carcere non fu condivisa da Togliatti. Ne derivava pertanto uno scenario del tutto nuovo relativamente alla stesura della storia dell’incarcerazione e della morte di Gramsci. Ma si era già negli anni Novanta, quasi sessant’anni dopo lo svolgersi degli eventi e nonostante si fossero spesi fiumi d’inchiostro per una difesa disperata. Frutto d’una storia falsa, appunto. Carlo Pellacani A. GIANNULI, L’abuso pubblico della storia. Come e perché il potere politico falsifica il passato, Guanda, Parma 2009, pp. 368, 18,50 euro «La storia è il suo uso pubblico, coincide perfettamente con esso», dichiara senza tentennamenti Aldo Giannuli. E rincara l’affermazione chiedendosi: «Ma la storia, al di fuori della comunicazione delle sue acquisizioni, a cosa serve?». Da queste premesse è facile intuire il taglio problematico che Giannuli riserva al suo lavoro. Egli è convinto che fra la storia e la politica esista un’attrazione reciproca e inevitabile, in grado di tradursi in un rapporto elettivo fra lo storico e il potere. E non ravvisa motivi di perplessità nel fatto che il potere politico cerchi di usare la storia ai propri fini, definendo «moneta corrente di ogni epoca e paese» strumenti come le cerimonie pubbliche, la monumentalistica, la toponomastica, gli indirizzi nell’insegnamento della storia, la definizione delle materie storiche specialistiche a livello universitario, le scelte di finanziamento di una ricerca piuttosto che un’altra. Si tratta di un condizionamento che si è espresso in gradi diversi a seconda del tipo di forma statuale da cui proveniva. E tale condizionamento assume livelli diversi, dal negazionismo fino al revisionismo, intersecandosi con certezze storiche e regimi che parevano dover durare per sempre sono andati in briciole, e nel contempo i valori che li avevano sorretti sono messi in discussione, tallonati da altri che cercano di rimpiazzarli. Se può essere condivisa la convinzione che i resoconti storici non sono mai neutrali perché ogni analisi storica implica decisioni e scelte, è altrettanto vero che «lo storico ha il diritto di porre al passato le domande che ritiene, ma non di dettare al passato la risposta che vorrebbe sentire» come sta evidenziando in modo ripetuto buona parte della storiografia italiana della seconda metà del Novecento. Così come appare sconcertante la presunzione di non rispettare le premesse scientifiche della disciplina, ma di intervenire su fatti e comportamenti con una logica cronachistica o peggio ancora da romanzo d’appendice. Più di ogni tentativo revisionista, questo è il più grave abuso che si sta facendo della storia, cui compete di ridefinire identità, giustificare interessi e legittimare aspettative che siano fondamento per il senso comune e motivino strategie. Il potere politico avverte l’esigenza di controllare la produzione storica e la partecipazione alla vita civica e politica che da essa deriva. Già cinquecento anni or sono Machiavelli forniva al Principe un’adeguata legittimazione e gli strumenti concettuali per un progetto di espansione o conservazione del suo potere. Tale correlazione era motivata allora come oggi dalla consapevolezza che nessuna strategia politica è pensabile senza una base storica. E che lo sviluppo di una collettività non 201 può prescindere da un rigoroso senso della memoria. Ciò che invece non trova alcuna giustificazione è che «si approvino leggi che stabiliscano cosa si possa o non si possa scrivere in materia storica e una parte del dibattito finisca nelle aule dei tribunali» oppure si creino commissioni parlamentari che si arroghino il diritto di stabilire una verità storica, delegando ai servizi segreti la definizione di vere e proprie operazioni storiografiche. Questi comportamenti, eccedenti le regole della convivenza democratica, mettono a repentaglio le basi dello Stato repubblicano. E costituiscono un vero e preoccupante abuso della storia. Carlo Pellacani L. GUERZONI (a cura di), Quando i cattolici non erano moderati. Figure e percorsi del cattolicesimo democratico in Italia, Il Mulino, 2009, pp. 292, 20 euro D. MENGOZZI (a cura di), La «sinistra (cattolica) modenese». Cronache di una singolare esperienza politica di base, Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, Modena 2009, pp. 304, s.i.p. I due volumi meritano una recensione congiunta per più motivi: intanto perché indagano su un periodo di particolare effervescenza dei cattolici emiliani e modenesi impegnati in politica, poi perché derivano ambedue dalle esperienze dirette di protagonisti che hanno segnato in modo indelebile la storia dei partiti in Italia. Il volume curato da Guerzoni riporta gli atti di un convegno di studi che ha potuto contare su contributi di autorevoli studiosi e di esponenti dei movimenti cattolici del dopoguerra: Guido Formigoni, Paolo Pombeni, Alberto Melloni, Giuseppe Tognon, Fulvio De Giorgi, Valerio Onida, Giuseppe Ruggieri, Paola Gaiotti de Biase, David Sassòli e Paolo Prodi. Il volume curato da Mengozzi appartiene, invece, al genere cronachistico, riportando fatti e avvenimenti che l’autore espone sulla base del ricordo personale e sulla scorta di un coinvolgimento diretto. Ambedue riguardano l’attività della sinistra cattolica, e più specificatamente della sinistra cattolica modenese che si è caratterizzata per essere un gruppo a forte valenza comunitaria e per aver influito in modo significativo sull’evoluzione sociale e culturale locale. Tra la ricostruzione degli avvenimenti effettuata dagli storici e l’esperienza diretta dei protagonisti sussiste, talvolta, qualche sfasatura, sia per la difficoltà di censire il succedersi di iniziative che si è sviluppato nel periodo indicato, sia per una comprensibile difficoltà di memorizzazione dei diversi aspetti di una diaspora che – soprattutto a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso – ha interessato il mondo cattolico emiliano e in particolare la sua componente più riformista. Una modificazione di assetti e di prospettive che si realizza con molto anticipo rispetto allo sfaldamento della sinistra laica derivante dalla caduta del muro di Berlino. I due volumi, documentando lo svolgersi di un unico processo di cambiamento e risarcendo un’inquietudine diffusa e motivata delle coscienze, rappresentano comunque un’occasione importante per accostarsi senza infingimenti e per attribuire la giusta portata alla ricerca di una presenza politica locale e nazionale che fosse coerente con i principi di riferimento e con la storia della Democrazia cristiana e del magistero ecclesiale. 202 Essi, tra l’altro, attestano che i protagonisti modenesi e reggiani di quella fase storica hanno assunto un ruolo determinante nel multiforme procedere dei «gruppi spontanei» e nelle scelte della dirigenza della Democrazia cristiana a livello nazionale. A Modena e Reggio sono maturate e sono state elaborate molte indicazioni circa le iniziative da adottare, come dimostra la ricostruzione del succedersi degli eventi e della partecipazione di persone. Anche quando la consistenza della narrazione, in quanto basata su fonti esterne o su memoriali, sembra sconfinare nell’agiografia, il periodo che va dal 1968 al 1972 racchiude scelte e fatti che hanno determinato le opzioni di quell’area d’impegno politico nei mesi successivi. E non soltanto dei cattolici. Basti pensare ai prodromi del movimento studentesco che si erano sperimentati a Reggio; agli incontri con i fratelli Dossetti; all’uscita di Corrado Corghi dalla Democrazia cristiana; alla pletora di contatti e di prese di posizione che animano i gruppi del dissenso, fino alle assemblee di Modena e di Reggio che ne sancirono il repentino silenzio. Da queste premesse derivò il proliferare di incontri e di proposte che, senza tenere conto di alcuna logica di schieramento, tentarono di dar vita ad una «nuova sinistra» nella quale avessero voce paritetica le forze laiche e cattoliche. Senza esito, come attesta l’analisi postuma degli eventi. Mentre il volume di Guerzoni si dedica ad un’indagine sulla vitalità del cattolicesimo democratico (rendendo omaggio all’autorevole e influente apporto di Pietro Scoppola), il «diario» di Mengozzi rende conto dell’esperienza politica del movimento cattolico modenese, guidato da Ermanno Gorrieri dagli anni del dopoguerra fino alla fine degli anni Settanta, ed è dedicato alla memoria di Francesco Luigi Ferrari, a settantacinque anni dalla sua morte a Parigi. Per chi, come chi scrive, ha partecipato allo svolgersi dei fatti di cui si occupano le due opere e ne ha già tentato una ricostruzione storica (Il sogno dell’alternativa, 2002), i lavori di Mengozzi e Guerzoni, pur con una differente ottica d’indagine, costituiscono una valida occasione di ripensamento e di stimolo per un approfondimento sistematico di un periodo che è ancora poco conosciuto. Tra gli altri aspetti da considerare, emerge l’esigenza di una miglior conoscenza del rapporto del cattolicesimo emiliano con i mezzi di comunicazione, cui giustapporre l’analisi delle vicende di periodici minori come «Ricerca politico-culturale», «Sinistra modenese», «Esperienze dell’EmiliaRomagna», «Sinistra DC di Reggio Emilia» e le ragioni del fallimento di un’impresa editorialmente suggestiva quale quella del «Foglio» o i condizionamenti che derivavano dalla disponibilità di risorse finanziarie. Da questi due volumi si può partire per trovare spunti di riflessione per l’agire dell’oggi e per effettuare il dovuto risarcimento a persone che hanno dedicato le loro migliori energie ad un progetto politico. La disponibilità di testimonianze e documentazioni attendibili su questo periodo, ancorché piuttosto recenti, può offrire la dimensione del clima di collaborazione e di coesione che accomunava forze appartenenti a province contigue nel perseguire un sogno di partecipazione democratica e un’effettiva uguaglianza sociale nei rapporti di lavoro e nelle relazioni con lo Stato. Carlo Pellacani 203 E. HILLESUM, Diario. 1941-1943, con una prefazione di J.C. Gaarlandt, Adelphi, Milano 2008, pp. 270, 11,50 euro Quando ricerchiamo fonti di protagonisti della deportazione e della morte nei campi di sterminio, siamo ormai abituati a riferirci al Diario di Anna Frank, pubblicato e tradotto in molte lingue e trasposto in testi teatrali, film e fiction di successo, ed in misura minore a Dal liceo ad Auschwitz di Louise Jacobson (L’Unità, 1996) o alle Lettere da Auschwitz di James Pogonowski (Frap Books, 2004). Ancora poco noto è il diario di Etty Hillesum che è stato pubblicato in Olanda e in Inghilterra all’inizio degli anni Ottanta e che viene ora proposto dalle Edizioni Adelphi con una prefazione di Gaarlandt. Si tratta di un documento di rara efficacia, che consente di rivivere le emozioni e le speranze di una donna di Amsterdam di ventisette anni nel periodo più cruento della guerra e dell’oppressione da parte dell’invasore tedesco. Il diario raccoglie le sue impressioni più intime ed è compreso tra il 10 novembre 1941 e il 13 ottobre 1942. In calce al diario sono pubblicate alcune lettere che la giovane scrive ad amici e parenti dal campo di smistamento nel 1943. Dopo la resa dell’Olanda, nel maggio 1940, i tedeschi avevano iniziato ad isolare gli ebrei e dopo il febbraio 1941 (quando Amsterdam fu teatro del primo sciopero anti-pogrom della storia europea) la repressione contro gli ebrei fu inasprita: furono cacciati dal lavoro, fu loro vietato di fare acquisti nei negozi normali e furono raccolti in ghetti e in campi di lavoro. Dal 29 aprile 1942 furono costretti a portare la stella di David, iniziando di lì a poco le deportazioni di massa, che avevano come prima tappa il concentramento a Westerbork, un centro di smistamento posto nella zona orientale dei Paesi Bassi che era l’anticamera di Auschwitz. Etty Hillesum era ebrea e volle condividere ogni momento della sofferenza della sua gente. Dall’inizio di agosto del 1942 (dopo aver trascorso quindici giorni come dattilografa al Consiglio ebraico di Amsterdam) è a Westerbork, ove lavora all’ospedale locale e ove dispone di una certa libertà, potendo tornare ad Amsterdam una dozzina di volte e rendendosi utile nel trasferire informazioni ai gruppi resistenziali da parte di prigionieri e raccogliendo medicinali per gli internati. Il 7 settembre 1943 viene caricata, assieme ai suoi genitori, sul treno per Auschwitz. Dal finestrino di quel treno getta una cartolina, raccolta e spedita da alcuni contadini, in cui scrive «Siamo partiti dal campo cantando». Morirà ad Auschwitz il 30 novembre 1943. I suoi diari, raccolti in otto quaderni fittamente ricoperti da una scrittura minuta e quasi indecifrabile, sono stati conservati dalla sua amica Maria Tuinzing, alla quale erano stati consegnati dalla stessa Etty con la convinzione di non avere scampo dalla persecuzione nazista e per l’ambizione di lasciare una traccia di sé ai posteri. Si dovrà attendere fino al 1980 per un’ipotesi di stampa, e grazie a Gaarlandt l’iniziativa si realizza. Il successo è immediato, in Olanda e in diverse parti del mondo. Il diario di Etty, d’altronde, si caratterizza per la sua grande trasparenza, franchezza e intensità. Esso accoglie le «confessioni» di una ragazza che descrive i suoi rapporti d’amicizia e d’amore, le vicende familiari, gli stati d’animo e le sensazioni, le sue riflessioni sull’ebraismo, sulle donne, sulle passioni umane, e dedica spazi sempre più rilevanti alla constatazione dello sfacelo del mondo che la circonda. La guerra e la repressione razziale è costantemente presente, rappresentando un impedimento costante alla normale esistenza. Il diario accoglie le ansie d’amore e il rapporto 204 particolare che Etty instaura con Julius Spier, un ebreo di 55 anni di età, esperto cultore dell’arte della lettura della mano dopo aver svolto per anni l’attività di bancario. Oltre allo sbocciare di una relazione passionale, Etty descrive nel suo diario la scoperta di una religiosità nient’affatto convenzionale dalla quale trarrà lenimento e forza nel suo difficile cammino. Il diario si conclude il 13 ottobre 1942. Le ultime parole sono: «Si vorrebbe sempre essere un balsamo per molte ferite». Carlo Pellacani G. D’ELIA, Riscritti corsari. Scritti per «L’Unità» 2001-2006. Epigrammi 2007-2009, Effigie, Milano 2009, pp. 172, 15 euro Che fare? Come opporsi? Negli anni Zero dell’Italia, che strada prendere per conservare la possibilità di un antagonismo non complice rispetto al nuovo fascismo che ci governa? Dove trovare un fondamento di fronte alla tracotanza dell’arbitrio e dell’ambiguità con cui siamo «felicemente» governati? Gianni D’Elia, da poeta, ha scritto per molti anni per «L’Unità» di Furio Colombo. Questo volume raccoglie gli interventi pubblicati su quel quotidiano e dedicati con ostinazione a un esercizio di «antropologia culturale sugli usi e i costumi» dell’Italia berlusconiana (al di là della grigia parentesi del centrosinistra chiamato «Unione»). D’Elia ha messo in pratica, da erede autentico di Pasolini (poeta, corsaro), una ricerca appunto pasoliniana sulla storia italiana più recente. Marxismo eretico e nuovo umanesimo sono richiamati per ricordare che una resistenza, tutta poetica e culturale, è pur sempre possibile («mettiamo i versi sugli striscioni»); in questo senso, D’Elia svolge una profonda riflessione critica rispetto alla «piega» che la contestazione ha preso alla fine degli anni Settanta, specie a Bologna. Quale è il male italiano più profondo? La continuità del silenzio del potere, l’uso sistematico del «segreto politico». Proprio con l’ultimo Pasolini: «Forse Pasolini ci direbbe che non basta la riforma dei servizi segreti di oggi, ma che occorre abolire il Segreto di Stato di ieri, perché finalmente gli italiani sappiano la verità, o semplicemente perché la dicano finalmente delle parole ufficiali: gli italiani non sanno ancora niente, né del delitto Mattei, né del delitto De Mauro, né del delitto Pasolini, né delle stragi da piazza Fontana a Bologna» (p. 148, corsivo nel testo). La storia politica italiana è ancora e nella sostanza una storia criminale. Andando avanti: quale può essere l’attualità di Pasolini? Il poeta di Casarsa è ad esempio nella lotta del movimentono «no TAV»: contro lo sviluppo, per il progresso democratico. Pasolini è stato un poeta civile (perduto però fuori della città), che ha proseguito l’«avanguardia della tradizione», lungo una linea che va da Dante a Leopardi. A che cosa servono, perfino oggi, i poeti? Servono a mantenere viva e concreta la memoria, contro l’omologazione del nuovo fascismo (ossia: consumismo e «governo dello spettacolo», oltre che violenza): «Con Pasolini, si riafferma quella avanguardia della tradizione, che è il portato più vivo della nostra cultura umanistica. Una resistenza della ragione contro l’“imperio dell’autorità”. La stessa, che mosse i partigiani contro i nazisti e i fascisti. Di questa resistenza, la poesia è il cuore. E sono 205 proprio le antropologie poetiche di Leopardi e Pasolini, dal negativo della diversità, a rispondersi, tra speranza ermeneutica e disperazione storica e cosmica. La materia e la storia entrano definitivamente nel canto della poesia nuova» (p. 74). E invece le accademie oggi producono (ad litteram) tanti idioti specializzati, per parafrasare Flaiano. C’è un tema che sostiene il volume: che legame c’è, che continuità è legittimo porre, fra Mussolini e Berlusconi? È la continuità che va dal Duce al duce delle televendite: «Anche oggi, la nuova ideologia italiana non può fare a meno del culto di un capo. “Ecco Mussolini”. C’era Berlusconi in televisione in doppiopetto, che arringava gli industriali. “Non vedi come si muove? Sembra proprio un Mussolini!”. Abbiamo tolto l’audio, e il rosato di quella faccia catodica, confrontato col mascellone del Duce, mi indicava l’evoluzione della razza, da contadino a piccolo borghese. È un fascismo delle merci, con la calza dell’obiettivo. E tornano buone tutte le analisi di Adorno, perché tra l’Italia di oggi e l’America degli anni 40 c’è un legame, ed è l’omologazione consumistica» (p. 21, corsivo nel testo). L’evoluzione del grottesco, oggi sul trono di un impero irresistibile. Il nostro disastro generale, causato da un nuovo fascismo che è omologazione eversiva, (profetizzato ancora come «senza volto» da Pasolini), ha bisogno del linguaggio degli scrittori, di proseguire con Pasolini e Sciascia; oggi, nell’Italia ancora fascista, non bisogna dimenticarsi di difendere autori come Antonio Tabucchi. Francesco Paolella AA. VV., Dall’Impero austro-ungarico alle foibe. Conflitti nell’area alto-adriatica, Bollati Boringhieri, Torino 2009, pp. 298, 24 euro Lo scorso anno, in concomitanza con la ricorrenza del Giorno del Ricordo, nel centro di Modena è apparsa una scritta: «Com’è bello far le Foibe da Trieste in giù». Più che una qualche forma di protesta politica il graffito mi pare simboleggi il trionfo della cultura pop sulla storia. Ma come ci si è arrivati? Come è stato possibile che in pochi anni un tema – quello delle Foibe - del tutto escluso dalla memoria pubblica italiana sia diventato tanto popolare da accostarsi alla fama imperitura di Raffaella Carrà? Smaltita anche quest’anno la sbornia delle rimembranze, è tempo di tirare le somme. Enzo Collotti – con lui altri studiosi di fama – ha più volte sottolineato il rischio dell’appiattimento delle due giornate commemorative (Memoria e Ricordo) istituite dallo stato italiano nei primi anni del Duemila. La vicinanza delle date facilita la confusione nell’opinione pubblica meno avvertita e gli stessi amministratori «costretti» a celebrare tali ricorrenze sembrano considerarle alle stessa stregua. Oramai la gita scolastica a Trieste sembra stai diventando un obbligo curriculare e include la visita alla foiba di Basovizza accostata a quella della risiera di San Sabba. La logica della par condicio ha sostituito quella della verità storica: Stalin deve godere dello stesso numero di passaggi televisivi di Hitler; i libri di testo devono contenere in egual misura riferimenti ai crimini fascisti e a quelli comunisti. Val la pena di notare che si tratta ancora una volta di un meccanismo autoassolutorio, perché noi italiani, barbaramente trucidati nelle foibe, siamo anche sempre pronti ad addossare interamente ai tedeschi le responsabilità della deportazione 206 ebraica. Memoria o Ricordo, si tratta sempre di una ricostruzione parziale, che non va ad intaccare lo stereotipo nazionalpopolare per eccellenza, quello degli «italiani brava gente». Mi è stato chiesto quest’anno se auspicassi l’eventuale istituzione di una giornata della memoria dei crimini fascisti. Ho risposto che la memoria di un popolo non si costruisce a colpi di commemorazioni completamente avulse dalla conoscenza della realtà storica. Mi sono domandato, con alcuni colleghi, quale può essere il ruolo dello storico di fronte al maggior peso, anche emotivo, che hanno le testimonianze dirette rispetto alla fredda ricostruzione storica. Mi pare necessario, da parte nostra, uno sforzo per far sì che la ricerca storica incontri le esigenze delle amministrazioni e dell’opinione pubblica, che fornisca loro gli strumenti, non per smentire la verità soggettiva dei testimoni, ma per dargli forza attraverso l’evidenza fattuale, per offrire una cornice scientifica che consenta di superare le reciproche diffidenze, le rispettive contrapposizioni e costruire una memoria davvero condivisa. Numerosi autori hanno negli ultimi anni pubblicato studi sulle responsabilità criminali dei sistemi di occupazione fascisti in Europa e Africa, e lo stesso può dirsi sulle sofferenze subite dagli italiani del confine orientale alla fine della seconda guerra mondiale. Ma che ricaduta hanno queste nuove prospettive sull’opinione pubblica? I crimini fascisti rimangono fuori dalla prima serata televisiva; il discorso politico, l’immaginario collettivo rimangono ancorati a vecchi stereotipi, a slogan privi di legami con la verità storica. Se lo sforzo degli storici è notevole, è difficile comprendere, fra le numerose pubblicazioni sul tema, quali possano avere un utilizzo anche didattico. Esistono alcuni prodotti multimediali, come ad esempio Una sottile linea bianca prodotto dall’Istoreto di Torino o AestOvest dell’Osservatorio Balcani, ma la ricerca storica su questi temi è ancora purtroppo confinata a un ambito specialistico. L’opera collettanea che ha visto la luce lo scorso anno (Dall’Impero austro-ungarico alle foibe) è forse una delle migliori e più pacate sintesi degli studi esistenti sul tema dell’esodo istriano e delle foibe. Non tutti gli storici che si occupano di questi argomenti vi sono rappresentati, ma la selezione è fra le migliori possibili. Spicca la presenza fra di essi di due autrici slovene, che contribuiscono, almeno in parte, a offrire al lettore anche il punto di vista sloveno e jugoslavo della vicenda. Il volume ha un pregio evidente fin dall’indice: la scelta di contestualizzare gli eventi allargando lo sguardo sia nello spazio che nel tempo. Innanzitutto le violenze commesse nell’area giulio-istriana nel periodo 1941-1945 rappresentano l’apice di un conflitto di lungo periodo fra nazionalismo italiano e slavo (sloveno, croato, jugoslavo). A questo lungo scontro sono dedicati i saggi di Vanni d’Alessio, Fabio Todero e Anna Maria Vinci. In secondo luogo tali drammatiche vicende vengono giustamente inserite, grazie ai tre saggi di Enzo Collotti, in un contesto internazionale segnato da guerre e spostamenti forzati di popolazione. In particolare l’area centro-orientale d’Europa (cui appartengono geograficamente Trieste e l’Istria) subisce devastazioni, stragi e mutamenti socioeconomici epocali, tanto da riemergere dal quindicennio 1941-56 del tutto trasformata da un punto di vista politico, sociale e nazionale. Alla specifica questione delle guerra, delle foibe e dell’esodo sono dedicati due saggi che offrono punti di vista antitetici sulla resistenza nella Venezia Giulia (Gian Carlo Bertuzzi e Nevenka Troha), quello di Franco Cecotti e soprattutto i tre interventi di Raoul Pupo, che sintetizzano in maniera chiara e analitica temi tanto dibattuti e politicamente manipolati. 207 Un accenno al destino dei profughi istriani in Italia nel secondo dopoguerra viene infine fornito da Enrico Miletto (con una prospettiva di storia socioculturale attraverso l’utilizzo dell’intervista come fonte privilegiata) e Alessandra Algostino (da un punto di vista prettamente giuridico). Il grande valore di questo volume è quello di fornire un quadro, seppur parziale, di un tema tanto malamente conosciuto, sgombrando il campo da una serie di assunti errati. Innanzitutto viene proposto un calcolo, certo non definitivo ma perlomeno verosimile, delle cifre delle vittime dell’esodo: tra i 200 e i 250.000 «italiani», contro i 350.000 che vengono normalmente citati in tutti i contesti pubblici. In secondo luogo, e questo è forse l’aspetto più importante, viene del tutto rifiutata l’idea di un tentativo di genocidio contro le popolazioni italiane e di una volontà di espulsione di massa da parte del governo jugoslavo. Gli arresti e le uccisioni che vengono solitamente definite col termine di «foibe» furono essenzialmente una forma di epurazione, in taluni casi «preventiva» (cioè contro individui ritenuti pericolosi per l’instaurazione di un regime socialista jugoslavo), che si pone, in termini numerici, a metà strada fra le violenze commesse da alcuni singoli partigiani italiani nei giorni successivi al 25 aprile e le decine di migliaia di vittime delle purghe repressive jugoslave nelle altre regioni occupate dall’esercito di Tito alla fine del conflitto. Infine l’esodo dall’Istria non fu il risultato della precisa volontà politica jugoslava di allontanare la popolazione italiana, ma la somma di una serie di fattori, interni e internazionali, che comportarono di fatto la scomparsa della minoranza italiana come entità culturale, e quindi un impoverimento del tessuto sociale istriano. Parzialmente in controtendenza col resto del volume, ma per questo particolarmente affascinante, è il saggio introduttivo di Marta Verginella, che mette in dubbio il senso dell’utilizzo del paradigma nazionale nell’area prettamente multietnica e multiculturale presa in esame. A suo modo di vedere è arbitrario tracciare un confine netto fra italiani e sloveni, fra «italianità» e «slovenità» in tale regione; si tratta di un’argomentazione che mette di fatto anche in discussione il valore dei calcoli statistici sulle vittime delle foibe e dell’esodo, basati sempre sull’appartenenza univoca ad una nazionalità specifica. Secondo il parere dell’autrice il testo redatto dalla Commissione storico-culturale italo-slovena – che ha condotto i suoi lavori dal 1993 al 2000 e il cui testo viene riprodotto a fine volume – non è altro che una giustapposizione di due separate memorie storiche nazionali. Si sarebbe dunque persa la grande occasione di andare oltre una visione nazionalista della storia di questa regione, inglobando e valorizzando le realtà sfumate, le identità fluide, le zone grigie. Se questa obiezione è del tutto condivisibile, sarebbe comunque un passo in avanti verso la comprensione reciproca se quel testo, con tutti i suoi limiti, venisse letto e diffuso, ad esempio in ambito scolastico, in occasione delle celebrazioni ufficiali. Contribuirebbe perlomeno a limitare l’immagine distorta che i media forniscono e a sgombrare il campo da alcuni cliché ormai assimilati dall’opinione pubblica, ma che niente hanno a che fare con la realtà storica. Bandire le parole «genocidio» e «pulizia etnica» dalle commemorazioni ufficiali, fare uno sforzo di comprensione di un punto di vista «altro», potrebbe rappresentare un primo passo nella prospettiva di una riconciliazione storica non solo fra noi italiani ma soprattutto fra noi e gli altri, fra noi e i nostri ex nemici. Eric Gobetti 208 L. VILLARI, Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento, Laterza, Bari 2009, pp. 360, 18 euro Ha tutte le carte in regola per fungere da introibo ideale ai 150 anni del Regno d’Italia. Sotto certo aspetti è una lettura «leggera»: il lettore non è oppresso da superflui indugi su questioni storiografiche per iniziati o su dettagli cari ai cultori, per usare il linguaggio di Nietzsche, della storia antiquaria. Gli è proposto invece il racconto appassionante di un’epoca di passioni – letterarie, morali, musicali oltre che politiche – vissute da personaggi in gran parte giovani. È allo stesso tempo una lettura «seria», perché non si risolve, giornalisticamente, in una serie di isolati medaglioni di quei protagonisti, ma li situa nel robusto quadro di un’epoca di grandi aspirazioni e di esiti repentini e sorprendenti (si pensi al fortunoso e travolgente biennio 1859-61). Quanti, ormai decenni or sono, hanno avuto la fortuna di incontrare queste vicende nei primi grandi manuali scolastici dell’Italia repubblicana (basti fare i nomi di Giorgio Spini e di Armando Saitta) saranno lieti di trovare ricordi, conferme, arricchimenti. Ma pure tutta la fascia più giovane dei cittadini di media cultura (accontentiamoci: chi legge più di un libro all’anno e più di un quotidiano alla settimana) sarebbe confortata nel ripercorrere la storia di uno dei rari momenti del nostro passato di cui essere fieri, a dispetto dei giudizi riduttivi e liquidatori che, temiamo, saranno sempre più merce corrente, in epoca di mode revisionistiche e di pulsioni politiche illiberali. Da par suo, Villari documenta infatti con grande efficacia il carattere di movimento nazionale del nostro Risorgimento, magari ricordando, semplicemente, la composizione sociale del popolo delle barricate e dei corpi volontari, o illustrando il convergere (anche in forma di concordia discors) di tante teste pensanti. A scanso di equivoci, va precisato che Bella e perduta non è un libro d’occasione e tanto meno è reticente sui limiti della «conquista regia» o sulla miope gestione dell’Italia unita da parte degli epigoni di Cavour (peraltro l’arco temporale considerato si conclude nel 1870). Al lettore è fatta grazia, con un taglio gordiano, della vecchia questione del terminus a quo: il disgusto per la Restaurazione nasce soprattutto dal constatarne la miseria dopo aver fatto le esperienze di rinnovamento dell’età «giacobina» e napoleonica. Anche qui parlano decisive citazioni dai testi: su questo almeno democratici e moderati (D’Azeglio in primis) non divergono. Sarà dunque un best seller quest’opera utile ed avvincente? Il dubbio è lecito. Il tramonto di un senso comune storicistico – pienamente giustificato su un astratto piano teorico – ha reso debole la ricerca dell’identità collettiva nei processi che l’hanno generata («il vero è risultato», diceva il vecchio Hegel). Oggi l’identità conviene inventarla, quando non se ne faccia addirittura un orrido feticcio, miscuglio di rozzi istinti di esclusione e di particolarismi dal fiato corto. E i libri che «tirano» sono quelli ispirati al punto di vista del maggiordomo, delle cose vista dal buco della serratura. Farà fortuna chi parlerà male di Garibaldi (avviene già, del resto). E le radici illuministiche, anche da alte cattedre, sono additate come fonte dei mali odierni. Aspettiamoci, per il 2011, un’onda di cinica ipocrisia nelle celebrazioni ufficiali e un fiorire (coazione a ripetere, dopo le prove fatte sulla Resistenza) di lacrimose storie dei «vinti». Ettore Borghi 209 M. FIORAVANZO, Mussolini e Hitler. La Repubblica sociale sotto il Terzo Reich, Donzelli, Roma 2009, pp. 216, 16 euro Per una scelta editoriale che ha precedenti anche illustri, il titolo è suggestivo, ma il proposito e l’ambito di questo lavoro è indicato dal sottotitolo, con quella sua formula inequivocabile, «sotto il Terzo Reich», che dichiara da subito la conclusione (il punto d’orientamento) della ricerca. Un libro a tesi, dunque? L’argomentazione serrata e puntigliosa, netta nel respingere le ben note teorie apologetiche della letteratura filofascista, così come nel denunciare alcune non trascurabili negligenze della storiografia «seria», potrebbe legittimare questa affrettata etichetta. Più correttamente, conviene parlare di un libro «a tema», solidamente basato sull’attento uso delle fonti (molto ampio e puntuale, ad esempio, il ricorso ai diari di Goebbels) oltre che, non occorre dirlo, sulla conoscenza dell’ormai ampia ed esaustiva bibliografia riguardante la RSI. Ma proprio l’aver tematizzato la questione se, ed eventualmente entro quali limiti, la RSI possa considerarsi uno stato sovrano, consente alla studiosa di fornire un libro nuovo, capace di gettare luce sull’intera vicenda saloina, e soprattutto sulla assolutamente singolare situazione giuridica e politica in cui, nei mesi che vanno dal settembre 1943 all’aprile 1945, viene a trovarsi la popolazione dell’Italia occupata. La decisione, da parte nazista, di costituire uno stato fascista vassallo segue di pochissimi giorni l’8 settembre, tanto che è fissata in termini ultimativi la data (23 settembre, ore 12) entro cui annunciarne la costituzione. La liberazione di Mussolini dal Gran Sasso e il suo ritorno alla leadership politica aggiunge senza dubbio elementi simbolici di continuità, da esibire agli occhi dell’alleato giapponese e di altri minori (Ungheria, Finlandia…), ma non cambia in alcun modo la preesistente volontà di salvaguardare un patrimonio di risorse (impianti, forza lavoro, comunicazioni) disponibili nell’Italia centro-settentrionale e «predabili» per il sostegno bellico. È pure evidente che la delega a personale italiano, in forma subordinata, di attività amministrative e di controllo del territorio, corrispondeva al disegno razionale di risparmiare il più possibile l’affidabile materiale umano tedesco, riservandolo ai compiti strettamente militari o di polizia politica. Pertanto il rischio di una «polonizzazione» dell’Italia come conseguenza del suo tradimento, col conseguente «sacrificio» del Duce per placare l’inferocito alleato, si rivela una malaccorta invenzione ex post, oltretutto in contrasto col carattere di Mussolini, la sua stessa documentatissima volontà di rivalsa e la sua convinzione, espressa sino all’ultimo, di un possibile rovesciamento delle sorti belliche grazie alle mitiche armi segrete (o, nel caso peggiore, di una lunga resistenza nei «ridotti» alpini). Per il suo stesso funzionamento, tuttavia, l’insieme delle attività delegate esigeva almeno la finzione della sovranità (ministeri, apparati periferici amministrativi e repressivi, comunicazioni, finanze pubbliche, esercito, annona). Si trattava, per usare la terminologia di Fioravanzo, di una «messa in scena», ma tuttavia essa si poteva reggere soltanto su un certo grado di agibilità effettiva e sulla capacità soggettiva di difenderla, fosse pure per banalmente comprensibili ragioni di prestigio o per l’indispensabile mantenimento di una residua credibilità agli occhi della popolazione. E uno degli aspetti più interessanti del volume è appunto la ricostruzione della lunga e sempre perdente «lotta per il riconoscimento» ingaggiata dal Duce e dai suoi maggiori collaboratori nella fitta corrispondenza col plenipotenziario Rahn o attraverso diretti 210 contatti diplomatici coi vertici di Berlino, meno disponibili delle stesso Rahn a tutelare «la parvenza dello stato sovrano» (atteggiamento per lo più condiviso dalle autorità militari occupanti). Lo scarso entusiasmo, da parte tedesca, per la effettiva costituzione dell’esercito di Salò, e l’orientamento a usare piuttosto gli italiani come forza lavoro in gradi diversi coatta, rappresenta certo la più cospicua frustrazione subita da Mussolini, solo che si tenga conto delle sue convinzioni circa il ruolo essenziale e altamente simbolico di una propria forza armata per l’identità dello Stato. Ancor meno però il Duce, che come si è visto continuò a coltivare sino a ora molto tarda la speranza della vittoria, poteva illudersi sulla conservazione – in questo improbabile caso – della sovranità territoriale sulle zone di operazione delle Prealpi e del Litorale adriatico. Nato anche sullo sfruttamento del combattentismo e sugli slanci dell’irredentismo, il fascismo al tramonto paradossalmente vedeva profilarsi all’orizzonte l’irrimediabile perdita delle terre «irredente», proprio come conseguenza dell’eventuale successo militare del regime con cui si batteva da «fedele» alleato. Ettore Borghi M. OMBRA, La bella politica. La Resistenza, «Noi donne», il femminismo, con la collaborazione di Ilaria Scalmani, prefazione di Anna Bravo, Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea «Giorgio Agosti», Editore SEB 27, Torino 2009, 12,50 euro Entrare nel racconto di Marisa Ombra è entrare nella storia di un’evoluzione: la sua vita è un concatenarsi di eventi che la porterà a essere un punto di riferimento per la politica «al femminile». Sin dall’inizio è evidente l’influenza della famiglia d’origine, che l’avvicina alla musica, ai libri, alla cultura in generale pur trattandosi di gente modesta; l’adesione all’antifascismo è un processo naturale, dettato più dal buon senso che da una reale preparazione politica. A Marisa viene trasmessa l’idea dell’ordine come perfezione di vita, necessario al raggiungimento delle proprie ambizioni per cui è necessario dare il massimo. L’ingresso nella Resistenza, insieme a tutta la famiglia, la scuote dalla crisi in cui è caduta dopo la morte dell’amata nonna, e determina il passaggio dall’infanzia all’età adulta, in cui la vita torna finalmente ad avere senso: libertà e responsabilità sono i sentimenti che l’accompagnano per tutto questo periodo. Inizia la sua attività nei Gruppi di difesa della donna che aprirono la strada alla presa di coscienza delle donne di poter aspirare ad una vita anche al di fuori della casa, provocando una rottura nel senso comune dell’epoca. Successivamente diventa staffetta, incarico che consisteva soprattutto nel camminare, spesso in solitudine, correndo enormi rischi, dimostrando che anche le donne possedevano non meno capacità e tenacia degli uomini. Alla fine della guerra, quando la condizione della donna regredisce nuovamente nella normalità ritrovata, diventa irrinunciabile per Marisa continuare la vita politica: definì l’iscrizione al partito comunista come il momento più felice della sua vita. 211 Sono anni in cui il PCI è davanti a tutto, una «passione senza misura», poiché frutto di una scelta maturata in un’esperienza totalizzante come quella della Resistenza. Il 1956 segna l’anno di svolta per Marisa, sia a livello ideologico, sia di partito: la sua situazione sentimentale irregolare è la causa del suo licenziamento, dovendo ancora sacrificare il suo ruolo politico all’essere donna. A questo punto Marisa torna alle origini della sua esperienza politica, diventando funzionaria dell’UDI, il luogo ideale in cui mettere a frutto la sua scelta di vita; gli anni trascorsi nell’UDI sono caratterizzati dal forte senso di appartenenza, di identità, ma anche dalla gerarchia, dal timore del giudizio, dalla necessità di rinnovarsi come associazione, dal confronto, spesso difficile, con il neonato movimento femminista. I due interrogativi conclusivi che Marisa ci lascia, sulla natura dell’amicizia tra donne e sul continuo, inevitabile cambiamento del mondo, ridimensionano le ambizioni, i sogni, le speranze dei vent’anni ma ribadiscono la necessità di non restare indifferenti, di far sì che ogni mutamento porti sempre a qualcosa di meglio. Giulia Cocconi 212
Scaricare