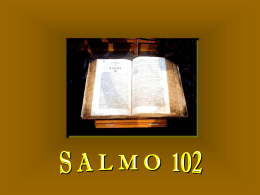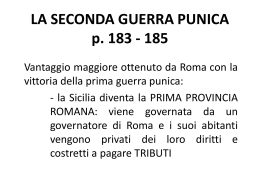In viaggio sulle orme del condottiero che sfidò Roma Prima tappa Sant'Antioco, in Sardegna, la Sulkì della tradizione punica Sardegna, l'isola che profuma di oriente Perla contesa da Romani e Cartaginesi Il Porto di Sant'Antioco IL VENTO africano si sveglia a mezzogiorno sull'isola di Sant'Antioco, a Ovest di Capo Teulada. Picchia rovente sul porto fenicio semisommerso e il castello sabaudo in cima alla collina, strapazza le bandiere dei pescherecci, fa ondeggiare le agavi, disidrata i lentischi come un enorme asciugacapelli. Ti cucina dentro. Quando succede, è meglio non uscir di casa e aspettare la sera, finché il mare diventa "color del vino" come quello descritto da Omero, gli osti stendono bianche tovaglie sotto i pergolati e sull'Iglesiente si sveglia la brezza di terra. Sant'Antioco ‐ la Sulkì dei fenici e dei cartaginesi ‐ non appartiene all'Europa. Lo dicono le vigne millenarie venute dal Libano, i leoni di pietra africani che guardano le porte della città perduta, i bronzi e i cocci sparsi nei campi. Lo confermano gli uomini, irsuti e taciturni come naufraghi di un mondo perduto; e le donne, olivastre, dagli occhi duri, cloni inconsapevoli della dea Demetra. Qui tutto sembra venire da oltremare, persino il mucchio selvaggio di olivastri, corbezzoli e mirti sparsi sul pendio. Anche la laguna interna, che al mattino s'incendia come un tempo a Cartagine. Se l'Africa è vicina, Cartagine ‐ alla periferia di Tunisi ‐ è vicinissima. 105 miglia appena, meno della Sicilia. A bordo di una trireme ci avrei messo, per andarci, un giorno e una notte soltanto, con l'aiuto del maestrale. Un posto a bordo l'avrei trovato subito, il traffico era continuo. Oggi è tutto finito. Non esistono più linee passeggeri dirette: con l'aereo dovrei fare scalo a Roma e col traghetto a Trapani. Questi peripli infami sono il regalo della globalizzazione: l'Africa è 1 diventata lontana, le isole hanno perso importanza, il Mediterraneo s'è spaccato in due, Islam contro Cristianesimo. Proprio per questo cominciamo da qui, dove pure Annibale non è stato mai. E' in Sardegna che misuriamo la decadenza dalla gloria di allora. Qui comprendiamo il "grande gioco" che scatenò il secondo, micidiale conflitto punico. A differenza dell'Italia di oggi, Roma non trascurava le isole. Voleva fortissimamente la Sardegna perché stava al centro del mare, e quel mare era il volano del suo dominio nascente. Per questo la rubò a Cartagine alla prima occasione, approfittando di una crudele guerra civile scoppiata in Africa dopo il primo conflitto punico. Fu allora che il padre di Annibale, Amilcare Barca, capì: con Roma la coabitazione era impossibile. Piero Bartoloni è il governatore‐ombra di Sulkì. Come archeologo, regna incontrastato sui tremila anni di storia dell'isola, le rovine cartaginesi e la sterminata popolazione di trapassati di un territorio dove case e necropoli si toccano, in labirinti sotterranei inestricabili. Ma il professore non è solo questo. E' anche l'unico romano di Roma tenacemente filo‐annibalico che esista. Lui a Sulkì ci abita apposta per stare lontano dalla Dominante. Si sente a casa sua solo in quest'ultima periferia, accanto al suo mondo perduto. "I Fenici ‐ racconta ‐ venivano dal Medio Oriente, erano gente di mare come i Filistei, i palestinesi. Commerciavano la porpora e il bisso color dell'argento. Navigavano fino alla latitudine dei Quaranta Ruggenti, quando ancora i Romani abitavano in capanne di fango". Poi vennero i Cartaginesi, che erano Fenici africanizzati, intrisi di cultura greca. Anche loro erano navigatori indomiti. Con l'ammiraglio Annone spinsero le loro navi fino al golfo di Guinea approfittando degli alisei. Ma Roma imparò presto a usare il mare, entrando in conflitto con Cartagine e battendola nello scontro navale delle Egadi. Il mare era la grande autostrada, la ricchezza, la misura del mondo conosciuto. Quando se ne allontanavano, gli antichi provavano vertigine da ignoto. Per questo le legioni, dopo aver sconfitto Annibale, avrebbero atteso decenni a conquistare la Padania, pur avendo già messo le mani sulle coste di mezzo Mediterraneo. Roma soffriva di mal di terra. Per i Greci non era diverso. "Pontos" ‐ da cui "ponte" ‐ era la mitica passerella per l'altrove. "Andrai fin dove i popoli non hanno mai visto il mare", aveva detto un indovino a Odisseo col tono di una tremenda condanna. La paura della profonda terraferma e delle sue montagne era tale che gli elleni la battezzarono Epiro, cioè "il non misurabile". Solo un figlio di quelle selvagge Terre del Limite, Alessandro, sarebbe riuscito a rompere il tabù, spalancando ai Greci ‐ con la conquista dell'Asia ‐ una dimensione terrestre mozzafiato. Vento, scampanìo, agavi che ondeggiano come alberi maestri. Saliamo sul castello sabaudo, costruito su un basamento di gigantesche pietre puniche. "Ecco, qui sei sull'ago del compasso. Intorno hai Trapani, Cartagine, Roma, le Baleari. Tutte a un tiro di schioppo. Più lontano, Marsiglia dei Greci. Dall'altra parte il faro d'Alessandria sul Delta del Nilo. Un po' più a Nord, la favolosa Colchide in fondo al Mar Nero. A Occidente, le porte dell'Oceano, le Colonne d'Ercole. 2 Traguardi questo smisurato campo d'azione e misuri tutta la potenza marittima di Cartagine". Ceniamo all'aperto con tonno fresco e vino fenicio, un Kanai robusto e denso come la terra di Sardegna. Il viceré mastica in silenzio, un sole albicocca tramonta nel mare color prugna. "Vuoi davvero capire quel mondo?" chiede a bruciapelo. "Pensa a ciò che mangi. Questo tonno l'hanno preso stamattina. Sapevi che a Sant'Antioco c'è una delle ultime tonnare? E da chi credi che qui abbiano imparato la tecnica della tonnara?". Lascia la domanda in sospeso, poi stringe il pugno come per quagliare un concetto, e risponde a se stesso: "Dai Fenici". Sono uscite le stelle, la macchina del tempo s'è messa in moto alla grande. "Prendi i nomi dei pesci. Anche quelli vengono da Oriente. Salpa, da "Shelba". Murena, da "Mrina". Triglia da "Trilia". Orata era "Orata" già tremila anni fa". Con l'espansione dell'Islam, l'arabo ‐ parente stretto del fenicio ‐ si limitò a far breccia sulla strada già segnata dai cartaginesi. Ammiraglio viene da "Al amir al bakhr", il capo del mare. Feluca, da "Fluka", barca. Cassero è figlio di "Al Kasr", il castello. E poi arsenale, generato da "Dar assina", la fabbrica. Roma avrà anche dominato le terre emerse, ma forse è stata solo una parentesi in un mare tutto segnato dall'Oriente. Fenici, Cartaginesi, Arabi, Greci, Turchi. E Venezia. Luna, silenzio. Alture con rocce sommitali grigie, squadrate come fortezze, coperte di licheni arancione, disseminate di piccole lapidi. Saliamo verso il "Tofet", il cimitero dei bambini. In posti così i cartaginesi seppellivano i loro morti prematuri, dolcemente, in pentole da cucina in terracotta, con accanto giocattoli e piccoli doni. Il mondo punico è disseminato di queste necropoli infantili, riservate a chi non aveva passato ancora il rito dell'iniziazione. Ebbene, su questi teneri monumenti alla pietà s'è consumato uno dei più sporchi imbrogli della storiografia. I cartaginesi, si disse, sacrificavano i loro primogeniti, li sgozzavano da bambini e li gettavano nel fuoco, per ingraziarsi il dio Molok. L'idea prese piede nell'Ottocento e fu in gran voga fino alla fine del ventesimo secolo. Nessuno osava contestarla. Tutto congiurava a tenerla in piedi. La "damnatio memoriae" dei Romani contro il "perfido" Annibale e la sua gente, la diffidenza latina contro i levantini "imbroglioni", il pregiudizio cattolico contro i pagani. Perfino l'accusa dei sacrifici rituali di bambini, mossa contro gli ebrei, e poi trasferita pari pari sui loro cugini naviganti. "Era, ovviamente, una balla colossale. Non ci volle molto a capirlo. Allora la mortalità era altissima, sette bambini su dieci morivano nel primo anno di vita; se avessero sacrificato i sopravvissuti, l'intero popolo fenicio si sarebbe estinto". Bartoloni raccoglie una piccola pietra incastrata in una fessura, la soppesa, la alza verso le stelle. Mormora: "Chissà chi l'ha messa, e quando". Poi sillaba: "Bet‐El". Casa di Dio. E' il nome di quel sasso. Nel mondo semita bastava una pietra a rappresentare il Tutto. Chissà quanto peseranno le ceneri di Annibale, si chiedevano ironicamente i Romani a guerra finita. La domanda era costruita apposta per ricevere in risposta un'unica parola: "Niente". La conferma, cioè, che il grande babau era diventato nulla, era sparito dalla storia. Ma i Romani non avevano fatto i conti col mito. La leggenda che ‐ come vedremo ‐ avrebbe invaso il Mediterraneo per secoli dopo la sua morte. 3 Nella città più africana d'Europa Luogo che non ha un'anima bellica, ma musicale Quel bimbo di Cartagena La Spagna che vide crescere il mito "CARTAGENA, destino final Cartagena". E' quasi l'una, mi sveglio di soprassalto. Ho russato un bel po', da quando il treno ha preso la strada della notte. Esco imbambolato, la piazza della stazione è invasa da un vento secco profumato di origano. Oltre le vecchie mura e la baia, intravedo le gobbe nere, inquisitorie, del monte Galeras e del San Julian che finora ho visto solo sui libri, e per un attimo ho la netta sensazione che Lui ci sia. Come se tra noi fosse cominciato un gioco a guardie e ladri. Destino final... un altro presagio! Già c'è stata quella partenza a Madrid all'ora fatale delle corride ‐ le cinque della sera ‐ dalla stazione di Atocha, sovraffollata come il giorno dell'attentato, nel marzo 2004. E poi, quel vuoto inquietante e un po' funebre della Castiglia, fatto di pale eoliche, mandrie e praterie. Ora, questo sbarco al buio, questo mare come un sipario, questa città silenziosa dove un tempo è cominciata la prima guerra "mondiale" della storia. Un tassista pazzo mi porta a cento all'ora tra le ramblas, rompe l'incantamento, sgomma, bestemmia, evita un frontale, per un attimo mi mette davanti al mio "destino final". Quando arrivo all'hotel ‐ un bunker afflitto da un arredamento mortuario da catena americana ‐ sono di pessimo umore. Ho perso anche l'orientamento: secondo le cronache di duemila anni fa dovrei essere su una laguna alle spalle della città. Invece sono su un fottuto interramento del secolo ventesimo. Intorno, cemento senza storia. E la sensazione che qui non ci sia niente da cercare. Al mattino trovo in soccorso nel cellulare un messaggio di mio figlio. "Ama Cartagena come l'ho amata io. Non troverai mai più una Spagna più Spagna di questa. Vai sulla piazza degli eroi di Santiago de Cuba. Il tuo viaggio comincia lì". E' un delizioso preludio di tapas, vino fresco e atmosfere forti. Finora è stato Michele a seguire le mie orme nei viaggi. Oggi scopro di essere io sulle sue, e subito la giornata prende la piega giusta. Nell'atrio dell'hotel c'è una gigantografia color seppia di Cartagena nel 1876, ancora simile a quella narrata da Tito Livio. Le barche a vela dei pescatori sono quasi le stesse, le mura e il mare interno sono ancora al loro posto. Ora mi oriento. Sto cercando un mondo scomparso solo l'altroieri, non duemila anni fa. Anche Pilar Ceniza, guida della regione Murcia che ho prenotato dalla Tunisia, m'illumina la giornata. Arriva con un casco di riccioli matti e una sporta di documenti sul passato 4 punico della città. Ha capito al volo che il nostro sarà un viaggio dell'anima. "El sangre de la ciudad es su puerto ‐ è il suo grandioso esordio ‐ Cartagena es una ciudad naval". Fuori c'è una gran brezza, luce forte e limpida, e quando usciamo sulla rambla mi spiega che da lì bisogna guardare le alture della città vecchia "immaginando di stare con l'acqua alla cintura", a mollo nella laguna. "El viaje es imagination" sorride. "Giusto Pilar", penso fra me, e poi "la vita è sogno", no? Lo diceva nel Seicento un tale Calderon, di cognome Barca come il nostro eroe. Sento in mano la chiave della storia. E' brevissima l'epopea di Cartagena. Ne ricapitoliamo la storia davanti a un caffè. Dunque: Amilcare sente che il partito filo‐romano vuol fargli la pelle, scappa dall'Africa e fa vela a Ovest e, con Annibale ancora bambino, approda a Cadice, ai margini del mondo conosciuto. Soggioga tribù, s'impossessa di miniere, trasforma il Sud dell'Iberia in una colonia, manda alla madrepatria favolosi carichi d'argento, riacquista il consenso perduto. E' qui che il cognato Asdrubale fonda Cartago Nova, la più grande colonia africana in Europa. Ma dopo pochi anni dopo, mentre Annibale devasta l'Italia spadroneggiando in casa del nemico, Scipione lo beffa marciando sulla Spagna e prendendo Cartagena. Erano così le guerre di una volta: più facili da vincere in trasferta. Entriamo in città fra rondini in fregola e immigrate marocchine ciabattanti dai vicoli, lungo quello che fu "el camino de entrada de Escipion". Qui, spiega Pilar, prendono tremendamente sul serio la storia. Ogni fine settembre una confraternita celebra uno spettacolare scontro armato romani‐
cartaginesi. E quando la città deve chiedere autonomia alla Murcia, lo fa sbandierando la "diversità punica" esattamente come i "lumbard" fanno con i Celti per battere cassa a Roma. "La antiguidad ‐ spiega ‐ es un valor economico". Ma Annibale è anche fascino, e Pilar non sfugge al rapimento per l'uomo del mistero. La città cartaginese non è fatta di pietre. E' un vuoto, un'impronta, uno stampo su cui è cresciuto tutto il resto: mondo arabo, Bisanzio e altro. Sopra le mura puniche sono sorte quelle settecentesche di Carlo III; sul porto militare è nato il primo grande arsenale della Spagna moderna. Oggi sull'arena dei gladiatori c'è la Plaza de Toros. E sulle orme dei cartaginesi passano ‐ onnipresenti ‐ i loro nipoti maghrebini, comparse perfette di un film d'epoca. Nel grande sonno dell'ora media a Cartagena non senti tamburi di guerra. E' come se rullassero sempre altrove. A Sagunto, a Nord di Valencia, che Annibale assedia nel 219 per costruire il suo casus belli con Roma. O magari sugli immensi altopiani fra Tarragona, Valladolid e Albacete, verso la Sierra de Guadarrama, dove poco prima di partire il Nostro sconfigge gli indomiti Carpetani, due volte più numerosi di lui. Il grande africano non è mai dove lo cerchi. Oleandri, cannoni arrugginiti, l'ombra di un portico dietro l'Arsenale. Mangiamo bottarga e mandorle, piatto ‐ garantisce l'oste ‐ di nobile origine punica. Intorno, panni stesi al vento, postriboli in disarmo e ficus grandi come case. "La ciudad tiene un aire napolitano" sorride Pilar, e cerca di ignorare la modernità blasfema che si fa strada. Un centro fitness sopra il foro e, sul cardo romano, orribili case gialline finanziate dalla Cassa Murcia. 5 Ma il senso del luogo resta più forte del cemento. In un'androna suona un pianoforte, sul colle di Esculapio con la cisterna araba gridano i pavoni reali, sul lungomare comincia il vocìo dello struscio. Le comari si chiamano dai balconi e agavi enormi cantano nel vento. Ora capisco a pieno il messaggio di mio figlio. Cartagena non ha un'anima bellica, ma musicale. Si lascia trascinare controvoglia in questa pazzesca avventura. Ma Lui dov'è? Se il porto è davvero il "Corazon de la ciudad", è là che dobbiamo cercare. Andiamo dritti all'Arsenale, in fondo alla baia, all'imbocco del canale d'accesso all'ex laguna interna. E' un posto dove i turisti non entrano, ma in Spagna lo stato è meno "spagnolo" che in Italia, e i militari ci fanno passare. All'ingresso, la scritta "Valor, lealtad, disciplina y honor". Dentro, cacciatorpediniere e sommergibili transoceanici al posto dei galeoni. La banchina è la stessa dove attraccava la flotta cartaginese. L'ammiragliato è una meraviglia. Scaloni scricchiolanti di mogano con rinforzi antiscivolo di ottone, azulejos con l'effige della Madonna del Pilar e un modellino del primo sommergibile, costruito dall'ebreo spagnolo Isaac Peral. Ma l'elenco dei caduti "per la patria" è solo quello dei falangisti di Francisco Franco, che pure attaccò Cartagena operaia con i battaglioni di "primera limpieza", orde di assassini incaricati di spianare la strada all'esercito. C'è anche il nome dell'ammiraglio Carrero Blanco, fatto saltare in aria dai baschi nel dicembre del '73. Ma sono dettagli, rispetto a duemila anni di storia. Vado nella sterpaglia verso l'ultima banchina dimenticata, dove sorge il "Penal de reos y galeras", l'antico carcere dei galeotti, diroccato e deserto, verso l'uscita della baia. Ne faranno ‐ che dio li stramaledica ‐ un museo e una "business school", e io sono forse tra gli ultimi a vivere questo incanto. Mi siedo sulla riva a fiutare il vento africano. A Est si spegne l'incendio del tramonto sulla Sierra Minera, dove Amilcare Barca trovò il suo argento, e in un lampo la pietraia diventa color cenere, poi azzurra di luce lunare. Che capolinea. Sono nello stesso tempo a Casablanca, Trapani, Haifa e Marsiglia. E' tutto così chiaro: Cartagine fu la Venezia del Mar d'Occidente, e Cartagena la sua base in Europa. Pilar se n'è andata, ora sono solo con i gabbiani. Domani comincia la lunga marcia. 6 Verso l'Italia, evitando le strade facili Nel 218 a. C. il condottiero ha 26 anni e comanda 90mila uomini Seguire un'ombra sui Pirenei tra fantasmi di cavalieri e stelle MA c'è differenza fra cercare Annibale e il mullah Omar? Forse no. Forse i duemila anni di storia che separano quei due non contano niente. Annibale e il mullah: sempre di un'ombra si tratta. Mi vengono pensieri così, nella meseta solitaria, mentre viaggio verso i dei Pirenei sotto piccoli scrosci di pioggia. E' il 218 avanti Cristo, il dado è tratto, il Nostro è già in marcia verso l'Italia con novantamila uomini, dodicimila cavalli e decine di elefanti. Cerco di immaginare quella massa in movimento, il polverone che solleva, l'odore che lascia, il rumore che fa. I bagagli, le scarpe, i vestiti, il foraggio, le cucine. Calcolo che tra la partenza dei primi e degli ultimi dal campo debbano intercorrere almeno cinque ore. Uno sforzo logistico pauroso. Novantamila uomini e dodicimila animali da nutrire, accampare e proteggere. Senza elicotteri, strade o ferrovie. Bivio Lerida‐Barcellona, primi cartelli in lingua catalana, illeggibili per le troppe "L" e "X". Raggi di sole, mucche, il paesaggio che si fa più verde. Verso Est, in direzione di Manresa, le guglie di Monserrat escono dai vapori. Sembrano un'istrice mitologica, penso che forse il nome di queste montagne viene da lì. "Peiro" in greco vuol dire infilzare, e i Pirenei sono un gigantesco forchettone puntato verso il cielo. Ma c'è anche un'altra spiegazione. La leggenda della ninfa Pirene la quale, amata da Ercole, partorisce un serpente, scappa sconvolta sui monti e muore sbranata dalle fiere. L'eroe, avvilito, chiamerà quei monti col suo nome. Ho con me tre monetine in peltro regalatemi da Pilar, la brava guida di Cartagena. Mi tintinnano in tasca come amuleti, insieme agli euro e alla minutaglia color rame. Sono la copia di esemplari punici e portano stampate ciascuna la testa di Annibale, del padre Amilcare e del cognato Astrubale. Annibale non ha la barba e mostra un naso forte, simile a quello di Alessandro Magno. Della sua vera faccia si sa pochissimo. Esiste solo un busto al museo di Napoli, riprodotto su tutti i libri di scuola. Ma è già un Annibale tardo, con un occhio solo. Il resto sono soltanto ipotesi. 7 Risalgo a Nord in direzione di Andorra, poi taglio su Berga per strade complicatissime in mezzo a foreste. Su e giù, su e giù, con davanti l'immenso deretano dell'elefante immaginario che mi precede. L'auto ha preso già la sua andatura. L'ho battezzata "Dumbo", a gloria dei pachidermi antichi, per propiziarmi la traversata dei precipizi pirenaici, del Rodano e delle Alpi. Ormai è montagna selvaggia: non incontro più nessuno, salvo boscaioli e tecnici dell'azienda elettrica. Secondo i sacri testi la strada dovrebbe essere questa. Il racconto di Polibio è impressionante. Il gran generale non marcia diretto verso la Gallia e le Alpi. Disdegna le strade facili. Non cerca una verdeggiante Roncisvalle. Combatte ancora, assoggetta altri popoli a Sud dei Pirenei. Lascia diecimila uomini dalle parti di Lerida, come guarnigione di difesa oltre l'Ebro. Poi offre a pavidi e incerti l'occasione di tornare a casa, rispedendone indietro altri diecimila. Perché lo fa? Annibale non vuole zavorre in viaggio. Ma a chi rimane promette gloria, e le sterminate ricchezze d'Italia. Leggo su Polibio che egli condusse un'armata "non tanto numerosa quanto valida ed esercitata in modo eccellente dalla serie ininterrotta di combattimenti sostenuti in Iberia". La lunga marcia era stata trasformata nell'allenamento alla grande prova. Geniale. "El mejor general ‐ mi aveva detto Pilar alla vigilia della partenza ‐ no es el que tiene el mejor ejército, sino el que sabe utilizar mejor el ejército que tiene". A Ripoll, l'ultimo paesone sotto i Pirenei, improvvisamente lo sento. Capita la sera, in un grande albergo sulla strada cantonale, abitato da rumorosi operai di un cantiere. Sto aspettando di cenare in una sala semivuota, in compagnia del fedele Polibio. Gli altri sono già in camera a bere birra e guardare la Tv, e un cameriere spiccio mi intima di ordinare in fretta. Fuori rombano camion verso la Francia, sull'erba si condensa nebbia. "Annibale dunque affrontava i passi dei monti Pirenei, temendo molto i Celti per la natura impervia dei luoghi". Tutte le strade hanno una voce, e anche la "Cantonal 17" comincia a raccontare. Bastano due righe di Polibio e i camion non sono più camion, ma cavalli che vanno. Novemila cavalli imbottigliati nella valle, un fiume animale che va nelle brume in una scia di nitriti, fra urla di gauchos ed escrementi, verso il campo già drizzato poco oltre la confluenza tra due fiumi chiamati Ter e Freser. Sento l'odore dei bivacchi, vedo i fuochi, le scintille verso le stelle. C'è anche Lui tra le ombre. E' vestito come gli altri, un semplice mantello. Ha solo 26 anni, ma gli uomini lo adorano come un padre. Li sento che ridono e parlottano in greco e altre lingue che non capisco, forse fenicio e la lingua dei celtiberi. Qualcuno intona una canzone malinconica (numidica?), altri giocano a dadi. Intanto il cameriere porta un pezzo di capretto al rosmarino di squisitezza assoluta e duemila anni di storia cominciano a vorticare in un bicchiere di brandy Xeres de la Frontera. Guardo la sala da pranzo. Mi sembra di essere in Afghanistan o in Bosnia durante la guerra. Anche lì, locande di provincia con gente strana, cene in solitudine a rimuginare voci e indizi, insonnia e apprensione sul domani o su cosa ci sarà oltre le montagne. Stessi appunti, stesso quadernino, stessa giubba scolorita senza maniche, piena di tasche con mappe, soldi e passaporto. 8 E poi quel senso di irrealtà, di sogno, che accompagna le guerre, quando tutto pare un film, anche le macerie e i morti ammazzati. Identico anche quello. Fuori nebbia. Penso che seguire Annibale è assai meglio che seguire una guerra vera. Non corro il rischio di essere embedded, finire intortato dai bugiardi uffici stampa degli stati maggiori. E poi, le rovine di un passato millenario non sono forse molto più eloquenti che il deserto contemporaneo dei non luoghi? E non sarà che, in un mondo dove tutto è diventato vicino con Internet e la Tv, stare lontano dagli eventi è diventato l'unico modo per capire le cose? Mattino limpido, brume che si diradano, dalla vicina Ripoll arriva uno scampanio a distesa. Vedo passare gente vestita a festa. "Ma come, non va a vedere la benedizione delle greggi in piazza?" mi chiede una simpatica concierge. Esco e, senza accorgermene, resto intrappolato con "Dumbo" dentro un migliaio di pecore che risalgono lente la valle verso il Pic de Finestrelles e il grande Canigou, il Mons Jovis dove gli antichi collocavano la "scala di Annibale". Sto andando nella stessa direzione, alla stessa andatura millenaria, in mezzo a uomini a piedi che lanciano gli stessi richiami. Di nuovo la strada racconta di quel favoloso viaggio. E io ci sono dentro. La festa è sul sagrato del monastero di Ripoll, ne vedo il campanile da oltre il fiume, ha il profilo di una solida bellezza romanica. Sopra di me, una via lattea di santuari medievali persi nelle montagne. La piazza è già piena di pecore, attorno ai chioschi la gente beve vino da orci di terracotta e addenta salsicce. Sul frontone, vecchio di milleduecento anni, uno stupefacente dispiegamento di santi, eserciti, cavalli e agnelli, schierati sotto un umanissimo Cristo‐boscaiolo, che mi sovrasta, compatto e potente. Allora il Cristianesimo non aveva tolto l'anima agli animali. Devo prendere le misura del tempo. M'accorgo che sono passati meno anni tra la costruzione di quel monastero e Annibale che non tra quel monastero e l'età contemporanea. Per capire meglio, decido di non dividere il tempo in secoli, ma in segmenti di sessant'anni, l'età media in cui si diventa nonni e la memoria passa ai nipoti. Bastano trentasei nonni per arrivare ad Annibale. I monaci medievali di Ripoll ne dovevano contare solo quindici. Forse ricordavano ancora l'evento. E forse quei cavalli e soldati sul frontone sono i nipoti di quella memoria. La carretera brulica di immigrati moriscos ‐ in libera uscita per la festa di paese ‐ nordafricani come la truppa del 218. Donne velate passano senza saperlo sotto le montagne traversate dal loro progenitore, e tutte stanno alla larga dal sagrato. Non è il più il buon tempo antico, quando ancora non c'erano gli dei unici a complicare le cose tra i popoli. Allora Melqart ‐ il fondatore di città, il divino eroe dei punici ‐ diventava Ercole senza imbarazzi. Entrambi abitavano lo stesso pantheon, entrambi si riconoscevano figli dello stesso mito. Ed era solo trentasei nonni fa. 9 Annibale traghettò quaranta pachidermi attraverso il corso d'acqua Un'impresa passata alla storia: forse non voleva solo spaventare i romani ma fare qualcosa di memorabile Oltre il fiume Rodano Sulle tracce di Ercole
In un silenzio impressionante il Rodano va verso la stretta di Beaucaire dove Annibale traghettò i suoi 40 pachidermi; scena raccontata magistralmente da Polibio e immortalata in secoli di grandiose iconografie. Poco prima dello sbarramento di Vallabréguès un cartello nell'erba indica "263", duecentosessantatré chilometri per la foce. Da una piazzola posso vedere le chiatte che entrano nelle chiuse e le famigliole ‐ molti nonni e bambini ‐ che vengono a sentire la voce antica del fiume. Il mio "Dumbo" russa esausto con le ventole al massimo, e se fosse davvero un elefante si succhierebbe il Rodano intero. All'ombra di un pioppo tiro le somme di una giornata incendiaria dai Pirenei fino a qui attraverso le terre dei Catari, devastate dai papisti cento volte peggio che da Annibale. "Come facciamo a distinguere gli eretici dagli altri?" pare abbiano chiesto i soldati al pontefice, che rispose: "Bruciateli tutti, Dio saprà chi salvare". Una giornata di gran vento, con le pietrose Corbières battute da diafane nubi atlantiche. E poi l'abbazia di Fontfroide, il Canal du Midi e l'impressionante acquedotto romano detto Pont du Gard, immobili nella canicola. Sul lato francese dei Pirenei mi ha offerto riparo il piccolo "Café de l'Union", stupendamente piazzato tra un tornante e il ponte sul Tech. Lì ovviamente non lo sanno, ma per me il luogo resterà immortale per via di una fornaia ambulante ‐ bella come la dea Cerere ‐ che mi ha salutato dal furgone, una ruvida ostessa di paese e una baguette al paté di cinghiale placidamente consumata sotto un platano, con birra e cetriolone d'ordinanza, i piedi quasi a mollo nel torrente. Poco prima, sul colle di Arès, quello valicato nel 218 dai cartaginesi, non c'era nessuno. Solo una moto ogni tanto. Nella locanda ero l'unico avventore, e il gestore era sul depresso. Gli ho consigliato di disegnare fuori un bell'elefante e scrivere in grande: "Annibale è passato QUI". Lui non sapeva niente della storia, e non so se mi abbia preso per matto. Quando alla stretta di Beaucaire vedo arrivare una chiatta di nome "Passaat", probabilmente olandese, con un marinaio francese a bordo, mi prende voglia di attaccar discorso. Da dove venite? 10 "Rotterdam, monsieur". L'uomo sta fissando le gomene, mentre i portonazzi della chiusa tornano a chiudersi. Gli chiedo se sa di Annibale e del suo passaggio qui. "Ici? Hannibal? Vraiment? Racontez‐moi, monsieur". Sì, gli dico, è passato con cinquantamila uomini e quaranta elefanti. E poiché i bestioni non amano l'acqua fonda, ha coperto le chiatte di terra e foglie, poi li ha legati per bene e ha mandato avanti le femmine. "Formidable, Jumbo che passa il Rodano, che spettacolo! Le femmine davanti e i maschi dietro... era un furbone Hannibal". Gli ricordo che Annibale era un maghrebino, dunque l'Africa invadeva l'Europa. "Un africano, sicuro... Qua è pieno di africani anche oggi. Non è cambiato niente, monsieur". Mi accorgo che intorno, a guardare le chiatte, ci sono anche famiglie immigrate dal Nordafrica. Eh, la Francia non è più la Francia, gli dico mentre il livello dell'acqua comincia a scendere. "Vero. Ma non sono loro ad averci invaso, siamo noi che li abbiamo fatti venire. Noi abbiamo ridotto la Francia a un ipermercato". Ora la chiatta è cinque metri più in basso, per sentirci dobbiamo parlare forte. Suona una sirena. Lui canticchia qualcosa. "C'est pas Hannibal, c'est pas Hannibal qui a détruit la France". Non è Annibale, non è Annibale che ha distrutto la Francia. Seguono altre parole incomprensibili. Faccio in tempo a chiedergli come si chiama. "Hercule, mi chiamo Hercule" quasi grida mentre le chiuse si aprono con cigolii spaventosi. Fantastico. Hercule, un nome introvabile oggi. "C'est pas Hannibal, c'est pas Hannibal..." Lo sento che canta il suo refrain, mentre la chiatta scende con la corrente verso il bianco castello di Tarascon. Ed è a Tarascon, subito oltre il ponte, che trovo il monumento ‐ appena inaugurato ‐ alla Tarasca, mitologico mostro anfibio alato che divora i viandanti appostandosi sui malpassi, guadi o gole di montagna. La municipalità tarasconese l'ha voluta simile a un'enorme tartaruga, gonfia come un pallone aerostatico e la pelle coperta di spuntoni tipo mina galleggiante. Tartarino è l'eroe liberatore, il cacciatore che esorcizza la belva sanguinaria, ma il moderno racconto burlesco è solo l'ultima trasformazione di una grandiosa leggenda antica. Quella di Taras, o Taranis, corrispondente celtico della sfinge. Dal Rodano fino al Po la rappresentano ancora, in mille varianti, in modo simile al drago thailandese sputafuoco che cammina, colorata gualdrappa portata da decine di persone. Una volta me ne parlò un mitico cacciatore di storie delle valli cuneesi, gigantesco pure lui come una Tarasca. Sergio Maffioli si chiamava, e in una sera di temporale mi raccontò per ore di come il mostro fu sconfitto da Santa Marta e da Maria Maddalena e poi scappò volando, per morire alla falde del Monviso. Leggo che un tempo in tutta la Gallia era costume uccidere i viaggiatori e che toccò a Ercole ‐ che poi avrebbe fondato la città di Alesia ‐ interrompere la barbara usanza. Ercole, come il marinaio della chiatta olandese. Chissà, mi chiedo, se fu lui a uccidere anche la Tarasca... Sarebbe logico: a pensarci, è la terza volta che incontro il Forzuto in questa strada annibalica. Nella sua variante fenicia di Melkqart, lui è già a Cadice, punto d'arrivo spagnolo della famiglia Barca da Cartagine. E' lì che uccide Gerione dalle tre teste, poi ruba le mele d'oro guardate da un drago nel giardino delle 11 Esperidi, dolci creature del tramonto. "Espera", in greco è la sera, e il giardino delle Esperidi segna le mitologiche "Porte della sera", dove l'Europa finisce nel Fiume Oceano. È attorno alle colonne d'Ercole che tutto comincia. È al tempio di Ercole‐Melkqart che Annibale celebra prima di imbarcarsi nella sua avventura. È la strada di Ercole che lui fa quando passa i Pirenei, chiamati così dall'eroe greco dopo la morte dell'amata Pirene. Forse è di Ercole anche il passaggio del Rodano abitato dalla Tarasca. Ma certo! Ercole di lì è passato di sicuro! Ercole dove va dopo i Pirenei? Sulle Alpi! Va sulle Alpi con la mandria di buoi dal pelo fulvo rubata a Gerione! Ma le Alpi non sono la strada di Annibale? Mi siedo sulla riva del fiume. Mi gira la testa, non sento nemmeno le zanzare. Che viaggio sto facendo? Ho con me il dizionario mitologico, un libretto che spesso mi toglie d'impiccio. Sotto la voce "Ercole" ci sono tre pagine di imprese complicatissime, stampate in caratteri minimi. Devo ‐ a questo punto è chiaro ‐ sapere dove va Ercole dopo le Alpi. Dove va, dannato lui? Sul Tevere va. E sul Tevere che fa? Uccide un pastore sputafuoco con tre teste, detto Caco, gli ha rubato due tori e quattro manzi tirandoli per la coda in modo da confondere le tracce. Di nuovo la strada di Annibale. E poi? Alle porte dell'Averno va, in Campania, dove Annibale si gode gli ozi di Capua. E Poi? A Locri, dove il Nostro parte per tornare a Cartagine, quindici anni dopo. Pazzesco. E se Annibale avesse fatto APPOSTA la strada di Ercole uccisore di mostri e fondatore di città? Leggo ancora che lui aveva sempre con sé un centro‐tavola d'oro raffigurante l'eroe. "Ercole Epitrapezios" si chiamava, e aveva accompagnato Alessandro il Grande nel suo cammino verso l'ignoto. Ma allora è chiaro: questo che sto facendo non è un viaggio, ma un pellegrinaggio. Annibale gli elefanti non se li porta dietro solo per spaventare i Romani, ma per fare qualcosa di MEMORABILE. Forse ‐ anzi, sicuramente ‐ lui affronta apposta le erculee fatiche, per segnare per sempre l'immaginario dei posteri. Le studia, le pianifica con cura. Lo fa per diventare un Grande, anche agli occhi dei suoi soldati, e legarli a sé per la vita. Parto verso Carpentras, col Mont Ventoux violetto nella sera che mi indica la strada come il faro dei naviganti. Ora lo so: sto seguendo un genio, che ha costruito un'epopea ricalcando uno schema immortale. Cielo verde, falcetto di Luna con Venere accanto, luci di villaggi verso le Alpi. 12 Gli storici lo prendono per imbecille, come se avesse affrontato i monti alla cieca. Ma lui aveva l'intelligence" La leggenda delle Alpi gli elefanti e la memoria
Un tuono cupo, poi una gigantesca valanga deborda dai picchi, precipita, esplode, riempie l'aria di pulviscolo iridescente, genera un soffio gelido che mi investe e alla fine mi sveglia in un lettone francese che non conosco. E' l'effetto ipnotico delle letture di Polibio: sono ancora vicino al Rodano, sulle colline attorno a Vaison‐la‐Romaine, ma la mente è già sulle Alpi. Ho addosso una strana inquietudine. E' come se fossi sempre in leggero ritardo su di Lui. Trovo la cenere ancora calda dei suoi bivacchi, l'eco delle voci della sua retroguardia, l'odore delle bestie da soma; ma Annibale ‐ magari per un soffio ‐ è regolarmente più avanti di me. E' chiaro, sto andando alla cieca. So a malapena che, passato il Rodano, Lui non imbocca la via maestra della Durance, ma fila a Nord lasciando con un palmo di naso i Romani che l'aspettano in Provenza. Va là dove nessuno oserebbe inseguirlo, tra i Celti transalpini. Ma qui nasce il problema: dopo Orange ogni strada diventa buona. L'Isère, la Drome, l'Aigues, le valli della Tarantaise e della Maurienne. Ho individuato almeno otto passaggi divisi in infinite varianti, ciascuna delle quali sostenuta da questo o quello storico, da questa o quella azienda di soggiorno. Dalle Marittime alle Graie, venti passi alpini mi chiamano dicendo: "HANNIBAL EST PASSE' ICI". ... Nella stanza che madame Houvel mi ha apparecchiato la sera prima c'è un manifesto con la mappa delle leggende provenzali. Sulle Alpilles è disegnata la capra di monsieur Séguin e il lupo che l'ha mangiata; più in basso c'è la mula del Papa, protagonista di un altro bel racconto di Daudet. Ci sono pure due elefanti: uno ben piazzato sopra Avignone e l'altro a Buis‐les‐Baronnies, sui meandri del fiume Ouvèze. Vorranno pur dire qualcosa. Di elefanti sulle Alpi ne trovi dappertutto, nelle insegne degli alberghi e sulle grandi strade. A Lubiana, per esempio. O a Bressanone, dove secoli fa transitò un pachiderma donato dall'imperatore d'Austria a uno zoo italiano. Ma se basta un singolo elefante da circo a fare leggenda, figurarsi quaranta. Gli elefanti sono fatti per restare nella memoria, e nessuno mi toglie dalla testa che Annibale se li è portati dietro per questo. Lui sapeva che, dopo la sua performance, qualsiasi altro esercito sulle Alpi non avrebbe avuto lo stesso effetto. Cosa che, puntualmente, accadrà già con suo fratello Asdrubale, che nessuno ricorda e che pure passa dopo qualche anno, col doppio di elefanti e molte meno perdite. Lo stesso con Giulio Cesare, Carlo Magno e Napoleone. Tutti degradati al rango di imitatori di 13 un'idea. Da quando è in pensione, monsieur Raymond Rozet ha un solo pensiero: Annibale. Rifare la strada del Grande Cartaginese. Da sette anni viaggia e raccoglie documenti a quest'unico scopo. Per Annibale ha abbandonato la sua Parigi e s'è ritirato a Buis‐les‐Baronnies, un posto fuori dal mondo dove, egli ne è certo, le "grand général" è passato nel 218. L'Europa, scoprirò presto, è piena di tipi così, febbrili apprendisti‐storiografi a caccia di indizi, cui il mito del Nostro ha regalato un senso nuovo e più entusiasmante dell'esistenza. Raymond Rozet Lo incontro un mattino di "grand soleil" sul ponte romano di Vaison‐la‐Romaine, un capolavoro di solidità a prova di camion, che "da solo ‐ esordisce sorridendo il francese ‐ basterebbe a farci piangere per l'apocalisse che fu la fine del mondo antico". Insieme andiamo a goderci il fresco al Café des Arts, per confabulare sul nostro uomo. "Ecoute‐moi, Paolo, le strade di una volta erano i fiumi. Ma i fiumi cambiano strada. Se cerchi i fiumi di oggi sbagli tutto. La Durance, per esempio, si buttava nel Rodano molto più a Sud, oltre Beaucaire". E il Rodano? "Anche quello era diverso... Le rive erano malariche, paludose, si passava per un arcipelago di colline...". Già, ma Annibale? "Che senso aveva che andasse tanto a Nord? A Nord c'erano gli Allobrogi, e lui li temeva. Gli bastava poco per dribblare i Romani, che si allontanavano sempre poco dal mare...". Ma Tito Livio, obietto, parla del fiume Isère. "Tanto per mettere le cose in chiaro, io sono un integralista di Polibio. Tito Livio raccontava balle, rispondeva alle esigenze della propaganda romana. L'Isère... C'è qualche demente oggi che parla persino del Grand Saint Berndard ... Une connerie...". Ho la sensazione di fare un salutare bagno di buon senso. Vista dal Rodano persino la salita del Col Clapier, da cui è iniziato questo viaggio, mi appare improbabile. "Gli storici prendono Annibale per un imbecille, come se avesse affrontato le Alpi alla cieca... Ma figurarsi. Lui sapeva tutto, aveva le sue guide, le sue basi; sapeva dove trovare vettovaglie e aveva i soldi per pagarle... Aveva la sua intelligence... era in combutta con i Celti della Padania...". Vabbé, ma io domani dove vado? "Mon ami, se uno deve partire da qui per andare lì, che cosa fa: un periplo? No, si informa sulla strada più semplice. Provaci anche tu". 14 Il latino è micidiale, si scolpisce nella mente. La sera commetto l'errore di rileggere i sacri testi, e Tito Livio mi frega togliendomi il sonno. "Postero die profectus adversa ripa Rhodani mediterranea Galliae petit...". Non capisco, perché dovrebbe andare sull'altra riva del Rodano se l'ha appena passato con gli elefanti? "Non recta regione iter instituit, sed ad laevam in Tricastinos flexit". Ma come a sinistra? Lì c'è la Savoia, troppo lontano! "... inde per extremam oram Vocontiorum agrit tendit in Tricorios...". Chi sono i Tricastini, i Vocontii e i Tricorii? Dove diavolo abitano? "... haud usquam impedita via, priusquam ad Druentiam flumen pervenit". Ma come? Se va a Nord verso Grénoble, come si ritrova sulla Druentia, cioè la Durance? Il giorno dopo, esausto davanti al café au lait, non ho ancora un'idea della strada da fare e così, per disperazione, decido di seguire il consiglio di Raymond. Mettermi nei panni di Annibale e cercare la strada chiedendola ai locali. Una veduta delle Alpi Trovo un anziano alla Brasserie du Siècle. Monsieur, gli chiedo, quelle est la route du Piémont? Quello non ha un attimo di esitazione. "Tout droit, mon ami. Vai a Nyons, segui la "D 94" sull'Aygues, riprendi la Durance per la Route Napoléon e ti cali su Cuneo per il Col de Larche...". Ah... Di colpo tutto fila. La D 94 è solitaria e magnifica, con rocce laterali e piccole praterie sul fiume. Dopo Curnier faccio pediluvio sul greto e sento un'eco di bestie all'abbeverata. Ma l'eco non è una divinità greca? Non si riproduce all'infinito anche dopo il disfacimento dei corpi? E se è la memoria delle voci, perché la strada non dovrebbe conservarlo come un "file" qualsiasi? Viaggio con Polibio in testa e piccoli rapaci che roteano alle zenith. Mi fermo a una fontana, l'acqua è buonissima. Mentre bevo, m'accorgo che sopra c'è scritto "SISTE VIATOR BIBE", "fermati viandante e bevi", in lingua latina. Quello che sto vivendo è infinitamente meglio di una navigazione erudita. Dopo Serres tutto si riapre e Lui è con me. L'armata si distende e pascola per praterie, ruscelli, cicale. Allucinazione? Forse. Ma che importa? Mi fermo in un paese di nome Barcillonnette. Penso: "E se c'entrasse Lui?". C'è la radice "Barca", il suo cognome, come in Barcellona, battezzata dai punici... E se Annibale avesse lasciato sul posto 15 delle guarnigioni? M'accorgo che sulla mia strada c'è un altro paesone dal nome simile, Barcelonnette. Vivo una perfetta allucinazione. Sono dopato, avverto piccole esplosioni nel diaframma ‐ come un colpo di fulmine ‐ come quando si rivede tra la folla una persona perduta tanti anni prima. Non sento la fame, la sete, la fatica. A un distributore, una mora rapinosa dal viso andaluso mi indica montagne roventi simili a quelle di Cartagena. Prendo i tornanti verso il Col de Larche, ed è un'ascensione in un cielo opale, tra enormi fortificazioni. Dopo un cartello "Si affittano asini da gita", compaiono le prime nevi, poi un camion di legname che sale in prima, uno skilift tra le margherite, l'Hotel de la Paix, il Relais d'Italie. Ritrovo la stessa emozione del Col Clapier, dove è nata l'idea del viaggio. Mi stendo sull'erba del passo a guardare le nuvole, in stato di perfetta felicità, e decido che non mi importa niente sapere se quello che ho visto è vero. 16 Alla fine di settembre del 218 il condottiero rincuora i suoi uomini, rimasti in 30 mila, un terzo di quanti erano partiti In cima al passo alpino alla conquista dell'Italia Annibale che scorge le terre italiche per la prima volta, Francisco Goya 1771 "Soldati? A chi l'Italia!". A noiii! "E a chi Roma?". A noiii! Chissà se andò così, quando Annibale arrivò in cima al passo alpino e rincuorò i suoi uomini distrutti dalla fatica. Era la fine di settembre del 218 e i soldati erano rimasti in trentamila, un terzo di quanti erano partiti. Molti erano restati a presidiare i Pirenei, altri erano tornati a casa. Tanti erano caduti nei burroni o erano stati uccisi dei Celti durante la salita. Si fa presto a dire "Italia", penso guardando il pendio verso Cuneo dal Col de Larche, detto della Maddalena. Come sul Col Clapier, dove sono passato con gli alpini, scarpate, canaloni innevati, strettoie. Rileggo Livio e Polibio: discesa infame, con neve fresca sopra scivoli di neve vecchia gelata che fa affondare gli animali da soma e rischia di far precipitare gli elefanti. Se questo è il passo più facile delle Alpi Occidentali, dio solo sa come si facciano a immaginare attraversamenti altrove. ... "Inde ad rupem muniendam per quam unam via esse poterat milites ducti...". Qui Livio narra l'inverosimile: una rupe che ostacola il passaggio, dopo essere stata scaldata con un enorme fuoco di legna, viene fatta "esplodere con l'aceto". La descrizione, che ha provocato bollori di emulazione in generazioni di allievi ufficiali, è stata rielaborata all'infinito, generando specie in epoca napoleonica esplosioni retoriche ‐ Ah "le fracassant vinaigre"! Ah "les rochers petardés!" ‐ ben più terrificanti di quelle reali, innescate dai genieri di Annibale. Vento caldo, fischiar di marmotte. Scendo ex summis Alpibus assieme a camion stracarichi, in un miagolio di freni. Sono travolto dall'ammirazione. Ma come faceva Annibale, a 26 anni, a non avere mai dubbi, a dormire la notte, con tutto quell'ambaradan al seguito? Come faceva a non dirsi: in che follia mi sono imbarcato? Come manteneva l'ordine in quella babele di africani, celti, iberici, greci e frombolieri delle Baleari? Quale infinita autostima lo sorreggeva? Aveva uno terapeuta al seguito? ... La sera, alla locanda "La Randoulina", poco fuori Demonte, racconto alla piccola Eleonora, figlia dei gestori, la storia del grande generale e dei quaranta elefanti che passarono davanti a casa sua, 17 tanto tanto tempo fa. Dalla casa, che ha preso il nome dalle rondinelle che un tempo nidificavano nella stalla, posso sentire la voce della Stura che galoppa verso il Po e i Galli Insubri (leggi Lumbard), con i quali Annibale è già in combutta per la sua marcia su Roma. Cammina cammina, arrivarono nella grande pianura dove li aspettava l'esercito nemico... La piccolina ascolta in silenzio, non c'è videogioco o cartoon giapponese che valga il fascino di un racconto. C'è stato un gran temporale, la valle è diventata una manica a vento, gonfia di luce giallo‐oro. E' strepitosa la Valle Stura: anche la Val Susa sarebbe così, se non fosse stata stuprata dal cemento e dalle tangenti. Nella valle anche la protesta anti‐Tav ricorda il passaggio di Annibale Demonte, sulla scarpata dell'altra riva, è un gioiello assoluto, memoria viva di un Piemunt estinto altrove. Vado sul greto a dare una tirata di pipa. Penso: e se il Nostro fosse passato per più passi contemporaneamente? Barbarossa, che pure aveva meno uomini, per venire in Italia divise il suo esercito in quattro passi tra Lombardia e Piemonte, perché i suoi cavalli non soffrissero di carenza di foraggio. Perché non dovrebbe averlo fatto Annibale? ... Comincia la piana degli italioti deambulanti con telefonino, in apnea sotto nubi monsoniche, persi in una viabilità demenziale. Sulla tangenziale di Cuneo mi invade un senso di incommensurabile decadenza ‐ anzi di sfacelo ‐ rispetto al mondo antico, poi una strana nostalgia per Cartagena e il suo golfo con la Sierra Minera. La contemporaneità mi è diventata intollerabile. Penso che i soldati di Annibale morirono guardando in faccia il nemico e noi, nell'arrogante terzo millennio, moriremo per uno starnuto da febbre aviaria. Devo andare a Torino, che Annibale assediò e dove, scrive Polibio, egli "fece passare a filo di spada tutti coloro che gli si erano opposti". Una spedizione che "gettò tra i barbari vicini un terrore così grande, che questi vennero spontaneamente ad arrendersi". Cerco la segnaletica per Torino, ma tutto ‐ letteralmente ‐ mi tira da un'altra parte. Le acque della Stura, le nervature del terreno, la segnaletica, le strade, la politica, l'immaginario collettivo, tutto sembra voltare le spalle a Torino e guardare verso Alessandria e Pavia, alla confluenza fra Po e Ticino. Esattamente la meta del cartaginese. E' insolubile il mistero per cui Cuneo ignora Torino. Ma una cosa è certa. Se dal Rodano Annibale punta sulle terre degli Insubri, è questo il grande passaggio a Nordest. La Stura. Non è solo la strada più breve, ma anche la più facile, visto che non ci sono da guadare grossi fiumi come la Dora 18 Baltea e il Sesia. E poi, prima dell'età di Augusto, Torino non esisteva. Cherasco, invece, sì. Proprio negli anni di Annibale ci sono, nelle sue antiche pietre, i segni di una misteriosa distruzione. ... In un viaggio mitologico è rischioso incontrare uno storico. Puoi uscirne con le ossa rotte. Tu gli dici, per esempio, che l'ascia di tuo nonno resta sempre l'ascia di tuo nonno, anche se tuo padre gli ha cambiato il manico e tu magari la lama. Lui ti dirà che non è vero, spezzerà l'incanto, e tu nutrirai per lui un inevitabile rancore. Silvia Giorcelli, professoressa di storia romana all'università di Torino, mi spiazza in senso contrario già prima di aprir bocca. Busso alla porta del suo ufficio e mi si para davanti una bionda e delicata creatura iperborea ‐ l'esatto contrario di un topo di biblioteca ‐ con un ipnotico anello basculante al dito e, accanto, una gigantografia di Russel Crowe, protagonista del "Gladiatore". In background, la Mole Antonelliana con un trionfo alpino. "Del passaggio di Annibale in Piemonte non ci sono prove ma solo leggende", mette in chiaro, ma poi accetta entrare nel terreno sdrucciolevole della mitologia. "Nei panegirici romani ‐ racconta ‐ Annibale era visto come un empio arrogante, che per questo penò tanto sulle Alpi". Era il segno, mi spiega, che il metus punicus, la grande paura dell'invasione cartaginese, secoli dopo non era stata ancora superata. "Imperatori come Massimiano, invece, superando agevolmente i valichi, dovevano mostrare pietà e rispetto per la sacralità dei luoghi..." Strano ascoltare una prof di storia romana che pare uscita da una saga germanica e si muove a suo agio tra gli avversari più tosti della Dominante. La Giorcelli mi porta per mano tra i temibili Celto‐
Liguri, indica le ombre dolenti dei Salassi di Val d'Aosta ‐ grandi controllori di passi, fiumi e miniere ‐ che furono sterminati dai Romani (i pochi superstiti furono venduti come schiavi al mercato di Ivrea), m'accompagna fino alla corte di re Cozio a Susa, quello che incontrai al ritorno del Col Clapier, e che eresse con Augusto un arco di trionfo dopo l'accordo sulla sicurezza dei transiti alpini. ... "... Nulla finora / resistergli poté. Tremò l'Iberia / da lui percossa, e fu scampo a lui / sottometter se stessa: invano i Galli / gli s'oppongon frequenti, invitti, ei passa / vede, vince, debella: ergesi invan l'ostacolo dell'Alpi / che confinan col ciel: le non tentate / ripide, anguste vie...". Non ci sarà magari nulla di annibalico nelle misteriose fondamenta di Torino, ma dagli archivi del 19 Teatro Regio spunta una sorpresa: un libretto di Jacopo Durandi musicato nientemeno che da Giovanni Paisiello, messo in scena il 26 dicembre 1779 sotto il titolo: "Annibale in Torino". Un successone, a giudicare da quanto scrive Alberto Rizzuti in una brochure prodotta per conto dell'Associazione per la Musica. Un drammone oggi indigeribile ‐ troppi colpi di scena, battaglie, amori, ninfe e sfolgoranti apparizioni di dei ‐ che però dimostra la testarda vitalità di una memoria corsara. Ma che fece Annibale, disceso in Italia per le Alpi dei Taurini"? "Accampossi in vicinanza della costoro città, e cercò di far lega cò medesimi". E che disse, alla vista della pianura? "Compagni invitti, ecco l'Italia a cui / fra l'armi e fra contrasti / di popoli nemici, e di frequenti / rapidi fiumi e dirupati monti / mercè del valor vostro alfin siam giunti". Ormai ci siamo. Verso Piacenza ci attendono le legioni. 20 La battaglia campale nel Piacentino. La mappe di oggi non coincidono con gli spostamenti delle truppe nel 218 Alla ricerca del fiume Trebbia che nei secoli si è spostato Una curva della Trebbia MALEDETTA Trebbia. Sono fermo da ore in un caffè di piazza Vittorio a Torino, a rileggere la battaglia e i movimenti delle truppe in quel nevoso dicembre del 218. Appena li confronto con la carta del Touring al 200mila, mi inchiodo, sempre sullo stesso punto. Il fiume, che mi mette di fronte a infernali controsensi. Esempio: le legioni venendo da Oriente attraversano la Trebbia con zattere per andare a Piacenza. Impossibile. Oppure: dalla riva sinistra, a fine battaglia, i soldati ripiegano sulla città senza passare il fiume. Egualmente impossibile. Traccio febbrilmente schemini sui tovaglioli di carta, ma non ne vengo fuori. Guardo il Po in grigioverde che marcia verso il luogo fatale e chiedo a me stesso che senso ha andarci, se non sono in grado ‐ scorno massimo per un cartografo maniacale come me ‐ di leggere le mappe. Sono paralizzato davanti alla prima grande battaglia campale, come se non volessi prendere atto della prima sconfitta di Roma. O come se avessi paura di verificare la fondatezza storica di un mito troppo grande per me. Ho la tentazione di rinunciare a Piacenza, e di chiudermi nella lettura di Polibio e di trasformare la ricerca di Annibale in un comodo viaggio tutto virtuale. Sandra Piana, amica di letture e passeggiate padane, mi ricorda che a Torino c'è la scuola di guerra. Grandiosa idea! Cercare Annibale tra gli ufficiali di oggi! Chiedo un permesso e, mezz'ora dopo, sono già atteso al portone d'angolo di un edificio settecentesco dalla potenza prussiana, a due passi da Porta Nuova. Un militare dai gloriosi baffi risorgimentali mi accompagna per scaloni, corridoi e cortili di quello che fu l'arsenale di Torino, fino a un tenente colonnello che resta interdetto dalla mia febbre annibalica e mi spiega amorevolmente che negli eserciti è cambiato tutto in pochi decenni. "E' un grande tema, ma sa, le battaglie campali non esistono più". Mi commemora El Alamein, la Marna e lo scontro corazzato russo‐tedesco a Kursk‐Orel, tutto è straordinariamente interessante, ma mi accorgo che non sto ascoltando, perché sono stupefatto dal luogo. Sono in un fantastico luogo della memoria, tra i muri di quelle che furono le Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione, anno di fondazione 1739. Sono nella prima grande industria di Torino, nata secoli prima del Lingotto. La sapienza metalmeccanica e quella militare del Piemonte nascono qui. Qui s'è costruita l'unità d'Italia. 21 Una galleria di meraviglie. Stampe di grandi manovre, la pagella con i voti dell'allievo Camillo Benso di Cavour, il tavolo della commissione d'inchiesta su Caporetto. Nella biblioteca monumentale, incunaboli del Quattrocento e l'Enciclopedia di Diderot e d'Alembert in originale, 33 volumi. Nell'annuario del Regio Esercito scopro persino il nome di mio padre, nominato sottotenente il primo ottobre 1939, giusto in tempo per la guerra. Poi, una targa di bronzo, che mi conferma quanto so da tempo: le guerre stellari sono niente rispetto ai millenni. "La disciplina dei Romani li fece trionfare delle astuzie dei Greci, della forza dei Germani, dell'alta statura dei Galli e di tutte le nazioni della Terra". Tutto come allora. "Ma adesso venga a vedere il Crispillo", mi dice un ufficiale, invitandomi a entrare in un archivio con un'occhiata complice. Estrae da un cassetto uno scatolone, e ne toglie nientemeno che il capostipite del Risiko. Il nobile e sconosciuto "Crispillo", versione sabauda del "Kriegspiel", complicatissimo gioco prussiano, munito di tavole di tiro, regoli, mappe, abachi per i calcoli, tabelle, istruzioni e centinaia di rettangolini in piombo, coperti di carta colorata, a rappresentare i reparti in movimento. Eccolo, lo strumento giusto per capire la battaglia della Trebbia e i suoi demenziali controsensi! Provo a sistemare in fretta i rettangolini sulla carta, di qua e di là di un fiume immaginario, sposto le legioni di Publio e Tiberio, ripasso a memoria i passi di Livio e Polibio, la carica degli elefanti, la ritirata verso Piacenza sotto la neve del solstizio d'inverno. Ma nemmeno così funziona. Maledetta Trebbia. Comincia nel peggiore dei modi la mia campagna d'Italia. Rivergaro sulla Trebbia, caldo da bestie, leggo Polibio sotto un platano davanti alla piana della battaglia. Il testo è di una bellezza esaltante, ha la potenza di un training autogeno. Annibale spiega ai soldati che combattere lontano dalla patria è un enorme vantaggio, perché non c'è via di fuga, dunque non esiste altro che la vittoria o la morte. Eccola, la genialità del condottiero, che trasforma gli svantaggi in forza vincente. Mi chiedo che ci faccio qui, con le mie miserabili questioni topografiche. Sono venuto a fare che cosa? Quale istinto mi spinge a fiutare ancora il terreno in questa giornata d'agosto? Il mio sguardo è catturato dal curvone del fiume, che all'uscita dell'Appennino piego improvvisamente a sinistra, pur in assenza di ostacoli. Capire una battaglia può essere un'ossessione, e quel fiume maledetto mi fa sentire impantanato come nelle paludi del Mekong. D'un tratto ci penso. I fiumi possono spostarsi! Ma certo... non me ne ha parlato anche monsieur Rozet prima della traversata alpina? "Écoute‐moi, Paolo ‐ ha detto ‐ le strade di una volta erano i fiumi. Ma i fiumi cambiano strada". Come non ci ho pensato prima? Hanno cambiato strada i meandri del Po, figurarsi la Trebbia! Forse ho trovato la chiave dell'enigma. Difatti è un geologo, non uno storico, a soccorrermi come un cherubino del cielo. Arrivo a Giuseppe Marchetti con un giro acrobatico di telefonate su rete cispadana: lui s'accomoda nella mia auto impolverata dalla traversata alpina e pirenaica, e mi spiega subito che il tema l'ha studiato così a fondo che ora è in grado di leggere ogni nervatura del terreno. Viaggiando, mi 22 racconta che anche Gianni Granzotto, anni avanti, inchiodatosi sulle stesse contraddizioni nella scrittura del suo "Annibale", aveva tratto giovamento dalle sue spiegazioni. Dunque sì, certo: la Trebbia s'è spostata, come un serpentone, per dribblare i suoi stessi detriti. S'è spostata, e di tanto, quindici chilometri a Ovest, traslocando lo sbocco sul Po a monte di Piacenza. Nel 218 avanti Cristo costeggiava ancora la Statale 45 per Bobbio, che arriva dritta in città e che, se guardi bene, viaggia da Rivergaro in giù sull'orlo di una scarpata coltivata a grano, come l'argine di un fiume che non c'è. In campagna, segnato sulle carte rinascimentali tra Verza e Niviano, trovi il nome del rigagnolo superstite: la Trebbiola. E in città individui facilmente l'antica confluenza: sta nel punto in cui via Benedettine entra come in un fossato, accanto alla sede del giornale "Libertà". Dal piccolo cimitero di Niviano, alto sulla scarpata del fiume scomparso tra i campi di erba medica, tutto è perfettamente leggibile. Il campo dei Romani ad Ancarano. La valletta verso Rivalta dove Magone, prima che facesse giorno, appostò i suoi cavalieri per l'agguato decisivo. Il meandro di Rivergaro, improvviso, secco come lo scambio di un treno in una stazione, con le acque cristallina della Trebbia che piegano a Ovest in direzione di Rivalta e del campo di Annibale. Tutto torna: Polibio aveva ragione. Ora li sentiamo e li vediamo, come nelle stampe delle grandi manovre esposte nei corridoi dell'Arsenale a Torino. Sulla piana è tutto un attestarsi, dispiegarsi, arroccarsi; un gioco di convergenze, ripiegamenti e avanzate. Il campo della prima grande sconfitta romana è un cimitero, dove ‐ mi racconta Marchetti ‐ da sempre i contadini sussurrano di zanne di elefante e ferri romani sepolti. A Campremoldo ci sarebbe un ossario romano e cartaginese... A Rottofreno Annibale avrebbe rotto le briglie della sua cavalcatura, da cui il nome del paese... Tutti sanno, tutti scavano, e nessuno racconta nulla, nella ricca piana piacentina. Hanno ragione: tanto il Palazzo se ne fotte. La Padania ha altro da fare che ricordare battaglie di duemila anni fa. Meglio mettere in batteria altri cinque milioni di maiali, irrigare nuovi campi di angurie con l'acqua del Po che muore. A Rottofreno, davanti a un bar, un caustico pensionato in canottiera ci dice che lì, davanti alla chiesa, c'era la tomba di un generale russo, morto in un'altra battaglia della Trebbia nel Settecento, ma ci hanno fatto sopra un parcheggio. "Curia, Comune e Soprintendenza tutti d'accordo". Sul ponte della Statale 10 trovo un monumento austriaco del 1820. Un tronco di colonna in granito rosa di Baveno, che trema al passaggio dei camion. C'è scritto in latino che di là passarono, vittoriosi, i generali Hannibal, Liechtenstenius, Souvaroff et Melas. Per il resto, a Piacenza, niente che ricordi la leggenda. 23 La strada che è la chiave delle vittorie di Roma Costruita alla fine della seconda guerra punica: il condottiero fa ancora paura La forza della via Emilia linea di frontiera lastricata La strada romana sotto il livello attuale della via Emilia PIACENZA, pilastro d'inizio della via Emilia. Intorno, zanzare e la Padania intera che crepita di temporali erranti. Sono fermo come un ramarro tra i camion, in asse sul rettilineo che dovrà spararmi come una palla di fucile in direzione di Bologna‐Rimini. Non un ramarro: peggio, una mosca in una ragnatela. Dopo duemila chilometri clandestini da Cartagena, improvvisamente sento che l'ordine romano mi cattura e mi paralizza. Se Roma aveva un marchio, era la sua allergia alle foreste, terreno d'elezione delle imboscate, e questa paura nei secoli ha generato un'ansia quasi patologica di ordine territoriale. Roma dunque è, a pieno titolo, la via Emilia; questo stradone fiancheggiato per quasi trecento chilometri da campi ossessivamente rettangolari, quelli che Roma usava dare in premio ai centurioni in pensione. Lo è quasi più delle arene della Provenza, o dei giganteschi acquedotti spagnoli che ho incontrato sul mio cammino. Leggo la data di costruzione: 186 avanti Cristo. La seconda guerra punica è appena finita, lo choc dell'invasione è ancora diffuso, la Penisola sfiancata da quindici anni di battaglie, scorrerie e reclutamenti; ma soprattutto Annibale è ancora vivo, circola nel Mediterraneo alla ricerca di alleati contro Roma. La via Emilia fu fatta in questo clima. Forse fu addirittura generata da questo clima. Barrito di freni, clacson, autoarticolati in coda nella piana ipermercata. Nulla, apparentemente, che mi colleghi all'ombra maledetta che cerco. E invece no, proprio quella via è la traccia. Ora ne sono certo. Lo stradone dove si imbottiglia il traffico della regione più opulenta d'Italia, costruito ventidue secoli fa dal console Marco Emilio Lepido, è stato generata dalla grande paura annibalica. E' nata a causa di Annibale. Nessuno più, aveva deciso il Senato, avrebbe dovuto passare impunemente gli Appennini. I Barbari avrebbero potuto provarci ancora, magari arrivando dai valichi facili delle Alpi Orientali. Occorreva dunque una barriera, ma una barriera intelligente. Non una miserabile muraglia ‐ come la Linea 24 Maginot, ridicolizzata dalla Blitzkrieg nazista ‐ ma una strada. Una strada veloce per le legioni, che collegasse le colonie‐avamposto da Rimini a Piacenza, attraverso Forum Julii (Forlì), Bononia (Bologna), Mutina (Modena) e altre. Parto nel temporale, incrocio Tir e supercilindrate dirigenziali, attraverso odore di erba e porcilaie, e a un tratto me ne accorgo. La Via Emilia non è una strada. Non è un vettore di espansionismo come saranno le arterie romane verso le Gallie o il Danubio. La via Emilia non serve ad andare "verso" qualcosa, ma a segnare un territorio. E' una linea d'arroccamento, un "Limes". Un'incredibile, funzionale, efficacissima, avveniristica e geniale frontiera. "Mi scusi, dovrei salire al dipartimento di storia antica, ho un appuntamento col professor Brizzi". Università di Bologna, via Zamboni 38, ora della siesta. L'usciere alza lentamente gli occhi dall'interno del chiosco, in fondo al corridoio. Mi guarda con stupore, sono l'unico umano di passaggio a quell'ora infernale. "Il professor Brizzi ‐ insisto, temendo l'uomo non abbia capito ‐ quello che si occupa di Annibale". L'impiegato sorride, e intanto lo stupore del suo viso s'orienta decisamente verso l'ironia e il compatimento. Poi con accento emiliano profondo, strascicando esageratamente le zeta, risponde: "Guardi che il professor Brizzi non si occupa di Annibale...". Sto per replicare no, lei si sbaglia, ho davvero un appuntamento con lui, quando l'usciere finisce la frase lasciata appositamente a metà. "... il professor Brizzi è Annibale". Poi, dissimulando la soddisfazione per la battuta, aggiunge meccanicamente: "Brizzi ascensore quarto piano scala interna fino al quinto prima porta a destra accanto alla segreteria". Salgo in una facoltà che è un labirinto si scale e retropassaggi, chiedendomi che faccia avrà l'uomo che è diventato Annibale. La porta al quinto piano è socchiusa. Dentro, un uomo della mia età, riccioluto e mite, sguardo ironico incompatibile col topo di biblioteca, che scatta come un attendente per aprirmi la porta e mi fa accomodare. "Piacere Brizzi", ed è quanto basta per intuire un tosto accento bolognese. Ride della battuta del portinaio, e ammette che c'è del vero. "La mia identificazione in Annibale è tale che per capire certi angoli bui della sua storia devo mettermi nei suoi panni. A tanti storici verrebbe l'orticaria. A me no". Gli racconto del mio viaggio. Lui ascolta con qualcosa di più forte dell'interesse. Invidia. "Che meraviglia, quei luoghi li dovrò vedere anch'io un giorno o l'altro". Dice cose che non mi aspetto da un professore di storia antica. "Ah, la verità storica... è un'isola‐
che‐non‐c'è, ti spalanca buchi neri che puoi riempire solo col condizionale...". Con Annibale svela un rapporto intimo. Io con Lui sono andato oltre, ho scritto dei libri in cui mi sono messo nelle sue scarpe, uno addirittura in prima persona". Penso sia anti‐romano, come tanti filo‐cartaginesi, ma mi sorprende anche qui: spiega che l'africano fu, anzi, il grande collaudo della grandezza di Roma. "Nessun popolo avrebbe resistito 25 dopo tutte quelle sconfitte sul campo. Con Annibale la storia cambia marcia: quando Roma supera lo choc della guerra punica, rompe ogni diga e dilaga nel Mediterraneo". Passa senza fermarsi dall'italiano al latino, mantenendo inalterato l'accento bolognese. "Roma però non si limitava a conquistare, sapeva anche gestire i territori... non come noi oggi in Afghanistan e in Medio Oriente... Provincias difficilius est optinere quam facere... Provinciae viribus parantur, jure retinentur...". Traduce: "Le province si prendono con la forza, ma si reggono col diritto. Facile conquistarle, difficile tenerle...". Un giorno Ryzsard Kapuscinski mi disse che i generali americani avrebbero dovuto leggere Erodoto e Senofonte prima di affrontare l'Iraq. Ora il conto tornava. "Ma lei verrebbe con me sulla strada del Cartaginese?", chiedo a bruciapelo al Brizzi sempre più infervorato nel racconto. Lo chiedo sapendo già che accetterà. E' un buontempone, acchiapperà l'occasione al volo e sono certo che mi divertirò come un matto. Resta interdetto, poi fa un po' di melina: mi lasci pensare, forse, vediamo, devo spostare degli impegni, domani ho un colloquio... E' fatta! E' chiaro che è fatta. Non ho dubbi. Per qualche giorno l'uomo che divenne Annibale mi porterà alla ricerca di se stesso. Andiamo a studiare il percorso sull'enorme atlante storico del Barrington, magnifica palestra di viaggi virtuali, inchiavardato a un leggio nella biblioteca al quarto piano. Dentro, profumo di praterie, foreste, e i colori di un'Italia vergine, appena segnata da qualche strada. La Flaminia, l'Emilia, la Cassia. Vedo tutto, come se navigassi con un lettore satellitare. I bracieri fumanti degli Insubri a Nord del Po. Le ridotte fortificate dei Sanniti nelle irsute montagne irpine. Le città greche del Metaponto, trafficate e piene di navi. Sibari, con la casa dove morì Erodoto, da qualche parte sotto il monte Pollino in Calabria. I palazzi rossi e giallini degli etruschi e i templi dei loro aruspici chini sulle interiora degli animali. I campi di grano e gli ulivi dell'Apulia. Vedo anche l'accampamento di Annibale, i quartieri d'inverno, il freddo padano terribile, la nebbia, e gli elefanti che muoiono uno per uno. "Quelle strade ‐ sussurra il prof per non disturbare gli studenti ‐ sono la chiave della forza di Roma... lastricate, indistruttibili, sopraelevate lontano dal fango, capaci di far passare le legioni anche d'inverno, anche sulle montagne... le legioni andavano avanti disboscando e costruendo la strada della loro stessa avanzata... una macchina micidiale... Quei fanti erano dei mostri, con trenta chili sulle spalle erano capaci di tutto". L'Italia ci aspetta, oltre l'Appennino. 26 Laddove si scopre che i Romani furono alfieri della razza bianca e Annibale lascia tracce ovunque nei nomi Dentro al mistero dell'Appennino dove il gran Generale perse un occhio È fatta. Si va per l'Appennino. Il superesperto professor Giovanni Brizzi, dopo una cena memorabile a base di lasagne, lambrusco, bolliti in salsa verde e quantità impressionanti di aneddoti conditi di latinorum, ha accettato di imbarcarsi nell'avventura annibalica non prima di avermi solennemente nominato "Viator", il viaggiatore. Starà con me ‐ ha promesso ‐ almeno fino a Canne, per narrarmi la strage più spaventosa del mondo antico: sessantamila morti in un giorno, il macello applicato per la prima volta agli umani. Canne, il capolavoro tattico che ha incantato generazioni di allievi alle scuole di guerra. Aspettando la partenza sulle orme del Nostro, vago nel labirinto universitario bolognese; un arcipelago di scalette interne, cunicoli, porte sbarrate, pareti di libri, ballatoi, muri trompe‐l'oeil, studenti prigionieri di stanzette senza finestre. Come nella biblioteca del monastero dove Eco ambienta "Il nome della rosa", anche nel dipartimento di storia antica si fanno scoperte intriganti. Sugli scaffali di una sala di lettura trovo per esempio la "Storia di Roma" in trenta volumi voluta da Mussolini negli anni della conquista d'Etiopia. Mi siedo accanto a una studentessa giapponese tutta concentrata a ticchettare sul suo computer, e apro il primo volume. Intestazione maiuscola: "ISTITVTO DI STVDI ROMANI", con fastidiose V al posto delle U. Le consonanti, è chiaro, erano più maschie delle vocali. Segue foto del Duce abbronzato, con inusuale giacca e cravatta, sguardo diagonale sinistro, vagamente mistico, rivolto a chissadove. Vergata a mano, la dedica: "Al camerata prof. Carlo Galassi‐Patuzzi, all'inizio della finalmente romana e italiana storia di Roma, con fervido sincero augurio. Roma, 9 febbraio XIII, Mussolini". Due pagine dopo, fortificato dal viatico, il suddetto Galazzi‐Patuzzi dilaga. "... un popolo che nel nome di Roma è rinato ad unità e potenza...", popolo "posto alla testa della civiltà europea dalla 27 rivoluzione fascista" e che "sotto la guida di un condottiero romano ha infranta la coalizione di 52 stati e fondato un impero...". È un crescendo di vanagloria privo di senso del ridicolo, lontanissimo dalla brevità romana e dalla modestia della Repubblica. Doveva essere un affarone ‐ penso ‐ insegnare storia romana ai tempi del Fascio. Potevi prostrarti al regime fingendo di ammirare Roma. Leggo avanti: "Roma ha sempre esercitata una missione normalizzatrice nei confronti della razza bianca..." Falso! Prevedibile e falso. Roma fu aperta a tutti i popoli della Terra. Ebbe imperatori spagnoli, africani, dalmati, asiatici. "Roma, fonte di una civiltà cristiana che si diffonde in tutto l'orbe". Falso anche questo! Il cristianesimo diede a Roma il colpo di grazia. Distrusse il Pantheon politeista che consentiva ai diversi popoli di essere rappresentati con pari dignità. I trenta volumazzi fascisti ‐ ora mi appare chiaro ‐ vennero messi in cantiere per sdoganare le leggi razziali e suggellare l'alleanza col Vaticano. Le premesse dell'antisemitismo, poi, c'erano tutte. Proprio in quegli anni usciva sugli schermi "Scipione l'africano", dove Annibale è il prototipo dell'infido levantino, grasso, ributtante, con un occhio solo. Macellaio di popoli, traditore dei patti, sleale tessitore di inganni. Tutto quadra: i fenici parenti degli ebrei, dunque razza inferiore. Figurarsi i cartaginesi, fenici imbastarditi con gli africani. In cima a una scaletta di ferro da sommergibili, sbuco in un altro recesso accademico, popolato stavolta di sole donne, nel numero fatidico di tre. E' lì che Patrizia Tabaroni, sapiente sacerdotessa di cose antiche, m'illumina sulla leggenda dell'uomo nero, aprendomi una mappa dell'Appennino Tosco‐emiliano dove il nome di Annibale ‐ segnato in rosso ‐ punteggia come la scarlattina valli e fiumi oltre ogni limite dell'immaginazione, radiografando dal Po in giù un'epidemia toponomastica che non ha eguali rispetto agli altri Grandi della storia. Casteggio: fontana di Annibale. Modigliana: pozzo di Annibale. Due ponti d'Annibale sull'Arno e due sul Sieve. Un canto d'Annibale nel Mugello. Un monte Annibolina verso le spiagge di Rimini. Una singolar, polarissima tenzone medievale a Faenza, chiamata "palio del Niballo". Pievepelago passa ogni limite: passo di Annibale, ponte d'Annibale, via d'Annibale, campi d'Annibale. Poi un paese di nome Magona (da Magone, si dice, il fratello minore di Annibale), una frazione di nome Tàrtago e un'altra di nome Zerba, fantasticamente attribuite a Cartago e Djerba dai valligiani piacentini. Pazzesco. In Emilia e Toscana il Nostro è rimasto pochissimo ‐ le ha tagliate in fretta nella sua Blitzkrieg ‐ eppure il suo nome è ovunque. Perché? Cosa accadrà verso Sud, dove lui è stato per quattordici anni? Come sulle Alpi, dove almeno venti passi si contendono la palma dell'attraversamento, anche in Appennino tutti vorrebbero far passare Annibale da casa loro. Ma mentre sulle Alpi la memoria si sorregge più su dibattiti accademici, qui essa affonda nell'immaginario ‐ nel subconscio quasi ‐ della nazione. Entra nella carne del Paese. Annibale è il Gramling, l'uomo nero nelle fiabe per bambini. 28 "Se c'è fosco mistero in un luogo, Annibale viene invocati a dargli un senso", sussurra Patrizia nella penombra del suo "sancta sanctorum". Annibale è la risposta perfetta agli enigmi. C'è un vecchio ponte medievale? Invece di chiamarlo ponte del diavolo lo chiamano ponte d'Annibale. Esiste una località di nome Sanguineto? Deve averci combattuto Annibale... Si scopre un altare votivo con punte di freccia sulla cima del Falterona? Roba cartaginese di certo. L'osso di un mastodonte? E' uno dei suoi quaranta elefanti. Uno scheletro nel sotterraneo di casa? Un soldato sbandato della guerra punica. Non c'è una delle valli da Piacenza a Cesena che non rivendichi il blasone del transito illustre. Liti furibonde sul tema avrebbero diviso persino i sapienti dell'illustrissima Accademia degli Incamminati. Giogo della Scarperia! Ma no, non esiste, il posto giusto è il Sasso di San Zenobio. La Futa! Fu sicuramente la Futa! Macché Futa, a quei tempi la strada migliore per l'Arno era il valico di Porta Collina, poco oltre Porretta. Niente affatto, giurano alcuni: la strada è Forlì, Meldola, passo del Muraglione. No, no e poi no, giurano altri, Lui è passato per Castel dell'Alpi. Oppure in Val Lamone. "Né la freddura poté far riparo / con la gran neve al giogo d'Appennino, / benché il passar assai li costò caro; / né fu tal ventura né 'l distino / di Flaminio mio e dè compagni / che potesson por fine al suo cammino". Così Fazio degli Uberti descrive nel Trecento il passaggio dall'Emilia alla valle dell'Arno. Un viaggio disastroso: bufere di neve peggio che sulle Alpi, paludi, morte di tutti gli elefanti. Il Nostro perderà anche un occhio, per un'oftalmia mal curata, e da allora resterà per tutti "il losco". Petrarca ci costruirà rime un po' scontate, scrivendo del "gran Cartaginese" che "l'un occhio avea lasciato in mio paese, / stagnando al freddo tempo al fiume tosco, / sì ch'egli era a vederlo strano arnese / sopra un grande elefante un duce losco". Un grande elefante. L'ultimo, secondo la leggenda. L'unico di razza indiana. Il leggendario "Saurus", che portò Annibale verso Firenze durante la malattia, e che Plinio definisce "il più valoroso di tutte le guerre puniche". Guidando verso Firenze, penso che forse anche Saurus morì nel pantano dell'Arno, sotto la pioggia, prima della battaglia del Trasimeno. Maledetto Arno. Di tutti gli spostamenti annibalici, quello fu il più penoso. Peggio dei Pirenei e persino delle Alpi. Quattro giorni di cammino ininterrotto nel fango, senza riposare un attimo. Polibio scrive che "delle bestie da soma la maggior parte, cadendo in mezzo alla melma, moriva lì, recando agli uomini, nel cadere, un solo vantaggio: sedendosi su di esse e sui bagagli ammucchiati, essi restavano al di sopra del pelo d'acqua, e in tal modo dormivano per una piccola parte della notte". Ma il "Losco" va avanti, anche con un occhio solo ci vede benissimo, ha capito che dopo lo choc della Trebbia Roma è nel panico, vive ‐ azzarda Brizzi ‐ una sindrome "da 11 settembre". Studia il terreno, sa che uno dei due consoli, Flaminio, è accampato ai bordi dell'Arno, e con una mossa ardita lo supera in direzione di Roma, saccheggiando le campagne per "suscitare la rabbia dei nemici". Sa che da quel momento l'avversario sarà costretto a inseguire, per non perdere la faccia davanti al Senato e ai suoi stessi soldati. Cosa che puntualmente avviene. 29 La scarpata che scende sul Trasimeno. Il malpasso che inghiottì le legioni romane attirate con l'astuzia dal generale La tomba del console un fantasma senza testa Una battaglia tra romani ed esercito di Annibale in un'antica stampa DOPO aver rifatto per l'ennesima volta quel brutto sogno, il conte Teodorico Moretti Costanzi, luminare di filosofia teoretica all'università di Bologna, decise di fare qualcosa. Arpionò Giancarlo Susini, allora giovane assistente di storia romana, e gli ordinò di passare qualche giorno nella sua villa sul Trasimeno, dove abitava la fonte dei suoi incubi. Perplesso, questi accettò, ben sapendo di non potersi negare a un principe del senato accademico. Quando arrivarono al palazzo del Capra, nobile costruzione in arenaria con cipressi poco fuori il paese di Tuoro, il conte mostrò il ritratto di una giovane antenata del sedicesimo secolo, uccisa ‐ si vociferava ‐ per una questione rusticana. Costei, disse, gli appariva di notte e gli sussurrava: "Teodoricooo, le mie ossa non trovano requie... sono sepolte fra ceneri di infedeli... Mi troverai nel viale, sotto il terzo cipresso. Vieni... aiutami a riposare in pace". Ci aveva provato, il conte, a scavare sotto quell'albero, ma non aveva trovato niente. Solo il giovane Susini avrebbe potuto risolvere l'enigma, per amore o per forza. E Susini venne; perse il sonno, deambulò col sole e con la luna nel viale dei cipressi, finché capì. L'albero dove si era cercato non era quello giusto. Era il quarto, perché il terzo era stato tagliato molti anni prima. Lo spazio vuoto c'era ancora: lì bisognava scavare. E lì, infine, si scavò. La trovarono subito. Uno scheletro di donna con una croce d'argento, in mezzo alle ceneri di migliaia di maschi di epoca romana. Non ci volle molto a capire che erano i morti del Trasimeno. Dopo la battaglia Annibale vittorioso aveva fatto costruire un "Ustrinum", una camera di combustione, per cremare una parte dei ventimila caduti della seconda battaglia campale fra Roma e Cartagine. Venne il prete, vennero i Carabinieri col magistrato, la dama infelice fu esumata e nuovamente sepolta in terra consacrata, con tutti gli onori, davanti alla famiglia Moretti Costanzi. Invece per le ossa dei romani uccisi cominciò, come vedremo, un tempo senza pace. 30 "Ecco qui" fa Giovanni Brizzi, l'esperto annibalico che m'accompagna in viaggio, e s'accuccia alla base di una scarpata erbosa, presso una porticina simile a un forno di pizzeria. A vedere ciò che resta della fossa cinquant'anni dopo la scoperta, sono venuti Ermanno Gambini, specialista di geografia storica, e Lorenzo Borgia, assessore alla cultura del Comune di Tuoro. C'è pure il custode della villa, serissimo in canottiera, col mazzone di chiavi alla cintura. Intorno, ulivi contorti, quasi squartati, come mezzene di bue. Cinque‐sei metri più in alto, in mezzo alle cicale, come sospeso in una luce bianca acciecante, l'imbocco della voragine cilindrica della fornace. Guardiamo dentro: le ceneri dei caduti non ci sono più. "Le hanno portate a Firenze ‐ mi spiegano ‐ ma si teme che siano sparite dopo l'alluvione, che devastò gli scantinati della soprintendenza". Non so interpretare l'evento. Morti insepolti? Ombre dannate per sempre? Ma forse no: dopo il fuoco era semplicemente arrivata l'acqua purificatrice, come il Gange a Benares sui resti degli indù. Pian di Marte "Chissà se tra quelle ceneri c'era anche Flaminio...", chiedo a Brizzi. Flaminio era il console caduto nell'imboscata, ucciso in combattimento da un guerriero insubro partito a testa bassa contro di lui. "Anche il conte Moretti Costanzi voleva che questa fosse la tomba di Flaminio, ma così non era... Il console del Trasimeno resta il grande assente fra noi. E' un fantasma che vaga, come quello di Harry Potter... Ma per capire è giusto che andiamo a vedere cosa accadde sul lago". Zanzare, canneti, aria di temporale, una scarpata che scende sul Trasimeno. Eccolo il malpasso che inghiottì le legioni. E' l'unico punto dove strada, ferrovia, superstrada e pista ciclabile si imbottigliano in uno spazio di pochi metri. Lo guardi e pensi: solo un idiota poteva cacciarsi lì dentro. Ma Flaminio lo fece. Perché? "Semplice ‐ risponde Brizzi ‐ i romani ritenevano che le battaglie campali non dovessero comportare trucchi. Le regole d'ingaggio dovevano essere trasparenti. Ci si schierava in campo aperto e ci si confrontava". E Annibale? "Annibale è cartaginese ed è intriso di cultura greca. L'astuzia, per lui, fa parte della guerra. Quando sulla Trebbia ordina al fratello Magone di acquattarsi in una valletta con i suoi cavalieri, gli dice: vai tranquillo, Romani nihil ad hoc genus belli adsueti... i Romani non sono abituati a questo tipo di guerra...". 31 Ma il corpo del console? "Ci ho messo anni a scoprire cosa accadde. Sapevo solo che l'insubro l'aveva ucciso per vendicare i suoi morti, e il saccheggio delle sue terre da parte dello stesso Flaminio in terra lombarda" Ci fermiamo a bordo lago. Un treno passa sferragliando, il rombo della superstrada aumenta, una ragazza urla tra i canneti. "Ho trovato un passo di Livio che spiega tutto. Un flash back del Trasimeno, ambientato anni dopo. Annibale è scontento dei suoi soldati, sfiancati dagli ozi di Capua, e si lamenta: Ubi ille miles meus est, qui derepto ex equo Caio Flaminio consuli caput abstulit? Dov'è finito quel mio soldato che fece cadere da cavallo il console e gli tagliò la testa?". Ecco perché Flaminio vagava senza pace. Era un fantasma senza testa, come Carlo primo d'Inghilterra. Tuoro è un paese segnato da una gran vista e una querula atmosfera papalina. Dappertutto, la Gran Memoria. Hannibal Café, agriturismo Annibale, centro di documentazione Annibale. Il Comune ci dà dentro alla grande: visite guidate, esposizioni, convegni. In un'osteria ci dicono: "Se cercate ossa di cartaginesi, andate al poggio di Pian di Marte. C'è una chiesa sconsacrata, e la cripta ne è piena... Le hanno trovate pochi anni fa". Il Trasimeno è pieno di misteri. Li trovi narrati nelle cronache di un certo abate Liverani; raccolti nella "Wunderkammer" dell'abbazia di Farneta, la stanza delle meraviglie riesumate dal defunto priore; persino evocati dai fuochi di San Giovanni accessi fino a cinquant'anni fa sul luogo della battaglia. Alessandro 32 Pian di Marte, che bel nome di guerra. Come Sanguineto, poco lontano. O la fonte d'argento, detta anche di Annibale, sulla strada per Roma. Oppure la Casa delle Vedove, dove la tradizione vuole che che si trovassero le mogli dei legionari caduti. "Vox populi" ce n'è quanta se ne vuole sulla sconfitta del Trasimeno. A Pian di Marte, dicono in paese, si sarebbe rifugiata una parte della cavalleria romana, ma il generale Maharbal avrebbe costretto alla resa i fuggitivi e annientato i rinforzi guidati da Gneo Servilio. Il posto è fantastico, fuori dal mondo. Una grande locanda, una stalla resa abitabile e la chiesa di San Cristoforo, col tetto appena rifatto e, sotto, un altare con le insegne dei Cavalieri di Malta. Alessandro, proprietario del luogo, è un tipo trimalcionico con un testone riccioluto così straordinario che se avesse accanto un grappolo d'uva sarebbe Bacco perfetto. Ci accompagna a vedere le ossa, apre una botola di legno sul pavimento della chiesa, ingombra di attrezzi destinati al restauro, e con una torcia illumina lunghi femori nel buio. "Non avvicinatevi troppo, là sotto l'aria è mefitica", avverte. "Sono ossa gigantesche, le abbiamo misurate con una microcamera; appartengono a uomini di due metri. Quando li abbiamo trovati, la gente ha subito detto: sono cartaginesi. Ma io non ci credo affatto. Questa chiesa è costruita su ruderi precedenti, sta su una piccola necropoli. Quando il posto era abbandonato, veniva gente a fare messe nere. I pastori qui intorno hanno visto i fuochi da lontano". Il profumo della cena ci richiama imperiosamente al mondo dei vivi: rigatoni alla pagliata, scottiglia mista di carni, crostata all'amarena, vino Ciliegiolo di Narni. Ce la scodella Angela, la bionda compagna di Bacco, che Brizzi identifica subito nel "perfetto archetipo di Flora", la dea della natura che segue le tre grazie nella Primavera di Botticelli. Dormiremo qui. Intorno lucciole e stelle, lampi lontani, ombre nere di colli, nebbie azzurrine negli avallamenti. Nessuna luce. La foresta risuona come un'Arca di Noè. Rane, grilli, pecore, voci di pastori. Su tutto, il richiamo dell'assiolo, regolare come un "S. o. s.". 33 Dove il Nostro devasta le campagne più vicine all'accampamento di Fabio per sottolinearne l'impotenza Le Termopili d'Italia poco oltre le Forche Caudine MANDRIE di bufale, caldo turco, aria di tempesta che scende dal Sannio, il Volturno che va come un serpente ubriaco. Stiamo facendo una cosa da pazzi: seguiamo un'ombra di duemila anni fa, ignorando il presente. Piloni in cemento, caselli autostradali, tralicci ad alta tensione: tutto cancellato. L'Appennino è ridotto alla sua nudità primordiale e l'umanità ne emerge con l'aura del mito. Da quando abbiamo lasciato il Trasimeno, è come se avessimo la febbre. Dal parabrezza vediamo eburnee gigantesse africane in agguato, accanto a roghi violetti nella sterpaglia, ombre di nere proserpine confabulanti nei villaggi, torvi sanniti al pascolo sulle praterie, baccanti italiote dagli occhi da lupa che si svegliano al tramonto. Sul sedile del passeggero, il professor Giovanni Brizzi ‐ l'uomo che volle essere Annibale ‐ ormai fiuta l'Ager Campanus come un bravo cane da punta. Dopo la batosta del Trasimeno è successo di tutto. Roma è nel panico, Annibale potrebbe assediarla, ma di nuovo spiazza tutti, snobba la preda, allunga il passo, punta sull'Adriatico e le ricche terre dei Piceni. Forse cerca di mostrare all'avversario di poter fare ciò che vuole, per attirarlo in nuove trappole. Pascola i suoi uomini nell'Italia felix, li rinvigorisce, mostra il paradiso conquistato, scende verso la Puglia, fa il pieno di vino e olio, poi ‐ non contento ‐ traversa l'Appennino in diagonale e piomba sulla Campania verdeggiante di messi, a far razzia di buoi sotto il naso dei Romani. L'anno 217 per lui è una pacchia colossale. "Nunc est bibendum". E' ora di bere, annuncia Brizzi nella canicola, alla vista di un bar. 34 Cerco di rispondere a tono: "Appropinquiamoci". Il latino è entrato in noi, dunque "appropinquarsi" è meglio di "avvicinarsi". Abbiamo un lessico nuovo. "Age", per dire sbrigati, muovi le chiappe. "Sursum", alziamoci. E poi "Pedibus calcantibus", di goliardica memoria. Spunta anche il greco: "Veneri callipigie", per segnalare donne dalle rotondità ragguardevoli. Dopo Cassino, il paesaggio gronda storia già dai nomi. Cerreto Sannita e Gioia sannitica, Sant'Agata dei Goti, Forche Caudine, Cuma della Sibilla, Taburno Camposauro, Casagiove, Guardia Sanframondi, Piedimonte Matese, e anche quel benedetto Teano dove re Vittorio fermò Garibaldi. E' come sfogliare le pagine gialle del tempo. C'è di tutto, da Romolo al Risorgimento. ... Se dalla Casilina pieghi per la S 372 in direzione di Benevento, subito trovi alla tua sinistra una montagnola con sotto il paese di Pietravairano. Gli aerei per Napoli le passano sopra prima di virare alle falde del Vesuvio. Il Volturno le sta un po' dietro, nascosto da una barriera di altre collinette che sbucano come isolotti dalla pianura. Tra un'altura e l'altra vedi aprirsi gole profonde ‐ tante piccole Termopili ‐ che la natura stessa ha messo a guardia della terra più fertile d'Italia. La nostra altura è la prima della serie e il suo nome è Callicula. Il luogo dove, un anno prima di Canne, Annibale compie il suo capolavoro. Succede che il Nostro saccheggia la Campania, mentre Fabio Massimo ‐ il comandante in capo soprannominato Temporeggiatore ‐ lo segue dalle alture senza mai farsi sotto. Il Cartaginese sa dai suoi servizi segreti che il Romano è criticato per la sua prudenza, e si muove con astuzia luciferina. Devasta le campagne più vicine all'accampamento di Fabio per sottolinearne l'impotenza e suscitarne la rabbia. Sceglie i luoghi per la loro visibilità scenografica più che per la loro importanza strategica. Vuole essere visto, fa della Campania il suo palcoscenico. E' furbo come il diavolo: rapina ogni luogo tranne i poderi campani dello stesso Fabio, per far credere al Senato di essere in combutta con lui. Un giorno passa il limite della sfrontatezza. Il Romano ha messo il campo sulla cima del colle di Callicula, e lui gli si mette sotto, a poche miglia. Si sente così sicuro che non gli importa nemmeno 35 di essere in trappola, circondato di montagne. Fabio capisce che è il momento di attaccare, blocca tutte le uscite dalla conca, ma Annibale non gli dà il tempo di agire. Fa radunare duemila buoi e fa legare torce alle loro corna. Quando arriva il buio, le accende e fa spingere la mandria verso la collina. I romani pensano che i cartaginesi li attacchino, sguarniscono le gole e salgono a combattere. Ma quando si accorgono del trucco, Lui è già passato con l'esercito per la strettoia. La sera scende sulla conca di Teano, con un odore ubriacante di terra fertile. Come allora, mandrie al pascolo. Vediamo tutto, leggendo Plutarco. "Le vacche, finché il fuoco era scarso e bruciava solo i sarmenti, avanzarono tranquillamente lasciandosi sospingere verso i piedi del monte; le fiamme che risplendevano sull'estremità delle corna ... e ... sembrò che un esercito marciasse in file ordinate alla luce di molte torce; ma quando il fuoco, bruciate le corna fino alle radici, si appiccò alle carni, gli animali sconvolti dal dolore ... si precipitarono di corsa verso i monti, tutti una vampa dalla cima della testa all'estremità della coda, incendiando gran parte dei boschi attraverso i quali fuggivano". Annotta. Lontano, piccoli incendi verso il Volturno. Odore acre della pianura attorno a Capua. Brizzi continua. "Fu questo uno spettacolo terrificante per i Romani di guardia ai valichi; infatti le fiamme parevano fiaccole portate qua e là da uomini in corsa; grandi furono la confusione e il panico perché credettero che il nemico li attaccasse da un lato e dall'altro e li circondasse da ogni parte. Non osarono quindi resistere al loro posto, ma si ritirarono verso il grosso dell'esercito, abbandonando le gole". A distanza, nell'ultima luce, oltre le Termopili campane, bianche contro il cielo nero, lente come i mulini a vento di Don Chisciotte, pale eoliche ruotano sulla sommità dei colli. ... La Campania profonda è terra di agguati, e la sera talvolta ti prendono oscuri presentimenti. "Castel Morrone Termopili d'Italia" ammonisce un cartello a monte di Caserta, in un labirinto di montagnole infestate di ginestre. Sotto i ruderi di Castello Limàtola, forte sannitico poi longobardo e poi angioino, finiamo in un terrificante fondo cieco. Poco oltre, eccoti le Forche Caudine, dove i Sanniti ‐ gli eterni sconfitti ‐ attirarono le legioni in una tremenda imboscata cent'anni prima di Annibale. A Sud i "passi" scompaiono; sui monti esistono solo "selle" e "forche", dall'etimo più trasparente. Tra Dugenta e Caserta (strada per Telese) ci fermiamo sotto un grandioso acquedotto borbonico, costruito dal Vanvitelli sulla traccia di un acquedotto romano preesistente. Sotto un'arcata, una femmina di cane‐lupo abbandonata ci viene incontro, esausta, scodinzolando come per dire "Non fatemi del male" e "Non abbiate paura di me". Gli animali abitatori di antichità e rovine si caricano spesso di simboli, e questa cagna ci porta via l'anima. E' troppo smunta per essere la lupa di Roma. E' semmai il monumento a una maternità dimenticata. Le lasciamo i panini, mentre loschi figuri parcheggiati lì accanto ci guardano come fossimo pazzi. 36 Vaghiamo sotto le stelle fino all'eremo fortificato di Sant'Angelo di Palombara, alto su un promontorio di roccia, raggiunto dopo una strada piena di trappole, buche, strettoie, bivi senza segnaletica e ingannevoli fondi ciechi. Da quassù, l'Agro Campano è visibile come in nessun altro luogo, demenziale ingorgo di umani, bufale, strade e industrie. Sopra, l'Orsa Maggiore. Davanti, un nero cancello sbarrato, un nero Cristo in ferro. Siamo sul ponte di comando di una nave solitaria. Sulla nostra destra, lontano, la strada per Benevento. A sinistra quella per Avellino e l'irsuta Irpinia. "Secondo te siamo pazzi?" chiedo al compagno. Hannibal risponde dal buio: "Tutto questo è magnifico". Poi aggiunge: "Se si insegue un mito è normale smarrirsi". Nell'aria c'è un forte odore di assenzio. "Ma oggi ‐ dico ‐ il mito non c'è più. Nessuno lo cerca". "La morte del mito è la cosa più oscena dell'oggi. E' la fine dell'incantamento, dell'immaginazione, del desiderio". Verso Capua, davanti alla Luna, nubi in corsa come un incendio azzurro. "Senza quella cosa l'uomo si perde, diventa un grande invalido. E perciò andiamo, siamo sulla strada giusta". 37 Il ricordo di morti insepolti e divorati da cani, l'epitaffio della bella morte omerica, quella dei corpi profumati L'inferno di Canne, la strage e l'epifania di una morte sconcia VENTO e praterie. Lontano, lo scintillio dell'Ofanto e la striscia del mare davanti al Gargano. Non vedo che questo, mentre risaliamo a piedi la vecchia ferrovia Barletta‐Canosa‐Minervino. Nient'altro che vento, cicale, e il nostro "paso doble" sulle traversine. E poi ancora silenzio, ulivi, filari di vigne come eserciti, sudore, respiro pesante, sete. Intorno, solitarie masserie dai nomi incompatibili col sole libico che ci sovrasta: Maltempo, Epitaffio, Lamacupa. Canne va raggiunta così, controvento, lontano dalle grandi strade, col sole di mezza estate allo zenith, nella controra quando l'ombra è pesante, i fantasmi escono come a mezzanotte, e i trapassati ‐ come temeva Pitagora ‐ si arrampicano per le radici delle fave. Caldo tremendo: come quel 2 agosto 186 avanti Cristo, quando in un pomeriggio il generale Annibale distrusse otto legioni. "Guardati da questa bellezza" esala esausto Giovanni Brizzi. Non è solo la sete che gli abbassa la voce; è l'emozione. Della battaglia sa tutto, ma per lui ogni volta è come la prima. Ci sediamo nel cono d'ombra della stazioncina "Canne della Battaglia", magnifica nel suo rosso pompeiano d'ordinanza. Sopra di noi rotea un falco. Il luogo dell'ecatombe è davanti a noi, chiuso fra la vecchia linea e una barriera di colli sui sessanta metri. Basta salire di poco verso il Monte San Mercurio e subito pare di affacciarsi su un'incommensurabile nulla, una voragine di luce che inghiotte ogni cosa e ti spara in una dimensione senza tempo. Siamo sul luogo dove la morte in battaglia raggiunse dimensioni inimmaginabili. Un evento fuori scala. Sessantamila morti fanno seicento cataste di cento corpi ciascuna. Il doppio di Austerlitz. Più dei caduti americani in anni di guerra in Vietnam. E' la più orrenda strage del mondo antico, l'epifania di una morte sconcia, deturpante. Una morte "moderna"; la stessa che Remarque racconta nella Grande Guerra. A Canne si celebra l'epitaffio del duello omerico, quello che finisce con i corpi lavati e profumati da consegnare all'eternità. Brizzi: "La battaglia di Cheronea fu un trauma per i Greci, ed ebbe quattromila caduti. Al confronto, Canne è l'inferno". Leggiamo da Tito Livio cosa si vide il mattino dopo. "Alcuni, cui le ferite morse dal freddo avevano 38 fatto riprendere i sensi, nell'atto di alzarsi in piedi coperti di sangue furono annientati dal nemico... Altri erano distesi a terra anche se vivi, poiché avevano i femori e i garretti tagliati, scoprivano la nuca e la gola e invitavano i nemici a bere il sangue che rimaneva loro... Certuni furono trovati con le teste affondate in buche, ed era chiaro che da soli se l'erano scavate e che, seppellendo i volti, col gettarvi sopra la terra si erano soffocati". Ma l'immagine più atroce è un'altra. La leggano, quelli che credono alla bellezza della guerra. "Attrasse l'attenzione di tutti un Numida ancor vivo, tratto col naso e gli orecchi mozzati di sotto a un Romano che gli si era steso sopra morto; questo, non servendogli più le mani per afferrare un'arma, aveva trasformato in rabbia la sua ira ed era spirato straziando con i denti il nemico". Canne è il macello di una classe dirigente che vuole combattere in prima linea, la morte di tre consoli ed ex consoli, di otto questori, quaranta tribuni, ottanta senatori. Il fratello minore di Annibale, Magone, portò a Cartagine tre canestri di anelli, tolti dalle dita degli "equites" in quella sola battaglia. Canne è morti insepolti, divorati dai cani e spogliati delle loro armature; è gambe sgarrettate dal colpo di gladio dei cavalleggeri spagnoli; è "Detruncata corpora", ferite che "ultra mortem patebant"; è agonia di settimane per infezione e setticemia senza un medico o un'infermiere sul campo. Non c'è la Croce Rossa a quei tempi; Canne è anche scannamento dei sopravvissuti, all'alba del giorno dopo, Un'ammucchiata sanguinolenta di vivi e morti. Dalla cima del monte uno guarda la piana accanto alla ferrovia e dice: impossibile. E' lo spazio di uno stadio. Invece no: a Canne tutto avviene davvero nello spazio di uno stadio. O meglio, di una tonnara. Avviene con la tecnica e i tempi di una tonnara. Per capire, devi averne visto una, con il mare che ribolle, le vittime che si ostacolano a vicenda e gli uomini come posseduti che cantano "alamoa alamoa, janzù janzù", lanciano colpi d'arpione alla cieca. Penso: ma la tonnara non è una pesca rituale inventata dai fenici e dai cartaginesi? Perché in tutte le altre battaglie, i morti sono dispersi su una scia, e invece qui sono concentrati in un fazzoletto di 39 terra? Sessantamila caduti in un fazzoletto. Perché i Romani non si mossero di un pollice e si lasciarono massacrare? Fa caldo da bestie, non è facile ragionare sotto un sole che accieca. Con un bastoncino Brizzi traccia segni nella ghiaia, parla di "superamento della falange macedone di Alessandro Magno", di nascita della "manovra avvolgente", di valorizzazione della cavalleria contro una legione basata sulla fanteria pesante. Ma di tutto, sotto il sole di Canne, capisco una cosa soltanto. Tre parole. "Annibale‐vinse‐arretrando". Vedo sulla ghiaia il fronte cartaginese convesso che si lascia investire, diventa concavo, poi si richiude, finché le cavallerie alle ali sigillano lo spazio rimanente, formando una camera della morte imperforabile come quella di una tonnara. Ma ancora non basta, dico. I Romani erano novantamila, buon dio, più del doppio del nemico. Come poterono soccombere? "Il numero eccessivo fu il limite. Combatterono in novantamila nello spazio in cui erano abituati a combattere in quarantamila. Si ostacolarono a vicenda e non riuscirono a reagire". Non basta ancora... "La cavalleria romana era inferiore e i fanti erano quasi tutti reclute, dopo le stragi sulla Trebbia e sul Trasimeno". Ma l'organizzazione romana era comunque una macchina mortale... "Però i due consoli erano in disaccordo tra loro, e la tecnica del comando a giorni alterni giocava a favore di Annibale". La tonnara, la maledizione della tonnara... Forse Annibale non fece che applicare su terra le tecniche secolari di una civiltà di mare... "Ti rispondo con Polibio: dopo Canne 'risultò evidente ai posteri che in tempo di guerra è meglio avere la metà dei fanti rispetto ai nemici e un'assoluta superiorità in cavalleria, piuttosto che affrontare la battaglia con le forze più o meno uguali a quelle dei nemici'. Canne cambiò la storia della strategia". Beviamo limonata fresca sulla terrazza del museo, ascoltando il rumore del trenino per Barletta che taglia la campagna. Manifesti dell'associazione "Pro Canne" annunciano escursioni e ricostruzioni storiche sul campo. Ci ha raggiunto Vincenza Morizio, professoressa di storia romana all'università di Foggia, e discutiamo della suggestione ipnotica del luogo, di questo maledetti campi della morte che sono spesso di una bellezza sconvolgente. Mi tormenta un dubbio. E se i generali avessero scelto questi luoghi non solo per motivi strategici, ma anche per costruire una cornice mitologica "indimenticabile"? Se così non fosse, come mai il campo di Waterloo riesce a emanare una pace arcadica anche sotto la pioggia? Non si spiega, 40 altrimenti, come mai Gettysburg, dove gli americani ebbero nella guerra civile più morti che in Giappone o in Normandia, sia un idillio assoluto. Per non dire del mare di Lepanto, fra Itaca e Patrasso: divino spazio blu di quiete e maestrale. E se fosse solo suggestione? E se Canne fosse altrove? Nel museo vedo che nella vallata si è trovato poco o niente che confermi l'ecatombe. Ma qui sono tutti d'accordo. Delle grandi battaglie non rimane mai nulla. Già di Waterloo non si trova più nulla. I corpi vengono spogliati di tutto ciò che serve, i contadini fanno il resto. Proprio la battaglia di Canne lo dimostra: i fanti libici si presentano, terribili, davanti alle legioni, indossando le armi tolte ai romani uccisi nella battaglia del Trasimeno. Mostrano al nemico la sua stessa morte. E poi, qui o altrove fa poca differenza. "Canne è un luogo della mente" ammette la Morizio che proprio lì ha imparato ad amare la storia antica. "Ricordo il generale Ludovico che illustrava la battaglia ai bambini delle elementari, rumorosissimi, poi questi scappavano fuori a mangiare fave, ma alla fine, davanti alla valle, si fermava il respiro anche nel loro petto di mocciosi". 41 Dell'eterna questione del cambio di strategia E di quando Maharbal lo esorta a saper approfittare della vittoria La forza, la prudenza e l'acume del grande condottiero NOTTE di levantazzo duro in un albergo di Canosa di Puglia, cittadina abitata dall'ombra terribile di Asdrubale (qui la sua testa venne recapitata al fratello dopo la battaglia del Metauro) e da quella triste del longobardo Boemondo, sepolto in cattedrale. Faccio un brutto sogno: uno spettro gommoso, che vola come un giornale spiegazzato nel vento, si rintana nelle fessure, s' impenna, sparisce di nuovo, poi si riforma come inchiostro di seppia negli avvallamenti. Al mattino, quando vado a chiamare Brizzi per la colazione, lo trovo già pronto come un vigile del fuoco di turno. L'uomo che volle essere Annibale vive in stato d' allerta perenne: sbirciando nella sua stanza, noto che il lenzuolo è perfettamente liscio, come se vi si fosse coricato un uomo senza peso. Tre giorni prima, già la locandiera sul Trasimeno mi aveva avvertito ridendo: "Diavolo, nel tuo letto pare ci abbiano dormito in cinque. In quello del tuo amico nessuno". Normale, penso, per uno vissuto duemila anni fa. Sono un po' suonato: il sole è già alto sugli ulivi e la sera abbiamo tirato tardi a masticar pensieri sulla battaglia delle battaglie. Abbiamo evocato l'ombra di Pirro e dei suoi elefanti, parlato dei favolosi Daunii, divagato su Federico secondo. Ma su tutti noi gravava un'unica, grande domanda. Come mai Annibale non approfittò della vittoria per calarsi direttamente su Roma? Cosa fermò l'uomo della Blitzkrieg? Una certezza o un nero presentimento? Livio racconta quello che accade il mattino dopo lo scontro. "Mentre intorno ad Annibale vincitore tutti i comandanti si rallegrano, cercando di persuaderlo a far riposare le truppe per un giorno e una notte, Maharbal, comandante della cavalleria numidica, ritenendo che non si debba mollare sul più bello, esclama: per capire cosa sia questa battaglia, tra cinque giorni banchetterai in Campidoglio". Die quinto victor in Capitolio epulaberis. "Seguimi ‐ gli dice Maharbal ‐ io ti precederò con la cavalleria, perché i Romani sappiano che sei arrivato prima di sapere che stai per arrivare" Ma Annibale esita, chiede tempo per riflettere sul da farsi. Al che Maharbal gli risponde con una frase immortale: "è chiaro che gli dei non danno tutti gli doni a uno stesso uomo. E tu sai vincere, Annibale, ma non sai approfittare della vittoria". Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis. Questa rinuncia e questo giudizio hanno fatto impazzire generazioni di studiosi di strategia. Il capo della cavalleria aveva ragione o torto? Tutte le battaglie campali della storia si riassumevano in 42 quell'unica domanda. "Maharbal was right" dichiarò vanaglorioso il generale Montgomery, forse equiparandosi al numida, dopo aver vinto senza gran merito a El Alamein. Azzardo: "E se Montgomery avesse ragione?". "Montgomery was wrong!" reagisce Giovanni come punto da una vespa. "Anzi, Montgomery era un cretino". Ecco, succede quello che aspetto dall'inizio del viaggio: l'identificazione totale dello studioso con l'oggetto del suo interesse: Annibale. Ora è il momento. Il bolognese afferra la tazza del caffellatte, la saliera, il barattolo della marmellata, e comincia a spostarli vorticosamente sulla tovaglia per rappresentare i movimenti di truppe. "Cosa fai con quattromila cavalieri sotto le mura di una città? Le evoluzioni? Cosa fai senza fanteria pesante? Avanti, che fai?". Taccio; non so se mi ha preso per Montgomery o Maharbal. "I tuoi imprendibili cavalieri sotto le mura te li massacrano tutti. Roma è blindata, e i Romani son gente tosta, aggrappata a quelle loro zolle. Testardi e tignosi, non molleranno". Come immaginavo, il vaso della marmellata di albicocche e la tazza del caffè si scontrano, fragorosamente. Ora tutta la sala ci guarda. "Roma ha sedici chilometri di mura. Se‐di‐ci‐chi‐lo‐me‐tri... Che facciamo, senza le macchine da guerra con cui prendemmo Sagunto! E poi, come lo controlli il fiume? Il Tevere è navigabile~ Che fai, ci passi in mezzo per farti ammazzare? Dividi l'esercito in due?" Non so replicare. Ha vinto Annibale, dannato lui. Lui fa ciò che è logico: aspetta che Roma si arrenda. Chiunque si arrenderebbe dopo tre disastri campali e centomila morti. Livio riassume in una riga sola le conseguenze della gran rinuncia: "Mora eius diei satis creditur saluti fuisse urbi atque imperio", si crede universalmente che l'indugio di quel giorno abbia salvato Roma e la sua potenza futura. Quel giorno il mondo poteva cambiare e invece non cambiò. Ma Roma non si arrende. Non riconosce nemmeno la sconfitta. Nel panico, reagisce nel solo modo possibile. Dice: match non valido, l'avversario ha barato. Peggio: Annibale non è una persona, è un mostro, un demonio. Il mondo latino, abituato allo scontro leale in campo aperto, non ha altre strade di fronte alla superiorità di un uomo che non ha schemi d' ingaggio trasparenti. Roma arranca, alla ricerca di una risposta all'astuzia e agli agguati, e intanto si muove come l'Occidente contemporaneo di fronte al terrorismo suicida. Parla di "guerra asimmetrica". Condanna, demonizza, rivendica pateticamente la propria innocenza. Fuori si è risvegliato il vento polveroso che scende dal Vulture, il monte di Melfi. Penso che tutto finisce qui, sul Tavoliere inondato di luce: le strade degli eserciti e i destini degli uomini. Finisce qui, con la stessa inevitabilità del corso dell'Ofanto e della discesa degli armenti lungo i tratturi. Ascoltando Brizzi mi rendo conto di essere alla grande svolta della storia. "Nessun altro popolo avrebbe sopportato quello che sopportarono i romani" stava scritto più o meno in una lapide fatta mettere dal Duce sul campo di Canne. Una volta tanto, i fascisti dicevano il vero. 43 Vincenza Morizio, la prof di storia antica che ci ha accompagnato a Canne, svela di aver perso il sonno attorno a questo enigma. E anche lei, come Brizzi, ammette di aver trovato la risposta "immedesimandosi" nella storia, vivendola da dentro come un "insider". "E' straordinario ‐ mormora ‐ Roma ne viene fuori semplicemente negando l'evidenza della sconfitta. Ed è proprio questa consapevolezza cocciuta, quasi ottusa, che rende Annibale, nel pieno della vittoria, oscuramente consapevole della propria sconfitta finale". Davanti a Canosa si stende il granaio d' Italia che nutrì il grande africano. Poco è cambiato. Lontano, su un colle, biancheggia Venosa dove nacque Orazio. Poco in là, il paesotto di Barile popolato di grotte‐cantine, dove Pasolini girò la Passione secondo San Matteo. Vincenza, che di solito è di un'allegria debordante, ora è seria. "Col suo rifiuto ad attaccare Roma, Annibale si svela un grandioso eroe tragico. Ha stravinto, ha umiliato militarmente l'avversario, ha spinto gli alleati a passare dalla sua parte, ma sa di aver mancato il suo obiettivo finale: costringere Roma a trattare. E trovare un'alternativa credibile alla sua rete di alleanze". Autostrada per Bari, vento forte, navi che vanno a Nordovest. Siamo sulla grande linea delle battaglie: Lepanto, Azio, Canne, Mostar, Sarajevo, Vienna. è, anche, la linea che separa Oriente e Occidente nel cuore dell'Europa. Anche Roma si è scontrata con qualcosa di orientale, anzi di "greco": lo stratagemma. è qualcosa che ancora non conosce. In latino, il termine "stratagemma" non esiste. In guerra l'astuzia non è contemplata. Dunque, il callido Annibale è "perfidus", perché è violatore della "fides", cioè la fiducia. Ma Annibale fu davvero un imbroglione, se vinse in campo aperto contro forze superiori? è fondata l'accusa di Roma? Il termine "perfidus" dovrebbe mettere in allarme. La Chiesa l'ha usato per duemila anni contro parenti stretti dei cartaginesi ‐ gli ebrei ‐ e fu un trucco miserabile. Un modo per mascherare il timore, l'invidia, talvolta la rapina. Certo: la forza nobile è del leone, e l'astuzia è della volpe. Ma se una volpe batte un leone, chapeau. Se poi il leone ferito impara gli odiatissimi trucchi della volpe e diventa imbattibile, due volte chapeau. è esattamente ciò che accade dopo Canne. Roma impara gli stratagemmi e se ne serve a man bassa, 44 in modo anche più cinico di Annibale. Diventa orientale ‐ anzi, greca ‐ e così conquista il mondo. L'incredibile è che sia stato proprio Annibale a toglierle ogni freno inibitore. Del fatto che dopo Canne il Nostro non andò subito a farsi sconfiggere a Zama ma restò tredici anni al sud, come recita l'orgoglio "terrone" Noi, figli di Annibale Oggi a Bari succede di tutto nel cielo. Prima un Levantazzo umido e snervante. Poi un risveglio incendiario di Scirocco che trasforma il mare in una prateria di schiume. Verso le tre, dal lato di terra, piomba sulla città un Ghibli desertico e abrasivo, che fa tremare i vetri, entra in ogni fessura, si porta dietro il profumo africano della Numidia e di Cartagine. Ma ecco che verso le cinque tutto si scioglie in un Ponente calmo e regolare, che riempie le prime vele al largo verso le terre degli Illiri e degli Epiroti. E non è finita, perché d'improvviso, verso le nove, il segnavento di tutte le barche in rada si sposta verso Nord a indicar la Tramontana, che invade il lungomare d'una corrente ristoratrice. Siamo inchiodati in Puglia, terra di messi e oscuri presagi. Anche Annibale trovò qui il suo capolinea, in questo tavolato spazzato dai venti che par navigare verso l'Africa, segnato da tre colori, il giallo del grano, il blu del mare e il verde‐grigio metallico degli uliveti. Sarà stato il vento di Puglia, o la polvere mangiata dal Trasimeno fin qui, ma siamo in preda a una grande stanchezza. La corsa è finita, le grandi vittorie anche. Ora la storia cambia marcia. Dopo Canne, ci spiegavano a scuola, Annibale partì dall'Italia per andare a farsi sconfiggere a Zama. Poco o niente ci dicevano dei tredici anni che passò nel Sud ‐ soprattutto in Puglia ‐ prima di imbarcarsi per l'Africa. Non ci quadrava mai troppo, questa seconda parte della storia. "Africa, Africa Africa... / Annibale Annibale gran generale nero / restò in Italia da padrone ... / ecco perché molti italiani hanno la pelle scura / noi siamo figli di Annibale / tutti quanti figli di Annibale / capelli neri... / di pelle scura... / con gli occhi scuri... / sangue mediterraneo... / sangue d'Africa... / Africa, Africa, Africa...". A volte la storia la si riscopre millenni dopo. Come in questa canzone di orgoglio "terrone" cantata dagli "Almanegretta". Al Sud, soltanto al Sud capisci. Tredici anni sono una vita, la misura di un destino. In Puglia si scopre che Annibale è più italiano che africano, vive nella Penisola più tempo che in Africa, la terra da dove è partito a soli nove anni. In Puglia si vede che a Canne non finisce un bel niente, semmai inizia una storia nuova. Annibale non ha navi per partire ‐ Roma è padrona dei mari ‐ ed è prigioniero del luogo. Ma la prigionia è anche la sua forza oscura, perché i suoi mercenari, privati di ogni via di fuga, sono condannati a essergli fedeli e non hanno alternative tra vincere e morire. Per questo egli si attacca come una zecca alla carne del Paese, segnandola nel profondo con una guerra di logoramento e saccheggio le cui conseguenze ‐ come vedremo ‐ saranno visibili anche oggi. La casa di Mara e Antonio Mallardi, alta sul mare, trema come un bastimento nei vortici d'aria. Appesi alle pareti fra una libreria e l'altra, tre violoncelli, un'infinità di carte nautiche, un gran timone di paranza e disegni di scafi a vela. Sopra la scrivania, inchiavardato su tubi Dalmine, un letto sospeso come quello di una nave, dal quale è possibile vedere al tempo stesso i libri e il mare. Questo luogo dell'anima è un approdo fisso, ogni volta che scendo in Puglia. Antonio, conoscitore profondo del Sud, ha fatto di tutto nella vita: il costruttore di barche, il contadino in un kibbutz, il 45 violoncellista accanto a Pablo Casals, l'abitatore di un casello ferroviario, il dirigente del settore vendite della Einaudi, il viaggiatore mediterraneo in compagnia di Fosco Maraini. Stiamo nel salone del biliardo a parlare di questo pazzesco viaggio nel tempo e dare ogni tanto qualche colpo di stecca. Fuori, un torrido splendore che consuma gli occhi, abbaglia specie noi del nord; anche il padano Giovanni Brizzi, l'esperto annibalico che s'è imbarcato con me verso le lucenti terre del Sud. Viviamo l'ora in cui ‐ scrive Norman Douglas in "Old Calabria" ‐ uomini e bestie sono incatenati dal sonno e gli spiriti si aggirano, come a mezzanotte, sotto platani sussurranti. Ed è a quest'ora inquieta, in bilico fra scirocco e maestrale, che rievochiamo le pagine più terribili della seconda guerra punica. Il dopo Canne. Gli anni della paura, delle terra bruciata, delle rappresaglie e degli agguati. Succede, racconta Brizzi, che poco dopo la battaglia, a Nord, in una foresta impenetrabile sacra ai Celti e denominata Selva Litana, poco lontano da Modena, i Galli Boi alleati di Annibale attirano in una trappola il console Postumio Albino e i suoi quindicimila uomini, massacrandoli tutti. Il console viene ucciso, decapitato, la sua testa scarnificata viene placcata in oro e argento per essere trasformata in coppa da vino. Accade, in quella landa della Padania, qualcosa di terribile e soprannaturale: gli alberi stessi partecipano allo scontro, si avventano sui legionari paralizzati dalla paura. Sono, probabilmente, Galli mimetizzati nella brughiera; e sono, anche, alberi segati in modo tale da precipitare al primo contatto e schiantarsi sulla compagine in marcia, spezzandone l'assetto di difesa. E' peggio, molto peggio del Trasimeno, dove i Romani, acciecati dalla nebbia, finiscono in trappola per ansia di combattere. Qui è la stessa situazione della Selva di Teutoburgo, dove Varo andrà a cacciarsi in bocca al nemico in un terreno difficile e inesplorato, per essere sterminato con tutti i suoi uomini dai Germani di re Arminio. Ma è anche, a ben guardare, un'anticipazione del "Macbeth" di Sheakespeare, tragedia di sangue che si conclude con la visione della "foresta che cammina", il bosco vendicatore di Dunsinane in marcia contro il castello del regicida. È lo scenario barbarico degli alberi combattenti, caro al mondo celtico: quello che viene evocato del poema epico bretone "Cad Goddeu", dove i soldati si trasformano in alberi e sconfiggono il nemico dopo aver alzato le loro voci in "quattro toni d'armonia". Ora il vento s'è quietato un po' e nella casa navigante è sceso il silenzio. Le paratie piene di libri, gli oblò verso il mare, i violoncelli, il biliardo e il letto sopra la scrivania hanno smesso di beccheggiare. Siamo arrivati come sull'orlo di una voragine, nel buco nero del racconto: la paura di Roma, il panico che si raggruma attorno al Foro Boario e al Campidoglio e spinge le matrone a spazzare la terra con i capelli. Episodi inspiegabili come la Selva Litana, stragi spaventose come Canne, unite a segni del cielo come grandinate, pestilenze o nascita di bambini deformi innescavano fiammate di superstizione e timor religioso, con appassionati ritorni alla ritualità arcaica. Quella dei sacrifici umani. Cominciò con le vestali, che in tempi come quelli era facile accusare di sacrilegio per lesa verginità. Un "corruptor" lo si trovava sempre, e quello per primo finì al patibolo ‐ Lucius Cantilius si chiamava ‐ flagellato a morte col collo sulla forca, nudo, in pieno comizio. Ma erano le vestali, ci 46 raccontava Vincenza Morizio, la "cartina tornasole della purezza della Res Publica" ed erano soprattutto loro a dover morire. La punizione venne inflitta "con una ritualità cupa": un corteo attraversò la città con la colpevole chiusa dentro un carro, poi la vestale fu chiusa in una stanza sotterranea per morire di fame. Lo Stato non doveva macchiarsi della colpa di uccidere una sacerdotessa: per questo non usava il ferro e, per scaricarsi definitivamente la coscienza, lasciava nella camera della morte appena un po' d'acqua e pochissimo cibo. Era chiaro: si trattava di un sacrificio umano giuridicamente mascherato da condanna ed esecuzione capitale. Due furono le vestali accusate, Opimia e Floronia. La prima fu sepolta secondo il costume presso la porta Collina. La seconda si sottrasse al seppellimento col suicidio. Ma il peggio venne dopo. Nel clima di disfatta militare, un inviato speciale fu spedito a Delfi a consultare l'oracolo degli oracoli. Al suo ritorno, venne riesumata un'antica profezia etrusca, secondo la quale Roma sarebbe stata invasa dai Galli e dai Greci. Ora, poiché le profezie erano di per se stesse vere, dunque inevitabili, si poteva soltanto depistarne l'effetto, facendole avverare in parte, in una situazione, per così dire, "sotto controllo". Galli e Greci avrebbero invaso Roma? E Roma decise di seppellire vivi, in pieno Foro Boario, una coppia di incolpevoli Greci e una di Galli, destinati a "conquistare" il cuore della città morendo nel peggiore dei modi. A suggello di questa "no stop" funeraria, il Senato proibì ogni manifestazione di lutto per i morti in battaglia. Era vietato piangere e urlare. E alla fine Roma tutta fu invasa dal silenzio. 47 L'epopea della ricca Capua granaio di Roma Sonno, amplessi e vino sbaragliano un esercito. Ma Annibale non abusò mai delle italiche Grande madre Campania terra di donne e Giunoni "Attento alla femmina dell'Ager Campanus", mi avverte Marino Niola con una telefonata da Napoli. Sto andando a Capua, la terra degli "Ozi" di Annibale, e so che gli antropologi sono dei visionari che sparano immagini estreme; quelli napoletani figurarsi. "La donna capuana ‐ incalza Marino ‐ è allo stesso tempo Persefone e Demetra, luogo di morte e di fertilità". Mio dio, penso, chissà quali esperienze avrà avuto. Ma lui galoppa ancora: "Capua è il ventre caldo delle madri che toglie le forze ai Cartaginesi". Quando arrivo scopro che la donna dell'Ager Campanus esiste eccome. Ne vedo subito una oltre il traffico e la plebe, davanti al numero 22 di via Alessio Simmaco Mazzocchi a Santa Maria Capua Vetere (nelle terre dei Borboni un nome di due sole parole non è degno di considerazione): una matrona del Volturno dagli occhi come braci, dominatori e indifferenti, adorna di una cascata di riccioli neri e un peplo di bianco lino plissettato, aperto con generosità sulle sue bellezze. Praticamente Giunone. La Campania è piena di donne così, simili alle Grandi Madri, le antiche gigantesse di pietra cariche di spighe e bambini che quando entri al museo di Capua sembrano saltar su e urlare tutte insieme "Attento, questa è la terra delle donne!". Certo, tutto è cambiato da quando l'antica Capua aprì le porte ad Annibale invitandolo a godersi la vita: eppure, tutto è rimasto lo stesso. Antico e moderno generano intrecci da mal di testa. Quando ti siedi al caffè non sai se al tavolo vicino c'è Socrate o Peppino de Filippo. Per strada confondi satiri e bottegai, comari e torbide Clitennestre, ombre di aruspici e parroci di campagna, ninfe delle fonti e commesse di supermercato, parche tessitrici di destini e cameriere russe capaci di sparare ordinazioni con la durezza di una fucilata. "Amplexu multoque mero somnoque virorum / profliganda acies...". Silio Italico, nel suo poema sulla guerra punica, scrive della vecchia Capua che "è con gli amplessi, il molto vino e il sonno che va sbaragliato un esercito che né spade né fiamme, né Marte sfrenato hanno potuto abbattere". Aggiunge perfidamente: "Gusti, il condottiero, i piaceri che si insinuano nel profondo delle viscere...". Come dire: muori Cartaginese. Dimenticava che nel grembo delle Madri gli africani lasciarono anche figli. Il seme della rinascita, e quindi della rivincita. 48 "Ah ‐ sospira Giovanni Brizzi, la mia inclita guida annibalica, subito catturato dal fascino del luogo ‐ dovettero godersela assai i soldati da queste parti... In quattro anni, di donne ne avevano viste poche...". Beh, gli dico, ci saranno pur stati degli stupri. "Difficile. Annibale su questo era severo. Proibiva di toccare le donne del nemico". Non ci credo, come li tieni dei soldati vincitori? "Lui era inflessibile. Chi trasgrediva era duramente punito. Sapeva che se tocchi il nemico nell'onore, scateni l'impensabile. Trasformi in leone anche un agnello. E soprattutto, dopo la guerra, rendi impossibile un'alleanza duratura con l'avversario. Era una scelta politica". Africano anomalo questo tuo generale... "Il suo modello era greco: Alessandro Magno, che dopo la vittoria non toccò un capello alla moglie e alle figlie del re persiano Dario. Tutta la famiglia di Annibale era così. Talmente continenti che gli altri clan cartaginesi li accusavano di pederastìa". Annibale non ebbe donne? Non ci credo. "La moglie Imilké era lontana, in Spagna, ma questo non cambia le cose. Nella sua vita le donne sono quasi assenti". Non si concesse una prostituta? "Plinio il Vecchio racconta che ne ebbe una in Puglia, in un paese di nome Salapia, poco lontano da Canne, nei mesi del campo invernale". E che dice Plinio? "Dice che gli abitanti di Salapia erano ancora così orgogliosi di questo primato, che secoli dopo portavano ancora i viaggiatori a vedere la casa degli amplessi. Significa che nessun altro, in Italia, poteva vantare fughe amorose di Annibale". Davanti all'anfiteatro dei gladiatori c'è un cane bianco e nero che dormicchia sotto le arcate. Occupa platealmente la passerella d'accesso, poi ci fa passare con uno sguardo pigro da usciere. Scavalcare questo metafisico abitatore di rovine è come varcare la soglia dell'altro mondo. Siamo con due universitari napoletani buoni osservatori del terreno, Giacomo de Cristofaro specialista di storia romana, e Osvaldo Sacchi studioso delle fonti del diritto romano. Rievochiamo, gesticolando, la storia. In principio fu Capua, la più meridionale delle colonie etrusche. Il punto di contatto con le terre selvagge dei Sanniti. La città più ricca d'Italia. La terra del vino falerno, del giurano e del massico, dolceamari come il sangue, inimmaginabili ai palati di oggi. Terra di argentieri, profumi e frutta formidabile, bestiame e unguenti come il meli‐loto della rosa. Qui Roma impara il rituale gladiatorio, qui Spartaco formerà l'esercito dei suoi ribelli. Qui nasce la commedia popolare detta Atellana. Qui è il granaio di Roma, fino alla conquista della Sicilia e dell'Egitto. C'è la defezione della città italica dall'alleanza con Roma, ci sono gli "ozi", poi la riconquista e la punizione terribile. La classe dirigente si suicida o viene messa a morte. Da allora, una lunga decadenza e l'oblio. Ma Capua resta egualmente così ricca e invidiata che le usurpano anche il 49 nome. La vicina Casilinum diventa Capua per decisione vescovile, e la capostipite viene declassata a Santa Maria Capua Vetere. Poi, a due passi, nasce Caserta, con la reggia dei Borboni. Due città figliastre in trenta chilometri. E in mezzo lei, prolifica come una grande madre. Non c'è nessuno oltre a noi. Fruscio di passeri nella sterpaglia, passerelle, voragini che si aprono sugli inferi dei gladiatori e delle belve. Il moncone sud dell'anfiteatro che si staglia nel cielo bianco come il teschio di un bisonte. Questo non è il Colosseo, infestato di orde in bermuda. Tutto è infinitamente più intrigante, come sulla Trebbia o a Canne. Dove è passato Annibale la magia resta, e la peste dei non‐luoghi non attecchisce. C'è un'energia primordiale che percepiamo ovunque. Qualcosa di molto più vecchio di Roma. "Qui l'antico riaffiora persino nella circolazione stradale" spiega Osvaldo Sacchi mostrando dall'alto un fittissimo labirinto di mura medievali, viabilità borbonica, ville romane e chiese barocche. "Qui l'asse egemone dovrebbe essere quello Est‐Ovest, la via Appia" dice indicando la "N 7" tangente al centro storico. "E invece no! Quando sono arrivato qui ho capito che le strade laterali avevano tutte la precedenza e spezzavano l'onda verde della via Appia... Era chiaro: comandava un asse molto più antico, quello Nord‐Sud, che parte dal tempio di Diana sul Monte Tifata! Qui Cardo e Decumano sono invertiti rispetto al normale. Che roba è questa se non un inconscio rifiuto dell'impianto spaziale romano?". Ci inghiottono gli inferi del Mitreo, un sotterraneo dove si sacrificava il toro bianco del dio Mitra. Nel semibuio intravediamo l'affresco dell'uccisione, la vasca del sangue, il serpente e il cane che lo bevono, lo scorpione che punge i testicoli dell'animale, il corvo vaticinante, le costellazioni. Usciamo muti di meraviglia dal secondo secolo dopo Cristo, un'epoca che ha già alle spalle Annibale e l'eruzione di Pompei. I barbari sono ormai alle porte, Capua è già l'ombra di sé: ma la luce abbacinante dell'esterno ci sbatte in un presente così volgare che persino quel tempo ci sembra una meraviglia di "humana pietas". Brizzi ha capito e sorride. Ora vorrebbe viaggiare come Don Chisciotte, hidalgo fuori‐tempo fra i cialtroni. Ormai è Calcutta. Caldo monsonico, fiori e cumuli di immondizie, roghi di sterpaglia, nebbie rossastre della sera. Una negra statuaria e altissima ci taglia la strada; pare Atropos, la gladiatrice che aveva il nome della parca che taglia il filo della vita. Non torneranno più per Capua i fasti di Annibale. Quando ebbe in mano la resa senza condizioni della città, il console Quinto Flavio Flacco mandò a morte i 53 maggiorenti che non si erano già suicidati, fregandosene del parere del popolo 50 romano. Una lettera del Senato gli raccomandava clemenza, ma lui la tenne chiusa apposta fino a esecuzione avvenuta. Allorquando la città passa ai Cartaginesi Archimede organizza la difesa e poi viene trafitto La svolta di Siracusa e il genio dei teoremi Morte di Archimede, mosaico di Ercolano Siracusa. Impossibile lasciar fuori Siracusa da questa storia. Me ne rendo conto a Capua, leggendo Tito Livio in una sera languida color melograno. La colonia greca è una svolta della guerra: nel 214 la città passa ai Cartaginesi, ma i Romani reagiscono immediatamente, capiscono che, se il nemico s'insedia in Sicilia, il loro dominio sul mare è finito, e così ne attaccano la città più splendida. La stringono d'assedio con quattro legioni. Ma Siracusa è soprattutto Archimede. E' il genio dei teoremi e delle macchine da guerra, dei rompicapi e dei codici perduti, che organizza la difesa, incendia con specchi ustori le basi del nemico, ne solleva le navi con enormi gru arpionanti, e poi muore, ucciso da un legionario distratto nel giorno della capitolazione, anno 212. Una grande storia da raccontare. Ma ha senso, mi chiedo, una deviazione così lunga? Temo che il viaggio si complichi e perda ritmo. E poi oltremare Annibale non ci va mai: il lavoro in Sicilia lo fa fare ad altri al posto suo. Gli Stretti non li passa, resta abbarbicato al Continente fino al giorno del ritorno in Africa. Che ci vado dunque a fare tra gli Iblei? E come faccio a staccarmi dal mio uomo dopo averlo seguito fin qui? Non mi resta che chiedere consiglio al compagno d'avventura, l'esperto di cose cartaginesi professor Brizzi Giovanni da Bologna. Lui mi gela: "Caro "viator" ‐ risponde come la Sibilla ‐ non posso venire. E' ora che ci separiamo". Resto interdetto dalla risposta a bruciapelo. Chi parla: il professore o l'Annibale che è in lui? Spiega sornione: "Mi fermo a studiare un po'". Continuo a non capire: deve davvero lavorare, oppure non può staccarsi dal suo mitologico "alter ego"? 51 Concede: "Tu puoi andare; anzi devi andare". Gli chiedo perché. "Questo abbrivio del viaggio ti aiuterà a capire l'allargamento degli scenari, la trasformazione della guerra". Spiega che dopo Canne tutto si complica: Scipione l'Africano marcia sulla Spagna e conquista Nova Cartago, Annibale si allea con i Macedoni, suo fratello Magone corre in Africa a chiedere rinforzi, flotte romane battono il Mediterraneo in ogni direzione. Insomma, dalle Colonne d'Ercole all'Egeo è tutto un rullar di tamburi. Parto verso Scilla e Cariddi per le terre dure degli Irpini, degli Alburni e dei Lucani, giù fino al Pollino e alle nocche del Ditone calabro. Un saliscendi terrificante; nel quale dio solo sa come Annibale potè muoversi a suo agio, e nel quale mai i Romani osarono affrontarlo. Tra Palmi e Bagnara Calabra, un colpo di vento quasi mi butta nel Tirreno, duecento metri sotto. Asperrimo Mezzogiorno. Per questo l'Africano la elesse a ultimo rifugio. Sud, Sud, Sud. Valli, nubi intrappolate nelle gole, camion a centro‐strada, foreste impenetrabili, lampeggiare di sguardi diffidenti sui picchi controllati dai Bruttii e dai Greci di Locri. Che avrebbe fatto Alessandro il Grande, conquistatore dell'Asia, in un terreno simile? "Che avrebbe fatto ‐ si chiede orgogliosamente Tito Livio nel nono libro delle Storie ‐ se avesse visto le balze dell'Apulia e i monti della Lucania" e magari avesse avuto di fronte consoli come Quinto Fabio Massimo e Lucio Papirio Cursore?". Ricostruzione dello Stomachion Livio deborda. L'Italia non è la Persia di re Dario, che si trascinava dietro "eserciti di donne ed eunuchi, gravati di porpora e oro..., più simili a una preda che a un nemico". L'Italia, proclama lo storico passando il limite del buon senso, non è l'India, nella quale Alessandro "avanzò gozzovigliando con l'esercito ebbro". Italia Italia Italia... par di leggere la Storia romana di era fascista. Livio non dice una cosa: proprio questa Italia fu affrontata da Annibale Barca, il quale la domò, la percorse e vi batté moneta affrontando i migliori consoli romani per tredici anni. Non può dirlo, perché il suo libro è un lavoro in lode di Roma. Ma oggi, qui, traghettando fra spaventose correnti 52 sullo stretto fra i Nebrodi e l'Aspromonte, il declassamento liviano di Alessandro mi appare in una luce tutta nuova. Un'indiretta, splendida "laudatio" del grande cartaginese. A Siracusa, ci vuol poco a capirlo, di Archimede se ne fottono. Al massimo lo usano come "acchiappa‐citrulli", per intitolar convegni sull'energia pulita e le pale eoliche. Povero genio dimenticato, ridotto a testimonial (defunto e dunque gratuito) di un business miliardario. Di lui trovo solo un riquadro in acciaio inossidabile, sporcato di graffiti blasfemi, in un'androna dello "scoglio" Ortigia. E' una ricostruzione, per giunta sbagliata, dello "Stomachion", il rompicapo geometrico che anticipò di duemila anni il cubo di Rubik, e che è possibile trasformare in centinaia di forme diverse. "Stomachion" si chiamava, appunto perché era così difficile da provocare i crampi. "Siracusa non merita un genio simile" brontola Umberto Di Marco, un innamorato di Archimede che ha ricostruito alcune delle sue incredibili macchine da guerra. Gli chiedo se questa dimenticanza è cosa di oggi. "Niente affatto. Quando Cicerone andò in Sicilia un secolo dopo la sua morte e chiese di vedere la sua tomba, scoprì che i siracusani non sapevano dov'era e nemmeno CHI egli fosse". Chi fu davvero Archimede? "La cosa più grande che ci ha lasciato la Grecia. Il grande teatro ellenico, per esempio, è cosa non trapiantabile fuori dalla nostra cultura. Il teorema sul galleggiamento dei corpi, invece, funziona ovunque. Siamo di fronte a un genio più universale persino di Leonardo. Ma non se ne parla". La sua morte fu davvero come la raccontano? "Dicono che lui tracciasse formule sulla sabbia, che vivesse fuori dal mondo, e il legionario lo uccise perché esasperato dal suo straniamento. Ci credo poco". Cosa accadde? "Fu un delitto di stato. Lui era il Von Braun della situazione. Una mente militare del nemico. Era il prototipo di ciò che i Romani detestavano: un Greco costruttore di stratagemmi e inganni. Ai loro occhi soprattutto un imbroglione". 53 Ortigia Dicono che il console Marcello pianse alla notizia... "Francamente mi sembra una balla, come il pianto di Scipione Emiliano sopra le ceneri di Cartagine che lui stesso aveva bruciato. Quando una città cadeva, non c'era pietà. Si scannava tutto ciò che si muoveva". Il vero specchio ustorio di Siracusa è l'alba. Il sole che esce sul mare immobile del mattino ti schianta come un faraone egizio. E' il disco incandescente di Ammon‐Ra sopra le teste rapate dei costruttori di piramidi puzzolenti di cipolla e sudore. Non hai scampo. A Ortigia, d'estate, l'unica attività che ti viene concessa è scegliere quale percorso fare per evitare il sole, sempre ammesso che tu non preferisca una sovrana immobilità. In quest'isola‐
transatlantico con la prua a Sud, altro non puoi fare che passeggiare sul lato Ovest al mattino e sul lato Est alla sera. Tertium non datur. Persino raggiungere il castello Maniace, lì a 500 metri, è un'impresa. C'è di mezzo la chiacchierata dal barbiere con lo specchio floreale fine‐Ottocento, la sosta al mercato da Tito Cappuccio che affetta pesce spada come nessuno, il caffè con Totò che discetta sulle ultime de "La Sicilia". Scrivo sulla sabbia una grande parola: OTIUM. Questo sono le Sirene: il metabolismo che rallenta, la deriva verso l'Africa. La giornata che si riduce all'attesa della sera. Sulla terrazza di Aldo Palazzo ‐ artista‐fotografo dalla ruvida chioma moschettiera ‐ aspetto il tramonto con due olive, un pomodoro e una coppa di bianco fresco. Il sole indora architetture arabo‐normanne, sveve e ispaniche. Mi sento a Cartagena; col viaggio che torna al suo punto di partenza. Non c'è più niente di greco qui, se si esclude il fantastico duomo, cresciuto dentro le colonne doriche di un tempio a Minerva. Incontro stranieri drogati di sublime lentezza. Come Kali Jones, che viene a tuffarsi con me dagli scogli. Kali non chiede altro dalla vita. I tetti, le rondini, il mare; e il rumore di stoviglie nella sera. 54 Quando il generale passa il Volturno nella speranza che i nemici corrano in difesa della loro città mollando l'assedio di Capua I popoli del lupo e gli ozi di Capua TORNO sul Volturno da Siracusa e, come temevo, trovo il compagno Brizzi infiacchito dagli ozi di Capua. Il professore che volle essere Annibale s'è sistemato da pascià alla fattoria Colombaia, accudito da generose cuoche campane, felice tra libri e casse di zucchine biologiche. Ah, "Otium", nobilissima parola! Ma dove sta scritto che l'ozio è dei fannulloni? In latino vuol dire altra cosa: "tempo libero utilmente impiegato" in studio, giardinaggio, camminate. E' la più sublime delle attività umane. Se così non fosse, il lavoro quotidiano non si chiamerebbe "Negotium", degradazione (o negazione) dell'ozio. Ozio per noi stasera è discettare sul senso delle parola "Capua", forse etrusca, accanto a un fumante sartù di riso; è scacciare pigramente i moscerini rimasticando il nome "Volturno" che tanto fa pensare a gorghi, meandri e giravolte, e poi scoprire che discende dalla dea "Volumna", portatrice del vento di scirocco. A Santa Maria Capua Vetere, ci conferma la cuoca, la gente chiama "ò Vortice" la nuova area mercatale costruita su un crocicchio battuto dal vento di cui sopra. Ma "Otium" per noi stasera è soprattutto studiare sulla carta, discutendo fino allo sfinimento il blitz di Annibale su Roma. E' l'anno 211 e le legioni ‐ ingelosite dalle delizie offerta ai cartaginesi ‐ si son calate sull'agro campano per assediare Capua. Annibale cerca di spezzare la tenaglia, ma il nemico è tosto, non molla. Allora il Capo attua una mossa geniale. Passa platealmente il Volturno in direzione di Roma nella speranza che i romani corrano in difesa della loro città mollando l'assedio di Capua. Già, ma come arrivare a Roma? Ci sono otto legioni che lo cercano. 55 Fa così: dopo la partenza "coram populo" s'infratta nell'Appennino. Sparisce dagli schermi radar, poi sbuca a sorpresa da Rieti e si cala sulla città da Nordest. "Hannibal ante portas!" è l'urlo dei Romani. Ma Annibale non cerca affatto di entrare. Vuole solo alleggerire la pressione su Capua. Compie evoluzioni sull'Aniene, devasta, incendia, fa bottino, poi riparte, e Roma tira il fiato. Ma tutti continuano a chiedersi: come ha fatto, quel satanasso, ad arrivare fin qui senza farsi intercettare dalle legioni? Mattina di brume, vecchia Capua addio, risaliamo il Volturno in cerca del santuario di Sant'Angelo in Formis, l'ex tempio di Diana Tifatina dove Annibale sacrificò un elefante. Il teschio del mastodonte, si vocifera in paese, sarebbe stato conservato dai monaci per secoli. Dico: dura scannare un bestione simile. No problem, spiega Brizzi. Basta un martello nella cervice. Un benzinaio ci indica la strada. "Passate 'o ponte r'Annibbale, poi a destra su per la montagna". Ponte di Annibale? "Sì, nun ci sta nessun cartello, ma si chiama 'o ponte r'Annibbale. Tutti lo chiamano a' cussì. E' bello grande. Ma a Cusano Mutri ce ne sta n'ato c'a fa ancora cchiù impressione". Me lo faccio mostrare sulla carta. Intanto il treno Caserta‐Piedimonte Matese ci passa accanto sferragliando. "A Faicchio sul Titerno ce sta pure o' ponte e' Fabio Massimo". Ah. Fabio il Temporeggiatore, che sfiancava il Cartaginese senza attaccarlo mai. Pago la benzina. Di nuovo toponimi, di nuovo un passato che sembra ieri. Ma qui sono di fronte a qualcosa di speciale. La rappresentazione teatrale della storia, come o' presepe napolitano. A Sant'Angelo comincia di colpo la montagna aspra di Frà Diavolo, del cinghiale e del lupo. Il santuario sorge a bell'apposta sulla frontiera millenaria tra pastori e agricoltori. Una tipa riccioluta ci apre il pesante cancello e ci schiude, oltre un frutteto, una vista pazzesca sul gran teatro della memoria. Sul frontone, un patchwork di epoche: capitelli corinzii, un arcangelo Michele dagli occhi azzurri, il vescovo longobardo Desiderio, gesticolanti statue barocche, nomi di principi normanni, mosaici di barbuti patriarchi bizantini. Ma l'insieme è coerente: rappresenta la stessa chiesa trionfante, orientale, dove l'uomo è nulla. 56 Ora la cordigliera del Matese ci sovrasta, e i Sanniti che l'abitano scendono per strade inverosimili a bordo di Api, trattori o furgoni. Hanno facce larghe di campagna; Napoli è lontanissima. Chissà se Annibale passò di qui, mi chiedo davanti alle mura di Alife, romane quanto si vuole, ma recanti un elefante quale civico emblema. "Sì che è passato ‐ conferma Geppino Buonomo, che sorveglia i beni storici della zona ‐ la città gli si è consegnata senza colpo ferire e così ha evitato la distruzione". Mi dicono che vicino a Montelatone sta emergendo una città sannitica bella come Micene. Sta per piovere, l'alta valle del Volturno è segnata da mandrie di bufale inquiete. Passa un contadino sul trattore, ma io vedo un centauro, mezzo uomo mezzo cavallo, garretti lucidi e zoccoli infangati. Tuona. Saliamo verso il lago e la sella del Perrone. Siamo su un'acropoli, una roccaforte dell'autosufficienza appenninica, un mondo ricco di legna, acqua, frutta e mandrie. Ora piove, e Brizzi mi racconta una storia tremenda. C'erano una volta sull'Appennino i popoli di montagna. La loro terra non bastava a sfamarli tutti. Per sopravvivere, decisero di sacrificare i loro figli in primavera, ogni certo numero di anni. Era il sangue del cosiddetto "Ver sacrum", l'atroce "primavera sacra" dei popoli italici. Nei secoli il rituale si umanizzò e si scelse di espellere, anziché uccidere, gli uomini in sovrabbondanza. Partivano a eserciti, nelle primavere stabilite, accompagnati dall'emblema di un animale totemico. "Hirpus", il cinghiale; "Picus", il picchio; "Luk", il lupo. Così nacquero popoli che furono il nerbo d'Appennino: gli Irpini, i Piceni, i Lucani. Ora siamo entrati in una gola paurosa. Sulla strada non c'è spazio nemmeno per i paracarri. Un'insegna addita il "Saloon dell'impiccato". Brizzi continua: "Per sfamarsi, questi cominciarono a premere su città, coste e pianure, ma vennero ricacciati indietro. E quando Roma cominciò a espandersi, si arroccarono sulle montagne adottando una tecnica "afghana" di agguati, senza mai scontri in campo aperto. Spesso si federarono, comunicando fra loro con una rete di tratturi". Forse gli stessi che Annibale avrebbe attraversato. C'è il fuoco acceso nella taverna molisana di Mario Di Meo, e il suo vino Tintilia, bevuto tra le lucciole del giardino, provoca allucinazioni tipo Lsd. Brizzi canticchia "Lucy in the sky with diamonds", io fantastico sul tratturo come collante di un'Italia federale, Mario ‐ più praticamente ‐ affetta funghi con occhio da fauno e spiega che la pernacchia è nata duemila anni fa tra i Sanniti, come manifestazione di spregio verso i Romani invasori. Penso che se i vettori transumanti erano anche spazi di sedizione armata, forse Roma costruì le sue vie consolari ‐ come la Flaminia ‐ apposta per tagliare le comunicazioni degli irrequieti Highlanders d'Appennino. Ma sì! Ecco perché i tratturi non corrono quasi mai paralleli alle strade! Ecco perché Annibale riuscì a passare invisibile fino a Roma e a nascondersi per tredici anni nel nostro Sud! 57 Il mattino dopo salita dolce, motori al minimo, per Pietrabbondante, il grande santuario dei popoli italici nati dal cinghiale, dal picchio e dal lupo. Fratelli dei boschi, che continuarono ostinatamente a ribellarsi prendendo feroci bastonate. Prima con Pirro, poi con Annibale, poi con la guerra sociale e la guerra civile che furono il massacro finale. Arriviamo a quota mille tra i boschi, tra rotear di farfalle, api, e falchi a grande altezza. Siamo perfettamente soli. Pietrabbondante è un'assemblea di spuntoni in bilico tra i due mari. Sotto, in un pendio coperto di funghi prataioli, un tempio, con davanti un anfiteatro protetto da Sfingi e massicci Telamoni in pietra. I Sanniti se la curano ancora, la loro capitale segreta. Falciano l'erba, tolgono ogni cartaccia. Macché Pontida. Pietrabbondante è meglio di Stonehenge. Che vengano qui, gli italioti, a vedere quanto fu grande l'Appennino. 58 Sulle sponde del fiume Metauro, dove i Romani, memori di Canne, restituiscono pan per focaccia ai Cartaginesi La corsa delle legioni Emil Zatopec era detto la "locomotiva umana" OGGI il generale comandante prof. Giovanni Brizzi se ne va: torna a malincuore tra i Celti dell'Emilia dopo una settimana di scorribande appenniniche. E' silenzioso, mentre lo accompagno verso la riviera adriatica, la lunga linea azzurra che già ci cattura allo sbocco delle valli d'Abruzzo. L'uomo‐ombra di Annibale vorrebbe dirmi che non è una ritirata la sua, ma solo... una corsa verso il Metauro. Sì, il fiume delle Marche, dove i Romani restituiscono pan per focaccia ai Cartaginesi, sconfiggono Asdrubale alla grande e ne spediscono la testa tagliata al fratello accampato a Canosa. E noi al Brizzi gliela diamo per buona, purché racconti un'altra delle sue favolose istorie. San Trigno, San Buono, San Salvo. Di nuovo rullar di tamburi. E' in questo Appennino dal pantheon barbarico che nel 207 il console Claudio Nerone passa con le truppe in direzione delle Marche, in una delle avanzate più fulminee della storia bellica mondiale. La sua è una strada trans‐collinare di estenuanti saliscendi: Canosa, Termoli, Atri, ponte sul Tronto. Fermo, Loreto, Senigallia, Urbino. Cinquecento chilometri, in meno di una settimana: una marcia a tappe forzate, senza dormire mai. Appena il tempo per mangiare, defecare, pulirsi, decongestionare i piedi. Erano questi gli uomini di una volta. In latino si dice "quam maximis itineribus", e a noi sembra una formuletta scolastica. Invece è fatica, disciplina, sudore. Il latino è un concentrato di tutto questo. "Itineribus expeditis", per esempio: vuol dire che gli uomini viaggiano non "im‐pediti", cioè senza bagaglio. E il bagaglio ‐ udite ‐ è roba di trenta chili: armi, cibo, coperta, borraccia, pali dell'accampamento. E' così che viaggia la legione in corsa verso il Metauro. Senza portarsi niente appresso. Già, ma come nutrire una simile moltitudine? La scelta logistica è iper‐moderna. Claudio Nerone manda avanti dei corrieri a spron battuto "ut omnes ex agris urbibusque commeatus paratos militi 59 ad vescendum in viam deferrent", affinché tutte le popolazioni dalle campagne e dalle città preparino lungo la strada vettovaglie per il nutrimento dei soldati. Allerta i Larinati, i Marrucini, i Frentani e i Petruziani perché facciano trovare cavalli e altre bestie, per aiutare gli uomini più stanchi. Sta per affrontare Asdrubale: un fulmine di guerra anche lui, che ha passato le Alpi assai più velocemente del fratello. "Erano decatleti" quasi digrigna i denti Brizzi, quasi gli duolesse ammettere la sua ammirazione per Roma. "Erano belve. Macchine di morte". Stiamo chiacchierando al bar della stazione di Pescara, ma il professore ‐ in partenza di lì a mezz'ora dal binario due ‐ non sente e non vede Pescara. E' già sul Metauro. "Avrebbero massacrato qualsiasi gladiatore". Rivedo l'immagine di Russel Crowe, nei panni del generale iberico che scende nell'arena, riprodotto alle spalle di Silvia Giorcelli, prof di storia romana a Torino. Dal mare arriva un po' di vento di bora. "I veterani, i veterani... erano degli invincibili... Gli ebrei di allora, che erano gran combattenti, lo sapevano: non attaccavano mai i veterani. Mai mai mai". Veterani. Penso che una volta il mondo era alla rovescia. I vecchi erano più forti, e i giovani... comandavano. Condottieri giovanissimi, come Napoleone, Gengis Kan, Annibale stesso. Figli che comandavano i padri. Oggi sarebbe inconcepibile, oggi spadroneggiano gli ottantenni. "Ah, la Quarta Decima Legio... ‐ incalza Brizzi ‐ una leggenda... la quattordicesima legione di stanza a Carnuntum, sul Danubio presso Vienna, a guardia del Limes orientale". La disciplina? I prussiani erano dilettanti al confronto. Non gli ammutinamenti, ma già le proteste sono punite con la morte. Brizzi legge da Livio un passo della guerra di Scipione in Spagna. "L'esercito batté con immenso strepito le spade sugli scudi... i condannati furono portati nudi... mentre si preparavano gli strumenti del supplizio... poi furono scudisciati a morte e decapitati con le scuri, senza che un solo gemito o mormorio di protesta si levasse dalle file". Regnava il terrore, più che la disciplina. Contempliamo affranti i nostri pallidi garretti sedentari. I superlativi non bastano per le tabelle di marcia di duemila anni fa. Come quella di Cesare, che porta i suoi dalla Toscana all'Andalusia in ventotto giorni. Ven‐tot‐to‐gior‐ni. "Non parliamo del resto... L'esercito inglese ha tentato di rifare il ponte di Cesare sul Reno con i mezzi di allora: ne è uscito a pezzi... Gli svizzeri hanno provato a viaggiare "quam maximis itineribus", e sono finiti all'infermeria". Si parte, Brizzi ora parla dal portello dell'Eurostar. Non prende atto che viaggerò da solo verso le Calabrie. "Ricordati. Il mondo ha prodotto tre grandi fanterie corazzate: gli opliti greci, i legionari romani e gli svizzeri con le alabarde... Quando Carlo Quinto vince a Pavia e scende su Roma, trattiene i suoi Tercios manda avanti tredicimila lanzichenecchi svizzeri, guidati da un capo che tiene con sé indovina cosa... un laccio d'oro per strangolare il Papa". 60 Il portellone si chiude, l'uomo delle meraviglie continua a raccontare, ma non sento più niente. Meno male che mi resta Tito Livio per immaginare la fine della lunga marcia. "Et, Hercule, per instructa omnia ordinibus virorum mulierumque, undique ex agris effusorum, inter vota ac preces et laudes ibant". E, per Ercole, tra ali di folla, uomini e donne da ogni dove, tra voti, preghiere e lodi essi passavano... erano chiamati difesa dello Stato, vindici dell'Urbe... nelle loro mani era posta la salvezza e la libertà loro e dei loro figli... Era ormai chiaro, la fortuna era girata, la maggioranza dei popoli italici non accettava di passare ad Annibale. La vittoria del Metauro era già nell'aria. Ridiscendo a Sud, verso la Lucania e la Calabria, ultime roccaforti di Annibale, per raccontare la fine dell'epopea italiana. Roma ha tenuto duro, c'è una macchina micidiale che cresce dentro di lei: l'espansione mediterranea, l'impero, l'efficienza delle legioni che con Annibale si è affinata e già viaggia verso la grande stagione di Cesare e degli Antonini, gli imperatori filosofi che daranno a Roma la più perfetta macchina militare della sua storia. Nell'area di servizio di Vasto vedo un titolo di giornale: gli americani manderanno in prima linea dei robot, macchine con la licenza di uccidere. Non leggo nemmeno l'articolo per paura di riflettere su ciò che questo significa. Mi tornano in mente, in compenso, i bravi alpini della scuola di Aosta che ho incontrato sulla neve del Col Clapier, dove è partito il viaggio a caccia di Annibale. E' stato bello lassù. Insieme abbiamo letto Polibio, parlato del generale passato di là, ascoltato il tuono di valanghe lontane, persino incontrato due amazzoni di passaggio. Ho voglia di chiamarli e sapere come va. Telefono. "Le passo il generale Bruno Petti" mi dice una voce. Per Ercole, mi bastava un sottopanza, non volevo scomodare un generale, ma dopo dieci secondi ecco già in linea "penna bianca" dalle Grandi Alpi d'Occidente. "Allora, l'ha trovato questo suo Annibale?", mi chiede sornione. Ha evidentemente letto il giornale e visto le foto dei suoi uomini. Gli spiego che sto cercando Annibale da settimane ma quello è più furbo e mi scappa sempre. "Vada sulla Sila ‐ mi suggerisce ‐ forse lo troverà nelle valli dei Bruzii". E' esattamente dove sto andando. Ho alla cornetta un uomo colto. Gli regalo un detto spagnolo imparato nel viaggio: "El mejor general no es el que tiene el mejor ejército, sino el que sabe utilizar mejor el ejército que tiene". Sud, Sud. Bivio per Matera, bivio per Taranto. Scendendo sullo Jonio, sento il generale guercio ancora più vicino. Ora che perde, ne misuro ancor meglio la grandezza. Penso al fantastico terrore riflesso che ha emanato, un terrore che duemila anni dopo è ancora capace di trasformarsi in fascino e ammirazione. Mi piace questo suo andare per zone d'ombra, traendo vantaggio dall'ombra medesima per diventare leggenda, evitando la noia della storiografia. Nel buio lo vedo seduto al bivacco con i soldati, sempre venerato e sempre solo, tempra d'acciaio, lupo senza amici e senza amori. 61 Di quando Annibale venne ospitato dai Brettii sulla Sila Una volta tornato in Africa, per il popolo dei boschi fu il tempo delle punizioni I montanari maledetti Tra Puglia e Basilicata finisco in un trappolone segnaletico, un labirinto di cartelli con direzioni tentatrici tipo Eramo Marzagaglia, Pizziferro Monsignore, Gemmabella o Masseria Bellaveduta. Tutte mi sussurrano "Vieni" come le sirene, e mi allontanano dalla mia meta, lo Jonio e le Calabrie, ultimo rifugio di Annibale in Italia. Chiedo la strada a degli anziani seduti a filosofare sotto un pergolato. E' Italia del Sud, ma potrebbe essere Grecia profonda. "E che ci vai a fare in Calabria Saudita?" ghignano. "I calabri bestie sono. Hanno crocefisso Nostro Signore". Sto al gioco: "M' hanno detto di questa storia, e mi piacerebbe saperne di più". Ovviamente non ne ho mai sentito parlare. "Hai presente quelli che hanno piantato i chiodi? Erano calabresi". E giù a mimare il martello ridacchiando come comari. Il viaggiatore inglese Patrick Fermor ebbe istruzioni altrettanto allarmanti quando chiese notizie del selvaggio monte Taigeto ai contadini della Laconia. Ora fiuto la stessa diffidenza "altimetrica" dei Greci. "Prendi per San Basilio, poi Madonna del Carmine, e poi giù a Marina di Castellaneta. E poi nnand... nnand... chiù nnand sciam e chiù n' Calabr sciam", più avanti siamo e più in Calabria siamo. E con la mano indicano una fosca direzione mitologica oltre la malaria del Metaponto, oltre le frane della Lucania, le fiumare desertiche del Pollino e le terre roventi del Crati. L'ultima roccaforte del Cartaginese, il bastione della Sila. Annibale e Cristo si incontrano in Calabria? Mah. Scendo verso lo Jonio e il mistero aumenta. La segnaletica ignora la direzione Sud. C' è solo l'Est. Taranto. Brindisi. Lecce. La Calabria scompare. Ecco perché mi sono perduto. C' è mare violento dopo Marina di Amendolara, le raffiche strapazzano le magnolie sul guard rail. Un paesaggio spettacolare, segnato da vuoti sinistri. A Sibari è morto Erodoto, il più grande storico dell'antichità, ma gli italiani non lo sanno. Erodoto desaparecido: come Pitagora, dimenticato da Crotone, e Archimede, ignorato a Siracusa. I più grandi pensatori greci sono vissuti qui, ma l'Italia se ne fotte. In Francia leggerei maxi‐cartelli: "La ville d'Hérodote", "L'ile d' Archimède". Qui tace anche la segnaletica. Mi sta inghiottendo uno dei numerosi buchi neri della memoria nazionale. Le vetrate del museo di Sibari tremano controvento; dentro c'è la folla che il mare grosso ha sloggiato dalla battigia. Chiedo di un archeologo, e dietro montagne di libri sbuca Silvana Luppino, che ‐ mi dicono ‐ conosce anche la Sila a menadito. Subito mi apre il gran vaso di Pandora della Magna Grecia: ne svela il lusso e le periodiche crisi, i segreti dei favolosi Enotri, la ricchezza e l'oblio di Sibari la potente, protetta per secoli da dune costiere e poi inghiottita della malaria per duemila anni, fino alle bonifiche del Fascio. E Annibale? "Fu ospitato dai Brettii, i montanari della Sila" replica la Luppino mentre le vetrate lasciano passare micidiali spifferi di scirocco. Avevo sentito parlare dei Bruttii e dei Bruzii. Ora scopro una terza versione del nome. "Era un popolo indipendente ‐ narra l'archeologa ‐ che procurava ai naviganti alberi maestri e la miglior pece del Mediterraneo". Cosenza era il quartier generale, che in latino vuol dire "Consentia", il luogo del consenso, del "patto di alleanza". 62 Temuti dai Greci e invisi ai Romani, furono duramente puniti quando Annibale se ne tornò in Africa. I loro terreni vennero requisiti. I loro diritti aboliti. Nelle legioni fu consentito loro di svolgere solo le mansioni più infami. Come gli zingari nell'esercito ottomano, obbligati a occuparsi dei supplizi. "Di sé non hanno lasciato quasi nulla, tranne la pessima reputazione tramandata dai Greci e dai Romani". Comincio a sentire il profumo di una storia. Azzardo: "Dicono che abbiano crocefisso Nostro Signore". "Se è per questo, qualcuno ha appiccicato la loro identità anche a Giuda", risponde l'archeologa, e proprio in quell'attimo il vento fa sbattere rumorosamente la porta dell'ufficio. Apriamo un libro dell'archeologo Pier Giovanni Guzzo: c'è scritto che appena nel Settecento la Chiesa ha assolto i boscaioli della Sila da queste calunnie infami. Ma allora è chiaro! Per duemila anni i Brettii sono stati maledetti da Dio e dagli uomini. E' quanto basta perché il conto torni. Cristo e Annibale si toccano davvero sulla Sila. L'ombra brigantesca del secondo s'allunga sul primo sotto forma di un boia che inchioda un innocente alla croce. A Rossano la strada s'impenna e l'abitacolo trema nel maestrale. Ho con me una mappa archeologica punteggiata di fortificazioni ("Castra") con su scritto "Bruttium", la terra dei Brettii. Appena fuori dagli orrori cementizi comincia un Eden dimenticato. Torrenti costeggiati di magnolie e mentuccia, villaggi arroccati, ponti a schiena d'asino. Ma la bellezza si sposa di nuovo, misteriosamente, a un vuoto sinistro. Gli uliveti sono chiusi da reticolati e piantonati da torve sentinelle venute da chissaddove. Il segno duro del latifondo. "Mi scusi, le rovine di Castiglione di Paludi?". Due uomini si girano, affranti di fatica e sudore. Sono albanesi, non capiscono cosa sto chiedendo. A Paludi mi soccorre una brettia monumentale affacciata al balcone. Le manca solo la treccia per arrampicarsi su. "Scendi fino dove la strada finisce ‐ ordina con un gesto imperativo ‐ lì trovi un cancello chiuso, lasci l'auto e passi a piedi". Scendo fino a un cartello che parla di un restauro con fondi europei, poi più nulla. Custodi, orari di apertura: niente. Erbe alte, fiori violetti grandi come cactus, il vento, la Sila e il mare in lontananza. Scavalco il cancello. Oltre i lentischi, i cardi e gli ulivi, in un coro assordante di cicale, la roccaforte. Muraglie nerastre, dalla robustezza incaica. Malinconiche, come quelle degli Incas. La malinconia dei popoli vinti: Liguri, Osci, Lucani, Boi, Sanniti, Salassi. Una cittadella intera che i Romani costringono allo sgombero, come cento altre. Un mondo che raggiunge la massima gloria con Annibale e dopo Annibale sparisce nel nulla. La casa di Antonio Milano, professore di latino a Lamezia, pare la torre di controllo di un aeroporto. Altissima con la terrazza sulla città, vi si danno appuntamento tutti i venti del Sud. Ai tuoi piedi, perfettamente leggibile, la trigonometria del mito. Lassù c'è Cosenza "senza mura, come l'antica Sparta", laggiù il posto dove uno zio di Alessandro Magno fu misteriosamente sbranato da donne. Lì c'è un ponte di Annibale; lì i marosi di Squillace, il grande capolinea da dove il Cartaginese lasciò l'Italia nel 203. E là in fondo, tra le nubi, la strada dove, con un nero cavallo, arrivò per morire Alarico re dei Goti, intrappolato pure lui in Calabria. Lo sguardo vola, la mente galoppa, passa da Demostene a Senofonte, da Diodoro Siculo alle rivolte degli schiavi nel Sud. Parliamo dell'età ellenistica, "che non fu affatto decadenza come vogliono farci credere". Rievochiamo soprattutto i Bretti, e don Antonio ne conosce ogni segreto, ogni cittadella nascosta tra gli ontani e le fiumare della roccaforte chiamata Sila. Gli chiedo qual è la 63 versione giusta: "Brettii, Bruzii o Bruttii?" "Brettii, per carità, viene dal greco Brettioi". Poi chiede: "A proposito, il tuo Brizzi, mi sa tanto che è un Brettio di origine. Sulla Sila fanno un pecorino che porta il suo nome". Rivelazione come un fulmine! E se davvero 22 secoli di rancore antiromano avessero fatto il nido in un ignaro professore bolognese, trasformandolo in Annibale? Chiamo Brizzi al telefono. "In effetti ‐ gracchia il nostro alla cornetta ‐ i 'brizzì nel mio Appennino sono 'montanarI' , e l'origine potrebbe essere quella. Perché no?". Non ci possiamo credere. Antonio ride: "Con un Brettio travestito viaggiavi... dannato te!". Nei viaggi le sorprese non finiscono mai. 64 Di quando il condottiero africano lasciò l'Italia per sempre per raggiungere a malincuore la natìa Cartagine Il saluto del vulcano Stelle filanti sullo Jonio, così grosse che fanno rumore. Oltre i canneti e la ferrovia, la linea pallida del golfo di Squillace, l'immenso anfiteatro di sabbia da dove nel 203 l'africano lascia per sempre l'Italia e l'Europa, portandosi dietro parecchie migliaia di calabresi. Se ne va a malincuore, spinto dal vento di Maestro, per raggiungere Cartagine. Laggiù c'è un console romano, Scipione, che ha osato attaccare la sua patria, esattamente come fece lui quindici anni prima, passando le Alpi per sfidare la Dominante. Volevo aspettare la notte a Capo Colonna, presso Crotone, sulle rovine del tempio di Era Lacinia, là dove Egli incide le sue gesta su un bronzo che Polibio leggerà prima che vada perduto. Volevo, ma non ho potuto, perché a Capo Colonna non si vedono le stelle. C'è troppa luce. Una funebre processione di lampioni simili a capestri ha sconciato il promontorio più bello del Mediterraneo. Pomposi manifesti glorificano la Provincia che ha ucciso la notte. Il mito richiede penombra, e qui nulla più dice del gran fuoco lacinio che dava la rotta ai naviganti tra le coste illiriche, il tacco d'Italia e il cratere fiammeggiante dell'Etna. Oggi troppe cose devo ignorare per carpire quella magia: la devastazione edilizia di Crotone, i bottini stracolmi di immondizia, i bimbi protervi che ostentano impennate in motocicletta, le radio a tutto volume, il parcheggio nuovo già a pezzi, la strada che porta a un ristorante anziché al tempio. E poi quell'irrigazione a pioggia col sole alto mentre i giornali locali alzano pianti greci sulla grande sete. Ma il peggio è scoprire che il Capo è superiore a tutto questo: se ne sta con la sua solitaria colonna, appoggiato ai faraglioni, come un oggetto celeste indifferente agli umani. Astronave immobile sotto l'ultimo cielo italiano di Annibale. Non dormo stanotte. Resto a guardare il mare sulla strada costiera, perfettamente deserta, all'altezza di San Leonardo di Cutro. Qui niente spot, niente luci arroganti. È bastato scavalcare il guard‐rail e traversare le erbe alte nel buio, fin'oltre la ferrovia jonica. Colgo un fico da un albero, lo mangio, annuso l'aria ferma. Il mare è nero. All'orizzonte, le luci della Locride. 65 A monte, le costellazioni dei Brettii. Forse i "Castra Hannibalis", le ultime basi fortificate, erano qui, dove mai i Romani osarono venire in presenza dell'africano. Apro il dizionario mitologico, lo esploro con la torcia, cerco di Crotone, e scopro con un brivido che Capo Lacinio, o Capo Colonna che dir si voglia, è il punto terminale del viaggio di Ercole, prima dell'imbarco per la Sicilia. Ancora Ercole! Il viaggio di Annibale è tutto sulle sue tracce. Parte dal suo tempio a Cadice, continua per la "Via haerculea", valica i Pirenei dove l'eroe ha amato una ninfa, passa le Alpi sempre sulla sua strada, e così avanti fino in Lazio. Capo Colonna Se avevo dubbi che Annibale avesse costruito la sua strada apposta per entrare in un mito erculeo, ora non ce l'ho più. Crotone DOVEVA essere il suo imbarco. Lì due ricchi mandriani di nome Kroton e Lakynos rubano al gigante parte delle mandrie, e quelle mandrie vengono... da Cadice. A Crotone lui li ammazza, costruisce il tempio di Era ‐ la dea contenuta nel suo nome "Era‐kles" ‐ e quel tempio è puntato verso le porte dell'alba esattamente come il tempio di Cadice è aperto verso l'Oceano, sulle leggendarie "porte della notte". Simmetria perfetta. Povero Jonio. Era il re dei mari, oggi è un lago di terza classe, più dimenticato persino dell'Adriatico della grande Venezia. Roma di oggi guarda solo al Tirreno. E tu Crotone, come ti sei perduta, dopo che Pitagora cercò in te le leggi dell'universo... Crotone, dove gli uomini giusti partivano per l'Aldilà con in bocca istruzioni su foglie d'oro, e dove Evemero da Messina spiegò che gli dei erano solo uomini che avevano lasciato memoria immortale di sé. Esattamente come Annibale. "Latifundia perdidere Italiam", il latifondo ha rovinato l'Italia. Lo aveva capito già il vecchio Plinio, grandissimo storico dell'antichità. La sentenza mi batte in testa da giorni, da quando ho ricevuto uno straordinario regalo di Roberto Cerati, glorioso patriarca di casa Einaudi. Un doppio volume 66 dell'82: L'eredità di Annibale di Arnold Toynbee, studioso inglese che ha speso trent'anni sugli effetti della guerra punica in Italia. Da quando ce l'ho, ci spendo ore d'appassionata lettura. Anche in questa notte sul Grande Imbarcadero. Un conflitto durato il quadruplo della Grande Guerra non può che lasciare segni indelebili nel territorio in cui si gioca. E' quanto accade all'Italia del Centro‐Sud. A piegarla, più delle distruzioni e delle rappresaglie, sono gli arruolamenti in massa dei liberi contadini allontanati dalle loro campagne e le vendette romane contro i popoli e le città passati ‐ o costretti a passare ‐ ad Annibale. Alla fine della guerra la piccola proprietà contadina del Mezzogiorno è in ginocchio e la nobiltà italica diventa padrona di terreni immensi requisiti agli "infedeli". È allora che esplode il latifondo, il grano soppianta orti e frutteti, i contadini scappano nelle città, i pastori transumanti dilagano, l'Appennino si riempie di schiavi‐mandriani, pastori armati pronti a diventar banditi. Forse la questione meridionale non nasce con i Borboni o l'unità d'Italia, ma molto prima. Negli anni di Annibale. Non sempre i Romani portarono ordine, legge, acquedotti e strade. Nel 204, col Cartaginese ancora in Italia, eccoteli a saccheggiare le coste greco‐calabre esattamente come lui, e ad aggiungere anarchia alla distruzione. Un esempio? Presa Locri, Scipione consegna la città al suo agente Quinto Pleminio perché la punisca "non con la sferza ma con flagelli chiodati". Una feroce vendetta appaltata. Locri è sempre stata filo‐romana ed è caduta combattendo nelle mani di Annibale, ma poco importa: ora Roma se ne sbatte del tradimento della "fides" (la lealtà reciproca), infrazione tanto spesso invocata ‐ in tempo di sconfitte ‐ contro il presunto "fedifrago" Annibale. Pleminio non si limita a infliggere tormenti ai locresi. Saccheggia il tempio di Persefone, il cui tesoro persino Pirro il terribile aveva spontaneamente restituito dopo una tempesta ammonitrice. Ma la divisione del bottino scatena una guerra tra cosche militari talmente feroce che due tribuni sono spediti a riportare l'ordine. Questi si muovono con la stessa ferocia, e puniscono Pleminio, "tagliandogli naso e orecchie e spaccandogli le labbra". Ma Scipione interviene, rimette il reo al 67 suo posto. Costui subito si vendica, sottopone i tribuni a tortura e li fa ammazzare. Lo stesso fa dei locresi che si sono lagnati di lui col Senato. Sembrano storie di 'ndrangheta, ma è una 'ndrangheta romana. È un andazzo generale: dopo la partenza di Annibale, i governatori locali cominciano a trattare le popolazioni italiche come colonie sub‐sahariane. Saranno i fratelli Gracchi (poi uccisi) a lamentarsene in Senato in un discorso del 173 a. C. riportato da Aulo Gellio. Ne trovo nel libro dei passi illuminanti. "Un console andò a Teano. Sua moglie disse che voleva servirsi dei bagni degli uomini e si ordinò al questore di cacciarne quelli che li stavano usando. Ma la signora riferì al marito che i bagni non erano stati messi prontamente a sua disposizione e che non erano puliti. Per questo motivo si piantò un palo nel foro e vi si condusse Marco Mario, il membro più autorevole della comunità, che fu spogliato e frustato. Quando gli abitanti Cales ne furono informati, introdussero una regola per cui nessuno doveva usare i bagni quando un magistrato romano si trovava in città". "L'arbitrio dei giovani nobili ‐ protesta Caio Gracco ‐ arriva a estremi sconcertanti. Uno... stava tornando dall'Asia dove aveva compiuto una missione come legato. Viaggiava in lettiga, e un pastore di Venosa incontrò il gruppo per la strada. Non sapeva chi fosse il viaggiatore e chiese per scherzo se dentro c'era un cadavere. Sentito ciò, il giovane ordinò di mettere a terra la lettiga e frustare l'uomo con le cinghie. La fustigazione continuò fino alla morte dello sventurato". Esce dal buio una littorina, bella e disperata come il Sud. E' anche lei una stella filante, e si porta dietro un soffio di ruggine, erba e salsedine. Sopra il Mediterraneo poche stelle di nome latino; la toponomastica del cielo parla arabo e greco. Sulle loro navi, i veterani di Annibale avvistano l'Etna in eruzione, girano attorno a Capo Passero, puntano nella notte su Pantelleria. Tornano a casa dopo quindici anni. 68 A Zama i romani costretti all'inseguimento Ma infine i veterani di Scipione sconfiggeranno il nemico Il momentaneo capolavoro in quella grande battaglia La battaglia di Zama in un dipinto di Cornelis Cort, 1567 Tunisia. Colline steppose, mulinelli di polvere, greggi. Lo stradone per Zama punta a Sud, decolla e plana nelle turbolenze d'asfalto tra venditori di galline e meloni enormi come turbanti, s'infila sotto le arcate di un acquedotto romano (restaurato dagli Arabi) rimasto in funzione fino al 1300. Il campo di battaglia è annunciato da donne berbere, ragliare di asini nei campi infuocati, villaggi con piccoli minareti quadrati e nude montagne. La Numidia è tutta un campo di battaglia, terreno per cavallerie e grandi manovre. Fiume Medjerda, ponte di Fahs, l'antica Sicca Veneria col tempio di Astarte dove sacre prostitute si diedero ai forestieri. L'archeologo Piero Bartoloni guida in stato di trance sulla stessa strada di Scipione, indica alla sua sinistra ‐ oltre una montagna detta Zaghouan ‐ la "linea di convergenza" seguita da Annibale dalla costa fino al nemico, sull'altopiano di Numidia. Potrebbe guidare anche a occhi chiusi; conosce il posto come nessuno. Scava il campo della morte dal '96, primo dopo duemila anni di oblio. Paracarri di pietra indicano "Jema", un grosso villaggio su una valle oblunga coltivata a orzo. Lì si è combattuto, giusto sotto le rovine sepolte di Zama Regia, su una terra che ha masticato e digerito centinaia di migliaia di punte di freccia senza restituire più nulla. "Dimmi se questa non è una valle per cavallerie!" esulta Pietro. Ed è vero: Zama è meglio di Waterloo, meglio di Solferino. E' l'archetipo perfetto dei campi di battaglia. Ha un'eco speciale, come se portasse impressa per sempre l'acustica dell'evento. "Io li vedo", sussurra Bartolini nel vento. "E se chiudo gli occhi li sento". Una cicogna ci sorvola, ali larghe, e plana nell'orzo. Siamo seduti nell'erba alta, sulla collina di Zama Regia, con i testi di Polibio e di Tito Livio in mano. Dall'alto la dinamica dello scontro è leggibile come un diagramma. Nulla avviene di ciò che ci si aspetta. Scipione ha rinunciato da tempo alla lealtà romana. E' diventato più callido di Annibale. Ha occupato mezza Tunisia fregando i cartaginesi con spie travestite da ambasciatori, operazione che gli consente di dare alle fiamme gli accampamenti del nemico. 69 Da Annibale ha imparato anche la manovra avvolgente, la stessa che ha stritolato i Romani a Canne tredici anni prima. La perfeziona, la adatta alla fanteria pesante romana. Per la prima volta è in vantaggio come numero di uomini e anche come cavalleria, il tradizionale "pivot" delle manovre cartaginesi. Può farlo, ha con sé i Numidi di Massinissa, ex alleati di Annibale, ora passati dalla sua parte. "Massinissa, quel maiale traditore" ringhia Bartoloni, il romano più filo annibalico che esista in Terra. La tomba di Salal Ben M'hammed Ma Annibale è una volpe, compie proprio a Zama il suo capolavoro. Attira Scipione in una trappola statica. Manda i suoi Numidi in fuga e costringe le cavallerie romane all'inseguimento, dirottandole dalla manovra a tenaglia. Poi lascia i suoi "invincibili" ‐ i veterani della campagna d'Italia ‐ fermi in retroguardia, per schiantare i romani già stanchi dall'assalto. Scipione è in difficoltà, ma i suoi non mollano. Sono anche loro uomini anziani, ma a differenza dei cartaginesi mai hanno sentito in bocca il gusto della vittoria. Sono i superstiti al carnaio di Canne. Uomini cui Roma mai ha espresso gratitudine: reparti di punizione, tenuti in Sicilia per dieci anni, lontano da casa, a purgare la sconfitta. Si faceva così allora: compassione zero per i perdenti. Cartagine non puniva i soldati, ma crocefiggeva i generali sconfitti. Quei veterani il giovane Scipione se li è visti assegnare dal Senato, ed è un regalo al veleno. Gliel'hanno fatto i molti invidiosi che a Roma sperano in una sua sconfitta. Ma lui trasforma quei disperati nel suo percussore. Ha capito che i "vecchietti" sconfitti da Annibale hanno due motivazioni in più: la vendetta e la voglia pazza di tornare a casa. Così accade. Le legiones cannenses tengono duro finché le cavallerie romane, sconfitto il nemico, tornano sul campo a dare la bastonata finale, come il generale Bluecher a Waterloo contro Napoleone. "Venga a vedere la fonte di Annibale" sorride Ahmed Ferjaoui, archeologo epigrafista, che scava Zama Regia da dieci anni assieme a Bartoloni. Sotto una tettoia stanno emergendo una basilica cesariana, mura bizantine e vasi cartaginesi. L'équipe al lavoro ha appena fatto emergere un'anfora fenicia da una profondissima trincea, ma oggi Ahmed vuole mostrarci "la Source d'Hannibal". 70 "Appiano e Vitruvio ne parlano... pare che chi beveva quell'acqua riceveva in dono una bella voce". Siamo soli tra le cicale, camminiamo finché nella sterpaglia si apre una fessura. Scendiamo per una scala. Oltre una porta, ecco una grotta trasformata in cantina, col segno di una vecchia fonte. Per terra, tracce votive chiaramente femminili. Fazzoletti annodati, strani geroglifici in tintura henné. Segno che l'acqua‐femmina era invocata dalle donne perché portatrice di fertilità. "L'acqua non c'è più, perché hanno catturato la vena a monte, e l'hanno dirottata su un acquedotto", lamenta Ferjaoui sorridendo. I tunisini sorridono sempre, anche se dununciano cose orribili. "Qui Annibale vive ancora, la gente del posto l'ha santificato, un po' come voi fate con San Giorgio, quello che uccide il drago". E come si chiama in arabo questo santo? "Si chiama Sidi n'bil", risponde Ferjaoui mentre una cicogna passandoci sopra proietta su di noi la sua ombra portatrice di fortuna. "Le tombe si affollano attorno a un recinto di pietra" "Il signor Annibale". A Zama "Sidi n'bil" è come dire "Apriti sesamo". Pronunci quel nome e la memoria si mette in moto. "Andate a vedere la sua tomba" esorta a gran voce uno degli operai locali dal fondo della trincea di scavo. La tomba di Santo Annibale? "Certo", sorride Ferjaoui, che conosce il posto. Torniamo nella luce abbacinante e traversiamo a Sudest, sulla schiena di quella che fu Zama Regia e oggi è solo una collina. Settanta ettari di rovine annegate nella sterpaglia. Ne è stato scavato uno soltanto, anzi la metà di uno. C'è ancora tutto da fare quassù: foto satellitari, prospezione magnetica. Mancano i soldi. "Ecco, laggiù". C'è uno spazio di tombe, ai margini della città, verso quello che fu il campo cartaginese. Tombe anche recenti, con date fino al 1990, ma dalla forma inequivocabilmente fenicia. Sullo spazio in 71 maiolica, ornato in caratteri arabi, c'è scavata una coppa per le libagioni. Un segno di almeno 1200 anni più vecchio di Maometto. M'hamed Hassin Fantar, gran professore di Tunisi, mi aveva avvertito: "Qui Annibale è un mito, conserva un'aureola e un prestigio immenso nonostante la sua sconfitta militare". Le tombe si affollano attorno a un recinto di pietra, come se la gente di Zama volesse dormire il Lungo Sonno proprio accanto a quel luogo, sopra la collina delle rovine. Sul marmo di Salal Ben M'hammed, 10.10.1910 ‐ 2.6.1983, c'è scritto "Dio chiede all'anima di tornare a lui calma e serena". Un cancello arrugginito e, dentro, altre tombe in una foresta vergine di cardi blu, coperti di piccole lumache. In fondo a sinistra, il "kodesh kodeshim", il sancta sanctorum, il recinto con la tomba di Lui. Ferjaoui: "Narrano che una lupa venne qui una notte d'inverno per spegnere la candela accesa sulle sue ceneri, ma la luce divenne così forte che la lupa fuggì per sempre, e ancora la senti ululare di dolore sui monti dell'Atlante". Una lupa? Qui ci sono solo sciacalli! La lupa non può essere che Roma. Abbiamo i brividi. Il cancello è aperto, ma non riusciamo a entrare. E' come sporgersi su un baratro. Una mano invisibile ci respinge. Torniamo al mare e a Cartagine. Un numida ci galoppa accanto per qualche centinaio di metri. Sappiamo che Annibale non muore affatto a Zama, e a Zama non finisce un bel niente. Al contrario. Il viaggio più lungo e misterioso comincia ora. Verso Oriente. 72 E' il 189 e il condottiero approda sull'isola Si dice cerchi rifugio dai pirati ma ormai la sua storia è nel mito L'ombra del minotauro Strani sogni a Creta Isola di Creta, alba sul porticciolo di Agios Pelàgia. Unico rumore, i pesci che saltano dall'acqua. C'è la stessa luce gialla di Cartagena, tra Bahia Escombreras e il Mar di Mandarache con i sommergibili ai moli. Ho sonno, orde di inglesi hanno fatto baldoria tutta la notte impedendomi di dormire, ma ormai è giorno e decido di aspettare il ritorno dei pescatori. E così, al tavolo del primo caffé aperto, solo con i cormorani e una mappa dell'Egeo, m' accorgo di essere letteralmente assediato dal mito. A Est, Eraklion e il palazzo di Cnosso con l'ombra del Minotauro. A Nord, il mare che inghiottì Atlantide e mezza Santorini. A Sud, altissimo nelle nubi, il Monte Ida culla di Giove, con una scarpata di 2500 metri. A Ovest, il bastione del Levka Orì con le "termopili" di Samaria e le bianche rovine di Lissos sul Mare Libico. A Nordovest, sulla rotta del Peloponneso, Citera isola di Venere, con i suoi fantastici galli che svegliando i piumati confratelli di Anticitera ‐ giura Patrick Fermor nel libro Mani ‐ possono trasmettere onde di "chicchirichì" fino a Creta, in giornate senza vento come questa. E' il 189. Sono passati tredici anni da Zama e Annibale è approdato a Creta. Che ci fa da queste parti? Si dice cerchi rifugio presso i Fratelli della Costa, pirati in azione sulle grandi rotte del Mediterraneo Orientale. Si dice che si attrezzi una sua Tortuga al riparo dai 73 Romani che lo cercano ancora. La sua storia è scivolata da tempo nella mitologia. Di lui si sa pochissimo, salvo che compare qua e là come una meteora nel buio. Ricapitolo le tracce del vecchio leone dopo la sconfitta di Zama. Nel 201 lui spiazza di nuovo tutti e diventa il miglior garante della pax romana. Fa di più: sorveglia il pagamento dei danni di guerra e riesce a risanare le finanze di Cartagine. Attacca i privilegi dei ricchi, ne denuncia gli abusi, scopre scandali finanziari, e per questo si mette in urto con la classe dirigente che comincia a complottare contro di lui. Patria ingrata! Un'ambasceria è mandata a Roma, dall'ex nemico, perché il vincitore di Canne sia tolto di mezzo, ma lui fiuta il pericolo, salta sa una nave e scappa fino a Tiro nell'attuale Libano. Anche lì non ha pace. Si sposta a Efeso e incontra Antioco, re di Siria. Gli dà consigli strategici, torna per suo conto in Libano ‐ l'antica Fenicia ‐ e gli procura una flotta. I Romani s'inquietano, temono che il nemico risorga dalle ceneri, e ne richiedono la consegna ad Antioco. Spiegano che "numquam satis liquebit nobis ibi pacem esso Populo Romano, ubi Hannibal erit", mai sarà pace sicura per i Romani là dove ci sarà Annibale. Così lui è costretto a scappare e rifugiarsi a Creta, perfetta "no man' s land" del Mediterraneo. Faccio strani sogni in questo viaggio. E' come se smuovessi i sedimenti di un mare profondo. L'altra notte ho visto un esercito al campo. Portava divise della Grande Guerra. Ogni compagnia si apprestava a macellare una pecora sotto una tenda, solo che le bestie erano grandi come elefanti. Pecore enormi e tranquille, in piedi a gambe larghe, mentre il coltello lampeggiava e altri soldati arrivavano di corsa con ceste ricolme di spighe fruscianti. Ma a un tratto tutti corsero nella stessa direzione: c' era un'elefantessa che partoriva, e dal suo ventre uscì una Venera nera, una dea nilotica di stupefacente bellezza. Da quando sono partito, nel sonno non vedo più figure solitarie ma grandi scene di gruppo. Mandrie, greggi, eserciti transumanti. Sogno spesso cavalli, è come se un centauro mi abitasse. Parto al galoppo, saltando di groppa in groppa con Dioniso in corpo, fino a dove il branco rallenta per l'abbeverata. E poi, sempre più spesso, quella sveglia prima dell'alba senza sapere cioè se il sogno è veritiero o ingannevole, "uscito ‐ come dice Omero ‐ dalla porta di corno oppure da quella d' avorio". Anche Annibale sognava, e spesso erano brutti sogni. Il più orrendo lo fece prima dell'avventura italica, un anno prima di valicare i Pirenei con i suoi novantamila uomini. Cicerone ne scrive nel suo De Divinatione, dedicato ai presagi. "Dopo la presa di Sagunto Annibale sognò che era chiamato da Giove al concilio degli dei. Lì gli venne ordinato di portar guerra all'Italia e gli venne dato un dio come guida. Seguendo le sue indicazioni, cominciò a marciare col suo esercito. Quel dio, allora, gli ordinò di non voltarsi e non guardare mai indietro. Ma lui non riuscì a resistere e, cedendo alla bramosia di vedere, si voltò". "Tum visam beluam vastam et immanem circumplicatam serpentibus...". Vide una belva enorme e orrenda, circondata di serpenti, la quale, ovunque passava, abbatteva ogni albero, ogni virgulto, ogni casa. Annibale stupefatto chiese al dio che lo guidava cosa fosse mai un mostro simile, e il dio rispose che quella era vastitatem Italiae, la devastazione dell'Italia, e gli ordinò di continuare il cammino senza curarsi di ciò che avveniva alle sue spalle, quid retro atque a tergo fieret ne laboraret". Chissà se Annibale partì davvero tranquillo. 74 E chissà se qui a Creta, all'ombra egualmente mostruosa del Minotauro, ebbe tempo di ripensare a quel sogno riavvolgendo il filo d' Arianna della sua vita. Il mostro era davvero la devastazione dell'Italia, oppure altro? Che cosa lo aveva sconfitto in quella campagna militare, se Roma non era mai riuscita a batterlo in campo aperto? Il mostro deforme non era piuttosto la resistenza di Roma, la sua testarda volontà di resistere nonostante la ripetute sconfitte? L'uomo senza pace era nascosto a Creta, e intanto Roma vinceva in tutto il Mediterraneo, aveva conquistato la Spagna, vinto in Africa, battuto i Macedoni impegnandosi in una nuova durissima guerra subito dopo quella con i Cartaginesi. E allora quel mostro non era forse la micidiale forza organizzativa di una potenza capace di affrontare qualsiasi sacrificio? Non era la durezza implacabile e la disciplina di una classe dirigente in grado non solo di conquistare ma anche di governare i territori tessendo relazioni d' élite? Ma certo. Ora ne sono sicuro. L'idra era semplicemente Roma imperiale, cui Annibale aveva tolto ogni freno inibitore. Salgo ad Anogia, ultimo paesone sotto il Monte Ida. Sulla piazza, platani immensi che sembrano entrare nelle case. Nelle giornate d' inverno ‐ giura la gente di qui ‐ i rami si agitano come braccia di Titani, giganti incatenati alla montagna dove Giove fu allattato dalle capre. Fa freddo d' inverno ad Anogia, e l'Ida si copre di un mantello di neve. Qui, nell'aprile 1944 avvenne uno degli episodi più romanzeschi della seconda guerra mondiale. Patrick Fermor, allora trentenne, era stato paracadutato in zona per coordinare la resistenza antinazista, e decise una mossa inaudita: la cattura del generale Heinrich Kreipe, comandante della guarnigione a Creta. Un commando di partigiani greci travestiti da tedeschi mise a segno il colpo e nascose l'alto ufficiale in una grotta. Un giorno Fermor vide che il tedesco, seduto sul bordo della caverna, guardava incantato il Monte Ida ancora coperto di neve e mormorava in latino versi di Orazio: "Vides ut alta stet nive candidum Soracte", guarda il monte Soratte candido di neve alta. L'inglese, che conosceva bene il greco e il latino, proseguì il verso: "Nec jam sustineant onus silvae laborantes geluque flumina constiterint acuto". Il tedesco si voltò, stupefatto. "Ach so, herr Major", disse. E Fermor, emozionato: "Jawohl herr General". Significava: vedi, qualcosa ci accomuna, vecchio mio, anche se siamo nemici. Al che Kreipe, con un sorriso: "Vedo che abbiamo bevuto alle stesse fonti". "Da quel momento in poi le cose furono diverse fra noi", mi raccontò Fermor sessant' anni dopo. "Pensi ‐ commentò pensando alla grossolana distruzione del patrimonio iracheno ‐ quant' erano preparati i militari una volta~ Io ero stato mandato in Grecia perché avevo studiato Omero, e Kreipe aveva fatto otto anni di studi classici. Sono cose che non esistono più". Mentre penso alla straordinaria forza di quelle fonti millenarie, capaci di avvicinare anche acerrimi nemici, il cameriere mi porta una birra "Mythos" con un'occhiata complice. E' come se mi dicesse: "Non avere dubbi, il tuo non è un viaggio visionario". Grandiosa birra greca con vista. Ho in tasca un biglietto aereo per l'Armenia, ultima pazzesca frontiera della nostra storia. 75 Dalle mappe è sparito, il suo nome è stato rubato Poi, nelle prime luci del mattino, eccolo svettare il grande monte di Noé Terminator sull'Ararat la città in capo al mondo Il monte Ararat Il gate "H 46" dell'aeroporto di Monaco è già Armenia profonda. Gli uomini dalle folte sopracciglia aspettano il volo della notte per Erevan con facce da guerrieri, fermi sulle loro Termopili, reduci da infiniti diluvi, abbarbicati alle loro montagne alle porte dell'Asia. Facce ossute, alla Aznavour, segnate da mille invasioni: Cimmerii, Sciti, Parti, Persiani, Tartari, Russi, Turchi. Parto con loro, perché anche Annibale andò su quelle montagne, e fu ‐ nessuno se l'aspetta ‐ l'unico ad andarci senz'armi. Un blitz il suo, una meteora. La resurrezione di un uomo che un giorno smise di fare la guerra e volle fondare una città: Artaxata, sotto le nevi dell'Ararat dove sbarcò Noè. L'aereo decolla nella pioggia sopra piccole luci azzurre, poi emerge come l'Arca su un mare di nubi illuminate dalla Luna. M'accorgo che tutto l'equipaggio è femminile; anche il pilota è una donna, una dea del terzo millennio che mi guida verso un chiarore in fondo ai secoli, in capo al mondo verso un'Atlantide perduta. Dove sto andando? Non esistono guide dell'Armenia nemmeno nelle fornitissime librerie di Monaco. Solo poche pagine, in volumetti sul Caucaso in generale. Sulle mappe l'Ararat è sparito: il monte‐simbolo del Paese sta in territorio turco, a un passo dal confine, e i padroni gli hanno cambiato il nome, ribattezzandolo Buyukagri Dagi. Li sento parlottare, gli armeni, con quella loro lingua crepitante di "R" e di "T", mentre sotto di noi passano lenti i Balcani, il Bosforo, l'Anatolia. Ma quanta strada ha fatto Annibale? Ogni tanto, un'isola di luce come un segno zodiacale: uno scorpione, una lira, un granchio. Non so a che tempo appartengano, se siano cielo terra o mare, costellazione montagna o arcipelago, oppure un alfabeto assiro ingigantito, un lineare‐B per tavolette d'argilla proiettato su dimensioni stellari. Poi l'ombra dell'Ararat chiarisce tutto, testone di drago color rosa‐cenere nella prima luce del mattino. Odore di carburante e albicocche, polvere e montone. Nei chioschi già aperti le albicocche hanno lo stesso colore forte e lo stesso nome dell'alba; gli armellini lo stesso profumo e lo stesso nome dell'Armenia. Donne ex‐sovietiche infagottate spazzano le strade ancora in ombra, poi la bruma si 76 dissolve e la montagna di neve emerge, immensa, sui palazzi stalinisti di Erevan; immateriale su un materasso di vapori; dio vicinissimo e intoccabile, come il Sinai degli ebrei, segregato oltre i reticolati di quella che fu la cortina di ferro. "La guardo e mi carico d'energia" esulta l'architetto Arà Zarian, respirando a pieni polmoni. Poi mi accompagna al museo archeologico tra tori di bronzo e poderose bipenni, carri solari dell'età del ferro e archi da guerra più antichi della guerra di Troia. Tutto emana forza: le barbe mesopotamiche nelle monete, certe teste coniche del mille avanti Cristo simili a quelle del Nemrut Dagi, soprattutto un focolare zoroastriano del terzo millennio, splendido, con gli alari a testa di montone. Il primo stato cristiano del mondo nacque da questa sovrabbondanza di energia barbarica segnata da roccia, acqua e fuoco. Il pastore Arà è amico di Antonia Arslan, l'autrice del libro La masseria delle allodole sulla tragedia armena in Turchia; è stata lei a indicarmi questa guida coltissima e appassionata che mi aiuterà a ritrovare Terminator nel posto più lontano e impensabile della sua odissea. Mi insegna a scrivere "Hannibal" in alfabeto armeno, poi mi apre un testo di Plutarco. "Il re Artassa ‐ c'è scritto ‐ rimase contento dell'idea di Annibale e lo pregò di assumere lui stesso la direzione dei lavori. Sorse così un modello di città grande e assai bella che, assunto il nome stesso del re, fu proclamata capitale dell'Armenia". *** La città di Annibale sorge su un arcipelago di colline basse, poco oltre il monastero di Khor Virap, sul punto d'incontro di tre colori: a Sud il bianco abbacinante dell'Ararat, a Est il verde smeraldo di un grande acquitrino coperto di canneti, a Ovest il giallo‐polvere della steppa. Aveva 130 mila abitanti Artaxata, ed era segnata su tutte le carte dell'antichità. Oggi il vuoto e il silenzio sono tali che sul lato verde, verso il fiume Mezamòr, sento il gracidar delle rane e il tuffo delle carpe tra i papiri, e sul lato giallo distinguo una per una le aggressive formiche armene muoversi con l'addome inarcato tra i cavalli di frisia. La cortina di ferro che qui ‐ unico posto al mondo ‐ nessuno s'è mai sognato di togliere. Maledetto africano, ci ha spiazzato ancora. Una domanda ci perseguita sotto il sole del Caucaso, in mezzo alle rovine coperte di origano e capperi rampicanti. Perché Egli volle costruire una città in capo al mondo? Perché non la progettò per se stesso ma per un re straniero? Camminiamo nel 77 vento fra escrementi di mandrie verso grappoli di fazzoletti votivi annodati agli arbusti in cima alle colline. Cosa cercava Annibale su queste montagne? Forse niente di diverso da ciò che lo spinse a sfidare la morte in battaglia. L'immortalità della memoria. Ma se così è, forse c'era ancora Ercole, il suo mito, a indicargli la strada. Eracle uccisore di mostri e costruttore di città. "Andiamo un po' sulle montagne, la vera Armenia è quella", annuncia eccitato Zarian spingendo l'acceleratore della vecchia Zigulì su per una rampa desertica bestiale. Siamo subito soli tra montagne giallo‐ocra e rosso‐bauxite. Già Asia profonda: Persia, Hindukush, Amu Darija. Gli armeni sentono come rabdomanti l'energia dei luoghi e qui la topografia del sacro è fittissima: in ogni gola, sotto ogni parete, c'è una chiesa medievale. Ahimé anche i confini sono onnipresenti ‐ Karabakh, Iran, Turchia ‐ come se una mano perfida li avesse disegnati apposta per suscitar discordie. Dopo un'oretta lasciamo la strada principale e prendiamo a destra una gola nascosta di nome Noravankh, un Eden di frescura, alberi da frutto e torrenti. Da lontano arriva profumo di carne arrostita: è la casa di un pastore su una radura. Si chiama Vardges e ha due occhi neri accesi come braci. Sotto uno strapiombo ha sistemato tre tavoli di pietra sconnessa e prepara merende per i viaggiatori. La città Yogourth, formaggio, pomodoro e pane tipo "carta musica". Una donna porta una brocca di terracotta con un rosso chiamato Arenì, denso come il sangue, che ci spinge subito in stato di estasi. Non ho mai bevuto niente di simile. E' aromatico, dolce, amaro e frizzante nello stesso tempo. Sa di violetta e ciliegia e svela tutta l'anima della terra da cui proviene. Forse, penso, è l'archetipo del vino. La prima vendemmia di Noè. Il pastore mi chiede perché sono venuto. "Sto cercando un uomo chiamato Annibale, passato duemila anni fa". "Ah ‐ risponde ‐ quello che ha fatto il giuramento contro Roma". 78 Resto di stucco. Un pastore che conosce Annibale, in Armenia. L'uomo mi guarda come per dire: ora devi dirmela la storia. Mi accorgo che anche il resto della famiglia sta aspettando che cominci. C'è un silenzio che si taglia col coltello. Racconto la fuga da Cartagine, l'Oceano, i Pirenei, le Alpi, gli elefanti. Zarian traduce felice, Vardges porta altro vino, il piccolo Armen dai capelli rossi ascolta con occhi sbarrati. "Ma lui raggiunse il suo scopo?" chiede alla fine il pastore. "Sì ‐ gli dico ‐ se è vero che oggi parliamo ancora di lui. Annibale credeva solo nell'immortalità della memoria". E poi: "Vedi Vardges, se quell'uomo non fosse esistito 2200 anni fa, noi non ci saremmo mai conosciuti". Il pastore diventa serio di colpo. Si alza in piedi, versa a tutti altro rosso di Arenì, alza il bicchiere e inizia un lungo discorso sulle vie misteriose del destino. Chiama a raccolta Mosè, Elia, e tutti gli angeli raffigurati su un tappeto oro, rosso e albicocca appeso alla parete. Poi conclude: "Forse Lui non credeva in Dio, ma se non fosse stato in contatto con le stelle non avrebbe lasciato questa traccia". L'ha evocato! E' chiaro a tutti che l'ha evocato e la sua ombra è scesa tra noi per bere lo stesso vino. Il piccolo Armen è mortalmente serio, sua madre ha smesso di affettare mentuccia, il nonno dondola il capo come in un mantra. Tutti aspettano il brindisi. "Che tu beva con me, Anush, e ciò che hai bevuto ti sia di gradimento". E' come se si rompesse una diga. Esplode l'allegria, arriva un agnello arrosto con cipolle e patate, tre nuovi ospiti bevono alla salute del focolare e giurano amore eterno per l'Armenia, poi raccontano di re Tigran il Grande e di Crasso decapitato dai Parti. Siamo ubriachi e felici. Ora anche Noè è tra noi, mentre scende l'ora dei grilli. 79 Per le strade della Turchia sulle tracce del mistero della tomba e del tradimento ad Annibale La beffa della profezia Dalla Turchia verso Oriente Strada per l'Iran, stelle. Ogni tanto un camion esce dalla notte armena, oltrepassa l'ombra dell'ultima frontiera, la muraglia di ferro e ottone che ‐ secondo una leggenda ‐ Alessandro Magno eresse contro Gog e Magog, mostri dalle grandi orecchie al servizio del diavolo. Qui l'Oriente è la direzione maestra; è profumo di gelsomino, spazio per cavallerie, orizzonte di carovane, pastori e fuggiaschi. Anche Annibale potrebbe prenderla, nulla lo fermerebbe. Invece, proprio qui sotto l'Ararat, egli compie un'altra delle sue imprevedibili giravolte e piega verso il Bosforo, dove si compie la parabola della sua vita. Perché lo fa? Come mai torna sul luogo del delitto? Per quale motivo non riesce ad allontanarsi dallo spazio dove i Romani lo cercano? La domande mi vengono incontro in fondo a una notte profumata di tabacco e melone. Non so cosa dire. Ma poi spunta la Luna sopra la bianca montagna di Noé, ed ecco arrivare le risposte. È chiaro. Annibale NON va a Oriente per NON seguire Alessandro, per non essere la copia di nessuno. Le strade altrui non gli interessano. Vuole aprirne di nuove, come il suo grande modello, Ercole uccisore di mostri e fondatore di città. Se andasse a Oriente, sparirebbe nella steppa. A Occidente, invece, sa di tornare visibile e di poter seminare altre briciole di leggenda. Ed è appunto una città che egli fa costruire. La seconda, dopo l'armena Artaxata. Il suo nome è Prusia, in onore di Prusa, il re di Bitinia che accetta di ospitarlo, ma nei secoli diventerà Bursa, prima capitale dell'impero ottomano. Se esiste davvero una traccia del suo passaggio in terra, eccola: sta sull'acropoli di Bursa. Non sul campo di Canne o di Zama, dove non è rimasto nulla, ma in Anatolia, a due passi dall'antica Troia, dove l'Asia finisce sul Mar di Marmara. Un luogo, mi dicono, di bellezza folgorante, a metà strada fra mare e montagna, in mezzo a fiumi abbondanti e sorgenti termali. Annibale fu, in guerra come in pace, un insuperabile interprete dei luoghi. Volo Erevan‐Istanbul, il viaggio va all'ultimo capolinea in un'alba color rame che indora i monti del Tauro. È lì che la storia finisce, nel 183 avanti Cristo, vent'anni dopo la partenza dall'Italia. Il cartaginese s'è costruito un buen retiro a Libyssa, l'attuale Gebze, 40 chilometri a Est di Bisanzio, ma i Romani non lo lasciano in pace nemmeno lì. Un'ambasceria guidata da Tito Quinzio Flaminino 80 è andata dal re Prusa per chiedere la testa dell'illustre protetto, e questi, per non inimicarsi la Grande Potenza, ha accettato di tradirlo. Quando Annibale si scopre circondato, si fa dare il veleno "tenuto in serbo da tempo per un evento del genere". "Liberiamo il popolo romano dalla sua angustia ‐ esclama, prima di morire, nella cronaca di Tito Livio ‐ se esso trova che duri troppo l'attesa della morte di un vecchio. Né grande né gloriosa è la vittoria che riporterà Flaminino su un uomo inerme e tradito. Basterà questo giorno a dimostrare quanto sia mutata l'indole dei Romani. I loro avi misero sull'avviso il re Pirro, loro nemico insediato con un esercito in Italia, che si guardasse dal veleno. Questi di oggi, invece, istigano... a uccidere a tradimento un ospite". Poi, continua Livio, "dopo avere imprecato contro la vita... e invocato gli dei ospitali a testimoni della fiducia violata dal re, vuotò la tazza". Hic vitae exitus fuit Hannibalis. Questa fu la fine di Annibale. Aveva 64 anni. A Istanbul, la sorpresa: nessuno sa nulla di lui. Niente di niente, nemmeno che è morto in Turchia. Se ne parlo, la gente si stupisce: i ricchi dei club esclusivi di Besiktas, e i poveri agli imbarcaderi di Karakoy e Uskudar. Tutti, semmai, chiedono a me le informazioni che cerco e che non posso dare. Di Gebze riesco unicamente ad apprendere che c'è un ponte a tre arcate del grande architetto Sinan e che in quella zona il Mar di Marmara è "good far sailing and boating", buono per la vela e per la nautica da diporto. Anche qui il turismo di massa è passato come un diserbante. Ho pochissimi elementi per trovare la fine della storia. So che da quelle parti l'imperatore romano Settimio Severo, intorno al 195 dopo Cristo, trovò un tumulo di pietre col nome di Annibale e lo fece ricoprire di marmo bianco. Non era solo un gesto tardivo di "pietas". Era anche un segno di rivincita dopo il grande tradimento: Settimio era nato in Africa come il cartaginese, e non aveva più imbarazzi a ricordare il grande conterraneo dopo secoli di "damnatio memoriae". Il monumento è segnalato fino al 1700, poi più nessuna traccia. Appena una riga su una guida: da qualche parte, tra Gebze e il porticciolo di pescatori di Eskihisar dove sbocca il fiume Dil (l'antico Libyssos), esiste una "tomba di Annibale". Sì, ma quale tomba? Costruita da chi? Non c'è verso a saperne di più. Non mi resta che andare sul posto alla disperata. Scrivo su un foglio a grandi caratteri "Anibal Mezar", che in turco vuol dire la tomba di Annibale, e in un mattino di tramontana parto per la riva asiatica determinato a estorcere l'informazione giusta. 81 Il vaporetto "Mehmet Pashà", impavesato nel vento, taglia il mare più trafficato del mondo, s'inclina nelle raffiche tra i gorghi, incrocia pattuglie di migratori a volo radente e carrette mitologiche in rotta per gli ultimi recessi del Mar Nero. A poppa di una chiatta nera di nome "Volgo‐Balt 38" faccio appena in tempo a vedere una marinaia russa stupenda e ferocemente triste. C'è una collisione continua fra il traffico delle mercanzie e quello degli uomini. Ho già gli occhiali offuscati dalla salsedine e penso che non esiste al mondo posto più perfetto per ambientare la fine di una storia. A bordo c'è una giovane pantera in tailleur bianco e nero, la testa inguainata in un velo dello stesso colore e i piedi con stivaletti tacco a spillo. I suoi occhi dicono "sono io la nuova Turchia, l'unica combinazione possibile fra progresso e tradizione", ma un lampo di malizia lascia intuire un messaggio parallelo: "Sotto questi sigilli c'è un giardino di delizie destinato a un uomo solo". Una parte del traghetto le rivolge occhiate di fastidio. La Turchia laica non crede che Islam e modernità possano andare in pace. A Uskudar la strada per Annibale comincia in un turbinar di gabbiani sulla banchina della stazione di Hayderpasha, costruita dal Kaiser Guglielmo Secondo prima della Grande Guerra. È un perfetto set per gialli alla Agatha Christie; un carillon annuncia partenze per favolose destinazioni come Diyarbakir, Gaziantep e Konya; tradotte da 24 o 48 ore di viaggio, con i binari traslucidi che vanno verso il Grande Oriente. Un venditore di frutta secca mi indica la metropolitana di superficie per Gebze, mentre una voce di donna ripete le soste del Pammukkale Express. Parto per l'immensa periferia asiatica di Istanbul con la netta sensazione di andare controcorrente, in un Paese che emigra in massa solo verso Ovest. "Anibal mezar". Guardo il biglietto con la meta e mi chiedo se saprò trovare il mio uomo. Annibale, chi era costui. Ho paura che il viaggio finisca nel nulla, nella nube d'oblio di un narghilè. Nelle stazioni di Feneryolu, Pendik, Erenkoy, l'antica anima mercantile di Costantinopoli è già scomparsa sotto l'urto delle masse anatoliche. Il treno fa dondolare donne infagottate e in dieci chilometri Istanbul è già un sogno lontano. Con Annibale il cartaginese sono finiti anche i greci, i fenici, gli ebrei, gli armeni, i siriani. Un mondo mediterraneo che esisteva ancora non mille, ma solo cinquant'anni fa. 82 Plutarco, vita di Flaminio, capitolo 20, paragrafi 5 e 6. "Sembra ci fosse una vecchia profezia sulla sua morte. Così recitava: 'una zolla libissa ricoprirà il corpo di Annibale'. L'interessato credette che il riferimento fosse alla Libia e dunque a una sua sepoltura a Cartagine, e che là avrebbe finito i suoi giorni. Ma vi è in Bitinia una regione sabbiosa presso il mare e lì un piccolo villaggio chiamato Libyssa...". L'uomo che non aveva mai dato retta agli dei venne beffato dall'unica profezia che si era deciso di ascoltare, quella del santuario africano di Giove Annone, lo Zeus dalle corna d'ariete. Era stato tradito da un gioco di parole. "Gebze stazione di Gebze fine corsa". Scendono tutti. Sulla strada solo tre taxi, con gli autisti assopiti sul volante. Busso al primo e mostro il cartello. "Anibal mezar". Il driver si sveglia di colpo, legge, annuisce e parte nel vento. 83 A Gebze, Turchia: su una collina coronata di cipressi ecco la roccia, quel volto e una scritta: è tutto ciò che resta del condottiero Sulla tomba del generale la leggenda non finisce mai Annibale in una stampa del XVI secolo "ANIBAL MEZAR". Il tassista legge il biglietto che gli ho messo in mano, annuisce e parte senza esitare per una strada a tornanti, in discesa verso il Mar di Marmara. Che fortuna, penso, ho trovato l'unico turco che sa dove è la tomba di Annibale. In cinque minuti siamo nel villaggio costiero di Eskihisar; un forte vento di tramontana spazza il mare verso le isole dei Principi. Il driver esce, interroga il gestore di un chiosco di bibite, poi mi indica, sul lato della collina, un pendio alberato con una decina di vecchie tombe. Gli dico di aspettare e salgo tra le erbe alte. I sepolcri sono di epoca ottomana, portano ciascuno un pilo con un turbante di pietra e una lapide con "sure" del Corano in caratteri arabi. Il più antico appartiene a un certo Osma Hamdi Bey. No, non può essere questo il posto. Il mio vecchio non può dormire tra gli imam. Ridiscendo al taxi, faccio capire all'autista che è altro che cerco. Per spiegarmi, scrivo su un altro foglio: "GENERAL ANIBAL MEZAR". Spero che la parola "generale" lo galvanizzi: gli alti gradi hanno sempre avuto effetti adrenalinici sui maschi di qui, abituati a servizi di leva interminabili fin dai tempi del sultano. Infatti il turco s'illumina, scatta come un attendente davanti al superiore. Non conosce una parola di lingue straniere, ma ce la mette tutta. Nulla deprime un turco più di un cliente insoddisfatto, così lo chauffeur riparte sgommando in salita per la stessa direzione da dove è venuto. Dopo un po' siamo davanti al cimitero comunale. 84 L'autista si volta verso di me con un gran sorriso. Vorrei ridere, ma non posso, so che potrei offenderlo. Che fare? Le pie donne all'ingresso del camposanto mi guardano curiose. Il tassista aspetta che mi decida. Faccio un ultimo tentativo. Strappo un altro foglio del notes e disegno un guerriero antico completo di scudo, lancia ed elmo piumato. Ci riscrivo accanto "GENERAL ANIBAL" e glielo passo. Con violenza l'uomo batte sulla fronte il palmo della mano destra, poi se lo passa con le dita aperte sul cuore. Significa: tu cerchi qualcosa di speciale, e io ti giuro sul mio onore che te la troverò. Riparte, raggiunge un ufficio turistico, entra, e dopo due minuti ne esce più cupo che mai. Nemmeno lì sanno qualcosa di Annibale. E' qui che inizia la caccia al tesoro. Entriamo in una strada tortuosa piena di oreficerie e donne alle vetrine. Il turco non molla. Ormai è in uno stato di ansia ipercinetica. Appena vede un anziano ben vestito dall'aspetto colto, lo punta, gli si ferma accanto e gli mostra il foglio col guerriero antico. E' evidente: cerca un intellettuale che lo tolga dall'impiccio. Seguire dal finestrino i suoi approcci surreali è uno spasso. Anibal mezar, Anibal mezar. Dài che funziona. "Non è una tomba ma è tutto quel che resta di lui, sei stradine concentriche che portano a una roccia" Alla fine il colpo riesce. Aydin ‐ così si chiama l'autista ‐ arpiona un distinto signore in blu che annuisce sorridendo e indica, oltre la periferia orientale di Gebze, una collina coronata di cipressi, con gran vista sul Mar di Marmara. In fondo a un viale di pini marittimi una sbarra con una garritta di poliziotti ci blocca il passaggio. Alle loro spalle, un enorme cartello con la scritta "Tubitak Gebze Yerleskesi", una fondazione scientifica voluta da Ataturk. Più oltre ancora, un college popolato di giovani. Noto che nessuna delle donne è velata. Spieghiamo agli agenti della nostra meta, loro annuiscono, mi chiedono "How are you", poi mi fanno lasciare il passaporto e mi danno venti minuti per la visita. Venti minuti per chiudere un viaggio di un mese. Scendiamo tra i pini, la costa asiatica del Mar di Marmara è tutta ai nostri piedi, l'acqua blu cobalto è spazzata dalla tramontana. Sulla destra una rampa, poi, in cima, il luogo. Non è la tomba, è solo un monumento, ma è tutto quello che rimane di lui. Sei stradine concentriche portano a una roccia, con incisa la sua faccia sul lato del tramonto. Intorno, una corona di cipressi. All'inizio di 85 ogni sentiero, una lapide in una lingua diversa. Ecco alcune righe del testo. "ANNIBALE 247 A. C. ‐ 183 A. C. QUESTO MONUMENTO E' STATO COSTRUITO COME ESPRESSIONE DI APPREZZAMENTO PER IL GRANDE GENERALE NEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI ATATURK. ANNIBALE SCONFISSE I ROMANI DOPO AVER RICEVUTO COME RINFORZI DEGLI ELEFANTI A BARLETTA. QUANDO SEPPE CHE PRUSIA RE DI BITINIA STAVA PER CONSEGNARLO AL NEMICO, SI SUICIDO' A LIBYSSA (GEBZE) NEL 183 A. C. QUESTO MONUMENTO E' STATO COSTRUITO NEL 1934 SU ORDINE DI ATATURK." Il sole è allo zenith, i cipressi si agitano, il mare si gonfia nel vento, i minareti di Gebze chiamano alla preghiera. L'energia del luogo è fortissima. La lapide è stata eretta dopo la morte di Mustafà Kemal, ma su suo preciso ordine, segno che l'idea era contenuta nel suo testamento spirituale. Penso che in Annibale c'era qualcosa di laico che piaceva al padre della patria turca. Annibale non si prostrava davanti a nessun dio, credeva solo nella memoria delle cose fatte. Ed è quella memoria che Ataturk ha voluto tenere in vita. E poi quel monumento protetto da guardie, circondato da una fondazione scientifica, cioè da un mondo agli antipodi della moschea: Annibale non è consegnato a una cripta buia ma a un luogo illuminato della mente. Ma c'è un altro dettaglio che commuove. La storia degli elefanti fatti arrivare a Barletta. Indica il desiderio di istruire il popolo sulla vita di un Grande. Peccato che tutto questo sia finito. Oggi i turchi hanno dimenticato Annibale. Il passato antecedente all'Islam non conta più niente in Turchia. Il politeismo pagano figurarsi, con la sua grande lezione di democrazia laica. Oggi i muezzin gridano ogni giorno più forte, ogni anno qualche negozio in più chiude per il ramadan e rinuncia al piacere del vino. M'accorgo che l'autista del taxi s'è tolto il cappello leggendo la lapide in lingua turca. Non sapeva, 86 Aydin, di avere un simile personaggio sotto casa. Soprattutto non sapeva dell'ammirazione di Ataturk. Mi guarda con gratitudine per avere imparato tutto questo. Alle 17 il traghetto Okmeydani si stacca dalla riva di Eskihisar quasi senza bisogno dei motori, tanto forte è la tramontana che lo spinge al largo. Guardo dal mare la collina con i cipressi che segna la tomba di Annibale. Sono l'unico a bordo che sa cosa c'è lassù, e sento che questo mi dà una forza visionaria enorme rispetto agli altri passeggeri. Tutto il Mar di Marmara ha per me un senso nuovo e invisibile, di cui la gente accanto a me non ha la minima idea. Certo, non ho trovato le sue ceneri, ma il suo mito sì, ed è quello che conta. Passa un sommergibile nero, silenzioso e immateriale come una balenottera, identico ai sottomarini ancorati all'ammiragliato di Cartagena. Mi sporgo dalla murata e ho gli occhi umidi non so se di salsedine o di commozione. Ora sarà dura fare a meno del sogno, ma forse, grazie a quell'uomo, qualcosa di nuovo è entrato per sempre nel mio modo di viaggiare. Vorrei dire ai turisti accanto a me: buttate via guide e tour operator, costruitevi da soli i vostri sentieri invisibili. Ritrovate la dimensione fantastica del viaggio. La collina dei cipressi sparisce all'orizzonte. Sono gonfio di ammirazione. Hai vissuto in piedi, Hannibal, fino all'ultimo dei tuoi giorni. Hai preferito morire alla grande piuttosto che svanire nel nulla. Mi torna in mente un motivo di Neil Young che gli si attaglia alla perfezione: "It's better to burn out, than to fade away". Il traghetto taglia le onde controvento verso il Bosforo. Anche un analfabeta, qui, potrebbe scrivere la parola "fine" su un romanzo. Istanbul ti regala mille finali possibili ‐ Yalova, Kadikoy, Kaydarpasha, Ortakoy, Besiktas, Rumeli Feneri ‐ ognuno più sensazionale del precedente. Ecco perché Lui, ineguagliabile regista di se stesso, ha scelto di morire qui: perché la leggenda non finisca mai. Siamo al capolinea, Annibale ha vinto la sua scommessa con la memoria. Ma la storia non finisce qui. 87 L'ultima tappa alla scoperta di chi sconfisse Annibale Lo invochiamo e lo cantiamo negli stadi, ma di lui sappiamo poco o nulla Dell'Elmo di Scipio vincitore a Zama Piatto decorato con il busto di Scipione l'Africano ANNIBALE addio. Un sipario di pioggia si chiude sul Mar di Marmara lasciando una domanda in sospeso. E Scipione? Tuona sul Bosforo, dalla finestra dell'albergo vedo i traghetti bucare il monsone che viene dal Mar Nero e penso che è strano: il Paese che "dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa" sa poco o niente di come si chiude la storia del vincitore di Zama. Non sa che fece una fine ingloriosa, in esilio, tra le paludi dell'Ager Campanus, condannato dal parlamento dei senatori per aver coperto le malversazioni di un parente. Una morte triste, lontano da Roma ingrata, nella proprietà di famiglia a Literno, tra Napoli e il Volturno. E' vero: sappiamo poco o niente dell'uomo che invochiamo a squarciagola negli stadi, e forse non c'importa nemmeno di saperlo. Scipio è stranamente assente come mito nel Paese dei santi e dei navigatori. Nel mio viaggio ho incontrato decine di ponti e fontane di Annibale. Il nome del Cartaginese si annida ovunque nel territorio italiano e talvolta riscuote simpatia come quello di Robin Hood e dei suoi arcieri di Sherwood. Perché non succede con Scipione? Giochi del destino. Il vincitore della guerra muore nello stesso anno di Annibale, pare dopo avere appreso la fine del grande avversario. Per 35 anni egli è stato la sua unica ossessione e ora, senza di lui, è possibile che si sia sentito solo all'improvviso. E' vero: Annibale gli ha rubato tutto, il padre e lo zio in battaglia, la gioventù e la bellezza. Ma è stato anche il suo modello. Gli ha insegnato le regole d'ingaggio nella battaglia campale, la micidiale manovra avvolgente, l'uso della cavalleria, l'abilità diplomatica nel rubare alleati al nemico, la passione per la cultura ellenica e tanto altro. Non a caso, dopo la battaglia di Zama, è su Annibale che Scipio fa riferimento come garante della pace con Cartagine. 88 Ebbero, Scipione e Annibale, spericolate vite parallele: ciascuno andò audacemente a sfidare il nemico in trasferta, e ciascuno lottò contro le invidie della classe nobiliare. Entrambi finirono in esilio, costretti ad andarsene dalla patria che avevano reso grande. E come il romano fu l'unico dei consoli a fregiarsi del nome di un popolo vinto, così Annibale spese più tempo in Italia che nella sua Cartagine. Se Scipione era l'Africano, Annibale era sicuramente l'Italiano. Ora ne sono sicuro. La storia non può finire così, sotto la pioggia di Istanbul, lontano dal grande teatro degli eventi che fu l'Italia. Al racconto manca l'ultimo sigillo: la tomba di Scipione in Campania. Per trovarla ho con me solo un passo di Plinio che narra di un uliveto piantato dalle mani stesse del console, e di un gigantesco mirto accanto a una grotta abitata da un serpente. "Ma che ci andate a fare a Villa Literno?" mi avvertono a Napoli. Chiedo perché non ci dovrei andare. "E' il peggio del peggio, con Giugliano e Casal di Principe". Capisco, cumpà, ma io è lì che devo andare, ci abita Scipio. "Ah, nù parente vostro...". Sì, nu parente mio. Nel Sud è impensabile smentire le ragioni della famiglia accampando quelle della storia. Ancor più difficile è spiegare che non vado a Villa Literno, capitale degli inquieti mandriani da bufale, ma nella vicina e sconosciuta Liternum, sulle rovine di una piccola colonia fondata dagli Scipioni. Passo Cuma della Sibilla, i fumanti Campi Flegrei, l'antica Via Campana tra Capua e il Tirreno, il margine dell'Ager Campanus punteggiato di roghi di munnezza, e a un tratto la segnaletica comincia a sparare un nome squillante: patria. Marina di Patria, Lago di Patria, Quadrivio di Patria. Liternum è lì in mezzo, dimenticata tra svincoli, canali, sfasciumi, canneti, prostitute e alberghi non finiti. E' questa la patria che circonda le ceneri di Scipione. Il nome invocato negli stadi qui non se lo fila nessuno. Non c'è nessun pantheon, nessuna tomba, nessun monumento, nessun cartello a ricordarlo. Il turco Mustafà Kemal ha fatto per Annibale molto di più di quanto l'Italia ha fatto per il suo Napoleone. Liternum è solo un ammasso di rovine coperto d'erbacce e recintato dalla locale soprintendenza. Le rovine più degradate dell'Italia, ma nobili e indifferenti allo sfascio che le circonda, all'immondezzaio che le ricopre e al grande nulla che ci inghiotte tutti. Canneti, vento, mandrie immobili nel cielo nero verso Baia Domizia, Suessa Aurunca e le Termopili del Sannio. Il fiume va, solenne, pigro, grigioverde, diventa mare aperto oltre Castel Volturno, piccola isola di ordine nel caos campano. Mi chiedo perché non è rimasto niente della romanità negli italiani di oggi. Perché la più grande classe dirigente del mondo antico è scomparsa nel nulla senza lasciare eredi? Che cosa ha cancellato quell'ineguagliabile senso della res publica che segnò Roma al tempo di Annibale? Lavorando su Annibale ho misurato la forza di Roma. Ciò che sconfigge il Cartaginese non è la potenza militare, ma l'incredibile rete di collegamento costruita tra le classi dirigenti delle province italiane. E' una struttura solidissima e aperta, che consente anche a un notabile umbro, etrusco o dell'Apulia, di diventare senatore o console e di imparentarsi con le grandi famiglie. Mai, invece, un principe numidico avrebbe potuto entrare nel "Gerontion" di Cartagine, e mai un tessalo o un epirota avrebbero potuto diventare cittadini ateniesi. Dopo il trionfo di Canne, nel 216, Annibale sente odore di sconfitta. Perché? Si è reso conto che 89 uno Stato capace di non arrendersi di fronte a una simile disfatta è un grandissimo Stato, capace di qualsiasi cosa. E' per lo stesso motivo che, anni dopo, durante il suo blitz su Roma, egli devasta un santuario italico ‐ quello di Scorano, l'antica Lucus Feroniae ‐ macchiandosi di sacrilegio. Lo fa perché è esasperato dai popoli della Penisola che si ostinano a non schierarsi con lui nonostante la sua netta superiorità militare. Radici cristiane dell'Occidente? Prima delle radici cristiane ci furono le radici greche e romane, fondamento di un concetto di governo basato sulla "lex" e la responsabilità dal basso. Un'idea che fu semmai smantellata dal cristianesimo, portatore di un'idea teocratica orientale che smantellava i legami trasversali fra élites e trasformava i capi supremi in "unti del Signore". "Quel mondo ‐ mi ha detto un giorno l'inestimabile compagno di viaggio Giovanni Brizzi ‐ non finì con le invasioni barbariche ma con la morte di Giuliano l'Apostata, l'imperatore che tentò inutilmente di tornare ai vecchi dei". E' finito un viaggio nel tempo, il più lungo della mia vita. Dall'Atlantico all'Ararat, rivedo un film pieno di facce antiche: Sanniti, Armeni, Celtiberi, Numidi, Insubri, Cretesi. Si accendono altri roghi, a Liternum è l'ora dei viados e delle lucciole venute dall'Africa. E' penoso ripensare al mondo antico dal fondo di questo disastro. L'impero romano aveva diecimila ‐ dicansi diecimila ‐ città munite di anfiteatri, terme, acquedotti e fognature. Le frumentazioni mobilitavano quasi un milione di persone. La sola Roma aveva tredici acquedotti per un totale di 16 milioni di litri al giorno, livello superato solo nel 1960. Nulla vi fu di lontanamente paragonabile nel medioevo, nemmeno nella favolosa Spagna degli arabi. Solo la Londra vittoriana riuscì a essere come Roma, ma 1700 anni dopo. Il mondo ha nella memoria due apocalissi mitiche ‐ il Diluvio e la fine dell'Atlantide ‐ e un'apocalissi reale: la fine del mondo antico. Ne possiamo leggere i segni monumentali ovunque, dalla Britannia alla Libia, e quei segni svelano la nullità dell'oggi. Il dominio di Roma sul mondo era di tipo imperialistico fin che si vuole, ma gli dei altrui erano rispettati e inglobati nel Pantheon. Le élites dei Paesi conquistati entravano a far parte della macchina di governo: anche africani e asiatici potevano diventare imperatori. La leadership non era fatta solo di legioni, ma di strade, ponti, sicurezza, e la sua "auctoritas" mai avrebbe consentito anarchie di tipo iracheno dopo una vittoria militare. Al largo s'è accesa una luce verde pallido, le bufale nei canneti sono immobili come statue di bronzo. 90
Scaricare