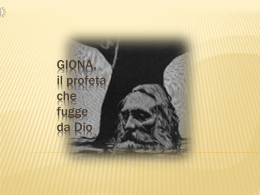VIVERE IL VANGELO DELLA MISERICORDIA E DELLA PACE AI
POVERI
Lectio del libro di Giona
L’unica cosa che ci fa vivere è la compassione (Drewermann)
Dio si comunica rubandoci. Si rivela sconcertandoci (de Certeau)
INTRODUZIONE
Poiché la lectio verte sull’intero libro di Giona, mi pare necessario dedicare questo primo incontro a una introduzione
generale al libro stesso che ci aiuti a inoltrarci nel modo più adeguato nell’analisi dei singoli brani.
1. Data di composizione. Il libro risale al secolo V o IV; in ogni caso prima del 200 a.C., perché a questa data esso
faceva già parte dei dodici profeti cosiddetti minori. Siamo comunque nel periodo successivo all’esilio (597: inizio delle
deportazioni; 587: caduta di Gerusalemme; 538: inizio del ritorno in Palestina per decreto di Ciro).
2. Contesto vitale e scopo. Se noi comunità giudaica siamo l’unico popolo che Dio si è scelto, perché Dio concede
prosperità e perdono anche a quelle nazioni pagane che, oltre a non credere in lui, ci perseguitano? Lo scopo del libretto
è quello di combattere l’integralismo e il fanatismo religioso (cfr Bianchi, 135).
3. Genere letterario. È una lunga parabola o “racconto esemplare” (Ravasi, I profeti, 276) o “midrash” (Bianchi, 136).
Vediamo perciò che cosa è la parabola, perché Dio parla in parabole e come dobbiamo leggerle.
Nessun dubbio può essere sollevato sul fatto che il nostro brano sia una parabola.
a)Che cosa è la parabola. È un racconto fittizio che dà da pensare in una determinata direzione e dà da fare nell’unico
senso ad essa conseguente, sollecitando uditore e lettore a lasciarsi sorprendere, provocare e convincere dall’unico
inequivocabile messaggio in essa contenuto. Vediamo in modo analitico.
+ Racconto. Occorre una situazione che si modifica, una storia in movimento che viene narrata.
+ Fittizio. Che la vicenda raccontata sia realmente accaduta o no, non ha importanza. Decisivo, invece, è che abbia una
sua logica intrinseca e attinga il materiale da una situazione socio-culturale specificamente connotata da un proprio
simbolismo. Qualcuno (Pitta, 755) preferisce parlare di “racconto anfibologico, vale a dire narrazione con duplice
significato, che trasmette continui riferimenti agli eventi oppure alle situazioni che l’ hanno generata […]. Lo stesso
intreccio narrativo […] può riferirsi ad eventi realmente accaduti” (come ad esempio la parabola dell’amministratore
disonesto: Lc 16,1-8); ma non è il nostro caso.
+ Dà da pensare. La valutazione del lettore è assolutamente necessaria (nel nostro caso, egli deve dissentire dal
comportamento di Giona e consentire col comportamento di Dio, da valutare come l’unico adeguato). Per la verità, la
collaborazione del lettore è di rigore per qualunque testo, in quanto “il lettore come principio attivo dell’interpretazione
è parte del quadro generativo del testo stesso” (Eco, 7). D’altra parte la funzione relazionale della narrazione, tanto più
se parabolica, risulta ancor più evidente. Infatti “la narrazione non mira, come l’informazione, a comunicare il puro in sé
dell’accaduto, ma lo cala nella vita del relatore , per farne dono agli ascoltatori come esperienza […]. L’informazione ha
il suo compenso nell’attimo in cui è nuova. Essa vive solo in quell’attimo, deve darsi interamente ad esso e spiegarglisi
senza perdere tempo. Diversamente la narrazione; che non si consuma, ma che conserva la sua forza concentrata e può
svilupparsi ancora dopo molto tempo” (Benjamin, in Casetti – Giaccardi, 341). In questo senso la parabola “deve
contenere una verità più alta (Martini, Perché Gesù…, 103) di quella dei fatti materialmente intesi. Peraltro tale verità
non deve essere conosciuta né troppo presto (altrimenti il resto del racconto non avrebbe alcun senso plausibile: se mi
arrestassi, nella lettura, al cap. 3 e prendessi una decisione pratica conseguente, mi verrebbe a mancare un buon quarto
della parabola, il quale è importante almeno come i tre quarti che lo precedono), né troppo tardi (se indugiassi sui
particolari più minuti per spremere il valore simbolico di ciascuno, finirei con l’interpretare la parabola come fosse
un’allegoria e non arriverei mai al dunque che – ripetiamolo – è univoco e chiarissimo). Proprio per questo “il senso, nel
racconto, non si dà nell’istante” (Casetti – Giaccardi, 343). In ogni caso resta vero che aspetto narrativo e aspetto
argomentativo sono, nella parabola, strettamente intrecciati e perciò non devono essere dissociati (cfr Fusco, Oltre…,
123-128).
+ Dà da fare. La parabola si limita a rimuovere i pregiudizi, sciogliere i dubbi che ostruiscono la strada della fede in
JHWH, ha il compito – per così dire – negativo e propedeutico di eliminare gli ostacoli all’accoglimento dell’annuncio
salvifico; apre un varco verso la novità del vangelo: “è solo un tratto di strada; può condurre soltanto fino alle soglie
dell’annuncio, che resta intatto nella sua fragilità, nella sua nudità” (Fusco, in NDTB, 1094), tanto - appunto – da poter
essere accolto responsabilmente o clamorosamente disatteso. Anche da questo punto di vista, “le parabole sono inviti
1
aperti che aspettano una risposta. La parabola non è efficace finché non venga liberamente fatta propria. Rota Scalabrini
(a.c., 79) giunge a qualificare le parabole come “trappole”, in quanto “l’interlocutore di Dio [perciò anche il lettore] è
costretto a decidersi, a dire da che parte vuole stare, a chiarire a se stesso la propria relazione rispetto al messaggio di
Dio” (cfr anche Ricoeur – Juengel, passim; tuttavia è utile precisare che non si tratta di “una trappola mortale, non è
un’arma che uccide: è la spada a doppio taglio della parola di Dio che separa il bene dal male, che asporta ciò che è
malato e porterebbe alla morte” [Meynet, Vedi questa Donna?..., 59]); le parabole fanno appello alla razionalità
dell’uditore e del lettore (cfr Fusco, in NDTB, 1094), perché diventino “più vulnerabili all’annuncio”. Insomma,
“malgrado le apparenze, la parabola è un genere di estrema gravità. È in gioco la mia vita. Non soltanto la vita effimera
che condivido con ogni essere mortale per così poco tempo, ma proprio ciò che il Vangelo chiama la vita eterna. Non
c’è un minuto da perdere: il tempo è contato e la minaccia di morte è sempre presente, ora più che mai. Praticamente
sempre fuori del tempo, la parabola evangelica punta per questo allo stesso tempo verso l’istante presente, quello della
vita, e al momento finale, quello della morte: più ancora, dice che sono lo stesso” (Meynet, Vedi questa Donna?..., 10).
Un articolo di Meynet del dicembre 2003 rimarca “il carattere spesso enigmatico delle parabole”, sicché, “se l’enigma
rappresenta il genere letterario sapienziale per eccellenza, la parabola appartiene anch’essa, nonostante la sua apparente
semplicità, alla letteratura sapienziale [...:] frutto della sapienza di colui che l’ha coniata [...,] è rivolta a chi è ritenuto
capace di decifrarla [...:] un enigma proposto alla sagacità del lettore” (“PSV”, n. 48, a.c., p. 114): una tesi, questa,
peraltro già presente in Vedi questa Donna?...(anno 2000).
b) Perché Dio parla ( o, meglio, può parlare) in parabole. Rifacendoci al libro omonimo di Martini, riassumiamo la
sua risposta (cfr pp. 104-108). 1)Esiste una somiglianza tra il corpo e l’anima, che consente il passaggio dal visibile
all’invisibile; 2)c’è una qualche proporzione tra la storia umana e il regno di Dio, sicché da quella si può passare a
questo; 3)Dio è narrabile: essendo un Essere personale e libero, interviene nella nostra storia compiendo azioni che si
possono raccontare come le nostre azioni umane; 4)pur avendo a che fare con il regno di Dio, la storia non coincide con
esso; sicché “guardando il mondo si scopre il mistero di Dio, ma deve esserci rivelato” (Ib. 107).
c)-Come leggere le parabole. Sempre Martini (pp. 49-52) dà i seguenti suggerimenti: 1)Porsi in atteggiamento
contemplativo; 2)Ascoltare (leggere) con calma, senza pretendere di capire tutto subito (“La fretta è di Marta: Gesù però
loda Maria”); 3)Interrogare Gesù con la convinzione di fede che egli darà la risposta giusta al momento giusto (“Non
sempre è necessaria la luce accecante; il Signore si può rivelare nel mistero, nel nascondimento”). Su alcune
caratteristiche della “pazienza” nell’interpretazione richiama l’attenzione anche B. Maggioni: “Si buttano semi, non
alberi; non l’assillo del concreto nel senso dell’efficienza, ma la lentezza della contemplazione, la saggezza della
ripetitività; non l’ansia delle molte cose, ma la volontà di assimilarle” (“Riv. cl. it”, a.c., pp. 563-564).
4. Aspetto letterario. Si tratta di un’opera magistrale, che “maneggia la prosa come uno dei migliori classici ebrei”
(Schoekel, 1146). Essa rielabora elementi di racconti popolari di diversa provenienza (miti indiani, persiani, egizi, greci)
diffusi nel porto di Giaffa (Wolff, 15-35), piegandoli però all’originale messaggio di fede iavista che intende
trasmettere, sicché le tangenze tra Giona e questi miti, lungi dall’intaccare la sostanza del nostro racconto, si limitano
alla forma espressiva. “È un racconto in cui il gusto di narrare, l’eleganza e la leggerezza non hanno confronti in tutta la
letteratura profetica” (von Rad, 340).
5. Destinatari. Sia i pagani sia, soprattutto, gli ebrei.
6. Contenuto o “rema”. Lo sintetizzo schematicamente in due serie di affermazioni. a) Persino i pagani, per di più
oppressori accaniti, possono - se vogliono - convertirsi dalla loro condotta morale riprovevole, e così essere a tutti gli
effetti perdonati da Dio, che mai cessa di amarli. b) Di conseguenza, i credenti in JHWH devono convertirsi a questa
idea di un Dio che ama e perdona assolutamente tutti, pagani oppressori compresi, e adottare una prassi corrispondente a
questa idea e cioè i credenti in JHWH devono, quanto meno, tendere ad amare e perdonare tutti indistintamente.
Dunque, conversione morale dei pagani nemici e conversione religiosa dei credenti. Tuttavia, poiché quest’ultima è più
dura da accettare e più difficile da realizzare, l’Autore “vi ha calcato la mano” (Schoekel, 1151); in effetti, gli ultimi due
versetti dell’opera (Giona 4,10-11) costituiscono la chiave interpretativa indispensabile di tutto quanto il libro, così
come gli ultimi due versetti della parabola del figlio prodigo (Lc 15,3132) lo saranno della parabola omonima. “Giona
vuol convincere i particolaristi ebrei a non attendersi la punizione dei pagani, ma a temere per se stessi: Guai a voi,
ebrei, perché se Dio avesse inviato ai pagani, quali i niniviti, i profeti che ha inviato a voi, essi avrebbero fatto penitenza
(cfr Mt 11,21)” (Tufariello, 6).
7. Struttura. Comprende cinque scene o quadri.
I. Vocazione e fuga di Giona (1,1-3)
II. Tempesta e bonaccia (1,4-16)
III. Angoscia, pentimento, gratitudine di Giona (2,1-11)
IV. Conversione dei niniviti e compassione di Dio (3,1-10)
V. Quale volto di Dio? (4.1-11).
8. Particolari che sorprendono e danno da pensare.
2
- In generale, poche decisive parole e molti fatti provocatori. Senso: Dio fa il suo “mestiere” di salvatore parlando e
operando nella concreta storia umana.
- In particolare, poche essenziali parole rivolte prevalentemente ai niniviti, molti fatti straordinari destinati soprattutto a
Giona. Senso: la conversione dei pagani persecutori è più agevole di quella dei credenti sedicenti giusti.
- Cinque parole soltanto, pronunciate da Giona sotto comando di Dio, producono la conversione morale dei niniviti.
Senso: l’unico redentore anche dei pagani resta Dio, non il suo profeta. (Consiglio l’audizione delle Cantate di J.S. Bach
BWV 61 e 62 intitolate Nun Komm, der Heide Heiland [Vieni ora, Redentore dei pagani] nell’interpretazione di
Rilling).
- Giona non scambia mai una parola con i niniviti dialogando con loro. Senso: i credenti, purtroppo, compiono talora il
proprio dovere per dovere, senza coinvolgimento affettivo con le persone cui sono mandati. Viene in mente la frase di
Caino: “Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4,9).
- Addirittura i niniviti, “il massimo della disumanità” (von Rad), sono amati dal Signore. Senso: Dio”fa sorgere il sole
sui cattivi e sui buoni, e manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45).
- I niniviti non cambiano religione, ma “ciascuno si converte dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue
mani” (3,8). Senso: vi sono dei valori morali che hanno la precedenza sui valori religiosi, in quanto se mancassero quelli
non potrebbero darsi questi; in altri termini, ciascuno deve fare il passo secondo la gamba.
- Benché ribelle, Giona non è abbandonato da Dio, dal quale anzi viene salvato. Senso: l’amore di Dio per i pagani non
toglie nulla al suo amore per i credenti; egli ama tutti, credenti e pagani.
- Giona fugge, tace, dorme, desidera morire: va sempre più giù. E viene tirato su da Dio. Senso: nessuno è all’altezza
della propria situazione; non ci si salva, ma si è salvati da Dio.
- Il libro è intriso ora di fine ironia, ora di sarcasmo pungente. Un solo esempio: “Giona, figlio di Amittai” equivale a
“Colomba, figlio di Fedeltà o Veracità”; ma si dà il caso che la colomba voglia la distruzione dei nemici, e la fedeltà o
veracità se la dia a gambe di fronte al pericolo...
- Ripetizione ossessiva del termine “grande”. Senso: i valori e i disvalori in gioco sono letteralmente decisivi, ne va della
vita stessa.
9. Giona nel NT. a) Citazioni esplicite o allusive: Mt 12,39-41; 16,4; 26,38; Mc 14,34; Lc 11,29-30.32. b) Analogie
suggestive: Mt 18,23-35 (il debitore spietato e incoerente); 20,1-16 (gli operai con lo stesso salario); 21,28-32 (i due
figli); Lc 13,24-30 (la porta chiusa); 15,11-32 (il padre e i due figli)
Da notare che le citazioni del libro di Giona fatte da Gesù non possono provare la storicità dei fatti ivi narrati. “Gesù
utilizza questo apologo dell’AT come i predicatori cristiani utilizzano le parabole del NT: è la stessa preoccupazione di
insegnare con immagini familiari agli uditori, senza che sia portato un giudizio sulla realtà dei fatti” (Bibbia di
Gerusalemme, 1550).
A conclusione, qualche spunto da assumere come chiave di lettura del libro.
* Elaborare un mio progetto su Dio, o inoltrarmi nel progetto che Dio Padre ha da sempre pensato per me e che mi
rende, grazie al suo Spirito, “copia” sempre più fedele di Gesù?
* Tenere salda la mia fede come un tesoro da godere in santa pace, o viverla come un regalo da partecipare agli altri con
senso di responsabilità?
* Derousseaux (a.c., 41) rileva: “Giona è l’unico libro biblico in cui appare costantemente l’umorismo, ossia una certa
distanza sorridente da se stessi e dalle proprie convinzioni più serie”. Ne traggo l’invito a leggerlo anche da questo
punto di vista: un po’ meno di serietà, e un po’ più di umorismo o autoironia, che mi permette di non dimenticare
l’essenziale, vale a dire l’amore universale di Dio.
VOCAZIONE E FUGA
(Giona 1,1-3)
A) LECTIO
* V. 1. a) La parola di una persona determinata (Dio) viene rivolta a una persona determinata (Giona). Importanza e
insostituibilità del rapporto interpersonale. b) Giona = colomba. Ora la colomba nella Bibbia è simbolo di amore (Ct
2,14; 6,9), bellezza (Ct 1,15), prontezza (Sal 55,7), fiducia (Sal 74,19), pace (Gen 8,11), semplicità (Mt 10,16), dono
per il sacrificio a Dio (Lv 12,8; 14,22) e dello Spirito santo (Mt 3,16; Mc 1,10; Gv 1,32) (cfr Lurker, 56-57). Ecco
allora l’ironia: Giona assume un comportamento in opposizione diametrale a questi simbolismi. Analoga osservazione si
deve fare circa “Amittai”( = fedeltà). c) Non “questa parola” (traduzione CEI), bensì “la parola”: è lei il soggetto agente,
il protagonista indiscusso; non un Dio in sé, ma Dio quale essere personale che parla e interpella; “è come se il soggetto
umano perdesse consistenza e questa venisse guadagnata dalla parola di Dio” (Schoekel, 1154): “come potrebbe Dio
esistere e fare esistere senza sorprenderci? L’AT non è solo l’affermazione del Dio Uno, è la storia della sua invasione”
(Beauchamp, 322). d) ”Fu rivolta”: è un passivo divino o teologico = il Signore rivolse la sua parola. Mowinckel, citato
da von Rad (II, 112, nota 12) traduce con rara efficacia: “La parola di JHWH divenne realtà attiva presso N.N.”.
Insomma, “in principio la Parola” (Gv 1,1). e)La vocazione di Giona è descritta in un solo versetto. Ciò che rende
3
profeta Giona è Dio che gli parla, né più né meno che Dio stesso. Non di più, perché che c’è di più grande di Dio,
Signore del cielo e della terra? Non meno, perché in tal caso Giona non sarebbe profeta, uno che parla “in nome di” Dio
e “davanti” all’umanità (Ravasi, in Schoekel, 8). Il Signore Dio, che con la sua parola ha dato inizio alla storia
universale (Gen 1), ora dà inizio alla storia di Giona come profeta.
*V. 2. a) ”Àlzati”: è imperativo. Chi comanda è Dio, chi obbedisce Giona. Il verbo ordina un cambiamento: il profeta da
seduto scatta in piedi o, forse meglio, passa dal clinostatismo all’ortostatismo. Poiché Dio ha parlato, niente è come
prima. b) ”Va’”: anche qui un imperativo. Dopo il movimento verticale, ecco quello orizzontale. La vocazione è in
funzione della missione, Dio chiama perché il chiamato “vada” (Gen 12,1) altrove, presso altri da sé. c) Ninive è la
capitale dell’impero aggressore e oppressore; pagana, è una metropoli sterminata, simbolo di tutta l’umanità non
credente (Wolff, 116; Schoekel, 1154.1155). d) ”La loro malizia è salita fino a me”: il compito del profeta è, in questo
caso, quello di “gridare contro”. “Neanche per sogno gli viene detto: vai a Ninive e salva all’ultimo istante la città dalla
sciagura [...]. Se il compito fosse questo, Giona ci vedrebbe chiaro. Ma ciò che invece lui, di fatto, deve andare a dire è
una pura opposizione contro la città assira, senza scopo e risultato. Predica contro di essa: questo è tutto. In tal caso non
è forse lecito pensare che proprio questo mette in ansia una persona: doversi levare per un puro e semplice mettersi
contro?” (Drewermann, 31; v. anche Schoekel, 1155). Cfr Sodoma e Gomorra (Gen 18,20 21). Giona deve dire non
quello che vuole lui, ma quello che comanda il Signore, evidenziato dal terzo secco imperativo: “proclama!”; egli non
deve aggiungere né togliere nulla alla parola di Dio in quanto tale, anche quando risultasse ostica e dura da accettare. e)
Tenuto conto dei rapporti di autorità allora vigenti, è implicito il dovere per Giona di rivolgersi non solo genericamente
agli abitanti della città, ma a chi in essa ha potere decisionale, il re. Insomma il profeta deve fare di tutto perché tutti
conoscano il messaggio di Dio, di cui egli è latore – quanto indegno, lo dirà il prosieguo del racconto.
*V: 3. a) ”Giona si alzò per fuggire”: anche qui abbiamo un moto verticale seguito da uno orizzontale, opposto a quello
ordinato dal Signore. A dirla tutta, Giona è in buona compagnia quanto a riluttanza, dato che altri profeti muovono
obiezioni alla missione loro affidata: Mosè (Es 4,10), Elia (1 Re 19,3-18), Osea (Os 3,1-3), Geremia (Ger 1,6). Giona
però – e questo fa la differenza - tace e disubbidisce (Bernini, 257): egli “fugge in un mutismo che indica non solo la
sua paura, ma anche la sua volontà di fare come se Dio non gli avesse parlato” (Bianchi, 138). Per questo il suo gesto è
“di un’insolenza superba e rara. Mentre, prima di lui, chi rifiutava di rispondere a Dio rimaneva pur sempre davanti a
Dio, Giona si sposta deliberatamente da davanti a Dio, espressione alla quale occorre dare tutto il suo contenuto
plastico” (Neher, 165). b) ”A Tarsis”: cfr Is 23,6; 66,18-19. “È l’estremo occidentale opposto all’orientale Ninive”
(Schoekel, 1156), ubicata probabilmente sulle coste meridionali della Spagna. Giona cerca solo tranquillità e sicurezza;
infatti a Tarsis non si conosce JHWH (Is 66,19) e questo lo lascia tranquillo, visto che JHWH è anche molto esigente;
inoltre Tarsis è un centro fiorente dal punto di vista commerciale (vi si lavora l’argento: Ger 10,9), e questo – con la
prospettiva di un potenziale successo economico – gli dà sicurezza (Wolff, 117). c) ”Lontano dal Signore”: rimarca, se
mai ce ne fosse bisogno, la disobbedienza di Giona: via, il più lontano possibile da Dio! D’istinto viene in mente il
“paese lontano” nel quale si reca il figlio prodigo (Lc 15,13.20), dopo avere abbandonato la casa paterna. Un profeta, e
dunque un uomo di fede, si comporta da non credente, non fidandosi di Dio che gli ha parlato, dato la vocazione,
indicato la missione. d) ”Scese a Giaffa”: cfr Am 9,1-4; Sal 134; 1 Re 13 (Elia fugge da Gezabele). Incomincia la
discesa di Giona, che arriverà sino al fondo del mare. e) ”Pagato il prezzo”: anziché metterci del suo per fare la volontà
di Dio, Giona paga per fare di testa propria, adica alle proprie responsabilità. f) “Lontano dal Signore”: è una ripetizione
intenzionale, perché il lettore capisca senza possibilità di equivoci che Giona – il quale come profeta dovrebbe parlare al
posto di Dio – taglia alla radice la stessa possibilità di parlare. Le conseguenze non tardano a manifestarsi: colui che è
un “chiamato” (nabì), non risponde; colui al quale è data la capacità di vedere ciò che sfugge agli altri uomini, chiude
gli occhi; l’uomo “portato” dallo Spirito di Dio, si divincola; l’uomo di Dio rappresenta soltanto sé stesso; il servo di
JHWH fa da padrone; il messaggero se ne sta muto come un pesce; la sentinella che dovrebbe “svegliare l’aurora” (Sal
57,9; 108,3) si mette a dormire; il custode non custodisce un bel niente; il pastore “abbandona le pecore e fugge” (Gv
10,12); chi dovrebbe diminuire, cresce decidendo da sé (cfr Gv 3,30). In una parola, alla vocazione corrisponde – ahimè
– la fuga.
B) MEDITATIO
Perché la vocazione divina si trasforma in fuga umana? La risposta completa verrà data in 4,1 (la vedremo a suo tempo).
Per ora ci soffermiamo sulla paura, che è la risposta insinuata in questi primi tre versetti. La delineiamo sulla falsariga di
una situazione analoga narrata in Mc 4,35-41, commentando così Bibbia con sé stessa, un metodo ermeneutico ed
esegetico assai caro ai Padri della Chiesa e, in ogni caso, intramontabile.
35. Quel giorno, calata la sera, Gesù ordina loro: “Passiamo all’altra riva”.
36. Sicché lasciarono la folla e lo prendono, così com’era, nella barca. Anche altre barche lo accompagnavano.
37. Quand’ecco scatenarsi una rabbiosa tempesta di vento: le onde flagellavano di continuo la barca, al punto che la
barca andava ormai riempiendosi d’acqua.
38. Intanto lui, a poppa, con la testa appoggiata al cuscino, dormiva placidamente. Allora lo svegliano e gli gridano:
“Maestro, per noi è finita! Non te ne importa nulla?”.
4
39. Destatosi, minacciò il vento e intimò al mare: “Taci e tieni chiusa la bocca!”. All’istante il vento cessò e si fece
una grande bonaccia.
40. Fu quello il momento di farli ragionare: “Perché vi lasciate prendere dal panico così? Ancora non avete fede?”.
41. Al che un grande timore s’impadronì di loro, tanto che tra loro andavano ponendosi l’interrogativo: “chi è mai
costui, dal momento che addirittura il vento e il mare gli obbediscono?”.
Intanto può essere utile un excursus sul significato psicologico e filosofico dei termini.
+ Paura. E’ l’emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo, che può essere reale, prevista,
ricordata o fantasticata. Spesso la paura è accompagnata da una reazione organica, mediante la quale il sistema nervoso
prepara l’organismo alla situazione di emergenza, disponendolo a difendersi mediante la lotta o la fuga. Sempre è paura
di qualche cosa, vale a dire la paura è in ogni caso determinata quanto all’oggetto.
+ Spavento. E’ la reazione emotiva a un pericolo imprevisto, inaspettato, lo stato di chi si trova di fronte a un rischio
senza esservi preparato, e sottolinea l’elemento della sorpresa.
+ Sgomento. E’ un forte spavento che provoca prostrazione, abbattimento.
+ Panico o terrore. E’ un episodio acuto di ansia caratterizzato da tensione emotiva e terrore intollerabile, che ostacola
un’adeguata organizzazione del pensiero e dell’azione. E’ accompagnato da turbe vegetative, quali ipersudorazione,
pallore, tachicardia, dispnea, tremore. Tende a esaurirsi spontaneamente, lasciando un senso di prostrazione.
+ Fobia. E’ una paura irrazionale e invincibile per oggetti o situazioni che, secondo il buon senso, non dovrebbero
provocare paura. Esempi: agorafobia, claustrofobia, eritrofobia (paura di arrossire), rupofobia (paura dello sporco),
patofobia (paura delle malattie).
+ Timore. E’ un termine che deriva dal contesto religioso e indica il sentimento che pervade la persona umana quando
avverte la presenza di un Essere trascendente che manifesta la sua potenza senza rivelare la sua essenza profonda. Se
viene interiorizzato, concorre alla formazione della coscienza morale, arginando le spinte trasgressive. Nel contesto
ebraico-cristiano significa un rispetto reverenziale, colmo di gratitudine e di amore (timào vuol dire onoro, stimo,
venero, rispetto); sicché solo con larghissima approssimazione ha a che fare con la paura: è la “paura” di fare del male a
un Essere personale, Dio appunto, dal quale sono certo di essere benvoluto e amato.
+ Angoscia. A)Punto di vista filosofico. Secondo Kierkegaard (1813-1855) è il sentimento dell’uomo di fronte al suo
essere nel mondo. E’ del tutto indeterminata, non paura di questo o di quello. E’ il puro sentimento della possibilità.
L’uomo nel mondo vive di possibilità, perché la possibilità è la dimensione del futuro, e l’uomo è continuamente proteso
verso il futuro. Ma le possibilità che gli si prospettano non hanno alcuna garanzia di realizzazione. Solo per una pietosa
illusione gli si presentano come possibilità piacevoli, felici o vittoriose; in realtà celano sempre l’alternativa intrinseca
dell’insuccesso, dello scacco, ultimamente della morte. “Nel possibile tutto è possibile”, vale a dire la possibilità
positiva non ha maggiore certezza di venire realizzata della possibilità negativa. Pertanto l’uomo, rendendosi conto di
questo, riconosce l’inutilità di qualsiasi tattica o strategia, e non ha di fronte a sé che due vie: o il suicidio o la fede,
ossia il ricorso a Dio “al quale tutto è possibile”. Dunque, senza la fede il peggio può ancora accadere. Secondo
Heidegger (1889-1976), l’angoscia è il sentimento che, prendendo l’uomo nell’intimo, gli rivela il niente a cui è
sospeso. E’ la paura che nasce quando l’uomo avverte che tutto è privo di consistenza, tutto è “essere per la morte”,
sicché egli si trova “spaesato”. Dunque, l’angoscia rivela il niente. Secondo Jaspers (1883-1969), bisogna distinguere tra
l’angoscia dell’Esserci e l’angoscia dell’Esistenza. Attraverso l’”angoscia dell’Esserci” (Dasein) l’uomo sa che al
termine della vita c’è la morte, di fronte alla quale può assumere due atteggiamenti: o la disperazione o la rimozione,
quest’ultima con la conseguente banalizzazione della vita. Mediante l’”angoscia dell’Esistenza” (Existenz) l’uomo si
rende conto che la propria esistenza è apertura al senso che ha come scopo l’implosione di ogni senso in occasione della
morte. B)Punto di vista psicologico. L’angoscia “corrisponde alla situazione di trauma , cioè a un afflusso di eccitazioni
non controllabili perché troppo grandi nell’unità di tempo” (Ancona). Accenno solo a un tipo di angoscia, la cosiddetta
“ansia fluttuante”, che è un’inquietudine e un’apprensione che sorge dalla sensazione di non essere all’altezza dei propri
compiti o ruoli: che la paura di cui Giona è preda sia di quest’ultimo tipo a me sembra incontestabile.
Riprendiamo le domande poste da Gesù ai discepoli - “Perché vi lasciate prendere dal panico così? Ancora non avete
fede?” – , per poi approdare, nella lectio successiva, all’interrogativo che i discepoli si pongono riguardo a Gesù (“Chi
è mai costui?”).
1. La paura dello stolto che non crede in Gesù. Se mi affido a Gesù, non ho motivo di paura (Sal 14,5; 27,1; Sir
34,14), perché posso contare sulla sua onnipotenza che mi custodisce anche nelle situazioni più drammatiche. La paura,
quindi, caratterizza in questo senso il non credente (Sir 2,12). Comprendo così che le domande di Gesù ai discepoli sono
estremamente pertinenti: egli si rende ben conto della gravità del pericolo al quale lui e loro sono esposti; ma gli preme
approfittare dell’occasione per fare ai discepoli una catechesi essenziale sulla fede. Aver fede è affidarsi all’onnipotenza
divina a partire da uno stato di radicale impotenza umana. Continuando a dormire, Gesù diventa il modello per
eccellenza di confidenza in quel Dio che, sempre e comunque, si prende cura di tutti i suoi figli (Sal 3,6; Prov 3,24; Gb
11,18-19). Dunque, una prima risposta alla domanda di Gesù circa la paura è quella dello stolto, che per la Bibbia è il
non credente. Ma si dà il caso che da non credente, purtroppo, talora mi comporto anch’io, che pure tengo molto a
dichiararmi credente cristiano. Per diventare non credente basta poco: è sufficiente pensare che, di fronte a situazioni di
rischio estremo, Dio stesso – quand’anche volesse intervenire – non potrebbe fare assolutamente nulla. Così però, al di
là delle intenzioni, la difficoltà si fa onnipotente, e Dio impotente di fronte alla difficoltà stessa (o – che è lo stesso –
meno potente della difficoltà), la quale quindi avrebbe la meglio non solo su di me (cosa abbastanza normale), ma
5
perfino su Dio stesso. Eppure sta scritto che a Dio nulla è impossibile (Gen 18,14; Ger 32,17.27; Mt 19,26; Mc 10,27;
Lc 1,37; 18,27; Rom 8,3), anzi, di più, che anche al credente come tale niente è impossibile (Mt 17,20; Mc 9,23; Lc
17,6).
+ Verificare o fidarmi? Mettere alla prova o affidarmi? Constatare o credere? Voler vedere per credere o credere per
poter davvero vedere – con gli occhi della fede – ciò che allo sguardo umano risulterebbe comunque invisibile?
Lasciarmi prendere dal panico per le situazioni senza via d’uscita o credere che proprio tali situazioni-limite sono la
cartina di tornasole della fede stessa?
2. La paura del discepolo che accusa Gesù. Se voglio essere sincero fino in fondo, devo ammettere che io pure avrei
agito come i discepoli: “Maestro, per noi è finita! Non te ne importa nulla?”. Oltretutto, chiamandolo Maestro, i
discepoli professano la loro amicizia con Gesù. L’hanno visto operare esorcismi (Mc 1,21-27) e guarigioni (1,29-31.4045; 2,1-12; 3,1-6); lo considerano tuttora un’autorità in fatto di insegnamento (1,22-27); hanno goduto di un rapporto
privilegiato con lui, essendo stati chiamati a stare con lui e a predicare il vangelo (Mc 3,13-19); soltanto a loro, in
disparte, Gesù ha spiegato i misteri del Regno (Mc 4,10-12.34). Con tale e tanta dimestichezza, che male c’è a parlare
così con lui? E’ vero che le loro espressioni non sono delle migliori e delle più sorvegliate; ma, di fronte a tale e tanto
pericolo, chi avrebbe tempo e voglia di curare il galateo? Tra l’altro, ricorrendo alla forma interrogativa e non a quella
assertiva, la frase equivale in pratica a un invito pressante perché Gesù intervenga a liberarli dal pericolo mortale. Anzi,
è verosimile che siano proprio loro i primi loro a desiderare che il loro rimprovero a Gesù si dimostri ingiustificato. Se
così fosse, la loro reazione sarebbe un’espressione di fede: se svegliano Gesù, è perché da lui attendono l’aiuto e la
protezione di Dio; se lo rimproverano, è perché interpretano il sonno come segno di disinteresse nei loro confronti da
parte dell’unica persona che li può veramente aiutare. Tutto questo dico sul piano della spontaneità, della sincerità
spietata, della reazione prima-prima. Ma –c’è un ma! – spontaneità, sincerità e reazione di primo acchito non sono
necessariamente la “verità”. Prima di interpellare la Parola di Dio scritta, devo lasciarmi interpellare e giudicare da essa;
prima di mettere sul tappeto i miei problemi, devo permettere al Signore di pormi i suoi, se ci tengo a essere davvero
credente. Ora, la parola pronunciata da Gesù è netta e inequivocabile: il comportamento dei discepoli è patognomonico
della mancanza/assenza di fede autentica. Che significa, infatti, accusare Gesù di disinteresse? Gesù s’interessa a modo
suo. Che vuol dire insinuare che Gesù non si prende cura di loro? Egli è libero di prendersi cura di loro a modo suo. Che
senso può avere fare urgenza a Gesù perché soddisfi immediatamente le loro attese? Gesù – glielo si permetta – le
soddisfa se e quando vuole e, in ogni caso, sempre a modo suo! Che cosa può voler dire dichiarare la propria
idiosincrasia alla “sorpresa” della salvezza donata, e pretendere viceversa una salvezza annunciata, prevista e
programmata? Gesù, in quanto Dio, non può che cogliere di sorpresa: un dono previsto nei minimi dettagli è facilmente
interpretabile come un diritto da far valere. Si badi: non l’insorgere della paura, anzi del panico, è indice di mancanza di
fede (anche Gesù proverà paura e angoscia , né i primi tre evangelisti si vergognano di registrarlo a chiare lettere: Mc
14,33; Mt 26,37; Lc 22,44), bensì il senso che i discepoli assegnano alla paura, senso che – vale la pena di ribadirlo –in
questo passo è univoco: anche Gesù, il nostro maestro, ci ha abbandonati. In questo senso la paura rivela mancanza di
fede, di fiducia.
+ Che senso do alle mie paure? Accuso Dio perché non constato il suo intervento o credo nel suo intervento permanente,
benché invisibile? Ho imparato effettivamente che il Signore non realizza tutti i miei desideri, ma mantiene sempre tutte
le sue promesse? So stare…a bagnomaria nell’attesa paziente della salvezza o fremo d’impazienza scalpitando come un
cavallo non domato? Sono capace di vincere la paura, che talora mi prende, con la fiducia in Gesù? Se è vero – come
dice don Abbondio – che “il coraggio, se uno non ce l’ha, non se lo può dare”, è ancor più vero che può lasciarselo dare
da un altro, precisamente da quel Gesù nel quale professa di credere. Paura e fede fanno a pugni (Gv 14,27; 2Tim 1,7;
Rom 8,15; 1Gv 14,18). Numerosi infatti sono i personaggi che da Dio vengono esortati a non avere paura: ad esempio
Abramo (Gen 15,1), Isacco (Gen 26,24), Giosuè (Gios 1,9; 8,1), Tobia e Sara (Tob 12,17), Daniele (Dan 10,12.19),
Giuseppe (Mt 1,20), Zaccaria (Lc 1,13), Maria (Lc 1,30), Pietro (Lc 5,10, Giovanni (Ap 1,17), Giairo (Mc 5,36; Lc
8,50), Paolo (At 18,9; 27,24). Soprattutto notevole è il fatto Gesù stesso supera la paura affidandosi al Padre (Mt 26,3646; Mc 14,32-42; Lc 22,39-46; 23,46).
TEMPESTA E BONACCIA
(Giona 1,4-16)
A) LECTIO
*V. 4. a) È sempre Dio che prende l’iniziativa, qui attraverso eventi spaventosi dal punto di vista naturale: un vento
impetuoso e una tempesta furiosa. Umanamente non c’è più niente da fare. Cfr Sal 48,8; 2 Cr 20,37. b) Per quanto
s’ingegni, Giona non può fuggire dal Signore: gli sembra di allontanarsi, ma Dio in realtà è sempre lì (Am 9,2-4). È la
prima contesa: Giona contro Dio.
*V. 5. Seconda contesa: Giona contro i marinai. a) Giona fugge dai pagani di Ninive e si ritrova tra i pagani della nave.
b) Egli non obbedisce al suo Dio, a differenza dei marinai che invocano ciascuno il proprio dio. c) Il profeta dorme
come un ghiro: è un letargo più che un sonno (Neher, 163); cfr il sonno di Adamo (Gen 2,21), di Abramo (Gen 15), di
Sìsara (Gdc 4,21), di Elia (1Re 19,5) e soprattutto il sonno di Gesù durante la tempesta sul lago (Mt 8,24; Mc 4,38; Lc
6
8,23), sonno quest’ultimo che ovviamente ha tutt’altro significato. d) Giona scende sempre più in basso, in senso fisico e
religioso. e) Mediante il sonno, egli esorcizza la paura, “non vuol vedere né sentire nulla, vuole la sua tranquillità”
(Wolff, 118); i marinai invece tremano dalla paura, sono letteralmente presi dal panico, espresso dal fatto che “coloro
che di solito lavorano solo in piena solidarietà, ora diventano individui isolati, ciascuno grida al suo Dio” (Id., 122-124).
*V. 6. Terza contesa: Giona contro il capitano. a) È notevole che il capitano, un pagano, ribadisca – sia pure
inconsapevolmente – la vocazione e la missione di Giona: “àlzati, proclama!”. b) Dal capitano Dio è chiamato
“Elohim”, vale a dire il Dio d’Israele, JHWH, viene da lui riconosciuto come il Dio supremo. c) ”Forse”: un pagano
nutre rispetto e speranza nei confronti di JHWH.
*V. 7. La pur grande paura non toglie ai marinai pagani quella lucidità sufficiente a intuire la presenza della mano di
Dio nello scatenarsi della tempesta. Cfr Gios 7 e 1 Sam 14. L’idea chiaramente espressa è che la tempesta costituisca il
castigo divino per i peccati commessi da qualcuno, in questo caso da Giona, visto che la sorte cade su di lui; si tratta di
una concezione conforme alla mentalità del Primo Testamento.
*V. 8. Inizia l’interrogatorio. Sebbene inespresso, il significato fondamentale soggiacente alle domande è: “che cosa hai
fatto perché ci troviamo in questa situazione disperata?”.
* V.9. “È la prima volta che Giona parla. Non a Dio però. E parla costretto dall’evidenza dei fatti” (Bernini, 262). La
sua risposta è oggettivamente corretta, ma parziale e astratta, “priva di entusiasmo” (Ceresko, 760). Date le circostanze
(i marinai non sono di fede ebraica, e la tempesta continua a infuriare), essa è però sufficiente, visto che Dio è
riconoscibile come creatore anche dai non ebrei. Fatto positivo: Giona professa la sua fede in JHWH, e le sue – mette
conto di ribadirlo – sono le prime tra le pochissime parole da lui pronunciate, e così anche quelle riportate al v. 12. Cfr
Gen 1,9-10; Es 14-15.
*V. 10. Ecco la domanda cruciale: “Che hai fatto?”. Notevole la descrizione del peccato come allontanamento da Dio.
*V. 11. Individuato il colpevole, chi meglio di lui potrebbe consigliare il da farsi?
*V. 12. Giona confessa esplicitamente la propria colpa e suggerisce la soluzione. Ma non si tratta ancora di una vera e
propria conversione, tanto da indurre Wolff (o.c., 134) a scrivere: “Forse la richiesta di Giona fu determinata più da
cocciutaggine che da spirito di sacrificio”, per cui essa risulta interessata, come quella del figlio prodigo (Lc 15,17-19).
Piuttosto che cadere nelle mani dei niniviti, il profeta preferisce morire: il che la dice lunga sulla sua paura degli abitanti
di Ninive.
*V. 13. È desiderio di tutti evitare la soluzione proposta da Giona sacrificandone la vita.
*V. 14. a) I marinai nutrono un grande senso di rispetto verso il Dio di Giona, ma non credono formalmente in lui. b)
D’altra parte non vogliono assolutamente macchiarsi della colpa di omicidio. Nel merito la Bibbia in lingua corrente
offre una traduzione illuminante: “Ti preghiamo, Signore, se quest’uomo morirà non punirci come se avessimo ucciso
un innocente! Tu, Signore, sei responsabile di tutto questo! L’hai voluto tu!”. Cfr il comportamento di Pilato durante il
processo di Gesù (Mt 27,24-25).
*V. 15. “Il mare placò la sua furia”: Dio ascolta l’invocazione dei marinai e placa la tempesta.
*V. 16. Vale la pena di ribadirlo: i marinai pagani “non si sono fatti monoteisti; e tuttavia riconoscono il Signore come il
Dio possente dell’universo. Le parole e i fatti li hanno portati a un riconoscimento, pieno di timore, del Signore
numinoso e palpitante” (Schoekel, 1160).
B) MEDITATIO
Nell’incontro precedente abbiamo riflettuto sulla paura di Giona nel suo versante negativo. Ora è il momento di
analizzare brevemente la paura dei marinai nel suo risvolto positivo. A tale scopo continuiamo a lasciarci istruire dal
brano marciano della tempesta sedata.
La paura del discepolo che s’interroga su Gesù. C’è un’ulteriore, ultima risposta alle domande poste da Gesù ai
discepoli. Due testi dell’AT la illuminano. a) Es 14: dopo l’intervento miracoloso di JHWH nel passaggio del mare, “il
popolo credette nel Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè” (v. 31).Qui paura e fede coesistono, tanto che la fede
si esprime con un grandioso inno di ringraziamento a Dio accompagnato da danze (Es 15,1-22). b) Giona (cap. 1): dopo
la tempesta sedata da Dio, “quegli uomini (= i marinai) ebbero un grande timore del Signore” (Giona 1,16). Anche qui
paura e fede o, meglio, fiducia vanno a braccetto, al punto che la fede si manifesta con sacrifici di ringraziamento e voti
al Signore. Insomma esiste una paura che va d’amore e d’accordo con la fede; per questo viene detta “timore”, nel senso
di stima, onore e affetto deferenti, reverenziali nei confronti di Dio, accolto come “Totalmente Altro”. Qualcosa di
7
simile accade ai discepoli che, dopo il miracolo, affrontano Gesù non più con un’accusa, ma con l’ interrogativo: “Chi è
mai costui?”. Come succederà alle donne davanti al sepolcro vuoto di Gesù risorto: “Non dissero niente a nessuno
perché avevano paura” (Mc 16,8). “E’ la necessaria reazione dal punto di vista degli uomini al primo impatto con il
punto di vista di Dio manifestato pienamente nel kerigma pasquale” (Vignolo). Quindi, se la paura – anziché degenerare
in accusa contro Gesù – si apre all’interrogativo sulla sua identità, viene a trovarsi sulla strada che porta al “timore di
Dio” che, manco a dirlo, è uno dei sette doni dello Spirito santo (Is 11,2; Ger 32,40; 2Cor 5,11; Ef 5,21; Col 3,22; Eb
12,28). D’altra parte non basta interrogarsi su Gesù, si deve rispondere positivamente all’interrogativo. Allorché i
discepoli arriveranno ad affermare nella fede che il Cristo risorto (= il Maestro che comanda al vento e al mare) è
esattamente il Gesù terreno (=il Maestro che dorme sulla barca); quando crederanno che Dio si fa conoscere nella
vicenda storica di Gesù di Nazaret intessuta di difficoltà, contraddizioni, tentazioni, sconfitte umane e alla fin fine della
morte affrontata per amore: allora, e solo allora, la fede esploderà in tutto il suo enorme, sconvolgente potenziale.
Sicché, per giungere a credere, il discepolo è paradossalmente chiamato a farsi “esperto in paura”(De Vogt), sino a che
riuscirà a dare una risposta completa e definitiva alla domanda: “Chi è mai costui?”. A questo punto mi resta da
chiedermi perché sia inevitabile (il dèi greco) passare dalla paura per arrivare alla fede, sperimentare il dubbio per
approdare alla certezza, entrare nell’oscurità per essere avvolto dalla luce. La risposta è rigorosamente una: certezza,
luce, evidenza e quant’altro mi costringerebbero a credere; mentre paura, dubbio e oscurità mi lasciano libero di credere
e nel credere. Che fede sarebbe, se fosse costretta? Che fiducia avrei, se fosse inevitabile? Che tipo di affidamento
risulterebbe quello di non poter fare a meno di affidarmi? Se bastasse l’evidenza per credere, persino un computer
sarebbe in grado di avere fede, e per di più …in tempo reale! La fede è una grandezza omogenea all’amore. E l’amore o
è libero o non è tout court: “o per amore o per forza”. Diciamolo con le parole di Léon-Dufour: “Gesù si è sempre
sottratto alle pressioni che volevano ottenere da lui un segno dal cielo (Mc 8,1-12; Mt 16,1-4); una prova irrecusabile
della sua divinità avrebbe distrutto la fede, costringendo l’incredulo o l’indeciso a dare a Gesù un’adesione che egli
voleva ricevere dalla sua sola libertà” (Studi sul vangelo, 224). Insomma c’è un non so che di fierezza nell’esercitare la
propria libertà nel senso della fede cristiana, malgrado la possibilità reale di orientarla nel senso contrario: fierezza tanto
affascinante da non poter essere barattata con nessuna cogenza razionale, evidenza scientifica, ragione strumentale e
calcolante.
+ Sono in grado di superare le mie paure ponendomi la domanda ultimativa su Gesù: chi è Gesù per me? E so
rispondere, come Pietro, “tu sei il Cristo” (Mc 8,29)? Pensare a Gesù mi aiuta a superare le mie paure o non mi fa né
caldo né freddo? Lotto con la fede contro le mie paure o m’illudo di vincerle con la fuga o la negazione? Quali frangenti
mi trovano più vulnerabile rispetto alla paura? Di che specie sono le mie paure? Dio mi fa (ancora) paura? Il fatto che
Gesù abbia sperimentato in sé stesso la paura, che cosa potrebbe insegnarmi? Sono capace di “ancorarmi in Dio e
imparare a dormire nella tempesta” (Casati, 154), ovviamente non come Giona che per stare tranquillo chiude gli occhi
così da non vedere la realtà, ma perché mi fido del Signore e a lui mi affido?
ANGOSCIA, PENTIMENTO, GRATITUDINE
(Giona 2,1—11)
A) LECTIO
*V. 1. a) Il protagonista e il regista resta, sempre e comunque, Dio. b) Egli per salvare utilizza anche mezzi duri, ostici;
in effetti, quale che sia il simbolismo del pesce gigantesco, esso non promette niente di buono. Il pesce assumerà,
invece, valore tutto positivo in epoca cristiana, in cui diverrà simbolo di Gesù (pesce in greco si dice ichthys; le iniziali
dei versi dell’acrostico significano Gesù Cristo, di Dio Figlio, Salvatore), del battesimo, dell’eucaristia, dei cristiani
(circa le motivazioni di tali e altre interpretazioni v. Ruggeri, 88-102. 139-140; Chevalier – Gheerbrant, 204-206;
Biedermann, 391-395). c) Il simbolismo del pesce nel libro di Giona non è originale: “il nostro autore si serve di un
racconto che circolava nel porto di Giaffa e che troviamo in una forma simile nelle leggende antiche greche e indiane”
(Wolff, 132). d) ”Tre giorni e tre notti”: ha un’ambivalenza di significato, in quanto da un lato indica “ciò che è
completo e definitivo” (Mateos – Camacho, 176), cioè siamo di fronte all’umanamente irrimediabile, e, dall’altro lato,
preannuncia velatamente la liberazione come opera esclusiva di Dio (Priotto, 2175).
*V. 2. “Pregò il Signore suo Dio”: passaggio dal Dio creatore e trascendente (cfr 2,9: “il Signore Dio del cielo, il quale
ha fatto il mare e la terra”) al Dio salvatore e condiscendente. Da una adorazione formale e impersonale a una supplica
coinvolta e appassionata. La stessa espressione troviamo al v. 7.
*V. 3 ss. a) Giona descrive eventi futuri come se si fossero già realizzati: a livello logico è una contraddizione palese,
ma a livello psicologico è una verità profonda. Infatti: il salmo fa le veci di “una pausa narrativa, un intermezzo
musicale” (Maggioni, 186); inoltre i verbi al passato vanno intesi come “presenti sincronici” (Drewermann, 73), che
scandiscono un “racconto anticipato, tipico di questo genere letterario” (Schoekel, 1165). Ne consegue, ad esempio, che
il v. 3 andrebbe tradotto così: “che cosa mi resta da fare se non gridare al Signore nella mia angoscia?” (Drewermann,
73). b) Dipendenze e coincidenze (Schoekel, 1163-1164; Bibbia di Gerusalemme, 2008-2009; Drewermann, 68;
Bernini, 264-268):
8
v. 3a: Sal 120,1
v. 3b: Sal 31,23; 116,1; Lam 3,55
v. 4a: Sal 69,3.16
v. 4b: Sal 42,8
v. 5a: Sal 31,23
v. 5b: Sal 5,8; 138,2; 69,2
v. 6a: Sal 18,6; 116,3
v. 7b: Sal 103,4; 30,4; 16,10
v. 8a: Sal 143,4; 142,4
v. 8b: Sal 88,3; 18,7
v. 9: Sal 31,7
v. 10a: Sal 116,17
v. 10b: Sal 116,18; 3,9; 22,26.
c) Queste dipendenze o coincidenze non annullano l’impronta personale dell’autore del libro di Giona (Schoekel, 1163),
almeno nel senso che è lui stesso a scegliere queste espressioni e non altre. Del resto, perfino il Magnificat proclamato
da Maria (Lc 1,46-56) usa lo stesso procedimento (cfr Valentini, Il Magnificat. Genere letterario. Struttura. Esegesi,
EDB, Bologna 1987; Drewermann, pag. 68, nota 77). d) La preghiera di Giona inizia come supplica accorata (v. 3) e
termina come azione di grazie (v. 10): dalla domanda al ringraziamento, quindi assistiamo a un’ulteriore conversione di
Giona. e) Si passa dallo sprofondamento voluto e attuato dal profeta all’innalzamento benevolmente realizzato da Dio.
f)L’idea centrale è espressa al v. 10 (“La salvezza viene dal Signore”): l’uomo, lasciato alle solo sue forze, precipita nel
male, nel peccato, nella morte; in altri termini, “la conversione non è mai un merito dell’uomo” (Wolff, 132). f) ”Esiste
una speranza anche per i messaggeri di Dio più incapaci e ostinati” (Wolff, 133).
*V. 5. “Sono scacciato lontano dai tuoi occhi”: essendo un passivo divino (Schoekel infatti traduce: “mi hai rigettato
dalla tua presenza”, o.c., 1161), potrebbe far pensare che sia Dio a respingere Giona. In realtà – tenuto conto della
mentalità semitica che attribuisce a Dio ogni evento, eccetto il peccato – bisogna intendere che è Giona ad allontanarsi
dal Signore, e niente affatto il Signore a respingerlo da sé.
V. 11. a) Dio è il salvatore di Giona, che “ha ripetuto a suo modo l’esperienza degli israeliti attraverso il Mar Rosso”
(Schoekel, 1166). b) ”L’espressione vomitò è da intendere come enfatica, cioè nel senso che dalle viscere vitali della
morte uscì vincitrice la vita” (san Gerolamo, citato in Schoekel, 1166). c) Suggestiva risulta l’interpretazione dello
psicologo del profondo E. Aeppli: “Scoprire di avere in sé la natura del pesce significa, globalmente, trovarsi di fronte
alle forme originarie e a sangue freddo dell’esistenza umana, di fronte a un profondissimo strato dell’anima [...]. Perciò,
chi deve attraversare una profonda trasformazione interiore, così come accadde al leggendario profeta Giona, viene per
un po’ di tempo inghiottito dal suo inconscio, da un grosso pesce che ha una gola simile a quella della balena. Una volta
trasformatosi, verrà gettato sulle chiare rive di una nuova coscienza” (in Biedermann, 394).
B) MEDITATIO
Che significa pregare? Desumiamo le caratteristiche della preghiera dal brano che abbiamo analizzato, tenendo presente
che il suo genere letterario è salmico. Mi auguro che questo ci possa aiutare nella celebrazione quotidiana dei salmi
previsti dalla Liturgia delle Ore. Lascio invece a ciascuno il compito di verificare sul Padre Nostro, la preghiera per
antonomasia, le semplici osservazioni che faremo, sì da rilevare somiglianze e differenze.
1. La preghiera sgorga dalla vita e tende a coincidere con la vita. I salmi sono nati da mille situazioni, che potrebbero
essere le nostre: allegria, gratitudine, tristezza, angoscia, peccato, frustrazione, disperazione, dubbio, amicizia, malattia,
vecchiaia, persecuzione, noia, angoscia... Dunque nessuna situazione è come tale incompatibile con la preghiera, anzi
ogni situazione ha un misterioso reale rapporto con essa e quindi con Dio. Le cosiddette distrazioni possono diventare
oggetto di preghiera esse stesse. La vita in quanto tale è uno stimolo alla preghiera. Dove trovare il materiale per
pregare? Nella vita quotidiana, che è di per sé capace di ricordarmi e rivelarmi Dio. Nella preghiera infatti sono in gioco
io come persona . So che Dio sa tutto; ma so anche di non sapere quasi nulla di lui. Per questo ho bisogno di parlargli, di
raccontargli di me: se neppure Dio mi ascoltasse, a chi mai potrei rivolgermi? Dio mi ama, perciò non prego perché si
decida ad amarmi. Ma io non sono troppo convinto del suo amore per me, e dunque prego per convincermene. So anche
che Dio è sempre presente nella mia vita e che tutta quanta la vita è preghiera; tuttavia ogni tanto ho bisogno di isolarmi
per non “lasciarmi vivere”. Mi metto davanti al Signore così come sono, con tutta schiettezza: sono così certo, Signore,
del tuo amore che tu puoi amare nel mio peccato me già rinnovato. Nota acutamente von Rad: “Israele fu più audace di
qualsiasi altro popolo nell’illustrare poeticamente JHWH e la magnificenza della sua apparizione e del suo operare.
Proprio i profeti, che conosceranno meglio di altri la natura dell’idolatria, sono coloro che si sono spinti più avanti nella
raffigurazione estetica di JHWH”.
2. La preghiera sgorga dalla fede e tende a coincidere con la fede. Il rapporto esistenziale che intercorre tra il cristiano e
Dio conduce a una visione nuova dei salmi. Da quando Gesù ha pregato coi salmi, da quando egli è stato rappresentato
come scopo ultimo del salterio, i salmi diventano in qualche modo preghiera con una caratterizzazione singolare, sia
perché detta da lui sia perché dice lui. Dal momento in cui Cristo ne ha fatto uso, i salmi trovano in lui il loro senso
9
pieno. Sotto questo profilo, la preghiera nasce dalla fede ed esprime la fede nell’Uomo-Dio. Io sono “figlio nel Figlio”.
Solo Dio, di cui sono immagine, mi capisce fin nelle più intime fibre dell’essere. Mi sento fatto per qualcosa che è più
avanti, e per così dire tento di accelerare i tempi, confrontarmi, ritrovarmi, colmare con lui la mia solitudine. Sono fatto
per Dio, solo in lui mi tranquillizzerò. Le cose di questo mondo saranno anche belle, ma sono soltanto segni di Dio, che
è sempre più grande, più avanti. Non sono integrato da niente e da nessuno; per quanto viva nella comunità cristiana,
sono sempre insoddisfatto. Con tutte le creature soffro le doglie del parto (Rom 8,2). E la mia insoddisfazione esplode
nella preghiera. Non ne posso più, non riesco ad aspettare oltre e mi aggancio fin d’ora a colui che adesso vedo in modo
confuso, come in uno specchio, ma che un giorno vedrò faccia a faccia (1 Cor 13,12). La mia anima ha davvero sete del
Dio vivente (Sal 42,3; 63,2), Nessuna persona, nessuna comunità, neppure l’umanità intera può sostituirmi Dio. Per
questo la preghiera non può coincidere col mettermi in rapporto con gli altri, ma significa essenzialmente relazionarmi
al “Totalmente Altro”, che in Gesù è diventato uno di noi senza cessare di essere chi era da sempre e per sempre. I
salmi, insomma, mi dicono che non sono io a realizzare me stesso, ma è Dio che mi salva non senza la mia libera
collaborazione. Pregare è riconoscere che la mia salvezza è dono divino assolutamente gratuito e incondizionato.
3. La preghiera sgorga dalla conversione e tende a coincidere con la conversione. Il Dio in cui credo vuole che io viva
da uomo nuovo quale sono diventato attraverso il battesimo, cioè che mi converta. Sarei ingenuo se ritenessi che per
pregare con i salmi basti capirli con la mente. Se credo davvero che i salmi mi rivelano Dio, non posso non tentare di
mettermi in sintonia con lui, il Santo. Ma la mia conversione, prima che essere frutto del mio impegno, è una grazia del
Signore: in questo senso pregare significa creare spazio all’azione divina. Mi affido a Dio, perché faccia di me un figlio
come il suo Unigenito Gesù. Sotto questo profilo pregare è aprirmi al Dio del progresso e non della conservazione; è
parlare con il Dio “che sta davanti a noi”. Come ha fatto Gesù: “non la mia, ma la tua volontà sia fatta” ( Mt 26,42; Mc
14,36; Lc 22,42).
4. La preghiera sgorga dalla comunità e tende a coincidere con la comunità. Come cristiano non sono solo. Sono parte
della Chiesa, popolo di Dio e corpo di Cristo. Sono uno dei tanti fratelli di cui Cristo è il primogenito (Rom 8,29).
Anche per questo mi sento a mio agio quando prego con i salmi: in essi, benché spesso si esprimano in maniera
individuale, si rinvengono sentimenti condivisi da tutti quelli che, come il salmista, credono nel medesimo Dio e si
ritrovano nelle identiche condizioni di miseria e di peccato. Anche nella preghiera più individuale e intima, lungi
dall’essere isolato, parlo a Cristo in compagnia dell’intero popolo di Dio. Non esiste salmo che pensi in maniera
individualistica; ogni salmo prega in termini di “noi” e raggiunge il Signore attraverso una comunità vivente,
storicamente determinata e strutturata. I salmi sono la voce del “corpo di Cristo”, i canti della “città di Dio”in cammino
verso la Gerusalemme celeste. E come tali essi appartengono alla liturgia.
CONVERSIONE E COMPASSIONE
(Giona 3,1-10)
A) LECTIO
Luogo: Ninive. Personaggi: Dio, Giona, i niniviti, il re, gli animali. Tema unificante: la conversione. In effetti tutti i
personaggi si convertono. Anche Dio, nel senso che di fronte al pentimento dei niniviti egli non realizza il castigo
minacciato. Tuttavia, per marcare la differenza abissale tra la conversione di Dio – assolutamente innocente e benevolo
– e la conversione dei restanti personaggi – tutti a vario livello colpevoli - , preferisco usare il termine compassione per
il primo e conversione tout court per i secondi.
*Vv. 1-2. Viene ribadita la vocazione di Giona in funzione della missione. Si comincia da capo.
*V. 3. a) Stavolta Giona obbedisce. Nel ventre del pesce si è pentito, e a questo punto si converte eseguendo l’ordine
divino. b) L’enfasi sulla grandezza della città (alla lettera: “grande anche per Dio”; ma Enzo Bianchi traduce
stupendamente: “divinamente grande” [o.c.] ) intende evidenziare la smaccata proporzione tra le insufficienti risorse
dell’uomo Giona e il compito assegnatogli da Dio; una sproporzione che secondo le intenzioni dello scrittore dovrebbe
suscitare il riso del lettore e fargli esclamare all’indirizzo di Giona: “Illuso! Non ce la farai mai!”.
*V. 4. a) La predica del profeta è ridotta all’osso: solo cinque parole ebraiche. Si noti la differenza dalla prima missione:
qui, in luogo della denuncia del male commesso dai niniviti (1,2), è presente la minaccia del castigo conseguente. Per
questo Bianchi ritiene che quella di Giona non sia vera obbedienza: “Dio lo voleva profeta, portaparola, annunciatore di
un avvertimento: che cioè Dio conosce il male presente in Ninive; ma lui si fa profeta di sventura, minaccioso: Tra
quaranta giorni, la shoà di Ninive! Questa è un’antica tentazione: quella degli uomini religiosi che vogliono interpretare
Dio e dire di più di quanto Dio comanda loro. Giona era disobbediente prima, quando fuggiva, è disobbediente ora che
non predica secondo il mandato di Dio... Sì, è più facile essere profeta di sventura: per questo [i profeti di sventura]
abbondano in ogni tempo” (o.c., 140). In ogni caso, l’autore gioca sull’ambiguità del temine, che possiede sia il
significato negativo di distruzione (Gen 19.21.25.29; Ger 20,16; 49,18; 50,40; Dt 29,22; Is 1,7; 13,9; Am 4,11), sia il
10
significato positivo di conversione (Dt 29,22; 1 Sam 10,9; Es 14,5; Sal 105,25): cfr Scoekel, 1168; Priotto, 2176;
Craghan, 170-171. b) ”Ancora quaranta giorni”: il numero simboleggia una totalità determinata, in concreto tutta la vita:
tutta quanta la durata dell’esistenza terrena di una persona è il tempo opportuno per convertirsi. Insomma Dio non
dispera mai, “è un Dio di speranza”, e Giona “è lo strumento scelto da Dio per offrire ai niniviti la possibilità di una
riconciliazione” (Craghan, 171).
*Vv. 5-8. a) Si afferma non che i niniviti credono in Dio (il Dio d’Israele), ma che credono a Dio, cioè cambiano
condotta (v. 8) ma non religione: ritengono giusta, perché meritata, la minaccia rivolta a loro dal messaggero di Dio. b)
Si tratta di un cambiamento generale sotto ogni profilo: grandi e piccoli, popolo e re, uomini e animali (Sal 36,7; “se la
fame degli uomini provoca la compassione di Dio, anche la fame e la sete degli animali può rinforzare questa
compassione”: Schoekel, 1169). Il re pagano di Ninive assume un comportamento positivo esattamente contrario a
quello negativo del re credente di Gerusalemme, che fa bruciare il rotolo contenente le decisioni di JHWH (Ger 36,2326).
*V. 9. “Dio può cambiare se l’uomo cambia: è la lezione centrale del libro” (Schoekel, 1170), “i cambiamenti nella
rivelazione di Dio sono sempre correlativi ai cambiamenti che si producono nell’uomo e nella storia”. Si noti il può
della prima affermazione (il testo biblico recita: “Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente
sdegno sì che noi non moriamo?”): in altri termini, Dio non è tenuto a cambiare parere, ma cambia se liberamente
decide di farlo; la conversione dell’uomo è condizione necessaria ma non sufficiente della compassione-misericordia di
Dio, tant’è vero che egli ci ama anche quando – colpevoli di peccato – non meritiamo affatto di essere amati (1Gv
4,10.19; Rom 5,8). Bernini (o.c., 273) fa notare che le parole del presente versetto costituiscono “la formula profetica
per affermare che Dio perdona a chi si pente (Gl 2,14a; cfr anche Sof 2,3)”. Per la verità, questa interpretazione non
dice ancora tutto, anzi potrebbe risultare fuorviante. Infatti, se “per-donare” è il massimo dell’amore, è giocoforza
affermare che non esiste mai un momento in cui Dio non perdoni, cioè il suo perdono è assoluto, incondizionato, ed è il
grembo – l’unico grembo – da cui possono sbocciare il pentimento e la conversione dell’uomo. Se tale pentimento e
conversione sbocciano, allora l’uomo rimane effettivamente perdonato; se non sbocciano, il perdono divino non produce
i suoi frutti nell’uomo. In altri termini, il pentimento è condizione necessaria non dell’esistenza del perdono, bensì della
sua efficacia (cfr Milani, o.c., passim).
*V. 10. Dio si pente: cfr Es 32,14; Ger 26,13; in senso contrario Gen 6, 6-7. Dio perdona chiunque, anche un non ebreo,
non appena constata un pentimento sincero ( = il suo perdono diventa efficace allorché il peccatore si pente). La novità è
evidente: il Signore si pente non soltanto del castigo decretato al suo popolo, ma anche di quello minacciato alle nazioni
pagane. “Le minacce divine [...] non sono i decreti di un destino cieco, ma l’espressione della volontà di un Dio
misericordioso; esse raggiungono il loro scopo esattamente quando non hanno bisogno di realizzarsi” (Gautier, in
Tufariello, 4).
Questo dovrebbe essere tutto quel che si può dire, e la storia potrebbe finire qui. Invece continua: come la parabola del
figlio prodigo la quale, dopo che la festa è iniziata (Lc 15,24), inaspettatamente prosegue (vv. 25-32).
B) MEDITATIO
Mi pare che il miglior commento a questo brano sia rappresentato dal comportamento del padre nei confronti del figlio
che torna a casa nella parabola cosiddetta del figlio prodigo. Esaminiamolo con un’analisi eccezionalmente puntigliosa,
che potrà istruirci – ritengo – anche sul comportamento di Dio nei confronti di Giona.
20. Era ancora lontano, quando suo padre lo vide, fu preso da una commozione irresistibile, mise le ali ai piedi, gli si
aggrappò al collo e lo coprì teneramente di baci.
21. E il figlio a dirgli: “Papà, ne ho combinate di tutti i colori contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di
essere chiamato figlio tuo…”.
22. Il padre non lo lasciò finire e spiccò ordini ai suoi servi: “Su, datevi una mossa! Tirate fuori un vestito – il
migliore, mi raccomando – e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi;
23. poi prendete il vitello – quello bel grasso -, ammazzatelo : mangiamo e facciamo festa,
24. perché nientemeno che mio figlio, proprio lui che è qui – capite? – era morto ed è tornato a vivere, era perduto ed
è stato ritrovato!”. La festa ebbe inizio.
* v. 20b. “Era ancora lontano”: in senso fisico, ma anche in senso morale, cioè il figlio non è ancora né pentito né
convertito. C’è forse anche un’allusione al fatto che il padre spesso usciva di casa a scrutare l’orizzonte, nella speranza
di veder spuntare il figlio. Tuttavia riesce suggestiva anche l’interpretazione secondo cui il padre insiste nello stare
fermo in casa ad aspettare, per “testimoniare come la sua casa sia il perimetro buono che indica un fondamento non
vacillante e un confine sicuro”; così il padre “che ha saputo star fermo, fidandosi della libertà del figlio e del fascino
della bontà della propria casa, può allora uscire incontro al prodigo che torna” (Rota Scalabrini, 81-82; cfr Martini,
Ritorno..., 26). Paradossale come sempre, Kierkegaard può giungere ad affermare: “Quando il padre ebbe un figlio
prodigo, fu allora che divenne padre sul serio (Diario, vol. 7, n. 2726, p. 42), e ad annotare: “Gli altri padri amano
esserlo quando si tratta di un figlio senza difetti; quando invece si tratta di un figlio prodigo, il padre dice: Io non voglio
essergli padre, se ne vada per i fatti suoi. [Viceversa, al padre della parabola] la paternità non sta attaccata come un
11
titolo posticcio, No. Il figlio vuol andarsene – egli è il padre. Il figlio parte – egli è il padre. Tutto è perduto, il figlio è
perduto – egli è il padre” (Ibidem, 43). Si noti, proseguendo nella lettura, la successione rapidissima degli eventi, in un
climax crescente, reso dal polisindeto (in italiano lo si coglie meglio ricorrendo all’asindeto). La progressione parte dal
generico “lo vide” e approda al delicatissimo “lo coprì teneramente di baci”, passando per la commozione (”fu preso da
una commozione irresistibile”), propria di una madre (Is 49,15; 1Re 3,26) ma possibile anche in un padre (Ger 31,20;
Sal 103,13), che gli attanaglia le viscere (stesso verbo in Lc 7,13; 10,31 e soprattutto 1,78, dove il termine splànchna
designa la reazione della visita di Dio all’umanità nella persona di Gesù; la versione in dialetto milanese rende
magnificamente con “tutt sòtt sora”: p.333), passando quindi per la corsa, qui tradotta con “mise le ali ai piedi”per
esprimere l’improbabilità e l’eccezionalità del gesto, e infine – ultima tappa prima del traguardo – per l’ ”aggrapparsi al
collo” (alla lettera: “cadde sul collo”): “si ha quasi l’impressione che il padre, nello slancio della corsa, cada addosso al
figlio e lo stringa forte nell’abbraccio per non cadere” (Pronzato, Parabole..., 189). Sul particolare della corsa del padre
vale la pena di insistere: “In un contesto culturale in cui i ritmi del tempo sono impostati a una grande lentezza e dove
tutto quel che riguarda la fretta è visto con sospetto - “chi cammina in fretta sbaglia strada” Pr 19,2 -, il correre è
un’azione disonorevole recante grave danno a colui che la compie. Non importa. Per il padre restituire vita e dignità al
figlio disonorato è più importante del proprio onore” (Maggi, 81). Il bacio poi è manifestamente segno di perdono
(2Sam 14,33), che costituisce sempre e comunque la pointe dell’amore e simbolo di parità (Linnemann, 101); anzi,
“quei baci, più che perdono, dicono amore. Addirittura gratitudine. Sembra che il padre, invece di dire al figlio Ti
perdono, gli dica Grazie!” (Pronzato, Ibidem). Ma il perdono è un’offerta che precede la domanda, ed è frutto di un
“amore preveniente” (Brambilla, 728); infatti il figlio, a questo punto, non è ancora riuscito a pronunciare nemmeno una
parola di fronte ad padre (cfr anche Weder, 300). In tutta l’opera lucana (Vangelo e Atti) il bacio assume, secondo le
circostanze, valenze diverse: in 7,38.45b amore riconoscente; in 7,45 stima e deferenza; in 22,47.48 tradimento; in At
20,37 gratitudine, affetto e augurio (cfr Boscione, 49-54; Lurker, 26-27). Giustamente qualcuno fa notare che le azioni
paterne “hanno la funzione di accogliere il figlio entro i confini della patria potestà, affinché nessuno si arroghi il diritto
di molestarlo o di offenderlo, pensando di vendicare così il buon nome del padre” (Azione Cattolica Ambrosiana, 76; cfr
anche Turoldo, 197). Viene da pensare a JHWH che protegge Caino dalla vendetta altrui (“Il Signore impose a Caino un
segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato”: Gen 4,15). Infatti il male si vince soltanto con il bene (cfr
Rom 12,21). In ogni caso, “nell’amore del padre v’è qualcosa d’inatteso che sorprende il figlio minore, che lo trascina,
che lo attira a sé” (Brambilla, 734); d’istinto vien da pensare a Gesù: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me” (Gv 12,32). Anche Anna e Tobi avevano aspettato il figlio Tobia e si erano comportati in modo analogo al padre
della parabola (Tb 11,5-18), il quale svolge contemporaneamente la funzione paterna di Tobi e quella materna di Anna
(cfr Nepi, in “PSV” cit:, 147). Tale concentrazione paterno-materna è evidenziata artisticamente da Rembrandt in Il
ritorno del figlio prodigo: la mano destra del padre che abbraccia il figlio è femminile; la sinistra, maschile (descrizione
molto analitica e appassionata in Nouwen, 144-149).
* v. 21. Il padre, che fin qui ha ritenuto di ricorrere al solo linguaggio gestuale, ora consente al figlio di esprimersi con il
linguaggio verbale che, a questo punto, gradiremmo manifestasse pentimento autentico. Aspettativa legittima, ma non
suffragata dal testo biblico che, concentrato com’è sul perdono paterno, non prende neppure in considerazione la
questione della genuinità della conversione filiale e dunque non l’affronta né la dirime. Per la verità, anche il figlio
adopera il linguaggio dei gesti, nel senso che li subisce o, meglio, accetta di esserne il destinatario. Ora, proprio in
questo lasciarsi fare non è inverosimile scorgere, come in filigrana, la pienezza del suo pentimento: vero pentimento
sarebbe, in tal caso, accogliere l’amore del padre con le modalità e secondo i ritmi voluti dal padre stesso; la vicinanza,
non respinta, creerebbe l’inizio del cambiamento di vita. Però non possiamo farci illusioni, in quanto – rileva Aletti
(o.c., 182) – una vera conversione avrebbe dovuto essere introdotta da una frase del tipo: “Preso dal pentimento, il figlio
cadde ai piedi del padre e gli disse...”.
*v. 22. Onde evitare l’assurdo, è giocoforza ammettere che pentimento e conversione si realizzano nel passaggio tra
quanto narrato al v. 21 e quel che è raccontato al v. 22. Al v. 21 è descritta l’accoglienza, dal v. 22 al v. 24 la festa,
estesa a tutti coloro che vorranno prendervi parte. Ora, se l’accoglienza allude all’esistenza del perdono accordato dal
padre in modo unilaterale, preveniente e incondizionato che - in quanto tale -non presuppone né esige nulla in chi viene
perdonato, la festa invece non può che esprimere la gioia per il cambiamento di vita in chi è stato perdonato e che è stato
constatato da colui che ha offerto il perdono, e dunque rivela l’efficacia, l’impatto positivo del perdono stesso, ossia il
pentimento e la conversione del figlio. Quasi tutti i commenti interpretano nel senso che il padre tronca bruscamente le
parole del figlio. Perché? Su quale fondamento? a)Anzitutto “il padre non si chiede quali siano i sentimenti del figlio per
lui, ma ciò che può fare per il figlio” (Fusco, 48). Si spiegano così gli ordini concitati impartiti ai servi, con tutto il loro
ricco simbolismo (non possiamo trascurare le prime parole:”Su, datevi una mossa!”), ancor più marcato dalla dovizia e
puntigliosità dei particolari: non un vestito qualunque, ma “il migliore mi raccomando”, con l’aggiunta pleonastica
“fateglielo indossare” (cfr Est 6, 6-11); non semplicemente un anello quale che sia, ma l’anello-sigillo “al dito”; non dei
sandali, ma “i calzari ai piedi”, vale a dire “calzature di lusso come portano soltanto i personaggi distinti, in circostanze
eccezionali” (Gourgues, Le parabole di Luca, 134). Precisazioni, tutte, così ovvie (quale uso può avere un vestito se non
quello di essere indossato? dove si porta l’anello se non al dito? e i calzari a che servono se non per essere calzati?) che,
fuori dal contesto di gioia irrefrenabile in cui si trovano, risulterebbero semplicemente ridicole. Ma “il cuore ha delle
ragioni che la ragione non riesce a comprendere” (Pascal).
12
*v. 23. E poi non un pasto qualsiasi, ma un banchetto coi fiocchi, a base di carne di vitello “bel grasso”, tenuto in serbo
per le grandi occasioni, ad esempio per le nozze del primogenito (cfr Mt 22,4). Insomma tutto gronda di enorme
generosità, di spreco voluto, di grande abbondanza, di esagerazione ostentata. Il padre fa l’impossibile per il figlio
tornato a casa. Il lettore – sembra ammonire l’evangelista – non si azzardi a pensare che il padre abbia lesinato! b)Siamo
così al secondo motivo che giustifica l’interruzione delle parole del figlio da parte del padre: questi desidera un figlio
pentito (solo se è pentito, il perdono dà i suoi frutti), ma gli ripugna averlo nel ruolo del dipendente avvilito e umiliato,
come avrebbero indicato le altre parole preparate dal figlio nel provino, se non fossero state troncate sul nascere. Un
esegeta avanza l’ipotesi che sia il figlio stesso, sbalordito e commosso per il comportamento del padre, a interrompere il
discorso pur accuratamente preparato: “il figlio non riesce ad esprimere ciò che sarebbe fuori posto dopo
quell’accoglienza paterna” (Grasso, 421). “Mangiamo e facciamo festa” (cfr Blass – Debrunner, pp. 419-420, paragrafo
339, nota 3): su un totale di sei occorrenze del verbo “far festa” nel terzo vangelo, ben quattro sono presenti nella nostra
parabola: quasi a dire che, se una festa ci deve essere, è proprio quella che si fa per un morto-tornato in vita, un perdutoritrovato. Si noti il plurale: tutti quanti debbono sentirsi invitati; sarà tanto più festa, quanto più numerosi sono i
partecipanti (cfr Rasco, 227-228; Boscione, 97-104; Lurker, 119-121). Gourgues (o.c., 14) scopre che sette sono le
azioni comandate dal padre ai servi: tirar fuori il vestito, farlo indossare, mettere l’anello al dito e i sandali ai piedi,
prendere il vitello grasso, ammazzarlo, mangiare, fare festa. Esattamente come sette erano i gesti compiuti o comandati
dal buon samaritano (Lc 10,33-34: aver compassione, farsi vicino, fasciare le ferite, versarvi olio e vino, caricare sulla
cavalcatura, portare in albergo, prendersi cura).Ora, sappiamo che il sette è simbolo di pienezza: un indizio in più, se
mai ce ne fosse bisogno, del fatto che il padre fa tutto il possibile per il figlio prodigo ritornato: egli non solo perdona,
ma celebra il perdono. Il perdono va regalato e festeggiato. È strano, però, che l’evangelista non informi il lettore circa
l’impatto sul figlio della festa organizzata in suo onore: vi avrà partecipato contento? Che sia così, è l’andamento stesso
del racconto a confermarlo. La reticenza di Luca può significare soltanto la volontà di focalizzare energicamente la gioia
paterna rispetto a quella filiale: Dio è infinitamente più felice per un peccatore convertito di quanto possa esserlo il
convertito stesso. Del resto è altamente sintomatico che questa sia l’unica parabola lucana in cui si parla di Dio sotto
l’immagine del padre (cfr Laconi, 133.135).
* v. 24. Le parole pronunciate dal padre intendono giustificare i suoi ordini. Ma a chi vengono rivolte? Non ai servi,
perché il padrone non è in alcun modo tenuto a motivare a dei servi il suo operato. Ma neppure al figlio, dato che di lui
si parla in terza persona. Non resta che una soluzione: come già il figlio nel suo soliloquio (vv. 17-19), il padre parla a
sé stesso, esprimendo ad alta voce il suo stato d’animo. È importante poi constatare come il soggetto dei verbi sia
costantemente il figlio: era morto (cfr Rom 5,12; Ef 2,1) ed è risuscitato (cfr Rom 6,13; Ef 5,14), era perduto (Cfr Lc
9,24.25.56; 17,33; 19,10) ed è stato ritrovato (cfr Lc 15,4.5.6.8.9). La presenza del figlio in carne ed ossa permette al
padre di constatare che è vivo; il padre è felice non tanto perché il figlio sia lì (affetto troppo possessivo), quanto perché
il figlio è “sano e salvo”, come del resto correttamente interpreterà (v. 27) uno dei servi. In altri termini, l’amore paterno
gode del bene del figlio in sé e per sé, e non anzitutto della sua utilità pratica (gratificazione soggettiva che ne potrebbe
ricavare, due braccia in più a lavorare nell’azienda di famiglia, ecc.). Lo stesso verbo trovare troviamo in Lc 2,45-46:
Gesù dodicenne, “non trovato” tra parenti e conoscenti (v. 45), viene finalmente “trovato” nel tempio da Maria e
Giuseppe “dopo tre giorni” (v. 46), con l’allusione a Gesù risorto dopo la scomparsa dovuta alla morte (Lc 24,5). Come
Gesù era – per così dire - morto a Maria e a Giuseppe per aver obbedito al Padre suo (Lc 2,49) e sarebbe morto in croce
sempre per obbedire al Padre (Lc 23,46), ma rispettivamente fu e sarebbe stato trovato vivo (Lc 2,46; 24,5); così il figlio
prodigo era morto e perduto per aver disobbedito al padre, ma ora è stato trovato vivo (cfr Manzi, a.c., 480-481). “La
festa ebbe inizio”: alla lettera bisognerebbe tradurre incominciarono a far festa. Ho reso invece come indicato per tre
ragioni: a)marcare l’avvio della festa mediante la dislocazione a destra del termine “inizio”; b)mostrare che la festa
coinvolge tutti: la festa si fa per libera scelta previa (la decisione del padre), ma ancor più nella festa si entra, cioè la sua
riuscita dipende dalla decisione concomitante di ogni persona che partecipa, proprio mentre vi partecipa; c)preparare il
lettore alla reazione del figlio maggiore. Il ritmo narrativo subisce a ragion veduta un rallentamento, che sembra fatto
apposta per invitare il lettore a prendersi una pausa in cui contemplare la festa e gioire, come se lui stesso fosse tra gli
invitati. D’altronde la festa incomincia soltanto. Il lettore capisce l’antifona: la storia non è finita, non è ancora detta
l’ultima parola. Difatti c’è l’altro figlio: Come reagirà? Approverà la decisione adottata dal padre? La festa – si sa – è la
conclusione logica di ogni storia che si rispetti. Qui, però, di dà il caso che sia appena iniziata. Per usare un’analogia
musicale, è come se il lettore si trovasse di fronte a un accordo che potrebbe benissimo essere l’ultimo del brano
musicale, ma che in realtà ultimo non è affatto. Penso, d’istinto, al finale del Gloria della Missa sollemnis di Beethoven:
dopo la cadenza dell’Amen che conclude una stupenda progressione ascendente in tempo binario, improvvisamente
irrompono coro e orchestra a ricamare – in un tempo ternario – una progressione ancora più travolgente (cfr, ad
esempio, Von Karajan, con i Berliner Philarmoniker e i Wiener Singverein, Deutsche Grammophon 423913-2). È poi
sorprendente che il figlio perdonato e festeggiato non dica nemmeno una parola di ringraziamento: sarebbe bastato un
semplice e affettuoso “Grazie, papà!”. Perché? La risposta è facile: non ci si deve attardare sull’itinerario di conversione
del figlio, bensì soffermarsi il più possibile sull’amore perdonante del padre: a fuoco è sempre il padre, sfuocato il
figlio: il grandangolo naturalmente riprende entrambi, il teleobiettivo invece è sempre puntato sul padre (cfr Aletti, 183).
Comunque, se è vero che il figlio più giovane “non era, partendo, il tipo del peccatore”, è altrettanto certo che egli “non
è, tornando, il tipo del convertito” (Abignente, 37). Un’ultima notazione a scanso di equivoci: il padre non confonde le
carte in tavola: accoglie – è vero – incondizionatamente la persona del figlio peccatore, ma nel contempo stigmatizza
senza mezzi termini il peccato da lui commesso (“morto”, “perduto”); e così anche nella conclusione (v. 32) (cfr Orsatti,
in “SdP”, n. 325, p. 120).
13
QUALE VOLTO DI DIO?
(Giona 4,1-11)
A) LECTIO
Siamo alla stretta finale. Come la parabola del figlio prodigo prosegue e si conclude con la vicenda del figlio maggiore,
così la parabola del profeta Giona. Oltre a Lc 15, 25ss., si possono vedere Mt 20 ( gli operai della prima ora) e Mt 18 (il
debitore malvagio e incoerente). In senso opposto si può meditare su Lc 6,27-38 e il suo parallelo Mt 5,43-48. Lascio
tutto questo alla buona volontà di ciascuno.
*V. 1. Dio perdona troppo facilmente – pensa Giona. Dovrebbe essere forte e irremovibile, e invece si mostra debole e
arrendevole: un Dio francamente sconcertante e imprevedibile. Io – dice in sostanza Giona – sono letteralmente
sbalordito e irritato per due buone ragioni: 1) i niniviti hanno cambiato condotta; ma si può mai convertirsi in quattro e
quattr’otto? 2) ammesso e non concesso che la loro conversione sia davvero sincera, a loro rimane comunque il dovere
di pagare di persona per il male commesso nel passato remoto e prossimo. A tale scopo io stesso avevo già calcolato con
cura, col mio computer, la pena per le atrocità da loro perpetrate. E che mi ritrovo? Un Dio che non solo con
l’introduzione di un virus annulla il mio programma, ma addirittura distrugge lo stesso computer. “È stata annientata
Gerusalemme, la città santa: perché Dio risparmia la città empia, Ninive?” (Bianchi, 141-142). Decisamente
insopportabile! Basta! Non m’importa un bel niente né dei niniviti (che vadano al diavolo!) né di un Dio così (e qui
taccio per non arrivare alla bestemmia...).
*Vv. 2-3. Se così stanno le cose, se tu Dio cambi parere e non realizzi il castigo da te stesso minacciato, sappi che io
non ci sto, non voglio più saperne di te. Fammi morire e...non se ne parli più! Sei troppo diverso da me e dagli altri
uomini: quando noi persone umane ci incattiviamo, desideriamo e facciamo il male; tu invece, allorché “ti incattivisci”,
ti metti a fare tutto il bene di ‘sto mondo al peccatore perché smetta di fare il male. No, mio caro, io non ti seguo più,
non so più che cosa è bene e cosa è male, non capisco più nulla. La mia vita ormai non ha più senso, perciò toglimela,
fammi morire. Annota Bernini (o.c., 275): “A Giona il modo di agire di Dio fa crollare tutta una concezione intorno a
Dio, come gli amici di Giobbe il contestare di costui”. Giona vuole insegnare a Dio.
*V: 4. Ed ecco la risposta di Dio. Giona, stai dando i numeri? Abbi il coraggio di ascoltarmi, osserva con attenzione il
bene che sto per farti.
*V. 5. Allora Giona, provocatoriamente, per dimostrare che può fare a meno di Dio, si rimbocca le maniche e costruisce
un capanno di frasche. Poi aspetta con atteggiamento di sfida: voglio vedere se il Signore ascolterà le mie rimostranze o
andrà avanti imperterrito per la sua strada cancellando ai niniviti ogni addebito. “Non solo Giona non dimostra alcuna
sensibilità per la sorte di Ninive, come invece Abramo la dimostra per Sodoma e Gomorra (Gen 18,16-32), ma pregusta
già la gioia della sua rovina, che vuole godersi con tutto l’agio e la comodità” (Bernini, 276).
*V. 6. In un primo tempo, Dio sta al gioco, e al profeta sembra di averla avuta vinta. In effetti, la pianta di ricino fatta
crescere da Dio procura a Giona una frescura salutare. In realtà Dio vuole mostrare che la liberazione dal male che
affligge il suo profeta, lungi dall’essere un prodotto della intraprendenza umana, è e può essere unicamente un dono da
accogliere con gratitudine: il capanno di frasche non basta a dargli pace, è necessario l’intervento di Dio. Ma Giona,
fraintendendo, pensa di essere riuscito con le sue argomentazioni a persuadere Dio, sicché alla rabbia subentra la felicità
o, forse meglio, l’euforia.
*V. 7. La lezione impartita dal Signore a Giona non è terminata. Come gratuitamente e liberamente Dio ha fatto crescere
il ricino, altrettanto liberamente lo fa seccare.
*V. 8. Un vento afoso completa l’opera. E, come volevasi dimostrare, Giona, per la seconda volta, invoca la morte.
*V. 9. Nell’economia di questa “parabola in azione” (Schoekel, 1173), la domanda mi sembra ambivalente: intesa come
una interrogativa reale, significa che è giusto rimpiangere un bene perduto; considerata come una interrogativa retorica,
vuol dire che è ingiusto rimpiangere un bene perduto come se fosse il bene supremo.
*Vv. 10-11. Bene supremo, infatti, - sentenzia Dio – è la salvezza di tutti gli uomini, non solo la salvezza di Giona. La
eccezionalmente lunga interrogativa retorica con cui si conclude il libro “interessa sia coloro che si credono buoni e
condannano i cattivi, invidiosi se Dio perdona loro; sia coloro che sono cattivi e sono in cerca di salvezza” (Maggioni,
188). Il senso globale del libro è, in ultima analisi, espresso in 1 Tim 2,4: “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità”. Scrive Drewermann (o.c., 125): “A ben pensarci, tutta la morale del libro di
Gina consiste in questo: Hai tu amato davvero una persona, ne hai amata una addirittura a Ninive? Condannare è tanto
semplice, già ancora quando la molla che c’è dietro è aggressione oppure odio, o amore deluso che si è ribaltato in
14
negazione e annientamento. Onestamente, Giona, troveresti [sic! Meglio: proveresti] un qualche rincrescimento se
Ninive, la città grande, non ci fosse? No? Ma che cosa capisci, allora, della terra, Giona, se tu passi oltre alle persone
senza rincrescimento? Come vuoi [sic! credo stia per puoi] aspettarti che uno si rincresca della tua scomparsa? Anche
nella tua voglia di morire pur vive qualcosa di simile a una delusa richiesta di attenzione e di grandezza. In fondo, tu ti
annienti solo perché non c’è nessuno che dice di sì a te. Ma potresti farlo anche tu – dire di sì agli altri! Un piccolo
arbusto di ricino, che miracolo! Il vento che ti soffia intorno, che enigma! L’esistenza umana nella sua miseria, che
grandezza incredibile!”.
“Ninive non sta solamente là dove non vogliamo andare, ma è tutti quelli a cui non vogliamo perdonare, ai quali Dio
vuole che perdoniamo, ai quali perdona. Ai quali perdona come ogni giorno perdona a noi, poveri insensati, che
saremmo già da tempo maledetti se Dio la pensasse come noi” (Brillet, 650).
Come possiamo constatare, siamo molto vicini alla concezione neotestamentaria: “Forse Dio è Dio soltanto dei Giudei?
non lo è anche dei pagani? Certo, anche dei pagani!” (Rom 3,29; cfr Bibbia di Gerusalemme, 1549; De Groot, 55)
Conclude Enzo Bianchi: “Non è un caso che Israele legga il libro di Giona nella ricorrenza di Yom Kippur, il giorno
dell’espiazione e della conversione. E noi non dovremmo dimenticare l’attualità di questo messaggio: l’identità del
credente, la sua verità, non va cercata contro gli altri e senza gli altri, ma nella dolcezza della compagnia degli uomini.
Ecco l’invito di questo libretto della misericordia di Dio: Quaerere veritatem in dulcedine societatis” (o.c., 143).
B) MEDITATIO
Si impone per la citazione che Giona stesso fa di Es 34,6-7. Ispiriamoci dunque a questo testo.
Mi soffermo unicamente sui versetti 6-7.
Gli esegeti fanno notare che questi versetti, al di là della forma lessicale tipica dell’autorivelazione di Dio, sono in
realtà una professione di fede in JHWH. E ne adducono le ragioni: a) è strano e inusuale che Dio proclami il proprio
nome (v. 5); b) ancora più strano è il fatto che parli di sé in terza singolare (v. 6). Forse si potrebbe dire che, per
garantire la verità del contenuto, l’agiografo con un abile escamotage presenta Dio come se parlasse di sé; se infatti è
Dio stesso a farsi conoscere, noi possiamo soltanto prendere o lasciare. Ma le stranezze non finiscono qui: abbiamo
una definizione astratta di Dio che tenta di coglierne l’essenza e non, come ci aspetteremmo dalla Bibbia, una
descrizione della sua azione. Lo si evince dai seguenti dati: a) nessun accenno a Israele, ma allusione all’intera
umanità, quindi anche ai non credenti; b) focalizzazione esclusiva sul nome di Dio e sui suoi attributi. Poiché ne
vengono enunciati 13, nella tradizione ebraica la formula è nota come “Il patto dei 13 attributi o delle 13 misure”.
Vediamoli.
I)
JHWH (prima soggetto e poi predicato): JHWH è JHWH, ossia “Colui che ama appassionatamente,
l’appassionato” (Goitein).
II)
Dio.
III)
Misericordioso. Il termine ebraico si riferisce direttamente all’utero materno, dunque dice tenerezza,
compassione, misericordia: un amore letteralmente viscerale, radicato in quella linea di confine tra
l’affettivo e il fisiologico. Cfr. Os 2,21; Sal 40,12; 145,8; e soprattutto Is 49,14-15 ("Sion ha detto: “Il
Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato”. Si dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io
invece non ti dimenticherò mai").
IV)
Pietoso. Esprime la relazione del superiore con l’inferiore e dunque significa condiscendenza, vicinanza,
essere propizio. Cfr, ad es., Num 6,25; Sal 4,2; 6,3.
V)
Lento all’ira. Dio è paziente, possiede l’arte finissima di coniugare il valore etico con il tempo necessario
all’uomo per conseguirlo.
VI)
Ricco di grazia. La grazia è l’amore di Dio giurato nel patto di alleanza. Cfr. la suggestiva ripetizione del
ritornello “perché eterna è la sua grazia” del salmo 136.
VII) Ricco di fedeltà. La fedeltà è la tenuta, la stabilità, la saldezza della roccia che dà sicurezza. Cfr. Sal 89;
146,6; 71,2-4; 125,1-2; 30,7-9; 62.
VIII) Conserva il suo favore per mille generazioni: ama sempre, costantemente.
IX)
Perdona la colpa
X)
Perdona la trasgressione
XI)
Perdona il peccato
Sono praticamente dei sinonimi che significano: ama e perdona l’uomo peccatore (non: ama e perdona il peccato)
XII) Non lascia senza punizione. In altri termini: l’amore di Dio è una passione forte e coraggiosa, non un
sentimento ingenuo che si lasci ingannare.
XIII) Castiga la colpa fino alla terza e alla quarta generazione. Appare subito evidente la voluta enorme
sproporzione (3/4:1000) rispetto a “conserva il suo favore”: “l’illogica e sterminata misericordia divina sta
alla giustizia quanto l’infinito sta a 3 o 4” (Borgonovo, 61).
1) Dio ama in modo assoluto (“misericordioso e pietoso”). Passione ardente e strabocchevole, bontà abbagliante e
aprioristica, tenerezza intensa e delicatissima, tenacia risoluta e incrollabile, perdono incondizionato e smisurato
15
fanno tutt’uno in lui, esplodono, si riversano sull’uomo intridendone ogni fibra dell’essere. Le parole umane sono
balbettamenti patetici per “cantare quello che non potremmo dire e non sappiamo tacere”.
Quale idea mi sono fatto di Dio? Un Dio appassionato o un idolo gelido? Un tifoso entusiasta o un arbitro
intransigente? Una persona magnanima o un individuo pusillanime che cerca ostinatamente il pelo nell’uovo? Un
padre tenero o un funzionario intrattabile? Un amico fidato o una banderuola imprevedibile? Una persona pacata o
un figuro bilioso? Perché, in che circostanze e sotto pressione di quali eventi mi succede di coltivare l’una o l’altra
idea di Dio? Non mi sfiora il dubbio che la Lectio divina e la catechesi possano costituire un efficace antidoto a un
mio eventuale identikit fuorviante di Dio, un mezzo per stanare e sciogliere i pregiudizi su di lui?
2) Dio ama così tutti quanti. Oggetto, destinatario e partner del Dio d’amore è ogni persona umana. Razza, cultura,
religione, latitudine, epoca, status sociale e qualsiasi determinazione della libertà creata sono irrilevanti al 100%
rispetto a Dio, che ama tutti senza risparmio. E’ questa una costante di evidenza palmare nel NT e una variabile
tendente alla costante nell’AT; nel nostro brano poi è un’affermazione esplicita, quasi una sorta di masso erratico
che ha del prodigioso nell’AT.
Credo davvero che ogni persona umana, lo sappia o no, è amata da Dio? Poiché sono credente, so di essere amato
da Dio? Questa certezza diventa per me motivo di comunione o pretesto di divisione? Ragione di parità con gli altri
o incentivo di superiorità sugli altri? Dio ama gli altri perché sono “un po’ uguali” a me (così che, se non lo fossero,
non li amerebbe) o perché sono sé stessi, ognuno unico al mondo? La diversità personale viene da me vissuta come
fattore di arricchimento o paventata come potenziale minaccia?
3) Dio ama facendo il bene oggettivo (“Non lascia senza punizione... castiga la colpa”). Ora il bene oggettivo esige
talvolta potature drastiche, incisioni profonde, terapie intensive, colpi di mano audaci. L’abbiamo visto: se i primi
undici attributi si trovano sull’asse dell’amore, gli ultimi due insistono su quello della giustizia. E se la misericordia
la vince di larga misura sulla giustizia, questa non è però annullata da quella: non sarebbe misericordia, se
prescindesse totalmente dalla giustizia; Dio è più che giusto, ma non sarebbe Dio se non fosse anche giusto; per
questo egli ama anche andando su tutte le furie. La giustizia è come l’altra faccia della misericordia. In breve:
l’immagine di Dio qui delineata, anziché essere ingenua e infantile, è al contrario adulta e coraggiosa. Misericordia
e giustizia di Dio sono aspetti che vanno non solo simultaneamente affermati, ma pure correlativamente compresi.
L’idea che mi sono fatto di Dio lascia sussistere in lui l’ambivalenza misericordia/giustizia o annulla la “differenza
di potenziale”, così che non c’è corrente e l’amore di Dio non passa? Corretto è premere l’acceleratore sull’una o
sull’altra in funzione dei miei reali bisogni, tuttavia mai si potrà negare una delle due. Il mistero di Dio è più grande
della stessa Bibbia che pure, da lui ispirata, di lui parla: un mistero dunque che devo accogliere con meraviglia e in
cui devo introdurmi con garbo, non un problema da affrontare con accanimento. Da persona adulta nella fede, sono
capace di accettare anche gli aspetti di Dio che non mi piacciono granché, dato che egli rimane sempre Altro,
Diverso, Trascendente?
Nel Talmud (Berakhot 4a) si legge: “Insegna alla tua lingua a dire "non so", perché non ti capiti di essere preso per
mentitore” (P. De Benedetti, in Cattedra dei non credenti o.c.,38): “aver paura di dire "sì" e aver paura di pensare
"no"” (Wiesel, Ibidem, 39). Lascio che Dio sia Dio senza catturarlo negli idoli concettuali umani?
CONCLUSIONI
Tenendo come filo conduttore l’insegnamento della parabola del figlio prodigo, che con quello della parabola degli
operai nella vigna mi sembra il parallelo neotestamentario più suggestivo, formuliamo tre conclusioni di carattere
rispettivamente teologico, cristologico ed ecclesiologico, con l’aggiunta di una postilla.
1. Riflessione teologica: Dio è Padre così. Dio è un padre scandalosamente amorevole e misericordioso. Essendo
l’Amore in persona (1Gv 4,7.8.10.16), non è capace se non di amare. E ama tutti, perché tutti sono creature sue.
Essendo il Perdono per eccellenza (Es 34,6; Sal 130,4; Sap 11,23; Sir 18,11; Sof 3,15; Os 2,16-25; 11,7-9; Ez 16; Gio
4,2; Lc 5,20; 7,48; At 3,19; 2Cor 5,19; 1Gv 1,9; 2,12), non sa se non perdonare. E perdona tutti, perché tutti
indistintamente sono peccatori (1Re 8,46; Sal 14; Is 57,4; 71,1-6; Rom 5; 1Cor 15,21). Gravità e frequenza dei peccati
da un lato, e amore suo verso i figli che li hanno commessi dall’altro sono per lui direttamente proporzionali. Dio è
“presbite” (Fausti, 550), vede meglio i lontani, quelli che volontariamente si sono allontanati da lui: li aspetta con
pazienza al varco della misericordia, li pensa con nostalgia, li desidera con ansia, li abbraccia con trasporto. Anziché
andare loro incontro quando sono pentiti o se prevede che si pentiranno, li precede con l’amore fino a perdonarli e spera
che accolgano il suo perdono per essere effettivamente perdonati, ovvero – se del caso – semplicemente li aspetta con
apprensione amorevole e colma di speranza. E, una volta tornati, fuori di sé dalla gioia fa festa con loro e per loro (Sof
3,17-18) e invita tutti a fare altrettanto. In grado di scrivere diritto su righe storte, esercita spesso e volentieri tale
capacità, senza esigere nulla in contraccambio. Nell’incontrare e festeggiare i suoi figli, prodighi o diligenti che siano,
lungi dal giocare al risparmio, profonde tutto sé stesso con una generosità che sconcerta. Non confonde il peccato, che
odia a morte, con il peccatore, che ama alla follia. La sua gioia raggiunge l’acme allorché vede tutti i suoi figli – vicini e
lontani – vivere insieme da fratelli che si vogliono bene. Dà loro tutto l’amore che ciascuno può ricevere: dove c’è vuoto
16
lo riempie, dove esiste lacuna la colma, dove scorge malattia la guarisce, dove trova colpa la perdona, dove vede
tristezza infonde serenità e gioia, “si offre a tutti come un tu di misericordia e di fedeltà” (Martini, Ritorno..., 19).
2. Riflessione cristologica: Gesù è il Figlio unico di un Padre così. Chi ci ha detto che Dio è un Padre così, è Gesù di
Nazaret. E il solo che ha perfettamente...copiato dal vero un Padre così, è ancora e sempre Gesù. Accogliendosi come il
Figlio per antonomasia, egli ha realizzato in sé i caratteri di un Padre così. Totalmente e nient’altro che Figlio in quanto
in lui il Padre – per così dire – esaurisce la propria capacità generativa, a differenza del figlio minore della parabola sta
sempre con il Padre (Gv 14,10-11), con il quale – lungi dal prenderne le distanze – forma una cosa sola (Gv 10,30;
17,20), compiendo sempre la sua volontà e soddisfacendone i desideri (Gv 4,34; 5,30; 6,38; 8,29; 14,31; Mt 26,39.42;
Eb 10,5-7), perché dal Padre si sa e si sente amato (Gv 3,35; 5,20; 10,17; 17,23; Mt 11,25-27; Lc 10,21-22). Totalmente
e nient’altro che Figlio, differisce pure dal figlio maggiore, invidioso e risentito, della stessa parabola. In effetti, Gesù “è
paziente, benevolo, non invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto
scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor 13,4-7). Per conoscere meglio Gesù, Figlio di un Padre così,
basterebbe rileggere con attenzione i tratti delineati nella prima riflessione e constatare che coincidono con quelli del
Figlio fatto uomo (Gv 1,18), in tutto uguale a noi tranne che nel peccato (2Cor 5,21; Eb 4,15; 7,27; 1Pt 2,22; 1Gv 3,5;
Gv 8,46; 9,16). Insomma, Dio è così solo in quanto è il Padre di un Figlio così, cioè “del Signore nostro Gesù Cristo”
(2Cor 1,3; Ef 1,3; Col 1,3; 1Pt 1,3).
3. Riflessione ecclesiologica: devo diventare ciò che sono, cioè figlio di un Padre così e, mediante Gesù, fratello di
tutti i figli di un Padre così. Il compito che mi resta da svolgere è unico: diventare sempre più figlio di un Padre così
imitando Gesù e quindi vivendo da fratello di tutti, perché così Gesù ha vissuto. Implicazioni e/o conseguenze sono
presto dette.
+ Vivere da figlio di Dio. Il figlio lavora per vivere amando; il dipendente vive per lavorare senza necessariamente
amare.
+ Vivere da fratello e amico di Gesù. Il fratello (Lc 4,22 e par.; Mt 25,40; Gv 20,17; At 1,14; Rom 8,29; Eb 2,11-17) e
l’amico (Lc 12,4; Gv 11,3; 15,14) comunicano e condividono tra loro; il servo e lo schiavo, invece, eseguono
pedissequamente senza comunicare né condividere.
+ Vivere con i fratelli di fede nella reciprocità dell’amore. Gv 13,34; 15,12.17; 1Tess 4,9; 1Pt 1,22; 1Gv 3,11.23;
4,7.11.12; 2Gv 5.
+ Vivere da fratello con ogni uomo e donna. 1Gv 3,15; Lc 10,30-37; 6,27-35.
+ Perdonare chiunque. Mt 6,12.14-15; 18,21-35; Lc 6,36; 11,4.
+ Rallegrarmi e far festa per qualsiasi morto-ritornato in vita e perduto-ritrovato. Lasciarmi trascinare dal ritmo della
danza condotta dal Padre così, il quale appunto danza con i peccatori.
Esiste un circolo virtuoso tra paternità e fraternità: capendo il Padre capisco il fratello, ogni fratello; e comprendendo il
fratello, qualunque fratello, capisco il Padre (cfr Orsatti, 49). L’affetto paterno di cui Dio immeritatamente mi gratifica e
l’amicizia che Gesù mi regala fruttificano davvero a una precisa condizione: impegnarmi a declinarle in fraternità umana
verso tutti e ciascuno. Sino a festeggiare i peccatori più patentati che rientrano a titolo pieno nella comunità cristiana. In
tal modo la Chiesa apparirebbe come “luogo della festa” perché spazio del perdono, “città della gioia” perché “tempio
della pace e della riconciliazione” (cfr Brambilla, 744). La sfida – non è chi non veda – “fa tremar le vene e i polsi” (Inf.
I, 90). Eppure ha ottime probabilità di essere vinta, perché “lo Spirito che mi fa vivere in Cristo Gesù” (Rom 8,2)
assume in essa il ruolo non dell’arbitro severo e intransigente, ma del mio tifoso più appassionato.
(Un saggio di verifica-meditatio più dettagliata si può trovare in Orsatti, o.c.,51-53).
4. Puntualizzazione conclusiva: un equilibrio instabile di contro a un amore assolutamente costante. Nella
parabola del figlio prodigo, che presenta numerose analogie con il racconto di Giona, non è detto che il figlio maggiore
(molto simile alla figura di Giona) sia irrecuperabile. Anche se dovesse decidere di non entrare in casa per partecipare
alla festa, non potrebbe tuttavia impedire al padre di volergli bene. E se vi partecipasse, conserverebbe pur sempre la
facoltà di uscirne disgustato sbattendo la porta e, arrabbiato più che mai, buttarsi a corpo morto - come già il fratello più
giovane – in una vita da scavezzacollo. Ma anche in tale evenienza il padre, con tenerezza struggente, si comporterebbe
con lui come con il figlio minore. D’altra parte la parabola non assicura neppure che il più giovane (nella parabola di
Giona potrebbe essere rappresentato dai niniviti) rimarrà per sempre “tornato in vita” e “ritrovato”. In ogni momento,
infatti, egli potrebbe cambiare bandiera e di nuovo cedere al fascino dell’avventura spregiudicata e senza remore. E il
padre rifarebbe per lui, ancora una volta come fosse la prima, quanto aveva fatto al suo ritorno.
Morale: se il peccatore può sempre, grazie a Dio, diventare giusto, il giusto può sempre – ahimè – diventare peccatore.
Potenzialmente e strutturalmente ambigua, la libertà non viene mai meno nell’arco dell’esistenza del singolo, che è
appunto – per usare un’espressione scioccante di Sartre – “condannato ad essere libero”. Ne consegue che considerare
irrimediabile un’esperienza negativa equivale, al di là delle intenzioni, a negare quel Padre così che, amando, libera;
come – simmetricamente – illudersi che una esperienza positiva non possa degenerare significa non credere nello stesso
Padre così che, amando, lascia liberi.
Dunque, “non è vero che oggi non si possa più parlare di Dio. Solo che è giunto il momento in cui non è più permesso
parlarne con presunzione. ed è presunzione anche quella di chi nega che se ne possa parlare” (Dianich, in AA. VV.,
L’ombra di Dio..., 226).
17
Ecco allora l’oratio, ispirata a Mazzolari (o.c., passim).
Padre buono, tu mi salvi lasciandomi perdere. mi insegni che il mio limite non mi distrugge ma mi salva. Mi fai capire
che ho più bisogno di essere amato che di amare. Mi rendi consapevole che mi posso abituare a tutto, anche ad essere
abietto: che posso addirittura contendere le ghiande ai porci, ma non posso accontentarmi delle ghiande. Che solo gli
uomini meschini hanno paura della libertà. Che l’uomo è grande anche quando ti rinnega. Che l’amore non segue mai
ma precede sempre, e che chi ama non è mai assente.
Davanti a questi doni e a molti altri ancora, io voglio lasciarmi abbracciare da te, Padre buono.
Solo così avrò il coraggio di accogliere i figli tuoi e fratelli miei, per poi far festa con loro. Sì, unicamente se mi lascerò
abbracciare da te potrò pregustare quella festa senza fine che da sempre è il tuo paradiso, e che spero diventi il mio, il
nostro, il paradiso di tutti. Te lo chiedo per la mediazione di Gesù, mio unico Signore e Maestro e mio fratello
maggiore, nella letizia dello Spirito santo, mia guida interiore. Amen.
BIBLIOGRAFIA- ALONSO SCHOEKEL L.., Dio Padre. Meditazioni bibliche, ADP, Roma 1998, pp. 23-57
- ALONSO SCHOEKEL .L. – SICRE DIAZ J.L., I profeti, Borla, Roma 1996, pp. 1145-1174
- BEAUCHAMP P., L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, Paideia 1985 (in particolare pp. 87-122)
- BELLORA M., Sotto il segno di Giona, in ID., Il Signore della danza, Portalupi, Casale Monferrato 2004, pp. 93-99
- BERNINI G., Sofonia – Gioele – Abdia – Giona, Paoline, Roma 1972, pp. 235-278
- BIANCHI E., Giona: il profeta riluttante (Giona 4,1-11), in AA. VV., Alle origini dell’Occidente. AT. Immagini, luoghi,
personaggi, Morcelliana, Brescia 2003, pp. 133-143
- Bibbia concordata (La), vol. II, Mondadori, Milano 1999, pp. 695-700
- Bibbia di Gerusalemme (La), EDB, Bologna 1985
- Bibbia in lingua corrente (La), Elle Di Ci – Alleanza Biblica Universale, Leumann – Roma 1985
- BIEDERMANN H., Enciclopedia dei simboli, Garzanti, Milano 1991, pp. 391-395
- BOCIAN M., Grande dizionario illustrato dei personaggi biblici. Storia – Letteratura – Arte – Musica, Piemme, Casale
Monferrato 1991, pp. 275-279
- BOGGIO G., Giona, in Logos. Vol. III: Profeti e apocalittici, Elle Di Ci, Leumann 1995, pp. 185-188
- BONHOEFFER D., Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Paoline, Cinisello Balsamo 1989, p. 483
- BORGONOVO G., Giustizia punitiva e misericordia in Gen 1-11, “PSV” n. 37 (1/1998), pp. 53-68
- BOVATI P., Il corpo vivente. Riflessioni sulla vocazione profetica. I: “Riv cl it” 4/1987, pp. 266-272; II: “Riv cl it” 5/1987, pp.
332-346
- ID., La parola come atto profetico, “Riv cl it” 1/1996, pp. 33-51
- BRILLET G., Meditazioni sulla bibbia per ogni giorno dell’anno, Paoline, Milano 1961, pp. 645-650
- CASATI A., E la casa si riempì del profumo. Commento al lezionario festivo romano e ambrosiano dell’anno B, Centro
Ambrosiano, Milano 2002
- CERESKO A., Giona, in Nuovo grande commentario biblico, Queriniana, Brescia 1997, pp. 757-762
- CERTEAU (de) M., Mai senza l’altro, Qiqajion – Comunità di Bose, Magnano 1993
- CHEVALIER J. – GHEERBRANT A., Dizionario dei simboli: Vol. II, BUR, Milano 1999, pp. 204-206
- COLZANI G., Dio onnipotente nell’amore: una certezza, molti problemi, “SdP” n. 309 (1999), pp. 22-25
- COMMISSIONE TEOLOGICO-STORICA DEL GRANDE GIUBILEO DELL’ANNO DUEMILA, Dio Padre di misericordia,
San Paolo, Cinisello Balsamo 1998
- CRAGHAN J., Ester, Giuditta, Tobia, Giona, Queriniana, Brescia 1995, pp. 153-179
- DECLAIS J.L., Nel nome del Dio misericordioso e pietoso (Es 34,4b-6.8-9), “PAF” n. 28, Queriniana, Brescia 1973, pp. 11-18
- DE GROOT A., La salvezza dei popoli nella Bibbia, Paoline Bari 1971, pp. 47-56
- DEROSSEAUX L., Dio ama tutti gli uomini (Giona 3,1-5.10), “PAF” n. 31, Queriniana, Brescia 1973, pp. 35-43
- DI SANTE C., Potenza e non potenza di Dio, “SdP” n.309 (1999), pp. 17-22
- Dizionario enciclopedico della Bibbia, Borla – Città Nuova, Roma 1995
- Enciclopedia illustrata della Bibbia, 3 voll., Marietti, Casale Monferrato 1997
- Esercizi 2004. Vivere e annunciare il Vangelo della misericordia e della pace ai poveri. La missione e la testimonianza dei laici
nell’oggi. Meditazioni sul libro di Giona, Roma 2004- FESTORAZZI F. – MAGGIONI B., Introduzione alla storia della salvezza, Elle Di Ci, Leumann 1974
- GALBIATI E. R. – ALETTI A., Atlante storico della Bibbia e dell’Antico Oriente, Massimo – Jaca Book, Milano 1983
- GIOVANNI PAOLO II, Dives in misericordia (1980), in EV/7, nn. 857-956, pp. 780-883
- GROLLENBERG L.H., Atlante biblico per tutti, Massimo, Milano 1965
- GUERRIERO E. – TARZIA A. (a cura di), L’ombra di Dio. L’Ineffabile e i suoi nomi, Paoline, Cinisello Balsamo 1991
- LEHMANN K., Dio è più grande dell’uomo, “Il Regno” 18/1999, pp. 637-648
- LOHFINK G., Ora capisco la Bibbia. Studio sulle forme letterarie della Bibbia, EDB, Bologna 1977, pp. 67-75
- LURKER M., Dizionario delle immagini e dei simboli biblici, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994
- MAGGIONI B., Giona, profeta controvoglia, “Riv cl it” 3/1996, pp. 182-191
- MARTINI C.M., Àlzati, va’ a Ninive, la grande città!. Lettera ai pastori e alle comunità della città sulla evangelizzazione, Centro
Ambrosiano, Milano 1991
- MATEOS J. – CAMACHO F., Vangelo: figure e simboli, Cittadella, Assisi 1991
- MELLO A., Il Dio misericordioso e gli attributi della sua misericordia, “PSV” n. 29 (1994), pp. 37-50
- MILANI G., Fino a settanta volte sette. Spunti di meditazione sul perdono, In Dialogo, Milano 1991
- NEHER A., L’esilio della Parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Marietti, Genova 1991 (in particolare pp. 162-168)
- NOTH M., Storia d’Israele, Paideia Brescia 1975
18
- Nuovo dizionario di teologia biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994
- Profezia (La), “PSV” n. 41 (1/2001)
- PRATO G. L., Tratti di violenza nel volto di Dio, “PSV” n. 37 (1/1998), pp. 11-24
- PRIOTTO M., Giona, in La Bibbia, Piemme, Casale Monferrato 1995, pp. 2173-2179
- QUINZIO S., Un commento alla Bibbia, Adelphi, Milano 1991, pp. 338-339
- RAD (von) G., Teologia dell’AT. Vol. II: Teologia delle tradizioni profetiche d’Israele, Paideia, Brescia 1974, pp. 338-342
- ID., La sapienza in Israele, Marietti, Torino 1975, in particolare pp. 177-187
- RAVASI G., Universalismo e particolarismo nell’AT, “PSV” n. 27 (1/1993), pp. 11-24
- ID., I profeti, Àncora, Milano 1975 (in particolare pp. 276-277)
- RENCKENS H., La religione d’Israele, Paoline, Modena 1972, pp. 207-249
- RICOEUR P. – JUENGEL E., Dire Dio. Per un’ermeneutica del linguaggio religioso, Queriniana, Brescia 1978
- RINALDI G., Giona, in La Sacra Bibbia. L’AT, vol. II, Marietti, Casale Monferrato 1964, pp. 1195-1200
- RIZZI A., Dio a immagine dell’uomo? Il linguaggio antropomorfico e antropopatico nella bibbia, “Rass teol” 1/1994, pp. 26-57
- ROCCHETTA C., Teologia della tenerezza. Un “vangelo” da riscoprire, EDB, Bologna 2000, pp. 103-132
- ROLLA A., (a cura di), Giona, in Il messaggio della salvezza, vol. II, Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1967, pp. 679-684
- RUGGERI C., Stenografie dell’anima. Simboli epigrafici delle catacombe, Piemme, Casale Monferrato 1991
- SALDARINI G., Il popolo di Dio e le nazioni, “Riv cl it” 11/1993, pp. 726-740
- SEMBRANO L., Giona va a scuola dai goym. La parabola di un Dio estroverso, in PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE, Padre nostro...liberaci dal male, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, pp. 83-93
- SEQUERI P., Il timore di Dio, Vita e Pensiero, Milano 1993
- Simboli. Dizionari Piemme, Piemme, Casale Monferrato 1993, pp. 186-187
- SOGGIN J.A., Introduzione all’AT, Paideia, Brescia 1974, pp. 467-471
- SPREAFICO A., I libri profetici e la profezia biblica, “Rass teol” 6/2003, pp. 805-820
- ID., Peccato, perdono, alleanza, “PSV” n. 29 (1994). pp. 25-36
- TUFARIELLO R., Giona, in Schede biblico-pastorali n. 136, EDB, Bologna s.a.
- TURCONI D., La storia di Giona, “Ev” 10/2001, pp. 594-596
- VIRGULIN S., Giona, in Introduzione alla Bibbia, vol. II/2, Marietti, Casale Monferrato 1971, pp. 536-543
- WESTERMANN C., Teologia dell’AT, Paideia, Brescia 1983, pp. 159-199
- WOLFF H.W., Studi sul libro di Giona, Paideia, Brescia 1982
- ZENGER E., Primo testamento. La bibbia ebraica e i cristiani, Queriniana, Brescia 1997
* Giona nella musica
- CARISSIMI G., Jonas, in Integrale degli oratori (= 9 CD), CD n. 1, Ensemble Seicentonovecento diretto da COLUSSO F.,
Musicaimmagine Records 1996 – MR 10020
* Giona nell’arte
- BEATO ANGELICO, I profeti, Duomo di Orvieto – volta della Cappella di san Brizio. Vedilo in MORANTE E. – BALDINI U.,
L’opera completa dell’Angelico, Rizzoli, Milano 1970; e in BERTI L., Angelico, Sadea – Sansoni, firenze 1967, tavola n. 83. (In
realtà risulta difficile individuare Giona tra i sedici profeti affrescati).
- MICHELANGELO, Ionas, Città del Vaticano – volta della Cappella Sistina. Vedilo a colori in ZUFFIS S., Michelangelo. La
Cappella Sistina, Electa, Milano 1999, e in bianco e nero in AA. VV., Michelangelo. Artista – pensatore – scrittore, De Agostini,
Novara 1980, p. 215
- Giona nel pesce. Miniatura tratta da La Bible de Sens, in BOCIAN M., o.c., p. 481
- Storie di Giona, sarcofago (fine III - inizi IV sec) , Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano. Vedilo in Iconografia e arte crisiana, vol.
I, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, figura n. 11, pag. 392.
don Gabriele
19
Scarica