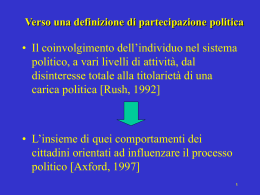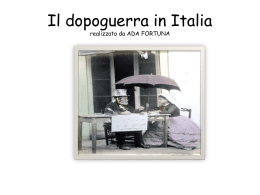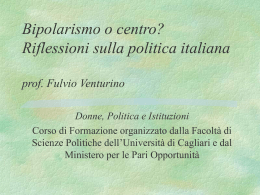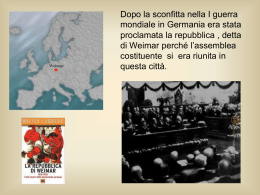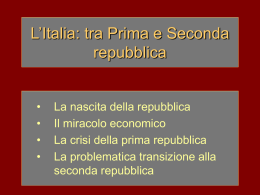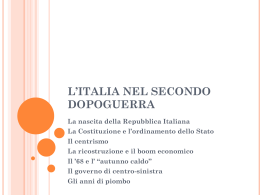EMANUELE CEGLIE La questione socialista oggi, dal Socialismo identitario al Socialismo “largo” Materiali politici di Rino Formica 1 Questo libretto è una specie di contenitore di materiali politici. Un raccoglitore di idee, analisi, riflessioni, semplici appunti, annotazioni; il tutto utilizzato, grosso modo dal 2007 ad oggi, per partecipare a un evento specifico oppure per fissare una linea di ragionamento da sviluppare magari in seguito e in un giro più largo di discussioni. Insomma, allo stesso tempo un memorandum di questioni e un tracciato per una storia e un’analisi politica della Sinistra e del Paese, una sorta di reagente chimico da immettere in un contesto di dibattito pubblico che da troppo tempo è inerte. Nel libretto c'è un cuore e un cervello, un sentimento e una ratio, entrambi impiantati nella politica. Sto parlando di Rino Formica, una figura notoriamente atipica, rispetto all'idealtipo del politico di professione che lo vuole o tutta tattica o tutto strategia in un quadro, naturalmente, dove se messe in competizione la tattica prevale quasi sempre sulla strategia. E perché sia chiaro che non si vuole fare qui l'agiografia del personaggio, va detto che personalità di questo tipo si sono formate in “scuole” particolari e sono maturate dentro una particolarissima esperienza storico-politica collettiva, quella del socialismo autonomista italiano, con l'accento posto sull'aggettivo "autonomista" e senza nulla togliere al valore di altre scuole. Si sta parlando di quella particolare esperienza che ha dovuto confrontarsi e scontrasi con l'Ideologia italiana, scritta nella Carta costituzionale, l'ideologia dello "stare assieme". Quella Costituzione "ideologica" voluta soprattutto dalle componenti "organiche" delle due più grandi forze politiche dell'Italia del dopoguerra: la sinistra democristiana e il PCI disegnato da Togliatti. Va da sé che l'Ideologia italiana poteva essere ricondotta nel solco della normalità liberaldemocratica e delle sue regole dell'alternanza, solo a patto di usare buoni gruppi dirigenti nonché la tattica più la strategia in una combinazione positiva di ardimento tattico e di saggezza strategica. Ecco spiegate le ragioni della formazione di un gruppo dirigente di “eccellenza”, quello socialista ed ecco spiegate anche le "atipicità" prodotte da quella esperienza. Quella storia finì come sappiamo nel 1993 e incominciò un'altra storia, una storia senza più il socialismo autonomista. Anzi una storia perfino contro la memoria di quel socialismo. Lo sviluppo impetuoso degli avvenimenti di questo ultimo ventennio associato allo status di semplice osservatore (quasi come ufficiali della riserva!) hanno creato le condizioni giuste per una riflessione che, in questo libretto, si srotola in più direzioni ma che sempre ritorna al suo nucleo originario: spiegare le ragioni della "diversità" dell'esperienza democratica nazionale e la durezza dello scontro per una risposta "normale" che i socialisti hanno voluto offrire alla governabilità del Paese, non riuscendoci. Un punto di osservazione certamente non neutro ma sicuramente disincantato e critico rispetto alle recriminazioni e alle pulsioni che ancora gravano sul campo di Agramante della Sinistra italiana. Questo libretto è ispirato da Rino Formica ed è cresciuto in un rapporto pluridecennale di scambio culturale, nel senso del confronto tra due culture politiche con molti tratti convergenti ma non omologabili, non fosse altro che per ragioni anagrafiche. La mia, maturata nella prima metà degli anni '60 tra i giovani comunisti per i quali la “via italiana al socialismo” è stata comunque una via “rivoluzionaria”, quella di Formica negli anni "ruggenti" dell'antifascismo nelle fila, assai scomode per quei tempi, di un socialismo non "frontista" e che si incontrano all'angolo di strada della crisi del berlinguerismo (siamo agli inizi degli anni '80) con le nuove prospettive aperte dal riformismo del nuovo PSI. Sullo sfondo c'era la Sinistra di governo, una sinistra che su quello sfondo oggi proietta una immagine di sé perdente se non informe. Se dunque l'ispirazione si deve a Formica, l'articolazione dei testi qui raccolti mi appartiene, come mi appartengono non poche dilatazioni concettuali e di giudizio, soprattutto alcune indulgenze per un moderatismo (il fenomeno del berlusconismo) che ha dato e sta dando pessima prova di sé ma che ha 2 anche segnato un punto di frattura rispetto al moderatismo "consociativo" della Prima repubblica, dal quale un altro personaggio assai distante dal “Cavaliere”, Bettino Craxi, tentò una difficile deviazione. Ebbene, di queste “forzature” sono pienamente responsabile, nella condivisione di un punto centrale di giudizio politico e di lettura storica delle vicende nazionali, vale a dire l’idea della forza passiva e conservatrice esercitata dalla Costituzione “organica” sulla forma della nostra democrazia e sulla tormentata evoluzione del nostro sistema istituzionale verso un modello di governance adeguato al tempo della globalizzazione. C’è una idea, in breve, che accomuna: la Sinistra di governo del nuovo millennio o riparte da qui, da questa “larghezza” di visione o sarà un’altra cosa. Emanuele Ceglie Per una guida alla lettura: I primi due capitoli, “La questione socialista oggi” e “Oltre la democrazia organica”, sono rispettivamente dell’aprile e settembre 2007. Entrambi sono stati elaborati come base di discussione sulla forma della nostra democrazia nell’occasione del 60° anniversario della Carta costituzionale. A settembre di quell’anno fu organizzato un convegno cui parteciparono vari esponenti della Sinistra e in quella sede i due documenti furono presentati e dibattuti. Il terzo capitolo dal titolo “Revisionismo e popolo” riproduce il documento presentato da Formica alla manifestazione nazionale organizzata dai Socialisti democratici italiani (SDI) per il lancio di una proposta di legge d’iniziativa popolare per l’elezione di un’Assemblea costituente. La manifestazione si svolse a Vieste (Fg) il 21 settembre 2008. Il quarto “L’uscita di sicurezza del Socialismo largo” è stato presentato a maggio 2012 a Milano. La rivista e il circolo socialista “Critica sociale” convocarono i “volenterosi” per il rilancio del quotidiano storico del PSI l’Avanti!, con Rino Formica direttore. Il capitolo quinto “Oltre la stagione dei manifesti” e il sesto “L’Italia: una società senza nazione” sono del 2012, anno “terribile”: crisi del berlusconismo, rinascita del centrismo, il fenomeno di massa del grillismo. E’ stata anche la stagione dei Manifesti politici, tra i quali quello di Giulio Tremonti, al quale i due documenti, riprodotti nei capitoli quinto e sesto, rivolgono una attenzione simpatetica e alla stesso tempo critica. Il capitolo settimo “Idee per una Sinistra senza l’idea del socialismo” e l’ottavo “Dalla questione morale alla questione criminale: il declino della Sinistra” sono del 2013 e non hanno avuto circolazione. Vanno letti come un memorandum di questioni, predisposto con l’idea di avviare un giro di 3 discussioni, coinvolgendo circoli socialisti, associazioni, gruppi di militanti e di compagni. Un giro per l’Italia per parlare del “Socialismo largo”. 4 Indice: Cap. I: La questione socialista oggi, dal socialismo identitario al socialismo largo (pag. 7) Cap. II: Oltre la democrazia organica (pag. 23) Cap. III: Revisionismo e popolo (pag. 35) Cap. IV: L’uscita di sicurezza del socialismo largo (pag. 47) Cap. V: Oltre la stagione dei manifesti (pag. 73) Cap. VI: L’Italia, una società senza Nazione (pag. 93) Cap. VII: Idee per una Sinistra senza l’idea del socialismo (pag. 109) Cap. VIII: Dalla Questione morale alla Questione criminale. Il declino della Sinistra (pag. 127) 5 6 Cap. I: La questione socialista oggi, dal Socialismo identitario al Socialismo “largo”. Per una discussione sulla forma-Partito: dal Partito-padrone al Partito-libertà. Per una rivisitazione del dibattito sul Revisionismo nella Sinistra: dal Socialismo liberale alla socialdemocratizzazione “passiva” del PCI. Sull’ “anticomunismo democratico” di Craxi e la “diversità” del comunismo italiano Note per un seminario socialista sul 60° anniversario della Costituzione italiana. Aprile 2007 7 Premessa: la crisi è sistemica E’ dal ’94 che ciclicamente alle debolezze e insuccessi del centro-destra seguono le delusioni del centro-sinistra. I governi dell’uno e dell’altro schieramento paiono sottostare a una legge che li condanna inesorabilmente a un basso profilo riformatore, a una ordinaria governabilità a fronte di arretratezze strutturali del paese, a una qualità della classe dirigente inadatta a mantenere una tensione riformistica come necessario e come promesso agli elettori. Le deludenti performances che segnano trasversalmente l’intero schieramento politico nazionale, hanno il loro fondamento e ragione nella distanza tra il carattere sistemico della crisi italiana, nell’incompiutezza della transizione italiana e gli strumenti dell’ordinaria manutenzione messi in opera dalla classe dirigente emersa a seguito dell’esaurirsi della prima repubblica, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Dalla caduta dell’impero e del comunismo sovietico sino ai giorni nostri, si è assistito, per rimanere allo scenario nazionale, al deperire lento ma costante dei grandi Partiti di massa (a cominciare dal PCI, più direttamente coinvolto dallo sgretolamento del polo sovietico perché in linea di continuità ideologica, nonostante gli sforzi interpretativi e storicizzanti, con la teoria leninista del potere) che hanno rappresentato l’ossatura del sistema democratico e di governo del Paese; uno sgretolamento che ha riguardato sia le grandi culture che hanno animato e caratterizzato le forze dell’arco costituzionale (la cultura cattolico-democratica, la cultura socialista-riformista, la cultura comunista-democraticocostituzionale) sia le strutture organizzative (i Partiti) che hanno permesso la partecipazione e la vita democratica. Dall’esterno (il crollo dell’URSS) e dall’interno (l’esaurimento della spinta propulsiva del sistema politico nato dalla Costituzione e dal patto politico tra le grandi forze nazionali) provengono i colpi demolitori portati alla forza e all’autorevolezza della DC, del PCI e del PSI. Nello spazio vuoto lasciato dai grandi partiti fanno irruzione forze localistiche, gruppi e partiti di Destra e di Sinistra rimasti ai margini del sistema, suggestioni e scorciatoie populistiche e leaderistiche, tentativi velleitari perché esclusivamente volontaristici di ricostruzione di vecchie storie politiche, strumenti e procedure istituzionali (nuovi sistemi elettorali) per gestire la transizione solo per via tecnocratica e comunque ordinaria. Il PCI, la DC, il PSI Se la crisi del PCI sta dentro la tenaglia del crollo del regime sovietico e il suo continuismo ideologico (in sostanza la irriformabilità e la rigidezza delle sue strutture politicoideologiche), la crisi della DC è più complessa e comunque assai più complessa delle ragioni francamente semplicistiche fondate sulla cosiddetta questione morale come spiegazione del suo declassamento a partito cattolico minoritario. Certamente la ragione storica della centralità democristiana data dalla sua funzione di contenimento della forza del comunismo italiano è assumibile per comprendere la crisi di questo Partito, ma non è sufficiente, accanto alla questione morale, a spiegarne la marginalità politica. Fatto sta che lo smantellamento del potere e del partito della DC ha come causa e nello stesso tempo conseguenza, straordinaria ed epocale, l’emersione di una nuova questione cattolica in Italia, che per comodità possiamo classificare all’insegna di un doppio dispositivo: l’operare congiunto di un processo di “departitizzazione” della Chiesa e delle gerarchie (liberate cioè da un rapporto di reciproco scambio e influenza con la DC) e 8 nello stesso tempo di “politicizzazione” del ruolo della Chiesa, la quale a partire da questo momento storico, mostra interesse a immettere nell’intero circuito politico-istituzionalecivile un progetto per il credente-cittadino e la società. La Chiesa si riconosce in un progetto di vita e di società e per questa prospettiva chiama trasversalmente a raccolta tutte le forze, senza preferenza alcuna. E’ la Chiesa, pertanto, a diventare polo aggregatore di individui, di pezzi di società, di classi dirigenti e ispiratrice di “politiche”. Come l’emergenza della questione morale nella sensibilità sociale e nella vita politica non spiega la crisi della DC, così non dà ragione di quella del PSI. La forte spinta revisionistica impressa da Craxi a partire dagli anni ’76-78 e dispiegatasi nel decennio successivo non incrina l’asse dell’ortodossia del PCI, al massimo introduce elementi di dialettica (anche in forma organizzata) al suo interno, né tanto meno ne riduce la forza elettorale. Sarà evidente, nell’ambito di un giudizio postumo, il limite della politica socialista di quegli anni (sostanzialmente durante tutto il decennio degli anni ’80): al revisionismo ideologico la dirigenza socialista non ha fatto seguire una piattaforma riformistica organica che riguardasse l’ambito della società, dell’economia e soprattutto delle istituzioni. Com’è altrettanto convincente il giudizio per cui il completo dispiegarsi della strategia riformatrice del PSI sarebbe inevitabilmente entrata in contraddizione, in virtù del patto ad excludendum, con il profilo degli accordi politici con la DC (il preambolo) che impegnava entrambi i partiti a mantenere l’azione di governo al di sotto della necessaria iniziativa riformatrice. Chi riempie il vuoto di riformismo? Il vuoto riformistico degli anni Ottanta sarà riempito nel decennio successivo da due fenomeni: il primo che chiameremo Berlusconismo, vale a dire una forza nata per raccogliere vaghi sentimenti di rinnovamento ma senza capacità di rielaborazione politicoprogettuale di medio-lungo periodo; puro contenitore di moderatismo, di conservatorismo e di generiche aspirazioni liberistiche, in attesa di rimodellarsi spontaneisticamente sull’onda di dinamiche e processi nazionali e sovranazionali. Il secondo chiamato Ulivismo, fenomeno senz’altro più complesso, nel quale non fa difetto la progettualità e che, anzi, si può dire sovraccarico di obiettivi, tra i quali la rigenerazione palingenetica della politica e la fusione delle tradizioni riformistiche del centro-sinistra italiano in un unico soggetto politico. Il progetto ulivista (che oggi si sostanzia nella costituzione del Partito democratico) sul quale la maggioranza del Centrosinistra scommette per una ristrutturazione degli schieramenti politici e dello stesso sistema politico, poggia sostanzialmente su due elementi che non partono costitutivamente come punti di forza ma sono piuttosto risposte a condizioni di emergenza politica: il primo è dato dalla necessità di dare uno sbocco “democratico” (e non socialdemocratico) al lungo cammino del comunismo italiano e alla sua necessità quasi fisiologica di rinnovarsi nella continuità; il secondo dall’esigenza del cattolicesimo democratico di praticare il terreno della politica al tempo dell’autonomismo della Chiesa cattolica (e quindi al tempo della fine del collateralismo) e dalla necessità di mantenere una identità in assenza di una forte leadership (dice Scoppola: “ (…) solo tenendo insieme e valorizzando le 9 diverse componenti che (sono) confluite nell’Ulivo si potrà sostenere da posizioni forti e credibili il confronto con tutta la coalizione, con un elettorato plurimo e anche con quegli ambienti cattolici e con quella parte della gerarchia che non è pregiudizialmente favorevole” in La democrazia dei cristiani, Laterza 2006). Il progetto ulivista si colloca dunque ad un crocevia nel quale confluiscono le crisi delle tradizioni politiche, le urgenze rigenerative della progettualità politica, forti istanze di rinnovamento in tutti i campi a seguito di una notevole maturità della società civile, e non ultima la questione cattolica nelle forme inedite che abbiamo descritto, a partire dalla sua “politicità” vale a dire della generalità e trasversalità della missione civile della Chiesa nel segno della identità della civilizzazione cristiana-occidentale. La forma-Partito: gli anni Settanta 1.- Agli inizi degli anni Ottanta i tre maggiori partiti sono organizzati attorno a modelli diversi ma assimilabili alla funzione di controllo sociale: il PCI conferma la forma partito di tipo centralista, sostanzialmente simile al modello leninista costruito nel dopoguerra; diretto da politici di professione e da un sistema di controllo politico sugli iscritti e sulla società di riferimento che esercita attraverso: un funzionariato a tempo pieno; il rifiuto del riconoscimento delle articolazioni interne; una posizione dirigistica rispetto alle organizzazioni di massa collaterali se non satellitari (prima tra tutte il sindacato, la CGIL). Il PSI abbandona sin dalla metà degli anni Settanta il modello morandiano-leninista. Per comprendere i termini della svolta dei socialisti non si può non partire dalla Conferenza d’Organizzazione del 1975 e dalla relazione di Formica, il quale, superando per la prima volta il leninismo (sub specie del morandismo) nella concezione della teoria del Partito propria della Sinistra, modella la riforma del Partito sulla base delle nuove articolazioni amministrative territoriali (la regione e il territorio urbano, come i distretti e le circoscrizioni, nel tentativo di depotenziare i vecchi gruppi di potere organizzati attorno alla Federazione provinciale). Il PSI si avvia verso modelli “leggeri” di organizzazione e formule organizzative sempre più lontane dai luoghi tradizionali (le sezioni) e sempre più tendenzialmente simili a “Club”, nei quali il rapporto gerarchico con gli iscritti non è funzionale al rigido controllo politico ma piuttosto a quello dell’allargamento del consenso. La DC sposta definitivamente e irreversibilmente il baricentro organizzativo dalla Sezione territoriale di partito alle molteplici forme di organizzazione socio-culturale e statuale, dalle quali ricava e nelle quali custodisce il consenso (dal sindacato alle parrocchie ai Ministeri). La DC, inoltre, con maggiore spregiudicatezza di altri, “personalizza” il rapporto con gli iscritti e fa della “corrente” di partito il luogo in cui il rapporto politico è filtrato attraverso la fidelizzazione con il Capocorrente e con la filiera dei personaggi di riferimento. Va detto che la “corrente” tende a riprodurre al proprio interno meccanismi di funzionamento e di relazione simili al Partito e non è in grado di sperimentare formule alternative di organizzazione. La “corrente” viene vissuta, da chi non può ancora consentirne l’agibilità al proprio interno (il PCI) e da chi invece le utilizza (la DC e il PSI) come forma degenerativa di organizzazione politica, in una dimensione “moralistica” e non, invece, come forma impropria e indiretta di “laicizzazione” della politica e dell’organizzazione. 10 La forma-Partito: gli anni Ottanta 2.- Gli anni Ottanta trascorrono in un sostanziale immobilismo della forma-partito. L’elemento più dinamico dei tre partiti presi in considerazione, il PSI, non sviluppa il progetto innovativo, concentrato com’è nell’impresa di governo, e si perde in una sorta di empirismo e di spontaneismo organizzativo che contempla sia la permanenza delle vecchie sezioni che la nascita di organismi sostanzialmente destrutturati e attivabili soprattutto durante gli scontri elettorali. Il PCI sotto la pressione del “dinamismo” dei socialisti e della consunzione del modello centralista-leninista, adegua la propria politica organizzativa in forma passiva, accettando le situazioni di fatto senza rielaborarle e incorporarle in una nuova visione strategica dell’organizzazione. Ne è l’esempio la nascita delle correnti e la loro accettazione come male minore. Si può dire che il PCI si indebolisce organizzativamente per lenta e inesorabile consunzione del modello storico ma non innova il modello di Partito. Uguale ragionamento può esser fatto per la DC, nella quale la fenomenologia che ha caratterizzato la lenta trasformazione della cultura dell’organizzazione, vale a dire la delega verso le strutture collaterali (dall’associazionismo alle strutture statuali) e il modello personalistico-correntizio, si dispiega appieno privandola di un sistema di difesa adeguato alla centralità politica di questo Partito. Un primo bilancio 3.- Si può sostenere che un intero ventennio (gli anni ’80 e ’90) di profonde trasformazioni nel Paese e di interconnessione con altri sistemi politici e di relazioni internazionali nel quale l’Italia è organicamente inserita, è passato senza segnare sostanziali modifiche nella forma partito di PCI, PSI e DC. A Sinistra, nonostante gli stop and go tentati dai socialisti italiani (il superamento della sezione a favore dei Club) e gli sforzi dei comunisti e, successivamente all’89, dei postcomunisti di preservare la “cultura dell’organizzazione” dalla modernizzazione della società e dal fallimento del socialismo reale, il modello prevalente resto il “modello misto”: partito socialdemocratico (di massa) e il partito leninista (delle avanguardie e dei gruppi dirigenti). Per inciso va detto che nonostante l’indebolimento dell’organizzazione comunista (e postPCI), questa ha resistito, al contrario del PSI e della DC, all’ondata antipolitica e antipartitica che ha avuto negli anni di Tangentopoli il momento topico. Anzi, l’essere stato il PDS in quel periodo l’unica struttura organizzata funzionante e ancora intatta nella sua articolazione, ha consentito a questo partito di incanalare politicamente i propositi giustizialisti indotti dalle iniziative di Mani pulite in una direzione tendente a massimizzare il consenso al partito a danno degli altri. Il secolo breve si chiude, dal punto di vista della concezione e della struttura del partito, con la sommatoria dei due modelli che ne hanno caratterizzato la storia: la socialdemocrazia tedesca e il PCUS nelle sue varianti nazionali. Il partito socialdemocratico nella funzione di controllo sociale diffuso, di educazione politica, di selettore delle istanze e delle aspirazioni sociali e di amministratore politico e di governo di tali istanze. 11 Il partito bolscevico nella funzione di produttore di classe dirigente, di cultura ed egemonia politica, a metà strada tra Nuovo Principe, custode dell’ordine statuale e Ingegnere sociale e politico. S’avanza un nuovo modello: il Partito “americano” 4.- La disaffezione politica che oggi è assai diffusa soprattutto tra le nuove generazioni esige un completo ripensamento della struttura del partito e della stessa cultura politica che sorregge l’Organizzazione. Tale ripensamento non può che avvenire attraverso un rovesciamento e una completa ristrutturazione del “modello misto” e ad ogni modo non può avvenire se non dopo aver preso atto che il modello anglosassone di partito (per dirla più rozzamente: il “Partito americano”) è quello che più di tutti ha dato prova di tenuta, di efficienza e di vitalità. Potremmo dire: il Partito americano contrapposto al Modello misto europeo. Va preso atto che il “modello misto” o partito “a due piani” (socialdemocrazia più partito bolscevico) si è dimostrato alla prova dei fatti, vale a dire alla prova della maturità democratica delle moderne società, assai debole proprio là dove doveva esibire la sua forza di attrazione: il controllo sociale. Infatti i modelli anglosassoni vincono la competizione con i modelli continentali e latini in quanto percepiscono con maggiore velocità il cambio di direzione della funzione organizzativa del moderno partito politico: il passaggio dalla funzione di controllo a quello di strumento di partecipazione e di fluidificazione del rapporto cittadino e potere, regolandone lo scambio politico. Il modello socialdemocratico invecchia E’ evidente come la diversa cultura organizzativa si rovescia direttamente nella cultura politica e nei programmi politici. Il vecchio partito socialdemocratico è legato a programmi redistributivi della ricchezza, propri di una funzione dirigistico-elitaria dell’azione politica. L’altro modello invece punta alla fluidificazione e alla massificazione delle opportunità di crescita sociale ed economica. Il povero non diventa più ricco sottraendo a quest’ultimo quote di ricchezza (attraverso la leva fiscale ad esempio). Il povero diventa ricco se ne è capace e soprattutto se la società provvede a fornirgli gli strumenti (le opportunità) per diventarlo. Il modello “alternativo” a quello socialdemocratico presuppone una relazione gerarchica tra iscritti e gruppo dirigente, completamente diversa dalle forme fin qui conosciute nell’esperienza nazionale. Mentre nel primo modello (diciamo “misto”) prevale la figura del “dirigente politico” il quale, attraverso la “carriera” e l’esperienza politico-partitica, legittima il ruolo di preminenza politica e di controllo sulla base degli iscritti, nel secondo modello è la figura del cittadinoelettore a prevalere. L’esercizio della democrazia nell’esperienza anglosassone si sostanzia soprattutto nel momento del voto che è anche il momento di conferma dell’adesione al Partito o al leader, piuttosto che nella “militanza” nel partito, nella permanenza nel partito, nel “lungo corso” all’interno del Partito. 12 In tal guisa il cittadino-elettore, attraverso la sua partecipazione attiva o passiva alla campagna elettorale (che diventa non solo evento “elettoralistico” ma anche momento di discussione e di perfezionamento del programma di governo) regola il grado di adesionepartecipazione all’attività politica. Come? 1.- iscrivendosi alle liste elettorali per la partecipazione alla scelta del candidato (le primarie); 2.- finanziando pubblicamente il partito o il candidato, con ciò dichiarando (pubblicamente) una volontà partecipativa e una esplicita richiesta di scambio politico (informazioni sull’attuazione del programma, sull’attuazione di precisi punti del programma che erano alla base dello scambio politico pubblico; quindi non solo scambio di prebende o favori). In pratica viene a configurarsi una struttura articolata di partecipazione: sia a bassa intensità (momento elettorale) sia ad alta intensità (iscrizione in Liste pubbliche di partito, adesione diretta la partito, finanziamento etc.). Si afferma un modello a “partecipazione variabile”: dal basso verso l’alto (partecipazione alla vita pubblica e alla vita dell’amministrazione e del governo, dalla scelta del candidato, al sostegno economico e di militanza, al voto per il leader prescelto); dall’alto verso il basso (flusso di informazioni sulle attività di governo non omogeneamente distribuito ma per l’appunto proporzionato al livello di adesionepartecipazione del singolo all’attività politica: “tanto più dai al Partito o al candidato, tanto più riceverai in cambio, in termini di feedback sull’azione di governo”). Alcune conclusioni: a)- Per un intero ventennio si confrontano due “soluzioni” organizzative: quella di derivazione nazional-comunista caratterizzata da struttura piramidale e centralismo e quella più “leggera” costruita dai due partiti che hanno condiviso la responsabilità del Governo di centro-sinistra, il PSI e la DC. Questi ultimi lentamente ma costantemente lasciano deperire la forma-partito del dopoguerra per diventare “macchine del consenso” (di produzione e di conservazione del consenso), sempre meno legate alle e vincolate dalle strutture “interne” e sempre più dipendenti dalle articolazioni del potere (locale, burocratico-amministrativo, dell’impresa pubblica), quindi seguono una linea di riorganizzazione “esterna” (è stato coniata per tale mutazione una definizione efficace “il partito degli assessori”). Partito leggero e interessi “pesanti” La domanda è: perché nonostante la posizione governativa e predominante di PSI e DC negli anni qui considerati, gli anni Ottanta e buona parte dei successivi, il partito leggero ha perso di fatto la competizione con il modello burocratico-leninista? Una possibile risposta può trovarsi nella considerazione secondo cui la società italiana, intesa come configurazione complessiva dei rapporti politici, economici e sociali, non era ancora pronta ad accogliere la riorganizzazione della forma-partito (riorganizzazione inconsapevole e spontaneistica) operata da PSI e DC ed era ancora organicamente rappresentata da modelli di militanza-rappresentanza di tipo verticale assicurati invece dal PCI e funzionanti anche dentro le mutazioni post-comuniste di questo Partito. Probabilmente il PCI e successive denominazioni hanno interpretato meglio di altri lo “spirito del tempo” della società e della macchina politico-istituzionale italiana. 13
Scarica