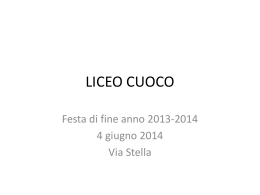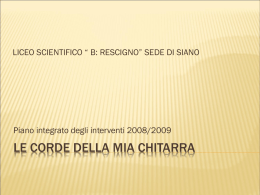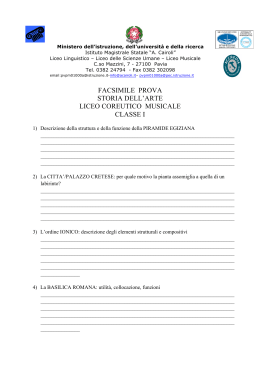LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.D. CASSINI” Via Galata, 34 C - 16121 GENOVA TEL. 010 580686 - FAX 010 541549 e-mail: [email protected] A.S. 2014/2015 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ B 08 maggio 2015 1 SOMMARIO I PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO ........................................................................................ 3 II PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ........................................................................................ 4 TABELLA 1. INSEGNANTI NEL TRIENNIO ............................................................................................................. 4 TABELLA 2. STUDENTI .............................................................................................................................................. 4 STORIA E FISIONOMIA DELLA CLASSE .......................................................................................................................... 5 III TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE................................. 6 III. 1. TEMPI E VERIFICHE DELL’ULTIMO ANNO (FINO AL 08 MAGGIO) ...................................................................... 6 III. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO. ..................................................................................... 6 III. 3 INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO.............................................................................................................. 6 IV. SINTESI PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE MATERIE ........................................ 6 IV. 1 ITALIANO DOCENTE: PROF.SSA CLAUDIA GHIONE.............................................. 7 IV. 2 LATINO DOCENTE: PROF.SSA CLAUDIA GHIONE ............................................ 12 IV. 3 INGLESE DOCENTE: PROF. SSA M. LUISA CAMBIASO ................................................ 14 IV .4 STORIA DOCENTE: PROF. SSA SILVANA MARCHETTI .............................................. 15 IV. 5. FILOSOFIA DOCENTE: PROF. SSA SILVANA MARCHETTI ........................................... 15 IV. 6 MATEMATICA DOCENTE: PROF.SSA LUCIA DAGNINO ............................................. 19 IV. 7 FISICA DOCENTE: PROF. FABIO VALERI................................................... 20 IV .8 SCIENZE DOCENTE: PROF. SSA PAOLA MARIA ARECCO .......................................... 21 IV. 9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DOCENTE: PROF. MARIO CARAFFINI ................................................ 22 IV. 10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: PROF.SSA DANIELA POGGI ................................................. 23 IV . 11 RELIGIONE DOCENTE: PROF. SSA ADELINA PALESTINI ........................................... 24 V ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI ............................................................ 25 VI SIMULAZIONI .......................................................................................................................... 25 VII ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO ............................................................... 26 VIII INDICE ALLEGATI .............................................................................................................. 28 IX IL CONSIGLIO DI CLASSE .................................................................................................. 299 2 PREMESSA COMUNE (dal P.O.F.) I PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO Il Liceo Scientifico ha il compito istituzionale di formare giovani che mostrino spiccati interessi per le discipline scientifiche, ma che considerano basilare una formazione umanistica. Offre, pertanto, una preparazione culturale generale solida e ben armonizzata nei rapporti tra le diverse aree disciplinari. Educa al pensiero critico, al rigore concettuale e logico, all'analisi dei problemi con adeguate metodologie di indagine. Il corpo docente si impegna a sostenere l’alunno nel suo sviluppo, nella sua maturazione, nella sua crescita culturale e anche nelle difficoltà, nell'esercizio delle sue capacità di scelta, nell'assunzione di responsabilità. I docenti sono consapevoli della centralità dell'alunno nella scuola, che è chiamata a porsi al servizio della sua educazione, ed a rivolgere perciò particolare attenzione per le condizioni che favoriscono l'apprendimento (e quindi la conquista della cultura) e, soprattutto, per la "qualità" della relazione e della comunicazione educativa Obiettivi formativi generali Il Liceo, attento ai dispositivi di innovazione istituzionale e di ammodernamento culturale del sistema scolastico, ha attivato e continua ad attivare strategie organizzative e didattiche in grado di assicurare all'intera sua utenza un'elevata qualità dell'istruzione. Obiettivo comune è che il Liceo sia luogo di formazione attraverso percorsi disciplinari progettati con serietà e rigore, nella consapevolezza che una scuola depotenziata culturalmente e orientata alla formazione in modo generico è antidemocratica e non crea uguali opportunità per i suoi fruitori. Profilo formativo in uscita Area umanistica: - competenza logico — linguistica - interpretazione e contestualizzazione di un testo nella prospettiva artistica, storica, letteraria e linguistico — comunicativa - autonoma decodifica dei testi in lingua latina - consapevolezza del distacco storico nell’istituire collegamenti tra eventi, istituzioni, problemi, mentalità del passato e del presente - ricostruzione delle diverse problematiche filosofiche esposte in modo corretto a livello teorico e terminologico Area scientifica: - uso corretto del lessico specifico - analisi e schematizzazione di situazioni problematiche - descrizione di fenomeni attraverso modelli teorici - esposizione sintetica e rigorosa di teorie scientifiche - applicazione di leggi e procedimenti adeguati nella risoluzione di esercizi e problemi - uso corretto degli strumenti e delle norme di rappresentazione grafico - bidimensionale e tridimensionale per il disegno geometrico e a mano libera 3 Obiettivi trasversali: - metodo di studio rigoroso - competenza linguistico — comunicativa - coerenza sul piano logico — argomentativo - ricettività riflessiva e rielaborativi. II PRESENTAZIONE DELLA CLASSE Tabella 1. INSEGNANTI nel TRIENNIO Insegnanti Materia 3^ Liceo 4^ Liceo 5^ Liceo 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Religione Adelina Palestini Adelina Palestini Adelina Palestini Italiano e Latino Claudia Ghione Claudia Ghione Claudia Ghione Silvana Marchetti Silvana Marchetti Silvana Marchetti Storia Paola Boschieri Silvana Marchetti Silvana Marchetti Inglese M. Luisa Cambiaso M. Luisa Cambiaso M. Luisa Cambiaso Lucia Dagnino Lucia Dagnino Lucia Dagnino Fabio Valeri Fabio Valeri Fabio Valeri Cristina Krawietz Paola Maria Arecco Paola Maria Arecco Mario Caraffini Mario Caraffini Mario Caraffini Giuliana Piacentini Giuliana Piacentini Daniela Poggi Filosofia Matematica Fisica Scienze Disegno e St. Arte Scienze Motorie e Sp. Tabella 2. STUDENTI Consistenza numerica della classe Studenti Totale Non promossi Ritirati 3 1 3^liceo 19 (provenienza 2B) 4 (provenienza 2P) 5 (provenienza 2L) 28 4^ liceo un nuovo inserimento 25 5^liceo un nuovo inserimento (non effettivamente frequentante) 22 3 4 Storia e fisionomia della classe L’analisi dei dati relativi al triennio mostra come la classe V B abbia subito una progressiva riduzione numerica. Per quanto concerne la stabilità didattica, occorre segnalare che non vi sono stati cambiamenti radicali, tranne che per l’avvicendamento dell’insegnante di Scienze dalla Terza alla Quarta e di Scienze Motorie dalla Quarta alla Quinta. La natura composita della classe terza, risultante dall’unione di tre gruppi provenienti da sezioni diverse, ha determinato sin dall’inizio una certa disomogeneità dal punto di vista comportamentale e metodologico. Nel corso del triennio tale condizione non è stata totalmente superata. Ora infatti la classe presenta un gruppo che ha raggiunto gli obiettivi prefissati con risultati apprezzabili in quasi tutte le discipline, mostrando un impegno costante con un profitto buono e un gruppo che, per difficoltà pregresse e impegno non costante, in alcune discipline ha raggiunto risultati appena sufficienti . Sul piano dei rapporti interpersonali, i ragazzi si caratterizzano per notevole vivacità, unita a buone qualità umane, disponibilità al dialogo e alle iniziative culturali proposte dai docenti: è necessario sottolineare come, durante le visite guidate svolte nel corso del triennio e durante varie attività condotte fuori dall’ambiente scolastico, la partecipazione e l’interesse sono sempre stati apprezzabili, corretto il comportamento. III IL PERCORSO FORMATIVO III. 1 La proposta formativa Nelle riunioni del consiglio di classe e dal confronto dei piani di lavoro sono stati individuati obiettivi comuni alle diverse discipline. I docenti hanno finalizzato la loro attività al raggiungimento di tali obiettivi, considerati primari, e hanno collaborato in modo da far giungere agli studenti un messaggio didattico e formativo omogeneo. III .2 Metodologia Nel corso del triennio il Consiglio di Classe non ha utilizzato in modo sistematico la dimensione interdisciplinare. Tuttavia, pur evitando inutili ed innaturali forzature, i docenti si sono preoccupati, ove possibile, di realizzare una più stretta collaborazione e di armonizzare contenuti e metodologie didattiche. Ogni volta che se ne è presentata l'opportunità, è stato indicato agli studenti un possibile coordinamento con altre materie di studio, lasciando loro il compito di una eventuale personale elaborazione in senso interdisciplinare. Tutto ciò è stato fatto in vista della preparazione alla prima parte del colloquio e nella convinzione che gli studenti fossero sufficientemente autonomi per poter operare delle scelte personali, in base alle loro attitudini e ai loro interessi. Ovviamente gli alunni che ne hanno fatto richiesta sono stati sostenuti dai docenti che li hanno orientati circa il materiale di consultazione e circa il percorso da esplorare. Nella didattica è stata privilegiata la lezione frontale, pur sollecitando gli alunni ad una risposta il più possibile vivace ed attiva. Nel corso del triennio la classe ha usufruito, entro i limiti del possibile, dei laboratori di fisica, di scienze e di informatica, nonché del videoproiettore e delle altre attrezzature multimediali di cui è fornita ogni aula di questo Liceo. Il lavoro ha rispettato un impianto essenzialmente storico per le discipline umanistiche, come previsto nei manuali e come tradizione della cultura liceale. Per quanto riguarda invece le materie scientifiche, il loro specifico statuto disciplinare – di un sapere come descrizione della realtà fenomenica o di un sapere articolato nella dimensione della consequenzialità logica più che nella consecutività cronologica – ha comportato l'adozione di un diverso impianto metodologico. 5 III TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE III. 1. Tempi e verifiche dell’ultimo anno (fino all’ 8 maggio) III. 2 Criteri di valutazione adottati dal Consiglio. I criteri di valutazione risultano dal confronto e dalla sintesi dei criteri specifici dei diversi ambiti disciplinari, con riferimento agli aspetti comuni. La valutazione degli studenti, coerentemente con quanto previsto dai parametri per l’Esame di Stato si è articolata tenendo conto del livello di partenza, del profitto, dell’assiduità alle lezioni, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. Più in dettaglio, per le prove orali il consiglio ha ritenuto di tener conto dei seguenti elementi: Comprensione della domanda Informazione puntuale sugli argomenti proposti Correttezza espressiva e uso di un lessico adeguato Coerenza logica e abilità intuitive Rielaborazione e capacità di collegamento. I parametri indicati coprono in sostanza tutta la gamma valutativa, dall’insufficienza grave al livello di eccellenza. In particolare, per la sufficienza nei colloqui, il consiglio ha ritenuto che fosse necessario soddisfare i seguenti criteri: informazione essenziale uso di un linguaggio senza errori di rilievo accettabile capacità di orientarsi negli argomenti richiesti. Per le prove scritte ovviamente i parametri di valutazione si differenziano secondo le discipline, per ciascuna delle quali si rimanda alla griglia di valutazione, tuttavia è possibile individuare alcuni criteri condivisi dai docenti di tutte le materie: esatta interpretazione del testo completezza coerenza logica correttezza (linguistica, concettuale, di calcolo, grafica e formale). III. 3 Interventi di recupero e sostegno. Tutti gli insegnanti hanno provveduto al sostegno in itinere a seconda delle necessità degli studenti. Nel secondo quadrimestre sono stati attivati un corso di recupero di 6 ore di matematica in vista della prova di recupero dell’insufficienza del primo quadrimestre. Gli studenti hanno inoltre avuto la possibilità, durante tutto l’anno scolastico, di usufruire di sportelli tenuti dagli insegnanti della scuola. (Matematica e Fisica, Scienze, Latino, Storia e Filosofia). IV. SINTESI PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE MATERIE Si presentano gli aspetti fondamentali delle programmazioni individuali, predisposte all’inizio dell’anno dai singoli docenti. Per una puntuale indicazione dei contenuti svolti si rinvia ai programmi allegati. 6 IV. 1 ITALIANO Docente: Prof.ssa Claudia Ghione Obiettivi e prestazioni Cod Descrizione dell’obiettivo obiettivo Ob.1 Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta 1a (decodifica e ricodifica di messaggi) 1b a .Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale Ob.2 Ob.3 Ob.4 Ob.5 b. Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta (organizzare un discorso orale in forma grammaticalmente corretta e sempre più efficace; affrontare con sempre maggior autonomia e consapevolezza testi di ogni genere, utilizzando progressivamente le tecniche di lettura e di studio più adatte; produrre testi scritti di diverso tipo, dimostrando di sapere padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici; usare correttamente la lingua nelle sue strutture fondamentali, nelle diverse funzioni e nei vari modelli di scrittura (saggio breve, relazione, articolo di giornale, intervista, lettera), come previsto dalla normativa, pur nel rispetto di un processo graduale, in relazione anche alla fisionomia delle varie classi) Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano (considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature) Capacità di interpretazione corretta di un testo e di contestualizzazione Elaborazione di un giudizio critico (sviluppo della capacità di riflettere sui testi, facendo interagire in un confronto dialettico critico le proprie idee con quelle proposte dai testi medesimi e dalla critica) Sviluppo del senso estetico, dell’abitudine alla lettura, della curiositas in senso lato Codice prestazione Esplicitazione della prestazione Prest.1 Prest.1a Prest.1b Lo studente deve dimostrare : a) competenza espositiva nell’orale, esprimendosi in modo corretto ed appropriato, con graduale acquisizione del lessico specifico b) capacità di produrre vari modelli di scrittura, oltre al tema tradizionale: analisi di testi letterari e non saggio breve (Testo sintetico, rivolto ad un pubblico esperto, che affronta tematiche culturali, con l’obiettivo di fare il punto sulla questione e esprimere una posizione. Coerentemente con tali caratteristiche, esso può avere vincoli di spazio e un’articolazione della traccia in singoli quesiti); articolo di giornale (Diverse le tipologie: dagli articoli degli opinionisti alle cronache, ai servizi, alle inchieste. Due i vincoli fondamentali: le coordinate dell’informazione – chi, cosa, dove, quando, perché – e le caratteristiche del destinatario che condizionano anche la scelta del registro linguistico); e se opportuno in rapporto alle disposizioni ministeriali: intervista; lettera ; relazione. 7 Prest.2 cogliere, attraverso gli autori e i testi più rappresentativi, le linee essenziali della tradizione letteraria nella prospettiva storica e culturale Prest.3 condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; collocare il testo in un quadro sempre più completo di confronti e di relazioni riguardanti i seguenti fattori: le tradizioni dei codici formali e le istituzioni letterarie; altre opere dello stesso autore o di altri autori coevi o di altre epoche; altre espressioni artistiche e culturali; il contesto storico di appartenenza. Prest.4 mettere in rapporto il testo con le proprie conoscenze ed esperienze e la propria sensibilità e formulare un motivato giudizio critico Prest.5 modificare il proprio atteggiamento in relazione agli interventi didattici Obiettivi – Prestazioni attese Prest.1 a Esposizione Prest.1 b orale Produzione vari modelli di scrittura Ob.1 a Padronanza linguistica orale Ob.1 b Padronanza linguistica Scritta Ob.2 Conoscenza storia letteraria Prest.2 Conoscenza linee essenziali della prospettiva storica X Prest.3 Analisi del testo Prest.4 Dal testo al giudizio critico X X X X X X X X X X Ob.3 Conoscenza testi Ob.4 Interpretazione testi e X X X X X X X X contestualizzazione Ob.5 Elaborazione di giudizio critico X 8 Nuclei fondamentali del percorso didattico Codice nucleo Descrizione Nucleo 1 concetto di testo e testo letterario, procedimenti retorici, generi, principali forme metriche Nucleo 2 pratica della produzione scritta da esercitare in forme varie che abituino gli alunni ad elaborare testi di diversa funzione e diversa natura ( riassunto, paragrafazione, risposte a quesiti rispettando limiti di estensione, raccolta ed organizzazione di dati) Nucleo 3 orientamento sui grandi movimenti letterari ( il fenomeno letterario nel suo costituirsi) Nucleo 4 conoscenza degli autori più significativi (indicati dalla critica come tali e presenti nella pratica scolastica) Nucleo 5 conoscenza di testi esemplari ( che meglio documentano la poetica degli autori, che sono inseriti nel percorso di storia letteraria, che sottolineano le relazioni tra produzione letteraria e società ed i rapporti tra la letteratura e le altre manifestazioni artistiche, ma anche utili per completare percorsi pluridisciplinari concordati nei Consigli di classe o rispondenti ad interessi manifestati dalla classe). N.B. Non dimenticare la valenza estetica del testo Nucleo 6 riflessione metalinguistica ( comprensione e descrizione delle strutture della lingua e dei fenomeni linguistici) Nucleo 7 nuclei didattici propri del consiglio di classe in relazione ad un percorso plurudisciplinare Contenuti disciplinari Storia della Letteratura italiana dalla fine del Settecento alla metà del Novecento, con particolare attenzione agli autori che, per acquisito giudizio vengono considerati più rappresentativi e lettura, analisi, commento di loro testi significativi: Il Neoclassicismo * Foscolo * La polemica classico romantica Il Romanticismo: Manzoni Leopardi Dal romanzo storico al romanzo contemporaneo La reazione al Romanticismo: Carducci, Scapigliatura Verismo: Verga Decadentismo: Pascoli D’Annunzio I Crepuscolari e i Futuristi Pirandello Svevo Ungaretti Montale A discrezione del singolo docente, si potranno inoltre presentare esempi di poesia e di narrativa contemporanea italiana e straniera ( anche come risultato di letture svolte nell’arco del triennio, ad es. Gadda, Pavese, Calvino, Sciascia, Silone , Pasolini,etc.) 9 Divina Commedia: lettura, analisi e commento di almeno 7 canti del “Paradiso”, qualora non si sia optato per scelte diverse nei due anni precedenti. * Qualora tali argomenti si siano svolti nel corso della classe quarta, il programma inizierà dalla polemica classicoromantica. Verifica - valutazione Prove scritte secondo le varie tipologie dell’esame di Stato; verifiche orali alla fine di ogni argomento trattato; durante le lezioni domande informali ( senza voto) alla classe o al singolo allievo per il ripasso e la puntualizzazione degli argomenti trattati ( si veda la tabella seguente ) Tipologie degli strumenti utilizzati per la verifica prove scritte Tipologia Le varie tipologie previste dall’ esame di stato prove orali Tipologia Interrogazione breve (interventi) Interrogazione lunga Test / questionari Questionari Lavori assegnati Agli studenti per casa Tipologia Quesiti a risposta singola (con n° di righe indicato) Quesiti a risposta multipla Quesiti a tipologia mista Tipologia Esercitazioni di scrittura (saggi brevi, analisi testuale, stesura di testi per percorsi disciplinari o pluridisciplinari, parafrasi, riassunti) con eventuale correzione a campione Relazione libri letti Revisione e approfondimento di argomenti trattati Metodologia di svolgimento delle verifiche scritte Viene data a tutti la stessa prova? Vengono comunicati in anticipo gli obiettivi da sottoporre a verifica? Viene comunicata in anticipo la prestazione attesa? Viene presentata in classe una rilevazione statistica dei risultati ottenuti? I risultati di una verifica sono messi in relazione con quelli delle verifiche precedenti in termini di obiettivi? Le verifiche sono calendarizzate in armonia con quelle delle altre materie? Durante le verifiche gli alunni in difficoltà ricevono opportune indicazioni e aiuto? No Si Si Non formalizzat a Si Si Si 10 Metodologia della valutazione delle prove scritte - scritto grafiche questionari Viene predisposta una griglia di valutazione? (in caso di si alla domanda precedente) La griglia è nota agli alunni? La griglia è concordata con gli alunni? Indicare la gamma dei voti utilizzati ( voto minimo - voto massimo) Le valutazioni assegnate sono riferite alla media? Se in una prova vi è una maggioranza di esiti insufficienti, viene annullata? Se "si", quale deve essere la percentuale delle insufficienze? Se "no", quale significato viene attribuito alla verifica? Precisare brevemente: Si Sì 2 Si No 10 No Metodologia di valutazione delle prove orali Viene chiamato alla cattedra un alunno alla volta? Viene impostato un dialogo con più alunni alla cattedra? Viene impostato un dialogo con uno o più alunni dal posto? Viene usata una griglia di valutazione per il colloquio? Si Tale griglia (o i criteri)di valutazione vengono spiegati agli alunni? La valutazione del colloquio viene accompagnata da motivazioni adeguate? Nel caso di più alunni le motivazioni vengono confrontate? Le valutazioni vengono segnalate alla famiglia tramite il libretto? In caso di contestazione motivata siete disponibili a modificare la valutazione? Si Si Si Siete favorevoli alle interrogazioni programmate? Indicare una stima delle ore complessive, riferite al totale annuo, dedicate alle interrogazioni Sì Si Non formaliz zata No Sì Solo per errori material i Si No 1/3 circa 11 IV. 2 LATINO Docente: Prof.ssa Claudia Ghione Obiettivi e prestazioni Codice obiettivo Ob.1 Ob.2 Ob.3 Descrizione dell’obiettivo Acquisizione di solidi strumenti linguistici: conoscenze morfosintattiche e lessicali ( evoluzione semantica dei vocaboli più ricorrenti), retoriche (più comuni) Acquisizione di abilità di comprensione, traduzione ed analisi di testi in prosa e poesia Conoscenza della periodizzazione storica, letteraria e dei generi letterari e degli autori più significativi Ob.4 Individuazione del ruolo storico della lingua latina nella sostanziale unità della civiltà europea Ob.5 Attualizzazione ( riconoscimento della persistenza e/o della diversità )dell’antico e valutazione critica Codice prestazione Esplicitazione della prestazione Prest.1 Acquisizione di una competenza linguistica ricettiva ( classe 3°) Prest.2 Capacità di servirsi di tale competenza per decodificare i testi in lingua e renderli in forma italiana appropriata Prest.3 Capacità di collocare testi ed autori nel loro contesto storico e di genere (classe 3°) Prest.4 Capacità di rilevare i nessi tra latino, italiano e civiltà europea ( classe 4°) Contestualizzazione delle conoscenze nell’ambito della civiltà latina, attuando il confronto tra diversi modelli linguistici e differenti realtà culturali (classe 5°) Tabella dei nuclei fondamentali del percorso didattico Codice nucleo Prest.5 Descrizione Nucleo 1 Competenza linguistica ricettiva Nucleo 2 Metodologia e tecnica della traduzione Nucleo 3 concetto di testo e testo letterario, procedimenti retorici, canone, genere. 12 Nucleo 4 conoscenza degli autori più significativi (indicati dalla critica come tali e presenti nella pratica scolastica) Nucleo 5 conoscenza di testi esemplari ( che meglio documentano la poetica degli autori, che sono inseriti nel percorso di storia letteraria, che sottolineano le relazioni tra produzione letteraria e società ed i rapporti tra la letteratura e le altre manifestazioni artistiche, ma anche utili per completare percorsi pluridisciplinari concordati nei Consigli di classe o rispondenti ad interessi manifestati dalla classe). Contenuti disciplinari A. ripasso del programma di morfologia e sintassi B. Lettura, traduzione e commento di Autori classici: Lucrezio: almeno 150vv. e/o Seneca o Cicerone, o altri autori di prosa : almeno 10 passi C. Storia della letteratura latina: la letteratura dell’età imperiale: l’età neroniana: Seneca, Petronio, Lucano; la satira di età imperiale: Persio, Giovenale; la poesia epica nell’età dei Flavi; la retorica: Quintiliano; l’epigramma: Marziale; Tacito; ; Apuleio; caratteri generali della letteratura cristiana D. Si precisa esplicitamente che ogni docente potrà, anche in relazione alla programmazione del Consiglio di classe, approfondire uno o più degli argomenti indicati sopra o seguire percorsi per generi e temi, o ancora, a sua discrezione oltrepassare i limiti cronologici indicati dai vigenti programmi Verifica – valutazione Per le prove scritte si è scelta di preferenza, soprattutto nel secondo quadrimestre, la struttura della III prova, per la traduzione e/o l’ analisi di un testo di un autore conosciuto. Le prove orali si sono svolte in preferenza a partire dalla traduzione e dal commento dei testi di Seneca e Lucrezio ( si veda la tabella seguente). Strumenti utilizzati per la verifica: tipologia Tipologia prove scritte prove orali La tipologia prevista dall’esame di stato (3° PROVA) Traduzione Traduzione con domande di comprensione e / o di osservazione morfosintattica Commento di un testo noto o di cui è noto l’autore Tipologia Interrogazione breve (interventi) Interrogazione lunga Test / questionari Questionari Tipologia Quesiti a risposta singola (con n° di righe indicato) Quesiti a risposta multipla Quesiti a tipologia mista Lavori assegnati per casa Esercizi di traduzione dal latino 13 IV. 3 INGLESE Docente: Prof.ssa M. Luisa Cambiaso Metodologia Il programma è stato svolto utilizzando un approccio integrato, che ha privilegiato l’aspetto comunicativo ed il confronto con i testi letti, senza trascurare un talora necessario consolidamento linguistico. Le lezioni sono state in parte frontali ma spesso partecipate, con sollecitazione di interventi individuali o di gruppo. E’ stata necessaria una scelta degli autori più rappresentativi dei vari periodi esaminati e si è talora partiti da avvenimenti salienti della biografia, considerando la loro influenza sulla formazione e sulla produzione letteraria; talora, invece, si è partiti direttamente dai testi, per coglierne le caratteristiche ed i contenuti principali. Sono stati presi in considerazione lo sviluppo del romanzo e del teatro nell’Età Vittoriana e l’evoluzione dei tre generi letterari (romanzo, teatro e poesia) nel Novecento, offrendo anche un quadro sintetico del panorama storico culturale e utilizzando spesso risorse multimediali. Modalità di verifica e strumenti di valutazione Le interrogazioni orali sono state generalmente di media lunghezza e si sono svolte con domande sulle tematiche affrontate dai vari autori, sulle caratteristiche generali dei movimenti esaminati e sui testi letti, senza chiederne la traduzione puntuale. Sono state svolte anche prove di listening comprehension. Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia concordata nel coordinamento disciplinare. Si precisa che essa si differenzia dalla griglia proposta per la correzione delle altre materie della Terza Prova solo relativamente al peso attribuito agli indicatori, che sono comunque gli stessi. Il coordinamento di Lingue Straniere ha, infatti, deciso di attribuire maggiore punteggio alla valutazione degli aspetti linguistici e morfosintattici. Valutazione degli obiettivi raggiunti Il livello di partenza della classe era mediamente discreto: molto buono in alcuni casi ma con difficoltà espressive, soprattutto per quanto riguarda la correttezza formale, in altri. Ho cercato di motivare e coinvolgere attivamente tutti gli studenti ed il clima è stato generalmente positivo. Parte della classe ha seguito con attenzione e si è impegnata con continuità, raggiungendo risultati diversificati - dal sufficiente all'eccellente - ma comunque positivi; alcuni studenti, però, hanno lavorato in modo discontinuo, riuscendo a realizzare solo parzialmente i progressi possibili. 14 IV .4 STORIA Docente: Prof.ssa Silvana Marchetti Obiettivi Didattici Conformemente a quanto stabilito dal P.o.f., e come integrato e specificato dalla programmazione del dipartimento disciplinare, sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: acquisire la conoscenza dei fatti storici rilevanti affrontare le tematiche storiche anche attraverso l’interpretazione di testi e documenti riconoscere le problematiche entro le quali i fatti acquistano significato in relazione alla storia di breve e lungo periodo comprendere il passato al fine di comprendere il presente così più puntualmente declinati per la classe quinta: acquisizione approfondita e ricostruzione critica degli avvenimenti di un periodo anche attraverso l’uso di testi e documenti storici contestualizzazione delle tematiche affrontate evidenziando i possibili collegamenti inter o pluridisciplinari maturazione di una solida coscienza critica e civile. Criteri di valutazione Prevalentemente si è fatto ricorso ad interrogazioni orali che avessero la natura di ampio colloquio, effettuate nella modalità dell’interferenza logica e verbale, così da indurre gli studenti a problematizzare, motivando e approfondendo il loro discorso; solo sporadicamente sono state utilizzate prove scritte, nella tipologia delle domande a risposta aperta. Si è fatta propria la tabella di valutazione elaborata dal coordinamento disciplinare Parametri considerati Comprensione della domanda Informazione sugli elementi proposti Correttezza espressiva e uso di un lessico adeguato Coerenza logica Rielaborazione e capacità di collegamento Livelli della scala decimale Assolutamente insufficiente (1-3): conoscenza pressoché nulla dei contenuti culturali, totale incoerenza logica, scarsissima capacità d’uso del mezzo espressivo; rifiuto della prova. Gravemente insufficiente (4): vasta ignoranza dei contenuti culturali, spiccate difficoltà espressive, disorganicità nell’esposizione, fraintendimento delle domande. Insufficiente (5): Lacunosa conoscenza dei contenuti culturali, modesta capacità d’uso del mezzo espressivo, modesta organicità nell’esposizione, coerenza logica approssimativa. Sufficiente (6): Conoscenza dei principali contenuti culturali, uso sostanzialmente corretto del mezzo espressivo, argomentazione semplice e chiara. Discreto (7) conoscenza dei contenuti adeguata a sostenere l’argomento, uso corretto del mezzo espressivo, incisiva organicità nell’esposizione, sicura coerenza logica, valide capacità di collegamento. 15 Buono (8): ampia conoscenza dei contenuti culturali, brillante capacità d’uso del mezzo espressivo, incisiva organicità nell’esposizione, sicura coerenza logica, valide capacità di collegamento. Ottimo ed eccellente (9-10): ricca conoscenza dei contenuti culturali, brillante capacità d’uso del mezzo espressivo, piena organicità nell’esposizione, spiccate attitudini alla rielaborazione critica, sicura autonomia di studio. Metodologia e valutazione degli obiettivi raggiunti Pur non perdendo di vista il fatto che la storia è imprescindibilmente anche narrazione, si è cercato di condurre gli studenti alla consapevolezza che l’azione umana nel tempo è un insieme complesso, di articolato spessore, che risulta dal sommarsi e dall’intercettarsi di elementi di diversa natura. Pertanto, pur conferendo al programma un taglio prevalentemente politico, con riguardo alle Istituzioni e alla logica strategica, non si è trascurata l’analisi delle strutture socio-economiche e del loro interagire con le forme della politica in vigore. In particolare, per quanto concerne i contenuti, come risulta dal programma allegato, la trattazione ha risentito di una certa asimmetria orizzontale, nel senso che, pur rifuggendo da ogni sorta di eurocentrismo, si è comunque privilegiato l’esame delle vicende europee e il loro progressivo dilatarsi a dimensioni globali. Si è operata tale scelta eminentemente per due motivi: uno di ordine economico (la struttura modulare dell’orario curricolare di quest’anno è stata di per sé inadeguata alla vastità del programma da svolgere e, per di più, per differenti motivi, si sono perse molte lezioni, pari a circa tre settimane di scuola), l’altro, più ampiamente culturale, fondato sulla considerazione storica della assimilazione di diverse aree del mondo, per estensione dei modelli politico-istituzionali ed economico-sociali europei. Con l’intento di sviluppare una certa attitudine critica, si è cercato di conferire problematicità alla presentazione dei contenuti ed inoltre si è utilizzato un approccio inizialmente analitico e poi sintetico, allorchè la completa conoscenza del fenomeno in esame consentisse una contestualizzazione organica ed articolata. Pur nel cambiamento di insegnante nel passaggio dalla terza alla quarta, di fronte a tale proposta didattica la classe ha espresso un atteggiamento di interesse nei confronti della Storia, durante i momenti delle spiegazioni, tuttavia, a fronte di ciò, molti degli studenti non hanno fatto corrispondere un diligente, sistematico impegno nello studio domestico e pertanto non hanno conseguito un corretto metodo di studio né rigore espositivo e neppure hanno acquisito strumenti per una corretta autovalutazione. Il complessivo conseguimento degli obiettivi risulta pertanto piuttosto diversificato, da un livello di stretta sufficienza ad un livello decisamente buono. Nell’attività didattica si è privilegiata la lezione frontale, e, in sede sia di spiegazione sia di interrogazione, pur senza esasperare il valore della “data per la data”, si è insistito sul fatto che “la cronologia è l’occhio della Istoria” (C. Cattaneo) e che non la si può trascurare, se si vuol conservare la specifica consequenzialità della prospettiva storica. Il testo in adozione (A. DE BERNARDI-S. GUARRACINO, “EPOCHE”. EDIZIONE BLU. vol.3, Milano, 2013)) non è stato di valido supporto per il lavoro didattico e perciò è stato usato limitatamente dagli studenti, in modo integrato con gli appunti presi durante le lezioni in classe. 16 IV. 5. FILOSOFIA Docente: Prof.ssa Silvana Marchetti Obiettivi Didattici Conformemente a quanto stabilito dal P.o.f., e come integrato e specificato dalla programmazione del dipartimento disciplinare, sono stai individuati i seguenti obiettivi generali: ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei filosofi studiati con ordine e rigore logico presentare la filosofia come disciplina non nozionistica, né esclusivamente storicistica, ma formativa, in quanto capace di educare alla problematicità e al dialogo analizzare, anche attraverso i testi, i mutamenti avvenuti nei sistemi filosofici e comprenderne le ragioni rilevare la grande influenza che il sapere filosofico, nei diversi ambiti, ha avuto sullo sviluppo della civiltà e della storia con opportuni collegamenti inter e pluridisciplinari così più puntualmente declinati per la classe quinta: acquisizione della conoscenza dei principali filosofi studiati con un’opportuna padronanza di linguaggio, anche attraverso l’uso di testi valutazione critica del pensiero dei maggiori filosofi istituzione di collegamenti inter e pluridisciplinari. Criteri di valutazione Nel corso del triennio si sono prevalentemente utilizzate interrogazioni orali che, al fine di potenziarne la valenza formativa, sono state effettuate nella modalità dell’interferenza logica e verbale, così da indurre gli studenti a motivare o ad approfondire o a rivedere il loro discorso. Solo eccezionalmente si sono somministrate prove scritte, nella tipologia delle domande a risposta aperta. Si è fatta propria la tabella di valutazione elaborata dal coordinamento disciplinare. Parametri considerati Comprensione della domanda Informazione sugli elementi proposti Correttezza espressiva e uso di un lessico adeguato Coerenza logica Rielaborazione e capacità di collegamento Livelli della scala decimale Assolutamente insufficiente (1-3): conoscenza pressoché nulla dei contenuti culturali, totale incoerenza logica, scarsissima capacità d’uso del mezzo espressivo; rifiuto della prova. Gravemente insufficiente (4): vasta ignoranza dei contenuti culturali, spiccate difficoltà espressive, disorganicità nell’esposizione, fraintendimento delle domande. Insufficiente (5): Lacunosa conoscenza dei contenuti culturali, modesta capacità d’uso del mezzo espressivo, modesta organicità nell’esposizione, coerenza logica approssimativa. Sufficiente (6): Conoscenza dei principali contenuti culturali, uso sostanzialmente corretto del mezzo espressivo, argomentazione semplice e chiara. Discreto (7) conoscenza dei contenuti adeguata a sostenere l’argomento, uso corretto del mezzo espressivo, incisiva organicità nell’esposizione, sicura coerenza logica, valide capacità di collegamento. 17 Buono (8): ampia conoscenza dei contenuti culturali, brillante capacità d’uso del mezzo espressivo, incisiva organicità nell’esposizione, sicura coerenza logica, valide capacità di collegamento. Ottimo ed eccellente (9-10): ricca conoscenza dei contenuti culturali, brillante capacità d’uso del mezzo espressivo, piena organicità nell’esposizione, spiccate attitudini alla rielaborazione critica, sicura autonomia di studio Metodologia e valutazione degli obiettivi raggiunti Il taglio eminentemente teoretico che è stato dato allo svolgimento del programma risponde agli obiettivi didattici e ad esigenze formative: una riduzione del livello speculativo, infatti, non avrebbe fornito alla classe alcun contributo intellettuale, né favorito un approccio problematico alla materia, né consentito di realizzare gli obiettivi prefigurati nella programmazione annuale. La consapevolezza della connessione strutturale fra i contenuti filosofici e la loro specifica espressione linguistica, fra un uso corretto del lessico e la determinazione delle categorie concettuali, la conquista di una coscienza critica, nell’assunzione di un atteggiamento problematico e rigoroso, comunque disponibile all’apprendimento ed all’autoverifica, sono gli obiettivi a cui il lavoro scolastico si è indirizzato; l’impostazione speculativa, pertanto, è risultata funzionale a tutto ciò. Gli studenti, fin dalla terza, hanno palesato interesse per la Filosofia come disciplina del pensiero, partecipando alle lezioni con attenzione collaborativa e, in genere, hanno fatto corrispondere alla curiosità intellettuale un impegno coerente nello studio; in tal modo è stato progressivamente acquisito, anche da parte degli alunni con più debole attitudine critica, un metodo d’indagine sempre più sicuro. Il profitto, piuttosto diversificato, si colloca comunque su un livello medio più che sufficiente, . Il manuale in adozione (N. ABBAGNANO-G.FORNERO “Itinerari di filosofia”, vol 3A-3B, Paravia, 2011) e gli appunti presi dagli studenti durante le lezioni in classe sono stati usati in modo integrato. 18 IV. 6 MATEMATICA Docente: Prof.ssa Lucia Dagnino Metodologia Nel presentare i vari argomenti si è cercato di evitare un'impostazione mnemonico-ripetitiva e tentato di favorire un atteggiamento critico e attivo negli allievi, spingendoli ad usare le loro capacità intuitive, sia durante la dimostrazione dei principali teoremi di analisi, probabilità e geometria analitica dello spazio, sia nell’affrontare nuove situazioni problematiche. Nello svolgere gli esercizi si sono indirizzati gli alunni a cercare più metodologie e a scegliere la più conveniente, oltre che a valutare criticamente i risultati ottenuti. Modalita’ Di Verifica E Strumenti Di Valutazione Le prove scritte sono state quasi tutte strutturate secondo la tipologia della seconda prova, ma, visto che il tempo a disposizione non ha mai superato le due ore, sono stati proposti problemi con solo due/tre domande e si è richiesta la risoluzione di tre quesiti. Il punteggio è stato così diviso: 50% al problema e 50% ai quesiti. Alla riconsegna delle prove, oltre che la correzione, si è anche fatta un’analisi del loro andamento statistico e un confronto con i risultati di quelle precedenti. Nel secondo quadrimestre si è effettuata una simulazione di II prova della durata di cinque ore e trenta ed è stata usata la griglia di valutazione allegata Le prove orali si sono basate su interrogazioni in cui si è richiesta la risoluzione di problemi ed esercizi e la spiegazione dei metodi risolutivi adottati, oltre che la formulazione corretta e puntuale dei teoremi applicati e del loro significato geometrico o probabilistico nei casi di particolare rilevanza. Valutazione Degli Obiettivi Raggiunti I risultati finali sono differenziati. Gli obbiettivi sono stati mediamente raggiunti e comunque sempre in base al percorso di crescita e all’ impegno dei singoli studenti. Alcuni di essi infatti hanno faticato ad apprendere i contenuti del quinto anno, sia per un impegno discontinuo, sia per un metodo di studio non sempre adeguato al livello di apprendimento richiesto. . 19 IV. 7 FISICA Docente: Prof. Fabio Valeri Obiettivi Conoscere le leggi fondamentali dell'elettrostatica, del magnetismo e del legame tra i due. Conoscere la sintesi dell'elettromagnetismo insita nelle equazioni di Maxwell. Saper affrontare semplici problemi riguardanti l'elettricità ed il magnetismo. Acquisire la nozione di onda elettromagnetica e la propagazione delle onde come conseguenza delle equazioni di Maxwell. La velocità della luce ed il principio di relatività galiliano. Conoscere i fondamenti della teoria della relatività einsteniana. Modalità di lavoro L'impostazione didattica generale si è basata principalmente sulla lezione frontale. E' stata data importanza agli esercizi, sopratutto nella parte iniziale riguardante il'elettrostatica, mentre sulla seconda parte (magnetismo,induzione) è stato privilegiato l'aspetto teorico e concettuale. La classe è stata portata in laboratorio per assistere ad esperienze didattiche riguardanti il magnetismo e il fenomeno di induzione elettromagnetica. Le valutazioni sono state ottenute mediante prove scritte con esercizi e domande teoriche ( una per quadrimestre) sugli argomenti via via svolti ed un'interrogazione orale per ogni studente. Obiettivi raggiunti Una parte (60% circa) della classe ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti o buoni mentre la restante parte della classe non è riuscita a far propri i contenuti di parte del programma in maniera del tutto adeguata. 20 IV .8 SCIENZE Docente: Prof.ssa Paola Maria Arecco Metodologia-Modalità di verifica e strumenti di valutazione- Valutazione degli obiettivi raggiunti Svolgimento del programma A partire dal corrente anno scolastico 2014-2015, i programmi di scienze della classe quinta risultano profondamente modificati e comprendono argomenti inerenti a differenti discipline, quali la genetica classica e quella moderna, le biotecnologie, la chimica organica, la biochimica e le scienze della Terra ( tettonica delle placche). Si è cercato, per quanto fosse possibile, di individuare collegamenti e richiami tra i diversi temi e di fare spesso riferimento a quanto studiato negli anni precedenti. Il lavoro didattico ( 3 moduli settimanali) si è svolto con lezioni tradizionali, supportate da proiezioni di slides o video e sempre con la partecipazione attiva degli studenti. Modalità di verifica e strumenti di valutazione Interrogazioni e verifiche scritte (rif. simulazioni ) con quesiti a risposta aperta di lunghezza predeterminata. Si registrano per ogni studente , in media 3 valutazioni al Quadrimestre. La valutazione delle singole prove si è basata sulle griglie comuni, ma la valutazione finale tiene necessariamente in considerazione l’impegno dimostrato, la costanza nello studio , l’interesse e la partecipazione alle lezioni. Valutazione degli obiettivi raggiunti Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli studenti, con percorsi e risultati differenziati. La preparazione conseguita dagli studenti varia da sufficiente a ottima. 21 IV. 9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Docente: Prof. Mario Caraffini Metodologia La metodologia didattica utilizzata, tramite un numero rilevante di lezioni frontali sulla base della sequenza cronologica dei periodi culturali e dei moduli tematici, ha cercato di facilitare la comprensione, l'apprendimento e la sistemazione logica delle conoscenze da parte degli studenti per permettere loro di rielaborare gradualmente quanto appreso in modo personale. Metodi: metodo deduttivo, lavoro individuale, ricerca, relazioni. Strumenti: lezioni frontali, libri di testo e altri libri e riviste specifici della materia, visione di immagini e di film e uso di sistemi informatici. Modalità di verifica e strumenti di valutazione La valutazione è stata effettuata tramite una serie di prove di verifica, sia orali (colloqui/discussioni sia individuali che collettive) sia scritte/pratiche (brevi relazioni su temi specifici, schede di lettura di opere d’arte, ricerche personali). Parametri di valutazione delle prove: - utilizzo di linguaggio specifico appropriato e capacità di espressione; - saper riconoscere e descrivere un’opera d’arte collocandola nel giusto contesto; - saper trovare collegamenti e reticoli anche interdisciplinari. Durante l’anno scolastico sono state eseguite lezioni di ripasso generali o su temi specifici, tali da operare un continuo recupero in itinere. Criteri per la verifica dell’apprendimento: La valutazione è stata intesa secondo una prospettiva di coerenza e continuità e quale controllo sistematico dei processi di apprendimento e di sviluppo personale nel loro divenire per l’individualizzazione degli interventi, compensativi e di potenziamento atti a favorire il perseguimento degli obiettivi. Valutazione degli obiettivi raggiunti Il programma di “Storia dell’Arte” è stato svolto in modo regolare e senza particolari problemi in quanto la classe ha dimostrato un comportamento corretto e partecipativo ed un buon impegno ed interesse all’apprendimento. La classe ha acquisito altresì, durante l’anno scolastico, una sempre maggiore sicurezza nell’utilizzo del lessico specifico di materia e nella rielaborazione personale. Le conoscenze e competenze acquisite dagli alunni al termine del presente anno scolastico hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati in base alla seguente classificazione: - livello ottimo, per il 10% degli alunni che dimostrano una buona capacità di organizzare ed elaborare autonomamente le conoscenze, individuando relazioni tra le varie epoche e discipline con l’utilizzo di un linguaggio specifico appropriato; - livello buono, per il 20% degli alunni che dimostrano di saper leggere un’opera d’arte attraverso una buona esposizione ed un’adeguata terminologia specifica, rintracciando i nessi fondamentali tra le varie discipline artistiche; - livello più che sufficiente, per il 50% degli alunni che dimostrano di conoscere i maggiori artisti ed i relativi percorsi stilistici attraverso l’analisi delle opere più significative ma con poca capacità di elaborazione personale e utilizzando un linguaggio specifico non sempre sintetico ed adeguato; - livello sufficiente per il 20%degli alunni che dimostrano di conoscere solo superficialmente i maggiori artisti ed i relativi percorsi stilistici con poca capacità di elaborazione personale e utilizzando un linguaggio specifico poco appropriato. Durante i due quadrimestri gli alunni sono stati impegnati in un lavoro grafico e di ricerca su argomenti di architettura e urbanistica. La maggioranza della classe ha dimostrato un buon impegno che ha permesso di ottenere risultati soddisfacenti. 22 IV. 10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Prof.ssa Daniela Poggi Metodologie didattiche Per quanto concerne il momento didattico, sono stati utilizzati, a seconda delle esigenze, il metodo globale e quello analitico ,per arrivare ad un affinamento delle capacità coordinative ad un miglioramento delle capacità condizionali e all'acquisizione delle capacità operative e sportive. Utilizzando attività di gruppo misto (maschi femmine),piccoli gruppi di lavoro,lavoro specifico per singolo. Spesso certe unità didattiche sono trasversali a varie discipline (ad esempio il cambio di direzione e di mano, la visione periferica, il riscaldamento e l’allungamento per tutti i giochi sportivi) È stato l’alunno a costruirsi un’esperienza motoria personale partendo dal dato iniziale. L’esperienza che si intende offrire è quella di sperimentare, sentire, prendere atto, interiorizzare e memorizzare a livello ideomotorio e di ripetere nella giusta situazione movimenti precisi. Questa metodologia si rende necessaria per l’acquisizione di gesti motori specifici e tecnici in cui è utile la loro ripetizione fino al raggiungimento dell’automatismo desiderato. In tappe motorie più elastiche gli allievi, messi in situazione-stimolo, rielaborano personalmente i contenuti appresi per raggiungere l’obiettivo desiderato per prove ed errori; qui possono essere esaltate le personalizzazioni e la creatività del singolo. Si è cercato sempre di fornire una sintetica spiegazione tecnica e fisiologica degli esercizi, per rendere gli allievi consapevoli del movimento, per fare loro “percepire” la parte del corpo interessata, per abituarli ad ascoltare il proprio corpo stimolando la presa di coscienza e migliorando la consapevolezza per prevenire infortuni. Il tutto nello sviluppo della socializzazione,del rispetto delle regole,dei ruoli e delle consegne ricevute. Modalità di verifica e strumenti di valutazione E’ stata utilizzata l’osservazione sistematica dei processi d’apprendimento e momenti di controllo durante lo svolgimento delle lezioni, tramite vari procedimenti di osservazione e di verifica (percorsi, progressioni, circuiti a stazioni, numero palleggi , numeri tiri, gare a tempo, rilevazione tempo di esecuzione, ecc.).Il livello di partenza, inteso come soglia iniziale della conoscenza e delle capacità possedute dall’allievo, è stato rilevato dall’osservazione sistematica degli studenti. E’ stata positivamente valutata ogni evoluzione a partire dai livelli di partenza e non in riferimento a rendimenti oggettivi legati alle massime prestazioni. Nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse, della partecipazione alle attività proposte, della capacità di concentrazione, dell'autocontrollo, del comportamento e della adeguata maturità degli allievi nelle attività, nel gioco di squadra ed individuale. Si considerano inoltre l'impegno e lo sforzo effettuato da ogni alunno per il miglioramento delle proprie capacità psicofisiche. Numero di verifiche previsto per ogni periodo : minimo due. 23 IV . 11 RELIGIONE Docente: Prof.ssa Adelina Palestini Metodologia Dopo una prima analisi, opportunamente documentata,degli argomenti trattati ,è stato sollecitato un confronto critico fra gli alunni. In tal modo, il dialogo educativo ha condotto all’analisi ed all’interpretazione delle tematiche proposte. Modalità di verifica e strumenti di valutazione La valutazione ha tenuto presente la conoscenza dei contenuti, l’interesse, la disponibilità all’ascolto,al confronto, al dialogo e la capacità di rielaborazione personale. Obiettivi raggiunti L’irc ha inteso illustrare il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale. L’itinerario didattico è stato finalizzato a portare gli alunni: - ad affrontare le problematiche sociali e morali del nostro tempo tenendo conto della prospettiva antropologica e teologica cristiana - alla capacità di confronto culturale - a discutere in modo corretto sostenendo le proprie idee ascoltando quelle degli altri - ad individuare il problema dell’etica come orientamento della propria vita rispetto a valori ri conosciuti - a comprendere e a rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 24 V ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi eventi, spettacoli e manifestazioni. In particolare nell’ultimo anno, nel corso di uscite di classe o di eventi organizzati presso l’istituto e rivolti agli alunni di tutte le quinte, la classe è stata coinvolta nelle seguenti iniziative: spettacolo teatrale in lingua inglese “The Importance of Being Earnest” mostra a Palazzo Ducale “Van Gogh e il viaggio di Gauguin” commemorazione del Giorno della Memoria con l’intervento di G. Salmoni commemorazione del Giorno del Ricordo con l’intervento di A. Tacchella. commemorazione del 25 Aprile con l’intervento di P. Battifora. Nel triennio visita al patrimonio storico artistico del centro storico di Genova. Visita alla Fondazione Piano. Visione alla Sala Sivori della proiezione del film Turner, di Mike Leigh. Visione alla Sala Sivori della proiezione del film Il giovane favoloso, di M. Martone. Visita alla mostra Espressionismo tedesco 1905-1913 da Kirchner a Nolde a Palazzo Ducale di Genova. Diversi alunni hanno preso parte anche alle Olimpiadi di Matematica, Fisica e di Scienze. Alcuni hanno partecipato a GeMUN (Simulazione dell’ Assemblea delle Nazioni Unite, a Genova) e uno al PaMUN (a Parigi). Inoltre alcuni studenti hanno partecipato ad un concorso interno al Liceo su abilità argomentative. VI SIMULAZIONI Nel corso dell’anno sono state programmate due simulazioni della terza prova scritta, nelle date 5 marzo e 8 maggio. La simulazione di prima e seconda prova si sono tenute rispettivamente il 4 e il 6 maggio. Per le simulazioni di Italiano e Matematica le prove proposte sono state concordate uguali per tutte le classi, mentre per la simulazione di terza prova le materie coinvolte sono state scelte da ciascun Consiglio di Classe. . SIMULAZIONI DI TERZA PROVA La tipologia proposta nelle simulazioni di terza prova è stata definita dal Consiglio di Classe. Si tratta della tipologia B, ovvero quesiti a risposta singola (due per materia per cinque materie), con risposte di lunghezza massima di dodici righe da elaborare nello spazio di tre ore. Tale tipologia è stata comunque già ripetutamente proposta e verificata in corso d’anno e pare meglio corrispondere alle abitudini scolastiche degli alunni. La correzione delle prove delle singole discipline è realizzata individualmente dai docenti delle materie interessate, mentre per la valutazione globale in quindicesimi si procede in maniera collegiale. DATA 5 marzo 2015 8 maggio 2015 MATERIE Inglese – fisica – scienze – filosofia - latino Inglese – fisica – scienze - storia dell’arte - storia Il Consiglio di classe ha deciso di escludere dalla simulazione della terza prova scritta sia Italiano sia Matematica, in considerazione del fatto che le due discipline sono già coinvolte rispettivamente nella prima prova scritta e nella prova scritta di indirizzo; inoltre, conformemente a quanto deciso all’interno dei singoli Coordinamenti, non si sono somministrate prove di traduzione relativamente al Latino e alla Lingua straniera. Per i testi delle prove si rimanda all’Allegato N° 2. 25 VII ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLATICO Per l’assegnazione del credito scolastico il Consiglio di classe si è attenuto ai criteri indicati al riguardo da Piano dell’offerta formativa del Liceo che si riporta di seguito in estratto” CREDITO SCOLASTICO” CREDITO SCOLASTICO Il credito scolastico è il punteggio assegnato ad ogni studente di anno in anno nel triennio e che entra a far parte del computo per l’assegnazione del voto all’esame di Stato. Il credito è costituito, nell’ambito delle bande di oscillazione indicate da una tabella ministeriale, dalla media delle votazioni (M) dello scrutinio finale + una serie di altre voci che concorrono insieme all’aggiunta di 1 punto quali: assiduità nella frequenza, interesse e disponibilità al dialogo educativo, partecipazione ad attività integrative e complementari organizzate dalla scuola, eventuali crediti formativi. CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE M=6 6< M =7 7< M =8 8< M =9 9< M =10 M=6 6< M =7 7< M =8 8< M =9 9< M =10 M=6 6<M=7 7<M=8 8<M=9 9< M =10 Punti 3-4 Punti 4-5 Punti 5-6 Punti 6-7 Punti 7-8 Punti 3-4 Punti 4-5 Punti 5-6 Punti 6-7 Punti 7-8 Punti 4-5 Punti 5-6 Punti 6-7 Punti 7-8 Punti 8-9 Tabella 21-1: Tabella ministeriale dei punteggi del credito scolastico Il punto aggiuntivo nella banda di oscillazione viene assegnato in base ai seguenti criteri. Liceo Scientifico "G.D. CASSINI" A.S. 2014-2015 20 1) gli studenti cui, nello scrutinio finale, venga attribuita una sufficienza con voto di Consiglio accedono direttamente al punteggio inferiore di fascia, 2) gli studenti, che non rientrano nelle condizioni del punto precedente, con media pari o superiore al sette nei voti deliberati accedono direttamente al punteggio superiore di fascia. 3) Per gli altri studenti si riconoscono questi punteggi alle voci indicate: Media: al punteggio iniziale dell’intervallo di competenza si sommano tanti decimi quanti quelli eccedenti gli interi della media dei voti deliberati Partecipazione Partecipazione ad Organi Collegiali p.ti 0,1 l’uno Attività della scuola (salone OrientaMenti, porte aperte, redazione giornalino) p.ti 0,1 l’una Frequenza senza demerito di corsi extracurricolari e di attività di gruppo sportivo p.ti 0,1 l'uno (massimo 0,3) Frequenza del corso Progettazione architettonica p.ti 0,2 Conferenze organizzate dalla scuola p.ti 0,1 l’una Collaborazione a incontri organizzati dalla scuola p.ti 0,1 Superamento della fase di Istituto di Olimpiadi o concorsi p.ti 0,1 l’uno Partecipazione al progetto GeMun p.ti 0,1. 26 CREDITO FORMATIVO Attività sportive a livello agonistico a livello almeno provinciale p.ti 0,1 in tutto Corsi di lingua all’estero di almeno 2 settimane senza conseguimento di certificazioni p.ti 0,1 per corso; Conseguimento di certificazioni internazionali di lingua straniera p.ti 0,2 per ogni certificazione; Conseguimento completo ECDL p.ti 0,1 Volontariato sociale con certificazione dell’impegno p.ti 0,1 in tutto Cicli di almeno 3 conferenze p.ti 0,1 in tutto partecipazione di almeno 6 ore a stage universitari o formativi con orario extracurriculare p.ti 0,1 Frequenza del Conservatorio musicale p.ti 0,5 Partecipazione al coro del “Carlo Felice” p.ti 0,1. Nota: Il credito formativo è determinato da attività extrascolastiche (corsi extracurricolari / esperienze individuate dal D.M. n. 49 come studi all’estero, certificazioni linguistiche, volontariato sociale, attività sportiva a livello almeno regionale) che vengono valutate sulla base delle indicazioni espresse dal comitato tecnico scientifico del liceo. Nel caso di non promozione non si ha diritto ad alcun credito scolastico. 27 VIII INDICE ALLEGATI Al presente documento del Consiglio di classe si allegano: I programmi dettagliati delle singole discipline (Allegato N°1 ) I modelli delle simulazioni della terza prova scritta d'esame (Allegato N°2 ) Le griglie adottate per la correzione delle simulazioni delle tre prove scritte (Allegato N°3 ) 28 IX IL CONSIGLIO DI CLASSE Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di classe. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5^ B Prof.ssa Claudia Ghione Prof.ssa M. Luisa Cambiaso Prof.ssa Silvana Marchetti (Italiano e Latino) (Inglese) (Storia e Filosofia) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prof.ssa Lucia Dagnino (Matematica) ------------------------------------------------------- Prof. Fabio Valeri (Fisica) ------------------------------------------------------- Prof.ssa M. Paola Arecco (Scienze) ------------------------------------------------------- Prof. Mario Caraffini (Disegno e Storia dell’Arte) -------------------------------------------------------- Prof.ssa Daniela Poggi (Scienze Motorie e sp.) ------------------------------------------------------- Prof.ssa Adelina Palestini (Religione Cattolica) ------------------------------------------------------- Il Dirigente prof.ssa Daniela Cambiaso ------------------------------------------------------- Genova, 8 maggio 2015 29
Scarica