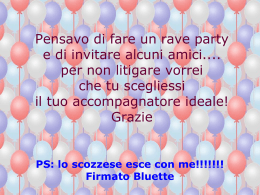Anno 6 - Numero 2 R i v i s t a d i C u l t u r a S t o r i a e Tr a d i z i o n i Aprile - Giugno 2010 Sommario In copertina Editoriale Acquarello e tecnica mista su cartoncino Don Giovanni Zorzoli (2010) Così si rideva duemila anni fa Al centro: Gioacchino Rossini. Dall’alto, in senso orario: Garcìa Lorca, Trilussa, Moliére, Leibniz, Lorenzo il Magnifico, Totò, Ariosto, Stendhal. Lo humour del caro estinto Secoli di barzellette Ironia, divertimento e satira sociale nella poesia di Porta Il Carnevale nel tempo Quando la risata era una faccenda “artigianale” La gioia è il principio della vita Fermare il tempo Le tre damine, frate Cesco e il vescovo Allegria, signor Mike! XLIV Premio Nazionale di Poesia “Città di Mortara” Il sorriso di un bimbo Il sorriso di un bimbo salva il tempo perduto, i ricordi svaniti di tutto quello che ho dimenticato. Nel sorriso, bisbigliano gli anni della gioventù. Nelle labbra spuntano parole così dolcemente note e tanto lontane. Nella mente si scioglie una nuvola, il passato immancabilmente ritorna, sottobraccio alla mia desolazione. da “Riflessi”, Giancarlo Costa (marzo 2009) 3 di Umberto De Agostino 4 di Nadia Farinelli 6 di Graziella Bazzan 8 di Maria Forni 11 di Eufemia Marchis Magliano 15 di Stefano Sedino 17 di Alessandro Marangoni 19 di Simone Menicacci 20 di Luigi Balocchi 22 di Sandro Passi 24 26 EDITORIALE La cultura dell’umorismo e del divertimento Alla fine non ci resta che ridere di Marta Costa Nel linguaggio quotidiano capita non di rado, per un singolare gioco di sinonimia, di sovrapporre la nozione di “serietà” con quella di “importanza”. Lecitando di fatto l’insorgere di un paradosso. In effetti, passando al setaccio gli atteggiamenti emotivi e ricercando tra di essi la spia dell’ottimismo, dell’energia, della salute spirituale e del pieno compiacimento esistenziale, si approda alla conclusione che questa dev’essere per forza una sana risata. Quindi ridere è una faccenda serissima. Lo riconoscono anche medici e psicologi, che assegnano al buon umore un valore terapeutico, in alcuni casi quasi taumaturgico, miracoloso. Non per niente l’esperienza del comico ha permeato la cultura artistico-letteraria, elevazione dell’animo umano e delle relative aspirazioni, fin dai suoi remotissimi albori. Ad esempio nel mondo latino le diverse forme di umorismo, come spiega Umberto De Agostino nelle pagine a seguire, ispirarono fior di poeti e letterati, come Plauto, Terenzio, Marziale. Le sfaccettature del “ridiculum” trovano nella letteratura classica un crescendo di impieghi, che va dalle licenziose trasposizioni del sarcasmo popolare (spesso beffardo e denigratorio) fino alle raffinatezze del paludato Ovidio. Strettamente correlato a questo argomento è il Carnevale, discendente di antiche usanze pagane, quali i Baccanali, i Saturnali e i Luperali. Con l’avvento del Cristianesimo, tratti caratteristici degli antichi cicli di festività vennero depurati delle originarie sfrenatezze e gradualmente assimilati dalle celebrazioni carnevalesche. Lo racconta esaustivamente, ripercorrendo la parabola storica che congiunge l’età dei Romani ai giorni nostri, Eufemia Marchis Magliano nel servizio a sua firma. Il Vaglio vira poi nella direzione dell’icastica satira sociale di Carlo Porta, poeta dialettale per eccellenza e cantore della Milano a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento. Nella voce a lui dedicata da Dante Isella nella Storia della Letteratura Italiana si legge: “È manifesto che la eccezionale personalità portiana ha finito con lo schiacciare sotto di sé, degradandolo a un ruolo più o meno passivo, di allievo o imitatore, chi, dietro il suo esempio, [...], si è messo per la strada dello scrivere versi in milanese”. La forza dei suoi versi, traboccanti sferzanti critiche alle classi dominanti, all’ipocrisia, alla falsa religiosità e al cinismo dei potenti, emerge a chiare lettere nel puntuale servizio confezionato da Maria Forni. La gioia e la sua stretta connessione all’arte della musica sono invece il tema eviscerato magistralmente da Alessandro Marangoni, un’autorità nel campo delle sette note. Il suo intervento mette in risalto l’influenza che la melodia esercita sugli stati d’animo, potente e incisivo veicolo di trasformazione dell’umore. La risata è vita, ma in alcune circostanze sconfina addirittura nel territorio della morte. La penna di Graziella Bazzan si è perciò soffermata sugli epitaffi divertenti, strampalati e insoliti sparsi per i quattro angoli del pianeta, presentati in una stuzzicante carrellata. In questo numero del trimestrale c’è materiale per ridere e sorridere. Buon divertimento. aprile - giugno 2010 3 & Cultura&& Mondo Classico Così si rideva duemila anni fa LA MORDACITÀ DEL MONDO ROMANO DALLE COMMEDIE DI PLAUTO AGLI EPIGRAMMI DI MARZIALE N di Umberto De Agostino essuno oserebbe affermare che imparare il latino sia divertente e che Giulio Cesare sia un autore prevalentemente umoristico. Se queste – assieme alle devote prediche di taluni insegnanti sulla gravitas e sulla dignitas dei Romani – rimangono le uniche e più pregnanti impressioni dell’antichità romana, non ci si deve meravigliare del perdurare del quadro tradizionale di Roma, in cui l’umorismo non ha posto alcuno. Il quotidiano dei Romani era tuttavia diverso e, tanto nella realtà quanto in letteratura e retorica, tutte le forme del ridiculum avevano un ruolo importante, di fronte al tribunale come davanti a un bicchiere di vino, alla mensa imperiale non meno che a teatro. La documentazione letteraria dell’umorismo romano è molto vasta. Basti pensare alle commedie di Plauto e Terenzio, alla poesia satirica (un autentico genere umoristico, “inventato” dai Romani), agli epigrammi di Marziale, allo spiritoso romanzo Satyricon di Petronio e all’umorismo raffinato e urbano per esempio di un Ovidio: buona parte della letteratura latina consiste di variazioni su questo tema e molta di essa è uno specchio dell’umorismo quotidiano. Alcuni epigrammi di Marziale costituiscono la forma linguisticamente condensata e raffinata del salace e aggressivo umorismo popolare, che non aveva rispetto per niente e per nessuno: sarcasmo e cattiverie prendevano di mira chiunque non corrispondesse alla norma consolidata. Le anomalie fisiche come strabismo, mancanza di denti, obesità, magrezza erano oggetto di mordacità, come le predilezioni e le stravaganze sessuali, e anche se il colto Quintiliano esorta a «non rinunciare a un Gli autori di epoca romana ci hanno consegnato molte opere umoristiche: buona parte della letteratura latina consiste di variazioni su questo tema 4 I L VA G L I O Plauto in un’illustrazione tratta dalle “Cronache di Norimberga” (1493) caro amico piuttosto che a un’osservazione salace», è probabile che molti la pensassero diversamente. Il quotidiano offriva numerose occasioni di scagliare dardi velenosi: banchetti con abbondanti libagioni, sempre conditi da umorismo di genere e livello variabilissimo; matrimoni accompagnati “umoristicamente” da scherzi salaci e osceni, i versus fescennini; i Saturnali, una specie di Carnevale romano in cui Mosaico romano del I secolo a.C. raffigurante le maschere della Tragedia e della Commedia (Roma, Musei Capitolini) umorismo, scherno e scempiaggini facevano da padroni. Anche i trionfi avevano spesso il carattere di festa popolare e, affinché il trionfatore non si elevasse troppo al di sopra dei comuni mortali, i soldati gli rammentavano la sua umanità con drastici scherzi. Anche gli eruditi, sebbene non fossero estranei all’umorismo salace-volgare (che tuttavia poteva assumere le sfumature brillanti di un Marziale), apprezzavano anche un umorismo più raffinato, di carattere aneddotico, che invitava non tanto alla risata quanto a un sorriso compiaciuto o alla gioia per il male altrui. Una caratteristica fondamentale di questo umorismo, in parte anche messo per iscritto, era la prontezza di parola. Nella formazione di un oratore non potevano mancare l’apprendimento di questo umorismo “classico” e l’affinamento delle capacità umoristiche personali: saper far ridere i giurati, al momento giusto, era considerato dall’antica retorica giuridica una caratteristica fondamentale del buon oratore. Alla fama di Cicerone, per esempio, contribuì non poco la sua prontezza di parola esibita nei tribunali come nei salotti. Eccone un assaggio, riportato da Quintiliano. Quando Fabio Dolabella affermò di avere trent’anni, Cicerone annuì dicendo: «È vero! Sono vent’anni che glielo sento dire». I Romani conoscevano sicuramente anche le barzellette, ma non ce ne sono pervenute. Dalle commedie di Plauto si evince che esistevano vere e proprie raccolte di barzellette scritte privatamente o addirittura sotto forma di libro; i parassiti che vogliono spacciarsi per ospiti divertenti ed essere così invitati a mangiare gratis ricorrono, quale ultima spes, anche a queste. «Bisogna che mi procuri un libro e impari a memoria le barzellette migliori», annuncia uno di costoro agli spettatori. Queste barzellette infioravano anche molti degli spettacoli tanto amati nel teatro imperiale, i cui copioni tuttavia non ci sono pervenuti probabilmente anche a causa della loro salacità. Il punto conclusivo della tradizione dei parassiti è costituita da quei “professionisti” che alcuni imperatori tenevano a palazzo come buffoni di corte o come spiritosi conversatori, a seconda dei casi. Un’unica raccolta di barzellette antiche è giunta sino a noi: quella redatta in lingua greca da Filogelo (letteralmente “amico del riso”). Essa nacque in età imperiale romana, ma fu redatta nella forma attuale solo nella tarda antichità. In massima parte si tratta di barzellette che prendono in giro gli abitanti delle “fortezze di pazzi” dell’antichità (soprattutto gli abitanti di Abdera, fiorente città della Tracia) o gli “Scholastikòi”: gente fuori dal mondo come se ne trova in tutte le professioni e fa ridere il prossimo con analogie taglienti quanto false. Le barzellette sugli Abderiti, menzionati anche da Cicerone perché proverbialmente stupidi, erano sicuramente in latino. Ecco due assaggi dalle 265 barzellette di Filogelo. «Uno Scholastikòs vide il suo medico e si nascose per non farsi vedere. Il suo compagno gli chiese perché lo facesse ed egli rispose: “È tanto tempo che non mi ammalo e mi vergogno”». «Un Abderita aveva cremato il padre defunto, come vuole l’usanza. Poi corse a casa, dalla madre malata, e le disse: «Mi è rimasta un po’ di legna. Se vuoi e puoi, fatti cremare con lui!». Più realistico è certo il consiglio che un umorista di tendenze filosofeggianti fece incidere sulla sua lapide: «Tu che sei qui davanti e leggi la mia lapide: gioca, scherza… e vieni!». aprile - giugno 2010 5 I Romani conoscevano anche le barzellette, ma non ce ne sono pervenute. Dalle commedie di Plauto si evince l’esistenza di vere e proprie raccolte & Cultura&& Spiritosaggini Secoli di barzellette DAGLI EGIZI ALLA TIVÙ DEI GIORNI NOSTRI, PASSANDO PER FREUD N di Nadia Farinelli on basta la passione. Per raccontare una barzelletta ci vuole talento. Sì, perché la barzelletta è un racconto umoristico troppo breve per ottenere l’effetto voluto senza una mimica che gli dia forza. Bisogna strappare la risata finale, unica misura del successo. L’origine del termine barzelletta è incerto. Potrebbe derivare da ballata, una forma musicale lieve e scherzosa tipica del XV e XVI secolo, ma i primi esempi sono decisamente più vecchi. Secondo le ricerche di Anita Rubini (Focus Storia 37), una delle più antiche storielle risale al 1600 a.C. ed è stata rinvenuta su di un papiro egizio. La più vecchia raccolta di barzellette è invece il Philogelos, libretto greco con una sfilza di facezie risalente a 1500 anni fa e giunto intatto fino a noi. Il professor Mario Andreassi, docente di letteratura greca all’università di Bari, ci spiega che questa raccolta rappresentava il cosiddetto “manuale del parassita”, dove per parassita si intende la persona che si presenta ai banchetti senza essere stata invitata. Mangia con voracità ed intrattiene i presenti con argute storielle, per far passare inosservata, tra una risata e l’altra, l’enorme quantità di cibo trangugiata. Il libricino permetteva di avere sempre a portata di mano più di duecento storielle, visto che le barzellette si dimenticano facilmente. Quest’ultimo aspetto aveva attirato anche l’attenzione di Freud, che attribuiva la difficoltà di imprimerle nella memoria ad una loro analogia con i sogni. Deriverebbero entrambi dall’inconscio e, anche se la barzelletta deve essere capita mentre il sogno il più delle volte rimane oscuro, raccontarli libererebbe dai tabù erotici. Certo la lettura di antiche barzellette ci lascia un poco indifferenti o al massimo ci strappa un sorriso. D’altronde sono troppo lontane dal loro contesto e non sono valorizzate dal talento del barzellettiere. I protagonisti e le vittime designate sono più o meno quelli di sempre. A partire dall’intellettuale pedante con la testa tra le nuvole del Philogelos, si è passati dapprima al monello Pierino, poi ad intere categorie (i politici, i carabinieri), fino ad arrivare al calciatore sempliciotto La più vecchia raccolta di racconti ironici è il Philogelos, libretto greco con una sfilza di facezie risalente a 1500 anni fa e giunto intatto fino a noi 6 I L VA G L I O dei giorni nostri. Nell’antica raccolta greca, per la verità, si prendono di mira anche persone per le quali c’è poco da ridere, come gli ammalati con particolari malformazioni e vi si legge anche qualche piccola crudeltà su etnie diverse: per esempio le città di Cuma e Sidone erano considerate la patria degli stupidi. Va anche ricordato che proprio nell’antica Grecia qualcuno non approvava affatto questo andazzo: il filosofo Aristotele (384-322 a.C.) diceva che l’arguzia era una forma di educata insolenza, sulla scia di Platone (427347 a.C.), che prima di lui aveva raccomandato di togliere dalla letteratura i passaggi in cui i protagonisti, eroi e dei, sghignazzavano troppo. Tuttavia ad Atene, nel IV secolo a.C., in barba ai filosofi, esisteva addirittura un circolo di aristocratici, i “Sessanta”, che si riunivano nel santuario di Eracle a raccontare barzellette. Erano così famosi che ogni storiella iniziava con: “I sessanta dicono che…”. Durante tutto il Medioevo non erano ammesse spiritosaggini. Solo i giullari di corte potevano permettersi qualche battuta, spesso utilizzata per trasmettere al sovrano delle verità scomode. Quando però, alla fine del ’400, presero piede i caratteri mobili di stampa, ci fu la rinascita della barzelletta: il massimo promotore di tale rinnovato passatempo fu Poggio Bracciolini, che nel 1450 pubblicò il “Liber Facetiarum”. Si tratta di una raccolta di storielle più o meno scabrose, che circolavano a Roma in ambiente pontificio. Bracciolini era stato il segretario di ben otto papi e aveva raccolto centinaia di aneddoti: gli impiegati della Cancelleria Pontificia si riunivano spesso al cosiddetto “Bugiale”, nel cuore dei palazzi vaticani, per scatenarsi in un gossip sfrenato. E Bracciolini trascriveva, in latino, ciò che ascoltava. Il successo fu grandioso, anche perché le masse non avevano dimestichezza con la lingua latina, dunque ne godevano solo gli aristocratici, compresi gli stessi ecclesiastici. Per questo dal papa non arrivò alcuna censura, nonostante l’argomento principe fosse la dubbia moralità degli uomini di Chiesa. Anche nel ’600 chi voleva sfondare in società doveva attirare l’attenzione Gli antenati di Pierino Poggio Bracciolini, incisione di Johann Theodor de Bry (1597) Achille Campanile in una caricatura di Augusto Camerini nei salotti borghesi, dunque ritornò di fondamentale importanza il talento del barzellettiere. I “libri delle burle” abbondavano ovunque e venivano aggiornati ogni sera: nessuna biblioteca privata doveva esserne priva. La satira politica divenne poi un’estensione della barzelletta, che nel ventesimo secolo fu portata addirittura in tribunale, spesso con drammatiche conseguenze. Fu imposto il bavaglio a chi raccontava storielle contro i vari tipi di regime. Dobbiamo arrivare agli anni Sessanta per leggere serenamente il “Trattato delle barzellette”, del famoso umorista Achille Campanile, fonte di ispirazione per grandi nomi del varietà e del piccolo schermo, come Gino Bramieri, Walter Chiari e Carlo Dapporto. In TV ci fu un grande rilancio della barzelletta, con gradevolissimi siparietti comici e fu soprattutto Gino Bramieri, definito il “re della barzelletta”, a dare notorietà e dignità a questo genere di risata popolare. •Come intrattieni un faraone annoiato? Navighi lungo il Nilo con una nave carica di giovani donne vestite solo di reti da pesca e lo inviti ad andare a pescare. Egitto 1600 a.C. • Una donna, cieca da un occhio, era sposata a un uomo da vent’anni. Quando il marito si trovò un’altra donna, le disse: “Divorzierò da te perché sei cieca da un occhio”. Al che lei rispose: “E l’hai scoperto solo dopo vent’anni di matrimonio?”. Papiro egizio 1100 a.C. • Un uomo che voleva insegnare al suo asino a non mangiare decise di non dargli più cibo. Quando l’asino morì di fame, l’uomo disse: “Mi è capitata una disgrazia. Proprio quando aveva imparato a non mangiare, l’asino è morto!”. Philogelos, Grecia, IV sec d.C. • Un uomo entra da un barbiere. Questi, tra mille complimenti, gli chiede come vuole che gli tagli i capelli. E l’uomo: “In silenzio”. Philogelos, Grecia, IV secolo d.C. • Augusto era in giro per l’Europa quando, tra la folla, notò un uomo che gli assomigliava in maniera straordinaria. Incuriosito, gli si avvicinò e gli chiese: “Sua madre è mai stata a servizio a palazzo?” “ No, Vostra Altezza”, rispose l’uomo “ma mio padre sì!”. Ambrogio Teodosio Macrobio, Saturnalia, V secolo d.C. • Questi codardi di inglesi! Non hanno avuto il coraggio di gettarsi in mare come i vostri soldati francesi, che sono saltati giù dalla nave lasciandola in balìa dei nemici, i quali non hanno mostrato alcuna inclinazione a seguirli! Giullare del re di Francia Filippo VI che annuncia al sovrano il disastro navale all’Ecluse , 1340 • Mulier, si filas, et cadit tibi fusus, quando te flectis, tene culum clausum” Poggio Bracciolini, Liber Facetiarum, 1450 • E’ la prima volta che quella coppia di coniugi va d’accordo: hanno deciso di separarsi. Achille Campanile, Trattato delle barzellette, 1961 aprile - giugno 2010 Negli anni Sessanta Achille Campanile pubblica il “Trattato delle barzellette”, fonte d’ispirazione per grandi nomi del varietà e del piccolo schermo 7 & Cultura&& Aldiqua Lo humour del caro estinto UNA CARRELLATA DI LAPIDI BUFFE E CURIOSE “ L’epitaffio racconta in breve la storia della persona, ciò che di buono o cattivo ha fatto, le virtù e le viltà, i desideri soddisfatti e delusi 8 T di Graziella Bazzan i tocca anche se ti tocchi” è il titolo di un libro e contemporaneamente un modo un po’ bizzarro per introdurre il discorso sull’evento degli eventi che coinvolge indistintamente ogni essere umano. La morte è senza dubbio un grande mistero e la tomba è l’unico tramite che unisce i defunti ai viventi costituendo “quella corrispondenza di amorosi sensi, che ci fa credere, finchè siamo vivi, che qualche cosa di noi sopravviverà nel ricordo dei nostri cari”. Essere ricordati! Ecco l’origine dell’epitaffio, nato come orazione funebre che si teneva pubblicamente ad Atene in onore dei guerrieri che avevano perso valorosamente la loro vita in battaglia, e poi iscrizione in memoria di un defunto sopra il sepolcro. Iscrizione che rappresenta l’appello postumo del medesimo al vivo. In essa chi non è più vuole attirare ancora l’attenzione fermando colui che guarda e passa, e nel riassumere la propria vita, esprime nella forma più genuina e più breve (appunto lapidaria) la scala dei valori del tempo in cui ha vissuto, la sua concessione della vita e del destino umano. Negli epigrammi di epoca classica, l’espressione poetica ha quasi sempre il sopravvento, mentre in quella delle epigrafi di epoca moderna, ci troviamo quasi sempre davanti a componimenti in cui prevalgono gli elementi del romanticismo. L’epitaffio racconta in breve la storia della persona, ciò che di buono o cattivo ha fatto, le virtù più o meno eroiche e le spicciole viltà, i desideri soddisfatti e delusi. Spesso viene indicata la causa della morte, viene descritto l’evento, vengono rivelati la professione, i comportamenti del defunto o di chi è rimasto a piangerlo e ha voluto che dei versi o delle parole, incise su di una lapide, lo ricordassero ai posteri. Attraverso questa glittografia cimiteriale, l’epitaffio fornisce del defunto una fotografia con accenti il più delle volte lirici e allegri, cosicchè la morte non faccia paura perché appare sdrammatizzata dall’umorismo e dalla teatralità delle parole. Alcuni di loro sono sorprendenti, alcuni sono enigmatici I L VA G L I O L’epitaffio di Gianfranco Funari: “Ho smesso di fumare” o da brivido, altri invece sono buffi e curiosi. Diversi ci emozionano mentre altri ironicamente ci fanno sorridere come quello del comico gallese Spike Milligan: “Ve l’avevo detto che ero malato”, o quello dello scrittore francese Georges Bernanos: “Si prega l’angelo trombettiere di suonare forte, il defunto è duro d’orecchie”. In un’iscrizione sepolcrale nelle isole Shetlands si piange ad esempio il pacifico, tranquillo e in ogni apparenza buon cristiano Donald Robertson, morto nel 1785 a sessantatre anni: “La sua deplorevole morte è stata provocata dalla stupidità di Laurence Tulloch di Clothister che gli ha venduto nitrato al posto dei sali di Epsom e l’ha così ucciso nello spazio di cinque ore”. “Giace qui da qualche parte” è scritto sulla lapide del fisico tedesco Werner Heisenberg, a riferimento del suo “principio di indeterminazione” secondo il quale non è possibile indicare simultaneamente posizione e quantità di un corpo. Sulla tomba di un certo Ignaz Breitenseher: “Silenziosa e solitaria fu la sua vita, fedele e attiva la sua mano”. Questa è l’incisione funeraria sulla tomba di un gentiluomo famoso in vita per la sua cortesia: “Qui giace lord Barlington. Scusate se non mi alzo”. Epitaffio di un avvocato in Inghilterra: Sir John Strange (strange significa raro): “Qui giace un avvocato onesto, questo è Strange”. Nel cimitero di Wimborne, sempre in Inghilterra, a ricordo di John Penny sta scritto: “Se ritrovare soldi è il tuo mestiere, scavando qui, alla profondità di qualche metro, potrai trovare un Penny”. Ancora in Inghilterra, a Ribbesford, per Anna Wallace: “I bambini di Israele volevano il pane e Dio mandò loro la manna . Il signor Cler Wallace voleva una moglie e il diavolo gli mandò Anna”. Epitaffio sulla tomba di Ezechial Aiklein Dalhousie. In Scozia: “Qui giace… età 102 anni, era buono. Morto giovane”. Su di un’urna funeraria le parole: “Pace alle mie ceneri. Si prega di non starnutire, grazie”. Ancora epitaffi: “Questa è la tomba di Serafino Viola, pagata a rate quand’era in vita”.“Qui giace Leo Cinquemani, instancabile lavoratore”.“Qui riposa Onofrio Mondragoni, uomo pieno di vita”. Celeberrimo quello di un vignettista e umorista di cui si è persa la conoscenza, morto a Roma nel 1998: “Ed ora che mia suocera qui giace, lei non lo so, ma io riposo in pace”. Di un attore etrusco: “Sono morto tante volte, ma così mai”. Per un incidente: “Uomo di grande dirittura morale, vissuto con linearità e rettitudine, morto in curva”. Rovinato dalle medicine: “Per stare meglio sono finito qua”. Di Benedetta Gaia Bellina sta scritto: “Qui riposa... donna instancabile. Ha amato la vita. Suo marito. Tutto il paese”. “Nacque, visse, morì Emilia Peruzzi Dell’Antella. Ora ella qui riposa in pace e finalmente tace”. Il poeta dialettale romano Giovan Battista Marini vol- le per sé questo epitaffio: “O passeggero, qui fra tanta quiete, ‘sto morto senza er nome su la targa, volemo armeno adesso, un po’ de requie, prega li vivi de passà a la larga”. Per il condottiero e politico Gian Giacomo Trivulzio, sepolto nella basilica di San Nazaro Maggiore a Milano, la scritta: “Chi non riposò mai, ora riposa”. Il celebre Piovano Arlotto, membro della confraternita di Cristo Pellegrino in Firenze, fece scrivere sulla sua lapide ciò che ancor oggi si legge: “Questa sepoltura il Piovano Arlotto fece fare, per sè e per chi ci vuole entrare”. “Ho smesso di fumare”, epitaffio per Gianfranco Funari a Roma e al Monumentale di Milano, sulla lapide di Walter Chiari, umorista fino alla fine, l’ultima battuta che ci ha lasciato: “Amici non piangete, è soltanto sonno arretrato”. Questo invece è un esempio di epitaffio a doppio senso, ovvero quando il marito si chiama Felice: “Alla moglie prematuramente scomparsa, il marito Felice QMP” (qui memore pose). In America, ma in stati diversi, queste epigrafi quasi tragicomiche. Di Margaret Danieli, nel cimitero di Richmond, Hollywood, Virginia, leggiamo: “Diceva sempre che aveva dei dolori ai piedi che l’uccidevano, ma nessuno le ha mai creduto”. Ad Enosburg Cade, Vermont, di Anna Hopewell sta scritto: “Qui giace il corpo della nostra Anna, morta a causa di una banana. Non è del frutto però la causa ma la buccia di esso che l’ha fatta scivolare”. A Thurmont, nel Maryland: “Qui riposa un ateo, tutto vestito bene e senza alcun luogo dove andare”. Albany, New York: Enrico Edsel Smith, nato nel 1903, morto nel 1942, “Ha guardato verso l’alto dal pozzo dell’ascensore per vedere se la cabina stesse scendendo. Sì, lo stava facendo”. In Girard, Pennsylvania, sulla tomba di Ellen Shannon: “Morto tragicamente in un rogo, il 21 marzo 1870, causato dall’esplosione di una lampada riempita con R.E.Danforth, olio per lampada non esplosivo”. Sempre nel Vermont: “Alla memoria di mio marito John Barnes che morì il 3 gennaio 1803. La sua vedova bella e giovane, di 23 anni, ha molte qualità di buona moglie e desidera essere confortata”. aprile - giugno 2010 9 Da sinistra: Emily Dickinson, Werner Heisenberg e Georges Bernanos Una quantità enorme di notizie è stata tramandata dalle lapidi fin dai tempi remoti: basti pensare alla loro utilità nella decifrazione delle lingue I vecchi cimiteri appaiono come mondi purgatoriali di quella lunga attesa, a cui l’essere umano non sa dare un nome, ma della quale non può fare a meno 10 Ritratto di Gian Giacomo Trivulzio Walter Chiari Dorothy Parker Il comico Spike Milligan Frank Sinatra Archimede, Domenico Fetti (1620) A Silver City in Nevada: “Qui giace Butch, giovane pistolero. Era rapido sul grilletto ma lento a scansarsi”. Uniontown, Pennsylvania in memoria di un incidente: “Qui giace il corpo di Jonathan Blake, ha messo un piede sull’acceleratore al posto del freno”. Qualcuno deciso a rimanere anonimo in Stowe, nel Vermont ha fatto incidere queste parole: “Ero qualcuno, chi non è affar tuo”. Imbattibile in stringatezza sembra l’iscrizione sepolcrale della poetessa americana Emily Dickinson: “called back” (richiamata). Per la scrittrice Dorothy Parker invece: “Scusate la polvere”. Terminiamo questa carrellata con l’iscrizione tombale (che è tutta un programma) dell’attore e cantante Frank Sinatra: “Il meglio deve ancora venire”! Una quantità enorme di notizie è stata tramandata dalle lapidi fin dai tempi remoti, quante figure e quanti fatti si sono conosciuti attraverso un epitaffio e quanto contributo esso ha dato alla decifrazione delle lingue. Cicerone a Siracusa riuscì a individuare la tomba di Archimede trovando sulla lapide incisi un cilindro e una sfera, il cui rapporto fu la grande scoperta dello scienziato, ma quanti messaggi sono giunti sino a noi anche da umili sepolcri? I L VA G L I O L’epitaffio un tempo raccoglieva la summa di un’esperienza, un ammonimento, il frutto estremo di un’esistenza tanto che ne ha fatto tesoro la letteratura. Molte composizioni dell’Antologia Palatina, la grande raccolta di poesia bizantina, sono forme poetizzate di epitaffi. Lo stesso procedimento usò Edgar Lee Masters nell’Antologia di Spoon River, e anche i discorsi di coloro che Dante incontra nella Divina Commedia, non sono che grandi epitaffi. Ora però ciò che ai nostri predecessori sembrava un giusto tributo di onore e di memoria per gli scomparsi, non si usa più: oggi suona altra musica! Nel giro di pochi decenni le tombe dalla terra si sono sollevate diventando megalopoli tutte uguali, alveari di anime; e i vecchi cimiteri appaiono come mondi purgatoriali di quella lunga attesa, a cui l’essere umano non sa dare un nome, una forma, ma della quale sa che non può fare a meno. L’uomo nel profondo più profondo sa che qualcosa deve venire e come il personaggio di Kafka nel Messaggio dell’Imperatore, si siede alla finestra e lo sogna, mentre passa la notte. Ironia, divertimento e satira sociale nella poesia di Porta & Cultura&& Letteratura TRA L’AMORE PER MILANO E L’AVVERSIONE ALLE IPOCRISIE di Maria Forni L Tra il Parini e il Manzoni, come poeta satirico e del costume, come inventore e modellatore di tipi saltanti su dalla vita, non può stare che il gran Meneghino Carlo Porta. Giosuè Carducci. ’impiegaa Carlo Porta, ovvero Carlin, definito affettuosamente dal Foscolo “l’Omero di Porta Ticinese”, trascorse la sua non lunga vita (1775-1821) nella città di Milano, di cui fu il cantore appassionato e critico, mosso da autentico amore ma senza remore né ostacoli alla lucida visione della realtà. Porta è un poeta interessato alla rappresentazione della vita vera, quotidiana, dura e pur cara, della società del suo tempo e della sua comunità, colta nel suo complesso, nelle relazioni tra individui della stessa classe sociale, ma anche in quelle, spesso complicate e inique, tra i diversi ceti e gruppi di una città vivace, dinamica e inquieta come la Milano dell’età napoleonica, divisa tra il vecchio e il nuovo, mossa da inedite prospettive e antiche fedeltà. Figlio di un funzionario statale della Milano austriaca, il Porta nacque a Milano nel 1775; dopo studi regolari, intraprese la stessa carriera del padre, fino al grado di cassiere generale al banco di Monte Napoleone. Apparteneva dunque a quel ceto impiegatizio borghese, abbastanza agiato, al quale toccò storicamente il compito di impegnarsi nello svecchiamento dei costumi e delle idee, lottando con le armi della cultura e dell’ironia contro l‘atmosfera soffocante, ipocrita e bigotta delle classi dominanti dell’aristocrazia e di un certo clero. Era quello un momento particolarmente inquieto e movimentato della storia europea, e naturalmente Ritratto di Carlo Porta, di Giuseppe Bossi (Museo di Milano) delle vicende di Milano, passata nel giro di pochi anni dalla dominazione austriaca a quella francese napoleonica, e di nuovo a quella austriaca dopo la sconfitta dell’Imperatore. aprile - giugno 2010 Porta, definito dal Foscolo “l’Omero di Porta Ticinese”, è un cantore della vita vera, quotidiana, dura e pur cara, della società del suo tempo e della sua comunità 11 Formatosi sui testi illuministici francesi e lombardi, l’autore milanese sostiene i grandi valori della libertà, della giustizia e dell’eguaglianza 12 Non era facile prendere una posizione coerente, ma il Porta, al di là degli inevitabili dubbi e perplessità, fu sempre fermo su alcune convinzioni radicate e indiscusse, in primo luogo l’ideale di giustizia e di buona amministrazione, intimamente legato all’aspirazione alla libertà politica, religiosa e culturale contro ogni dogmatismo e oppressione. Fu dunque uno scrittore morale quasi senza saperlo, come diceva lui stesso scherzosamente: morale sì, ma anche non all’oscuro delle umane debolezze, specialmente di quelle dei modesti cittadini esposti alle angherie e alle ritorsioni. Gh’hoo miee, gh’hoo fioeu, sont impiegaa… e perciò stesso non posso fare l’eroe. Negli ultimi anni della sua vita, con il ritorno oppressivo del governo austriaco e la rivincita della nobiltà più retriva, il poeta si convinse della necessità di un’indipendenza italiana da qualsiasi dominio straniero, anche dopo le deludenti esperienze fatte sotto la dominazione dei francesi. Egli condivise pertanto le attese e i positivi atteggiamenti della borghesia illuminata e progressista milanese: dapprima filonapoleonico, in considerazione della ventata di novità e di spinte democratiche di cui l’armata di Bonaparte sembrava portatrice, fu ben presto amaramente deluso dai soprusi e dai comportamenti tirannicamente arbitrari dei “liberatori” francesi, fino al punto di vedere con sollievo la partenza dell’esercito imperiale da Milano. Paracar che scappee de Lombardia, apostrofa così con ironica gaiezza i soldati francesi in fuga dalla sua terra, definendoli paracarri per la somiglianza dei loro alti copricapi con questi oggetti stradali: così del resto li chiamava il popolo. E tuttavia ciò non lo indusse a un ripiegamento su posizioni di individualismo qualunquista o tanto meno di moderatismo acquiescente all’antico dominatore ritornato, ma , doppiamente deluso dalla politica della Restaurazione e della Santa Alleanza, interessata a ripristinare i privilegi delle antiche classi dominanti e la politica del “trono e dell’altare”, si accostò al gruppo liberale e romantico del “Conciliatore”, ossia al primo gruppo milanese di “patrioti” iniziatori del Risorgimento. Strinse così una profonda e intensa amicizia con Grossi, Torti, Visconti, Berchet e con lo stesso Manzoni, tutti frequentatori della “Cameretta” del Porta, ove si riunivano a leggere e discutere ciascuno i propri scritti, mentre nascevano interessi politico-letterari sempre più rivolti alla dimensione liberale europea, proprio perché profondamente legati all’ambiente milanese, conosciuto e amato con autenticità di analisi e di interesse. E a Milano Porta morì nel 1821, anno fatidico per i primi moti risorgimentali che egli tuttavia non giunse a vedere. *** Formatosi sui testi illuministici non solo dei philosophes francesi ma anche della più schietta tradizione lombarda (Verri, Beccaria, Parini, il “Caffè”), il Porta sostiene i grandi valori della libertà, della giustizia e dell’eguaglianza, ma continua pure la consuetudine, tipica dell’Illuminismo italiano, o meglio milanese, di I L VA G L I O attenersi a una convinta fedeltà al reale, ai problemi concreti e pressanti della società, al desiderio di una “rivolta” contro le regole di una letteratura astrattamente classicheggiante, vuota di emozioni e di sentimenti “veri”, lontana dagli interessi e dalla comprensione della maggioranza dei lettori. Ma la produzione poetica del Porta finisce col diventare una personalissima sintesi tra istanze illuministiche e apertura alle nuove tematiche e finalità culturali prodotte dal sorgere in Europa della corrente romantica. Si pensi soprattutto all’estrema attenzione al dato realistico e sociale, all’assunzione del punto di vista delle classi subalterne mai prima considerate nella loro profonda umanità, agli ambienti degli emarginati colti nella sordida miseria della loro esistenza, ma anche nella loro solidarietà reciproca e nel tenace attaccamento alla vita. C’è davvero un nuovo epos soprattutto nei poemetti portiani, l’epos degli sfruttati e degli oppressi (si pensi a Manzoni, ma in un clima culturale laico), che vivono nell’indigenza e tuttavia non sono privi né di una loro spiritualità né della capacità vitalissima di scherzare sulle loro e altrui vicende, con una evidente dialettica tra farsa e tragedia, o meglio con la disposizione tutta popolana a costruire una commedia della tragedia, “ con una continua frizione tra i due poli e il conseguente scintillio elettrico della battuta, il guizzo impertinente della comicità”. (Paolo Mauri, 1995). Esplosiva è anche la novità espressiva e formale del Porta, il quale sceglie con consapevolezza di cultura e di poetica l’uso del dialetto, che si rifaceva sì a una lunga tradizione dialettale milanese dal sec.XV in poi, attraverso scrittori come Carlo Maria Maggi, canonizzatore della figura di Meneghino nel 1600 e Tanzi, Balestrieri, lo stesso Parini (pur severo classicista in lingua) nel 1700, ma aveva anche la forza dirompente di uno strumento nuovo e completamente libero,senza freni o autocensure. A ben vedere, il poeta portò alle estreme conseguenze l’obiettivo del Romanticismo italiano di scrivere in modo comprensibile ai più, di utilizzare cioè uno strumento linguistico liberato dagli artificiosi e polverosi accademismi classicistici e capace di parlare al popolo e per il popolo. Ma il popolo milanese in quel periodo utilizzava come strumento quotidiano di comunicazione il dialetto, e perciò, assumendolo come suo codice espressivo, il Porta operò una scelta decisamente romantica e fortemente innovativa. Il dialetto era davvero in quell’età la “lingua” di un’intera città, in tutti i suoi ceti: così nel mondo poetico portiano il messaggio linguistico viene adoperato nelle sue varie sfumature, dal livello schiettamente popolare e gergale tipico di quartieri e di gruppi sociali “bassi”, al cosiddetto “parlar finito”, proprio dell’aristocrazia reazionaria e ottusamente conservatrice. E’ quel modo di parlare in punta di labbra, altezzoso e tagliente, modificato rispetto al linguaggio della plebe dalla maggior vicinanza all’italiano, che lo rende artefatto e ambiguo come il costume e il modo di sentire di quella classe. In polemica con i sostenitori assoluti della lingua della “Il Naviglio a Milano”, stampa colorata della prima metà del XIX secolo tradizione, il Porta ribadisce di aver appreso i propri mezzi espressivi “alla scoera de la lingua del Verzee”, ossia alla scuola di lingua del mercato della verdura, dove egli si recava spesso, attratto dai vari tipi umani e dalla molteplicità di casi di quel vero laboratorio di vita e di linguaggio genuinamente popolaresco. Accanto all’uso sempre più consapevole e magistralmente vario del dialetto milanese, si riscontra nella produzione portiana anche il ricorso a quello che si chiama pastiche linguistico e che si costruisce accostando nello stesso testo linguaggi o addirittura lingue diverse: è il caso della mescolanza francese-milanese in molti testi riferiti alla dominazione francese a Milano nell’età napoleonica, particolarmente nel poemetto Desgrazi de Giovannin Bongee, il cui protagonista è un modesto lavoratore a cui quell’accident d’on cavion frances insidia apertamente la moglie provocando le sue proteste in un gustosissimo dialogo plurilinguistico. Un altro esempio di rara sapienza linguistica ed espressiva è costituito dal pastiche tra dialetto meneghino e lingua latina, usato con particolare efficacia nel famoso componimento On funeral, noto anche col titolo di Miserere, datogli dal Grossi. Il testo rientra nella numerosa produzione satirica nei confronti di una parte del clero, quella formata da preti senza vocazione, grettamente egoisti e avidi, meschinamente attaccati ai potenti per trarne lucro. Non si creda che il poeta voglia propagandare una concezione atea o irreligiosa: il Porta è piuttosto erede di quello spirito illuministico per cui la fede è un fatto personale e privato, che non può ridursi a gerarchie, riti, ipocrisie e interessi materiali: egli esprime il suo sdegno, ancorché sempre in forme di divertimento satirico, nei con- fronti di chi in nome di una falsa religiosità inganna il prossimo e soprattutto gli umili. Dalla satira abilissima emerge la condanna dell’ipocrisia e della violenza morale, in nome anche di una più schietta religiosità. El Miserere racconta di come il Porta assista in San Fedele all’ufficio funebre in suffragio di un ricco defunto e afferri nel contempo la conversazione che gli officianti intercalano ai versetti del Salmo, rivelando una assoluta indifferenza al rito che si va compiendo e una preoccupazione rivolta esclusivamente al pranzo che li aspetta e ad altri consimili questioni materiali e volgarmente quotidiane. Miserere mei Deus-E a disnà? Secundum magnam-do cosett o tre ... E el scabbi come l’è? (scabbi= vino) Et multum lava me Ab injustitia mea, et a delictoEel car?-Puttasca! E subet, munda me… La stessa satira, ma meno grottesca del canto salmodiante dei due preti blasfemi, si trova in molti altri componimenti: ne La mia povera nonna la gh’aveva parla un nipote a cui la nonna ha lasciato in eredità on vignoeu, una piccola vigna, raccomandandogli di dare la loro parte ai frati che venivano a benedire il podere, se voleva avere prodotto abbondante. Ma quando Napoleone elimina molti ordini religiosi, questo obbligo viene meno, eppure nulla di male accade alla vigna, anzi Franzeschin, l’erede, si trova avvantaggiato: in scambi hoo bevuu anch quell che dava ai fraa. aprile - giugno 2010 Attraverso la potente arma della satira, Porta esprime il suo sdegno nei confronti di chi in nome di una falsa religiosità inganna il prossimo 13 Piazza della Scala in una stampa ottocentesca Grazie al sapiente uso del dialetto milanese, Carlo Porta sostiene la posizione romantica nel dibattito tra i nuovi poeti e il classicismo 14 Né si può dimenticare il potente affresco de La nomina del Cappellan, in cui una dama altezzosa e conformista, la Marchesa Paola Cangiasa, sceglie, attraverso un sussiegoso maggiordomo, il nuovo cappellano di palazzo. Poiché in casa dopo la padrona viene subito al secondo posto la cagnetta, la Lilla, il cui accompagnamento a passeggio rientra nei compiti del Cappellano, viene alla fine scelto tra tanti postulanti non molto puliti e male in arnese, quello che sembra essere più gradito alla poco simpatica bestiola. Solo alla fine si saprà che il fortunato aveva in tasca tre o quatter fett/ de salamm de basletta… Del dialetto il Porta si serve anche per sostenere, dopo il 1815-16, la posizione romantica nel dibattito tra i nuovi poeti e i classicisti, dimostrando pure così, oltre che nell’uso di una metrica sciolta, armonica e regolarissima, soprattutto nelle ottave ariostesche e negli endecasillabi , che l’utilizzo del dialetto milanese non si risolve affatto per lui nelle “bosinate” dalla facile comicità o nelle poesie d’occasione, come fa notare Dante Isella, il grande studioso soprattutto della filologia portiana. Il dialetto diventa così uno strumento linguistico frutto di elaborazione culturale e tanto ampio nel respiro da poter affrontare anche temi di poetica e argomentazioni a sostegno della nuova corrente culturale. A buon diritto il Porta rientra nel dibattito culturale dell’epoca, dimostrando di aver perfettamente individuato l’elemento strutturale fondativo del Romanticismo, che consiste nel rifiuto delle regole cosiddette aristoteliche e nella rivendicazione dell’assoluta libertà del poeta nelle tematiche e nel linguaggio. Naturalmente I L VA G L I O lo fa assecondando lo spirito spregiudicato, scherzoso e ammiccante dell’idioma milanese. Così, nel componimento intitolato “Il Romanticismo”, sotto forma di una lettera a una signora, Madama Bibin (Barbara), che si era dichiarata avversa alla poesia romantica con competenza in merito quanto meno sospetta, il Porta spiega affettuosamente che la poesia è un fatto dinamico, che segue come tutte le cose i movimenti della storia e lo spirito del tempo. Ma la chiusa della lunga epistola, secondo le migliori tradizioni satiriche dell’inaspettato alla fine (fulmen in clausola secondo i Latini), paragona la libertà dei Romantici all’impossibilità di un passante nei pressi del Duomo di frenare i propri bisogni corporali: Fan tal e qual che fava quel bon omm/ che ghe criaven (che la scusa un poo)/perché el fava i fatt soeu depos al Domm:/ Se po’ no, se po’ no!..Ma mi la fo,… E il poeta conclude l’insolita quanto efficace similitudine con la frase S’el gaviss tort o no la diga lee. Il successo che i testi poetici del Porta (a cui il Cherubini aveva riservato il XII volume della “Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese” iniziata nel 1816) riportarono fin dalla loro prima uscita pubblica è testimoniato, tra le varie e numerose attestazioni, dal giudizio di un altro grande scrittore lombardo, Carlo Cattaneo: “…Fu allora che…il nostro dialetto si impregnò della più audace ironia. Nelle storie di Porta ella si unì a tutto il vigore e a tutta la verità di un dipinto fiammingo. La moderna poesia di tutta Italia non ha una pagina che somigli alla parlante evidenza di quelle scene”. & Cultura&& Storia Il Carnevale nel tempo ABBUFFATE, MASCHERATE, DANZE E ALLEGRIA I di Eufemia Marchis Magliano l carnevale è gioia di vivere, amore, allegria, giovinezza, vuole cancellare i momenti difficili dell’anno appena trascorso ed è speranza nel futuro. Esalta il concetto edonistico della vita così bene espresso nel delizioso Canto Carnascialesco di Lorenzo il Magnifico, il Trionfo di Bacco ed Arianna, in cui l’autore, secondo il critico Natalino Sapegno, “ si fa cantore di un’ebbrezza vasta e diffusa quanto indeterminata e povera di rilievo individuale.” Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto sia: di doman non c’è certezza... ...Ciascun apra ben gli orecchi, di doman nessun si paschi, siam, giovani e vecchi lieti ognun, femmine e maschi, ogni tristo pensier caschi: facciam festa, tuttavia. Chi vuol esser lieto sia Di doman non c’è certezza! Celebrare il carnevale è vivere una festa di libertà, un rito liberatorio, un mutare d’identità, un gioco delle parti, come riscatto da schemi in cui si è costretti ad operare. Ci si traveste, si indossa una maschera, si assumono ruoli diversi dal quotidiano. Questo è lo spirito del carnevale da anni lontani che si perdono nel tempo ed è ancor vivo ai giorni nostri: gli uomini indossano abiti femminili, le donne quelli maschili, si diventa un personaggio illustre o un poveraccio, il malinconico Pierrot o l’allegro Arlecchino, si diventa un’ immagine caricaturale di una persona nota, oppure un gattone, una tigre aggressiva, un mostro... Le feste dei bimbi sono affollate di fatine, Biancaneve, damine, pellerossa, Zorro, Batman, extraterrestri... L’etimologia della parola carnevale non è chiara; va per la maggiore la derivazione dal latino “carnem vale”, addio alla carne, proprio del primo giorno di quaresima. Le feste carnevalesche sono nate da miti antichissimi, proprii di varie civiltà, dal concetto della deità del Sole e della Terra e dei loro poteri misteriosi da propiziare con cerimonie sacre. Le costumanze carnevalesche nel corso degli anni si sono rifatte alle antiche feste religiose per gli auspici del nuovo anno agli inizi della primavera, la rinascita della natura dopo la stasi invernale. Assiri, Babilonesi, Egizi, Greci, Romani solevano dedicare i giorni di fine inverno a riti festosi con cortei, danze, maschere, canti, che terminavano per lo più con il sacrificio agli Dei di un animale, simbolo dello spirito del male. I popoli mesopotamici davano alla loro festa la caratteristica di un rituale magico in cui la lotta fra il bene ed il male rappresentava la ricerca dell’immortalità con le cerimonie dell’acqua e della “pianta di vita” nello svolgersi delle stagioni. A Babilonia il dio Sole era posto su di una nave con ruote che procedeva accompagnata da gente festante in ruoli invertiti: il ricco diventava povero, lo schiavo padrone ed era concessa una grandissima libertà; infatti non c’era freno alla lussuria, al gioco, a pantagrueliche abbuffate. Nell’antico Egitto l’avvento della primavera era celebrato con sette giorni di cerimonie e luculliani banchetti. Uomini, donne, giovani ed anziani, tutti mascherati, seguivano per le vie delle città un bue dipinto e dalle corna dorate, addobbato con un manto sontuoso. L’avanzare del corteo era accompagnato da fanciulle nude e da sacerdoti che danzavano cantando lodi al bue, ad Osiride, dio della vegetazione, ed alla sua sposa Iside, dea della natura. Al termine delle feste il bue era sacrificato agli dei fra il salmodiare dei sacerdoti. Questo tipo di festeggiamenti, passato in Grecia, diede origine alle celebrazioni del ritorno della primavera nel mito di Demetra, la madre Terra, e Persefone, sua figlia, simbolo della rinascita della vegetazione. Per una settimana, uomini e donne in maschera danzavano e cantavano inni di auspicio per il ritorno alla vita della natura, seguendo il corteo orgiastico del dio Dioniso, protettore del vino e del ciclo delle stagioni. aprile - giugno 2010 L’etimologia della parola non è chiara: va per la maggiore la derivazione dal latino “carnem vale”, addio alla carne, proprio del primo giorno di quaresima 15 Come tanti riti pagani, Baccanali, Saturnali e Lupercali, furono accolti nelle feste dell’epoca cristiana, evolvendosi nel Carnevale 16 Il rito greco continuò a Roma nei Baccanali, nei Saturnali, nei Lupercali. I primi in onore di Bacco, il Dioniso dei greci, signore della vendemmia e dei prodotti della terra. Nati fra i contadini che si davano ad una sfrenata allegria divennero così licenziosi a Roma da essere proibiti dai consoli e dal Senato nel 185 a.C. I Saturnali, dedicati a Saturno, dio della semina, esaltavano l’età dell’oro, allorchè tutti gli uomini erano uguali, con cortei di maschere e carri decorati, trascinati da animali con strane bardature. Durante i festeggiamenti che duravano da tre a sei giorni, cessava l’autorità dei padroni sui propri schiavi i quali, indossata una maschera, avevano il diritto di agire come desideravano. Veniva creato un re da burla, uno schiavo cui andavano tutti gli onori, ma che, a volte, veniva sacrificato al termine delle feste. I Lupercali, in onore della lupa, la leggendaria nutrice di Romolo e Remo, o del dio fauno Luperco, tutore della terra e della fecondità femminile, si celebravano il 15 febbraio di ogni anno con funzioni religiose dei sacerdoti lupercali, i quali mascherati e coperti di pelli, correvano intorno all’antica città palatina percuotendo con strisce di pelle le donne a cui il dio Luperco avrebbe donato la fertilità. Come tanti riti pagani, Baccanali, Saturnali e Lupercali, furono accolti nelle feste dell’epoca cristiana. I Lupercali giunsero a trasformarsi in una sfrenata orgia della plebe e furono proscritti dal papa Gelasio I nel 400. I Baccanali ed i Saturnali divennero un divertimento buffonesco: le cosiddette “Feste dei pazzi” che si tenevano nelle chiese con il permesso dei vescovi. Ma anche queste degenerarono; per le canzoni addirittura oscene tollerate dall’autorità ecclesiastica furono abolite e sostituite dalle feste del Carnevale dette Badie, organizzate da associazioni di giovani sotto la responsabilità di un Abbà ed il controllo della Chiesa. Nei secoli che seguirono si svolsero le feste carnevalesche nei paesi cattolici-romani. In Italia, Francia, Spagna si organizzarono festeggiamenti burleschi, talora sfrenati, al termine dei quali una figura grottesca dai nomi vari secondo i luoghi, veniva bruciata, gettata in acqua o comunque distrutta fra urla, improperi, maledizioni degli astanti come in uso fra i popoli antichi. Il fantoccio messo a morte ci riconduce al mito dell’incarnazione dell’arcaica divinità della vegetazione uccisa annualmente insieme alle sue negatività per rinascere in primavera, ricca di promesse e doni. Venezia era già celebre nel medioevo per le mascherate in cui il popolo si mescolava ai signori del Gran Consiglio, ai rappresentanti dei Sestieri, ad allegre compagnie di Siciliani, Napoletani, Calabresi, nei loro costumi caratteristici. Tutti solevano indossare una maschera, diritto inviolabile tutelato da apposite leggi, che poteva, però, essere complice d’intrighi e scherzi di cattivo gusto, allorchè, come venne di moda, riproduceva il viso di qualche persona e permetteva incresciosi scambi d’identità. I Veneziani, cui s’aggiunsero persone d’ogni parte d’Europa, si davano alla pazza gioia: balli, rappresentazioni teatrali, cortei di gondole sul Canal Grande tra suoni di piatti e mandolini e scambio di lazzi e frizzi dalla singolare arguzia e comicità. I L VA G L I O Le feste carnevalesche a Napoli hanno una tradizione più che secolare; nel 1400 giunsero ad essere di particolare splendore, organizzate con gran dispendio di denaro, ammirate anche dagli stranieri. I divertimenti di quell’anno furono tanti e tanto liberi da sfociare in tumulti, risse, incidenti addirittura mortali che produssero perfino condanne a morte. Ad ogni termine del periodo invernale, le feste napoletane erano ricche di carri, di maschere popolari che occupavano le vie della città in allegria anche smodata, mentre gli aristocratici si divertivano con galà, spettacoli, lauti pranzi. Nel secolo XIX i toni si fecero più moderati; per l’antico splendore è ricordato il ballo al Teatro Regio del 1827, sontuosamente allestito con quadri storici viventi i cui protagonisti erano gli appartenenti alla migliore società di Napoli. Maschere, danze, cortei di gente festante, sfilate di carri, scorpacciate caratterizzarono anche il carnevale di Firenze. I cittadini usavano aggirarsi per strade e piazze cantando canzoni satiriche ed erotiche. All’epoca di Lorenzo il Magnifico, i carri, detti “Trionfi” raffiguravano personaggi storici o mitologici ed erano accompagnati da suonatori di piatti e liuti e da maschere che cantavano i canti carnascialeschi del Magnifico e dei poeti della sua corte. Si percorreva la via dal ponte Vecchio a piazza del Duomo, mentre folleggiavano ninfe e satiri, redarguiti dai Piagnoni, seguaci del Savonarola, con la recita del Miserere sul loro nero carro adorno di scheletri e di casse da morto. Roma non fu da meno delle altre città sunnominate nelle allegre gazzarre dei giorni di carnevale, anche per la propensione ad atteggiamenti e linguaggi lontani dal comune senso morale. Il carnevale romano nacque nel X secolo ed il suo periodo di maggior sfarzo e raffinatezza si ebbe nel 1500. Papi, cardinali, alti prelati amavano travestirsi e mescolarsi ai cortei popolari. Vestivano abiti lussuosi, bordati d’oro, e seguivano i “trionfi” accompagnati da autorità, da uomini in arme, da paggi e valletti. Come nelle altre città i “trionfi” erano raffigurazioni di scene mitologiche o storiche. Negli anni di Paolo III, oltre i soliti carri, c’era un proliferare di banchetti di ecclesiastici, mentre il giovedì grasso erano d’uso sfilate di taverneri, falegnami, calzolai, musici, muratori, soldati alla presenza di una folla chiassosa e sovente rissosa. Il carnevale romano continuò i suoi fasti nel 1600 e nel 1700, ma non mancarono gravi zuffe fra popolani e signorotti prepotenti che sovente sfociarono in scene violente con morti e feriti. Il governo di Roma si trovò a comminare la pena di morte a chi, durante le feste, avrva commesso omicidi. A tutt’oggi il carnevale è presente in molte località con manifesrazioni eterogenee, maschere caratteristiche delle varie città, sfilate di figuranti e carri che ricordano epoche passate importanti. Il tutto accompagnato da ricchi pasti. E’ una festa alimentata da uno spirito affrancatorio, è un gioco che non vuole avere memoria degli avvenimenti negativi dell’anno trascorso, è la coscienza ancestrale dello scorrere della vita dal male al bene desiderato, propiziato, sperato. Quando la risata era una faccenda “artigianale” & Cultura&& Memoria LE EVOLUZIONI DEL SENSO UMORISTICO CONFRONTATE AI REPERTI DELLA SATIRA CHE FU di Stefano Sedino “Il Tavolo Rotto” del 16 febbraio 1946 U no degli effetti deteriori derivanti dall’ingresso della società nell’era catodica, o meglio, nel suo stadio morboso, è il generale appiattimento del senso dello humour. Ne sono prova i cosiddetti “tormentoni”, battute ad effetto che una volta conquistato il gusto popolare si trasformano in martellanti cantilene, piante infestanti allignate sul ciglio della strada della massificazione mediatica contemporanea. Le gag dei comici televisivi diventano un disco rotto che la gente continua a suonare nella convinzione di risultare simpatica, togliendo spazio vitale all’inventiva. C’è un rapporto di reciprocità, se non di subordinazione, tra questo fenomeno e la complessiva standardizzazione culturale prodotta dai media. Assottigliandosi il divario di conoscenze tra le diverse classi sociali (di per sé un’ottima cosa) è progressivamente venuta meno la relativa variabilità linguistica. In realtà, il lessico dell’italiano medio (altra creatura mostruosa delle comunicazioni di massa) corrisponde ad una porzione assai limitata dell’idioma nel suo complesso. aprile - giugno 2010 Oggi non c’è spazio per l’inventiva: la gente ripete a oltranza i “tormentoni” comici sentiti alla tivù, convinta per questo di risultare simpatica 17 Le prime pagine di “Al Giaferr” e del “Fasoulin” Il “Tavolo Rotto” e “Lo zio del Tavolo Rotto” sono la sintesi cartacea di quello spirito goliardico di casa al Caffé Lomellino nell’immediato secondo Dopoguerra 18 Lo si definisce “linguaggio di uso comune” e la tivù ha non poco contribuito a delimitarne i contorni. Parallelamente si è ristretto e conformato anche lo spettro dell’umorismo, che del linguaggio è parente strettissimo. Prima che il piccolo schermo smettesse di essere una macchina meravigliosa, spettacolare in sé e per sé, la ricerca di evasione passava per forme di creatività “personalizzate” e direttamente correlate alle condizioni socio-culturali degli individui. I contadini, dopo una giornata di estenuante lavoro, si ritrovavano nelle stalle per compensare gli sforzi diurni con lo svago dei pruwèrbi, “false friend” del termine “proverbi”, trattandosi quasi esclusivamente di apologhi spassosi: ognuno ci metteva del suo, adattando al proprio quotidiano e guarnendo con fantasia storielle facete trasmesse dalla tradizione orale. L’altro estremo della risata era l’umorismo raffinato delle classi colte, uno humor elitario dotato di un corpus lessicale più ampio di quello popolare. A metà strada si potevano trovare parecchie sfumature. Lo rivelano “reperti archeologici” come “Il Tavolo Rotto” o “Lo zio del Tavolo Rotto”, due pubblicazioni garbatamente satiriche redatte e date alle stampe nella Mortara dell’immediato secondo Dopoguerra, più precisamente nel febbraio e nel novembre del 1946. Queste pagine, oggi ammantate di gusto retrò, sono la traduzione cartacea del clima che si respirava al “Caffé Lomellino”, quartier generale degli sc-ciapatàvul. Il tipo di buon umore proposto è un punto di sintesi tra l’animo bohèmiene degli studenti universitari che frequentavano l’esercizio (tra cui un giovanissimo Giancarlo Costa) e la schietta comicità di provincia. Il registro che ne risulta è un felice impasto di terminologie forbite e sporadiche incursioni vernacolari, in pieno spirito goliardico. Ne “Lo zio del Tavolo Rotto” è inoltre presente una rassegna di I L VA G L I O notizie leggere come piume intitolata “Giro di Mortara”, spazio che tradisce un forte debito d’ispirazione verso il “Candido” di Guareschi e Mosca: l’incipit “Qui a Mortara tutto bene” ricalca il motto “Qui in Italia va tutto bene” con cui l’ideatore dei personaggi di Peppone e Don Camillo era solito iniziare la rubrica “Giro d’Italia”. Si potrebbe obiettare che, alla luce di ciò, allora come oggi i “tormentoni” e i modelli preconfezionati avevano la loro incidenza sul sentire umoristico comune. La differenza sostanziale sta nel fatto che mentre gli stereotipi odierni sono scimmiottati senza esercizio di personalità, i vecchi schemi facevano da impalcatura a libere variazioni sul tema, nel caso specifico rese originali da tratti, per così dire, di genuino sarcasmo territoriale. Tra le peculiarità dei fogli mortaresi si trova la capacità di chiamare in causa, con abili frizzi, i protagonisti della vita cittadina: politici del tempo, intellettuali, macchiette, amici e conoscenti... In questo “Il Tavolo Rotto” si fa erede dell’impostazione di fortunati settimanali dell’area “pavesofona” come il “Fasoulin”, “Ael ramolass”, il “Bagoulin” o “Al Giaferr”, castigamatti dei ghiribizzi delle mode, delle goffaggini popolane e in generale di ogni aspetto risibile dell’ambiente provinciale nei decenni sfavillanti della Belle Époque. Pochissimi gli esempi in questa direzione negli anni a venire. Si è perso il gusto della satira “localizzata”, forse perché si sono ridotte le distanze tra la realtà rurale e quella urbana, e al contempo si è rimpicciolita la gamma dei tipi umani divertenti. Allargando la visuale si può constatare come è la stampa satirica in genere ad essere in declino, confinata sempre più in una nicchia dai codici televisivi. Tuttavia, riflettendoci, il genio dello humour non è affatto scomparso. È solo nascosto dalla torma di replicanti che ne emulano le brillanti trovate. & Cultura&& Musica La gioia è il principio della vita LA FORZA CREATRICE E LA PORTATA CREATIVA DELLO STATO D’ANIMO PIÙ LEGGERO L di Alessandro Marangoni a gioia è il principio della speranza! La gioia è il canto della terra! La gioia è la musica del cielo! Quante volte nell’arte abbiamo sentito, visto o assaporato la manifestazione della gioia, attraverso un dipinto, una scultura, una sinfonia, un piatto di pasta al sugo: è lo stato d’animo per eccellenza che crea, fa scaturire, porta avanti, fa camminare, progettare, inebriare. E’ la spinta che forse convinse Colui che fece il mondo a non essere più solo, a mettere da parte il nulla e a dare inizio a tutte le cose. Anche nella musica essa è spesso il principio che fa tacere il silenzio e incominciare una linea melodica o un concatenarsi di armonie: basti sentire ad esempio qualsiasi coro dal Messiah di Händel o il celeberrimo Joy to the world per rendersi conto di quanto la musica da un lato sia originata da questo sentimento e dall’altro, invece, quanto essa stessa possa trasmetterlo in chi ha fortuna di ascoltarla o di eseguirla. L’atto dell’ascolto è infatti un momento di grande gioia; anzi, molto di più: è il momento nell’esistenza quotidiana in cui maggiormente si prova tale stato d’animo, un attimo o un tempo prolungato – se si ha particolare fortuna – in cui l’anima è ricolma di sovrabbondanza. Anche nelle grandi avversità, nei momenti di depressione, in cui ci si accanisce contro se stessi e contro il mondo, i grandi animi sanno e osano gioire, come nel caso di Beethoven, che passa dallo struggimento nero del “testamento di Heiligenstad”, al finale glorioso della Nona Sinfonia, diventato uno dei brani più famosi della storia, conosciuto da tutti come l’Inno alla gioia (su testo di Schiller) ed adottato come inno e simbolo dell’Europa. Anche nelle forme religio- Friedrich Schiller (1759 - 1805), autore del testo dell’Inno alla gioia se primordiali l’importanza della musica era centrale, insieme all’idea che essa fosse un veicolo potente di una forza, fino ai nostri tempi in cui è vista come strumento di eccitazione o di “sballo” (come nel rock ad esempio), capace di modificare gli stati d’animo anche grazie all’alternarsi di specifiche tonalità (maggiori, minori e così via). aprile - giugno 2010 Nelle forme religiose primordiali l’importanza della musica era centrale, insieme all’idea che fosse un veicolo capace di pilotare le emozioni 19 Conoscendo e apprezzando quanto nei secoli è stato prodotto in musica ma in generale in ogni forma di arte, sembra quasi che nell’epoca contemporanea (e con questo termine intendo il tempo in cui noi siamo viventi) si sia smarrito questo principio eccitante della vita, la gioia appunto. Sempre più frequentemente nelle giovani generazioni esiste un muro inibitore oppure un’ignoranza (più o meno volontaria) di tutto ciò che fa nascere la gioia: la quotidianità si rattrappisce sotto un velo che ci fa ombra, senza riuscire a comprenderne il perché fino in fondo, in modo spesso misterioso e inaspettato. E’ questo il tramonto dell’Occidente di cui parlava Spengler? O forse questa luce fioca appartiene solo a una sfortunata élite? Talvolta occorre osare e stare vicino a quelle cose che ci trasmettono quella gioia di cui abbiamo parlato finora. Un appello: ministri, amministratori pubblici, docenti di ogni rango, pensatori, uomini tutti “di buona volontà”, sarà forse la “Grande Musica” la soluzione che porterà la gioia? Ludwig van Beethoven e il frontespizio della Nona sinfonia Sempre più frequentemente nelle giovani generazioni esiste un muro inibitore, oppure un’ignoranza, di tutto ciò che fa nascere la gioia 20 I L VA G L I O Fermare il tempo L’INESORABILE FLUIRE DEI SECONDI.... SFUGGE ANCHE ALLE MANIERE FORTI S di Simone Menicacci draiato sul divano, lungo e stravaccato, con gambe e braccia posizionate da sembrare, usando un po’ di fantasia, la disposizione dei rami d’un olmo durante la stagione invernale, osservava, ancora intorpidito dal riposo pomeridiano, l’assoluta immobilità delle cose che lo circondava. Pareva tutto fosse inerte, statico, sprovvisto di iniziativa verso una qualsiasi sorta di movimento trasversale o laterale che potesse essere, né tanto meno obliquo o millesimale. Comprese le sue stesse funzioni cerebrali assolutamente coerenti con lo stato di immobilità collettiva. Solo un minuscolo oggetto, apparentemente innocuo, all’interno del micro universo quale era la stanza dove si trovava, con insolenza infastidiva la comune pigrizia che aleggiava soffice nell’aria: la lancetta dei secondi. Lei si muoveva con un fare a dir poco irritante e nevrotico, e le altre due, quella dei minuti e delle ore, sembravano contraddirla, rinnegarla, anche se, grazie ai disegni sul disco dell’orologio, ci si poteva accorgere usando un po’ di pazienza dei loro millimetrici spostamenti. Specialmente per quella dei minuti, che cercava di non farsi notare così spudoratamente come invece faceva la sorella più alta e secca. «Ad ogni passo di quella maledetta, un infinitesimo deterioramento in ogni atomo di un oggetto qualsiasi − pensava − anche ogni singola mia cellula sprecherà quel briciolo quasi invisibile di energia, stancandola verso un inesorabile processo d’invecchiamento». Pareva proprio non stargli bene questa irremovibile legge della natura. Ci sono questioni che per quanto noi ci si possa sforzare, non c’è verso di cambiare, nemmeno minimamente, possiamo scordarcelo. Ma lui, no. Non aveva intenzione di rassegnarsi a questa sconfitta senza provare almeno un tentativo. Si alzò lentamente, prima a sedersi, poi in piedi, con lo sguardo di sfida fisso sul marchingegno. Si avvicinò & Cultura&& Riflessioni “La persistenza della memoria”, Salvador Dalì (1931) a lui puntandolo col dito indice, come solo saprebbe fare un pazzo degenerato. Mirò una zona qualsiasi della sua superficie ed avanzò fino a toccarla con la punta del dito, approfittando dell’assenza di coperture che avrebbero protetto il movimento delle lancette. Aspettò, pazientemente, mentre un briciolo di cinismo gli storceva l’angolo della bocca, disegnando un ghigno quasi perfido ad attendere che la lancetta sbattesse contro il dito, sicuramente più forte del meccanismo che la faceva girare. E cosi fu. «Ecco, e adesso?» Certo era consapevole che quel gesto avesse del surreale. Sentiva la meccanica premere ripetutamente a scatti contro la carne e ciò gli infondeva una profonda soddisfazione, tanto da alleviare ogni pensiero negativo che di solito lo accompagna ai risvegli. La lancetta si sfiancava invano con tutte le sue forze per proseguire ciò che era stato presumibilmente interrotto: lo scorrere del tempo. Ad un tratto si ricordò, non seppe come, che avrebbe dovuto prendere il bus delle sedici e trentacinque che passava puntuale ogni giorno davanti casa sua. L’orologio era fermo e immobile sulle 4 e 32 circa. «Ma cosa stavo facendo?», pensò confuso, «Ah, sì! Ero già vestito e pronto per andare a sbrigare delle commissioni in città che mi sono proprio assopito sul divano. E’ un miracolo che mi sia svegliato giusto giusto per prendere il bus. Che tempismo!», ragionò con soddisfazione, «Saranno passati poco più di due minuti da quando ho bloccato l’orologio». E pigiò ulteriormente col dito quasi facendo flettere la superficie del cerchio. Indugiò ancora qualche minuto scrutando fuori dalla finestra. «Mah… ora saranno passati almeno cinque o addirittura sei minuti. Vorrebbe questo forse dire che stia veramente funzionando? Che sia riuscito in qualche maniera a fermare il…t…t…tempo? Ho sempre saputo di essere una persona speciale, ma fino a questo punto… mi sembra un esagerazione!». Guardò ancora fuori sulla strada. Niente. Nessun bus e per giunta non un autoveicolo o un passante che lo disilludesse dalla sua convinzione. Incominciò a preoccuparsi seriamente e a sudare qualche gocciolina. «Saremo almeno al settimo o all’ottavo. E’ impossibile!». Riflettendo su quest’assurda questione e perdendosi in qualche strana congettura, spostò ancora lo sguardo verso la finestra. Un ingombrante lamiera blu riempì in un lampo l’intera visuale della sua finestra, accompagnando il tutto con un rauco rombo di pistoni che saltellavano al minimo. Liberò immediatamente la presa mortale con la quale teneva alle strette il passare dei secondi e, infilatosi le scarpe, cercò le chiavi ed aprì la porta in tutta fretta. Il blu volgare dell’autobus lasciava ora spazio ad un azzurrino sbiadito con tanto di macchiette bianche soffici, e puntini neri lontani che si rincorrevano in evoluzioni curvilinee. Spostò lo sguardo alla sua destra. L’autobus che l’avrebbe portato in città spernacchiava sgarbatamente dalla marmitta nella sua direzione con un non so che di derisione, svignandosela a più non posso. Guardò l’orologio del campanile sopra i tetti delle case. Segnava le 4 e 36 del pomeriggio. «Puntuale come sempre». aprile - giugno 2010 21 & Cultura&& Storielle Le tre damine, frate Cesco e il vescovo PERFINO LA CARITÀ CRISTIANA PUÒ FAR NASCERE SPASSOSI EQUIVOCI L “Davanti a sé si trovò tre donne. Mezze congelate. Che d’impressa gli domandano di entrare. Mica bisognava esser dei geni par capì ch’ieran le tre tapine” 22 di Luigi Balocchi a cena dei frati era giunta al termine. Altro non si doveva che menar le chiappe al calduccio di un letto. Quando a un tratto…«Ma chi la l’è a q’l’ura chì?» Insorge un fraticello. A quell’ora e con quel tempo! Da almen due dì seguitava a nevicare. Sulla piana nostra vasta. Che, se mai aspra pe’ l’intarsio dell’erbe e delle rogge, qualora quarciata di neve dona agli occhi l’incanto di un’interminata levità. Allora tutto tace. Tutt al dròma. Gli uomini arretrano il passo. Si scondono in casa. Terso si spande un silenzio ancestrale. Per tal motivo, l’insolito, insistente, gracchiare del campanello non poteva che stupire i frati di quel convento sperso nella terra di Lomellina. Tra loro, frate Cesco fu il più lesto a sgambettare. Par andà a duer la porta. «Salve!..C’è bisogno di qualcosa?» Davanti a sé si trovò tre donne. Mezze congelate. Che d’impressa gli domandano di entrare. «Prego! Venite pure…». Farfuglia il fraticello. Or che son dentro, la vispa luce su quei musetti, fra Cesco risente in sé, ma di molto aumentato, lo stupore che, appena sverto l’uscio, lo aveva incolto. No. Mica bisognava esser dei geni par capì ch’ieran le tre tapine. Eran ben messe. E di carne generosa. Ecumenica, direi. Tre peripatetiche. Tre damine. Tre di quelle, insomma. E vestite di gran lusso. Qual si conviene a chi la vita se la gioca per la strada. Fra Cesco ha ben capito. Delle tre, la più vistosa parla piano. Una notte! Una sola notte, s’abbia la carità! Per sfuggire al gran gelo di tormenta che fuori impazza. E star lì. Al caldo. In una stanzetta. Del convento. Fra Cesco concede. Ma quella notte, l’insolita presenza di tre damine sotto il tetto, per anni ricetto di uomini I L VA G L I O Espressioni dialettali lomelline di Emanuela Cotta Ramusino In vernacolo si usa molto il paragone, riferito, in prevalenza, alle precipue caratteristiche degli animali e delle cose semplici della natura: • L’è biänc mé ‘l lat. • L’è biänc mé ‘n linsö. • L’è négar mé ‘l carbón. • L’è négar mé la nòt. • L’è giald mé ‘n limón. • L’è russ mé ‘n pivrón. • L’è vérd mé na lüsérta. • L’è vérd mé na föia. • L’è vérd mé i mé sacocc. • Ghè scür mé ‘n buca ‘l lù • L’è bèl mé ‘l su • L’è brüt mé la nòt • L’è bón mé ‘n tòc ad pän • L’è gràm mé ‘l rüd • L’è grass mé ‘n frà • L’è màgar mé n’anciüda • L’è fort mé ‘n tòr • L’è fiàc mé na räna • L’è malà mé ‘l rüd • L’è säc mé j armél • L’è gränd mé ‘l mar • L’è gränd mé na pértia • L’è duls mé la mé • L’è màr mé ‘l tòsi • L’è màr mé la fé • L’è dür mé ‘l mür • L’è mòl mé ‘n fic • L’è fräsc mé na rösa • L’è fürb mé ‘n ràt • L’è fürb mé ‘n gàt • L’è stüpid mé n’ oca • L’è gnuränt mé na cràva • L’è svèlt mé na légura • L’è nuiùs mé na musca • L’è sincér mé l’àcua • L’è fals mé Giüda • L’è siùr mé ‘l màr • L’è lòng mé la quarésma con il frullo della santità, non lo fece granché quietare. Le tre donne, ogni sera, timbravano il cartellino sullo stradone. Sempre lì. Lo stesso posto. Tutte insieme. Una sorta di cooperativa autogestita di servizi. Tra loro c’era chi pensava al grappino per la notte, chi alla legna nel bidone da brusà, chi alla macchina che portava sul luogo d’esercizio. Tutto regolato. Tutto calcolato. Si arrivava. Si praticava. As’turnava a cà. Abituate alla sveltezza, le donne lasciarono il convento appena l’alba. Fu fra Cesco in persona a svigiài. Ma qualcuno aveva visto. Qualcun di fuori. Malalingua di paese. E in breve, per la plaga tutta intorno, d’altro non s’ebbe a parlare… Si sa…Sesso e Religione son fratelli. Di padre e madre separati. Da una parte c’è l’Istinto, dall’altra la Morale. In mezzo, la morbosa curiosità. Sta di fatto che sto pisspiss di voci e vocette non tardò a giungere all’orecchio del vescovo diocesano. Era costui tra quei teologi infelici che spesso si rincagniscono sui mali e sui difetti, con quel gusto assai bizzarro di voler a tutti i costi raddoppiare il peso della croce sulle nostre malmesse spalle ed anzi spendendo ovunque il fardello del peccato. Si dà il caso che, passato qualche mese dal fattaccio, giusto il vescovo dovesse visitar il convento dei fraticelli. Andar per il quale era d’obbligo passar sullo stradone, transitar là dove le damine s’apprestavano al mestiere. A fra Cesco fu dato il compito d’andà a pià il vescovo. Di ciò ne fu lieto. Assai meno allorquando, dovendo tornare al convento con l’illustre passeggero, lo stradone risalì il declivio di un dosso, un alto gonfiore d’erba e gera, sul quale un largo spiazzo vedeva da tempo immemore sorgere un’osteria, posta a sentinella di tre strade. A tutta birra, fra Cesco vi si sta avvicinando. A tutta birra. Nella segreta speranza che le damine, chissà per qual ragione quel giorno giunte al lavoro in anticipo, non procurassero scandalo a pia sua Eccellenza. Che bene pensò, accidenti!, di intimare al fraticello di inserir la marcia bassa, giacché e calma e pacatezza son virtù da coltivare assai. Fra Cesco stortocollo obbedì. Si votò al silenzio. Sebben gli occhi ci vedessero molto bene. Così, ahimè, da schiarirle alla perfezione le tre damine. Sì. Giusto quelle ospitate in convento nella notte di tormenta! Eran lì. Ad attendere. Dapprima ritte sul dosso, non appena apparsa l’auto, si fecero vicinissime alla strada. E una volta riconosciuto il fraticello alla guida, mulinarono e gambe e braccia in vistosa contentezza. Costretto a passo d’uomo dal vispo calore delle nostre graziose che avevano invaso la strada, fra Cesco, russ mé ‘n pivrón, sorride e suda, suda e sorride. La mano abbozza un saluto. Benedice. Fa ciao. Fa segno, per pietà!, di sparire d’impressa dallo stradone. Il vescovo, sitàa da drera, ovvio che sboffi. Miope e avanti negli anni com’è, mica si rende conto che le damine hanno invaso la strada tutte in broda per il gentile fraticello. E sì che ha certo inteso la loro professione. Così da sbottar fuori tra l’iroso e il malmostoso: «Ma insomma, queste prostitute, con chi ce l’hanno? Chi mai stanno salutando?..» Ed è allora che la Grazia, colei che tutto puote e mai prevale, d’un tratto t’illumina appieno fra Cesco. Con un colpo di genio invero raro… «…Ma come, Eccellenza, non l’ha capito? Salutan lei! Salutano il loro amato vescovo!» aprile - giugno 2010 “La tentazione di Sant’Antonio”, Salvador Dalì (1946) “Dapprima ritte sul dosso, non appena apparsa l’auto, si fecero vicinissime alla strada. E una volta riconosciuto il fraticello alla guida, mulinarono e gambe e braccia in contentezza” 23 & Cultura&& Tivù Allegria, signor Mike! M La favola di Mike Bongiorno inizia a New York, passa per Torino, per la Resistenza, per il carcere di San Vittore, ma specialmente per le case e per la vita di tutti gli italiani 24 LE DUE STORIE CHE LEGANO IL RE DEL QUIZ ALLA LOMELLINA di Sandro Passi ike Bongiorno (1924 - 2009) è stato l’ospite d’onore di uno dei più grandi eventi mondani della Mortara dell’altro secolo, nel 1975, ed è il protagonista di un libro a lui dedicato scritto dal lomellino Giorgio Lazzarini nel 2001. Due storie di “mister allegria”, due storie targate Mortara Partiamo con il libro e spieghiamo chi è l’autore. Giorgio Lazzarini (1943 - 2002), abitava (anche, quando il lavoro non lo portava in giro per il mondo) in una cascina appena fuori Mortara in direzione Castello d’Agogna, è stato giornalista nei più famosi settimanali italiani (Oggi, Gente, Sorrisi, Noi). Negli ultimi anni era l’inviato speciale di Chi. Ha realizzato reportage internazionali e incontrato personaggi della scena mondiale, tra i quali Gorbaciov e Arafat. Specializzato sulle famiglie reali europee e su Mike. Ha ricoperto il ruolo di “signor no” nell’edizione di Superflash dell’84/85. Nel 2001 pubblica la biografia non autorizzata “Il signor Mike – Un’intervista durata 25 anni” per la casa editrice Frontiera. “Biografia non autorizzata” in gergo non significa una cosa fuori legge, Bongiorno ne era perfettamente a conoscenza e gradiva, solo che non aveva firmato qualcosa del tipo “ti ho chiesto io di farla”, in funzione probabilmente del fatto che dopo poco ne ha scritta una lui stesso, su se stesso, per Mondadori. La favola (dolce-amara) di Michael Nicholas Bongiorno inizia a New York, passa per Torino, per la Resistenza italiana, per il carcere di San Vittore, ma specialmente passa per le case e per la vita di tutti gli italiani e nessuno meglio del suo amico Giorgio Lazzarini poteva raccontarla. Il libro venne presentato anche nella città dell’autore, a Mortara, alla libreria Mirella, il 6 maggio del 2001. Giorgio Lazzarini fino alla fine dei suoi giorni, quando un male che non perdona se lo portò via, mantenne un contatto con Mortara facendo ogni mercoledì mattina il collegamento telefonico dalla redazione di “Chi” con la radio locale (radio RTM Mortara) per I L VA G L I O La copertina del libro di Giorgio Lazzarini dare le anticipazioni di quello che aveva in pagina il settimanale in quel determinato numero. Un lusso per una piccola radio di provincia, una cosa che succede solo nei grossi network, un regalo di un amico legato comunque alla sua terra. Adesso lo spettacolo e il suo grande protagonista. Sagra del Salame d’Oca 1975, edizione numero nove, trentacinque anni fa. Sicuramente il nome di Mike Bongiorno tra i tanti ospiti passati per il Settembre mortarese è stato quello più vip e certamente quello fu l’evento più chic tra gli appuntamenti nei vari cartelloni in oltre quarant’anni di Sagra. Era domenica 28 settembre 1975, ore 22, in chiusura della nona Sagra del Salme d’oca “sfilata di alta moda della Pellicceria Annabella di Pavia allo Spazio dei Fratelli Bottazzi. Conduce Mike Bongiorno”. Il negozio dei Bottazzi era un nuovo, avveniristico, mobilificio appena aperto all’angolo tra contrada di Loreto e via Ciro Pollini. Per lanciare l’attività, i Bottazzi hanno pensato in grande puntando su una serata che mai prima si era vista e mai poi fu eguagliata. L’ingresso era gratuito, ma per poter assistere alla sfilata bisognava andare in negozio (molti giorni prima) e richiedere gli inviti numerati e nominali. Prevedibile il tutto esaurito nel giro di una manciata di ore. Una platea con tutta la Mortara che contava, soddisfattissima di essere protagonista in una cerchia comunque ristretta, e i mobilieri che avevano fatto centro con il loro grande evento pubblicitario. C’era Giuliano Ravizza in persona, le pellicce (e le modelle), c’era Mike adorato dal pubblico, come sempre d’altronde. Quella sera, quando cenò al ristorante Bottala, prima dello spettacolo, Mike teneva sul tavolo un pacco di cartoline con la sua fotografia. Una piccola processione di fan entrava timidamente nel locale, i Baletti (il “signor” Siro e la “signora” Lidia, come li chiamavano tutti, gli storici titolari dell’albergo) permettevano loro, specialmente ai bambini, di avvicinarsi al privé. Lui autografava col pennarello nero la foto e ci scriveva sopra la sua solita frase: «Allegria!». Uno di quei bambini oggi ha scritto questo pezzo. Mike Bongiorno a Mortara con Giuliano Ravizza e i fratelli Bottazzi La prima pagina della Domenica del Corriere del 21 ottobre 1956 aprile - giugno 2010 In occasione della nona Sagra del Salame d’Oca, trentacinque anni fa, “mister allegria” raggiunse Mortara in qualità di ospite d’onore. Tutta la città partecipò all’evento 25 XLIV Premio Nazionale di Poesia “Città di Mortara” REGOLAMENTO 1 I poeti partecipanti dovranno inviare due poesie, ognuna che non superi i 50 versi, in 4 copie dattiloscritte. 2 Al premio non sono ammessi i vincitori dei primi premi delle ultime tre edizioni. 3 Tutte le opere dovranno indicare le generalità degli autori, eventuali email e dovranno essere inviate entro il 5 luglio 2010 a: Circolo Culturale Lomellino Via XX Settembre 70, 27036 MORTARA (PV) - Tel/Fax 0384 91249 allegando Euro 10,00 per spese di Segreteria. 4 Il Premio si articola in 3 sezioni: Poesia a tema libero Primo classificato Euro 500,00 e scultura d’autore Secondo classificato € 250,00 e medaglia d’oro Terzo classificato € 150,00 e targa Poesia in Vernacolo Lomellino Primo classificato Euro 300,00 e Medaglia d’oro Secondo e terzo classificato: Targa Poesia sulla Lomellina Premio Giancarlo Costa Primo classificato Euro 300,00 Medaglia di conio speciale Secondo e terzo classificato: Targa Verranno inoltre conferiti premi speciali, consistenti in medaglie conio d’autore. 5 I premi verranno assegnati a giudizio insindacabile della Giuria, la cui composizione verrà resa nota durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo a Mortara, venerdì 24 settembre 2010 alle ore 21, nel corso di una pubblica manifestazione, in concomitanza con la Sagra del Salame d’oca. Tutti i concorrenti sono invitati sin d’ora. 6 I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione. I premi in denaro di ogni sezione dovranno essere ritirati dagli interessati al momento della premiazione, pena il decadimento del diritto al premio; per quelli speciali, in casi eccezionali, è tuttavia consentito il ritiro del premio da parte di altra persona, purchè presenti delega del vincitore. Tutti i premi non ritirati personalmente o per delega, non verranno inviati e resteranno a disposizione del Circolo Culturale. 7 L’invito alla premiazione non dà diritto al rimborso delle spese di viaggio, soggiorno, eccetera 8 Il Circolo Culturale Lomellino avviserà per tempo i premiati, personalmente o con lettera raccomandata, comunicando il luogo dove si terrà la manifestazione; dell’esito del concorso sarà comunque data notizia alla stampa e sul nostro sito: www.circoloculturalelomellino.it 9 Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati. L’organizzazione non assume responsabilità per eventuali deprecabili plagi. 10 Gli elaborati non verranno restituiti e la partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 11 Eventuali modifiche del presente regolamento potranno essere attuate dall’organizzazione in relazione a situazioni contingenti 12 Sarà escluso dal concorso chi non osserverà le norme sopra riportate. I dati personali trattati sono tutelati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy CARICATURE E RITRATTI DI DON GIOVANNI ZORZOLI TRIMESTRALE DEL CIRCOLO CULTURALE LOMELLINO GIANCARLO COSTA RIVISTA DI CULTURA, STORIA E TRADIZIONI Anno 6 - Numero 2 Aprile - Giugno 2010 Reg. Trib. di Vigevano n. 158/05 Reg. Vol. - n. 1/05 Reg. Periodici Direttore responsabile Marta Costa Elenco speciale Albo professionale dei Giornalisti di Milano Coordinamento Sandro Passi Wolfgang Amadeus Mozart (1977) Albert Einstein (2007) Hanno collaborato a questo numero Luigi Balocchi Graziella Bazzan Emanuela Cotta Ramusino Umberto De Agostino Nadia Farinelli Maria Forni Alessandro Marangoni Eufemia Marchis Magliano Simone Menicacci Stefano Sedino (La collaborazione è a titolo gratuito) In copertina don Giovanni Zorzoli acquarello e tecnica mista su cartoncino (2010) Fryderyk Chopin (2007) Autoritratto (1974) Editore Circolo Culturale Lomellino Giancarlo Costa via XX Settembre, 70 - 27036 Mortara (PV) Coordinamento editoriale Alberto Paglino Realizzazione grafica & Impaginazione PromoPavese comunicazione by LogosMedia srl Info: 0382.800765 - [email protected] Stampa La Terra Promessa Via E.Fermi, 24 28100 Novara INFO: 0384.91249 Gioachino Rossini (2007) Giuseppe Verdi (2007) AGENZIA COSTA Studio di consulenza automobilistica Via XX Settembre, 70 - 27036 MORTARA Telefono e fax 0384.91249 Delegazione ACI Garlasco Piazza Repubblica, 25/26 Telefono 0382.810053 Editoria•Public Relations•Graphic Design•Marketing•Agenzia Pubblicitaria•Organizzazione Eventi Editoria•Public Relations•Graphic Design•Marketing•Agenzia Pubblicitaria•Organizzazione Eventi Vicolo del Forno, 12 - Garlasco (Pavia) • T 0382.800765 • [email protected] - www.logosmedia.it
Scaricare