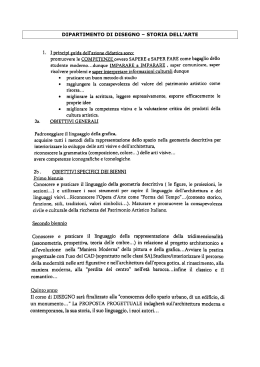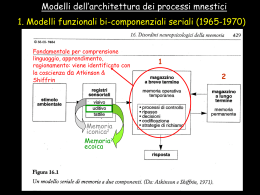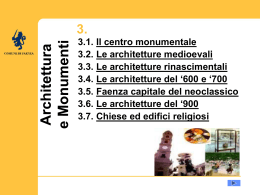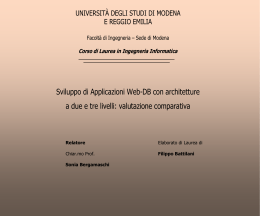Molto si parla e si è parlato di una sostanziale idiosincrasia tra l’architettura contemporanea e la gente. L'idea qui proposta non è certo nuova ma, a mio parere, ben si adatta a stimolare un confronto sul tema della architetture a forma curvilinea e sul rapporto che tali modelli possono avere sia nella concretezza costruttiva che nella didattica. In tal senso la questione centrale è identificare un modo mediante il quale l’adesione ad un idea di architettura sia esplicita e manifesta. L’urgenza di tale questione è da ricercarsi in un sempre maggiore ricorso a “previsioni digitali” che per propria natura non ammettono giudizi di natura analogica delle qualità che il progetto esprime. Claudio Umberto Comi Pongo architetture gnoseologia delle architetture freeform Claudio Umberto Comi (1960) è architetto e ricercatore universitario e si occupa di disegno del paesaggio e di architettura. E’ autore di numerosi libri tra cui: lezioni zen (1998); sul paesaggio (2001) la pratica del modello (2008), spazio, tempo e città (2009), e, quaderno di rappresentazione (in stampa). OPINIONI MINUTE Claudio Umberto Comi Pongo architetture gnoseologia delle architetture freeform Indice “non voglio abitare in una lattina schiacciata” 9 Lego e pongo 15 Il problema del nome 33 La percezione dell’architettura contemporanea 45 Forme dell’architettura 61 “Gli uomini che hanno una tempestosa vita interiore e non cercano sfogo o nei discorsi o nella scrittura, sono semplicemente uomini che non hanno una tempestosa vita interiore.” Da: “il mestiere di vivere” di Cesare Pavese Oggi, più che mai nel passato, la comunità scientifica s’interroga sul valore effettivo di una “pubblicazione”. In un impeto di trasparenza, finalmente anche in Italia, si chiede alla scienza di mettersi “in rete”1. Per alcune materie vi sono riviste affermate e riconosciute nel mondo che ogni, tanto accade, prendono anche una svista2. Per altre, forse figlie di un Dio minore, non c’è È allo studio un sistema di pubblicazione online, sul web, della produzione scientifica di ogni singolo docente. 1 2 Jacques Benveniste e l’articolo sulla ”memoria dell’acqua” (Human basophil degranulation triggered by verydilute antiserum against IgE), pubblicato su Nature, n.333, 1988, pp. 816-818) del quale lo stesso direttore della rivista in numero successivo diede smentita. 5 rivista che valga. Vi sono dei temi di cui non parla nessuno. Anche coloro che li approfondiscono, ormai, parlano poco tra loro. E il dibattito langue. Succede anche per l’architettura che continua a “cambiare la pelle”3. Si vede che quello che c’era da dire sì e detto. Oggi guardiamo tutti stupiti “il nuovo” che viene da fuori. Non so dire se sia un’idea provinciale. So soltanto che bisogna buttare un sasso nell’acqua che stagna e vedere se succede qualcosa. Questo libretto, probabilmente non avrà mai un impact factor4 elevato. Non ci tiene Aldo Castellano, “l’architettura cambia pelle”, L’Arca, n. 227 3 O, fattore di impatto. È la misura della frequenza delle citazioni che un articolo o in testo scientifico riceve. 4 6 nemmeno. Ha ambizioni davvero modeste. Si accontenta di innescare una qualche reazione. Sempre che qualcuno lo compri e dopo averlo sfogliato abbia qualcosa da dire. E’ solo il primo di un’idea che costerà davvero fatica5. Riprodurre “i millelire”6, adeguando il valore alla moneta europea, non è certo un idea originale. La vera idea sta nel offrire un spazio a “opinioni minute”. Cioè i pensieri che tutti facciamo e che Nel convincere un editore ad aprire una collana foriera di modesti guadagni e un grosso lavoro editoriale. 5 Collana proposta dal 1989 dalla casa editrice Stampa Alternativa che consisteva in libretti in formato 10x15 rilegati a sella di un determinato numero di quartini 6 7 non trovano spazio in un libro destinato a far avanzare la scienza. Qualcuno potrebbe obbiettare che la rete offre mille occasioni per esprimere idee, dialogare, animare il confronto. La realtà è che nella rete non trovi mai niente di davvero nuovo. Trovi si, infiniti pensieri, ma se li vuoi approfondire o per poterli obbiettare devi aprire anche tu il tuo blog. 8 “non voglio abitare in una latina schiacciata” Da quando un amico, che non si occupa di architettura, mi ha chiesto perché gli architetti da qualche anno a questa parte hanno cominciato a flettere, curvare, “spiegazzare” le loro costruzioni, ho cominciato a pensare in un modo diverso alle apparenti fascinazioni che tale tipo di architetture determinano. Per rispondere, così su due piedi, non ho trovato di meglio che dire che ciò accade perché il computer permette di esplorare nuovi “valori plastici” e quindi reinterpretare un interesse alla sinuosità della forma che, 9 partendo dal gotico ed ancora nel periodo barocco ha comunque attraversato anche parte dell’architettura del ‘900. La sua replica, a dire il vero laconica, è stata: sarà, ma a me non va di abitare in una “lattina schiacciata” e la cosa è finita li. Ripensando a tale scambio di battute, mi è venuto però il sospetto che forse solo tra gli architetti vi sia una consapevolezza, a dire il vero molto autoreferenziale, sulle ragioni per le quali legittimare un approccio alla costruzione che intende privilegiare valenze iconiche spesso prevalenti sulla funzione a cui la costruzione dovrebbe rispondere. Considerato che, in un certo qual senso, tali aspetti esteriori finiscono con il penalizzare le ragionevoli aspettative di coloro che di tali abitazioni o spazi vorrebbero sem10 plicemente fruirne. Per scacciare questo pensiero, ho quindi provato a ripercorrere mentalmente il complesso e confuso scenario di un architettura a cui ancora oggi è difficile dare un nome. Ed proprio pensando al problema del nome, inteso come possibile categoria a cui iscrivere episodi diversi per presupposti, metodiche di concezione e risultati, che sarebbe opportuno definirla “architettura nominalista”. Ovvero un architettura in cui il carattere prevalente, oltre alla stravaganza delle forme, è il nome che il progettista vi associa. Per la gente comune, l’architettura di Gehry, equivale a quella di Fuksas, quella di Ben Van Berg a quella di Eisesman, quella di Meier a quella di Forster, quella della Hadid a quella di coop Himmelbau. Le 11 differenze se vi sono, e vengono percepite, sono solitamente riconducibili alla relazione con il contesto in alcuni casi e, nella suggestione mediatica che tali edifici intendono affrancare, negli altri. La natura intrinseca di tali architetture agli occhi della gente comune è quella di affermare, al pari delle griffe più trasgressive della moda, un fenomeno che direi di costume. Quasi che l’intenzione, nemmeno troppo velata di tali progetti, sia conseguenza di un prevalente bisogno di apparire e non come normalmente ci si aspetta dall’architettura di rispondere ad un insieme di bisogni reali. Ponendo poi la questione dell’”abitare” una “lattina schiacciata” ad altri architetti, le risposte hanno finito con il delineare uno scenario che, seppur con i dovuti di12 stinguo, non sa o non riesce a dare risposte. Le chiavi di interpretazione, in funzione del carattere di ognuno tra gli interlocutori, non giungono mai a giudizi compiuti e pongono in luce, con i dovuti distinguo, alcune perplessità: ora sulla forma, ora sulla funzionalità, ora sul senso stesso del progetto. D’altro canto si sa che gli architetti sono una specie in cui la critica sul lavoro degli altri, spesso gratuita e molto argomentata, è una specie di malattia esantematica, che fa il paio con l’innata propensione a sovrapporre riferimenti e citazioni di dubbia coerenza sui propri progetti. Per chiudere il cerchio e vederci più chiaro non mi restava che interpellare i miei studenti. Trattandosi di studenti di architettura uno si aspetta che essi mostrino quantomeno 13 un interesse, se non una conoscenza compiuta, verso alcune di tali architetture a loro coetanee. Bene, in merito alla conoscenza molte della architetture che affastellano il contemporaneo sono per loro entità sconosciute, o realtà metafisiche. Come metafisici alla fine risultano i giudizi, spesso frutto di malintese interiorizzazioni di esegesi che imperversano in rete7. Messi poi alle strette sull’ambizione di abitare in una “lattina schiacciata” emerge, come in molti dei loro progetti, un’affezione verso modelli abitativi più prossimi alle “villettopoli”. Il web pullula di siti, blog, pagine e quant’altro che trattano di tali architetture 14 7 Lego e Pongo Mi sono poi chiesto se tali architetture abbiano invece una strana ragione. L’ho trovata nei giochi che facevamo quando si era bambini. Esiste una sottile differenza tra il Lego e il Pongo ma, non ha tutti è dato di conoscerla. Vi starete chiedendo quale importanza possa avere scoprire le differenze tra questi due giochi. Ebbene chi avrà la compiacenza di seguirmi arriverà forse a capirla. Per chi non avrà costanza e attenzione, spero che comunque questo tornare indietro nel tempo li possa aiutare a comprendere i fatti e gli eventi che hanno segnato il divenire di 15 quest’ultima metà del secolo. Per i più giovani, o per coloro che non sono mai stati in Danimarca e quindi non hanno avuto il piacere di visitare Legoland8, cercherò di sintetizzare quello che il Lego, una filosofia di vita prima che un gioco, ha rappresentato per una generazione che si appresta oggi ad affrontare la boa dei cinquant’anni. Il Lego si presentò timidamente nei primi anni della nostra vita. Di solito veniva regalato in confezioni che, in base alle disponibilità economiche del donatore, potevano spaziare da scatolette in plastica di cui il coperchio era una piastra grigia che sarebbe servita quale Parco di divertimento tematico costruito dall’ azienda Lego in Danimarca. 16 8 base per la costruzione, a ricche cassette in legno con diversi scomparti in cui riporre, per i più ordinati, i vari mattoncini divisi per dimensione, forma e colore. Quello del riporre con ordine era a, dire il vero, un esercizio maieutico di ordine logico propedeutico ad un ordinata tenuta del progressivo affastellarsi di cose che ha caratterizzato la maturità della società dei consumi. Evoluzione di cui il Pongo di cui diremo più avanti é stata la prima avvisaglia. Il Lego sin dalla sua apparizione, forse inconsciamente, si apprestava a soppiantare il successo del Meccano. Quel gioco che consentiva di costruire automobiline, gru, aeroplani e cinematismi, unendo pezzetti di lamiera forata e verniciata con viti e dadini. Credo che buona parte del successo del Lego, 17 sia dovuta a quello che oggi verrebbe definito come un ampliamento del “target” dei consumatori. Con il Meccano potevano giocare solo i bambini più grandicelli. Tante ragioni comportavano per il Meccano una specie di handicap. In primo luogo un oggettiva complessità della logica costruttiva. Un limite invalicabile per un bimbo nato negli nato nel ‘60 che sin dalla più tenera infanzia si addormentava al suono di un carillon con le api che girano. Un altro fattore era il potenziale pericolo dovuto alla lamiera e un elevato fattore di rischio di ingestione di viti e bulloni. A differenza del Meccano, il Lego poteva andare in mano anche a bambini di quattro o cinque anni dato che, per la felice intuizione posta alla base dell'idea ispiratrice, i matton18 cini non comportavano alcuna difficoltà di logica costruttiva. Al più i risultati erano scadenti ma con il tempo e la pratica sarebbero in ogni caso arrivati. Dal punto di vista del pericolo la plastica che li costituiva difficilmente si sarebbe rotta e quindi il pericolo di ferirsi era minimo. Mentre per il pericolo di ingerimento il rischio continuava ad esistere, ma questa generazione dimostrava in modo sufficientemente generalizzato una scarsa propensione al cibo, figurarsi se ci saremmo mangiati dei blocchetti di plastica. Il Lego deve parte del suo successo al fatto che si fonda su di una formula di prefabbricazione aperta e consumo “end-user”, ovvero un sistema di sviluppo che prevede il progressivo ampliamento delle possibilità di gioco. Una logica 19 questa, in parte mutuata dal Meccano, con la differenza però che nel caso del Lego, almeno nelle prime versioni, ogni elemento era perfettamente omologo a quelli già posseduti. Rispetto a tutti gli altri giochi che in seguito con formule più ho meno riuscite cercarono di imitare questo principio, solo il Lego riscosse un grande successo perché chi con cento mattoncini riusciva a costruire una casetta quando avesse raggiunto i mille poteva alternativamente in base alle propensioni sociali e culturali costruire un falansterio o un castello. Qualche anno dopo arrivò anche il Pongo, una pasta modellabile in vari colori. Anche questo gioco, consentiva in base alla quantità di materiale posseduto di realizzare varie cose, ma a differenza del Lego, anche con 20 un quintale di Pongo ed anni di pratica e con complessi calcoli strutturali per l’armatura strutturale in filo di ferro, non saresti mai riuscito a costruire un castello. Questa breve digressione mette in luce solo un aspetto peraltro marginale delle differenze tra i due giochi e si è resa necessaria per approfondire la genialità sottintesa alla concezione del Lego. Fulcro del sistema del Lego era il mattoncino “modulo oggetto”9 che determinava in modo proporzionale la passione per il gioco e la classe sociale di appartenenza. Ogni bambino aveva comunque del Lego, i più ricchi 9 C.G.Argan , “Progetto e oggetto”, Medusa Edizioni, Milano 2003, già nella rivista “La Casa”-Quaderni di architettura e di critica, n.2 , 1958. 21 con il loro patrimonio personale potevano realizzare a casa loro ciò che meglio credevano. I più poveri con il loro misero sacchetto di mattoncini solo “qualcosa”. Però mettendo insieme ad altri bambini, poveri, i loro mattoncini e sfruttando le doti creative e logiche del gruppo, si riusciva a realizzare costruzioni ancora più ricche e belle di quelle degli spocchiosi bambini ricchi. Quest'ultimi, se non ricadevano nella infamante categoria di coloro “che non sentono la loro puzza, perché non hanno il naso”, spesso umiliati da questo schiacciante confronto, supplicavano per qualche giorno di essere ammessi nel gruppo ed una volta accolti, ponevano il loro ingente patrimonio di mattoncini a disposizione della collettività. Questa specie di as22 sociazione in partecipazione senza fine di lucro, era possibile per un motivo molto semplice. I mattoncini del Lego erano tutti uguali, al più cambiava il colore, quindi una volta che sapevi quanti ne avevi portati, smontata la costruzione ognuno si riprendeva i suoi e tornava a casa felice. Viceversa, nessuno che ebbe la sventura di mettere in comunione con gli altri la propria quota di Pongo ebbe mai il piacere di riprenderselo. Altro non fosse perché nemmeno con una bilancia di precisione ed uno spettrofotometro saresti stato in grado di determinare quanto e di quale colore fosse stata la tua parte di Pongo. Credo che quelle esperienze di gioco abbiano avuto una ricaduta sul futuro professionale di molti ed anche di alcuni architetti. Un altro a23 spetto fondamentale del gioco del Lego era legato alla quasi totale mancanza di fatica per praticarlo. In primo luogo si trattava di un gioco sedentario, dato che si giocava seduti per terra e quindi consentiva la pratica anche ai bambini gracilini che spesso lo prediligevano ad altri giochi più pericolosi e quindi per loro proibiti. Poi era un gioco pratico e pulito dato che l'incastro era facile, sicuro e sembrava perfetto. Lo smontaggio era altrettanto veloce, tanto che con un pugno o buttando per terra, la costruzione si scomponeva in tanti tronconi che poi facilmente avresti suddiviso per mattoncini riponendoli nella loro confezione se eri di indole ordinato. Se già mostravi una propensione per il disordine e alla mancanza di regole, 24 buttavi invece tutto dentro la scatola e poi la volta dopo smontavi man mano per ricostruire. Questo aspetto lo differenziava sia dal meccano, che comportava una lenta procedura di montaggio, avvita, avvita, avvita e, se sbagli, svita e ri-avvita, ed una identica operazione per lo smontaggio. Sarà per questo che qualcuno un po’ più grandicello si convertì ben presto al Lego ed anche dal Pongo. Un gioco che per propria natura non consentiva alcuno smontaggio e troppo spesso ti costringeva a trasformare la tua creazione in una massa informe di un colore marroncino striato di venature variopinte. A qualcuno sorgerà legittima una domanda: - tutto questo a me cosa importa? Lascerò che sia il Lego a rispondevi. Dato che, pur senza parla25 re, il Lego era in grado di dare risposte a quasi tutti i quesiti della vita di noi bambini. Il primo quesito che però durava molto poco consisteva nel capire perché ti avevano regalato il Lego. Tu solitamente non lo avevi chiesto, allora non c'era la pubblicità nella tv dei ragazzi e i giocattoli nemmeno nel “Carosello” trovano posto. Quindi come avevano fatto a pensare al Lego? Chi ti regalava il Lego aveva solitamente giocato con il Meccano ma, essendo ormai un adulto e perciò, responsabile, vedeva nei bulloncini un oggettivo pericolo. Poi, quelli del Lego erano persone corrette dato che, in base alla disponibilità di mattoncini della confezione, mettevano sulla scatola solo immagini di cose realizzabili. Non voglio pensare alla frustrazione che a26 vremmo provato se più furbescamente avessero applicato un metodo diventato di moda qualche anno più avanti e non solo nei giochi. Cioè il trucco di farti vedere cose impossibili da realizzare perche ti mancava sempre qualche pezzo. Da questo punto di vista l’unico problema era come fare a realizzare quelle costruzioni. Uno cominciava a provarci. Solitamente, dato che nessuno "nasce imparato10", non ci riusciva, quindi smontava tutto e ricominciava e così via sino a quando non raggiungeva il risultato. La capacità di ricominciare da capo per imparare a fare qualcosa è una peculiarità dei 10 Titolo del libro di Camillo Albanese su Napoli. 27 bambini che hanno giocato con il Lego. Già alcuni miei amici che ci hanno giocato molto meno, quando qualcosa non gli riesce prendono e buttano via tutto. Quelli nati dopo, che ho avuto modo di avere come studenti, se non trovavano scritto come fare, non iniziano neanche a giocare. Un altra domanda consisteva nell'ipotizzare le possibilità di sviluppo e quindi stimare il fabbisogno di mattoncini per realizzare costruzioni sempre più belle e più grandi. Questo esercizio comportava una oculata strategia per fare in modo di ricevere in regalo in ogni occasione altri mattoncini. Raggiungere questo obiettivo presupponeva l'obbligo di dimostrare una smodata passione per questo gioco affinché i grandi percepissero con chiarezza e precisio28 ne che ogni investimento per nuovi mattoncini sarebbe stato un regalo gradito. Poi si passava ad una azione di coinvolgimento dei genitori nel gioco con lo scopo, nemmeno troppo celato, di sviluppare in loro un certo interesse e la comprensione del problema. Solitamente queste due azioni bastavano e per far si che al compleanno o a Natale arrivassero nuovi mattoncini. Se l'operazione falliva potevi sperare che un amico più grande, in un impeto di generosità ti regalasse la sua dote di mattoncini. Perché il Lego diventava così intrigante? In primo luogo perché era in prevalenza una sfida con te stesso. Una specie di gara di cui tu solo scrivevi le regole, davi gli ordini, sceglievi le mosse e giudicavi se il risultato fosse degno di essere mostrato ai 29 grandi. E già in questo c'è l'essenza di una metodologia che partendo dal progetto deve portare al risultato comportando inoltre una adeguata dose di autocritica anche perché se il risultato non era un gran che quando lo mostravi ai grandi quel “bravo” detto a mezza voce e con tono di sufficienza era peggio di un sincero: "che schifo" e quindi preferivi evitarlo. Quale conseguenza di questo primo aspetto c'era il fatto che il risultato aveva una vita molto breve, dato che si sarebbe dovuto smontare in fretta per recuperare i mattoncini per qualche nuova realizzazione. Questo aspetto ci ha insegnato che il conseguimento di ogni risultato vale in quanto tale e salvo poche ed eccezionali realizzazioni la durata di ogni sforzo e commisura30 ta al bisogno di raggiungere nuovi risultati. Vi starete chiedendo tutto questo cosa possa centrare con le architetture di oggi? Le certezze del Lego erano espressione compiuta di un pensiero positivista. L’informale che il Pongo introduce sono le premesse di una relatività ormai pervasiva. Di fronte alle forme che dicono siano decostruttiviste11 viene da chiedersi come chiamarle. 11 Ovvero architetture che si ispirano al pensiero del filosofo Jacques Derrida, che ha dato luogo alla mostra “Deconstructivist Architecture” organizzata a New York nel 1998 31 32 Il problema del nome In un probabile futuro, di molte delle architetture che animano il dibattito culturale di questo secolo da poco iniziato, come molte altre del passato prossimo e remoto, resterà traccia solo nei libri di storia. Certo è che affrontare le architetture del nuovo millennio pone in essere un primo problema che riguarda i numerosi tentativi di denominarle ed in qualche misura classificarle per genere. Architetture decostruttiviste, architetture non standard, architetture free form, architetture topologiche o a topologia complessa, architetture high-tech, architetture ad 33 alta densità tecnologica, architetture organiche, architetture new wave, architetture digitali, architetture delle nurbs, architetture blobboidali, architetture fluide e in estrema estensione architetture liquide, transarchitetture e Wilfing architettura12; sono forse solo alcune delle possibili denominazioni che chi ne abbia parlato o scritto, prevalentemente nel web, ha tentato di adottare. E’ al contempo corretto dire che tali denominazioni, in parte coniate dagli stessi autori, in parte da chi a vario titolo ed in varia misura ne abbia tentato, più che una analisi, un esegesi, sono state adattate di volta in volta a Sono tutti nomi di blog, siti o recensioni che si trovano nel web. 34 12 episodi tra loro estremamente diversi ed eterogenei. In questo senso basta chiedersi come possano essere assimilabili il cinema UFA di Dresda, una delle prime architetture di ampia risonanza di Coop Himme(l)bau, e gli interventi per il NYSE del gruppo Asymptote. Appare quindi chiaro che al di la di essere unanimemente riconosciute come architetture, in quanto edifici o spazi a vario titolo fruibili ed abitabili, che sicuramente esprimono una valenza formale se non unitaria perlomeno assimilabile nella spettacolarità del loro apparire, di per se stesso il problema del nome è un falso problema che condizionando la cronaca, attende paziente il giudizio della storia. In questo senso, confesso che alcune delle architetture di cui parlo, almeno 35 per quelle di cui ho avuto esperienza diretta, mi confermano nella convinzione che al di là del gioco formale, della curiosità per il nuovo, dell’interesse per la soluzione tecnica costruttiva, più o meno risolta, hanno lasciato in me il dubbio, in parte confermato dai fatti, che a differenza di altre architetture, alla seconda o terza visita non avrebbero avuto più nulla da dire. In alcune di esse, e qui penso al Gugghenaim di Bilbao di Gehry, alla Cupola di Foster per il Reichstag di Berlino all’Arcade Center di Piano sempre a Berlino, seppure piene di gente, quindi animate e vitali, il senso delle relazioni tra l’uomo e lo spazio risulta fortemente alterato e in parte irreale. Al punto di spostare la concentrazione dai caratteri che tale spazio 36 esprime, al senso che esso intende affermare. Altre invece come il museo ebraico di Libeskid quando era ancora vuoto e Notre Dame de Haut, che però certo non rientra nel nuovo dell’architettura, pur volutamente pensate per operare uno straniamento spaziale nel visitatore, sapevano comunicare con naturale immediatezza le scelte sottintese al controllo dello spazio prodotto. Sicuramente questi sono giudizi viziati dalla soggettività e quindi di per se stessi relativi. Sono comunque un impressione che ha radicato in me la convinzione che la novità architettonica fine a se stessa, la ricerca di una magniloquenza minimalista dello spazio ed in alcuni casi la reiterazione di modelli altrimenti risolti e funzionali come per le architetture 37 della tradizione, determinano casi riusciti e casi irrisolti. Diverso però deve essere l’approccio alla possibilità di definire per esse delle categorie omogeneamente valide per classificarle. In realtà il bisogno di classificazione è intrinseco alla natura stessa del loro essere, o voler essere, architetture ed in quanto tali, omologabili a ciò che sino al loro avvento è stata più o meno unanimemente considerata architettura. Ammettendo il fatto che il valore intrinseco di un architettura, specie agli occhi di uomo comune, sia e resti l’empatia emozionale che essa sa trasmettere. Di fronte ad una costruzione ciascuno di noi cerca il rasserenante senso di ricovero che questa sa offrire, una commisurata gestione degli spazi che esprimano un ordine idealmente 38 ricercato, una coerente e funzionale integrazione tra le parti e gli elementi che la costituiscono. In subordine a ciò, un architettura può destare stupore o meraviglia, curiosità ed interesse, in alcuni casi anche sgomento ma ciò sono sensazioni e giudizi che per effetto della loro natura effimera tendono a svanire nel disinteresse dell’abitudine. Ho usato deliberatamene il termine disinteresse dell’abitudine, vuoi per la sua assonanza con il senso intrinseco dell’abitare, vuoi perché credo che tra le categorie che a torto o ragione condizionano il giudizio sull’architettura, ogni spinta all’ innovazione comporti nei potenziali fruitori quel senso di disagio che ha portato molti ad asserire che gli architetti: pensano le case per la 39 gente e poi si arrabbiano perché la gente non ci vive come loro avevano immaginato. Ora anche se da più parti si va teorizzando l’avvento di un uomo cibernetico, ovvero un uomo talmente integrato al variegato mondo dei nuovi media istruiti da logiche digitali, che trarrà beneficio e benessere da una progressiva sinapsi con realtà virtuali, confesso che è una prospettiva che oltre a vedermi oltremodo scettico mi spaventa. Mi spaventa al pari della visione di un amico d’infanzia che ci immaginava soli, seduti in una poltrona, come in un cinema, a veder scorrere la nostra vita con la quale comunque interagivamo in una specie di realtà virtuale ante litteram. Ma certo è che oggi in tempi di global-network e second-life, l’idea di progettare per un 40 abitante nomade cibernetico se non facilita il compito, sicuramente smaterializza il giudizio su quelle che storicamente e universalmente sono state riconosciute come qualità intrinseche di un architettura. Ed in tal senso, senza scomodare le molteplici e ormai discrezionali terne vitruviane, è sicuramente più semplice riferirsi ai caratteri determinanti di ogni manufatto architettonico: la struttura, o se si preferisce l’impianto strutturale inteso come sistema di elementi portanti o autoportati che conferiscono stabilità alla costruzione. Lo spazio, ovvero la conformazione che i possibili elementi che costituiscono la costruzione determinano tra loro, con gli ambienti che generano e con l’intorno. Intendendo con ciò i molteplici approcci che tale 41 spazio consente in termini di percezione, percorrenza, fruizione o uso e le relative possibilità di descrizione geometrica. Da ultimo le superfici, ovvero le infinite variabili tra riflessione e permeabilità alla luce che i materiali adottati consentono e determinano. Prima di addentrarci in un tentativo di lettura di alcune di tali architetture mediante i caratteri sopraesposti è opportuno ritornare un momento sulla componente nominalista che molte di esse presentano. Il concetto stesso di nominalismo sottintende la citazione o il riferimento ad una altro e diverso oggetto o concetto da cui tali architetture dicono di trarre origine. Alcune di esse, forse quelle che finiscono per essere le meno curiose ed originali, mutuano per affrancare un processo 42 morfogenetico di natura topologica figure geometrico-matematiche come le superfici minime, il nastro di Moebius o la bottiglia di Klein. In ciò vi è una sola novità rispetto al passato, ed è il fatto che mediante sistemi di rappresentazione e prefigurazione istruiti da algoritmi basati su funzioni polinomiali, sia possibile operare con relativa facilità operazioni di discretizzazione delle geometrie curvilinee che definiscono tali oggetti. Consentendo così nella generalità di tali casi una modellazione plastica delle superfici da cui derivare, quando possibile, una matrice strutturale coerente. In tale ottica si giustifica una altro nome che tali architetture ogni tanto assumono:, “architetture delle pelli”, intendendo con ciò in senso estensivo la natura 43 stessa della pelle che non solo assolve la funzione di rivestimento al corpo umano ma essendo anch’essa organo vitale e sensibile può ricevere e trasmettere segnali e messaggi. 44 La percezione dell’architettura contemporanea Confrontarsi con alcune delle architetture contemporanee comporta dunque, oltre ad una radicale revisione delle categorie di giudizio, la definizione di nuovi paradigmi atti a inquadrare il fenomeno esperito. Certo è che, scorrendo la cronaca di architettura, che spesso finisce con il confondere la critica con il giudizio storico, forse prematuro e comunque ancora troppo vivido per una pacata valutazione, saremmo portati a pensare che il presente delle architetture free-form, possa condizionare e istruire il futuro delle 45 nostre città. Più di un motivo può pero portarci a pensare che così non sarà dato che ognuno di tali episodi, spesso frutto di oculate operazioni di marketing, legati allo star system dell’architettura, è di per se stesso unico e, si spera, irripetibile. Perché se così non fosse assisteremmo, come in alcuni casi già accade, ad una perniciosa clonazione di stilemi impropri che, laddove replicati serialmente oltre a perderne il senso già di per se stesso impalpabile, risulterebbero di una stucchevole incoerenza logica, formale e funzionale. Per alcuni versi pare che in tali architetture si riverberi quella che è stata l’atassia del design degli anni ‘90. Dove ad una non sempre coerente definizione del design inteso come spinta innovativa si è sostituita una reitera46 zione delle tecniche di morphing, fortemente coniugata a semplici operazioni di styling concentrate sulla valorizzazione degli aspetti esteriori ottenuta enfatizzando solo il trattamento delle superfici, ovvero la “pelle dell’ oggetto”. Non è quindi un caso che in molte di tali architetture, se tali poi possono essere considerate, l’involucro, cioè la pelle, sia proprio la determinante e la ragion d’essere. Ed altro non poteva essere dato che se mediante le nurbs è possibile condizionare e definire le geometrie della forma apparente ben altra cosa è la definizione dell’ impianto strutturale che conforma gli spazi, un compito in molti di tali casi demandato a complesse e non certo di uso comune operazioni di enginnering. Queste prime considera47 zioni non devono però trarre in inganno, dato che credo che l’unico atteggiamento mediante il quale confrontarsi con edifici sicuramente ricchi di suggestione ed in quanto edificati, ascrivibili al rango di architettura, sia un sano spirito agnostico. Già in queste prime righe ho usato tre termini per definire tali episodi: architetture, edifici, fenomeni. Dei tre il più coerente è probabilmente fenomeno, in quanto seppur edificati e quindi fruibili al pari di altre architetture del passato e del presente, tali spazi si propongono in primo luogo di stupire e far parlare di se. Tale componente per così dire mediatica che li accompagna, spesso ancor prima di vedere la luce, è forse la cifra che li accomuna tutti e li pone in una aura di meravigliato stupore 48 gravido di pregiudizi artatamente veicolati. In tal caso, la necessità di ridefinire oltre alle categorie usuali con le quali siamo soliti valutare, e per molti versi giudicare, un architettura: ordine delle generatrici geometriche organizzazione funzionale degli spazi, giustapposizioni dei volumi, impianto strutturale e soluzioni tecnologiche. Aspetti abitualmente considerati quali parametri della coerenza del progetto all’uso per il quale si propone, il paradigma, ovvero l’assunto metodologico mediante il quale condurre una lettura e trarre sintesi, non può prescindere da un rigore logico che vada oltre alla semplice percezione sinestetica all’apparenza unico medium che molti di tali edifici propongono. Paradigma che, condiviso o meno che sia, non 49 può prescindere dal considerare le relazioni tra episodio (di architettura) e contesto: socio-economico, culturale, politico e nella specificità del caso tecnologico. In tempi di globalizzazione, spesso conclamata e poco rispondente ai provincialismi che invece contraddistinguono i vari localismi che ancora contraddistinguono il pensare sociale, la vera novità che molti di tali edifici pongono in essere è proprio la sostanziale decontestualizzazione su cui si fondano. Recentemente un architetto italiano li ha definiti paracadutati e credo che non sbagliasse di molto ad asserire che ciascuno di tali edifici avrebbe potuto trovare posto in ogni luogo , che poi in sostanza equivale a nessun luogo. In effetti un primo equivoco che appare evidente è la contrad50 dizione tra architettura e oggetto di design, quali tali edifici sono e credo segretamente ambiscano ad essere. La prima nasce in luogo e con tale luogo dialoga in quanto in quel luogo permane. Il secondo in una valigia, o nella stiva di una nave, può raggiungere ogni punto del globo. Con il diffondersi di strumenti informatici di disegno assistito, nell’ambito delle discipline riconducibili alla previsione delle modalità di costruzione dell’architettura, si aprono numerose questioni che a vario titolo interessano il rapporto dualistico che lega procedimenti tecnologico-costruttivi e disegno. La prima di queste, con valore ordinatore, riguarda le condizioni di identità biunivoca tra capacità di prefigurazione del componente e sua effettiva com51 prensione. Alla tradizione fondata sulla necessità di pre-figurare, con finalità di verifica e comunicazione, mediante sistemi e codici grafici condivisi e perciò intellegibili, forma e caratteri del componente edilizio fosse questo concepito o conosciuto, si va sostituendo una pratica di tipo simbolico per effetto della quale il componente e di conseguenza le sue modalità di utilizzo ed applicazione vengono considerate date ed in quanto tali note. Un esempio significativo di tale atteggiamento è riscontrabile nella consuetudine di disporre e quindi avvalersi nei diversi software di disegno assistito di blocchi grafici precostituiti e poco importa se questi, spesso definiti in relazione a contesti edificatori, culturali o territoriali differenti, poco e male si adattino 52 allo specifico del progetto in cui vengono applicati. Un secondo aspetto, non certo secondario nel definire la questione, interessa il fattore di scala. Nel disegno analogico, la materialità supporto su cui si sarebbe attuato il tracciamento grafico, imponeva la previsione dell’intero impianto figurativo introducendo la necessità di operare preventivamente le necessarie riduzioni logiche e l’adozione di una coerente significazione semantica. Oggi in uno spazio virtualmente illimitato e basato su di una unità metrica sostanzialmente adimensionale, ogni elemento, componente o oggetto è concettualmente rappresentabile al reale anche se poi spesso tali rappresentazioni difettano del dettaglio che tale scala presupporrebbe o finiscono con il di53 venire ridondanti ove per la contingenza dei formati di output l’ammasso di informazioni in esse contenute diviene illeggibile. Terzo ma non ultimo fattore è il sistema grafico geometrico a cui tali raffigurazioni si rapportano. Anche in questo caso ad una consuetudine di scomposizione planare delle viste, comunque tra loro interrelate e quindi spazialmente comprensibili, si va sostituendo una concezione ibrida tra modellazione tridimensionale e disegno bidimensionale che in concorso alle ragioni sopraesposte difficilmente riesce adeguatamente ad assistere un naturale e coerente sviluppo del progetto. Vi è poi il problema, e proprio di problema si tratta, della effettiva comprensione e conoscenza del componente. In tal senso, ad un nume54 ro sostanzialmente limitato e circoscritto di elementi costruttivi spesso tra loro conformi, vuoi per il naturale processo di innovazione tecnologica, vuoi per la progressiva ibridazione del mercato dei componenti con materiali e tecnologie mutuate dal comparto industriale ed ancora per effetto di una non sempre esaustiva e coerente manualistica e pubblicistica di informazione tecnica, molti dei nuovi elementi o componenti che concorrono alla costruzione restano spesso ad un livello di conoscenza metafisica. Per l’insieme di tali ragioni, si finisce così per assistere ad un nuovo e diverso modo di porsi nei confronti del progetto. Un modo, o forse è più corretto definirlo atteggiamento, per effetto del quale andando perdendosi la cono55 scenza delle concrete potenzialità di componenti e materiali, delle tecniche e dei procedimenti tecnologici mediante i quali questi divengono idonei alla costruzione e dei modi e delle regole geometriche con cui si rappresentano, ogni scelta sia essa formale o figurale diviene in assunto possibile ed in quanto, mediante la virtualità del disegno, essendo visibile, plausibile. In questo senso è quindi indispensabile dare corso ad un ripensamento dei modi che ponga al centro di qualsivoglia proposta formativa, il grado di consapevolezza a cui lo studente giunge in relazione alle scelte che si trova ad operare. Con l’affermarsi di un spazio virtuale o se si preferisce digitale, si impone un ripensamento sui codici mediante i quali gli oggetti archi56 tettonici entro di esso prendono forma. Alla naturale capacità analogica di prevedere mediante scomposizioni planari la giustapposizione di elementi che conformando gli spazi definivano i volumi, si assiste oggi ad un inversione del processo per effetto della quale è dalla costruzione del volume, costantemente pre-vedibile, che discendono spazi ed elementi mediante i quali si giunge ad una definizione dell’oggetto architettonico. Di tale condizione, per alcuni versi ancora incompiuta e ambigua, vuoi per l’inefficacia dei mezzi strumentali a cui si ricorre , vuoi per una specie di costante ibridazione tra tendenza al nuovo e memoria dell’esperienza, si deve comunque tener conto nel concepire un modello contemporaneo di progetto formativo 57 all’architettura. In tal senso va inteso questo scritto che si propone in primo luogo come occasione di confronto e discussione tra le differenti discipline che ad essa concorrono ed al contempo vorrebbe assistere gli studenti in un processo di presa di coscienza sulla, solo in via teorica dimostrabile, identità tra i mezzi medianti i quali il fine che nel nostro caso è il fare architettura, vengano perseguiti. L’evidente inversione di termini determina, quale prima ricaduta sui processi formativi, una sostanziale revisione di un ontologia procedurale che fa discendere l’insieme, inteso come risultato del processo progettuale e formativo ottenuto per sommatoria dei fattori caratteristici, verso una proceduralità maieutica in cui da un insieme assunto a 58 caso di studio, vengono progressivamente estratti i caratteri specifici delle diverse componenti che ad esso concorrono e lo caratterizzano sino a giungere, cosa essenziale ai fondamenti scientifici e teorici su cui i diversi contributi disciplinari si fondano Detto in parole povere, dal insegnare a costruire il progetto si dovrà giungere quantomeno ad un abitudine nello smontare il progetto per comprenderlo e processarlo. 59 60 Forme dell’architettura L’architettura, qualunque architettura quindi anche il più comune edificio quello che Zevi ebbe a definire il “volgare dell’ architettura” ovvero l’ espressione di una cultura ed un sapere diffuso e spontaneo, rispetta, per legittimare la propria condizione di esistenza, le leggi della fisica. In altre parole si sviluppa nelle tre direzioni dello spazio euclideo, che poi è l’unico spazio con cui da millenni ci confrontiamo, operando un gioco di scarico delle forze nel rispetto della gravità. In questi due termini: spazio euclideo e gravità sono ancora oggi a mio parere i 61 confini del fare architettura, anche se qualche ingenuo ottimista pensa che con l’apparente smaterializzazione offerta dai sistemi digitali si possano riformare tali paradigmi adducendo che alcuni segnali già esistono, dato che La grand’arche13 alla Defense incarna l’idea dell’ ipercubo espressione della quarta dimensione, e la sede dell’emittente televisiva CCTV a Pechino14, è la materializzazione di una figura impossibile quale è la costruzione a 4 travi incrociate che notoriamente esiste solo Edificio costruito a Parigi a seguito del concorso del 1982 per la commemorazione del bicentenario della presa della Bastiglia. Concorso vinto da Johann Otto Von Sprecklesen. 13 14 Rem Koohlas 62 a livello grafico percettivo. In merito a ciò, come ho già detto, preferisco la rasserenante abitudine degli spazi che meglio conosco, ovvero quello euclideo governato dal sistema cartesiano, da cui guardare con curioso interesse le infinite trasformazioni che mi dicono si rendano possibili se al mio limitato spazio si venisse a sostituire un continum topologico. Con estrema sincerità confesso che sebbene creda di aver compreso, almeno in parte, la portata rivoluzionaria di una altro e diverso modo di concepire lo spazio e la flessibilità progettuale che assicura l’uso delle nurbs, constato che però poi tali illuminate speculazioni, devono tornare nel molto più prosaico mondo della gravità. Tant’è che del continuum del nastro di Moebius, nella Moe63 bius haus di UNStudio si è persa proprio la continuità, dato che ragionevolmente il vero problema era convincere gli abitanti, per quanto motivati e collaborativi fossero, a camminare a testa in giù per ritrovarsi in salotto. In merito a ciò, devo dire che da sempre si parla del contributo che la matematica, e con essa le differenti geometrie, possano apportare alla comprensione e alla definizione dell’ architettura. In realtà tale contributo sin dalle prime formalizzazioni delle regole architettoniche sia nel comporre, che nel costruire, è stato centrale nella formalizzazione di regole, o magari “ricette” che l’architetto standard e l’ingegnere medio potessero applicare ottenendo discreti risultati. Anche in passato qualcuno più dotato o più curioso ha 64 mutuato leggi fisiche interpretate con calcoli matematici per spingersi oltre, sempre però con la consapevolezza che le forze comunque le indirizzi e le orienti alla fine si scaricano a terra. Oggi però sempre più spesso si sente parlare delle infinite possibilità generative, magari anche auto elaborate, che la matematica alla base del calcolo elettronico offre. In questo caso, chiaramente non vi sono ricette da trasmettere, perché le ricette sono già implementate nel sistema di calcolo e definizione delle forme e quindi solo interagendo con il sistema stesso si potrebbero determinare variabili e discriminanti che vadano oltre alla naturale e per molti versi cognitivamente incontrollabile mutevolezza della curva per punti. A questo punto è chiaro 65 che all’architetto e per molti versi anche all’ ingegnere non è più richiesta la conoscenza dei presupposti geometrico matematici per governare gli esiti formali e strutturali, ma bensì la conoscenza matematica necessaria per interagire con i presupposti stessi al fine di determinare almeno in via ipotetica nuovi esiti comunque poi da verificare con la contingenza delle fattibilità tecnico costruttive. Si richiede dunque, ad un sapere prevalentemente tecnico, una diversa consapevolezza che per necessità sconfina nella scienza, un territorio notoriamente di frontiera in cui i paradigmi vengono definiti e ridefiniti in un costante divenire. In questo caso si dovrebbe quindi riformare il paradigma stesso su cui si fonda l’architettura che notoriamente mira 66 coniugare l’arido dominio della tecnica con la supposta ricchezza delle conoscenze umanistiche, ridefinendo così il ruolo di una figura professionale che già in proprio vive le contraddizioni di un sistema socio culturale in cui conta più ciò che appare nel firmamento dello star system che non la sostanza di ciò che si cela dietro tale apparire. Questo atteggiamento, che non temo di definire deliberatamente reazionario, si fonda però su più di una magari discutibile, ragione. La rincorsa del nuovo per il nuovo, in architettura, ha solitamente lasciato il tempo che ha trovato. In questo senso si pensi alle visionarie utopie di parte dell’architettura del primo dopoguerra,primo tra tutti Soleri e lo stesso Fuller, che appunto basava la propria ri67 cerca su presupposti matematici comunque fortemente connessi al mondo della fisica, le cui architetture hanno avuto riscontro e seguito prevalentemente nel mondo del fumetto. Architetture che solo oggi vengono riscoperte e in parte rivisitate proprio in quanto sgravate delle complessità matematiche da cui traggono origine in quanto facilmente raffigurabili mediante operazioni di morphing di primitive geometriche e solidi in un comune sistema di disegno assistito. Vi è poi la riscoperta dell’”architettura del calcolo”, in questo caso statico. Millart, , l’ultimo Le corbusier Nervi, Musmeci ed ancora Felix Candela, Reima Petilla e Otto Frei anche se quest’ultimo con sistemi di costruzione leggeri oggi riscoperti in funzione di un rinnovato interesse 68 per il Problema di Palteau15 sulle superfici minime; hanno esplorato le potenzialità della sinergia di materiali antitetici e complementari quali risultano essere ferro e cemento per ottenere con verifiche analitiche di tipo discreto, quello che oggi Mutsuro Sasaki ed altri studiano mediante algoritmi evolutivi, ovvero processi di calcolo capaci di auto rigenerarsi al fine di giungere potenzialmente alla defini- problema matematico noto come Problema di Plateau, dal nome del fisico belga J.A.F. Plateau (1801-1883) che partendo dallo studio delle lamine saponose, tende alla definizione delle superfici minime ed in ragione di ciò più efficaci alla reazione delle forze con esse interagenti 15 69 zione della forma migliore in base a parametri dati. In questo caso, senza essere luddisti, si comprende come il demandare alla macchina la determinazione suppur probabilistica ed interattiva di scelte che interessano la forma, introduce processi meccanicistici che molto assomigliamo alle innumerevoli funzioni od utility che ci propone oggi qualsiasi apparecchio elettronico. In questo senso esemplare è la funzione di riconoscimento del volto operata dalle più recenti macchine fotografiche digitali, un utility appunto che se tento di fotografare un edificio eclettico mi sfuoca la facciata per meglio definire il volto del fanone che regge il balcone sopra il portone. Da ultimo, ma non per questo secondario, l’architettura deve oggi, per necessità, 70 ridefinire il proprio ambito speculativo, dato che da un lato le pratiche urbanistiche hanno ormai operato il superamento della fase prescrittiva e dei modelli per giungere a dinamiche di tipo negoziale. Un approccio questo maggiormente orientato alle scienze sociali ed alla definizione di matrici culturali entro le quali il processo edificatorio risulta necessariamente un fattore secondario e, dall’altro l’ormai raggiunta autonomia del disegno industriale, che partendo in un certo qual senso da una posizione di sudditanza rispetto all’architettura, ha già avuto modo, altro non fosse che per meglio definire una propria autonoma fisionomia, di esplorare il complesso mondo delle potenzialità di generazione della forma e controllo delle fasi 71 produttive offerte dai sistemi di modellazione informatica. Passando peraltro, ancor prima delle potenzialità offerte dal mezzo informatico, nello studio del biomorfismo quale generatore della forma. Ed è proprio pensando al design e ad alcune delle sue peggiori derive di questi ultimi anni16 che l’architettura può trarre ulteriori criteri di giudizio sulle questioni poste in essere da questa nuova forma espressiva, quella del “free-form”, che forse è la denominazione più coerente per molte delle architetture di questi ultimi anni. 16 Si pensi allo “styling”, ovvero una ossessiva e volte improduttiva attenzione al valore delle superfici, intese come unico fattore di innovazione della forma. 72 Criteri che andranno in questo caso ad interessare sia il processo tecnologico di utilizzo dei materiali con la componente dell’effettiva durabilità delle loro prestazioni che cosa sicuramente di maggio importanza la differenza di scala. In quanto quello che vale alla scala dell’oggetto, che come tutti sanno dove lo metto sta e li permarrà per un dato tempo, non può valere per un architettura che, ci piaccia o meno, deve comunque dialogare, magari anche in modo contraddittorio e verboso, ma comunque coerente sotto il profilo logico con il contesto al quale si relaziona e potendo ammortizzare nel tempo gli investimenti che ha comportato specie se come in questi casi molto spesso accade mira ad essere unica e potenzialmente irripetibile. Chiuse con 73 ciò le premesse ritenute necessarie per delimitare il campo d’indagine è quindi possibile prospettare i metodi mediante i quali operare una lettura di alcuni casi inerenti tali architetture. 74 L’ho già detto, non ho scritto questo libretto per la gloria accademica. Qualcheduno potrebbe obiettare che il bene supremo è la scienza, e questo è un bel modo per perdere tempo. Sia ben chiaro, le parole e i pensieri che stanno qui dentro sono usciti nel tempo al di fuori dell’università. Un ambiente in cui ormai si fatica a capire perché il tempo passato a pensare sembra spesso sprecato17. Per il tempo c’è poco da fare. Sino a quando l’università sarà valutata con criteri pseudo aziendali, comprimere il tempo, incrementa il prodotto e la qualità dello stesso entra nel conto in termini solo 17 L’università sta vivendo una sindrome di efficientismo, per effetto della quale termini stranieri, prevalentemente in inglesi e muotati dal marketing imperano. 75 numerici. Oltretutto la materia prima in ingresso, cioè lo studente, a volte presenta numerosi difetti18. Non voglio passare per giovanilista, ma credo che la colpa non sia del soggetto, cioè lo studente, bensì di un sistema che lo ha abituato a pensare che la cultura ha un valore prevalentemente economico. Non è dunque un caso che quelle che ai mie tempi erano lacune di cui avevi consapevolezza, oggi siano diventati “debiti formativi”. Oggi, come ai miei tempi, un pezzo di carta non si nega a nessuno e il dibattito continua a girare attorno al valore legale di quel pezzo di carta. Angelo Pa- Si era soliti usare il termine “lacune”, oggi chissà perché rinominate “debiti formativi”. 76 18 nebianco19 recentemente20 ha teorizzato di poter circuire il problema invertendo il momento della verifica. Alla valutazione finale di un percorso di studi, si andrebbe a sostituire un esame in ingresso al successivo ciclo di studi. Così facendo, egli teorizza “seri esami obbligatori per l’accesso alle università” avrebbero come benefico effetto, un attenzione da parte di genitori e studenti sulla qualità della formazione. Chiudendo il suo pezzo invita al dibattito. Gli studenti a cui mi rivolgo con questo lavoro, sono entrati in una facoltà di architettura superando un test nazionale a detta Politologo e saggista, è professore universitario a Bologna presso la Facoltà di Scienze Politiche. 19 “Requiem per un esame”, Magazine del Corriere della Sera del 2 aprile 2009. 77 20 di alcuni, anche, selettivo. Per come interpreto io la questione, bisogna che l’università trovi il modo di uscire dalla posizione di stallo in cui è suo malgrado è finita. Da un lato abbisogna studenti21, dall’altro per alcuni corsi di laurea ne ha forse anche troppi22. Oggi è acceso il dibat- Stando alla scheda tecnica allegata al D.M. n. 146 del 28.070.2004, il 30 % del Fondo di Finanziamento Ordinario di una università è legato al numero di studenti iscritti, anche se poi intervengono correttivi in base al numero di laureati e ad altri indicatori inerenti la ricerca. Una seconda risorsa economica, non certo secondaria, sono le tasse universitarie che sono direttamente proporzionali al numero e al reddito degli iscritti. 21 Questa è una mia considerazione ma, stando ai numeri espressi dal rapporto del CRESME: il mercato della progettazione architettonica in Italia, del 78 22 tito sulla “governace”23 delle università. Quale che ne sarà la forma che la legge, se viene emanata, vorrà delineare, resta il problema del numero degli studenti e delle qualità culturali che presentano al loro ingresso. Per limitare numericamente gli accessi, un sistema ragionevolmente sicuro è aumentare le rette. È un sistema a dir poco ingiusto e classista, ma porterebbe allo scoperto la contraddizione di fondo per 2008 – il Sole 24ore, in Italia sono attivi 123.000 architetti e gli studenti di architettura sono 76.000. Considerando che il numero programmato per il 2008 prevede circa 10.000 studenti in ingresso su tutte le facoltà di architettura italiane è evidente una sproporzione tra il fabbisogno e l’offerta. Il termine governace è usato nelle Linee guida del Governo per l’Università emanate dal Miur del 6.11.2008 79 23 la quale non si sa bene se lo studente è un utente oppure un cliente o, più semplicemente, sta li senza saperne il perché. Nel primo dei casi ha anche doveri, nel secondo giustamente reclama solo diritti. Considerandolo utente gli dobbiamo qualcosa, se invece è un cliente più logico è vendergli quello che vuole. Se stesse li senza saper nemmeno lui il perché, la questione è spinosa. 80 Molto si parla e si è parlato di una sostanziale idiosincrasia tra l’architettura contemporanea e la gente. L'idea qui proposta non è certo nuova ma, a mio parere, ben si adatta a stimolare un confronto sul tema della architetture a forma curvilinea e sul rapporto che tali modelli possono avere sia nella concretezza costruttiva che nella didattica. In tal senso la questione centrale è identificare un modo mediante il quale l’adesione ad un idea di architettura sia esplicita e manifesta. L’urgenza di tale questione è da ricercarsi in un sempre maggiore ricorso a “previsioni digitali” che per propria natura non ammettono giudizi di natura analogica delle qualità che il progetto esprime. Claudio Umberto Comi Pongo architetture gnoseologia delle architetture freeform Claudio Umberto Comi (1960) è architetto e ricercatore universitario e si occupa di disegno del paesaggio e di architettura. E’ autore di numerosi libri tra cui: lezioni zen (1998); sul paesaggio (2001) la pratica del modello (2008), spazio, tempo e città (2009), e, quaderno di rappresentazione (in stampa). OPINIONI MINUTE Molto si parla e si è parlato di una sostanziale idiosincrasia tra l’architettura contemporanea e la gente. L'idea qui proposta non è certo nuova ma, a mio parere, ben si adatta a stimolare un confronto sul tema della architetture a forma curvilinea e sul rapporto che tali modelli possono avere sia nella concretezza costruttiva che nella didattica. In tal senso la questione centrale è identificare un modo mediante il quale l’adesione ad un idea di architettura sia esplicita e manifesta. L’urgenza di tale questione è da ricercarsi in un sempre maggiore ricorso a “previsioni digitali” che per propria natura non ammettono giudizi di natura analogica delle qualità che il progetto esprime. Claudio Umberto Comi Pongo architetture gnoseologia delle architetture freeform Claudio Umberto Comi (1960) è architetto e ricercatore universitario e si occupa di disegno del paesaggio e di architettura. E’ autore di numerosi libri tra cui: lezioni zen (1998); sul paesaggio (2001) la pratica del modello (2008), spazio, tempo e città (2009), e, quaderno di rappresentazione (in stampa). OPINIONI MINUTE
Scaricare