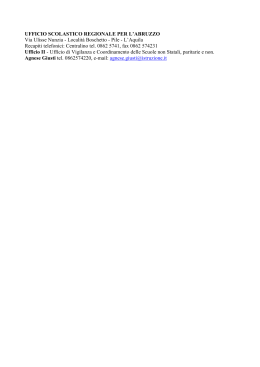L’Associazione Maria Bianchi di Suzzara (MN) ringrazia: Angela Staude Terzani, entusiasta e affascinata della nostra scelta di dedicare questo Terzo Concorso Nazionale al marito Tiziano; Duccio Demetrio, presidente della Giuria di valutazione dei testi, per la profonda competenza, l’estrema disponibilità, l’autentica modestia; gli Assessori ai servizi alla persona Claudio Bollani (Comune di Suzzara) e Fausto Banzi (Amministrazione Provinciale di Mantova) per i contributi economici, la partecipazione alla giuria, il sostegno umano e morale che da anni ci donano; la giuria perché il lavoro di lettura e valutazione mai come quest’anno è stato impegnativo, complesso, straordinario; tutti i partecipanti al concorso dall’Italia e dall’estero per il dono incomparabile che ci hanno concesso, rendendoci partecipi delle loro esperienze di lutto e di perdita; le persone amate dagli autori, ora decedute, che abbiamo imparato a conoscere e che ogni lettore potrà ‘incontrare’ leggendo questo libro: 1 PREMESSA Ci sono doni che lasciano senza fiato. Spesso sono quelli offerti con una gratuità e fiducia talmente potenti da dare quasi fastidio. Lasciano la sottile, indecifrabile sensazione di rimandare ad altro, a qualcosa d’oltre che non si riesce pienamente ad afferrare. Ci si sente poi in debito e qualsiasi pensiero per cercare almeno di contraccambiare risulta davvero inefficace. E’ questa l’esperienza che come Associazione Maria Bianchi abbiamo vissuto una volta diffuso il Bando del III Concorso Nazionale per testi autobiografici inediti sul tema del lutto: decine e decine di lavori sono arrivati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero nei mesi successivi con le conseguenti nostre riflessioni sui criteri di valutazione, sul diritto-dovere di scegliere, sulle emozioni che ogni scritto, ogni singolo scritto ha fatto nascere in ognuno di noi. Il lavoro della giuria è stato quindi davvero impegnativo e complesso perché quest’anno, più che nelle due precedenti edizioni, abbiamo sentito la responsabilità, l’inadeguatezza del nostro compito, gli errori che inevitabilmente avremo commesso. Ma, ancora una volta, sono state le stesse persone che hanno partecipato a farci capire la vera dimensione di questa iniziativa: ‘non sono la stessa che ero prima di iniziare a scrivere e a rivivere il mio amore’ ha detto una partecipante, sintetizzando splendidamente i pensieri di tanti altri che abbiamo contattato. Ed è davvero speciale ritrovare lo stesso pensiero, quasi le medesime parole, nella riflessione conclusiva di questo libro a cura di Duccio Demetrio, presidente della nostra Giuria e punto di riferimento ineliminabile in Italia per chiunque si avvicini alla metodologia autobiografica. Nicola Ferrari Associazione Maria Bianchi 2 A Tiziano Terzani, a quella sua risata spontanea, convinta, magnifica di saluto al mondo 3 PREMIAZIONE La giuria della III edizione del Concorso Nazionale per testi autobiografici originali ‘In prima persona’ sul tema: ‘L’esperienza del lutto’, ha lavorato ricercando in un primo momento modalità e criteri di valutazione comune dei testi. La lettura individuale di tutti i testi pervenuti da parte dei giurati ha permesso, proprio sulla base della precedente condivisione, di realizzare una prima scelta delle opere. L’ultimo fase di lavoro si è caratterizzata da un’ulteriore riflessione per individuare, tra i testi precedentemente selezionati, quelli da premiare e pubblicare. La giuria è composta da: Duccio Demetrio, Presidente Professore di Filosofia dell’educazione e di Teorie e pratiche autobiografiche all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Fondatore con Saverio Tutino e presidente della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Luciana Mignola, Presidente dell’Associazione Maria Bianchi, direttrice didattica, scrittrice. Matilde Motta, insegnante, pedagogista, volontaria dell’Associazione Maria Bianchi e facilitatrice dei gruppi di auto aiuto per persone in lutto. Ha conseguito il Secondo Premio nella Prima edizione di questo concorso con il testo ‘Accanto a Franco’. Nicola Ferrari, formatore, responsabile della formazione e dei progetti dell’Associazione Maria Bianchi e del Centro Servizi del Volontariato di Mantova. Ha attivato il servizio di sostegno per le persone in lutto tramite la comunicazione epistolare. Autore di vari libri, ha scritto per l’Associazione: ‘Ad occhi aperti – la relazione d’aiuto alla fine della vita e nelle esperienze di perdita’, Libreria Cortina 2005. Licia Cauzzi, insegnante di Lettere e Letteratura italiana. Volontaria dell’Associazione Maria Bianchi, co-facilitatrice dei gruppi di autoaiuto per persone in lutto. Claudio Bollani, assessore ai servizi alla persona del Comune di Suzzara. Ha partecipato a tutte le edizioni del Concorso come membro della giuria di valutazione dei testi La valutazione della giuria ha decretato vincitori per l’anno 2005 i seguenti testi: 1. Silenzio 2. Il Primo 3. Proprio adesso di Aldina Buratti Dei di Maria Concetta Scordi di Marco Pasinetti (Savona) (Palermo) (Bergamo) Si è deciso inoltre di pubblicare: • Tutto nero di Catia Salvadore (Bologna) • Abitare la distanza di Luciana Mignola (Mantova) • Troppo presto di Mariasole Galassi (Roma) e le poesie di Camelia Ciuban (Suzzara) 4 Arnaldo Maravelli Antonella Salvato (Suzzara) (Napoli) 5 Silenzio di Aldina Buratti Dei Questa solitudine non la sopporto, e sono vigliacca, ma poco vigliacca e poco coraggiosa. Gli amici? Le cene? Il teatro o il coro degli alpini? Lo scrivere? Parentesi di suoni e di umori tra il silenzio e il pianto. Le domeniche! Girare a vuoto per casa, piangendo, e allora uscire e fuori vedere le coppie, le famiglie e non avere nessuno con cui parlare, commentare, ridere o solo da prendere per mano. E tornare a piangere a casa, per non dare spettacolo. Poterti stringere tra le braccia e fare all’amore con te, ancora. Sì, mi manca anche il sesso, ‘quel’ sesso fatto con te, con tanta tenerezza, mi manca. Tanti mariti gretti e meschini, avari anche di sé, padroni arroganti e mal tollerati: Signore Iddio, se ci sei, comunque tu sia, perché non hai preso uno di loro? Perché hai voluto rompere questo equilibrio? E’ come dice Terzani: sono stata una vita sulla giostra e mi hanno dato anche il cavallo bianco ma non avevo pagato il biglietto e ora è arrivato il controllore. Il cavallo bianco me lo hanno tolto e la giostra cigola ma non si vuole fermare. Mai più: due paroline brevi che racchiudono un universo di vuoto, universo da cui non uscirò se non con la morte, finalmente. Eppure non dovrebbe essere difficile passare a qualcosa d’altro o al nulla. Cosa sei diventato? Sei l’essenza di una nuova creatura, un atomo nell’aria, pura energia? E quando mi pare di sentirti vicino, di ricevere da te messaggi, ci sei tu dietro, che mi comunichi ancora il tuo amore? Ti ricordi i nostri sorrisi di tenerezza e d’intesa quando ti dicevo che a settant’anni il cuore si metteva a battere ancora all’impazzata se vedevo una tua fotografia dei vent’anni? E’ davvero tutto finito? Cinquantasei anni. Cinquantasei anni da allora. Oggi è il ventiquattro agosto. Un vestito rosa, una ragazzina che crede di essere già donna, tante lampadine colorate sulla riva dell’Arno, musica. E tu, così bello, ti ho subito notato e seguito con gli occhi. Speravo che mi invitassi a ballare quei balli. E lo facevamo così male perché nessuno dei due amava le danze. Catturata dai tuoi occhi ridenti e dal tuo sorriso irresistibile sotto il cappello goliardico: la tua vicinanza 6 mi dava una specie di ubriacatura. E’ cominciata così, in una sera d’estate, la nostra bella storia, con mio padre lì, cerbero e vigile. Ventiquattro agosto da sola: è la prima volta che non lo festeggiamo. Ilaria dice che ti ho mitizzato: e allora? Se in cinquantasei anni il mito non si è dissolto o io sono perfettamente cretina o era un mito valido. In ognuno di questi casi io sono stata felice, e tu? Ho buttato alle ortiche la panzana che questa nostra unione così stretta e invidiata abbia nuociuto alle figlie (come mi è stato fatto notare) insieme a relativi miei sensi di colpa e sofferenza. No! Se l’equilibrio genitori-figli è spesso precario, i danni nei casi di coppie scoppiate penso che siano di gran lunga superiori. Almeno per questo adesso sono in pace con me stessa. Disperata, disperata, disperata. Oggi ero disperata più del solito. Annientata da questo dolore che non vuole finire, che a tratti mi schiaccia ma non mi annulla. Sono sempre qui. Camminavo per casa col piede rotto che mi faceva male, ripetendo, urlando: “Sto impazzendo, sto impazzendo”. Mi sono rivolta a te, alla tua foto appesa nello studio e fra le lacrime ti ho urlato: “Aiutami se puoi, ti prego, ovunque tu sia, qualunque cosa tu sia adesso, in nome di tutto l’amore che c’è stato tra noi!” E’ suonato il telefono, non volevo rispondere ma al quarto squillo l’ho fatto. Era la Sascia, mi ha invitato per domani: va con la Chicca a fare una gita in battello a Finale Ligure-Portofino, con sosta al largo per vedere i delfini. Non la sentivo da mesi. Certo che ci voglio andare, e ti porterò con me, amore mio: finalmente sarai nel mare come volevi, quel tuo mare che amavi tanto, che ti placava, e con il quale eri sempre in sintonia. E quando ti sarai finalmente confuso con lui, anch’io lo amerò come facevi tu. Ma dove sei, che poteri hai, hai captato la mia richiesta di aiuto e l’hai esaudita quietando almeno la mia angoscia di non aver potuto ancora collocare le tue ceneri come volevi?! Grazie. Ti ho portato con me, avvolto nel lenzuolo di lino ricamato dalla tua mamma. Aspettavo di gettare le ceneri in alto mare, nelle acque limpide e chiare, stavo in un angolino appartato. All’improvviso, vicinissimi a noi, un branco di delfini è emerso e si è messo a fare le capriole: che meraviglia! Quale luogo migliore per te? Ti ho 7 lasciato in loro compagnia. Stasera sono dolcemente commossa. Elisa e famiglia sono tornate dalla montagna e Ruben, il nipotino più piccolo, mi ha subito telefonato. E magari, ora che vado a dormire, ti sognerò. Troppo bello? Come dicevi tu, mai porre limiti alla provvidenza. Oggi è stato un giorno magico. La magia non dura, è magia: un giorno c’è e un altro non c’è più. Oggi è scomparsa, come il cielo azzurro di ieri, però in fondo in fondo al mio essere, da quello sprofondo da cui nasceva e mi inondava la disperazione, mi pare di scorgere uno spiraglio. No, non di serenità, quella devo scordarmela. Ma forse un barlume della tua capacità di sopportazione stai riuscendo a trasmettermelo. Tu che della sopportazione del dolore avevi fatto un esercizio quotidiano nell’ultimo periodo della tua vita. Così difficile, quel periodo. Quando ci hanno dato il verdetto - “Pochi mesi, forse cinque o sei” - temevo una tua esplosione. Dimenticavo che tu per gli amici sei sempre stato ‘il saggio’, e l’esplosione non c’è stata. Ti ho chiesto cosa volessi fare in quei mesi, anche l’assurdo: vendere la casa e trasferirti in un grande albergo, chiuderti a meditare in un monastero, farti un’amante e non so cos’altro mi è venuto in mente. Ti ho detto che comunque avrei capito e sarei stata d’accordo. Pacatamente, dopo attenta riflessione, mi hai risposto che dalla vita avevi avuto tutto, tante cose, belle e brutte, ma comunque ‘cose’. Hai aggiunto che eri contento delle figlie - “qualche volta sono un po’ stronze, ma va bene così, hanno ben utilizzato il concetto di libertà che abbiamo cercato di instillare loro” - e chiedevi solo che io ti restassi vicino e che non ti mandassi in ospedale. Temevo che poi, quando il dolore si fosse fatto più feroce, insopportabile, saresti diventato come qualcun altro che avevo visto: cattivo, aggressivo, offensivo, soprattutto con chi lo accudiva. Grazie, grazie per aver conservato sempre la tua dolcezza, per avermi trattata con lo stesso amore e rispetto, per non avere inveito contro la sorte crudele. Come qualcuno mi ha detto, tu eri bello dentro e fuori. Ti preoccupavi solo di me: “Sarai sola, e tu non sai vivere da sola.” Non sono sola: ho tanti muri su cui battere la testa, ma la mia testa è dura, è dura più del muro e più che ammaccature non riesco a farmi. Vado a dormire amore mio: se 8 puoi, se vuoi, non farmi risvegliare domattina. Portami con te. Te lo chiedo sempre e tu non lo fai mai, ora te l’ho messo anche per iscritto: se stanotte vieni a curiosare, ti lascio il quaderno aperto. Se lo leggi aiutami. Io qui non ho più niente da fare. Ho chiesto ad un nostro amico caro, medico illustre, di aiutarmi ad andarmene. Mi ha detto che al di là della sua etica - il giuramento di Ippocrate - sono io che non posso farlo: perché con l’amore che c’era tra di noi finché io vivo tu vivi in me. Sono le sette del mattino e sono sempre qui, un altro giorno di solitudine. La solitudine… E se non fossi sola, sopporterei meglio? Sopporterei di avere sempre qualcuno? Un’amica? Un uomo? No. Allora cosa voglio? Voglio te e non ti posso avere, e lo so che non ti posso avere, ma ugualmente non posso vivere senza di te. Per tutta la vita mi sono sempre sentita dire che io sono forte. Non era vero, sembravo forte perché dietro c’eri tu a sostenermi. Ce la farei, forse, se sentissi più spesso un po’ di vero calore dalle figlie e un po’ più di presenza dai nipoti. A parte Ruben, che essendo ancora piccolo, è più tenero e vicino. Intendo, per calore vero, le coccole che io non ho saputo fare e che ora pretenderei da loro. Quindi, sono patetica. D’altronde, ai nipoti più grandi, quando erano piccoli, di coccole ne ho fatte tante, e ora? Non esisto più, se non per rade comunicazioni telefoniche. Avevo puntato tutto sulla famiglia, da sempre, mi arrovellavo per cercare di fare il meglio, mi guardavo attorno per non ripetere gli errori degli altri e per cercare esempi positivi da seguire; non ho fatto altro e ho fallito: lui me lo hanno tolto, e loro due mi guardano col distacco di chi giudica il mio operato come se fosse stato solo un impiego ed io mi fossi data sempre malata, una lavativa. Cerco di guardarmi dentro, ma mi pare di no. Sono legnosa, sì. Non ho mai trovato il modo di rompere questo guscio che mi avvolge come quello di una noce, una noce che cresce interiormente e vorrebbe tanto esplodere ma non può; anche se grido di dentro, da fuori nessuno mi sente e lo schiaccianoci non si è trovato. Cerco le cause, le scuse: mia bisnonna adottata per mercede, per potere avere un piatto di minestra in più, era poco amata, e per questo non ha saputo amare sua figlia? E questa figlia, mia nonna, ha poi poco amato la sua, mia mamma, perché era rimasta in 9 vita mentre il fratellino (il maschio!) era morto a due anni. Mia madre, anche lei, oltre alle cure materiali, di coccole me ne ha fatte ben poche. E, piccolissima, mi aveva insegnato a dire: “Io i baci non li do e non li voglio”. E se invece la colpa fosse solo mia? Cioè la colpa di essere legnosa? Se ora l’abbracciassi stretta stretta, e la baciassi forte, come non ho mai fatto, lei forse mi respingerà, si domanderà perché lo faccio. E poi, le farà piacere? E intanto il momento magico è passato, nessuno si è accorto di nulla, e tutto è rimasto come prima. Perché tu non avevi mai queste complicazioni? Io devo restare finché chi tiene le corde deciderà, lui, chiunque egli sia, di dare un colpo netto alla mia e reciderla. Fino ad allora riuscirò ad essere serena davvero, senza la maschera che mi obbligo a mettere con gli altri? Da sola mi pare di non farcela e le porte a cui ho bussato finora sono rimaste chiuse: ho bussato troppo piano oppure dentro a chi c’era dietro c’era il vuoto? “Bisogna elaborare il lutto”. Ma chi ha detto questo ha mai provato? Finalmente, per qualche ora alla settimana, qualcosa da fare che mi distragga da te. Qualcosa che non sia la ridicola proposta di trovare qualcuno con cui giocare a carte (io che le detesto), un compagno nuovo (per sostituire te?), un gruppo con cui viaggiare (ma i miei viaggi erano i nostri)! Faccio volontariato il martedì e la domenica; la mattina a cucinare da Suor Bruna, nella casa che lei ha organizzato per accogliere donne sventurate in temporanea difficoltà: questo mi aiuta, posso essere utile. E mi rendo conto di quanto nella vita, fino a quel maledetto ventitre ottobre, io sia stata fortunata. Ho anche qualcosa d’altro da fare: mentre dicevo “Basta, basta, basta” mi ha telefonato un professore di psicologia: ha letto il mio libro “Chino”, gli è piaciuto, mi ha invitato a fare una conferenza sul romanzo storico. Come saresti stato contento! Perché ci sei ma mai con me? Stanotte, in un ennesimo sogno, sapevo che eri da solo nella macchina che precedeva la mia. Io avevo tre persone a bordo e tutte insieme dovevamo andare a mangiare alla baita sul Melogno; il monte però non era boscoso come nella realtà, era brullo, e dal basso si vedevano i tornanti della strada. Io mi sono dovuta fermare perché la macchina si era impantanata, tu sei andato avanti. I 10 miei tre passeggeri sono scesi e hanno spinto la macchina, abbiamo proseguito. Passata una curva la strada era sbarrata da transenne e c’era un cartello di divieto di transito. Poco lontano un uomo stava andando verso una baracca, mi ha detto che la strada era interrotta. Io gli ho indicato te che con la macchina salivi i tornanti, si è stretto nelle spalle e se ne è andato. Noi siamo rimasti lì. Io rimango sempre lì e tu te ne vai. Ma questo lo avevo già capito, non c’è bisogno di tutti questi sogni che ripetono sempre la stessa cosa. Mi sono guardata allo specchio: le palpebre gonfie, la bocca con una piega amara, gli occhi smarriti. Eppure il pianto è ancora un legame con te. Se ti piango, in qualche modo mi dai ancora un sentimento. Sono ancora vincolata a te e questo è, comunque, una ricchezza. Evviva, finalmente il tuo studio sugli Antifonari è in dirittura di arrivo. Il Lion e l’Istituto di Studi Liguri lo faranno stampare prima di Natale. Giovanni Murialdo ha rispettato il tuo desiderio di realizzarlo in forma cartacea e non su dischetto, e lo presenterà. La conferenza sul romanzo storico è andata bene, l’ho affrontata dal punto di vista dell’evoluzione del pensiero invece che da quello delle guerre o della politica, mi pare che ne sia venuto fuori qualcosa di buono. Quanto mi sarebbe piaciuto che tu ci fossi stato! A strizzarmi l’occhio, in prima fila, col tuo sorriso complice e affettuosamente canzonatorio. C’eri? E’ passato un anno. Un anno da sola. Sola come un cane? Che modi di dire stupidi: trattato come un cane, lavorare come una bestia, vivere come animali, feroci come un lupo. Ho gli amici, certo. Alcuni preziosi, teneri e protettivi, altri più distaccati, ma a tratti affettuosi. Pochi e quasi mi sfuggono: le vedove forse portano iella? Eppure all’inizio non piangevo, ero come anestetizzata e stupita di non provare dolore. Solo sollievo per te, perché tu avevi finito finalmente di soffrire. Soffrire dapprima dei dolori lancinanti di quel male buio che ti stava divorando. Poi delle conseguenze della terapia del dolore (mai abbastanza benedetto il medico che te lo toglieva) che 11 talvolta ti faceva sragionare. E non ti piaceva sragionare, te ne accorgevi e mi guardavi con occhi smarriti. Tu forse sei in pace, finalmente. L’inferno è mio. Gli Antifonari. Forse quello che muove le fila ti ha fatto morire per evitarti un colossale peccato d’orgoglio. Quanta gente! Ce n’era tanta e ne arrivava ancora. I frati benedettini continuavano a portare sedie ma ad un certo punto non ce ne stavano più, e sì che eravamo nella sala grande: la gente si assiepava in piedi. Tanta gente, sì: amici, estranei. Quando è toccato a me parlare mi sono tenuta sul minimalismo (altri avevano fatto di te un ritratto ufficiale): ho raccontato di noi due ragazzi, in giro per musei; di come, dopo essere andati in camporella, visitavamo le vecchie sagrestie delle pievi; e della copertina del tuo libretto universitario, in pergamena, su cui avevi dipinto una specie di antifonario in nero, rosso e oro. Te lo ricordi? La pubblicazione è stata molto apprezzata. Verrà distribuita attraverso il Museo e il Lion Club. Ma forse lo sai già, eri presente. Domani è Natale, il secondo Natale senza te. E dopodomani avremmo festeggiato le nostre nozze d’oro. Non so immaginare come starò. Sarebbe bello se io ti raggiungessi quel giorno, nel sonno, sorridendo, come hai fatto tu. Quando mi sono svegliata alle sei, dopo un’ora di sonno, ho trovato che non c’eri più, che mi avevi salutato, allungando la mano ormai inerte, sul mio cuscino. Ma volevi salutarmi o chiedermi aiuto? E io dormivo. DORMIVO, in quell’ora, dopo notti passate sveglia a guardarti, ad ascoltare il tuo respiro discontinuo e affannoso. Io dormivo; forse tranquillizzata da quel tuo respiro, finalmente regolare e sereno. Cerco scuse, ma non ne ho. E’ domenica pomeriggio e nevica. Poco, ma nevica e fa freddo. Ti ricordi i pomeriggi delle domeniche d’inverno, quando salivo da te nello studio con il vassoio delle tazze da tè e i biscotti? Io sono nello studio come allora, guardo dalla finestra la rocca di Perti come allora (la rocca di Perti che tu amavi tanto). Ma tu non ci sei, non c’è il tè e non ci sono biscotti. E piango, non posso fare altro che piangere in questo silenzio e in questo vuoto. Con te ero così allegra! E cantavo! L’oculista da cui sono andata per il controllo della retina mi ha detto che… ho scarsità di lacrime e mi ha ordinato le 12 lacrime artificiali. Sono sicura che se hai sentito avrai riso con me, abbiamo sempre sostenuto che l’autoironia aiuta. Sì, sono monotona, ma a casa piango sempre: questa casa che abbiamo tanto amato, con queste antiche mura che ti piacevano molto, sto cominciando ad odiarla. Eppure è come il ricordo di te: non potrei farne a meno. Stamattina il termometro sul terrazzo segnava meno due. Mai visto così basso, qui. Si gela e il gelo di fuori fa compagnia al gelo che ho dentro. Mi fa male il cuore, mi fa proprio male, è proprio dolore fisico; ma so che non è malato: è solo stretto da questo maledetto dolore che col passare del tempo si gonfia dentro e mi stritola, ma mi lascia qui. Sola, sola, sola. Questo silenzio. Dio, questo silenzio. Chissà se sono tutte come me, le vedove. Perché ne incontro alcune che sembrano essersi riprese finalmente la loro vita, che sono rifiorite, mi guardano con malcelata aria di complicità, come se io fossi come loro, come se io mi fossi liberata come loro. Ma io ho vissuto in osmosi con te e tu con me. E allora da sola non leggo più, non scrivo più, non penso più al giardino, giro a vuoto per casa, non riesco più nemmeno a vedere un film fino alla fine. Perché, perchè? Oggi ho ritrovato tra le tue carte la parte finale di una poesia di Umberto Saba che tenevi in vista sulla scrivania quando il male ti è caduto addosso: “E tanto in cuore aver d’amore da dire: tutto è bello anche l’uomo e il suo male, anche il me quello che m’addolora”. Ma io non ho la tua saggezza, il bello in questo mio dolore non riesco proprio a vederlo. 13 Camelia Ciuban Te ne vai a Raffaella Te ne vai vestita d’avorio e di seta in quel viaggio che da tanto prepari, di sola andata. Ad occhi chiusi come se già conoscessi la strada, senza nemmeno calpestare la terra che troppo poco per te è stata culla. Quel tuo profumo azzurro che pare un pezzo di aria caduta dall’alto è qui a bagnare i giorni d’estate. Oggi non credo nei cieli. Eppure ho promesso a tuo figlio che d’ora in poi sarai il suo angelo custode. Lui non mi ha chiesto niente mi ha solo detto con la tua luce negli occhi che lo sapeva già. 14 La tua città A Ilaria Allodi Profuma d’autunno e d’angoscia la tua città sommersa dai tigli, denudati ormai e salenti come lumache sui muri dopo la pioggia. I passanti non guardano dritto e gl’innamorati non si baciano più la sera, negli angoli bui. 15 A Fabrizio Quattrocchi Mentre moriva ho visto l’eroe nella terra lontana afosa crollava dal suo destriero su teneri amori non nati. Rivolto verso ponente pensava alla madre, pareva, ai giochi d’infanzia lontani una vita, sapeva che doveva morire! Così arrabbiato con Dio per non aver chiarito la sua posizione non sembrava nemmeno indifeso l’eroe morente. L’hanno sepolto più tardi in un luogo comune, sempre più vasto. Sulla lapide hanno scritto qualcosa di troppo consueto, insulso. Soltanto il suo nome ricorda la luce. 16 IL PRIMO Di Maria Concetta Scordi Chissà se poi è vero. Sarà una delle sue scuse per farmi andare da lui. Oggi mi sente però. Glielo dico: “Lei non è mica mio nonno”. Scattare, correre, rispondere; sempre così. Dove sono le scarpe? Sempre di corsa, sempre tutto di corsa con lui. “Senti, dobbiamo rimandare il mare oggi, non so, dice che il signor Crestobano è morto. Chi lo dice? Non ho capito bene, mi ha chiamato il medico che è stato chiamato dalla polizia che è stata chiamata dalla badante. Non so, non credo, vedremo”. Quest’altro egoista poi, perché non va lui invece di delegare me? Ah, i medici! Ora lo richiamo e glielo dico. Non è che solo perché è domenica, è luglio, e ci sono quaranta gradi… ora lo chiamo e glielo dico che ci può andare lui. E invece ci vado io, voglio andarci io. Le chiavi, il cellulare, tutti i suoi documenti, tutti i suoi… Primo, terzo, quinto piano, ho il battito accellerato, esagerato, saranno le scale. Ora mi sente, ora mi deve spiegare. E questo teatrino? La porta aperta, il vociare, la polizia? “Lei è una parente, una nipote, una…?” “Sono la sua assistente sociale, l’assistente sociale della S.A.M.O.T.” “Ah, bene. Può spiegarci… deve compilare… chi si occuperà…?” “Dov’è?” Dov’è il silenzio e il raccoglimento e il vuoto urlato della morte? Dove le donne compunte o biascicanti e i pianti laceranti e le ceneri sul capo e i capelli sul pavimento e i pugni sul petto? Dov’è lui? “Ah, ecco, lo abbiamo coperto per non impressionare…”. Voglio vedere, sei davvero morto? Nudo sotto il lenzuolo, secchi rami legnosi il tuo pene e il tuo collo e le tue dita. Chi ti ha messo in mano la coroncina del Rosario? A te, agnostico e strafottente? Ecco perché sembri sorridente, stai sfottendo? Sei proprio tu, ti riconosco, beffardo egocentrico, sornione e accentratore ed egoista e… e… e inqualificabile che non sei altro. Dio mio, morire in sordina no, eh? Che so, un lavorativo, un feriale, un Lunedì. Ecco, sì, un Lunedì sarebbe stato perfetto! Ma no, tu no, rognoso fino alla fine, così l’ufficio servizi funerari del comune è chiuso e io… come ti seppellisco io? Brutto… Ho bisogno d’aiuto, devo chiamare… ora chiamo. E invece faccio da sola, voglio farlo io, lo faccio io. “No, la moglie è morta un anno fa e gli unici parenti sono al Nord, non hanno rapporti da anni, sapete, aveva un carattere un po’ così, ha fatto terra bruciata attorno a sé e ogni sua relazione era conflittuale. Io… noi siamo un’équipe che fa assistenza domiciliare integrata per cure palliative. Sapete, quel servizio dell’ASL per migliorare la qualità di vita dei malati di cancro in fase terminale. Sì, lui aveva un cancro ai polmoni con metastasi ossee che lo divoravano da un anno e mezzo, credo un anno e mezzo circa. Io lo conosco da un anno e mezzo e noi cerchiamo di alleviare il dolore e… cioè, il medico fa questo e l’infermiere gli medicava le piaghe e io…”. 17 Tutto il resto. Io ti ho fatto tutto il resto, caro il mio signor Crestobano che muori in maniera così eclatante, così fastidiosa, così sbagliata. Proprio adesso che imparo a prenderti, che trovo un equilibrio e che sono tranquilla, perché ti so assistito, perché ho trovato una mercenaria che non è scappata da casa tua dopo due ore, due ragazzi che non litigano con te la notte e che ho accettato la tua delega per la pensione, perché mi hai sfinito con questa richiesta, e che ho fatto quella fila estenuante all’INPS e al municipio e che ho trovato chi ti porta la morfina quando ti serve e proprio adesso che non mi fai più impazzire, tu… tu non mi farai più… Bene, mi tocca tutto il resto con te, sempre, e adesso che non hai più dolore, sintomi, malattia e che nessuno né può né deve più far niente per te, ancora a me tocca il resto. E chiudiamola allora quest’assistenza, chiudiamola come si deve, chiudiamola a vita, chiudiamola con te dentro la tua bara. “Grazie, siete gentili, pomposi avvoltoi delle onoranze funebri con l’impresa sotto casa e il binocolo puntato alla finestra ma vedete, il signor Crestobano non ha una lira liquida, anzi non so se potrà… potrò… se si potranno liquidare i badanti che lo hanno assistito in quest’ultimo mese perciò… sì, capisco che vi pare triste, ma a lui il servizio funebre del comune andava benissimo, e poi in ogni caso non ha soldi per il vostro. Sì, giovani poliziotti che avete dovuto coprirlo perché le sue ossa vi impressionavano, i parenti lo sanno e hanno acconsentito al servizio comunale e sono pronti a ritirare le sue somme vincolate in banca. Anche se lui voleva donarle alle suore di Madre Teresa. No, non ha scritto nulla, me lo ha detto e ridetto e voleva che l’aiutassi a scriverlo ma io ho rimandato e rimandato e siamo a oggi. Grazie, grazie a tutti”. Dovrei fumare e ho già finito le sigarette. Scusa, permetti? Te ne rubo una, tanto tu che te ne fai? Anzi sai che faccio? In questo clima di sciacallaggio mi lascio coinvolgere e mi prendo tutto il pacchetto. Lo voglio io il tuo ultimo pacco di sigarette. Diamine, mi devi pur ricompensare in qualche modo,e mostrarmi riconoscenza e gratitudine e farti perdonare. Soprattutto farti perdonare. Mi sa che ho l’argomento per le prossime sedute d’analisi. “Allora, questi sono tutti i soldi che aveva in casa, eccovi pagati. Lei, signora, per favore domani faccia quest’ultima cosa, vada al comune e completi la pratica del funerale. Ma sì, si porti il frigo se glielo ha promesso, tanto i parenti hanno detto di sì, e voi ragazzi sì, potete portarvi gli abiti. No signora, gli abiti li lasci a loro, suo marito ne ha. Una curiosità: chi ha chiamato la polizia e perché? Voi? Non capivate se era morto? Avete avuto paura? E di che, buon Dio, di che?” E’ finita, ho le chiavi, domani le consegno ed è finita. Ma lui è ancora lì, in casa, nudo, avvolto in un lenzuolo, dentro la bara chiara del comune, in attesa che sia Lunedì, che vengano a prenderlo per la sepoltura. E chi ti veglia stanotte? Resto io, tanto non dormirò comunque. E a che serve la veglia? A chi serve? Meglio non esagerare, credo di dover andare. Sono a casa, con le sue, le mie sigarette e mi aspetta la mia notte. Cosa ho detto a quella gente? Cosa ho detto a lui? Quali pensieri davanti al suo corpo? Realizza, realizza… sei arrabbiata. Arrabbiata? Sì, e incredula e stizzita 18 e vorresti che fosse dinanzi a te, vivo, per gridargli tutto in faccia. Dio mio, tutto cosa? E perché mai poi? Arrabbiata con un morto solo perché è morto, con questa voglia malsana di chiedergli spiegazioni. Per esempio? Per esempio… non mi ha salutato e scusa se è poco. E non mi ha mai ringraziato. Bè, quasi mai e comunque sempre troppo poco e mai come si deve. E soprattutto non mi ha avvisato, non mi ha lasciato intendere… L’ho visto ieri, ha mangiato, ha pure mangiato! E abbiamo parlato: “Questa signora è brava, ha pazienza. A che punto è la delega? Prenda anche gli arretrati e li tenga lei o li dia in beneficienza. E lei come sta?” “A posto, signor Crestobano, tutto a posto. Lunedì le porto i suoi soldi e lei ne fa ciò che vuole. Ho portato la morfina così nel fine settimana è coperto. La signora mi ha detto che ha mangiato la pastina. Sente caldo? Si scopra un po’. Lunedì viene l’infermiere. Sì? Siamo tutti bravi?”. Però nessuno ti ha vestito. Neanche le mutande. E già che siamo a Luglio, e soprattutto che tu sei morto e non puoi sentire freddo, ma un cadavere seppellito nudo non si è mai visto. Io ti avrei vestito ma mi ha bloccato il tuo pudore. Non ti sei mai fatto trovare a petto nudo da quando ti conosco, mi sembrava di tradirti scoprendoti e toccandoti all’ultimo, senza che tu potessi obiettare. E poi ha un suo fascino questa nudità in bara, sa di abbandono a tutto e di tutto, sa di fine profonda, fonda, di restituzione totale. E poi non mi hai mai dato consegne in merito, mai una disposizione sull’abito o sulle scarpe. A volte mi chiedevi di aprirti l’armadio che avevi di fronte e guardando dentro sorridevi e facevi un gesto di menefreghismo, di strafottenza, di disinteresse. Oppure mi dicevi, accompagnandoti con la mano: “via, via… questo tutto via” e tornavi a guardare fuori la finestra. Avevi preparato tutto. “I gioielli di mia moglie li ho dati. I miei documenti dove sono? Dopo la delega li lasci nel cassetto. Si deve pagare questa santa donna. Me li conta i soldi? Ci pensa lei? Ci pensi lei. Lei crede in Dio? Mah… pensieri… vedremo. Quando torna? Va in ferie? Non parliamo di Settembre… non parliamo di domani”. Il mio primo paziente, i miei primi dialoghi con un morente, con te morente. E non ne ho capito niente. Non ho capito che mancavano settimane, e poi giorni e poi ore. Se avessi capito, se avessi saputo… “Cosa? Cosa avrebbe fatto? Cosa di diverso? Cosa in più o in meno?” “Dottoressa, io… l’avrei salutato. Sarei stata diversa, avrei potuto dirgli…”. “Lo sapeva. Eravate voi, nella vostra relazione, nella vostra modalità comunicativa. Cos’è più importante, che la gente da lei si senta amata o aiutata?” E con questa bella domanda che mi frulla in testa mi dico che la sua riconoscenza l’ho avuta. E’ solo che non posso aspettarmi che l’altro la esprima come farei io e che devo saper leggere i suoi messaggi alla luce della conoscenza che ne ho. E so anche che ha sentito il mio affetto, la mia comprensione, senza che io abbia dovuto verbalizzarli ad ogni costo. E allora? Dottoressa, mi liberi… “Lei è arrabbiata perché lui se ne è andato nonostante non fosse pronta. Lo lasci andare e basta. E riconosca il fatto che lei è a lutto”. 19 Io? Io a lutto? Mi aspettavo che ne sparasse una grossa ma questa! E perché mai? Che c’entra? Mica era un mio parente, mica ero una sua parente. Sono un operatore, una professionista, un’estranea! E poi sono passati sette, forse dieci giorni! E che c’entra il lutto con la rabbia? E questa tristezza di fondo che non mi lascia? Questa inquieta ribellione che non trova sfogo? Questa apatia diffusa e questa sorta di disinteresse per tutto? Sono depressa? Mi aspettavo mi dicesse che sono depressa. Del resto io mi sento proprio depressa. Gli operatori non vivono lutti per i loro pazienti, al massimo si deprimono un po’, come sta succedendo a me. Eppure ho letto tanta bibliografia in proposito, soprattutto quel libro… Dov’è, dove l’ho messo? E anche l’articolo di… e quel testo, come s’intitola, con le fasi del lutto. Com’era? “Stupore e incredulità segnano la negazione iniziale dell’evento; segue una sorta di rifiuto rabbioso dell’accaduto che lascia gradualmente il posto all’apatia e alla depressione proprie del processo di accettazione; giunge infine un’elaborata tristezza e una lenta ri-appropriazione del defunto attraverso i ricordi e l’attribuzione di significati…”. Ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho. Mio Dio… sono io, è il mio ritratto interiore. Miscuglio confuso e incerto di tutto questo, proprio come da manuale. “Non esistono fasi perfettamente distinte ma più spesso sovrapposizione dei vari momenti”. Alterno rabbia ed apatia, tristezza a incredulità e fuggo i ricordi come la peste o mi ci crogiolo dentro come un feto nel liquido amniotico. E poi di quanta significatività sto caricando ogni momento di questa storia, di quest’assistenza. Non è un caso che ti abbiano assegnato a me, eri pure fuori zona! Se penso che dopo pochi mesi, giusto il tempo di instaurare una minima relazione di fiducia, tua moglie ha avuto un ictus e ti sei ritrovato improvvisamente costretto a fare ciò che non avevi mai fatto: prendere decisioni, prenderti cura tu di lei. Stavi così male che hai dovuto chiedere aiuto. E a chi ormai, se non a noi, a me, unici punti di riferimento? Trova un’assistente privata e poi un’altra e poi un’altra perché eri proprio un dispotico maresciallo dei Carabinieri con cui nessuno voleva avere a che fare. E quando tua moglie è morta? “La prego, non so dove andare a stare, mi accompagni a girare le case di riposo.” Cinque settimane di lavoro e un giorno non rispondi più al telefono, al citofono: scomparso. Ti rifai vivo dopo un mese dicendo che avevi affittato un bivani e se potevamo riprendere l’assistenza. “ Certo signor Crestobano, che problema c’è? Dove abita adesso? Via Indovina numero 3? No, lì ci sto io, al numero 5…” Che persecuzione! Lo hai fatto apposta. Lo sapevi? No, non ne sapevi niente di me. Coincidenza a cui adesso attribuisco un senso: ho potuto assisterti, monitorare meglio le tue richieste, garantire risposte più immediate, insomma il mio bisogno di controllo era appagato. Grazie a te e a quest’assistenza mi sono conosciuta. La mia poca, poca pazienza, il mio bisogno di fare continuamente frustrato dalla tua autonomia, il mio imparare gradualmente il silenzio, il sano silenzio. Ho imparato a riconoscere che ce 20 la facevi, che dovevo muovermi solo su richiesta, che dovevo accettare decisioni assurde e rispettare il tuo snervante desiderio di indipendenza contro ogni dato di realtà. Ho trasformato il mio fare a tutti costi in capacità d’ascolto e analisi della domanda e ho potuto così esplicitarti quelli che mi sembravano i tuoi bisogni senza voler con questo costringerti a darvi risposta. Ho imparato a individualizzare l’intervento professionale, a rispettare chi avevo davanti e a fornire solo l’aiuto che mi veniva chiesto. Ho cercato, Dio sa e tu sai se ho cercato di importi il mio aiuto e proprio quello che io ritenevo ti servisse ma per fortuna non ha funzionato. Non funziona mai. La verità è che sei morto come hai voluto, così come hai vissuto e che è stato possibile starti accanto con azioni concrete che alla fine entrambi ritenevamo utili. Abbiamo contrattato, tanto, prima di giungere al nostro contratto; però alla fine era proprio condiviso. Mi hai sopportato quanto io ho sopportato te e mi hai scelta per alcune intime deleghe perché ormai ero capace di prenderle con discrezione, senza colpi di testa, senza pretese da eroina. In quest’assistenza comparivo poco perché ero diventata solo una parte del tuo corpo. Ti ho prestato le mani, i piedi, l’auto e la voce per lasciare attorno a te tutto come volevi. Ho raccolto i tuoi testamenti e li ho eseguiti. Quando insistevi troppo in una richiesta mi interrogavo sulle mie resistenze e mi ritrovavo a scoprirmi spesso stereotipizzante e piena di luoghi comuni su cosa può e deve fare un operatore sociale. Il mio dibattito interno sull’identità professionale e lo sviluppo dell’approccio critico alla metodologia sono cominciati allora, per l’esasperazione che produceva in me il tuo voler decidere che aiuto volevi. Non mi sono mai potuta sentire brava né buona in quest’assistenza (quante volte abbiamo litigato?), né mai commuovermi per struggenti emozioni di sapore cinematografico (e quale ragazzetta assistente sociale non se le aspetta dalla relazione con i malati terminali di cancro?), né mai professionista dalla spiccata e riconosciuta umanità (quante volte ti ho maledetto?), ma non mi sono mai sentita così utile. Con te ho seppellito il mio paternalismo, davvero e per sempre. Adesso sono a lutto perchè tu sei morto. E per forza, evidentemente, se io sono a lutto tu sei morto. E muori allora, vai, se devi, vai nonostante tutto, nonostante me. Io trasformerò quest’assistenza in esperienza, traccerò le mie linee guida per continuare in questo lavoro, per non lasciarlo. Intanto sono a lutto. Devo cominciare a piangerti. E’ l’ultima cosa che faccio per te. E per me. Mi sa che prima di far entrare altri morenti nella mia vita devo far andare via te, così, sai, eviterò lutti su lutti perché il primo è irrisolto. Quest’altra soddisfazione, di restare l’unico, non te la do. E’ già tanto che sei il primo e che sarai per sempre. Allora ti saluto: com’è che ti chiami? Qual è il tuo nome? Girolamo, Vittorio, Alfredo, Tullio? Ci penso e ripenso da giorni e non riesco a ricordare. Comunque, signor Crestobano, credo proprio che non sia importante. 21 Poesie Arnaldo Maravelli Mio Ulisse Immagino in quell’attimo il tuo travaglio per tornare qui dove con noi eri felice e disperata gridò la vita che fuggiva non vissuta e l’estrema preghiera a chi, se mai ci fosse, sconosciuto, avrebbe potuto aiutarti e l’addio non ancora sicuro quando nel cozzo col drago infinite volte da te domato sentisti le forze venir meno. Costretto, vidi il giorno dopo che il tuo viso era di marmo di una incredibile bellezza e c’era l’ombra misteriosa un velato sorriso di vittoria. Lì si svelò la beffa della sorte per quell’attesa già matura e vidi Ulisse in quel minuto. Vecchio Laerte, scendo, eroe, nell’erebo muto ad incontrarti. 22 Vento Da troppo tempo ormai non udivo la tua voce, ma oggi quando il vento si levò all’improvviso e fece suonare come arpa gli aghi dell’abete, mi svegliai di soprassalto dal torpore di anni e mi accorsi che nell’aria c’era qualcosa di nuovo qualcosa di strano che mai prima avevo avvertito. Era un messaggio leggero che passava tra a anime che si erano credute l’un l’altra perdute e si ritrovavano in quel dolce sussurro. Le tortore litanianti sono tutte ammutolite, i nostri respiri, figlio, e le nostre vite si sono fuse in quell’attimo senza tempo. 23 La spada Lo so, non per voluto eroismo impugno la scrittura come spada, ma per vendetta, sfida, e per amore contro quel dio che indifferente atomi aggrega e disgrega per gioco. La lama separerà di netto ciò ch’è fatto per caos o per caso da ciò che con pazienza e amore gioia e amore costruiscono perché duri nel tempo oltre la morte. Solo sé vede quel dio che non ha figli. Scrivere è esserci, anche per poco, prima che il suo dito ci disperda. 24 PROPRIO ADESSO di Marco Pasinetti La nonna è morta, inteso proprio nel senso del morire, che arriva il medico e “constata il decesso avvenuto”, alle nove e dieci della mattina del 14 aprile 2004. Era un giovedì, il giorno in cui al mio paese si fa il mercato e si dice che è il giorno dei matti, ed io, in quel preciso momento in cui mia nonna moriva, stavo facendo la mia colazione di tutte le mattine, espresso e brioche alla crema, in un anonimo bar lungo la strada che da dove vivo adesso porta al paese di mia nonna che poi è anche quello dei miei genitori e comunque anche il mio, anche se io non ci vivo più da dodici anni. Mi ricordo che sfogliavo velocemente La Gazzetta dello Sport e pensavo che forse mia nonna sarebbe morta proprio in quel momento lì e io sarei arrivato in ritardo perché avevo voluto fare colazione al bar anche quella mattina anche se mia nonna l’avevo lasciata la sera prima alle nove e mezza esatte e si capiva che, pur se il suo cuore era così forte da destare in me un’ammirazione quasi anatomica, sarebbe morta di certo in poche ore. Mi divoravo con questo rammarico in esercizio già sul presente e contemporaneamente continuavo ad avere la solida certezza che lei non sarebbe mai morta, e quindi neanche in quel momento, per le due buone ragioni che non era mai morta nemmeno fino a quel giorno e che aveva, appunto, un cuore che per me – ero stato a guardarlo per ore ed ore, ritirarsi e gonfiarsi ancora quando il resto del corpo era già addormentato sul suo letto –era come un toro ferito ma sempre nero e potentissimo. Questo miscuglio ingestibile di sensazioni contrapposte mi permise di bere il mio caffè stando seduto e di sfogliare il giornale ma, insieme, mi costrinse ad una moderata fretta in tutte le operazioni che eseguivo. Il 25 risultato fu che arrivai alla casa della nonna alle nove e un quarto precise, parcheggiai l’auto, salii le scale, aprii la porta d’ingresso che era aperta, e la zia – la zia Silvana, intendo, l’unica vera zia rimastami – mi disse che la nonna era morta da cinque minuti. Mia nonna, che io sappia, era stata tre volte in ospedale nella sua vita e non per partorire i quattro figli, due maschi e due femmine, che ha dato a mio nonno Angelo che dei miei quattro è il nonno che purtroppo non ho mai conosciuto. La prima volta che c’era stata doveva essere nel 1979 o nel 1980 - io comunque ero alle elementari e mi ricordo solo che facevo delle lunghe passeggiate nel giardino del grande ospedale ma non mi ricordo se era con lei o se mi facevano passeggiare per non farmi vedere la nonna che non stava bene e soffriva mentre io ero ancora troppo piccolo - quando entrò per un problema ad un orecchio che poi si scoprì che non era proprio solo un problema ma più esattamente quel tipo di problema abbastanza complicato che comunemente definiamo tumore maligno. Quando ritornò a casa l’orecchio non c’era più e le zie a turno venivano a farle la medicazione che da quel momento prese ad essere uno dei riti che battevano il tempo delle mie giornate che, a parte, la scuola e il campetto, trascorrevo quasi interamente a casa di mia nonna. La seconda e la terza volta in cui mia nonna fu ricoverata accaddero a circa un anno di distanza l’una dall’altra, nel 2002 e nel 2003. La prima di queste due volte arrivò in ospedale d’urgenza, di domenica, e quando arrivai io lei era piena di tubi e di canali che non si capiva bene se partivano da lei o vi arrivavano e non mi parve affatto cosciente. Siccome lei era una persona così cosciente sempre che penso che uno dei tre aggettivi che userei per descriverla anche adesso che è morta da quattordici mesi è certamente vigile, io pensai che se non mi sembrava cosciente doveva essere morta o sulla strada per diventarlo. In effetti si 26 scoprì che un infarto le aveva fulminato tuttauntratto (un tratto che segnava la sua carta millimetrata della vita esattamente al punto anno ottantaquattro e mezzo) un quartino di cuore ma lei dopo una breve immersione nel subcosciente che era un posto che non le veniva tanto di andarci di suo ritornò a galla con la solita grinta e si informò anche su quello che le era sfuggito quando era là sotto. In quel soggiorno ospedaliero e anche nel successivo io ero già abbastanza grande e avevo peraltro a mia volta piena coscienza di quella del tutto peculiare forma di adorazione che nutrivo per mia nonna, così passavo quasi tutti i giorni a trovarla, solo per chiacchierare o anche, se serviva, per imboccarla: se avevo un’ora di tempo nella mia giornata con la scusa che vivo anche molto vicino all’ospedale – mi portavo là e tante volte penso che una certa camminata che io e mia zia abbiamo fatto con lei una sera di quelle che cominciava ad avere un po’ di forza, sostenendola dai lati mentre andavamo avanti e indietro dal corridoio del reparto, sia un ricordo che non lo puoi dare via per niente e che è uno di quelli che mi fa sembrare tutti i giorni che lei c’è anche adesso che non c’è più. Il terzo soggiorno, invece, mia nonna entrò per un’infezione alle vie urinarie che le dava forti problemi di respirazione e certe crisi ed uscì che sapevamo che aveva un brutto male al fegato che però, ci disse il medico, nessuno sa quanto tempo ci mette a svilupparsi in una persona così vecchia che le cellule sono davvero stanche di riprodursi e magari uno vive ancora una vita e neanche muore di quel male lì. Così, noi, la mia famiglia di sicuro ma credo anche tutti gli altri, ci prendemmo la libertà di credere che lei ci avrebbe dato filo da torcere ancora per un bel po’ e anche se da quel giorno il suo muoversi fu un muoversi dentro la sua casa, anche se mio padre diceva sempre che vedeva che invecchiava, anche se lei stessa diceva sempre che non capiva che cosa aspettasse il Signore a raccoglierla, anche se molte cose 27 insomma, lei andò avanti ancora un anno e così ci facemmo ancora molte belle chiacchierate. Appunto: se uno mi chiedesse che cosa mi manca di mia nonna a parte le cose che comunque già da anni non facevamo più perché io già da anni non ero più un bambinetto, tipo che lei mi cambiava la canottiera sudata dopo un pomeriggio passato a giocare a pallone o che mangiavamo la minestra di latte a cena guardando Orzowei che a casa mia non avrei mai potuto farlo, cioè se uno mi chiede che cosa mi manca delle cose che facevamo ancora quando io ero già grande e fino a una settimana prima che lei morisse davvero, ecco, mi manca che chiacchieravamo bene, ogni volta che io andavo a trovarla, ci mettevamo lì con le nostre tre sedie – una per me, una per lei, una per la sua gamba che era piena di piaghe e lei così la stendeva – e parlavamo di tutte le cose di cui dovevamo parlare, ininterrottamente e senza dire una sola parola in italiano se non proprio quando le dovevo spiegare che cosa stavo studiando all’università e non sapevo proprio come farle capire in dialetto di che cosa si occupava l’epistemologia o che cos’era un’ idea pura. Tutto quello di cui dovevamo parlare erano proprio tante cose ma forse soprattutto che io le raccontavo come tiravo faticosamente avanti con le mie magagne dell’anima e lei mi raccontava di come tirava faticosamente avanti con le sue magagne del corpo e ci facevamo coraggio a vicenda e io sentivo che lei aveva fiducia in me e credeva che ce l’avrei fatta anche se in un modo tutto mio originale (perché lei pensava che io fossi tutto un po’ originale anche solo perché non avevo mai la maglietta stirata o perché mi piaceva viaggiare o perché avevo i capelli troppo lunghi ma, e questo ha sempre fatto la differenza per me e così io le raccontavo tutto senza limiti, non mi faceva sentire troppo giudicato per tutte le mie bizzarie e per le mie scelte ) e lei rideva perché io non le credevo che con 28 tutte quelle magagne lì poi il papà mi diceva che l’aveva trovata ancora sulla scala che spolverava i mobili in alto che, tra l’altro, a me mi sembravano già belli puliti. Poi lei diceva Che cosa aspettava il Signore a prenderla e io dicevo che avevo visto il Papa di sfuggita in tivù e che mi sembrava che stava molto peggio di lei anche se aveva tre anni in meno perché lui è del Venti e questo tante volte metteva un po’ di pudore nel suo dolore perché il Papa per una come lei era sempre il Papa e le dispiaceva sinceramente che soffriva. E alla fine, in questi casi, io lanciavo la scommessa se moriva prima lei o prima il Papa e lei si scherniva e io puntavo sul Papa che alla fine invece ha vinto lui perché è campato male ma sempre tutto un anno più della mia nonna. Dal momento in cui l’hanno messa nella bara io sono stato seduto lì davanti per due giorni interi, solo eccetto che andavo a casa a dormire di notte e che ho dovuto farmi quaranta chilometri il pomeriggio di venerdì per una stupidissima riunione di lavoro che, però, pareva proprio irrimandabile. Comunque ho fatto presto e così non mi son perso neanche la veglia della vigilia che a suo modo era imperdibile, per i tre buoni motivi che c’era un sacco di gente che era venuta a pregare per mia nonna e mi sentivo in compagnia, che il prete non ha mica detto delle cose stupide, che mia nonna che nella sua vita deve aver detto rosari per mezzo universo, secondo me, se si lascia perdere un po’ di schernimento di facciata, avrebbe avuto piacere se quelli che rimanevano indietro ne dicevano un paio anche per lei. Così la Piera e il prete guidavano le altre donne e io le osservavo ammaestrato e mi venivano in mente tutti quei segreti passati per le dita di mia nonna e il rosario brasiliano in legno di noce di cocco che le avevo regalato l’anno prima e che adesso è arrotolato intorno alla mia sveglia senza che io lo guardi molto ma che ogni tanto lo tocco e mi sembra chiaro che se si 29 raggiungono le nostre impronte vuol dire che questa cosa qui che ci è toccata in dono, cioè di amarci, non è nel tempo e non c’entra niente con il fatto di esserci o no sulla terra. Le ore che ho passato lì, la vicinanza ostinata che mi ha colto quando solo il suo cuore ci parlava ancora e poi quando l’hanno stesa a raffreddarsi e l’ho guardata talmente tanto e da una posizione così insolita che per la prima volta mi sono accorto che aveva il naso affilatissimo e con un leggero spigolo a metà, quelle ore, mi hanno fatto benissimo. Ero un animale che non poteva staccarsi dal posto da dove veniva, strenuamente, nel sordo convincimento che solo così avrei potuto risolvere il mio dolore. Vivevo tutto il dolore, davanti, perché sapevo (ma non sapevo come lo sapevo) che dovevo presiederlo, starci, per farmelo entrare dentro, mangiarlo perché si riponesse in me e si trasformasse in altro, masticato dal distacco e dalle cose che sanno andare avanti. Sono sicuro che quando penso a mia nonna so sorridere – sorrido con nostalgia, ma non è maligna, questa nostalgia, anzi – perché ho saputo stare lì in quei momenti, prendermi tutto, prenderli tutti. Il momento in cui mia nonna è morta è arrivato per me nel momento giusto, adeguato, come se lei avesse pensato che ero pronto, che eravamo pronti. Le persone che avevo intorno erano pronte, facevano le cose che si devono fare quando muore una persona che ti è cara: tacevano, parlavano confortandosi, ricordavano, si stavano vicine, dettavano l’annuncio al giornale, piangevano, sceglievano il legno della bara e i fiori del funerale, ridevano raccontando quanto testarda e piena di manie fosse quella persona. Mio padre guardava la gente che arrivava e diceva a mia zia che era venuto il tal e tal altro cugino di mia nonna, la tal vicina e che erano stati gentili a venire e che qualche volta noi non eravamo andati e che invece era importante andare perché a uno poi gli serve che altri lo confortino 30 in quei momenti e che forse bisognava imparare a farlo di più anche noi quando toccava a noi confortare gli altri. Siccome mio padre non è uno che dice cose come queste così a caso e siccome è uno che non concede tanto, uno asciutto, questa cosa qui dev’essere proprio vera, non è solo una cosa che ho sentito io cioè, ma si può dire quanto meno che ci è dato di assumerne una sua condivisibilità intersoggettiva, che tutti insomma dovrebbero darti una mano in un momento così, ascoltarti e se l’imbarazzo non li travolge dirti anche qualche cosa che tu senti che ti sono vicini, sono lì, e allora pensi che in un mondo così si può spartire il dolore e si può anche morire tranquilli quando viene il momento. La mattina del funerale sono arrivato presto e, quasi da solo e in pace, ho guardato per l’ultima volta la faccia di mia nonna per cinque minuti prima che i signori blu delle pompe funebri saldassero il coperchio della bara e ce la portassero via. Le ho messo un biglietto nella tasca della veste, così se vuole ogni tanto se lo guarda e quel biglietto dice tutto quello che dovevo dirle e niente di più. Poi sono sceso nel parcheggio da cui partiva il corteo e ho pianto così tanto prima che arrivassero tutti gli altri che poi alla cerimonia e al cimitero mi sembrava che non avevo più lacrime per piangere e guardavo chi c’era e com’era elegante mio zio Cecco che era l’unico fratello maschio di mia nonna e io l’avevo sempre visto con una tuta da lavoro blu ma sporca di verde perché il suo lavoro era il contadino. E mentre lui mi diceva come mai non mi facevo mai vedere e che m’ero fatto forestiero e di andare a trovarlo ma sempre un po’ biascicando perché era ancora commosso di quando avevano deposto la bara della nonna, io pensavo a come doveva essere la loro famiglia quando erano piccoli e mi veniva in mente quella scena che mi viene sempre in mente anche adesso in cui c’è mia nonna che con i bambini che vivevano alla 31 cascina del Cöc va verso la scuola, d’inverno, per una strada sterrata lunga dei chilometri e piena di neve e lei rimane sempre indietro ma l’aspettano perché è la più piccola e gli adulti se la sono raccomandata ai più grandicelli. Questa scena mia nonna me l’ha descritta mille volte perché parlavamo spesso di quando lei era piccola e anche di come si allevavano i bachi da seta e così, a ruota, di com’era il gusto del frutto del gelso che però non l’abbiamo mai chiamato gelso una volta perché qui si chiama ancora morone anche se adesso non ce ne sono più. Io aspettavo che lei avesse la vena buona per raccontarmi tutto questo mondo e le facevo mille domande perché volevo capire bene e volevo ricordarmi tutte queste cose che così mi rimanevano in mente anche quando lei era morta e non poteva più raccontarmele. Penso che ho fatto proprio bene a farle tutte quelle domande e a osservarla bene quando c’era. Adesso quando voglio mi rimetto lì e la vedo che mi cambia le magliette a sessant’anni, o che parte per il pellegrinaggio in giornata a Lourdes in aeroplano a ottanta, o che mangia sorridente a capotavola al pranzo della mia laurea a ottantaquattro, il giorno 4 giugno 2001 che è l’ultima volta che ho visto i miei nonni vivi tutti e tre insieme. Se ho un’altra voglia, invece, mi guardo la prima parte del film, quella che potrei pensare di non aver visto, se non mi ricordassi così bene di lei che rimbrotta mio nonno sulla sua moto al ritorno dall’osteria una domenica degli anni cinquanta. Ero lì, mi sembra, sono lì anche adesso. Abbiamo gli occhi sbarrati e il naso tappato: proprio sul piazzale dove al mio paese ora c’è il cinema ci sono i Mongoli, creature fiabesche, brutti ed enormi, mangiano e dormono per terra, sporchi come mai avevamo visto prima, stesi così, proprio a due passi dai loro cavalli. 32 Antonella Salvato Luglio, non m’incanti col tuo sole sfacciato. Io non odo richiami, non sento profumi d’estate. Solo, nella penombra della casa, il gorgoglio dell’ossigeno. Il mio tempo è una goccia che scende a nutrire le vene, è il respiro stanco di mia madre; è la sua mano chiusa nella mia, impercettibile fremito, a trattenere, un istante ancora il tenue filo della nostra storia. 33 Allenta i lacci di quest’amore soffocante. Veleno dolce è il tuo latte che intorpidisce i sensi. Io voglio correre come gazzella su verdi prati, volare oltre i confini del mondo. Sto vomitando versi per liberarmi di te. Voglio plasmarti con la parola, guardarti in faccia com’eri, come rimani in me, rimpianto antico, desiderio, sogno mai appagato. 34 Lascia ch’io ti sotterri. Non pretendere da lontani spazi imperitura dedizione. Lascia ch’io m’incammini. Non ingombrare con antiche nenie i miei giorni. È tempo di commiato, mamma. 35 Opere segnalate 36 TUTTO NERO di Catia Salvadore “Cosa conta non venir feriti, se si è spaventati a morte?” E. Hemingway Cosa volevi fare? La scrivania si era macchiata un poco. Lì, vicino al bordo, davanti alla bambina. Il sangue era filtrato attraverso la garza. Una retina rossa disegnata sulla formica candida del ripiano. “Cosa volevi fare, Agnese?” La dottoressa infilò una mano nella tasca del camice e tirò fuori un kleenex. Così, senza smettere di parlare, come fosse tutto normale. Pulì il tavolo. Strisce rosse sottili scomparvero di nuovo nel bianco. Strinse il fazzoletto di carta in pugno, e lo fissò un attimo con gli occhi assorti, come fosse qualcosa di prezioso. Poi fece un sospiro e lo buttò nel cestino e alzò lo sguardo sulla piccola paziente. Agnese teneva la testa bassa e stringeva il disegno con la mano, quella con il polso ferito. Le dita contratte l’avevano stropicciato ai bordi. Come se avesse paura di farlo cadere. Era l’ultimo. Tutto nero, non importava. Era il più bello. Gli occhi sbarrati presero a scattare all’intorno. Controllavano i colori. C’erano muri bianchi. Come la scrivania e le porte. Tutto bianco. Strizzò le palpebre con fastidio. Poi guardò la faccia pallida che sbucava sopra il camice. Risaltavano le vene azzurre nelle occhiaie. Agnese pensò che la sua mamma non le aveva mai avute delle occhiaie così blu. “Cosa volevi fare, Agnese?”, ancora quella domanda. La voce della dottoressa era calma, sembrava galleggiare. “Disegnavo” 37 Silenzi come mattoni nell’aria. “Non avevi paura di farti male?” “Stavo solo facendo un disegno” I pensieri erano farfalle impazzite. “Volevi disegnare sul tuo polso?” Agnese mosse il capo in fretta per annuire. Non le andava più di stare lì a rispondere a quelle domande. Tutto quel bianco la circondava e le dava fastidio. Era come un foglio vuoto e si poteva sporcare, gocce di nero qua e là. Macchie scure dappertutto. Segni di sangue, graffi, sbavature. Nel bianco erano nascosti tutti i colori, glielo avevano detto a scuola. Nel nero nessuno. Pensò all’inchiostro che si mescolava nelle sue vene. Liquido buio che attraversava la carne. Nessun colore. Una goccia di tempera che scivola sul tappeto. “Agnese, guarda cos’hai fatto” La sua mamma non riesce a sembrare cattiva. Non è mai stata capace. Quando fa la voce grossa, e appoggia le mani sui fianchi è solo per gonfiarsi un po’, come fanno i cigni con le ali quando hanno paura. “Stavo disegnando, mamma” “Hai sporcato il tappeto” Silenzio. Agnese fissa la macchia sul tessuto arabescato con espressione seria. “Mi dispiace…” sussurra. Il viso di sua madre si addolcisce di colpo. “Non importa, piccola. Lo laveremo”. Mamma bella. Rosa, dolce. Sempre buona. Mamma adesso sorride. “Cosa stavi disegnando?” chiede, mentre allunga il collo per scrutare il foglio. Ci sono tutti: mamma, papà, bimba, che si tengono per mano e ridono, circondati da colori vivi. “Siamo noi, piccola” Lei annuisce. E’ contenta. Riempire il bianco di un foglio con la gioia che sente dentro. Per smettere d’avere paura. Li aveva sempre fatti… I disegni. Ne aveva centoquattro. Ordinati, uno sull’altro, li conservava nell’armadietto di metallo accanto al letto. Qualcuno era un po’ accartocciato: i fogli facevano delle bolle nei punti dove aveva insistito di più con il pennarello ed erano venuti dei buchi. Troppo inchiostro. 38 Ma con gli anni era migliorata. Gli ultimi erano bellissimi. Prima elementare. Casa bianca, tetto rosso. Camino che fuma. Mamma rosa che ride. Seconda elementare. Giardino verde. Papà celeste che abbraccia Agnese. Nuvole chiare. Sole. Terza elementare. Macchie d’inchiostro, dappertutto. Da quel momento, i disegni li aveva cancellati tutti con il nero. Tranne quello del funerale, che stringeva in mano ora. “Dove hai trovato la china?” La dottoressa era lucida. Quando parlava sembrava le si scrostasse la faccia. Calcinacci giù, in terra. Agnese fece un’espressione, come un ghigno strano. …le labbra piegate all’ingiù in una smorfia senza tono, disegnata di paura. Non riesce a piangere e non può ridere. Resta chiusa, mentre decide cosa indossare, sotto gli occhi vigili di sua zia. La sorella di sua madre è arrivata subito, non appena ha saputo dell’incidente. E’ arrivata per dare una mano, per organizzare quello che serve. Non assomiglia a sua madre, non è rosa come lei e non possiede il suo sorriso. E’ arrivata dal paese piccolo che sta alla fine dell’Italia, quello dove ci sono casette bianche tonde, con i tetti scuri. La mamma li chiamava trulli, o comunque una parola così. C’erano stati in vacanza, una volta. Ma lei adesso non si ricorda, era troppo piccola allora. Solo, c’è una foto: Agnese con una maglietta rossa che si arrampica su una scala. La mamma sorride e la tiene forte per non farla cadere. “Zia, io mi metto questo” Agnese afferra la maglietta blu, quella con il disegno di Titti sulla pancia. Gliel’ha regalata sua madre il mese scorso. La stringe fra le mani, poi scappa fuori dalla stanza. “Agnese quello è un pigiama! Non puoi uscire con la maglia di un pigiama! Non oggi, comunque” Nel corridoio se la infila, senza smettere di camminare. Titti le sorride dalla pancia, attraverso le braccia conserte, strette sotto il muso lungo. Al funerale nessuno ci fa caso, al pigiama. Agnese passa in mezzo alla gente. Molti la guardano e scuotono la testa. Qualcuno finge di non vederla e bisbiglia di quello che è accaduto. E’ stato terribile, le auto distrutte… Agnese li guarda tutti, nei loro vestiti neri. C’è una rabbia strana. Li odia, vorrebbe solo scappare via, adesso. Invece prosegue, e stringe più forte la mano della zia. Si ferma davanti alla porta aperta della camera mortuaria. Grigia scura. Sua zia le appoggia una mano sulla spalla. Come per darle coraggio. La piccola esita, poi muove un passo. Varca la soglia ed eccolo, c’è tutto quel nero dappertutto. Le entra nei respiri fino giù, nei polmoni. 39 L’aveva infilato sotto la carne. Voleva tenerlo nel sangue, il colore dei morti. Voleva essere come la sua mamma, come lei era diventata. Per starle accanto anche adesso che non c’era più. La penna era nel cassetto aperto della scrivania di Suor Elena, in fondo al corridoio dell’orfanotrofio. Agnese l’aveva spiata mentre la riponeva al suo posto. Poi aveva atteso il momento giusto. Gli altri bambini erano tutti fuori a giocare, e lei era rientrata con la scusa di fare pipì e aveva percorso il corridoio, cercando di non fare rumore. Aveva aperto il cassetto e aveva rubato la stilografica. Si era rifugiata nella sua camera, si era seduta sul bordo del letto. Agnese con la mente vuota, gli occhi nascosti dentro la testa. Nella bocca parole che non sanno dove andare, cosa fare. Dopo aver caricato il serbatoio della penna nel calamaio, si era arrotolata la manica della camicetta. Poi aveva spinto la punta del pennino nella carne. L’inchiostro nero era entrato e si era mescolato al suo sangue. Bruciava, sotto la pelle. Con gli occhi chiusi aveva inspirato l’odore che c’era nell’aria. Pareva lo stesso di allora… La puzza dei morti. Impalata nella camera ardente Agnese è certa che quello che sente sia l’odore dei morti. Odore di fiori freschi e di lacrime. I suoi sandali rosa si muovono piano, uno dietro l’altro, sul pavimento porpora. La suola liscia scivola e i passi fanno un ticchettio sospeso. La sua mamma è sdraiata a pancia all’aria, pare dormire ed è bellissima. Anche se sembra fatta di cera. Agnese non sente paura. Né dolore. Solo curiosità. Allunga la mano e sfiora con un dito quel volto che sembra finto. Vuole essere sicura che ci sia per davvero. La pelle di plastica, molle, reagisce in un modo strano al suo tocco. Mamma dolce, rosa buona. Anche suo papà sembra dormire. Solo che non russa, ed è strano. Poi è un po’ più brutto, lui. Giallo. Pare indossare una maschera. Li hanno dovuti ricostruire, perché erano ridotti male. Qualcuno l’aveva bisbigliato, fuori, tra le facce nere, davanti all’entrata. Suo padre sembra finto, come sua madre. Suo padre è duro da toccare, invece che molle. Agnese resta a guardare, ancora un istante. Non fa male, non ancora. Poi arrivano due uomini vestiti impeccabili, giacca e cravatta e sembrano corvi. Le facce impassibili. Tengono in mano una specie di trapano. E una cassetta degli attrezzi come quella che suo papà aveva giù in garage. I corvi non la guardano, prendono i coperchi delle bare. I corpi di mamma e papà scompaiono. Agnese spalanca gli occhi e c’è un bruciore dentro, una palla che viene su dallo stomaco. Le stringe la gola, il fiato non passa più. 40 Pensa che il dolore non ha un colore. Il dolore è nero. Apre la bocca e grida, grida fino a consumare tutta l’aria nella stanza. Sua zia la trascina fuori, e i calci non servono a niente, e le lacrime nemmeno. E’ tutto nero. Buio pastoso, senza senso. E’come aver perso gli occhi. Niente più colori. Niente. Adesso tu sei sola al mondo. Adesso ci penseremo noi a te. No, non puoi stare con tua zia, perché sei malata, sai? Ti dobbiamo tenere sotto controllo. Noi… La dottoressa si piegò in avanti, minacciosa. “Mi fai vedere il tuo disegno?” Il polso ferito si alzò. La garza macchiata posò il foglio sul ripiano della scrivania. La carta è piena di facce buie. Abiti neri. Sciarpe e pizzi e camicie. Stracci di nuvole scure sovrapposti come mani intrecciate. Una bimba senza gli occhi. “Questa sei tu?” “Quale?” La dottoressa indicò con l’indice la sagoma della piccola al centro del foglio. “Questa qui, senza gli occhi” Agnese annuì. La dottoressa scrisse qualcosa sulla cartella medica che aveva con sé. Agnese pensò che no, quella là non capiva niente. Come tutti gli altri. “Perché non hai gli occhi?” Pupille vuote. A che servono, se non vedono nulla? Intorno, tutto nero. Morti appiccicati alle pareti. Ombre scure e puzza di carne putrefatta. A cosa servono gli occhi? Il bianco che la circondava era solo un’apparenza asettica, stonata. Lo studio medico un pertugio di paure, ossessioni. Una prigione fragile. A cosa servono gli occhi? Per vedere i colori. Il camice – candido, certo – aspettava. Il bianco contiene tutti i colori. Agnese si alzò. 41 Il bianco è fragile come un foglio che attende un disegno che non c’é. Funerale disegnato sul tavolo. Tutto finito. Tutto perduto. Adesso non servono più i colori. Afferrò il calamaio, ancora. E il camice non fece in tempo a capire. In un istante era tutto nero, finalmente. L’inchiostro scivolò sulla scrivania, e sul camice, e sul muro. Agnese si spalmò le mani e sentì la sua consistenza viscida, scivolosa. Il colore dei morti, il colore di papà e mamma, solo quello, per non sentirmi così sola. Fece appena in tempo a sporcare la garza, a sperare che l’inchiostro andasse su nella ferita, attraverso la carne. Qualcuno l’afferrò, mani ruvide e sgarbate. Le strinsero i polsi. E non importava a nessuno della sua ferita, ora. Agnese spargeva l’inchiostro dappertutto. Agnese gridava e piangeva. Strinsero. Dissero basta. Dissero la bambina è impazzita. Dissero che disastro, è tutto nero. La portarono fuori. E lei gridava, sempre più forte. E’ tutto nero. 42 Abitare la distanza di Luciana Mignola Trenta raggi convergono sul mozzo ma è il foro centrale che rende utile la ruota. Plasmiamo la creta per formare un recipiente ma è il vuoto centrale che lo rende utile. Ritagliamo porte e finestre nelle pareti di una stanza e sono queste aperture che la rendono utile. Perciò il pieno ha una sua funzione ma l’utilità essenziale appartiene al vuoto. Lao Tzu “Sono solo sgusciata nella stanza accanto”. Scrive così, in un messaggio avvolto dal mistero, l’adolescente tragicamente scomparsa, investita da un’auto, in Cuore Sacro, l’ultimo film di Optetzek. E così è stato anche per mia figlia Annalaura, che è ancora qui, accanto a me e continua ad abitare lievemente la nostra casa con una presenza densa e leggera che solo io riesco a percepire. Non mi è stato però consentito evitarle la tragedia dell’uscire di strada, dalla vita: si è schiantata contro un albero, a soli vent’otto anni, in una calda serata estiva e il senso di colpa per esserle sopravvissuta è la mia terribile condanna. Sono trascorsi quasi tre anni da quell’atroce giorno in cui il suo cuore ha smesso di battere e, da allora, il mio ritmo interiore non coincide con quello del resto del mondo. Prima, dopo, sono ormai parole prive di 43 significato per me. E la sua morte ha segnato un tragico spartiacque che mi costringe a inventare altri ritmi in cui è il dolore, a costruire la melodia di fondo. Nelle notti insonni, mi sorprendo spesso a pensare che la vera conoscenza inizia con l’incontro con il vuoto e che il pieno, là fuori, continua ad esserci ma non per me, non più come prima. Da quel giorno straziante, la mia vita, in qualche modo, si è fermata con la sua e tutto vive in una strana dilatazio- ne-compressione del tempo che si trasforma nel doloroso oggi, abitato da un’angoscia irrapresentabile nutrita da un sentimento di vuoto con il quale ho dovuto imparare a convivere per accorgermi, nel tempo, che anch’esso parla, se mi pongo in ascolto. La sua assenza è diventata per me una superpresenza, nel cuore, nella memoria, nelle mie viscere, luoghi dai quali non potrà più esserci alcuna separazione, nessuno strappo crudele. Non è semplice il percorso per comprendere ed accettare quanto è accaduto, almeno non per me che sono la madre. Nei primi mesi, che solo oggi riconosco deliranti eppur necessari, i miei sforzi erano tutti rivolti alla comprensione del concetto di distrazione, quella che allora ritenevo responsabile dell’incidente che mi ha privato del futuro. All’epoca, ricordo, ho cominciato a ragionare su quanto mi stava a cuore nel momento più atroce della mia vita: la distrazione necessaria, accecarmi per non vedere, accecarmi per allargare lo sguardo. Mi chiedevo, e mi chiedo ancor oggi, se la sua distrazione, pagata con la vita, le ha consentito di allargare lo sguardo, se i suoi occhi intensi e spesso disperati, si sono finalmente aperti nella verità. Prima confusamente e poi sempre più consapevolmente, mi sono accorta che le stesse riflessioni che avevano rappresentato materiale di molte discussioni tra noi, quando insieme studiavamo la filosofia e la tragedia greca, ritornavano a pretendere la vita. 44 Era in quel luogo e a quel tempo, mi ripetevo ossessivamente, che bisognava far ritorno per capire che la distrazione è la sola condizione necessaria per arrivare alla verità, solo spostare lo sguardo consente di giungere al logos. Poi, all’improvviso, le mie mani, il mio cuore, catturati dalla scrittura. Sola realtà sopportabile, tradimento di una presenza assente e sua unica traccia, la scrittura come veleno e cura per le notti insonni, forte quanto il desiderio dell’accecamento, unico strumento per vedere meglio e non morire. Impossibilitata nel collocare la mia vita in un tempo e in uno spazio, sono andata nella terra di nessuno, unico luogo possibile per il nostro incontro, alla ricerca delle parole che potessero rappresentare il mio dolore. All’inizio confuse, spezzate, qualche volta deliranti. Margherite Duras afferma che “ la scrittura rende selvatici. Si torna a una selvatichezza prima della vita. E la si riconosce subito, è quella delle foreste, quell’antica come il tempo… Scrivere è anche non parlare. E’ tacere, è urlare senza rumore”. Non è facile, nella disperazione, trovare le parole per far uscire il dolore che “se non parla”, come dice Shakespeare in Macbeth, “fa scoppiare il cuore agitato”. Il teatro è stato motivo di grande unione con mia figlia. Una vera passione che ci ha visto più volte insieme, nelle buie serate invernali, leggere testi e ragionare intensamente sui grandi interrogativi della vita. Già allora, forse in maniera oscura, sapevamo che il logos è maschile, pieno, yan, parola razionale e che noi percorrevamo, accanto a quella, la strada del corpo che si tocca in penombra, dell’abbraccio muto, della ricerca al femminile di strade che si trovano per caso e si separano per 45 andare in direzioni spesso sconosciute, qualche volta trasgredendo i confini per spingersi oltre. E’ partito dai suoi dodici anni, abbandonate le fiabe che inventavo e ripescavo nei miei ricordi di bambina per lei, il nostro metterci in viaggio alla ricerca della stella dell’imprevisto, sempre pronta a capovolgere schemi e a stupirci nella proposta d’itinerari insoliti. Per questo nella mia scrittura, ho capito poi, ho messo in scena la sua morte, un obbligo nei suoi e miei confronti dettato dall’amore. Partendo dal funerale e utilizzando il flash-bak, ho immaginato che ancora una volta insieme, l’ultima, raccontassimo ciò che è accaduto accanto a spaccati della nostra vita. Ho costruito un impossibile dialogo tra noi per avere l’opportunità di rappresentare, di dire e farle dire, ciò che in realtà non ci è stato concesso. Ho creato il vuoto, il silenzio, per far affiorare le parole e, non sapevo ancora, allora, che questa è meditazione. I miei familiari, i miei amici, hanno più volte, in quei primi mesi, temuto per la mia salute, per il mio equilibrio mentale. Trascorrevo anche dieci ore al computer a fare e disfare ciò che per me in quel momento era fondamentale: nominare l’innominabile, immaginare l’inimmaginabile, rappresentare l’irrappresentabile e accettare di sopravviverle. A volte diventa essenziale dire l’impossibilità di dire. Per me così è stato. Ogni cellula del mio corpo è ritornata ad una conoscenza antica, a ritmi di vita dimenticati nei secoli. Sono entrata in una dimensione sconosciuta che mi ha permesso l’accesso a fenomeni intrisi di mistero per iniziare un percorso negli 46 strati più profondi del mio essere, alla ricerca della sacralità perduta. Ho incontrato Inanna, personaggio mitico tra i più antichi, che simboleggia la capacità totale di lasciarsi andare agli eventi non passivamente ma nella consapevolezza di un totale rinnovamento. Inanna, dea adorata dai Sumeri e dai Babilonesi, che di sua volontà, intraprende un viaggio nell’oltretomba per incontrare la Dea Oscura. Parte per morire, rinascere e coltivare presso la sua gente, il potere di guaritrice appreso. L’ho seguita, d’istinto, consegnandole la mia vita. Sono ormai consapevole che il danno subito è irreversibile ma non mi lascio più aggredire dai ritmi frenetici della mia vita di prima e, cosciente che nella nostra cultura la capacità di accettare esperienze trasformative è ormai persa, mi sono lasciata guidare dal cuore. E’nato un testo che parla di noi, che in qualche modo è noi, che sopravvive alla sua morte e al mio dolore. Un testo disperato e di speranza perché se c’è l’amore, nulla è perso. Questo è il sentimento che mi ha prima sorpreso e poi nutrito. La consapevolezza che l’amore sopravvive anche alla morte, che i nostri anni vissuti insieme sono stati un meraviglioso dono d’amore che m’accompagna di giorno in giorno e mi dà forza nei momenti più strazianti che ancora mi colgono nel quotidiano. Ho smesso di voler governare la vita, ho smesso anche, con fatica e non sempre riuscendoci, di pretendere l’impossibile da me stessa e dagli altri. Mia figlia m’insegna tutti i giorni la pazienza e la compassione ed io mi lascio guidare da sentimenti ed emozioni ancora poco noti a me stessa per dire cosa sono diventata. La 47 scrittura è una cara e fedele compagna, insieme alla meditazione e alla solitudine. Il mio esistere convive con la ferita lacerante che sopratutto grazie alla scrittura, è diventata piena coscienza del dolore ma anche ricchezza del sentire, possibilità di inventare nuovi spartiti. Meditare vuol dire distrarsi, ho scoperto poi, lasciar andare la mente e divenire testimoni della vita che scorre nel perenne mutamento dall’essere al non essere e viceversa. Non contrastare ma aderire agli accadimenti e fare il vuoto totale nell’unione che abbraccia il tutto, è diventato per me esercizio necessario. Semplice a dirsi, meno a realizzare ciò che a noi occidentali per cultura e storia è quasi incomprensibile. In fondo non ho fatto altro che ritornare alla domanda antica, percorrendo un’altro cammino, quella domanda che ci ponevamo nei confronti delle grandi verità della tragedia greca: l’uomo può, in vita, accecarsi per vedere meglio? In ogni momento meditativo e di scrittura, rispondo sì e continuo il dialogo muto con Annalaura che s’interromperà, forse, solo con la mia morte. Percorro sentieri di conoscenza che hanno avuto inizio con la scoperta del dolore, quello che ti spezza in due e ti fa desiderare di non esserci più. E allora, cercare la saggezza e non il potere, dare spazio all’intelligenza del cuore e non a quella razionale, affondare lo sguardo nell’invisibile e abbandonarmi al flusso della vita che spesso sembra non avere ragioni se non quelle dettate dal continuo mutamento da una forma all’altra: il giorno e la notte, l’estate e l’inverno, la luce e il buio, la vita e la morte, sono diventati il mio nuovo spartito. L’inedita melodia che costruisco faticosamente, giorno dopo giorno - perché se il futuro per me non esiste più, devo 48 imparare a vivere “qui ed ora” - è quella che m’accompagna in un difficile cammino d’amore. Spesso in questi momenti inizio con lo sfogliare il catalogo della Bibbia di Marc Chagall, portatomi in dono da mia figlia, nel ’91, al ritorno da un viaggio scolastico a Urbino, dove nel Palazzo Ducale, erano esposte le acqueforti che costituiscono l’opera. Mi scrisse una dedica, in quel catalogo, che tra le tante e benedette parole tra noi dette o scritte, rappresentano il patrimonio per non morire: “Forse non riesco come te a piangere davanti ad una pittura di Chagall, ma riesco, grazie a te, ad apprezzarla… Un dono che cos’è se non un atto di fede?” Allora non lo sapevamo ma in un tempo senza veri profeti, con tutta la passione dell’anima, abbiamo giocato ad esserlo noi che con etica profonda, ci ponevamo inquietanti interrogativi sul vivere e il morire. Non sapevamo neanche, allora, che la nostra ricerca, nata come un atto di fede - e la fede è sempre un miracolo d’amore - ci avrebbe portato ad esplorare anche la confusione, il dubbio, la follia, la sofferenza, che in tutti i tempi, hanno fatto scoccare qualche scintilla di sacro per cui vale la pena vivere. Solo chi esprime attraverso le parole il suo sentire conosce il contrasto tra la necessità del dire e quella del silenzio, eterna contraddizione che ci ha attraversato nel nostro camminare insieme. La strada che abbiamo dovuto percorrere, paradossale e crudele, ci ha fatto vivere un'esperienza estrema: la madre che sopravvive alla figlia, costringendoci all’incontro con la finitezza e con l’infinito, con la morte che non scende a patti e con la conoscenza del limite. Il nostro tempo è stato punteggiato da paura e coraggio, da intensa felicità ed estremo dolore perché quando la morte giunge improvvisa, non c’è tempo per il saluto, rimane un 49 senso d’incompiuto, una storia lasciata a metà, una disperata mancanza di sguardi e di abbracci che aiutano a darsi la mano contro il buio, la separazione, la morte. La cognizione del dolore, oggi lo so ed è la mia paura costante, può portare alla pazzia, all’impossibilità dell’accettazione del limite se non è accompagnata dalla consapevolezza dell’eternità dell’amore. Annalaura mi indica la via della relazione con ciò che è diventata la mia vita, mi sussurra la necessità di osservarmi in profondità per uscire dai modelli dell’io di cui tutti siamo un po’ prigionieri, di fermarmi per entrare negli spazi vuoti e penetrarli, di aprirmi al mistero e all’intuizione che feconda un io sconosciuto che emergendo m’impone ad uscire dalla mia vecchia identità e mi obbliga alla relazione con la parte più profonda del mio essere. Abitare la distanza e scoprirla luogo in cui la morte e la vita possono incontrarsi, qui ed ora e non domani, è la mia condizione di oggi. Ma non c’è solo questo, oggi, per me. Ci sono gli affetti che coltivo con maggiore attenzione e dedizione, gli interessi, che continuano ad essere tanti, accanto alla consapevolezza della precarietà della vita. Ci sono i ‘soli ridenti’ che nulla sanno del mio dolore e mi accarezzano e stupiscono ancora, le mie tenere amiche che non hanno smesso di amarci e mi spingono a non cedere al dolore maligno, quello che ti rende più cattivo, quello che ti spinge a chiederti: perché proprio a me? Ci sono i suoi amici che ancora frequento, di tanto in tanto e che testimoniano con la loro presenza, il grande affetto per noi, mio marito che si prende cura di me con amore e mio padre, che con la dignità di nonno atrocemente ferito, m’insegna a non arrendermi, ci sono i dolci compagni del gruppo di auto-aiuto 50 che con la loro lieve presenza che nulla chiede, mi consentono di piangere e ridere ancora e, infine, c’è la vita, che nonostante il dolore, malgrado me, ancora pulsa nelle mie vene e mi costringe a dirle sì. I colori non sono più quelli di una volta. Fatico a sostenere lo sguardo di tramonti infuocati e di verdi sfacciati. Ma c’è pur sempre l’autunno, con i suoi gialloarancio sfumati e qualche volta inquieti e l’inverno con le sue atroci nudità di essenziali bellezze che m’inducono a pensare che questo è il mio tempo del dolore. Accettare è possibile, rassegnarsi No. Accettare che la vita mi sia stata ostile, che abbia abbandonato lei e non per questo remare contro. Anni fa, in un percorso analitico, mi è stato detto che per imparare a stare ‘con’, bisogna imparare a stare ‘senza’. E’ il mio esercizio quotidiano. L’assenza inequivocabile, genera la sua presenza costante. Certo, manca lo sguardo, l’abbraccio, il calore. Non l’amore che ogni giorno ci avvolge in un unico abbraccio. Basta solo creare un varco. 51 TROPPO PRESTO L’ idea del lutto Indaffarati e preoccupati, i medici ronzano intorno a qualcosa. Si scambiano notizie, pareri, indicazioni sul da farsi, ma soprattutto sguardi imprecisati. Tra loro, quelli che sono di guardia, a fine turno passano la staffetta ai successivi: la morte potrebbe sopraggiungere da un momento all’altro e non sono ammesse distrazioni, perché quando arriverà non dovrà farlo di sorpresa, senza che nessuno stia lì ad aspettarla. Tutti sembrano concentrati ed attenti, pronti ad assistere al momento del trapasso. Sembra che molto di quello che si dice e si fa tra i corridoi riguardi, non tanto la speranza di scongiurare una morte quasi inevitabile, quanto la preparazione ad essa. Durante la concitata attesa si contatta il Servizio psicologico del C.E.M. e vengo così messa al corrente della situazione. Quel clima di morte incombente, di emergenza e di costernazione, mi contagia. Tutto intorno a me pare dibattersi, solo un attimo prima che la morte di G. arriverà a rendere poi tutto immobile . Il moto e la stasi, il tutto ed il nulla, la vita e la morte si oppongono reciprocamente. Sembra che ogni cosa intorno a me, ogni voce, ogni gesto, ogni parola sia solo il prologo del proprio contrario, quando tra un attimo tutto si fermerà. 52 Questa angoscia, mia e di tutti gli altri, medici ed operatori, si propaga nell’aria in ogni angolo del Centro. La madre di G. da parte sua, avvertita di quello che potrebbe di lì a poco accadere, non vuole sapere, non vuole sentire, non vuole che il suo telefono squilli per annunciare la morte ormai compiuta. Il cerchio non si è ancora chiuso, la fine non è ancora giunta, eppure una delle due facce del lutto è stata vissuta del tutto. La morte, per chi dovrà restare, è un doloroso evento interiore che si può vivere anche cento volte prima della morte stessa. Poi, inaspettatamente, cessa l’allarme. Anche stavolta G. ce l’ha fatta a non morire, anche se altre volte è morto e morirà ancora dentro chi assiste alla sua malattia. Ma oggi, almeno, la madre ha cercato un altro modo per fronteggiare la paura del lutto imminente: è riuscita a chiedere un intervento psicologico proprio dopo aver toccato il fondo della propria disperazione . Il lutto Luigi non aveva ancora 18 anni. Viveva in attesa del trapianto e di tornare finalmente nel suo paese in Campania, in quella palazzina dove abitava insieme ai parenti. Luigi sognava di fare il cuoco, ma non ha avuto il tempo di diventarlo. Era stata sua madre a sollecitare l’equipe medica perché ci fosse un intervento psicologico a sostegno del figlio. 53 Quel giorno Luigi si era subito aperto ed aveva espresso sentimenti ed emozioni del tutto naturali e comprensibili; diceva di non sopportare gli ospedali e di sentire la mancanza degli amici e dei familiari. Aveva poi aggiunto di essere impaziente di affrontare il trapianto e sperava, ovviamente, che fosse risolutivo e che gli permettesse di tornare al più presto nel suo paese ed alla normale vita dei sani. Le difficoltà e le sofferenze che avrebbe incontrato non lo spaventavano, o meglio non lo spaventavano quanto il vuoto dei giorni di attesa da trascorrere in ospedale. Sua madre si mostrava molto preoccupata, provata, esausta. Anche a lei mancava molto la propria casa, ma non poteva fare a meno di stare accanto a Luigi. Restargli vicino 24 ore al giorno le risultava, ovviamente, molto gravoso e difficile. Tuttavia non riusciva neanche ad allontanarsi per dieci minuti dalla stanza del figlio, magari per prendere un caffè nel bar interno all’Ospedale. A volte sembrava che fosse Luigi ad incoraggiare la madre e non viceversa. Questo capovolgimento dei ruoli rendeva la loro vicenda certamente più amara e, in qualche modo, più tragica di quanto già non fosse. Luigi non doveva solo fronteggiare la malattia e la morte; non doveva solo dare a sé il coraggio di crederci, raschiando il fondo del barile delle proprie speranze; doveva anche trovare la forza di sostenere la madre che sembrava non farcela più a sopportare il peso della paura, del dolore, della fatica e della lontananza da casa. Dopo quel primo incontro ne sono seguiti altri cinque. Il trapianto, effettuato nel frattempo, non aveva dato gli effetti sperati, tutt’altro. Il giorno del sesto incontro, che non sapevo sarebbe stato l’ultimo, Luigi stava molto male, ma i suoi occhi di adolescente sembravano mantenere tutta la loro naturale vitalità mentre egli raccontava di aver visto e fotografato un’attrice famosa che aveva visitato l’Istituto. 54 Anche quegli occhi così vivaci, quel loro sembrare l’ultimo lembo di vita in un corpo ormai assediato e sopraffatto dalla morte, non sarà facile scordare. Quegli occhi così luminosi non attenuavano la tristezza, anzi la accentuavano: la loro vitalità e la loro gioia fugace brillava solo perché intorno a loro il buio stava calando. Quegli occhi non erano le prime luci di un’alba che si accendevano, ma le ultime di un giorno che si andava spegnendo. Ho saputo della sua morte, avvenuta la notte di un venerdi, giorno successivo al nostro ultimo incontro, soltanto il lunedì seguente. Durante il fine settimana mi ero chiesta più volte se l’avrei ritrovato vivo tornando al lavoro, perché una sorta di presentimento, o la semplice consapevolezza dei fatti, mi avevano preavvertito che la morte di Luigi poteva non essere lontana. Tuttavia, né quel presentimento, e nemmeno quella parziale consapevolezza erano riusciti, com’è forse naturale, a prepararmi del tutto alla sua morte. Solo una parte di me, in altre parole, era pronta a quell’evento eventuale ma annunciato, mentre un’altra parte di me, di fronte alla notizia che Luigi non ce l’aveva fatta, sembrava volere e cercare spiegazioni per quella morte prematura, come se quella stessa morte non potesse ancora essere accettata del tutto. Ho pensato più volte, senza che questo pensiero avesse un particolare senso, che l’avevo visto e gli avevo parlato solo poche ore prima e questo esiguo lasso di tempo sembrava di per sé giustificare una venatura, in me, di incredulità, di sorpresa e di non accettazione. Subito dopo, nella mia testa ho iniziato a ripetermi due parole, senza che ad esse ne seguissero, a caldo, altre che potessero completarle. Troppo presto, mi ripetevo, troppo presto. Soltanto nelle ore successive ho chiarito e capito in parte cosa intendessi con quelle due parole. 55 Luigi era morto troppo presto, perché era ancora troppo giovane; perché il giorno dell’ultimo incontro non sapevamo che sarebbe stato l’ultimo ( ma del resto, a cosa sarebbe servito saperlo ? ); perché non aveva fatto in tempo a tornare da vivo nel suo paese, a rincontrare i parenti e gli amici, a diventare cuoco, a realizzare almeno uno dei suoi sogni. Luigi era morto troppo presto perché non aveva fatto in tempo a vivere di più. Poi, nei giorni seguenti, anche per ricondurre quei miei pensieri e quei miei vissuti all’interno di un percorso professionale, ho cercato di cogliere qualcosa in più. Allora ho capito che lavorare con dei pazienti come Luigi che hanno speranze di guarigione, per quanto doloroso, non espone agli stessi rischi che si corrono lavorando con i pazienti terminali o con i loro parenti, perché quelle speranze, lo si voglia o no, contagiano anche la figura dello psicoterapeuta e si trasformano, tanto negli uni quanto nell’altro, in vere e proprie speranze di vita anche se la morte potrebbe, da un momento all’altro, cancellarle. Dott.ssa Mariasole Galassi Responsabile Servizio di Psicologia Centro Educazione Motoria Comitato Provinciale-Croce Rossa Italiana -Roma Collaboratore Servizio di Psicosomatica Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia Università degli Studi “La Sapienza” Policlinico Umberto I - Roma 56 Duccio Demetrio(*) SCRIVERE DI SE’ OLTRE LA PERDITA L’autobiografia del cordoglio e le sue implicazioni nell’elaborazione del lutto Un narrare multiforme Il genere autobiografico (comprendente scritti quali diari, agende, lettere, memorie, confessioni, poesie degli affetti personali…) non può più essere ritenuto esclusivamente una forma letteraria. Non pare nemmeno più riducibile a questo o a quel documento, in cui un io narrante di età variabile, più spesso matura, spiega, rivolgendosi a sé stesso o ad altri destinatari - già immaginati o meno- chi ritenga di essere od essere stato. Raccontano, costui o costei, vestendo i panni dei protagonisti assoluti e in maniere diverse, un po’ tutto quel che hanno incontrato per caso o perseguito nel corso della loro vita. Si descrivono fin dall’infanzia, rievocano quali furono i momenti indimenticabili, quali le persone decisive, quali le scelte e le svolte determinanti per l’iniziazione all’età adulta. Lei o lui sono mossi dal desiderio di realizzare, secondo coerenza cronologica o viceversa per frammenti, un progetto di scrittura -in forme anche antologiche, sparse e casuali – che solo alla fine assumerà una sua fisionomia e corrisponderà ad una sorta di autoritratto plausibile che quell’io andava cercando. Seppur dalla veridicità discutibile e che il suo autore, alla fine dell’impresa, non potrà che confermare invece attendibile. Poichè seppur soltanto approssimativamente gli assomiglierà. Le pagine, poi, dedicate a tale panoramica retrospettiva e introspettiva di quel che si è creduto di essere, di essere stati, di essere cambiati, diventeranno così un libro o una raccolta di liriche con dedica. Più di frequente, resteranno 57 un quaderno gualcito di fattura modesta ma fitto di grafie, di segni, di date. Quale sia l’entità e la qualità degli scritti, essi costituiranno almeno la prova che chi li ha creati ha vissuto alla ricerca di un sosia, di un alter ego, di un compagno segreto, cui confidare quel che solo così poteva essere detto. In un dialogo tra quell’io narrante-scrivente e l’io immaginario che sarà partorito dal primo. Tutto ciò che scriviamo di noi diventa in tal modo la carta di identità che più ci appartiene. E’ fatta e stampata in proprio, la si sia falsificata o no. Intenzionalmente o meno scaturisce a proprie spese grazie alla necessità di coniarsi, di riprodursi da soli. Per poter dire: “io sono figlio di me stesso”. Ho prodotto qualcosa che senz’altro mi somiglia e che si espone a svariate considerazioni. Proprio come qualsiasi scrittore fa con la sua opera che affida al destino, alla critica, ai lettori severi o compiacenti. Ebbene, questa immensa mole di scritti, questa letteratura amatoriale, soltanto in piccola parte è conservata (e salvata) in archivi, in biblioteche, in musei. Per la maggior parte, se non viene distrutta quando gli autori e le autrici scompaiono, diventa cimelio domestico e famigliare, di cui nulla mai sapranno non solo gli studiosi di letteratura civile o popolare ma nemmeno coloro che hanno iniziato a ritenere che l’autobiografia sia un genere anche sociologico, antropologico, filosofico: oltre che naturalmente storico. Tale vicenda ineluttabile ci espone ad una specie di seconda morte che però a differenza della prima può essere ritardata. Per non citare poi l’interesse che anche psicologia e pedagogia rivolgono a queste scritture, per il fatto che in esse sono rintracciabili tipi umani e profili, patologie e sintomatologie di cui gli scriventi erano e sono i portatori. Inoltre, l’aver deciso di scrivere la propria storia e di averla terminata, ci segnala la ripresa di un tragitto e di uno sviluppo di natura educativa. Un ravvedimento, il superamento di una difficoltà e la ricerca di nuove mete, 58 un pentimento sono categorie pedagogiche poiché inducono il soggetto a cambiare vita, ad imparare nuovi costumi, a darsi altri orientamenti e valori. Occorre anche specificare che, oltre a queste variazioni di prospettiva intervenute nell’analisi delle documentazioni autobiografiche, non possiamo più ritenere che la versione scritta di un racconto sia l’unica modalità di cui si avvale un autobiografo. Ad essa sono andate aggiungendosi e sostituendosi altre tecniche narrative quali il cinema biografico professionale o amatoriale, la videonarrazione, le sequenze pittoriche o le canzoni autoreferenziali. Si tratta difatti, in ogni caso, di scritture: seppur anomale e cioè di tracce lasciate non più su un foglio ma su una pellicola, una banda sonora o elettronica, una carta sensibile. Ci si trova comunque in presenza di un’impresa autobiografica, anche se questa non appare più indotta da ragioni strettamente individuali e riservate, specie se aspira a diventar commerciale e ha bisogno di mezzi, di sceneggiatori, di determinate condizioni di realizzazione, di effetti speciali. Numerose autobiografie tradizionali o scritte in forma romanzesca ispirano i media, se ne impadroniscono e il risultato, artisticamente riuscito o meno, è pur sempre un’opera autobiografica nella sua amplificata spettacolazione. Mentre all’autobiografo all’antica, esploratore oscuro della sua intimità, occorrono poche cose: un pezzo di carta, una penna o un altro mezzo che ne faccia le veci, un ripiano comodo, un po’ di silenzio e, soprattutto, una motivazione forte, un impulso a scrivere. Tanto più che non per denaro bensì per amor di verità, per testimoniare vicende memorabili, per denuncia civile, egli o ella vennero indotti a tenere un memoriale quotidiano o a scrivere degli avvenimenti di cui furono diretti responsabili o spettatori impotenti. Tutto il resto, lo hanno a disposizione: è la loro vita che può diventare storia nelle 59 storie. Questo è il setting, il quadro di lavoro, lo scrittoio reale e simbolico, assolutamente personale e trasferibile ovunque, di chi abbia deciso di far pratica diaristica, memoriale, poetica. Comunque autobiografica, se a regia dello scrivere collochiamo tutto quello che il nostro pensiero e le nostre sensibilità si prefiggono di presentare a qualche ipotetico lettore, in un’esposizione annunciata nella maggior parte dei casi. Del tutto insignificante in altri, quando ciò che più conta è viverne l’ esperienza, in quanto processo e gesto che lo scrivere produce durante l’infittirsi delle parole, più che il risultato, sia esso più o meno degno di avere qualche lettore sincero. L’autobiografismo è una controtendenza Al di là di tale varietà dei linguaggi citati - ormai agibili e impiegabili per raccontarsi -,ciò che indichiamo come autobiografico sintetizza un’ attitudine, uno stile del pensiero, una sensibilità e persino una condotta di vita improntata ad enfatizzare la dimensione soggettiva del vivere. Inoltre, dentro la parola autobiografia, rinveniamo aspetti e motivi che hanno a che vedere con questioni quali: l’inconscio, il non detto, la memoria, il carattere, la vita interiore… Tutti argomenti, questi, studiati dalle scienze menzionate, le quali ormai non si occupano più soltanto delle parole, dei discorsi, pronunciati oralmente dagli individui (siano essi pazienti o altro), ma anche di ciò che costoro scrivono, di quello che intendono per scrittura, di come progrediscono o si sentono meglio affidandosi a carta e a penna, del rapporto più o meno creativo che stabiliscono con le cose e i loro simili grazie a questa così umile arte. I nostri comportamenti risultano in tal senso autobiografici sempre, se possiamo dire a ragion veduta: ”questi segni o indizi mi appartengono”, ”sono miei”, ”se 60 non avessi scritto quel biglietto o scattato quella foto,non potrei riconoscermi”. L’autobiografia e la disponibilità a scriverla ci segnalano quindi un bisogno di appartenenza, di fedeltà, di rigore morale verso se stessi. E poiché entrambe ci chiedono di riattraversare l’esistenza, anche molto impegno e disponibilità a ri-patire, nella rimembranza inevitabile, quel che già soffrimmo, ci mancò, scomparve. Essa è una modalità, riconosciuta, di rielaborazione di tutta una vita: è un lavoro su se stessi affidato alle proprie mani che riaffondano con il bisturi della penna nella materia prima di un’esistenza che nessun altro può vivere al posto nostro. Questo immenso giacimento è racchiuso nel nostro cervello, nella mente che rielabora di continuo informazioni provenienti dal lontano e dal presente vivente. Non è un necrologio, né un epilogo: semmai è un intenso lavoro su di sé che restituisce energia e voglia di tornare a vivere chi vi si cimenti. Così come, anche se l’autorizzassimo, nessuno potrebbe scrivere la nostra autobiografia al posto nostro. Tutt’al più scriverà la biografia che saremo noi a dettargli ma non sarà mai la stessa cosa. Senza una tastiera sotto le dita, senza farle scorrere in mille combinazioni a ritroso nel tempo o nell’attimo fluente che sa cogliere il diario, non si attua vera autobiografia. Possiamo affidare la penna ad altri -come diremo- ma per un gesto di fiducia e di umana solidarietà e riconoscenza. In una delega condivisa che renderà un poco autobiografo il nostro eventuale biografo. Poiché è impossibile scrivere degli altri senza al contempo non trasfondere nelle loro storie salvate qualche cosa delle emozioni che provammo ricostruendone le vicende. Il che ci spinge oggi ad affermare che una mentalità, ovvero un habitus cognitivo ad orientamento autobiografico, di cui non possiamo non andar orgogliosi, se assunta come condotta anche morale, si oppone decisamente a quanto non possa dirsi autobiografico (poiché non l’abbiamo vissuto o non l’abbiamo connotato 61 con qualche nostra traccia peculiare) o sia da ritenersi decisamente anti-autobiografico e cioè proteso ad uniformare, ad omologare, a standardizzare, e mirante a cercare, a isolare, a restituire dati oggettivi su alcunché. Il che rende l’autobiografismo contemporaneo un movimento di scrittura e di pensiero che mira a qualcosa di ben più complesso della promozione di narrazioni e storie di sé scritte in prima persona: esso sta diventando una linea di tendenza esemplare - e quindi un’entità culturale e sociale in via di diffusione - in aperta polemica nei confronti di ogni atto, abuso, gesto implicito di cancellazione della nostra individualità e più in generale delle memorie, di tutto ciò che ci ha preceduto e che si preferisce sopprimere e rimuovere. L’autobiografia è quanto di meglio sia in grado di testimoniare la nostra libertà di parola, di opinione,di visione - assolutamente personale - dei drammi e delle situazioni esistenziali della vita connessi alla crescita, all’amore, alle responsabilità, al diritto al benessere se non proprio alla felicità, al dolore e alla morte. Il rapporto con la parola pronunciata Non è poco che la scrittura, più di ogni altra modalità narrativa, ci consenta di fissare il “mondo della vita” cui apparteniamo o che abbiamo abitato nelle stagioni dell’esistenza: sempre al singolare. Di avvertirci persone, unici, nel moto amanuense dello scrivere. E, inoltre, ci invita ad intraprendere un metodo specifico, quello appunto della scrittura autobiografica, incomparabile rispetto ad altri. Per vantaggi emotivi, sviluppo ulteriore dell’intelligenza e della parola, per il tipo di relazioni che instaura sul piano delle relazioni sociali concomitanti o successive agli esiti dello scrivere. Certo, possiamo anche raccontarci autobiograficamente ad alta voceo interiormente. Anzi, lo facciamo senza posa ma 62 in tal caso ci limitiamo ad adottare soltanto la parola orale o il pensiero, rinunciando troppo spesso di buon grado a metterci alla prova intimamente con noi stessi; ad osare l’impiego di una tecnologia e di un sapere (e la scrittura lo è) che ci fornisce sempre altri risultati, accentuando il nostro protagonismo nei confronti di quel che ci accadde o ci sta accadendo in quel momento, anche se andiamo scrivendo di passato. Quando avvertiamo il bisogno irresistibile di prendere la penna in mano, di sederci al computer o almeno di scattare una foto che, se poi commentata e corredata di didascalie e appunti, dirà inevitabilmente di più. Imprimerà ulteriore dinamismo alla scena. Il retro di una cartolina, lo spazio su di essa per scrivere, ha sempre avuto questo scopo: un’immagine senza parole sarà più enigmatica ma più povera di indizi rispetto a chi ce l’ha inviata. Scrivere è un impegno maggiore perché ci compromette,ci espone, ci affatica senz’altro di più. Ed è questa, una volta appreso, una competenza pratica leggera, agile, adattabile, di pronto uso a differenza di altre, di carattere pur sempre autoreferenziale o egonarrativo che esigono più complicati accorgimenti. Sul piano degli esiti, quanto riusciamo ad ottenere con lo scrivere e il leggere di noi non è paragonabile a quanto di noi si possa dire a voce e pensare. Il vantaggio e la peculiarità dello scrivere poi, se non risiede più nella maggiore diffusività dei messaggi lasciati, oggi consentita dai mezzi radiotelefonici e quindi da una oralità in diretta ovunque pervasiva, obbliga o invoglia gli autobiografi in senso tradizionale a scegliere di scrivere qualcosa di assolutamente speciale, che li costringa a guardarsi nello specchio metaforico del foglio che hanno dinanzi. Per cercare le parole più appropriate, per entrare nei dettagli della loro vicenda, allenando così la mente a ragionare su quanto accade loro di vivere o di soffrire in quell’istante in cui le emozioni, le idee, le fantasie divengono inchiostro. 63 Il rapporto col tempo Il riferimento al passato- presente, trapassato o remoto- in autobiografia è poi d’obbligo poiché la scrittura di una storia in parole o fotogrammi scandisce, ”batte” il tempo del pulsare narrativo. Mentre una sola immagine, specie un ritratto o una foto di famiglia, una volta ritrovata, pur presupponendo un racconto, un brusio di voci, eternizza e immobilizza il momento in cui venne fissata. Scrivendo però accade di avvedersi molto meglio che, nel tracciare su una superficie una frase dopo l’altra, procedendo dall’alto verso il basso, non siamo già più quel che eravamo un istante prima di accingerci a scrivere. La scrittura ha il pregio di essere inevitabilmente evolutiva, incalzante, trasformativa con immediate ricadute su chi ne faccia un uso regolare, continuativo, determinato. Quasi si trattasse di un farmaco. Anche perché c’è sempre, vivendo, qualcosa da medicare che la scrittura cura, se non addirittura guarisce con l’arte di ricordare, non con quella della dimenticanza. Con maggior rapidità di altre forme espressive, possiamo procedere di conseguenza velocemente, per ridar fisicità ai ricordi, per correggere o cancellare quel che non ci convince, nella ricerca di rendere migliore quel che, all’inizio, volevamo raccontare e che, strada facendo, in questo esercizio di revisione incessante, non ci piace più. Per troppa approssimazione o viceversa per eccessiva scrupolosità. Pertanto, se si vuole utilizzare con proprietà il termine in questione occorre non dimenticare che con auto/bio/grafia (lett: testo scritto riguardante la mia vita di cui sono l’autentico autore e responsabile) intendiamo una produzione, un lavoro kirografico della mano (della mente e quindi del corpo e di una sua articolazione preziosa) mediante il quale siamo intenti, o lo siamo stati, a scrivere retrospettivamente, se non proprio tutta la nostra 64 esistenza, almeno qualche suo episodio reputato importante. L’autobiografia non è mai stata comunque, fin dalle sue più antiche origini, soltanto questo. Fu in tempi lontani e continua ad esserlo – già lo si è accennato - anche un genere psicologicamente importante per chi lo coltivò o l’adotta sul piano della maggiore comprensione e interpretazione di quel che va vivendo, dei comportamenti, dei sentimenti provati che invogliano a spiegarsi, a dirsi, a rivelarsi maggiormente: nel momento in cui nell’esercizio della scrittura si individua una valvola di sfogo, una strategia per affrontare i problemi. Quando si sia soli o quando un’amicizia privata o un aiuto clinico non siano sufficienti o vengano meno. O quando, ancora, si cerchi volutamente la solitudine. Ovidio, Sant’Agostino, MarcoAurelio, de Montaigne e poi Rousseau con innumerevoli altri, per citare soltanto i classici di questo genere, vi ricorsero sovente per le stesse ragioni che inducono, ancor oggi, tanto le donne o gli uomini famosi, quanto coloro che resteranno anonimi pur avendo scritto di sé, ad affidarsi allo scrivere in situazioni di crisi, dolore, smarrimento, isolamento estremo. Le soglie critiche La scrittura di sè è un’arte povera che si arricchisce arricchendoci a seconda della dedizione e della passione che le offriamo. Ribadiamolo: la intraprendiamo con caparbietà, pazienza, umiltà, volontà di conoscerci anche nei più riposti nascondigli della memoria e per lottare, pur sempre ad armi impari, contro l’oblio. Rispetto ad esso, il narratore che superi la soglia critica (un blocco “agrafico”) ben nota ad ogni autobiografo, costituita dal timore di non saper quasi più scrivere, di non riuscire a ricordare, persino di troppo autocompiacersi, si accorge ben presto che va impadronendosi di un nuovo potere e di un piacere che prima gli o le era ignoto. Scopre di riprendere 65 padronanza di quel che, caoticamente, un istante prima gli si affollava nel cervello, pur trafitto da un dolore indicibile, da un senso colpa, da una perdita incolmabile di cui avvertiva l’istinto o l’impulso a esporre. Superato questo limite, le parole scritte si appropriano ben presto, trasformandole, soprattutto di quelle scene che si vorrebbero dimenticare; riconferiscono ad esse un distacco emotivo necessario a superarle, nella volontà matura di non cancellarle anzi di portarle con sé. Non più soltanto nascoste dentro di sé ma esposte in evidenza: quasi grida. Per cercare un conforto, una comprensione, una consolazione. Anche questo, ma non solo. Piuttosto per rendere omaggio, per onorare, per trattenere qualcosa che scomparendo lo impoverirebbe. Il dramma più atroce, se riesce a diventare una rappresentazione, leggibile e comprensibile da chi non lo visse, assume un’altra fisionomia: si trasfigura, oltrepassa la propria fattualità. La scrittura presiede alla “riparazione” di quanto si è frantumato, instaura un altro ordine della memoria. Le parole, facendosi pagina, aiutano a sciogliere i grumi di tristezza e desolazione che gravavano come pesi altrimenti non attenuabili; i sentimenti di pena e le nostalgie mutano il malessere (almeno) in una condizione di sopravvivenza più sopportabile. Inoltre i diaristi, i poeti dei propri ricordi, i novellieri degli episodi cruciali che li hanno coinvolti, se scrivono per sè, prima ancora che per un pubblico, assumono atteggiamenti diversi sia a seconda del senso e degli scopi che intendono attribuire al “lavoro” cui si sono accinti ,sia in ragione di motivi che sono inconsci o ancora poco chiari. Talvolta costoro si sorprendono a chiedersi: ”Perché ho incominciato a scrivere di me?”; ”che cosa mi spinge a prendere la penna in mano?”; ”a che possono servirmi queste pagine? Sono queste le domande ricorrenti e ataviche, cui è possibile dare una risposta in relazione allo 66 stato mentale ed emozionale di chi trova nella scrittura un sollievo, un’eccitazione creativa, un confessionale, un’occasione introspettiva e persino di meditazione. Estreme conversazioni, diari del commiato e memorie difese. Per tali motivi, nell’aiuto alle persone che hanno vissuto una perdita o la stanno vivendo, lo scrivere assume un’importanza che va oltre la devastante contingenza. Aiutandoci a superarla nella dignità di una consapevolezza, di una tenacia della memoria che non si vuole reprimere. Le scritture dell’imminenza E’, questa, un’ulteriore, insostituibile, risorsa per la tollerabilità di un lutto che si va annunciando, di quel che avverrà dopo e molto oltre. Alcuni, in grande forza e determinazione, nell’approssimarsi della fine, vogliono scrivere la loro autobiografia o almeno lasciare qualche memoria scritta. Ma si tratta di casi assai rari purtroppo, accessibile dove i livelli di rassegnazione e calma quasi sapienziale o spirituale verso quel che accadrà testimoniano una piena accettazione del proprio ineluttabile destino. Altre però possono essere le scritture da proporre che chiameremo dell’imminenza. Chi si occupa di queste forme di pietas, nella disponibilità personale o nelle pratiche professionali, può tentare di favorire alcune occasioni di carattere rievocativo che “naturalmente” si danno in queste circostanze, per introdurre i momenti di scrittura anche con gli stessi morenti. Quando le possibilità odierne di attenuazione della sofferenza acuta consentano, accanto ai famigliari, con la loro partecipazione, di sollecitare quegli istanti di rievocazione orale delle proprie memorie che spesso 67 alleviano la devastante solitudine del morente e confortano chi ne potrà serbare i racconti. I quali possono a loro volta essere trascritti e donati a chi resta, nella consapevolezza di aver svolto un’opera per chi va scomparendo in sua vece e di sostituirsi alla persona alla fine della sua vita con il suo consapevole consenso. In un’accettazione del morire che è già per tutti una via di reciproca consolazione e processione corale verso l’ultimo atto. Le scritture del commiato Oppure sappiamo bene ormai che i momenti di scrittura possono essere introdotti in circostanze di autoaiuto rivolgendosi a chi si accinge ad accettare l’inevitabilità della scomparsa, che nel “diario del congedo” può così trovare una forma di interazione con chi forse non può più udire o partecipare con i suoi racconti, ma può essere seguito dal rito laico e civile della scrittura del commiato. Questa riesplora una fisionomia, un mondo di affetti, per catturali in un racconto autobiografico, che potrà innestarsi in altri possibili ricordi di quella persona ormai scomparsa: più felici, dolci, ilari, conviviali. Sono le memorie dei ricordi “buoni” che un volontario della scrittura può aiutare a racimolare, a sistemare in album, in sacrari intimi e di famiglia che riorganizzeranno ogni traccia, testimonianza orale scritta, visuale, oggettuale anche dello scomparso. In ogni caso e modo, lo scrivere in condizioni estreme è senz’altro un’opportunità per riflettere, fare bilanci, ritrovare quel che, prima di accingersi a scrivere, sembrava inevitabilmente perduto. Talvolta,l’autobiografia per chi resta - nella sua forma massima o episodica, diaristica - come comportamento riferito a stati e a pene dell’animo, è persino un metodo di autoguarigione in quelle circostanze in cui l’afflizione raggiunga livelli insostenibili. E’un cammino dove i 68 sentieri scompaiono, si biforcano, si fanno spazio nell’oblio per sopportare ed affrontare il dolore, abbandonandosi e reagendo ad esso, per superare un tedio esistenziale e depressivo così frequente nel dopo lutto. Per farsi conoscere un po’ di più da chi crediamo ancora non ci conosca fino in fondo o reputiamo non ci abbia mai conosciuto in altre sembianze e che ci ha visto nei giorni del lutto imprevisto o annunciato. Sono le parti di noi che soltanto la scrittura è in grado di svelare. Poichè, ogni volta, lo scrivere anche il più naif, il più semplice, aggiunge qualcosa al ricordare, al pensare, al comunicare quotidiano . Le scritture della riconoscenza La scrittura è fonte di un poco di benessere anche quando non può placare, come vorremmo, né lenire il dolore. Poiché riconferisce una dignità, una storia, una rimembranza a coloro di cui narra. Si rivela così una inusuale cura e persino un apprendimento, introducendo uno “scandalo” in ogni banalità del male e della morte, per il solo fatto che ostacola la dimenticanza e ogni amnesia, ad essa opponendosi e resistendo. Ci allevia la sofferenza nel momento in cui quel che scriviamo non lo facciamo per noi ma per chi non c’è più. Si rivela un gesto di riconoscenza, di risarcimento, di restituzione simbolica per il tramite delle parole a chi purtroppo non potrà più ascoltarle che, in tal modo, vengono rivolte a lui o a lei e a ciò che, se scomparisse del tutto, condurrebbe alla negazione e alla cancellazione di ogni nostra presenza e legittimazione. Anche praticata a molta distanza dalla scomparsa della persona cara o la cui dipartita ci turbò profondamente, questa forma ulteriore di scrittura si configura come un gesto di “riconoscenza”. Equivale ai dialoghi, in forma immaginaria ma così confortanti, che sovente intessiamo con chi ci ha abbandonati. Quel ricordo, quella presenza umana 69 perdurante o di passaggio dalla nostra vita alla cui morte assistemmo o della quale apprendemmo entra a far parte di chi scrive di sé in veste di un tributo dovuto. Non solo perché, assai frequentemente, quella figura ci fu maestra, ci aiutò, condivise con noi qualche momento di vita, ma perché anche soltanto quella apparizione lunga o fugace, nella nostra vicenda fu fonte di piacere, di bellezza, di avventura. Sul piano della coscienza umana, civile, etica e spirituale, la scrittura ci riconsegna così ad una ragione di vita ulteriore. Fare in modo che almeno noi non si debba dimenticare chi è scomparso, di cui nessun altro, tranne noi, potrà scrivere: questo è l’intento. Scrivere all’inizio, durante, alla fine di uno stato di dolore annunciato e poi duramente vissuto, o con una difficile e rara serenità, è già un ricominciare a sperare e a vivere; è un aggrapparsi alla volontà di esserci senza brutali quanto inutili pretese di abolizione della memoria. In una autocancellazione di sé oltre che dell’altro. Ogni testimonianza autobiografica si espone così, giocoforza, al suo ampliamento: chi ricordiamo scrivendo di noi (poiché è impossibile raccontarsi a prescindere dagli incontri fatali e decisivi di una vita) entra nella nostra “immortalità” cartacea, anch’essa non eterna. Se le nostre scritture dedicate a coloro che ci videro nascere, ci amarono e amammo, possono trovare qualcuno che socialmente se ne faccia carico -oltre i nostri archivi personali e domestici,famigliar i- custodendole e diffondendole, nuovamente il genere autobiografico assumerà un’ulteriore configurazione. Nella semplicità, umiltà, parsimonia che lo contraddistingue: né una pietra tombale né un epitaffio sbrigativo ma una storia ricostruita che possa comprendere anche chi di essa si occupò. Ciò potrà divenire momento di partecipazione collettiva nella salvaguardia delle memorie individuali; sarà una riproposizione sociale non celebrativa e ritualistica che, in presenza di scritture, potrà rinnovarsi periodicamente al pubblico delle nuove generazioni. 70 Queste possibilità offerte al volontariato del commiato,che può rivolgersi con la pietà della scrittura a chi sta staccandosi dalla vita, come a chi non può che accettare il lutto imminente, immanente o successivo, rappresentano un impegno civile cui una comunità non può sottrarsi. Sono queste storie di “gente qualunque”, di gente come noi, che debbono impegnarci nella loro sollecitazione, trascrizione, raccolta. Ogni storia salvata dalla scrittura è un diritto per chi non c’è più e un dovere per chi resta. .(*)Professore di Filosofia dell’educazione e di Teorie e pratiche autobiografiche all’Università degli Studi di MilanoBicocca.Fondatore con Saverio Tutino e presidente della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari 71 72
Scaricare